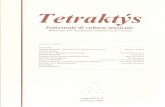Dispensa di Musica e Liturgia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dispensa di Musica e Liturgia
MUSICA E
LITURGIAOrientamenti di animazione
liturgico-musicale per cantanti,direttori di coro e organisti
PREMESSAAlcune pratiche questioni
Quali canti facciamo stamani? Una situazione anomala
1
Quante volte cinque o dieci minuti prima della Messa (o, se si èfortunati, durante le prove, qualche giorno prima) si sente dire:“Che canto si fa all’inizio? E alla comunione?”… e così diseguito. Questa scena contiene seri interrogativi: è necessariocantare alla Messa? Quali so-no i momenti in cui cantare? Checanti fare? Con quale criterio sceglierli? Chi deve sceglierli?Proviamo a rispondere a questi interrogativi in riferimento allaMessa domenicale.
Un riferimento indispensabile Fin dai primi secoli la Chiesa è consapevole che la liturgia èopera di Dio; infatti, attraverso i sacramenti il Cristo Risortoincontra il suo popolo e gli partecipa la salvezza, attuando cosìl’opera della redenzione (cfr. Sacrosanctum Concilium n. 2) perchél’uomo viva in lui e come lui. Talvolta avvertiamo che il linguaggio rituale e simbolico dellaMessa è estraneo dai nostri modi di esprimerci e questo rendedifficile la par-tecipazione, perché senza conoscere il senso deiriti il mistero rimane nascosto e partecipare alla liturgia senzaconoscere il mistero è come danzare senza avere il senso dellamusica. Una cosa bisogna tenere presente: non è il cristiano(prete, gruppo...) che fa (a suo gusto) la liturgia ma è laliturgia che fa (plasma) il cristiano. Solo una conoscenzaadeguata della liturgia permette di vivere il mistero che si fapresente nei riti e nelle preghiere. In questa scheda s’intendedare qualche chiarificazione riguardo al canto nella celebrazioneeucaristica domenicale.
2
È necessario cantare alla Messa? La risposta è: Sì! Non esiste – come si diceva anni fa – la Messaletta e la Messa cantata, esiste la liturgia eucaristica che deveessere “celebrata e percepita come evento pasquale ecomunitario…”. Il canto ha una funzione precisa: a. per sua natura serve a rendere chiare le cose che esprime; creaunità ed è sempre comunitario (anche quando canta uno e gli altriascoltano); è un linguaggio capace di esprimere l’indicibile; b. nella liturgia esso permette alla comunità di esprimersi con le stesseparole pronunciate nello stesso tempo grazie alla precisione delritmo. Inoltre, la funzione dei canti è di esprimere la fede dellacomunità orante. Nella Messa non si canta per rendere più solenneil rito (il canto non è una decorazione), tantomeno per faresibire un gruppo di persone; il cantare è il modo più forte dipregare dell’assemblea: non si tratta di cantare durante lacelebrazione ma di celebrare cantando. Per questo motivo il cantodeve coinvolgere il più possibile tutta l’assemblea (il che nonsignifica che tutti devono cantare sempre tutto).
Cosa cantare nella Messa? La Messa non è un contenitore in cui si può metter dentro ditutto. Anzitutto si deve cantare la Messa (cioè le parti del rito) e nonriempire alcune parti della Messa con dei canti. Inoltre ènecessario che ci sia una coerenza tra canti, riti e contenutidella Parola di Dio. La Messa è un rito dalla struttura bendefinita: non deve mai capitare che le letture danno un messaggioe il canto ne da un altro diverso.
In concreto: I primi e più importanti canti sono quelli che appartengono allastruttura del rito e nascono come canti: l’Alleluia, il Santo, il Gloria(nelle festività), le altre acclamazioni come il Mistero della fede, ilTuo è il Regno.
3
Questi per loro natura andrebbero cantati. Così pure il salmo tra leletture, proprio per la sua natura poetica esige un trattamentodiverso dalla semplice lettura. Il primo tipo di canti adatti alla liturgia, quindi, non vacercato fuori, ma all’interno stesso del rito. Occorre farcomprendere come queste parti vanno eseguite. È fuori luogo fareuna introduzione musicale ad una acclamazione superando la duratadell’acclamazione stessa, una o al massimo due note per aiutarel’assemblea che la invitano a cantare. Un discorso a partemeriterebbe il Santo che pochi ricordano far parte integrante dellapreghiera eucaristica, spesso viene inteso come con-clusione delprefazio e intermezzo prima del Canone.
Proviamo a mettere ordine: - la Preghiera eucaristica inizia con il dialogo del Prefazio chespiega il significato del rendere grazie a questa azione segue ilcanto del Sanctus che prosegue con ….. Padre veramente santo …. Noiti lodiamo …… Padre clementissimo ….. (quasi come un embolismo).Occorre ribadire con forza che non tutte le composizioni attualirispettano questa struttura; talvolta diventa un brano urlato,talvolta una esecuzione banale, talvolta un testo privo di senso. - Per rendere l’idea possiamo immaginare una gemma preziosa in-castonata in un altrettanto ricco gioiello. Ogni elemento diquesto monile deve essere armonico con tutto il resto altrimentinon solo perde di valore ma rischia di apparire volgare seincastonato su un elemento estraneo. - Comprendere e conoscere il significato del Santo aiuta a scoprirela bellezza di questo elemento inserito dopo il prefazio e primadella preghiera eucaristica e aiuta a fare scelte sagge. - Il Mistero della Fede va rivalutato nelle sue tre opzioni. purtroppoci siamo fossilizzati sulla prima. - Tuo è il Regno è una acclamazione bella ma purtroppo eseguita sullamelodia di altri canti risulta squalificata in pieno e la rendebanale. - Non meno problematico è il canto del Salmo responsoriale:andrebbe cantato sempre, ma come? Innanzitutto si parte dallacomprensione del testo, ciò detto diventa chiaro che una melodianon può andare bene in Avvento, in Quaresima, a Pasqua!! La suaesecuzione richiede estrema competenza e rigore e soprattuttoagilità nell’esecuzione. Lo strumento musicale deve solo sostenereil canto del ritornello e delle strofe, deve far sentire lamelodia solo all’inizio ma non ad ogni strofa, chi canta devesapere con quale nota deve iniziare senza attendere l’intonazione,
4
altrimenti l’esecuzione diventa pesante e noiosa. Il canto delSalmo deve essere espressivo, non patetico, sicuro non incerto,dolce non mieloso, insomma bello da ascoltare.
Un secondo blocco di canti liturgici ha come obiettivo quello dicommentare una parola risuonata nell’assemblea (es. canto legato alle let-ture bibliche) o la particolare giornata o il santo del giorno, oppureac-compagna un’azione (es. il canto d’inizio e il canto di comunione cheaccompagnano una processione). Anche questo secondo blocco ha un legamediverso ma ugualmente stretto con quanto si dice e si fa nellacelebrazione.
In sintesi: nella Messa incontriamo i canti-rito (Alleluja, Gloria, Santo) chesono parte integrante del rito, e canti nel rito (canto d’inizio,d’offertorio, di comunione…). Questa divisione deve orientare le scel-te: una cosa è il muroportante di una casa, altro è una parete divisoria: senza il primola casa non si regge, senza la seconda magari è meno bella o pocofunzionale… ma non crolla!
5
Con quale criterio scegliere i canti? Il criterio dei canti è dato dalla liturgia, è essa la norma chene deter-mina il contenuto, il numero e il momento. È un veroostacolo alla li-turgia che i criteri di scelta coincidano con igusti personali di qualcuno o con definizioni del bello che sirifanno a modelli più o meno progressisti o conservatori. Un cantoliturgico è tanto più bello (buono, “azzeccato”, utile, ecc.ecc. ) quanto più è ….. liturgico, cioè quanto più aiutaquell’assemblea specifica – riunita in quel luogo, fatta di quellepersone, con quegli animatori, con quei musicisti – a parteciparealla stessa Liturgia! Da questo principio derivano alcuni criteri che permettono diorientarsi nella scelta.
Per quanto riguarda i contenuti: 1. i canti devono contenere verità di fede per esprimerle inpreghiera, non possono limitarsi ad avere Dio per argomento,devono rivolgersi a Lui; 2. sono da preferire canti al plurale che esprimono l’esserechiesa davanti a Dio.
Per quel che riguarda la struttura musicale è necessario conservare: 1. coerenza fra testo e musica. Ci sono sentimenti molto diversida esprimere e la musica deve tenerne conto! Non si può cantare untesto penitenziale con una melodia festosa; così pure non si puòcantare la lode con una musica in tono minore... 2. Coerenza tra canto e rito. Dato che la musica è sempre aservizio del rito, anche la sua lunghezza deve essere calcolata.Non si può eseguire un canto di quattro minuti se il momentorituale ne dura uno, così come non ha senso cantare sempre tuttele strofe di un canto: è più opportuno scegliere le più adatte ecantare fino alla conclusione del momento rituale.
6
La scelta dei canti Se è la liturgia che determina il canto, va da sé che bisognaconoscere la Messa in tutte le sue parti e nel loro significato,conoscere le letture e il loro messaggio, tener presente il tempoliturgico che si vive. La scelta dei canti va decisa sempre prima della celebrazione, maiimprovvisata e in accordo con il presidente dell’assemblealiturgica che è il solo responsabile di tutto quel che accade(sacerdote).
Per quel che riguarda il rapporto con l’assemblea: I canti devono tener conto della capacità dell’assemblea: un cantotroppo ritmico o eseguito troppo velocemente o troppo esteso nonpo-trà mai essere cantato dall’assemblea: il canto deve unire(funzione simbolica) e non dividere (funzione diabolica)l’assemblea.
Il coro e la sua funzione nella liturgia L’animazione del canto liturgico è un ministero e non può essereaffidato a un qualsiasi gruppo per invogliarne i componenti apartecipare alla Messa; non ci devono essere esclusioni di sorta,ma si consideri che come si prepara un catechista prima dimetterlo a fianco di un gruppo di persone, allo stesso modo non sipuò affidare l’animazione del canto senza un’adeguata preparazioneliturgica e musicale. Lo stesso principio vale per l’uso deglistrumenti musicali, non si possono chiamare a suonare persone peril semplice fatto di coinvolgerle se non sanno dove sono e cosafanno.
a. Il gruppo che canta non è al di fuori dell’assemblea, chi suonauno strumento non è un corpo estraneo chiamato a fareun’esecuzione, ma è parte dell’assemblea e questo deve essere veroe visibile anche nella collocazione fisica (non ha senso un coro collocatodietro l’altare o in una cantoria distante dall’aula della celebrazione). Per lo stessomotivo, che senso ha chiamare “una brava corale” per solennizzareuna festa con l’esito disastroso che l’assemblea in festa restamuta? b. Il coro è un gruppo che svolge un ministero e per questoantepo-ne l’assemblea ai suoi gusti e ne vuole il bene. c. È da ricordare che prima di essere cantori o strumentisti icantori sono dei cristiani convocati dal Signore per ascoltare lasua Parola, per rispondere e pregare insieme con gli altri. Quando
7
si conclude un canto, per il coro non è in intervallo ricreativoriempito sfogliando il libretto o la cartella dei canti o parlandocon l’amico o l’amica. I cantori partecipano in tuttoall’Eucaristia, come tutti. d. Il compito del coro è quello di favorire il celebrare cantando ditutta l’assemblea e lo può fare sostenendola; alternandosi (ritornellicantati dall’assemblea e strofe dal coro); proporre all’ascolto e allameditazione dell’assemblea alcuni canti (sem-pre in tema con lacelebrazione). e. Anche per il coro esiste una veste liturgica che è diversa daquella usata nei concerti. Una corale che svolge attivitàconcertistica usa il frac per gli uomini, abiti lunghi per ledonne o altro abito scelto che non dovrebbe essere mai usato nelleAzioni Sacre proprio per distinguere la diversa attività e ildiverso momento in cui il coro è chiamato ad intervenire per nondare l’apparenza dell’esibizione durante gli atti di culto. Cometutti quelli che svolgono un ministero nell’azione sacra èprevista una veste propria per svolgere solo quel ministeroparticolare.
************* Per approfondire: ROBERT PHILIPPE, Cantare la Liturgia, Ed. ELLEDICI, pp.124, € 12.00. Il libro facendo riferimento al Messale presenta le parti dellaMessa che possono essere can-tate; indica i criteri per sceglierei canti; fa un inquadramento sugli “attori del canto”. Con-sideraanche i canti di celebrazioni particolari.
8
F. CASSINGENA-TRÉVEDY, La bellezza della liturgia, Ed Qiqajon pp. 118 € 7.00.Prezioso e piccolo testo per scoprire riti nella loro bellezza epoter contribuire a una celebrazione capa-ce di aiutarel’assemblea a esprimere la fede.
CANTARE LA LITURGIA
Conoscere la liturgia nella sua natura e nella sua funzione, è condizione prioritariaper tutti coloro che desiderano svolgere un ruolo nell’animazione liturgica.
A – Partiamo dalla “Liturgia”…
«La sacra liturgia, benché sia principalmente culto dellamaestà divina, è anche una ricca fonte di istruzione per il popolofedele. Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristoannunzia ancora il Vangelo. Il popolo a sua volta risponde a Diocon i canti e con la preghiera» (SC 33).
1. Che cos’è la liturgia? Dall’aggettivo greco léitos (= pubblico) e dal nome comune
érgon (= servizio, opera, lavoro) → Liturgia = “serviziopubblico”, “opera compiuta in favore del popolo”.
Liturgia = azione rituale in cui si celebra nella fedel’Alleanza che Dio ha stabilito col suo popolo; l’azioneliturgica prende forma attraverso gesti legati allanostra vita quotidiana di uomini e donne come il“cantare”. L’iniziativa è di Dio che propone un patto dialleanza al Popolo (linea discendente), che, a suavolta, è chiamato a rispondere (linea ascendente). Ognidialogo tra il celebrante e l’assemblea è segno deldialogo tra Dio e il suo popolo.
Cantare = gesto “profano” che diventa “sacro” nellaliturgia dovendo esprimere più che se stesso e “altro”
9
da se stesso (Dio), come espressione sensibile dellafede cristiana.
2. A tu per tu con Dio! Il canto nella liturgia diviene espressione della gioia
di un popolo che si rallegra nel Signore, come rispostaall’iniziativa amorosa di Dio: è il canto della “Sposa”(la Chiesa) per il suo “Sposo” (Cristo).
Il canto liturgico esprime l’unità e la “coralità” delpopolo radunato che canta “a una sola voce”.
B – Cantando e suonando la liturgia…
«La musica sacra deve per conseguenza possedere nel grado migliorele qualità che sono proprie della liturgia, e precisamente la santità ela bontà delle forme, onde sorge spontaneo l’altro suo carattere, che èl’universalità» (IS 2).
«La musica sacra sarà tanto più sana quanto più strettamente saràunita all’azione liturgica» (SC 112).
«La musica più moderna è pure ammessa in chiesa, offrendo anch’essacomposizioni di tale bontà, serietà e gravità, che non sono per nullaindegne delle funzioni liturgiche» (IS 5).
1. “Sacro profanato” o “profano sacralizzato”? Non tutti i canti rispondono alle esigenze della
liturgia. Le due categorie del “religioso” e del “sacro” non
servono a definire un canto “liturgico”, cioè adatto allaliturgia.; “canti religiosi” sono anche le canzonireligiose popolari e i canti catechistici o dianimazione; i “canti sacri” non hanno una forma e una
10
struttura precisa, ma sono solo canti che si distinguonodalle canzoni profane (il termine “sacro” è usato per laprima volta in Germania).
2. La “messa da concerto”! In Italia il termine “sacro” è usato invece per definire
uno stile di scrittura musicale (modelli della “musicasacra” del passato), in un contesto in cui, prima delConcilio Vaticano II, la messa era innanzitutto un’azionedel celebrante, mentre il popolo assisteva alla messa eascoltava un concerto di musica sacra o di organo.Obiettivo della musica era di condurre a una spiritualitàpiuttosto che a una partecipazione attiva dei fedeli.
C – Scegliere di cantare e i canti da scegliere nella liturgia…«L’azione liturgica riveste una forma più nobile quando è
celebrata in canto, con i ministri di ogni grado che svolgono ilproprio ufficio, e con la partecipazione del popolo» (MS 5).
1. Canto per Dio o per il popolo?«La sacra liturgia, benché sia principalmente culto della maestà
divina, è anche una ricca fonte di istruzione per il popolo fedele. Nellaliturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora ilVangelo. Il popolo a sua volta risponde a Dio con i canti e con lapreghiera» (SC 33)
Cantare è un atto “cultuale”: noi cantiamo per Dio. Cantare è un atto “pedagogico”: noi cantiamo per il
popolo.
2. A favore della liturgia!
11
«I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrinacattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra Scrittura e dallefonti liturgiche» (SC 121).
In linea generale per i testi e per la musica, èfondamentale scegliere in relazione all’azione liturgicae alla celebrazione del mistero eucaristico e non in baseai nostri gusti personali o a quelli che attribuiamo aglialtri.
Favorire l’unanimità : l’attore principale di unacelebrazione è l’assemblea, quindi è importante proporlecanti che possa fare suoi; ciò non significa che essadebba cantare tutto! La scelta dovrà cadere su canti chepermettano all’assemblea di intervenire quando laliturgia lo richiede (soprattutto nel Kyrie, Gloria, Alleluia,Sanctus, Pater noster, Agnus Dei).
Per una scelta corretta di un testo occorre sempre domandarsi:
a) la forma testuale del canto è adatta all’azioneliturgica che esso accompagna o costituisce?
b) qual è il rapporto tra il testo del canto e la festao il tempo liturgico che si celebra?
c) qual è il legame tra il testo del canto e la fontebiblica?
d) qual è il livello poetico del testo?
Se i testi dei nostri canti strutturano la fedecristiana, allora è importante scegliere dei canti che lanutrano e la facciano crescere.
Dei canti che si ispirino largamente alla Scritturapossono farcene scoprire passaggi che ignoriamo o checonosciamo male.
12
Memorizzare questi canti permette di ridirne le parole,di ruminarle, di rimasticarle al fine di gustarne fino infondo il sapore.
Occorre far scendere la preghiera dalla testa al cuore. Com’è possibile esprimere l’indicibile senza fare appello
a un linguaggio che privilegi la funzione “poetica”? È ilmistero del linguaggio “simbolico”, un linguaggio le cuiparole svelino davanti a noi una profondità che ciconduca aldilà di noi stessi. Bisogna lasciare lapossibilità al “gioco simbolico” delle parole dirisvegliare in noi l’amore di una realtà che ci supera.
3. Sedotti dalla musica!
«La musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente saràunita all’azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera efavorendo l’unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri»(SC 112).
Cosa influenza le nostre scelte musicali? Quando scopriamo una musica, essa si rivolge direttamenteall’universo dei nostri sentimenti. La musica va dritta al cuore e non sappiamo spiegareperché una musica ci prende e un’altra ci lasciaindifferenti.Alcune musiche ci proiettano fuori da noi stessi e altreci invitano a rientrare in noi e a gustare la bellezza diciò che si offre a noi.
Quali sono i criteri che dovrebbero orientare le nostre scelte?È importante spostare i criteri del nostro giudizio ecercare di giustificare le nostre scelte non in ragione
13
della nostra soggettività ma in rapporto all’azioneliturgica stessa. Per questo sarebbe utile:
a) scegliere melodie che rispettino e valorizzino iltesto;
b) rispettare il genere letterario utilizzando unostile musicale che gli si adatti;
c) scegliere una musica che esalti il valore simbolicodel testo;
d) scegliere un linguaggio musicale che introduca nelmistero celebrato della morte e risurrezione diCristo;
e) scegliere musiche che assecondino una varietàespressiva in base al momento liturgico celebrato(lode, supplica, meditazione, adorazione, ecc.);
f) scegliere musiche “giuste”, cioè adeguate ai mezzidi cui si dispone e agli attori musicali presenti(esecutori).
MUSICA RELIGIOSA, MUSICA SACRA E MUSICA LITURGICA
Musica religiosa secondo l’istruzione Musicam Sacram dellaCongregazione per il Culto divino (1987) sui concerti nelle chieseè quella musica
che si ispira al testo della sacra Scrittura o della liturgia oche richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi, o allaChiesa... (MS 9).
Una definizione parziale che, in ogni caso, non intende escluderetutta quella musica (soprattutto se munita di un testo ispirato)che in qualche modo affronta il problema dell’uomo, dei suoianeliti, del suo destino, o tocca i temi della bontà, della
14
fratellanza: tutti riconducibili facilmente alla tematicaevangelica. Infatti più avanti l’istruzione parla di
altre esecuzioni musicali, sia vocali che strumentali [che]possono servire o favorire la pietà o la religione (ivi).
Insomma tutta la letteratura musicale provocata da sentimentianche genericamente religiosi deve considerarsi a buon diritto“musica religiosa”. Questa musica non è fatta per la liturgia, nonne è abilitata. Può trovare posto in chiesa, «ma fuori dallecelebrazioni liturgiche» (ivi), quindi nei concerti spirituali o inmanifestazioni analoghe.
Musica sacra secondo la definizione classica è quella musica
che, composta per la celebrazione del culto divino, è dotata disantità e bontà di forme (MS 4).
Tale definizione è ripresa dal motu proprio di Pio X (Inter sollecitudines,1903, n. 2) e viene completata con la esplicitazione che per“musica sacra” s’intende quella musica
composta per la celebrazione del culto divino: è musica sacraquella in cui c’è il fine specifico, inteso in partenza con lavolontà iniziale di adeguare il più possibile la natura intimadella musica stessa alla santità della liturgia della quale èchiamata a diventare parte necessaria e integrante.
Quindi deve essere «dotata di santità e bontà di forme»; possederecioè una predisposizione antecedente al suo concreto inserimentonel rito, a differenza di altre musiche di natura e finalitàdiverse. Lo confermò Giovanni Paolo II in una storica omelia nel1983:
15
perché tale musica sia autenticamente sacra occorre che posseggauna predisposizione adeguata alla sua finalità sacramentale eliturgica, e sia, pertanto, aliena dalla musica destinata adaltri scopi. (Omelia alle “Scholae cantorum” riunite in S. Pietro, 25 ottobre1983).
Ma già il 21 settembre 1980 in occasione del centenariodell’Associazione Italiana di S. Cecilia si era pronunciato intermini analoghi e altrettanto chiari:
Non si può affermare che ogni musica diventi sacra per il fattoe nel momento in cui venga inserita nella Liturgia […]. LaChiesa esige che essa possegga una predisposizione adeguata atale finalità sacra e sacramentale, per particolaricaratteristiche, che la distinguano dalla musica destinata, adesempio, al divertimento, all’evasione o anche alla religiositàlargamente e genericamente intesa.
La bontà di forme, la predisposizione adeguata e antecedenteriguarda – come appare chiaro – la musica in se stessa,indipendentemente dal testo. Ma non tutta la musica sacra puòautomaticamente essere usata nella liturgia. Le occorrono deirequisiti ulteriori di natura più esterna, ma non accidentali, chesi possono riassumere nel termine di «liturgicità».
Musica liturgica, allora, è quella musica sacra che in concretopuò, senza inconvenienti o controindicazioni, venire inserita nelculto perché, oltre alla sacralità indispensabile, possiededeterminate caratteristiche di proprietà e funzionalità:- anzitutto un testo liturgico ufficiale o almeno approvatoufficialmente;
16
- poi la pertinenza, cioè la corrispondenza precisa tra quello chesi esegue e il rito che si celebra, e il tempo in cui si celebra(un canto quaresimale eseguito il giorno di Natale, oppure uncanto d’ingresso intonato alla comunione non sono liturgici perchéfuori posto, non pertinenti);- l’essere in linea con le prescrizioni rubricali, che poi a lorovolta sono dettate da preciso senso liturgico e teologico. Adesempio: porre un canto qualunque dopo la prima lettura è errato eantiliturgico, perché in quel mopmento è richiesto un salmo o uncantico, trattandosi ancora di proclamazione della Parola di Dio;- infine le dimensioni accettabili delle composizioni, la loroeffettiva eseguibilità, la loro capacità di essere capite e diessere veramente efficaci sul piano spirituale. Caratteristiche difunzionalità rituale che impediscono all’esecuzione di trasformarsiin un concerto, cioè in un momento musicale a se stante eautocompiaciuto o, peggio ancora, incomprensibile. Persino unamessa cantata in gregoriano rischia, per assurdo, di risolversi inuna scelta non liturgica se provoca choc e disorientamento inun’assemblea non preparata (nel giudizio circa la liturgicità efunzionalità di una musica gioca molto il livello culturale e lapreparazione spirituale dei fedeli).
Da queste definizioni derivano le ovvie affermazioni conclusive:- ogni musica liturgica è e deve essere sacra; tanto più èreligiosa;- la musica sacra è religiosa, ma non automaticamente liturgica;lo può diventare per ulteriori requisiti funzionali;- la musica religiosa non è né sacra né liturgica, pertanto innessun modo ha diritto di entrare nel culto.
IL CANTO NELLA MESSA
I canti della messa si distinguono in:
17
A - Canti del PROPRIO (con testo che varia secondo il tempo e lasolennità del giorno: proprio del tempo, proprio dei santi, comunedei santi) Introito, Alleluia, Graduale, Tratto, Sequenza, Offertorio, Comunione.(Introito, Offertorio Comunione = canti processionali o antifonali- Alleluia, Tratto, Sequenza = canti interlezionali). B - Canti dell’ORDINARIO (con testo fisso e invariabile) Kyrie, Gloria,Credo, Santo, Agnello di Dio. C - RECITATIVI dei ministri: Saluti, Orazioni, Letture ai quali siinnestano risposte ed interventi acclamatori dell’Assemblea edella Schola.
Canto d’IngressoNatura e funzione – «Lo scopo di questo canto è di aprire lacelebrazione, favorire l’unione di quelli che sono radunati,introdurre le loro menti nel mistero del tempo liturgico o dellafestività e accompagnare la processione dei sacerdoti e deiministri» (Istruz. gener. del Messale Romano n. 25).
Dunque una doppia finalità: una più esteriore e coreografica: accompagnare e solennizzare
l’ingresso dei celebranti; l’altra, più impegnativa, di creare con il testo e con la
musica il clima proprio della festa, “anticipando” e“riassumendo” in qualche modo il messaggio spirituale eteologico della celebrazione ricorrente.
Tutte le forme possono essere arricchite da preludi, interludi,postludi di organo. Il testo del canto d’ingresso può essere quello del Gradualeromano o del Graduale semplice o un altro (biblico o libero)purché si adatti convenientemente all’azione sacra del giorno odel tempo e sia approvato dalla Conferenza Episcopale (Istruz. gen. n.26).
18
Se la processione è molto breve, il canto può cominciare primadell’ingresso del sacerdote.
Canto d’OffertorioNatura e funzione – È il canto che accompagna la processioneoffertoriale e la presentazione dei doni sull’altare da parte delcelebrante; per questo è chiamato anche “canto per lapresentazione dei doni”. È uno di quei canti che si limitano a fare da sfondo ad una azionerituale e da essa sono condizionati: in verità il momentodell’Offertorio, quando non c’è processione e incensazione èridotto a ben poca cosa, temporalmente 2-3 minuti. È significativo che non sia più previsto un canto d’Offertorioufficiale: il silenzio assoluto o rotto appena da leggerosottofondo d’organo o di polifonia, o di gregoriano, eseguiti dalcoro è consigliabile. Comunque se si volesse proprio eseguire un canto, questo dovràavere il tema specifico dell’offerta o altri temi generici(meditazione sulla Parola annunciata, acclamazioni, preghiere dipropiziazione, di intercessione, alla Madonna, ai Santi…). Per la forma non ci sono preclusioni o prescrizioni particolari,anche se occorre affermare che il canto d’Offertorio dovrebbesempre rimandare alla funzione del dialogo tra celebrante(«Benedetto sei tu, Dio dell’universo…») e assemblea («Benedettonei secoli il Signore»), svolgendosi, per esempio, in formaresponsoriale.
Canto di ComunioneNatura e funzione – Ha lo scopo «di esprimere per mezzo dell’unitàdelle voci l’unione spirituale dei comunicandi, dimostrare lagioia del cuore e rendere più fraterna la processione di coloroche si accostano a ricevere il Corpo di Cristo» (IGMR, n 56, i).Importante è che tale canto abbia riferimento al tema eucaristico,mentre il collegamento con il tema liturgico del giorno può non
19
essere così forte. Salvo le forme apertamente acclamatorie, tuttele altre (corali, responsoriali, strofiche o libere) sono adatte arealizzare il Canto di Comunione.
GLI STRUMENTI MUSICALI NELLA LITURGIA
Afferma la Sacrosanctum Concilium al n. 120:
Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne,strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado diaggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, edi elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti.[…].
Ispirandosi a questo dettame, che identifica l’organo a cannecome strumento principe della liturgia, ci si auspica lavalorizzazione e la promozione anche da parte dei giovani(art. 218).
Se molte volte, per un lavoro di sapiente e accuratorestauro, gli organi vengono restituiti all’uso dellecomunità, altrettante volte non ne segue però lavalorizzazione mediante l’utilizzo nelle celebrazioniliturgiche, ove sovente si ripiega su chitarre o strumentielettrofoni anche in presenza di strumenti perfettamentefunzionanti.
Certamente, si dirà, l’organo a canne non è l’unico strumentoammesso nelle celebrazioni liturgiche.
Quale, allora, il giusto metro di giudizio per permetternel’uso di altri e quali, invece, dovrebbero esserecategoricamente vietati nelle celebrazioni?
Se in passato persino alcuni pontefici si scomodarono acompilare delle vere e proprie “liste di proscrizione” di cuioggi malvolentieri si accetterebbe l’imposizione, pur è veroche gli orientamenti che a tali liste portarono continuano a
20
rimanere validi, e vengono via via ribaditi dai documentimagisteriali e rubricali a tutt’oggi in vigore.
Così recita l’istruzione Musicam Sacram all’art. 63:
Gli strumenti che secondo il giudizio e l’uso comune sono propridella musica profana, siano tenuti completamente al di fuori diogni azione liturgica e dai pii e sacri esercizi.
Dall’associazione emotivo-mnemonica evocata dall’uso di certistrumenti, seppure in contesti liturgici ed in presenza dibrani sacri di per sé anche pertinenti, non si sfugge.
Se paradossalmente suonassi anche una messa di Palestrina conl’accompagnamento di basso elettrico e percussioni,sottofondo di sintetizzatori e amplificazioni vocali, nonsolo snaturerei irrimediabilmente quella musica ma larenderei “profana”, non adatta, cioè, all’ambiente sacro né,tanto meno, al servizio liturgico.
Quando, allora, uno strumento musicale contribuisce invecealla “gloria di Dio e all’edificazione dei fedeli”? Risposta:quando conferma, con la sua natura, nel modo in cui èsuonato, con la musica che si esegue, il rito che si compie.
Se ciò avviene, esso suggella il rito, non distoglie daesso.
Anche qui, il tema della formazione è cruciale.
Entreremmo qui in una querelle che comprenderebbe, da una parte,come sia vero che la Chiesa non investa in figureprofessionalmente competenti in ambito musicale oramai da decenni,assuefacendosi a tal punto alla mediocrità del livello musicale eliturgico ammesso al culto divino da considerare accettabili oaddirittura belle delle animazioni, il più delle volte,assolutamente incongrue rispetto al rito e mediocri sotto ilprofilo tecnico musicale e, dall’altra, la mancanza di umiltà da
21
parte di molti giovani che, seppure lodevoli sotto l’aspettodell’impegno e della dedizione ma assolutamente digiuni in ambitoliturgico musicale, non si mettono affatto in discussione al finedi una corretta interpretazione del loro ruolo.
IL DIRETTORE DI CORO
Il direttore di un coro liturgico deve innanzitutto essereconsapevole dell’importanza del suo ruolo, che consiste nellaselezione delle parti musicali adatte al rito e alla celebrazione,nella preparazione del coro, nella chiara ed efficace direzione, enell'educazione di un popolo che canta con fede. Tutto ciòdovrebbe essere preparato da un cammino di formazione liturgico-musicale, unito alla pratica e all’esperienza. Non basta essereottimi musicisti, è vero, ma non è certo sufficiente essere buoniamatori della musica o semplici appassionati, anche se spessosuccede che persone di buona volontà e obbedienza venganocatapultati nella direzione di cori parrocchiali. Come ha scrittoValentino Donella nell’editoriale del Bollettino ceciliano: «In chiesapiù che altrove il direttore di coro è chiamato all’eserciziodella fede (confessor fidei) prima che al trattamento delle note:soddisfazioni, umanamente intese, potrebbe non ricavarne mai. Puòanzi verificarsi il caso di un vero e proprio martirio (martyr fidei),per stare in analogia con la classificazione canonica dei santi». Riportiamo dallo stesso articolo i requisiti indispensabili albuon esercizio della direzione corale in chiesa:
1. eliminare l’esibizionismo: il direttore deve accontentarel’orecchio senza mai offendere l’occhio;2. sintonia con il parroco o con il responsabile della liturgia,al fine di garantire una regia concordata e ordinata dei riti (nondovrebbe succedere di vedere un parroco che ignora il coro e uncoro che ignora il celebrante e l’assemblea);
22
3. preparazione spirituale: uomo di fede e di pietà, riccointeriormente e capace di pregare (un uomo che sappia tradurre inmusica e trasferire nei suoi cantori la stessa voglia dipreghiera);4. conoscenza approfondita della liturgia, indispensabile adalimentare la stessa pietà personale e soprattutto necessaria ascegliere i testi, le musiche e il repertorio più appropriato percondurre il coro attraverso riti, festività diverse e calendariliturgici annuali, senza aspettare l’imbeccata del sacerdote -bisogna anzi contestare autorevolmente, con competenza, errateproposte di parroci e fedeli “tuttofare” e “tuttosapere”;5. carisma spirituale e artistico-musicale. Un direttore di coroesperto di liturgia ma non "a posto" musicalmente, non attraenessuno. Anzi, troppe volte si verifica che i direttori di coronascondano l'incompetenza musicale dietro tante dissertazioniliturgico-teologiche o troppo "specialistiche".
Infine occorre ricordare che l’operosità del direttore di coro nonè del tutto priva di dolci soddisfazioni: l’amicizia con icantori, la gioia di condividere con essi percorsi musicali eformativi che lasciano il segno, la consapevolezza di un ministerosvolto ad edificazione di tutto il popolo di Dio, la convinzioneche con il proprio cantare si prefigura la liturgia del cielo.
IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIATESTI DEL MAGISTERO
“La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore, cheeccelle tra le altre espressioni dell’arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unitoalle parole, è parte necessaria ed integrante della Liturgia solenne... Perciò la Musicasacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all’azione liturgica, siaesprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l’unanimità, sia arricchendo dimaggior solennità i riti sacri”.“Non c’è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni di una assemblea che,tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede. Pertanto la partecipazione attiva ditutto il popolo, che si manifesta con il canto, si promuova con ogni cura”.
23
IL CANTO SACRO, PARTE NECESSARIAE INTEGRANTE DELLA LITURGIA
Per musica sacra si intende: il canto gregoriano, la polifoniasacra antica e moderna nei suoi vari generi, la musica sacra perorgano ed altri strumenti legittimamente ammessi nella liturgia eil canto popolare sacro, cioè liturgico e religioso. Nellacelebrazione dell’Eucaristia con la partecipazione del popolo,specialmente nelle domeniche e nelle feste, si preferisca la formadella Messa in canto, anche più volte nello stesso giorno4. Inquesto senso è necessario educare il popolo a cantare la Messa enon ad eseguire canti nella Messa.La preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si facciad’accordo tra tutti coloro che devono curare la parte rituale opastorale o del canto (organista, animatore musicale, gruppocorale, ecc...) sotto la guida del Rettore della chiesa. Ènecessario che nelle celebrazioni festive o solenni vi sia sempreun cantore o maestro di coro per dirigere e sostenere il canto delpopolo. Questo è compito preminente degli stessi appartenenti alcoro liturgico che, in forza del loro ministero, attraverso laloro competenza e grazie alla loro disponibilità, devonopromuovere la partecipazione attiva dei fedeli al canto.
L’ORGANO E GLI STRUMENTI MUSICALI
Il principale e solenne strumento musicale liturgico della Chiesalatina (a partire dall’VIII-IX sec.) fu e rimane l’organoclassico, cioè l’organo a canne. L’organo destinato al servizioliturgico, anche se piccolo, sia costruito secondo le regoledell’arte e dotato di quelle voci che convengono all’usoliturgico; prima di inaugurarlo venga benedetto e lo si custodiscapoi con ogni cura.Altri strumenti musicali si possono ammettere al culto divino, agiudizio e con il consenso dell’Ordinario, purché si possanoadattare all’uso sacro, convengano alla dignità del luogo efavoriscano veramente l’edificazione dei fedeli. Tuttavia glistrumenti che, secondo il giudizio e l’uso comune, sono propridella musica profana, siano tenuti completamente fuori dell’azioneliturgica.
24
L’organo ed eventuali altri strumenti (ottoni, legni, archi...)legittimamente permessi, hanno il compito di accompagnare il cantodell’assemblea e del coro e di suonare come solisti nei tempiconsentiti.La voce solista di questi strumenti non è consentita in Quaresima,durante il Triduo sacro fino al Gloria della Veglia pasquale enelle Messe dei defunti10; tuttavia in quest’ultimo caso potrebbeessere consentito di preludiare con molta sobrietà peraccompagnare l’ingresso e l’uscita della salma.Nel tempo di Avvento l’organo può essere suonato, anche comesolista, con quella moderazione che conviene ad un tempo digioiosa attesa.Per la conservazione, il restauro e la costruzione dell’organo cisi deve attenere alle indicazioni del Vescovo proposte nelRegolamento dell’Ufficio Liturgico12 e come viene riportato alcapitolo apposito della quarta parte di questo Direttorio.Per i concerti e le manifestazioni corali nelle chiese si procedasecondo le norme della istruzione della S. Congregazione del Cultodel 5/11/87 e delle indicazioni riportate al capitolo appositodella quarta parte di questo Direttorio.
I MINISTERI NEL CANTO LITURGICO
L’Animatore del canto liturgicoÈ un ministero di fatto che ha lo scopo di aiutare il popolo acantare e di dirigere i gruppi corali. È caratterizzato da unasincera volontà di servizio e da una essenziale vocazionemusicale. Questo servizio liturgico richiede, di sua natura, nelcandidato un’adeguata formazione spirituale, una fede matura,l’esemplarità della vita ed una qualificata competenza musicalespecifica. Ogni parrocchia si adoperi a favorire la presenza e laformazione di tale ministero.
L’animatore del canto ha il compito di:– programmare e scegliere i canti secondo i vari tempi liturgici ele caratteristiche delle varie celebrazioni, in accordo con ilresponsabile della chiesa;– insegnare i canti, spiegandone preventivamente il testo, lamelodia e lo spirito generale. Si suggerisce di utilizzare per laprova i dieci minuti che precedono la Messa domenicale, senzatrascurare di istruire i gruppi parrocchiali, le classi dicatechismo ecc... durante le attività della settimana;
25
– dirigere l’esecuzione, sia del coro che del-l’assemblea, con unapresenza assai discreta e con gesti essenziali. La vocedell’animatore deve guidare, uniformandosi al canto comune senzamai prevalere. Non si abusi del mi-crofono.L’Ufficio Liturgico organizza, attraverso l’Istituto diocesano diMusica Sacra, la scuola di formazione degli animatori del canto.Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. È opportunoche anche nei vicariati si promuovano incontri formativi per glianimatori del canto liturgico.
L’Organista LiturgicoL’organista dovrebbe essere un cristiano convinto e maturo che,svolgendo un compito indispensabile alla comunità, offre unservizio specifico nel settore dell’animazione musicale dellaLiturgia. Egli svolge un ministero di fatto, riconosciuto estimato da secoli.È auspicabile che gli organisti e gli altri musicisti, oltre apossedere un’adeguata perizia nell’usare il loro strumento,conoscano e penetrino intimamente lo spirito della Liturgia, conpreparazione spirituale e ricchezza interiore. Anche dovendoimprovvisare, assicurino il decoro delle celebrazioni, secondo lavera natura delle varie parti, e favoriscano la partecipazione deifedeli.I compiti dell’organista, durante il servizio liturgico, sono:– introdurre, accompagnare, sostenere e concludere adeguatamenteil canto dell’assemblea e del coro;– far risuonare la voce solista dell’organo nei momentiparticolari consentiti nella celebrazioneeucaristica: all’inizio, all’offertorio, alla comunione, altermine. Il suono dell’organo che accompagna le azioni liturgichedeve essere adattato con cura diligente al tempo ed al giornoliturgico, alla natura degli stessi riti ed anche alle lorosingole parti.Durante la proclamazione delle parti “presi-den-ziali” non èconsentito suonare. Lo stesso discorso vale per gli altristrumentisti che prestano servizio liturgico.Si tengano presenti, inoltre, le indicazioni del Vescovo nellaLettera agli operatori musicali della Diocesi.
L’AssembleaLa forma più solenne e festosa delle celebrazioni è quella ditutta un’assemblea che, pur nella sua diversità ministeriale,esprime con il canto la sua pietà e la sua fede. Pertanto si
26
promuova con ogni cura, con una adatta catechesi e conesercitazioni pratiche, la più ampia partecipazione, piena eattiva, di tutto il popolo al canto. Questa educazione allapartecipazione deve tener conto di alcune priorità e di alcunicriteri.Prima di tutto si favorisca la partecipazione alle acclamazioni(Amen, acclamazioni dopo le letture, Tuo è il regno...), alle rispostedei saluti del sacerdote e dei ministri, alle preghiere litaniche(Kyrie, Preghiera dei fedeli, Agnello di Dio) e inoltre alle antifone, aisalmi, ai versetti intercalati o ritornelli, agli inni (Gloria eSanto) ed ai cantici.La schola potrà cantare qualche parte del popolo solo in casieccezionali, purché il popolo non sia escluso completamente dallealtre parti che gli spettano. I canti per l’assemblea si possonotrovare nel Libro della Preghiera del Triveneto, nel repertoriobase nazionale, nell’elenco proposto dall’Ufficio LiturgicoNazionale e nelle indicazioni dell’Ufficio Liturgico Diocesano.Circa il canto popolare liturgico si vigili attentamente perchénon entri nelle celebrazioni liturgiche quel “repertorio di canti”non composti per la liturgia, oppure banalmente compromessi con ilconsumismo della musica leggera, da cui spesso prendonoispirazione e movenze.
Il Coro LiturgicoTra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola ogruppo corale, anche se formato da soli giovani, i cui compitisono quelli di eseguire a dovere le parti che le sono proprie,secondo i vari generi di canto, e di promuovere la partecipazionedei fedeli al canto18. In ogni caso il coro non deve maisostituire od espropriare l’assemblea liturgica dai suoi compitispecifici.Il coro liturgico, per il compito ministeriale preciso dianimazione alla preghiera, è degno di particolare attenzione.Perciò, oltre alla formazione musicale, si dia ai membri dellaschola e dei gruppi corali anche una adeguata formazione liturgica espirituale, in modo che dall’esatta pratica del loro ministeroliturgico, derivi anche un bene spirituale per gli stessi cantori.Venga data attenzione e importanza alla collocazione del coro.Tenendo conto della disposizione della chiesa, bisogna fare tuttoil possibile perché la schola sia collocata in modo che appaiachiaramente la sua natura di essere parte dell’assemblea pur conuno specifico servizio ministeriale. Questa collocazione siastrutturata in modo da poter favorire l’esercizio del suo
27
ministero e da consentire ai suoi membri di poter parteciparepienamente alla celebrazione sia sacramentalmente che visivamente.Si vigili che i cantori si accostino alla Comunione durante lacelebrazione e non al di fuori di essa.La schola sia posta, di norma, fuori dal presbiterio, a meno che ladistribuzione dello spazio non lo permetta.Venga promosso il dialogo fra coro e assemblea senza lasciarsistancare dalle reali difficoltà che si possono incontrare,cercando di superarle attraverso reiterate prove d’insieme e lacollaborazione dell’animatore musicale.Si cerchi sempre di adeguarsi alle direttive indicate nellaLettera agli operatori musicali della Diocesi.
Il SalmistaÈ un ministro distinto dal lettore in quanto cantore specializzatonella salmodia in tutte le sue modalità di esecuzione; deve esserericco di musicalità e capace di trasformare l’esecuzione del salmoin momento di poesia e contemplazione. In ogni comunità sipreparino perciò dei cantori esperti nell’arte del salmeggiare edotati di buona pronuncia e dizione. Accanto alla preparazionetecnica si curi anche quella spirituale, biblica e liturgica.
**********Fonti
CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 112.
SACRA CONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 16.
SACRA CONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 4.
SACRA CONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 27.
Principi e norme per l’uso del Messale Romano, 73; vedi anche SACRACONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 5.
Principi e norme per l’uso del Messale Romano, 63-64; vedi anche SACRACONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 21.
28
CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 120.
Benedizionale, cap. L.
CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 120; anche SACRACONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 63.
SACRA CONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 66.
SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Cæremoniale Episcoporum, 41.P. MAGNANI, Ufficio Liturgico diocesano. Regolamento, in “Rivista dellaDiocesi”, 80 (1991), pag. 885.
CEI, Evangelizzazione e ministeri, 69.
SACRA CONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 67.
Principi e norme per l’uso del Messale Romano, 12.
P. MAGNANI, Musica e canto nell’azione liturgica. Lettera alle Scholae, alle CoraliParrocchiali, agli Operatori musicali della Diocesi, in “Rivista della Diocesi”,83(1994), pp. 953-967.
CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 30 e113; e specialmenteSACRA CONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 16.
Principi e norme per l’uso del Messale Romano, 63.
CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 29.
SACRACONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 19, 24.
SACRA CONGEGAZIONE DEI RITI E “CONSILIUM”, Musicam Sacram, 23.
P. MAGNANI, Musica e canto nell’azione liturgica. Lettera alle Scholae, alle CoraliParrocchiali, agli Operatori musicali della Diocesi, in “Rivista della Diocesi”,83(1994), pp. 953-967.
Introduzione al Lezionario domenicale e festivo, 55 e 56.CURIA DIOCESANA BRESCIA
UFFICIO LITURGICOCanto e musica
nella celebrazione del matrimonio29
Nell’intento di promuovere uno stile liturgico che rispetti evalorizzi il ruolo del canto e della musica nelle celebrazioni delMatrimonio, l’Ufficio liturgico offre alcune indicazioni su questoargomento importante e delicato.
1. Il canto e la musica sono elementi rituali che fanno tutt’unocon la celebrazione liturgica, la servono e la integrano. Hanno loscopo di manifestare l’aspetto ecclesiale della celebrazionestessa” (Musica Sacram 42). Limitarsi a farne solo una specie dicolonna sonora significa tradire un’esigenza liturgicafondamentale.2. Anche la celebrazione del matrimonio è una celebrazioneecclesiale nel senso che manifesta la Chiesa, radunandola erendendola sempre più sacramento del Cristo risorto. Non èun’azione privata degli sposi. Gli sposi vi entrano come ministriper rivelare il rapporto sponsale tra Cristo e la Chiesaattraverso la loro reciproca donazione così che nel loro gestotutti i presenti lo possano riconoscere e per esso diano lode alSignore.3. Gli sposi, perciò, siano adeguatamente preparati allacelebrazione liturgica del sacramento. Collaboreranno affinché conla loro presenza, i loro gesti e le loro parole si manifesti il“mistero grande” (Ef 5,32) che si compie in essi e nell’assembleaconvocata. Non si dimentichino che è l’immagine di Cristo e della Chiesaintimamente uniti che deve trasparire dalla celebrazione delmatrimonio.4. Grande importanza assume la scelta dei canti e della musica: deve servire afavorire l’intima unione tra tutti i partecipanti. I canti nella sceltasiano riconosciuti per questa loro funzione ministeriale (SC 112). Nonservano solo ad abbellire la celebrazione, ma soprattutto a crearee ad esprimere la comunione tra i presenti. A questo scopo saràopportuno fare molta attenzione al testo, alla forma musicale, achi li deve eseguire o ascoltare, al gesto rituale che accompagnanoo che interpretano.5. Si raccomanda di dare la priorità assoluta al canto dell’assemblea presente.Pur tenendo conto della sua atipica composizione spessoproblematica dal punto di vista della “partecipazione attiva,cosciente e responsabile” alla liturgia, si faccia in modo digarantire almeno i canti rituali essenziali cioè il ritornello del Salmo responsoriale(da non sostituite in ogni caso con una canzone che non rispettiil senso e l’atteggiamento interiore che il Salmo esprime), l’Alleluiaal Vangelo, il Santo e le successive acclamazioni (Mistero della fede,
30
l’Amen della dossologia) e infine il canto allo spezzare del pane,Agnello di Dio (da non sostituire con un canto sulla pace che non èprevisto sul rituale e rischia di far passare in secondo piano ilgesto importante dello spezzare il pane).Qualora si decidesse di cantare il Padre nostro, si abbia cura discegliere una melodia che rispetti l’integrità e la santità di questapreghiera. Non è lecito sostituirla con delle parafrasi o deirifacimenti arbitrari, spesso anche di pessimo gusto letterario,come quella usata sulle note della famosa canzone “Sound ofsilence” di P. Simon.Per gli aliti momenti o riti in cui è previsto il canto, ossiainizio, inno di lode, presentazione dei doni, comunione, nulla vieta chea cantare sia un piccolo coro, non il solista.6. Per questi momenti si abbia cura di scegliere dei testi conchiaro contenuto teologico e adatti al momento rituale specifico. Si evitinorigorosamente quei canti che appartengono al repertoriocanzonettistico dei festivals, dei films, dei concerti pop o dellamusica lirica che non sono in alcun modo legati all’azioneliturgica che si sta compiendo.7. Qualora in questi momenti la musica fosse limitata al suonodell’organo, si abbia cura di affidare l’incarico a un organistacapace di interpretare non solo i brani musicali, ma anche ilmomento e il mistero che si celebra.8. In questa prospettiva non sono adatte e non più proponibili le tradizionalimarce nuziali, consunte dall’uso cinematografico e pubblicitario, chespesso accompagnano l’ingresso degli sposi. Sono segnali che,posti all’inizio, sviano dal giusto motivo della convocazione edel raduno, che in ogni caso è la celebrazione del Dio che salva.Piuttosto di aprire lo spirito dei presenti a riconoscere e adaccogliere il mistero e la novità di Dio che si rivela e si donaattraverso gli sposi, rischiano di chiuderlo o di orientarloaltrove. È importante, invece, che anche le prime note musicaliaiutino gli invitati a mettersi alla presenza di Dio e aprepararsi alla lode e alla benedizione.Per lo stesso motivo sono da evitare durante la presentazione deidoni o durante la comunione brani operistici, colonne sonore difilms, arie o lied, nati come canti solistici in particolaricontesti culturali, con, intenti diversi da quelli necessari pervivere questi due momenti liturgici. E necessario prestareattenzione non solo al piacere musicale di un brano, ma anche alsuo contenuto e al ruolo specifico che deve svolgere nellaliturgia.
31
Si è già ricordato che durante la preghiera eucaristica non si suona, per noncoprire la voce del presidente, ma soprattutto per rispettare ilcarattere comunitario dì questa azione che, pur essendo compiutaprevalentemente dal presidente, in realtà richiede il massimo dìpartecipazione da parte dei presenti, espressa con laproclamazione del mistero della fede e con l’Amen della dossologiafinale.9. In linea con la semplicità e la sobrietà che devonocaratterizzare le celebrazioni cristiane e a vantaggio della loroverità e coerenza, si scelgano anche per il canto e la musicaforme espressive adeguate, che rispecchiano la realtàdell’assemblea e non le proprie possibilità economiche. Lacelebrazione del matrimonio non è luogo né di esibizione né di concerto.Tantomeno deve apparire come una fonte di guadagno per chi famusica o canta per mestiere. Sarebbe in contraddizione con lagratuità di Dio che si sta celebrando. Chi vi partecipa deve farloprima di tutto per fede. Starà, semmai, alla discrezione e allasensibilità degli sposi ringraziare con qualche segno diriconoscimento quanti hanno reso disponibile la loroprofessionalità per la riuscita della celebrazione.10. Annotazioni su alcune musiche non liturgiche. Non sono da eseguire leseguenti melodie per i motivi di seguito espressi:- Ave Maria di Schubert: ispirata ad un’opera di W,. Scott narrantela fuga di due giovani innamorati che, prima di iniziare la loroconvivenza, invocano la Madonna.- Ave Maria dì Gormod: è la rielaborazione di un preludio di J. S.Bach sfruttato da un editore con l’adattamento del testo all’AveMaria.- Sogno di Schumann: questa suonata, prettamente strumentale, èmusica da camera.I brani che seguono sono tratti da opere teatrali con un contestoben preciso, per cui non possono essere eseguiti come musicaliturgica:- Vergine degli angeli di Verdi, tratta da “La forza del destino”- Largo di Haendel, tratto dall’opera “Serse” e rievoca gli amorigiovanili del re persiano.- Marcia nuziale di Wagner; tratto dal dramma lirico “Lohengrin”. È ilcommento musicale all’ingresso di Elsa Lohengrin nel lettonuziale.- Ave Maria tratta dall’ “Otello” di Verdi.
È opportuno ricordare sempre che la liturgia non è un semplicecontenitore di canti e di preghiere pensando che l’accontentare i
32
gusti e le abitudini giustifichi qualsiasi canto. Nella liturgiasi canta e si racconta la vita di Dio e le sue opere. Solo inquesta prospettiva, anche nella celebrazione del matrimonio, sipotrà esperimentare quanto sia accattivante e attualel’affermazione n. 6 di Musicam Sacram: «Non c’è niente di piùsolenne e di più festoso nelle sacre celebrazioni di una Assembleache, tutta, esprime con il canto, la sua pietà e la sua fede».
33