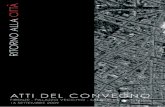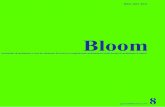E. GIORGI, P. BUZI, Bakchias (a cura di), Bakchias. Dall’Archeologia alla storia, Bologna 2014
Transcript of E. GIORGI, P. BUZI, Bakchias (a cura di), Bakchias. Dall’Archeologia alla storia, Bologna 2014
BakchiasDall’Archeologia alla Storia
a cura diEnrico Giorgi, Paola Buzi
prefazione diSergio Pernigotti
Bononia University Press
Archeologia2_Bakchias.indd 3 06/06/14 08.12
Bononia University PressVia Farini 37, 40124 Bolognatel. (+39) 051 232 882fax (+39) 051 221 019
© 2014 Bononia University Press
ISSN 2284-3523ISBN 978-88-7395-896-3
Progetto grafico: Irene SartiniImpaginazione: DoppioClickArt - San Lazzaro (BO)
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
Stampa: Editografica -Rastignano (BO)
Prima edizione: giugno 2014
Archeologia2_Bakchias.indd 4 06/06/14 08.12
Sommario
Presentazione 1Giuseppe Sassatelli
Premessa Per un’archeologia della visione. Note sul viaggio in Egitto di Flaubert e Du Camp 3Ettore Janulardo
Prefazione 9Sergio Pernigotti
Introduzione 11Enrico Giorgi, Paola Buzi
Prima parteStoria di Bakchias:la religione, lo sviluppo urbano, le fonti papirologiche, l’ambiente geografico 15
1. Per una storia di Bakchias 17Sergio Pernigotti
2. Il mondo religioso di Bakchias 39Sergio Pernigotti
3. La genesi e lo sviluppo urbano 53Enrico Giorgi
4. Fayyum tardo-antico e Bakchias cristiana 69Paola Buzi
5. Il contributo dei papiri 81Silvia Strassi
6. Esperienze di geomatica a Bakchias 93Gabriele Bitelli, Emanuele Mandanici, Luca Vittuari
Seconda parteArcheologia di Bakchias: la topografia urbana, gli edifici, la cultura materiale 107
1. Le aree templari di Bakchias 109Ilaria Rossetti
Archeologia2_Bakchias.indd 5 06/06/14 08.12
2. Il quartiere settentrionale 155Enrico Giorgi
3. Gli edifici lungo il canale e il Kom sud 165Enrico Giorgi
4. Il settore cristiano 179Paola Buzi
5. La decorazione architettonica del settore cristiano 213Mariangela Tocci
6. I materali ceramici e vitrei di Bakchias 243Valentina Gasperini
7. La schedatura degli edifici di Bakchias 323Ilaria Rossetti
Tavole 361
Bibliografia 409
Archeologia2_Bakchias.indd 6 06/06/14 08.12
L’area archeologica di Kom Umm el-Athl, che racchiude i resti del villaggio tolemaico-romano di Bakchias, si trova nel settore nord-orientale del Fayyum (nel markaz di Tamiyya), a metà strada circa tra Kom Aushîm e Darb Gerza, rispettivamente corrispondenti agli antichi centri di Karanis e di Philadelphia1.
La distanza tra Kom Aushîm e Kom Umm el-Athl è poco meno di 12 km, misura che sostanzial-mente corrisponde all’interessante dato fornitoci da un documento papiraceo (P.Michigan VIII 496) consistente in una lettera con la quale un abitante di Karanis invita un residente di Bakchias, preci-sando che il viaggio non sarebbe durato più di due ore, evidentemente a dorso d’asino o navigando lungo il canale2.
La strada che collega ancora oggi questi siti costeggia il canale di Abdallah Wahbi, la cui deno-minazione appare già nella cartografia egiziana del 1945 (in scala 1:25.000). Questo corso d’acqua inizia poco dopo Illahun, dove si distacca da un ramo del Bahr Youssef, l’affluente del Nilo che alimenta l’intera regione, e va infine a gettarsi nel Birket Qarun, il grande lago posto sul confine set-tentrionale. Si tratta di uno dei canali principali che delimitano la depressione fayyumica e dunque il terreno coltivato, anche se oggi la vegetazione è in rapida espansione e conquista continuamen-te spazio al deserto3. Nonostante l’efficace impegno sinora messo in campo dalle autorità egiziane per la tutela del sito, il progressivo avanzamento dell’area agricola rappresenta un problema per la conservazione dei resti archeologici. L’aumento di umidità di risalita, infatti, risulta essere estrema-
1 Per chi giunga al Fayyum provenendo dal Cairo, il sito si raggiunge abbandonando la strada principale al primo bivio posto poco oltre il Museo di Karanis e imboccando la prima strada a sinistra, 100 m circa più avanti.
2 Pernigotti 2000, pp. 61-62, con bibliografia. La distanza tra i due siti non può essere troppo variata nel corso del tempo per considerazioni di carattere storico-geografico. Infatti, dato che il canale antico era sostanzialmente simile a quello moderno (quando non coincidente era comunque vicino e parallelo), non sono intervenuti cambiamenti tali nella topografia dei luoghi da giustificare una variazione sostanziale del percorso (Morini 2006a; Mandanici 2007).
3 È da questo corso d’acqua che si dipartono numerosi altri canali secondari, alimentati da macchine idrauliche o dal naturale digradare del terreno, che formano l’ossatura del sistema d’irrigazione di questa parte della regione, integrato ora da altre opere connesse con la bonifica.
INTRODUZIONE Enrico GiorgiPaola Buzi
Archeologia2_Bakchias.indd 11 06/06/14 08.12
12 Enrico Giorgi, Paola Buzi
mente deleterio per la conservazione di strutture in argilla cruda, ossia per la maggior parte dei resti dell’antico villaggio4.
All’altezza dell’attuale abitato di Gorein si trova un ponticello che scavalca il canale e collega la strada sterrata che parte da Kom Aushîm con il settore nord del villaggio moderno e quindi con l’area archeologica5.
L’antica Bakchias, dunque, sorgeva ai margini della regione, sul ciglio dell’altopiano che delimita la depressione.
Da quando Petrie e i papirologi inglesi Grenfell, Hogarth e Hunt esplorarono Kom Umm el-Athl, la comprensione dell’insediamento urbano di Bakchias ha fatto enormi progressi, soprattutto grazie al lavoro sistematico condotto dagli archeologi italiani, che nell’indagine di quest’area sono impegnati da oltre vent’anni6.
In questa sede, tuttavia, si intende illustrare le conoscenze acquisite soprattutto negli ultimi anni, da quando nel 2005 le ricerche sono condotte dal Dipartimento di Archeologia – ora Dipartimento di Storia Culture Civiltà – dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento di Storia Culture Religioni della Sapienza Università di Roma, e il supporto del Centro Papirologico Medea Norsa di Trieste.
Dall’autunno del 2009, in particolare, le ricerche si svolgono sotto la direzione dei curatori di que-sto volume, anche se lo storico direttore della missione, Sergio Pernigotti, ne è tuttora parte attiva. Per la fiducia sempre accordataci non possiamo che esprimergli profonda gratitudine e questo lavoro vuole essere anche un modo per ripagarla.
Inoltre vogliamo ricordare che il progetto di ricerca in atto a Bakchias non avrebbe potuto trovare continuità e questo volume non avrebbe potuto essere realizzato senza l’accordo del Supreme Council of Antiquities of Egypt e senza il supporto assicurato dal Ministero per gli Affari Esteri della Repubbli-ca italiana e dall’Ateneo di Bologna. In particolare desideriamo ringraziare Mohamed Ismail Khaled, Ettore Janulardo e Giuseppe Sassatelli per l’attenzione che ci hanno sempre riservato ed Elisabetta Govi per il suo impegno negli ultimi anni.
Il presente volume è stato concepito principalmente allo scopo di informare i colleghi del lavoro di rivalutazione dei dati acquisiti – attraverso lo studio delle fonti e l’indagine archeologica – in atto da qualche anno.
Del resto, da un lato la diminuzione delle risorse economiche e dall’altro le oggettive difficoltà a condurre le ricerche sul campo in questo periodo di forte instabilità politica hanno incentivato lo stu-dio e la riflessione su quanto finora noto, anche attraverso il confronto con altre missioni che operano nella regione. È questo lo spirito con cui è stata concepita la tavola rotonda organizzata all’Università di Bologna il 25 maggio 2012, a cui hanno partecipato molti colleghi e che è servita a condividere di-versi interessanti problematiche di ricerca7.
Occorre tuttavia sottolineare che quella di puntare su un’ampia e sistematica rivalutazione del sito è stata una scelta consapevole, certo favorita (o condizionata) dalle sopracitate circostanze, ma comun-
4 Mandanici 2011; Id. 2012; Buzi, Giorgi, Gasperini, Mandanici 2011.5 Questo ponte è certamente il rifacimento di uno precedente chiamato Kubri Umm el-Athl (ponte di Umm el-Athl)
nella già citata cartografia storica egiziana. Sul suo spigolo nord è indicata la quota di 14,17 m s.l.m..6 Per le varie fasi della storia delle ricerche a Bakchias si rimanda al contributo seguente di Sergio Pernigotti.7 Oltre agli autori di questo volume hanno partecipato, tra gli altri, anche Willeke Wendrick, direttore della missione
dell’University of California (Los Angeles) a Karanis, ed Emanuele Papi, direttore della missione dell’Università di Siena a Dionysias. Inoltre erano presenti anche Antonio Curci, codirettore della missione congiunta dell’Università di Bologna e della Yale University sul territorio tra Assuan e Kom Ombo; Gianluca Miniaci, membro della missione dell’Università di Pisa a Luxor; Giuseppe Lepore, già membro della missione congiunta delle Università di Bologna e Lecce a Soknopaiou Nesos.
Archeologia2_Bakchias.indd 12 06/06/14 08.12
Introduzione 13
que da tempo auspicata. Ci sembra infatti di poter dire che, dopo la stagione dei “grandi progetti”, improntati soprattutto all’acquisizione di nuovi dati e alla puntuale presentazione preliminare delle ricerche in corso, sia ora necessario investire le risorse migliori nella presentazione alla comunità scien-tifica dei risultati conseguiti, senza nascondere le criticità e gli obiettivi non ancora raggiunti.
Questa scelta ci sembra fondamentale anche in funzione della pianificazione e dell’impostazione di progetti futuri.
Ricerche pluriennali, come quelle condotte a Bakchias, comportano il cambiamento non solo delle circostanze in cui si opera, ma anche delle persone che compongono il gruppo di lavoro. Abbiamo de-ciso di affrontare questo momento di sintesi con gli attuali componenti del team impegnato sul campo, senza per questo voler dimenticare il contributo fondamentale di tutti coloro che ci hanno preceduto o che ci hanno affiancato lungo il percorso, ai quali dobbiamo profonda gratitudine8.
Dal punto di vista editoriale il volume è articolato in due sezioni. La prima parte contiene contributi di sintesi, utili per cercare di tracciare la parabola storica del sito, mentre la seconda presenta i dati archeologici alla base di tale ricostruzione. Questa seconda sezione è improntata su base topografica, analizzando via via le singole aree di scavo, ed è seguita da due cataloghi di materiali, rispettivamente dedicati alla decorazione lapidea delle chiese e ai rinvenimenti ceramici.
Si tratta di contributi che – lo si ribadisce – tengono conto soprattutto delle scoperte più recenti, senza tuttavia trascurare quanto è già stato edito.
La presentazione dei vari contesti è di norma volutamente piuttosto essenziale. Le precedenti rela-zioni preliminari e alcune pubblicazioni di più ampio respiro, del resto, ci hanno consentito di com-piere un lavoro di sintesi, rimandando alla bibliografia precedente per una trattazione più analitica9.
Nell’ambito dei contributi archeologici si è deciso di dare ampio spazio agli studi condotti da al-cune giovani ricercatrici che negli ultimi tempi si sono concentrate su tematiche complesse, come la successione delle aree sacre nella città antica o la cultura materiale. Si tratta, infatti, di ricerche fiorite e di opportunità rese possibili proprio grazie al progetto di Bakchias.
La sezione archeologica si conclude con la schedatura dell’area urbana, grazie alla quale si porta a compimento un vecchio lavoro, mai pubblicato, che mira a proporre una sintesi topografica del sito, che permetta di percepire contemporaneamente la coerenza planimetrica di alcuni blocchi urbani, nel loro sviluppo diacronico, e il tipo di materiale edilizio utilizzato.
È doveroso fare un’ultima annotazione sull’esclusione da questo volume di alcune classi di materia-li: la pubblicazione di monografie – come quelle dedicate alle paste vitree e ai materiali lignei, alle scul-ture e agli amuleti – o di ampi articoli – come quelli sulle monete10 – ci ha convinti dell’opportunità di non ripeterci, così da rendere il volume esaustivo ma quanto più agile possibile.
8 Oltre a tanti altri amici e colleghi, vogliamo in particolare citare – per il periodo che qui più ci riguarda (dal 2005) – Cristian Tassinari (field director) e Anna Morini (responsabile del laboratorio materiali), entrambi autori di alcuni studi assai utili per la comprensione del sito. Ricordiamo inoltre Marco Zecchi (responsabile della Winter School), Federica Boschi, Alessandro Campedelli, Kevin Ferrari, Carlotta Franceschelli, Paola Fuselli, Chiara Gioia, Susanna Lena, Micol Mambelli, Diletta Minutoli, Ada Nifosì, Giovanna Paolucci, Barbara Rizzo, Silvia Vinci (responsabile di settore) e tutti i partecipanti alle varie edizioni della Winter School. Ringraziamo, inoltre, gli ispettori Maghed Abd el-Hameed Abd el-Aal, Nahla Mohamed Ahmed Hassan, Mohamed Hamed Mohamed Ahmed, Mohamed Hamed Gabr Salama Nureddin.
9 Per le relazioni preliminari si vedano Tassinari 2006a; Buzi, Tassinari 2007; Giorgi 2007; Id. 2009; Id. 2011c; Id. 2011a; oltre ai vari contributi apparsi nella serie Ricerche italiane e Scavi in Egitto (RISE), edita dapprima a cura di Ma-ria Casini e poi di Rosanna Pirelli. Per le edizioni definitive si vedano Rossetti 2008; Tassinari 2009, Giorgi 2012.
10 Parente 2004; Id.2008; Pernigotti 2008; Gasperini, Paolucci, Tocci 2008; Nifosì 2009.
Archeologia2_Bakchias.indd 13 06/06/14 08.12
PRIMA PARTEStoria di Bakchias: la religione, lo sviluppo urbano,le »ÄÃɾ�ŶžÇÄÁļ¾¸½º��Áĩ¶Â·¾ºÃɺ�¼ºÄ¼Ç¶IJ¸Ä
Archeologia2_Bakchias.indd 15 06/06/14 08.12
SECONDA PARTE�Ǹ½ºÄÁļ¾¶�¹¾��¶À¸½¾¶È��Á¶�ÉÄÅļǶIJ¶�ÊÇ·¶Ã¶�¼Á¾�º¹¾IJ¸¾��Á¶�¸ÊÁÉÊǶ�¶ɺǾ¶Áº
Archeologia2_Bakchias.indd 107 06/06/14 08.12