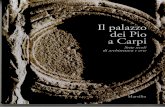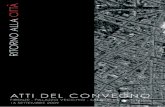Val di Vara: elementi per lo studio archeologico, dalla preistoria alla romanizzazione
Dalla Grosstadt alla metropoli diffusa
Transcript of Dalla Grosstadt alla metropoli diffusa
DALLA GROßTADT ALLA ‘METROPOLI DIFFUSA’ Renato Capozzi
Il presente scritto muove da una tesi di fondo: ogni idea di città premette un’idea di architettura e viceversa.
Se pensiamo, infatti, al famoso schizzo in cui Le Corbusier dispone architetture diverse - una cattedrale, un tempio, una basilica ed una casa (Villa Savoye) in differenti condizioni morfologiche e posizionali - questo assunto diviene esplicito: è l’architettura a ‘fondare’ i luoghi ed a determinare il loro carattere specifico. Il ragionamento qui proposto si articola didascalicamente in alcuni punti logicamente interrelati che a partire dall’analisi critica della condizione urbana attuale e delle sua complessa genealogia provano infine a proporre una alternativa plausibile e auspicabilmente perseguibile.
Idea di città
Parlare di ‘idea di città’ significa in definitiva parlare di ‘forma’ dell’insediamento, di ordine complessivo della costruzione urbana. In altri termini significa mettere in questione e riflettere sulla struttura d’ordine soggiacente, sulla nozione di impianto, di tessuto, di elementi eccezionali e ricorrenti, sul tema della configurazione generale della città, della sua finitezza/misura/in-finitezza. L’idea di città, quando è perseguita ed esposta con chiarezza, è sempre una risposta razionale al problema dell’informe, del caotico, dell’indistinto, dell’inconoscibile ed incommensurabile attraverso alcuni principî descrivibili che ne definiscono i caratteri di generalità ed intelligibilità. Le idee di città compiutamente fondate sono poche ma le loro applicabilità e declinazioni sono estremamente varie. Nella relazione specifica con i luoghi, con le “inerzie del reale”, ogni idea di città, per quanto ‘apollineamente’, compiuta ritrova ogni volta una sua individualità efficiente nella dialettica con la realtà fisica immanente ed i condizionamenti di luoghi che ogni volta costruisce. In ogni caso la città e le idee (eidos) che la sottendendono rimangono la “costruzione umana per eccellenza” (Lévi-Strauss, 1958) ed in definitiva la più complessa e densa di valore.
La città giardino e la Großtadt
Il problema della crescita incipiente della città industriale a cavallo tra il XIX e il XX secolo divenne il ‘problema d’elezione’ cui furono attese le migliori riflessioni della cultura architettonica europea. Alla città dell’Ottocento (Stübben-Baumaister-Sitte) che oramai saturava i suoi asfittici isolati fino al punto di diventare un’unica grande ed indistinta “città di pietra e di caserme d’affitto” (Hegemann, 1930) e della rendita di posizione (Bernoulli, 1951) la riflessione ‘moderna’ oppone sostanzialmente due grandi modelli alternativi: la città giardino (città natura) e la Großtadt (città ideale). Le due idee poi sono, nei fatti e nelle esperienze concrete, due risposte complementari alla saturazione e omologazione della città ottocentesca ma con conseguenze ‘assolutamente divergenti’. La città giardino in qualche modo rappresenta un’alternativa alla città di pietra – da cui però dipende in termini di relazioni funzionali ed economiche – nel tentativo di opporre alla città compatta e ‘chiusa’ una città ‘aperta’ al territorio in un rinnovato rapporto con la natura e la campagna. Uno dei suoi limiti sta proprio nella precisa rinuncia ad una compiutezza formale e quindi ad un principio di limite (peras) essendo anch’essa - come è facile riscontrare nella città americana - in un certo modo potenzialmente estensibile ad infinitum. La Großtadt d’altro canto è, prima di tutto, un tentativo generoso ma anche utopico di ricomporre, di riorganizzare e riordinare la città compatta esistente a partire da alcuni principî: il controllo della densità e il rapporto tra il tipo edilizio e la morfologia urbana. La Großtadt a partire dalle riflessioni di Karl Scheffler nel suo Die Architektur der Grosstadt (Scheffler, 1913) che in realtà lavora sulla espansione della città consolidata, trova una sua prima chiara impostazione metodologica in Ludwig Hilberseimer, la cui ricerca, in questo ragionamento, verrà assunta come paradigma per orientare la comprensione del passaggio tra la grande città moderna e la metropoli diffusa di questi anni.
La Großtadt di Hilberseimer
Hilberseimer è il primo che propone una vera e propria teoria della grande città: un “sistema ordinato di proposizioni” (Grassi, 1967) trasmissibili. Il suo lavoro avrà degli sviluppi assolutamente consistenti con le trasformazioni della città contemporanea e si articola in due momenti principali: il primo inerente la Großtadt, che è a ben vedere è una riflessione sulla città di Berlino; il secondo, coincidente con la sua stagione americana, che si appunta sul rapporto tra territorio geografico ed insediamento urbano, sulla questione della dimensione estensiva alla grande scala, sul riequilibrio tra città e campagna e sulla relazione tra insediamento umano e natura. La Großtadt di Hilberseimer nelle sue parole «non può essere considerata come un organismo indipendente ma è indissolubilmente legata al popolo che l’ha creata. La grande città non rappresenta solo un mutamento di
39
dimensione della città essa si distingue per la dimensione ma anche per la sua natura ». I due testi di riferimento (Hilberseimer, 1925-1927) che descrivono compiutamente le posizioni di Hilberseimer sono Grosstadtbauten (Architetture per la grande città) e Großstadt Architektur (Architettura della grande città): entrambi - come ha chiarito Gianugo Polesello - sono «due punti di vista architettonici sulla città moderna». Il primo scritto ha un carattere più architettonico e compositivo, il secondo tende al manuale ed è però significativo che ‘nestorianamente’ il primo e l’ultimo capitolo dei due saggi – “Architettura”/ “Grande città” - siano pressoché identici. In Grosstadtbauten gli esempi sono progetti dello stesso Hileberseimer, in Großtadt Architektur i riferimenti si allargano ad altri autori in una sorta di campionatura. In quest’ultimo scritto Hilberseimer, dopo una critica alla città per tre milioni di abitanti di Le Corbusier (poi Ville Radieuse) propone una idea di città fortemente determinata dal suo impianto (e dai problemi del traffico) in una circolarità tra piano/densità/tipo edilizio/forma della città (Grassi, 1967) che negli approfondimenti tipologici e morfologici rimanda all’assunto albertiano: «... e se è vero il detto dei filosofi, che la città è come una grande casa, e la casa a sua volta una piccola città, non si avrà torto sostenendo che le membra di una casa sono a sua volta piccole abitazioni (...)». L’idea di città di Hilberseimer è una risposta ‘strutturale’ al fenomeno dell’Urbanesimo che non rinuncia ad un suo centro, a proporre un ordine riconoscibile attraverso tipi edilizi, elementi primari, e riconoscibilità formale delle parti. Questa ‘città verticale’ - come ha lucidamente rilevato Aldo Rossi - in sostanza premette l’analisi e la comprensione della natura essenziale della ‘città della storia’, non rinuncia ai caratteri distintivi della città compatta (isolati/strade/luoghi centrali) ma li sottomette ad un principio generale omnipervasivo trovando nella ripetizione di alcuni elementi la sua ragione costituitiva in cui «la necessità di plasmare grandi masse eterogenee secondo una legge generale dominando la molteplicità» divine l’obiettivo prioritario. Ma non si deve pensare a questo modello di città solo come un’ipotesi astratta ed utopica, in quanto ritrova i suoi ‘antecedenti conoscitivi architettonici’ nei progetti di Mies (Alexander Platz, Friedrihstrasse), dello stesso Hilberseimer (per l’Unter der Linden e per l’Università di Berlino) e nel progetto per la Città resideziale (Trabatensiedlung) in cui - qui su un piano veramente astratto - si definiscono con grande chiarezza: l’ordine generale, l’impianto, l’unità ripetibile ma soprattutto le architetture in un rapporto di coerenza lineare tra il manufatto e la struttura urbana. Questa idea di città, con tutti i suoi limiti, non si è realizzata se non nel Cinema (Metropolis di Fritz Lang, 1927) o come sfondo in alcuni disegni (La città analoga di Arduino Cantafora, 1973). Essa mantiene il suo forte legame con la città antica in una sua ‘razionabilità’ molto evidente nel collage per il progetto di isolati nel Gendarmenmarkt a Berlino, o nel contro canto ‘radicale’ del Plan Voisin o dell’Ilot 6 di Le Corbusier a Parigi.
Il passaggio tra la grande città e la metropoli
Il passaggio tra la grande città (ancora definibile) e la metropoli (smisurata e inconoscibile) è analogo a quello filosofico tra la condizione ‘moderna’ e quella ‘post moderna’: persi i Grand récit (Lyotard, 1979) della tradizione, la metropoli programmaticamente rinuncia ad un ordine (cósmos) e persegue il disordine (cáos) come unico dispositivo riproducibile. La città europea - nella teoresi di Cacciari (Cacciari, 2004) - da pólis diviene urbs o meglio civitas augescens (sine ullo limite): la pólis si basava sul ghénos, sulla comunità ed aveva in sé l’idea di péras, di ‘limite/confine’, di nomos inteso come ‘norma’, la urbs come ciò che è definito dalle sue leggi amministrative contiene invece la possibilità di una crescita infinita (a-péiron), essa de-lira, esce cioè dal solco, dalla lira - dal recinto che delimitava la città - che in corrispondenza delle porte segnala la ‘soglia’ sacrale. Maurizio Ferraris a conforto di tale interpretazione afferma che «l’estetica postmoderna è [appunto] un’estetica della metropoli» (Ferraris, 1983). In qualche modo le ‘moderne’ costruzioni filosofiche (Heidegger - Benjamin - Weber) ma anche quelle letterarie (Bodelaire - Proust - Balzac) restano legate all’idea di pólis in cui era chiaro il rapporto tra ‘interno artificiale’ ed ‘esterno natura’ circostante. La città-pólis (cultura) - per Ferraris - è oppositiva alla natura (chora) che la circonda e la delimita, essa è un luogo circoscritto, definito e riconoscibile “artificio isolato” in un territorio naturale, di contro «nella tarda modernità la metropoli non è semplicemente un’estensione della città più grande e tecnologizzata. La metropoli non si oppone ad un esterno naturale – luogo dell’Essere contrapposto alla Cultura - abolisce radicalmente ogni riferimento alla Natura [si pensi all’Illuminismo] ogni riferimento all’origine [al ‘fondato/fondamento’ al Grund], dichiara il trionfo della Cultura, degli enti, delle tecnologie [intese] come ‘volontà di potenza’ […] si riferisce [- nell’oblio dell’Essere -] semplicemente a se stessa è causa sui e index sui, è spazio omnicomprensivo e sconfinato privo di intervalli» (Ferraris, 1983). La metropoli/megalopoli – pur derivando da mèter-pólis - non ha più il senso di città ‘generata’ da una città madre, da una altrice, è slegata dai caratteri specifici dei territori che invade e come in Heidegger è un ‘costruire’ senza un ‘abitare’ e quindi senza un ‘pensare’. La metropoli, abilmente descritta da Derrida (Ferraris, 2010) e da Deleuze, comunica e si connette – ma mai si relaziona – con altre metropoli che prima o poi toccherà nella sua ‘crescita agglutinante’. Come aggiunge ancora Ferraris: «è difficile cogliere la complessità della cultura [se non è diventata già la Halbbildung (Adorno, 1959)] quando è scomparsa la natura come referente altro » (Ferraris, 1983) la città così si riduce all’evento, alla performance.
40
La ‘metropoli diffusa’ Nella metropoli diffusa (leggi dispersa) si ‘scioglie’ il necessario rapporto tra residenza / lavoro / luoghi civili
(alla base di una qualità urbana accettabile) e si ‘installa’ quello tra ‘residenza’ individuale (i villini) o collettiva (condomini) e ‘consumo’ (ipermercati / shopping mall). Oggi la metropoli globalizzata smarrisce i suoi luoghi identitari e si costruisce come un insieme di ‘recinti impermeabili’, tende sempre più all’omologazione livellante dei sui modi di costruzione diluendo e smarrendo i centri di rappresentazione pubblici e collettivi in una ‘nebulotica’ dispersione di spazî privati (Monestiroli, 1994) che si auto-riproducono a tutte le latitudini sempre uguali a se stessi: in ogni suo punto è periferia, dislocazione rispetto a centri inesistenti o virtuali, diviene pervasivamente un ‘non-luogo’ (Augè, 1992). La non-città dei nostri anni si reifica in un deposito confuso di individualismi, congestione, consumo indiscriminato del suolo, invidia del centro (Stellario d’Angiolini, 2004) e ricerca dell’in-forme (Valéry, 1938). La ‘città diffusa’ è un’espressione che tende all’ineffettuale descrizione, alla‘constatazione’ di uno status quo (Gregotti, 2008) che «in nulla aiuta ad individuare strumenti, modi, metodi di controllo né tantomeno di sviluppo» (Stellario d’Angiolini, 2004). È l’ipostasi della ‘ripetizione pura’ che rinuncia alla “differenza critica” tra essere ed ente e diviene una mera ‘rappresentazione’, un’estetica del simulacro e delle de-territorializzazione, che non ha più origine né tanto meno fine: tutto ‘diviene’ incessantemente. La dispersione, la deflagrazione delle megalopoli contemporanee – si pensi a quelle dell’estremo oriente – determinano condizioni urbane e di vita basate sull’esperienza ‘distratta’ del movimento, del grande e dello smisurato: una post-città ‘nomade’ ed ‘errante’ dove «nulla merita di essere ‘rammemorato’» ma solo ‘consumato’ in fretta sino allo Junkspace di cui parla festosamente Koolhaas. È lo spazio infinito dello sprawl, della disseminazione, dove non vi è niente in cui potersi riconoscere e rappresentare. Non è certo quella ‘città diffusa urbano-rurale” di cui parla Agostino Renna nel suo testo L’illusione e i cristalli, che aveva ancora un rapporto essenziale e primario con la ‘terra’, con il disegno del suolo, con i suoi segni, con le sue regole, con il suo uso sapiente e ordinato sfruttamento, ma è solo continuum indifferenziato dell’esperienza sensibile dell’inedito, dello stravagante, dell’aggressione sensoriale obnubilante senza materialità dove tutto tracima nella virtualità (Maldonado, 1992). Questo grande e ‘cangiante simulacro’ è puro ‘evento’, installazione provvisoria, dove il nichilismo disumanizzante si afferma nel prevalere dell’individuo (mònade) sulla comunità. Per superare e risolvere tale condizione de-realizzata non bastano le risposte ‘deboli’ di un Baudrillard (1980) o di un Vattimo (Vattimo – Rovatti, 1987) riecheggianti la “gaia erranza” di cui parlava Tafuri (1987): un vagare tra grandi outlet nel più assoluto disorientamento fisico e psicologico.
Un’alternativa possibile
Cosa opporre a questa “perdita di forma” (Calvino, 1975), di fondamento, a tale delirio / metastasi, che sta erodendo e consumando il territorio confondendone i caratteri, le identità specifiche, rinunciando ad ogni possibile riformulazione e razionalizzazione? Anche nell’inabilità contemporanea a definire una forma urbis compiuta e definitiva si possono però individuare alcuni ‘frammenti’ che alludano ad un ‘ordine possibile’. Come affermava Le Corbusier compito dell’architettura diviene sempre più quello di “ordinare l’esistente” anche se questo meccanismo pervasivo di costruzione forse è proprio da ascrivere alla acritica riproduzione del dispositivo domino che assunto come “mera res” (mero fatto tecnico) ha reso possibile - sotto l’egida della speculazione immobiliare da Real Estate ma anche dell’autocostruzione - l’attuale moltiplicazione dell’identico. Il grande sforzo rifondativo del Movimento Moderno - come sottolinea Monestiroli nel saggio “L’arte di costruire la città” (Monestiroli, 1994) - rimane un ‘progetto incompiuto’ (Habermas, 1980) e proprio all’interno dei suoi sviluppi è necessario ritrovare un ‘origine’, un nuovo auspicabile ‘inizio’ (arché) da cui poter ripartire (Cacciari, 1990). Penso all’esperienza americana di Hilberseimer e di Mies nel Lafayette Park a Detroit, ai Qvartal (settori urbani) di May in URSS, al Piano di Chandigarh di Le Corbusier, ad alcuni progetti di unità di insediamento di Adalberto Libera: sono modelli teorici ed esempi realizzati non certo una ‘panacea’, ma dai quali occorre muovere per rinvenire nella città dei nostri anni quei luoghi aperti in cui una ‘collettività consapevole’ possa ancora identificarsi. Il settore urbano si pone come unità conforme di costruzione della città basata sulla mescolanza di tipi residenziali differenti: unità finita che ritrova al suo interno le gerarchie tra costruito e spazi liberi, quali ‘ferri d’attesa’ per una sua iterabilità. Questa unità elementare si combina con altre tramite precise procedure compositive: ripetizione/variazione, ribaltamenti/simmetrie. Ma la ripetizione non è indifferenziata o isotropa è regolata dagli intervalli prodotti dai vuoti-natura per le attrezzature collettive, in un rapporto figura/sfondo dove prevale il vuoto sul pieno. Il settore inoltre è dotato di una ‘duttilità morfologica’ che gli consente di razionalizzare e riconfigurare i contesti ‘dis-uniti’ (Monestiroli, 2002) delle nostre periferie partendo da una loro analisi/scomposizione formale (Rossi, 1960-1961) e non da mera descrizione/lettura di tipo letterario (Ricoeur, 1994), selezionando e distinguendo i fatti decisivi e ‘definiti’ da quelli ‘confondenti’ per radicare opportunamente nelle “resistenze del reale” (Grassi, 1967) questo principio insediativo. L’unità elementare diviene così ‘dispositivo’, ‘telaio’, ‘impalcatura generale’ che si adatta e riassume l’esistente introducendo nuove misure,
41
scansioni e differenze interne. Questo approccio rende possibile una compiutezza formale ‘per parti’ che rivela gli ‘indizi’ della presenza di una regola e indica una ‘linea tendenziale’: una chiara direzione da percorrere. L’opportuna collazione - lungo grandi sistemi infrastrutturali – e l’individuazione di nuove centralità possono rappresentare le ‘pause’ riconoscibili nella ripetizione controllata della residenza. Una ‘città policentrica’ (Monestiroli, 1995) quindi – come la città greca ma senza suggestioni ‘aurorali’ – una nuova sed antiqua forma insediativa che ristabilisce un corretto rapporto con le infrastrutture (oggi solo ‘flusso continuo’ che sfigurano nel loro sovrapporsi indifferente i territori che attraversano) e che prova a introdurre una possibile forma d’ordine: una struttura soggiacente che non sia ‘astratta’ ma ‘estratta’ (Pezza, 2005), verificata ogni volta nei contesti territoriali specifici in cui “la realtà modifica e invera l’astrazione”. Una costruzione ‘condivisa’ dove il contesto di riferimento ridiviene la natura (Monestiroli, 1995), in cui la costruzione ‘per parti compiute’ (Aymonino, 1975) sia rapportabile ad un tutto (Hòlos) o quanto meno aspiri a comporsi in un ‘mosaico intelligibile’ in cui i ‘condizionamenti’ ineludibili vanno sempre interpretati criticamente (Adorno, 1959 e1979). Una città che sia capace d’interpretare le singolarità geografiche e morfologiche e le nuove dimensioni multiscalari della città-regione, che obbligano ad una ri-semantizzaione dello “strumentario disciplinare” (Spirito, 2003), aggiornando le tecniche compositive di controllo dello spazio urbano e dei manufatti. Una città ‘equilibrata’ in cui tra le diverse parti non via solo ‘connessione’ materiale e/o immateriale (link) ma bensì ‘relazione’ formale e sintattica (ratio), dove il ‘vuoto tra gli oggetti’ ritorni ad essere un ‘campo topologico’ di relazioni a distanza - un ‘aperto’ che si fa struttura ordinatrice che ogni volta va svelato e interpretato - dove ‘avvengono’ le architetture, dove cambiano le metriche di controllo, le dimensioni, i problemi e la complessità generale. Una città ‘auspicabile’, dove la ‘foresta’ confusa si fa ‘radura abitabile’, capace di rimandare ad una costruzione collettiva della “scena fissa per la vita degli uomini” (Rossi, 1966), dove poter ancora conoscere e spiegare il mondo. Per trovare di nuovo nella città del nostro tempo i dimentichi valori civili e quei «luoghi silenziosi e spaziosi, di ampia estensione per riflettere, luoghi con alte e lunghe gallerie per il cattivo tempo o il troppo sole, dove non penetri il rumore delle carrozze e degli imbonitori e dove il più fine senso dell’educazione proibirebbe anche al prete di pregare ad alta voce: costruzioni e giardini pubblici che nel loro complesso esprimano la sublimità del meditare e dell’appartarsi» (Nietzsche, 1882).
42