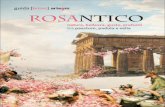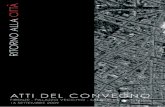E. Tonello, Guido Gozzano, Dalla poesia alla fiaba, dalla fiaba alla poesia. GSLI, 2012
-
Upload
uniecampus -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of E. Tonello, Guido Gozzano, Dalla poesia alla fiaba, dalla fiaba alla poesia. GSLI, 2012
Vol. CLXXXIX ANNO CXXIX Fasc. 6251° trimestre 2012
DIRETTO DA
F. BRUNI - S. CARRAI - M. CHIESA - A. DI BENEDETTO - M. MARTI - M. POZZI
2012
LOESCHER EDITORETORINO
COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
ZYGMUNT G. BARANSKI (University of Notre Dame), ANDREA CICCARELLI (Indiana University),JEAN-LOUIS FOURNEL (Paris VIII), ALFRED NOE (Universität Wien),
FRANCISCO RICO (Universidad autónoma de Barcelona),MARIA ANTONIETTA TERZOLI (Universität Basel).
REDAZIONE
ENRICO MATTIODA (segretario), LORENZO BOCCA
Il «Giornale storico della letteratura italiana», fondato nel 1883 da Arturo Graf,Francesco Novati e Rodolfo Renier, e da allora pubblicato a Torino dalla Loescher,
è punto di riferimento per gli studi di Italianistica.È presente nelle maggiori biblioteche internazionali, ha ottenuto la qualifica ISI
e si avvale della consulenza di lettori anonimi (peer review)per la valutazione dei contributi proposti per la pubblicazione.
Contributi proposti per la pubblicazione e libri da recensire debbono essere inviati a:«Giornale storico della letteratura italiana»
Loescher Editore, via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torinoe-mail: [email protected]
Coloro che desiderano sottoporre un contributo dovranno fare riferimento alle normeper la compilazione che sono scaricabili, in formato PDF, dal sito internet
www.loescher.it/riviste
Nel medesimo sito sono consultabili i sommari dei fascicoli delle ultime annate,gli abstract degli articoli pubblicati, le informazioni su abbonamenti, ristampe anastatiche,
fascicoli arretrati e prezzi
Le annate del «Giornale storico della letteratura italiana» dal 1883 al 1995sono inoltre consultabili on-line, previo abbonamento, nella banca dati Periodicals Archive Online
Modalità di pagamento 2012 (4 fascicoli annuali)€ 88,50 (Italia) - € 118.50 (estero) -Prezzo del singolo fascicolo: € 29,50
I versamenti vanno effettuati sul C.C.P. n. 96136007, indirizzati a S.A.VE s.r.l.Via Dell’Agricoltura 12 - 00065 Fiano Romanoindicando nella causale il titolo della rivista
Registrato al N. 571 del Registro Periodici del Tribunale di Torinoa sensi del Decreto-legge 8-2-48, N. 47. — Direttore responsabile: Arnaldo Di Benedetto.Fotocomposizione: Giorcelli & C. (Torino) - Stampa: Tipografia Gravinese (Torino)
SIMONE ALBONICO, Lettura del canto X dell’«Orlando furioso».M.M.M.M.M.M.VALENTINA MARTINO, La «Difesa della lingua fiorentina e di Dante, con le re-gole da far bella e numerosa la prosa» di Carlo LenzoniM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.
V A R I ET ÀFRANCESCA FAVARO, Spazi bucolici nelle «Rime boscherecce» di Marino: fra dia-loghi e silenzi di pastori.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.RACHEL A. WALSH, Difetti di disegno: «Sul nuovo teatro di Como» di Ugo Fo-scoloM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.ELISABETTA TONELLO, Guido Gozzano dalla poesia alla fiaba, dalla fiaba allapoesiaM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.STEFANON O T E E D I S C U S S I O N IARNALDO DI BENEDETTO, Edith Wharton e Bernard Berenson lettori «entusia-sti» dei «Viceré»M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.
B O L L ET T I N O B I B L I O G R A FI C OMARCO FAINI, La cosmologia macaronica. L’universo malinconico del Baldus di Teo-
filo Folengo (Mirco Bologna), p. 134. – FABIO MARRI-MARIA LIEBER, La corri-spondenza di Lodovico Antonio Muratori col mondo germanofono. Carteggi ine-diti (Franco Arato), p. 141. – VITTORIO ALFIERI, Vita/Mein Leben, a cura diGISELA SCHLÜTER (Arnaldo Di Benedetto), p. 145. – FEDERICO DE ROBERTO, No-velle di guerra, a cura di ROSSELLA ABBATICCHIO, presentazione di NUNZIO ZAGO(Lorenzo Bocca), p. 148.
ANNUNZI, a cura di NOÉMIE CASTAGNÉ, MILENA CONTINI, ARNALDO DI BENEDET-TO, MARIA LUISA DOGLIO, VALENTINA MARTINO, ENRICO MATTIODAM.M.M.M.
Si parla di: V.L. PUCCETTI. – Spagna ferrarese. – G. PONTANO. – Glossario leonar-diano. – P. GUARAGNELLA. – G. CATALANI. – V.G.A. TAVAZZI. – G. SCIANATICO. –V. ALFIERI. – Kunstreligion. – «Atti dell’Ateneo di Bergamo». – V. PADULA. –Ricordo di R. Spongano. – C. POSENATO. – Emilio Bigi. – N. GARDINI.
A B S T R A C T S . M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .
Vol. CLXXXIX Fasc. 625
SOMMARIO
Pag. 1
» 23
» 70
» 91
» 110
» 129
» 152
» 159
GUIDO GOZZANO: DALLA POESIA ALLA FIABA,DALLA FIABA ALLA POESIA.
La pura e semplice necessità di un mondo ideale in cui creature im-maginarie recitino una parte affrancata da ogni coercizione èdi gran lunga più profonda e antica delle regole della buona arte,nonché assai più importante. [...] La letteratura e la narrativa sonodue cose completamente diverse. La letteratura è un lusso, lanarrativa una necessità.
G.K. Chesterton
1. Le fiabe di Gozzano sono state talora sottovalutate dalla cri-tica. Lenzini, ad esempio, le ha considerate un’operazione commer-ciale guidata dalle regole del mercato italiano post-unitario (1). An-che Martin bolla l’intera produzione come poco originale e di scar-so interesse (2). Di altro avviso Piromalli, che invece rimarca piùvolte l’importanza della fiaba come rifugio dal reale e la suggestio-ne esercitata da leggende e motivi popolari sulla poesia gozzaniana(3). Un giudizio favorevole è espresso anche dalla Baldissone, chene sottolinea la congenialità e la «funzione consolatoria e rassicura-trice che le poesie non hanno» (4). A Sebastiani, poi, il valore del-le fiabe pare strettamente legato alla poesia poiché esse adempionoalla funzione eternatrice e all’anelito di eterna giovinezza che sononei voti del poeta: la loro importanza risiederebbe anzi nella capa-cità di spiegare e illuminare alcuni aspetti della personalità del poe-ta che restano in ombra nella lirica (5).Può giovare, a questo punto, il diretto ricorso alle parole del-
l’autore, generalmente trascurate: «Da anni vado studiando la lette-
(1) Cfr. L. LENZINI, Con le mani in tasca, intr. a G. GOZZANO, Poesie e prose, acura di L. Lenzini, Milano, Feltrinelli, 1995.
(2) Cfr. H. MARTIN, Guido Gozzano, Milano, Mursia, 1971.(3) Cfr. A. PIROMALLI, Ideologia e arte in Guido Gozzano, Firenze, La Nuova Ita-
lia, 1972.(4) G. BALDISSONE, Introduzione, in G. GOZZANO, Opere, Torino, Utet, 1983,
p. 33.(5) Cfr. G. SEBASTIANI, Gozzano e le fiabe, in G. GOZZANO, Fiabe e novelline, a
cura di Gioia Sebastiani, Palermo, Sellerio, 2003.
GSLI CLXXXIX, 2012, 110-128
ratura popolare, il folklore di tutti i popoli, da quello giapponese aquello scandinavo, e ho adunato elementi di poesia originalissima.Un mio volume di fiabe è già pronto per le stampe, ma non sarà li-cenziato che l’anno venturo, perché un nostro grande artista vuoleillustrarle accuratamente. Da tempo poi vagheggiavo di scrivere unteatro favoloso, volevo sceneggiare alcuni temi di mia invenzione,fare cose di poesia vera, dilettevole per piccoli e per grandi» (6).L’interesse di Gozzano verso il mondo fiabesco, stando a questa
dichiarazione, non fu dovuto a semplici contingenze, né dettato daragioni economiche, ma lo accompagnò per tutta l’esistenza e de-terminò alcuni tratti della sua poesia. Studioso assiduo e grande co-noscitore dei meccanismi narrativi, egli stesso ricorda la sua abitu-dine, da adolescente, di riunire i ragazzi del quartiere per intratte-nerli con i racconti che inventava sul momento, e la pratica di nar-rare ai nipoti le fiabe che conosceva e che scriveva per loro. Le fia-be vere e proprie rappresentano del resto una parte cospicua dellaproduzione dell’autore e la loro stesura impegna Gozzano per unperiodo di tempo piuttosto lungo, dal 1908 fino alla morte, nel ’16.
2. Tra fiabe e novelline la produzione gozzaniana di questo ge-nere assomma in tutto a venticinque pezzi, ma solo le prime, ospi-tate nel «Corriere dei piccoli», trovano sistemazione in due distinteraccolte: I tre talismani e La principessa si sposa, mentre quelle piùtarde, di matrice deamicisiana, vennero pubblicate nel 1911 sul set-timanale «Adolescenza». Questi raccontini virtuosi, scritti con pale-se intento pedagogico-morale furono composti senza passione e con-seguentemente senza risultati apprezzabili e pertanto non furonomai sistemate dall’autore, che le rinnegò in quanto prodotti dellamoda cattolica imperante, confezionati a solo scopo lucrativo (7).Diverso il rapporto con le prime fiabe, stese in un periodo di
grande fervore creativo, mentre il poeta attendeva alla compilazio-ne delle poesie che verranno a costituire I colloqui. In questo lassodi tempo Gozzano si trova faccia a faccia con l’angoscioso alternarsidi quelle coppie di opposti che formano il nerbo della sua poesia,ma che, spingendo in direzioni opposte, finiscono per creare una la-cerazione. Si tratta, in particolare, dei binomi antinomici di spazio-tempo e sogno-realtà.La poesia degli esordi di Gozzano è originata proprio dalla sen-
sazione di sgomento data dallo spazio e dal tempo, e dalla conse-
VARIETÀ 111
(6) F. CONTORBIA, Il sofista subalpino. Tra le carte di Gozzano, Cuneo, L’arciere,1980, pp. 79-80.
(7) Si veda M. MASOERO, Guido Gozzano, libri e lettere, Firenze, Olschki, 2005,p. 35.
guente necessità di un rifugio sicuro, ma anche dal desiderio di es-sere investito della loro vastità e grandiosità. A quest’altezza dellasua produzione, oltre a tali dicotomie, si deve necessariamente an-noverare anche l’idiosincrasia che si avverte tra irreale e concreto.«Ad un’intima vocazione fantastica rispondono dunque le favo-
le composte dal Gozzano. In esse l’autore non solo si mostra inter-prete sagace dei miti e delle cadenze fantastiche dell’infanzia, ma ri-vela in modo assai indicativo la sua preferenza per le situazioni piùimpossibili e contrastanti con la realtà» (8). Le fiabe sono il luogoletterario in cui tutto diventa possibile, gli elementi discordanti pos-sono suonare insieme, i conflitti trovano soluzione. Per il poeta èrassicurante fare il suo ingresso in un mondo in cui le regole sonodettate da categorie morali certe e salde e da una giustizia inappel-labile, creato di volta in volta per l’occasione e chiuso in sé, senzapossibilità di ripercussione alcuna. Nonostante una quota di manie-ra e di artificio che fa parte della poetica di Gozzano, un doloreprofondo e una malinconia autentica attraversano le sue opere mag-giori. Le fiabe, al contrario, agiscono in senso liberatorio: l’autoredimostra di essersi lasciato penetrare dall’amore per la semplicità delcreato, aver sciolto le briglie dell’immaginazione ed essersi abban-donato alla purezza del linguaggio.Se in poesia le immagini, i sentimenti, le emozioni e la ragione
si condensano e si fondono in un crogiolo in cui è difficile distin-guerli, nelle fiabe tutto scorre linearmente. Non occorre dire che illinguaggio nelle fiabe è sostanzialmente semplice, ritmato, cadenza-to da ripetizioni e formule, ma anche incisivo e deciso, evocativo,come se nominasse le cose per la prima volta. «È da notare come,toccando una fiaba, uno scrittore dia quasi sempre il meglio dellasua lingua: quasi che a contatto con simboli così particolari e uni-versali insieme, la parola non possa distillare che il suo sapore piùpuro. O forse può dominare pienamente quei simboli solo chi ab-bia della propria lingua un sentimento altrettanto liturgico quantoquello della messa domenicale, altrettanto familiare quanto il cibodi tutti i giorni» (9).A nulla vale rilevare le sia pur numerose corrispondenze lingui-
stiche e lessicali che rimbalzano da queste prose alla poesia; piutto-sto risulta interessante vedere le fiabe come una palestra linguistica,utile a sperimentare quel linguaggio dimesso e quotidiano che verràimpiegato nei Colloqui. Il titolo stesso dell’opera sottolinea la suavolontà comunicativa e al tempo stesso narrativa (10). Lo scrittore,
VARIETÀ112
(8) G. GETTO, Poeti, critici e cose varie del Novecento, Firenze, Sansoni, 1953,p. 36.
(9) C. CAMPO, Gli imperdonabili, Milano, Adelphi, 1987, p. 159.(10) P.P. PASOLINI, Saggio introduttivo, in G. GOZZANO, Poesie e prose, Milano,
Feltrinelli, 1995, p. V.
attraverso le storie che narra, supplisce all’esigenza di autodetermi-narsi. Egli colloca se stesso tra gli oggetti e le figure che popolanoi suoi scritti, a volte proiettandosi in altri personaggi, dal fratello, aPaul, all’Avvocato, a volte aderendo perfettamente alla propria bio-grafia, come nel caso di Alle soglie, cronaca di una delle tante visi-te in ospedale cui lo costringeva la malattia che avanzava, che si fariflessione sulla morte. Quando il poeta afferma, con ritmo martel-lante, ne L’ultima rinunzia: «Ma lasciatemi sognare!» (11) chiarisceil legame che esiste per lui tra letteratura e vita. Non si tratta del-l’invito alla leggerezza presente nei poeti che lo seguiranno; tutto ilcontrario del “Lasciatemi divertire” di un Palazzeschi che non scri-ve più cose significative perché non interessano nessuno, ma è in-vece un metodo di superamento del dolore attraverso l’evasione oni-rica. Il sogno è anche «il rifiutarsi alla vita in attesa della sola cer-tezza, la morte, è un opporre “all’ansimar forte/per l’erta faticosa”,all’indagine della ragione, al desiderio che costringe a stare al gio-co, la rinuncia e l’estraneità, il non pensare e il non desiderare, alfine di ottenere la tregua placata di una inconsapevolezza non do-lorosa e stemporalizzata» (12).
3. Nelle fiabe, a differenza del resto delle composizioni di Goz-zano, si avverte il sollievo che scaturisce dalla possibilità della scelta.Il mondo che viene creato di volta in volta dall’autore non è un mon-do dato, ma scelto: ciò riduce l’incidenza della malinconia, sentimen-to che scaturisce dalla constatazione dell’assenso di una via di fuga.La fiaba eponima che apre la raccolta I tre talismani è un ma-
nifesto programmatico delle infinite vie che è possibile percorrerenello spazio fiabesco. È la storia di tre fratelli che ricevono dal pa-dre, sul letto di morte, tre talismani che recano incredibili benefici.A Cassandrino, il protagonista, che è «poeta e più miserabile» (13),il genitore lascia una borsa nella quale si trovano cento scudi ognivolta che vi si introduce la mano. Egli sfrutta la borsa per arricchirsie vivere da gran signore tanto da entrare in rapporti con la famigliareale. Attraversate alcune peripezie a causa della principessa, il pro-tagonista escogita un piano per vendicarsi dell’artefice dei suoi dan-ni. Questa viene infatti sedotta con frutti fatati, ingannata con di-vertenti travestimenti boccacceschi e infine guarita dal male procu-ratole da Cassandrino, il quale finisce per risultare, con una clamo-rosa beffa visibile solo agli occhi dei lettori, l’eroe della situazione.
VARIETÀ 113
(11) G. GOZZANO, Poesie cit., p. 124 e ss.(12) L. LUGNANI, Gozzano, Firenze, La Nuova Italia, 1973, p. 43.(13) G. GOZZANO, Opere, a cura di C. Calcaterra, A. De Marchi, Milano, Gar-
zanti, 1949, p. 643.
Egli ottiene persino dal re l’offerta della mano della principessa,come da manuale nelle fiabe tradizionali, che si concludono con l’a-vanzamento di status del personaggio principale, sancito da matri-moni regali. Cassandrino stupefacentemente rifiuta, «torna al paesenativo [...] e, sposata una compaesana, visse beato tra i campi, sen-za più tentare l’avventura» (14).La conclusione, del tutto anomala rispetto al modello sopracita-
to, si spiega tenendo conto che il protagonista è, come già sottoli-neato, un poeta ingenuo che si è fatto abbagliare da fama e splen-dore e si è lasciato sopraffare dall’astuzia della gente. Quando se nerende conto, abbandona quel mondo e finisce per mirare alla sem-plicità, all’autosufficienza, alla normalità. Somiglia in questo a TotòMerumeni che vive appartato nella sua villa e chesognò per anni l’amore che non venne,sognò pel suo martirio attrici e principesseed oggi ha per amante la cuoca diciottenne (15).
Ma mentre Totò è afflitto da «un male indomo» (16), che «ina-ridì le fonti prime del sentimento» (17), e ha vissuto tristi vicendeche lo hanno portato a chiudersi in se stesso, Cassandrino rinunciaall’avventura e alla ricchezza deliberatamente. Mentre uno è inettoa vivere e per questo sente il suo isolamento come una condanna,l’altro è in possesso dei mezzi che lo potrebbero rendere potente egrandioso, ma rifiuta consapevolmente la possibilità di migliora-mento e preferisce la tranquillità della quotidianità. Entrambi ap-prodano allo stesso risultato, ma la soluzione proposta dallo scrit-tore è in un caso desolante e negativa, nell’altro positiva e volonta-ria. «Gozzano fiabesco è dunque il contrario di Totò Merumeni, èil consolatore di se stesso» (18).
4. La fiaba è la consolazione per eccellenza perché permette digodere a pieno ed insieme di tutti gli aspetti dell’esistenza e del so-gno. Il fatto che Cassandrino scelga la vita «ruvida concreta / delbuon mercante inteso alla moneta» (19) si può intendere come lasoluzione che l’autore trova per il singolo caso in questione. Nellefiabe ha modo di riversare i conflitti che lo turbano e di distribui-re alternativamente ad esse gli impulsi contrastanti, come per os-
VARIETÀ114
(14) Ivi, p. 653.(15) G. GOZZANO, Poesie cit., p. 215.(16) Ivi, p. 216.(17) Ibidem.(18) G. BALDISSONE, Guido Gozzano consolatore di se stesso, in Guido Gozzano.
I giorni, le opere, Atti del convegno Nazionale di Studi, (Torino 26-28 ottobre 1983),Firenze, Olschki, 1985, p. 382.
(19) G. GOZZANO, Poesie cit., p. 191
servare separatamente le due facce di una stessa medaglia. L’inca-pacità di decidere tra una vita attiva, da un lato, e un’esistenza ras-segnata e inerte, dall’altro, si risolve nelle fiabe attraverso una sem-plice spartizione di ruoli, che fa sì che queste due spinte dell’Io sia-no incarnate da personaggi distinti. Ne La fiaccola dei desideri agi-sce un personaggio attivo che collabora col fato per giungere al lie-to fine, ne La danza degli gnomi, un personaggio inerte, ma con qua-lità positive raggiunge la medesima felicità.Il primo personaggio in questione è Fortunato, che rappresenta
tutto il contrario del nome che porta: è infatti un ragazzo «malatic-cio, gobbo, distorto» (20) e povero, che abbandona la casa paternaper mettersi alla ventura. Entrato in possesso di un oggetto magico,il protagonista mette in moto un’escalation di desideri che soddi-sfano le sue esigenze più immediate, come la fame e la rimozionedelle deformità fisiche, ma anche quelle più ardite, come il posses-so di un castello e di un titolo nobiliare. L’unica cosa di cui senteben presto la mancanza è l’amore, che, si noti bene, non è acqui-stabile per mezzo della magia. Anche in questo caso si dà da fareper sedurre la principessa di un feudo limitrofo, con uno strata-gemma ricalcato dalla storia di Aladino ne Le mille e una notte, sca-tenando l’ira del potente signorotto che lo abita, suo rivale e padredella fanciulla.Dopo un’avventura che lo porterà a rischiare la vita, Fortunato,
soccorso dalla sua stessa astuzia, si libererà e sposerà la principessaraggiungendo quindi il suo meritato lieto fine. Egli si presenta findall’inizio, nonostante gli evidenti svantaggi che lo penalizzano, mo-tivato e intraprendente, è artifex suae fortunae; come tutti i perso-naggi delle fiabe è aiutato dalla magia e dal destino, ma è ancheprotagonista attivo della propria sorte.In poesia il dissidio tra vita attiva ed esistenza inerte si fa mate-
ria di composizione, nelle favole invece, incredibilmente, tutto trovauna sistemazione pacifica. È sufficiente attribuire ad un personaggiocerte doti e ad un altro certe altre per avere la sicurezza che en-trambi, con armi diverse, sono in grado di affrontare la vita e diuscirne vincitori, siano parte della stessa storia o affidati a due com-posizioni distinte. Il risultato sarà quello di ottenere la vittoria, sce-gliendo da tutto il ventaglio di possibilità che si offre ad un indivi-duo, senza soffrire dell’esclusione dai vantaggi che avrebbe compor-tato una diversa occasione o una diversa decisione, perché c’è sem-pre la possibilità di raccontare un’altra storia che la contempli (21).
VARIETÀ 115
(20) G. GOZZANO, Opere cit., p. 665.(21) Per questo Calvino afferma che le fiabe sono sostanzialmente vere, poiché
esse parlano di cose vere, perché soddisfano le più varie necessità di evasione econforto dell’uomo. «Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre
Per questa opzione esistono anche i personaggi passivi, come Se-rena, la protagonista della Danza degli gnomi. Ella non si ribella allasua condizione di inferiorità, cui è relegata a causa della prepoten-te matrigna. La storia prende le mosse dall’ennesimo capriccio del-la donna, che costringe la fanciulla ad attraversare, nella notte, il bo-sco infestato dagli gnomi, famosi per i loro dispetti.Incamminatasi, si imbatte in un gruppo di gnomi, che la invita-
no ad unirsi alle loro danze. Ella non se la sente di rifiutare ed ac-cetta. Colpiti dalla kalokagathia della giovane, non fanno che ri-compensarla con doti e virtù, che si vanno ad aggiungere a quellegià possedute. La fama del suo splendore fa sì che un principe lon-tano accorra per farne la sua sposa, ma la matrigna tenta nuova-mente e invano di ostacolarla, rinchiudendola in un baule, dal qua-le attenderà di essere liberata nel classico lieto fine.Serena è un personaggio assolutamente irresoluto. Non agisce se
non su comando di qualcuno ed evidentemente anche contro il suobene. Non esprime nemmeno un giudizio sul principe che le si pro-pone. Il fatto che il matrimonio sia invidiabile e che questi sia l’uo-mo dei suoi sogni è però indubitabile. E se ne può essere certi inquanto questa è evidentemente la ricompensa per essere un perso-naggio tanto positivo. La sua bellezza, unita alla sua bontà, le assi-curano, nel mondo delle fiabe, la felicità perfetta, il lieto fine che,anche per il sofisticato Caillois, è il suggello di ogni vera fiaba (22).Il finale positivo, sancito dall’avanzamento di status è assicurato
anche ad un personaggio che costituisce una via di mezzo tra i duemodelli sopra citati. Ne La leggenda dei sei compagni, il protagoni-sta Gentile ha bisogno dell’aiuto di sei personaggi straordinari percompiere la sua impresa. Il suo merito principale sta nella sua cor-tesia, come suggerisce il nome che porta, e nella sua abilità nel coor-dinare i compagni. Nonostante ciò, sarà lui e non i compagni adavere il premio ambito: la mano della principessa e il riconoscimentodi valore da parte del Re, mentre ai veri autori dell’impresa verràconcessa soltanto la carica di ministri del regno. Osservando la sto-ria passo per passo ci si accorge che la figura del protagonista man-ca di una serie di attributi fisici che evidentemente sono ambiti edapprezzabili, e che questi sono distribuiti invece nei cinque perso-naggi straordinari che lo accompagnano; Mangiatutto, Bevitutto,Occhiofino, Finorecchia e Primosempre. Essi portano espressa nel
VARIETÀ116
varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita[..], sono il ca-talogo di destini che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la par-te di vita che è appunto il farsi di un destino: la giovinezza, dalla nascita che soventeporta in sé un auspicio o una condanna, al distacco dalla casa, alle prove per di-ventare adulto e poi maturo, per confermarsi come essere umano» (I. CALVINO, Fia-be italiane Milano, Mondadori, 1993, p. 13).
(22) Si veda R. CAILLOIS, Dalla fiaba alla fantascienza, Roma, Theoria, 1999.
loro appellativo la loro speciale connotazione. Si tratta di una tec-nica ampiamente sfruttata nelle fiabe, ma propria anche del Gozza-no lirico, che «amava le parole composte come immagini sintetiche»(23). Anche la mancata prestanza fisica, più volte accusata da Goz-zano nella sua opera, è assorbita dalla fiaba, dove è risolta per mez-zo dell’artificio tecnico dello sdoppiamento dei personaggi. In que-sto modo si ha la sensazione della «liberazione attraverso l’immagi-nario. L’anima può essere tutto, [...]: non le basta mai un’unica tra-ma; la sua mancanza di disponibilità all’azione è compensata dallacapacità di fabulazione: ciò che imprigiona il corpo libera il vaga-bondo delle stelle» (24).Nei versi, all’opposto, il conflitto doloroso si affaccia senza trova-
re soluzione e senza possibilità di scissione. Nelle eloquenti quartinede La via del rifugio si ritrova, infatti, da una parte, il forte richiamodell’adesione alla vita attiva, dalla quale il poeta rivela di essere co-stretto ad astenersi. Egli si trova in una posizione di evidente sotto-missione su un metaforico prato, incapace di afferrare l’essenza del-l’esistenza concreta e operosa, rappresentata da un quadrifoglio e poidalla caccia alla farfalla cui prendono parte le nipotine:Resupino sull’erba(ho detto che non voglioraccorti, o quatrifoglio)non penso a che mi serbala Vita (25).
L’autore ignora la proposta del mondo reale e preferisce lasciar-si cullare indolente dalle note della filastrocca infantile con le qua-li si apre la poesia e la raccolta, ennesimo simbolo del tipo di esi-stenza che intende abbracciare, tentando di «evadere dalla realtà perrifugiarsi nel limbo di ciò che non può essere» (26), del passato no-stalgico, dell’infanzia, della creazione fantastica, del sogno, seppurcon numerosi rimorsi e ripensamenti:
La vita? Un gioco affattodegno di vituperio,se si mantenga intattoun qualche desiderio.
Un desiderio? Stosupino nel trifoglioe vedo un quatrifoglioche non raccoglierò (27).
VARIETÀ 117
(23) C. CALCATERRA, Della lingua di Guido Gozzano, Bologna, Minerva, 1948,p. 96.
(24) F. SAVATER, L’infanzia recuperata, Bari, Laterza, 1994, p. 153.(25) Ivi, p. 62.(26) Ivi, p. 37.(27) G. GOZZANO, Poesie cit., p. 67.
Dalla parte opposta vi è, quindi, evidentemente la prospettiva diun’identità passiva, abulica.
5. Il poeta inventa storie che lo consolano della sua malattia, mo-rale e fisica, ma anche della sua indifferenza emotiva. Nelle fiabe,come anche nelle poesie, trova il modo di scaldare il suo cuore conle creature partorite dalla sua stessa mente nel sogno e nella fanta-sia.Ne La lepre d’argento, Gozzano racconta una storia d’amore con
tutti gli ostacoli, i patimenti e le traversie del caso. Sulla falsa rigadi una fiaba della D’Aulnoy, narra la storia di un principe che sitrova per caso, dopo aver seguito un’abbagliante lepre d’argento du-rante una battuta di caccia, in un castello fatato nascosto in un al-bero.Qui è sottoposto a strane torture da parte di mani volanti, che
giocano a palla col suo corpo, per divertimento, durante la notte.Però, ogni notte passata a subire questo supplizio, fa guadagnarealla lepre, inquilina del palazzo, una porzione di sembianze umane.Il principe arriva quasi a morire, ma fortunatamente resiste, libe-rando così la lepre dal maleficio e riacquistando la donna che ave-va scelto per moglie tempo addietro e che, frenata dal maleficio,non aveva potuto raggiungerlo.Gozzano diverge ampiamente dal racconto della D’Aulnoy in un
punto della fiaba. Il gioco malefico delle mani e la pena che il prin-cipe deve patire sono infatti frutto della sua personale invenzione.Sembra voler suggerire al lettore l’intima connessione che lega amo-re e dolore, e la consapevolezza che la ricerca di una compagna èun fatto complesso e rischioso, che può anche risolversi in tragedia.Il dramma è consumato in Nevina e Fiordaprile, fiaba allegorica
incentrata sul mutare della stagioni. I protagonisti, appartenenti amondi distinti, sono costretti a dirsi addio per aver salva la vita; illoro sacrificio varrà la fine delle incursioni del freddo nella nuovastagione e quindi l’avanzare deciso di climi più miti.Sia in un caso, sia nell’altro, va posto l’accento sulla leggerezza
con cui è trattato il tema dell’amore, sempre legato, com’è eviden-te, alla morte e al pericolo. In poesia l’amore è reale, tenace edesclusivo solo se interessa le donne immaginarie: Carlotta, cocotte,Virginie. Negli altri casi le conclusioni tratte dalle relazioni sonosconfortanti; dalla donna aruspice, cui chiede conforto per la pro-pria incapacità di amare, il poeta riceve come risposta: «Perché nonv’uccidete?» (28), all’atto dell’amore consumato segue un silenzioche gela ogni contatto, all’Ipotesi di un amore borghese con una
VARIETÀ118
(28) Ivi, p. 83.
«consorte ignorante» (29) che potrebbe benissimo essere Felicita,corrisponde la morte della cultura e dello spirito, come testimoniala resa parodica delle vicende di Omero che trova posto nella me-desima poesia. Infine, altrove, non resta che sconsacrare anche l’a-more puro da favola con L’esperimento di un rapporto carnale conla creatura dei suoi sogni, Carlotta.Il contatto con l’amore genera sconforto, spaesamento e scon-
certo. Sembra non esistere una soluzione o una sistemazione ine-quivocabile per il male che affligge il poeta. Nelle fiabe invece, lestorie d’amore si concludono, nel bene e nel male, immerse in unclima di levità e avvolte da un’aura di serenità, in quanto tutto «ciòche trova una forma perde il carattere minaccioso del caos» (30).La forma del genere fiabesco permette il trattamento ordinato del-la materia amorosa e la rende appagante e senza peso, offrendo an-che in questo caso un’opportunità di conciliazione allo scrittore.
6. Per Gozzano l’amore, com’è noto, si lega indissolubilmentealla morte. Egli contempla entrambi come le uniche «due cose bel-le» (31). La morte è legata al tempo onnivoro e suggerisce ampi spa-zi di profonda riflessione. Il leit motiv della fuga dal mondo e delrifugio nella letteratura si concreta in poesia come un rifiuto dellavita vera, quella vissuta dai forti, dai borghesi, dai sani, con il con-seguente approdo alla morte, che acquista così connotazioni libera-torie. Le favole, invece, incarnando l’ideale della giustizia supremae confidando nell’etica degli eventi, distribuiscono vita e morte ri-spettivamente a chi agisce secondo il bene e il male. Ogni volontànichilista va sparendo e la morte perde ogni suo potere di seduzio-ne. Al contrario esse offrono l’illusione di poterla sfuggire, di esor-cizzarla.Così, in particolare, ne Il reuccio gamberino, fiaba dai toni leg-
germente filosofici per la sua capacità di sfiorare temi quali la cir-colarità del tempo e la coincidenza di morte e nascita. Sansonetto èil protagonista di questa vicenda, che lo vede tornar bambino a cau-sa di una maledizione. Per questo, il sovrano di Pameria ritira lamano della figlia, promessa al reuccio accompagnando il gesto conqueste parole: «fra qualche anno sarete un marito bambino, poi unmarito lattante, poi nascerete; cioè morirete... scomparirete nel nul-la...» (32).L’eroe intraprende così un viaggio di formazione nel quale sono
VARIETÀ 119
(29) Ivi, p. 363.(30) P. BICHSEL, Il lettore, il narrare, Milano, Marcos y Marcos, 1982, p. 18.(31) G. GOZZANO, Poesie cit., p. 234.(32) G. GOZZANO, Opere cit., p. 715.
inclusi gli incontri con gli animali, che svelano il costante amore diGozzano per la natura e i vantaggi che si ricavano da una solida al-leanza con essa, e una lotta contro un gigante, che gli permette unosfoggio artistico, poiché riprende, nel lessico e nelle movenze, alcu-ne ottave del poema di Ariosto (33). Dopo aver percorso un itine-rario che lo porta a scontrarsi con la morte, Sansonetto è chiamatoa rinascere a nuova vita. In questo modo lo scorrere angosciante deltempo viene arrestato e incanalato verso un nuovo corso.Con questa fiaba Gozzano afferma che l’uomo è destinato al nul-
la e ad esso verrà riconsegnato in ogni caso. Sia che il tempo scor-ra in avanti, sia che scorra all’indietro, l’uomo non sarà mai felice,perché la sua natura materiale lo costringerà a tornare cenere. Scri-vere e raccontare storie in ultima analisi ha a che vedere propriocon il Tempo, con la finitudine dell’essere umano e con la sua in-capacità di accettare questo fatto. Narrare, come fa opportunamen-te notare Bichsel, deriva dalla malinconia legata a questa consape-volezza (34).
7. Lo statuto particolare della fiabe concede, attraverso i lorotoni miti e le infinite possibilità che offrono, di sfuggire qualsiasisorte e qualsiasi evento triste, compresa l’infelicità stessa, il «tarlo /della malinconia» (35). In una fiaba in particolare, dal titolo La ca-micia della trisavola, viene affrontato tale argomento. Si tratta di unafiaba complessa, in cui si annodano diversi nuclei narrativi e varispunti tratti dalle opere di Basile e di Grimm. Il testo narra le vi-cende di Prataiolo, il tradizionale protagonista tardo e trasognato,che è guidato da una buone dose di rettitudine e che si rivela infi-ne astuto e vincente. Alcune peripezie lo portano in un regno tem-pestato di annunci che proclamano che la figlia del Re sarà data insposa a chi saprà guarirla dalla sua insanabile malinconia.Prataiolo si infiltra con furbizia nel castello e mette a punto un
piano ben architettato per offrire alla principessa un buffo spetta-colo, alla vista del quale la fanciulla scoppia in una risata che duraun’ora intera, dopo di che, rivolgendosi al padre, esclama: «Padremio, costui mi ha risanata ed io sono sua sposa!» (36).
VARIETÀ120
(33) Gozzano segue l’Ariosto passo per passo: «La testa impallidì, gli occhi det-tero un guizzo spaventoso, e il gigante che brancolava all’intorno, cadde con un tonfosordo. Era morto» (G. GOZZANO, Opere, cit., p. 719). Cfr. L. ARIOSTO, Orlando fu-rioso, XV, 87, 4-8 «Si fece il viso allor pallido e brutto, / travolse gli occhi, e dimo-strò all’occaso, / per manifesti segni esser condutto; / e il busto che seguia troncatoal collo, / di sella cadde e diè l’ultimo crollo».
(34) Si veda P. BICHSEL, Il lettore, il narrare cit.(35) G. GOZZANO, Poesie cit., p. 116.(36) G. GOZZANO, Opere cit., p. 684.
Questa offerta così diretta ed esplicita costituisce un eccezionealla regola nei meccanismi della fiaba, in cui solitamente principes-se e regine costituiscono trofei da vincere che sanciscono l’avvenu-to innalzamento di status dell’eroe e per questo difficilmente con-sentono un approfondimento psicologico. Ad esse viene affidato unruolo fondamentalmente passivo, non hanno spessore, non ci si curadel loro volere, spesso sono completamente mute ed è il padre aparlare per loro, ad offrire al protagonista la loro mano. In questocaso non solo la fanciulla parla, ma lo fa donandosi spontaneamen-te, a dimostrazione, prima di tutto, che la malinconia è stata supe-rata. L’intraprendenza e la schiettezza della profferta infatti, lo con-fermano concretamente.Il mondo fantastico, in cui tutto ha una forte apparenza di faci-
lità, ospita quello concreto, pur se interiore, per banalizzarlo e an-nientarlo. Una lunga risata è stata sufficiente per sconfiggere il cruc-cio della malinconia. L’ironia, che contraddistingue Gozzano sia inprosa che in poesia, sembra infiltrarsi anche all’interno delle fiabesotto forma di autoironia, come nel caso del miserabile poeta Cas-sandrino o della fontana di metamorfosi che diventa parodia del ge-nere stesso ne La cavallina del negromante e poi in tutti i casi fin’o-ra citati, che portano a guardare alla produzione maggiore e a ve-dere sconsacrati, semplificati, scissi e risolti quei problemi e quelletematiche che vi venivano così tristemente affrontati.Evasione e ironia vengono a coincidere nell’universo del fanta-
stico, poiché svolgono tutto sommato la stessa funzione attenuativae alleviante. In definitiva, infatti, entrati in questo luogo, pronun-ciando le parole canoniche e magiche “C’era una volta”, tutto ap-pare più leggero. Gozzano percorre la sua via del rifugio anche at-traverso la stesura di queste delicate fiabe, che rappresentano l’api-ce dello svago letterario e mentale. Come ha scritto Chesterton, «lapura e semplice necessità di un mondo ideale in cui creature im-maginarie recitino una parte affrancata da ogni coercizione è di granlunga più profonda e antica delle regole della buona arte, nonchéassai più importante. [...] La letteratura e la narrativa sono due cosecompletamente diverse. La letteratura è un lusso, la narrativa unanecessità» (37).
8. Venendo meno le condizioni di questa libertà espressiva, laproduzione fiabesca di Gozzano andrà incontro ad un calo di tonoe di originalità. Le fiabe scritte per «Adolescenza» risentono dellamorale cattolica che sembra averne condizionato i registri, i motivie i temi. Leggendo le sette fiabe composte per il settimanale, appa-
VARIETÀ 121
(37) G.K. CHESTERTON, Il bello del brutto, Palermo, Sellerio, 1985, p. 22.
re evidente che originalità e partecipazione sono venute meno. Lavisione delle fiabe come «piccoli strappi di paradiso, d’infanzia, diesotismo, di utopia» (38) lascia il posto ad una meccanica ripropo-sizione di temi scontati, di buonismi triti e desolanti. Il modo diguardare il mondo, gaio e colorato, va in frantumi ed è compensa-to da una diffusa atmosfera grigia che circonda personaggi e am-bienti scontati.Il problema dell’identità, che si era visto felicemente risolto e ac-
cettato nella stesura delle precedenti fiabe, torna a farsi urgente sul-le pagine della rivista, ma la soluzione al conflitto è tutt’altro cherassicurante. Nel raccontino Luca e Mario, ad esempio, un perico-loso scambio di persona viene messo in atto dalla ricca madre di unbambino malato, il quale finirà per lasciare la vita e il suo ruolo difiglio all’amico sfortunato e orfano. La madre infatti, alla morte delfiglio legittimo, si approprierà del ragazzino, rivestendolo e petti-nandolo come il bambino perso, creando confusione e squilibrio nelpiccolo, che fatica a comprendere quell’atto di amore tutt’altro chedisinteressato. L’identità è pericolosamente minata e il gesto di al-truismo coperto da un’inquietante sovrapposizione di persone.Non solo i rapporti tra le persone, ma anche il legame tra uomo
e natura va incrinandosi in questa fase. Le due madri è la struggen-te storia di un’aquila a cui viene sottratto il suo piccolo da un uomo,che lo imprigiona in una gabbia e lo lascia nel cortile della sua casa,con a guardia la moglie che stende i panni e bada al figlioletto neo-nato. L’aquila, a questa scena, ghermisce il bimbo e lo porta con sénell’azzurro. La madre ha un’ispirazione nel terrore di quel mo-mento e, liberato l’aquilotto, lo solleva sopra il suo capo per por-gerlo all’aquila che, a quella vista, sta già tornando sui suoi passi.«L’istinto delle due madri s’era compreso in quell’attimo di terribi-le angoscia» (39). Avviene lo scambio, ma non appena l’aquila fusalita in cielo, un colpo di fucile la raggiunse «ed essa cadde fulmi-nata, le grandi ali aperte, presso la madre, che stringeva il suo bim-bo intatto e riconquistato» (40).L’evidente sproporzione tra i destini delle due madri e della loro
prole fa pensare che Gozzano abbia perso la fiducia nell’equilibriotra uomo e natura. Le descrizioni del volo dell’aquila, degli spaziche sovrasta, sono sempre magnificate da un’apertura lirica, che di-mostra ancora una volta l’ammirazione dell’autore per il creato, mala conclusione tragica e l’immissione di tinte oltremodo cupe fa dacontrappeso alla leggerezza delle immagini evocate. I temi, ma an-
VARIETÀ122
(38) G. BALDISSONE, Guido Gozzano consolatore di se stesso, in Guido Gozzano.I giorni, le opere cit., p. 388.
(39) G. GOZZANO, La moneta seminata e altri scritti, introd. e note di F. Anto-nicelli, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1968, p. 33.
(40) Ibidem.
che gli ideali del poeta (41) vengono per così dire prostituiti da Goz-zano in questa particolare serie di racconti, verso i quali egli stessoconfesserà di provare, a posteriori, vergogna, in una lettera alla so-rella.Diverso il rapporto con le fiabe de I tre talismani e La princi-
pessa si sposa, alle quali dedicò molta cura e orgoglio, proprio per-ché le sentiva proprie, poiché sono «vere creazioni personali, ispi-rate ai motivi più consoni al suo spirito mite e umano» (42), in cuiquesti «motivi si accoppiano, s’intrecciano, si complicano, ma sonosempre i motivi dominanti della sua poesia» (43). Infatti «i raccon-ti e le fiabe di Gozzano sembrano in alcuni casi fornire note e spie-gazioni a quei sorprendenti distillati che sono le sue poesie» (44).Ne scaturisce che per i lettori ed i critici, la loro analisi possa rap-presentare una proficua occasione per arricchire e far luce sulla fi-gura di un poeta tanto complesso..
9. La produzione maggiore è attraversata da una vena fiabisticache è vera linfa dei componimenti. L’osmosi tra le fiabe e la poesiae le prose è qualcosa di profondo e di imprescindibile su cui pog-giano i processi creativi. La fantasia generatrice, gli elementi basila-ri del genere fiabesco e le categorie mentali che stanno alla base del-la trasfigurazione fantastica possono essere rintracciati nella produ-zione maggiore e divenire fecondo campo d’indagine dell’opera goz-zaniana.La personale natura dell’autore, per prima cosa, lo porta ad es-
sere vicino a quella sensibilità e alle suggestioni infantili che diven-tano risorsa infallibile per la creazione artistica. La sua personalitàgli impone di fuggire la pesantezza del reale e tentare di trovare unrifugio nella levità dell’esistenza fantastica, unico luogo in cui nonsi avvertono le contraddizioni dell’essere e i conflitti cessano di stri-dere. «Non agogno che la virtù del sogno» (45) è il verso che si tro-va nella poesia di apertura alla sua prima raccolta, che porta il si-gnificativo titolo de La via del rifugio, e che può essere, a pieno di-ritto, considerato un manifesto della poetica di tutto Gozzano. An-che la poesia infatti, come la sua prosa, oscilla tra i due piani della
VARIETÀ 123
(41) Il tema della violenza cresce in intensità ed orrore ne Il nastro dell’impa-zienza o ne Il mugnaio e il suo signore, dove affiorano pesanti punizioni corporali eomicidi gratuiti e l’ideale della giustizia è occultato dal silenzio del perdono cristia-no ne La corona del re.
(42) G. OSELLA, Le fiabe di Guido Gozzano, in «Lares», 3-4, 1963, p. 137.(43) Ivi, p. 144.(44) G. BALDISSONE, Introduzione, in G. GOZZANO, Opere cit., p. 30.(45) G. GOZZANO, Poesie, a cura di G. Bárberi Squarotti, Milano, Bur, 2006,
p. 62.
realtà e della finzione, mescolandoli e dando vita a nuove, emozio-nanti situazioni e cercandovi alternativamente dimora, trovandosicome risultato a volte respinto ed a volte accolto. È il caso, emble-matico, del rifiuto della vita e dell’abbandono sentimentale nelle li-riche I colloqui e Le due strade, nelle quali il poeta si interroga sul-la propria esperienza di vita, tira le somme e conclude che la suaesistenza è stata, fino a quel momento:
[...] un bel romanzo che non fu vissutoda me, ch’io vidi vivere da quelloche mi seguì, dal mio fratello muto (46).
Ed è proprio l’anatema che il poeta porta su di sé, questo suoamore per la letteratura, che lo trascina nel baratro dell’inettitudinee lo rende inadatto alla vita, ma anche alla passione amorosa, comedimostra ne Le due strade. In questa poesia infatti preferisce resta-re al fianco della vecchia e indesiderabile amica, piuttosto che se-guire giù per il pendio la leggiadra Graziella, la quale rappresentala sua occasione di riscatto e di adesione alla felicità di quella schie-ra di vivi in cui Gozzano non riesce ad inserirsi.Ma ciò che gli si confà alla perfezione è rovesciare la sua male-
dizione di adepto delle lettere e assaporare questa condizione finoin fondo, accettandone le regole e giocando a pieno la sua parte.L’amica di nonna Speranza è a tutti gli effetti un esempio della suaprofessione di fede in un mondo altro, collocato nel passato e nel-la fantasia, in cui si muovono personaggi da fiaba che vivono amo-ri sospirati e favolosi. E Gozzano questi personaggi li sente comereali, sente di poter provare sentimenti nei loro confronti, nono-stante la tanto insistita aridità sentimentale altrove proclamata, e ad-dirittura di amare la protagonista Carlotta.Sono questi suoi viaggi onirici che costituiscono il tessuto più
suggestivo della sua produzione lirica, quelli che, con una feliceespressione, Calcaterra ha battezzato «favole mimiche» (47) e checontengono tanti e tali elementi fiabeschi che vale la pena di ana-lizzare per comprendere fino a che punto la fiaba rappresenti il ri-ferimento e il sottotesto dei suoi componimenti poetici.Incapace di risolvere il conflitto tra l’interesse per la vita attiva
e la chiusura in se stesso, associata alla conseguente fuga dal reale,l’autore abbandona i propri sensi a scene di pura invenzione, comeaccade nella poesia Paolo e Virginia, in cui la vicenda dell’amore fia-besco tra i due giovani si svolge su uno sfondo artificiale che Goz-zano va via via invocando, fino a farsene assorbire tanto da imme-
VARIETÀ124
(46) Ivi, p. 132.(47) Si veda C. CALCATERRA, Con Guido Gozzano e altri poeti, Bologna, Zani-
chelli, 1944.
desimarsi completamente nell’eroe del romanzo di Henri Bernardinde Saint-Pierre e giungere ad affermare:
Morii d’amore. Oggi rinacqui e vivo,ma più non amo. Il mio sogno è distruttoper sempre e il cuore non fiorisce più (48).
L’unica soluzione possibile è vivere a pieno, ma solo nel mondoartefatto creato dalla poesia.Anche in prosa egli stravolge la storia e vi si inserisce come spet-
tatore, emozionandosi e partecipando alle vicende narrate. È il casodi Torino d’altri tempi, in cui la città, poco a poco, sfuma nel pas-sato e, come accade in molti altri componimenti dello stesso teno-re (49), «la storia si spoglia di ogni veste di ufficialità, si accordanaturalmente alla fantasia, anzi, si compenetra ad essa sino a darvita ad una fictio» (50). È come se le cose reali per Gozzano fosse-ro meno vere ed intense delle cose artificiali. Per questo si lasciatrasportare dalla suggestione di versi di canzoni popolari e canti cheseguono il filo della leggenda per comporre alcune della sue lirichepiù belle, come La bella del re o L’ultima rinunzia, a cui affidare leproblematiche e i nodi centrali della sua poetica.Oltre al legame concreto col retroterra fantastico, il debito nei
confronti del fiabesco si estende, per alcune tematiche, come adesempio l’identità, ai meccanismi di fondo della poetica gozzaniana.È superfluo ricordare che nel genere fiabesco i personaggi non han-no reale approfondimento psicologico, in quanto rappresentano va-rie proiezioni di un’unica identità o in virtù del fatto che possiedo-no unicamente un ruolo funzionale che li porta ad impersonare laticomplementari o opposti di un particolare carattere che è al centrodell’allegoria fiabesca.Gozzano, nelle poesie, mette frequentemente in scena personag-
gi positivi, antitetici a se stesso, come nel caso del fratello Renatonella lirica Il più atto, in cui si legge il significativo verso: «Ed eglisia quell’uno felice ch’io non fui!» (51). La concezione di sé si ri-vela centrale in diversi altri componimenti, nei quali il poeta non sadecidersi sulla strada da intraprendere e non riesce a districarsi trale opportunità e le occasioni che gli si presentano, a partire dallascelta di abbracciare la poesia o, in alternativa, gli interessi borghe-si, fino a quella più radicale del suo esistere, inteso in senso tra-scendente. La definizione di se stesso come di «una cosa vivente
VARIETÀ 125
(48) G. GOZZANO, Poesie cit, p. 175.(49) A titolo di esempio si vedano Un vergiliato sotto la neve, Carolina di Savoia,
Il castello di Agliè ecc.(50) M. CARLETTO, Per uno studio del motivo fiabesco in Guido Gozzano, in «Ita-
lianistica», 1, 1975, p. 102.(51) G. GOZZANO, Poesie cit, p. 163.
detta guidogozzano» (52) è significativa di tale considerazione del-la propria identità.Nelle novelle si possono riscontrare con una certa frequenza in-
teressanti scambi di persona, che spesso costituiscono il motore del-l’azione. La sfida è la storia di un amore fortuito tra un giovane mi-litare e una donna che si cela sotto uno pseudonimo maschile; fat-to che inizialmente confonde i rapporti tra i due. Spesso inoltre siincontrano personaggi contrapposti: in Melisenda ad esempio duefratelli possiedono qualità opposte e complementari, uno è un esse-re celebrale; l’altro sociale. Solo il secondo, “il più atto”, riuscirà aconquistare l’amore della bella attrice protagonista. Questo gustoper l’antitesi è anch’esso consono al genere della fiaba, che ama icontrasti a tinte forti e le nette opposizioni, per essere immediata-mente fruibile da un pubblico vasto e per offrire la visione più chia-ra e decisa possibile della realtà. Gozzano non solo divide i perso-naggi in schiere di buoni e cattivi, ma esercita un diffuso gusto este-tico per le contrapposizioni, sia nei temi che nel linguaggio, nel qua-le, in particolare, si producono le note “scintille” (53).A differenza della fiaba, la cui conclusione è di consueto conci-
liante, la poesia di Gozzano è dominata dalla nota stridente del-l’angoscia per il contrasto tra impulsi opposti. La stessa bramosiache il poeta avverte per gli spazi intimi e privati del Canavese e pergli ambienti domestici del giardino, del frutteto, del salotto, si scon-tra con l’anelito rivolto agli spazi infiniti, alla vastità cosmica, all’e-vasione, magari resa possibile da un viaggio esotico come quello chelo ha portato a visitare l’India. Ma anche il tempo ha la stessa ca-pacità di sdoppiarsi in memoria dell’infanzia e dei piccoli particola-ri privati da una parte, e in oblio mastodontico della Storia, con tut-ti gli eventi e i personaggi che abitano le composizioni del Nostro,dall’altra. Infine il bivio tra realtà e sogno è per il poeta addirittu-ra fonte di turbamento: egli stesso si rende conto della sua pro-pensione a guardare ora al di qua e ora al di là del confine dellarealtà, senza saper sempre distinguere i due piani e lo dimostra chia-ramente chiedendosi, in un emistichio che si ripete martellante eidentico, «Ricordo – o sogno? –» (54), nella poesia Il gioco del si-lenzio.
10. Questa tensione presente nell’opera poetica, derivante in par-te anche dalla crisi che in quel momento attraversava la letteratura
VARIETÀ126
(52) Ivi, p. 62.(53) [Gozzano è stato] «il primo che abbia dato scintille facendo cozzare l’auli-
co con il prosastico». (E. MONTALE, Saggio introduttivo a G. GOZZANO, Le poesie, Mi-lano, Garzanti, 1960, p. 9).
(54) G. GOZZANO, Poesie cit., p. 143.
e ne stravolgeva linguaggio e contenuti, sfocia nelle atmosfere gri-gie, negli ambienti pallidi, nel clima di diffusa stanchezza e, soprat-tutto, malinconia. Fanno eccezione alcuni slanci di autentica gioia eacceso sentimento: il più evidente consiste nella contemplazione del-le meraviglie della natura. Questa, infatti, resta esente da ogni om-bra di negatività, è presente in tutto il suo percorso poetico, tantoda divenire materia prima della sua ultima opera. Le farfalle sono laprova dell’incorruttibilità dell’amore per la natura, un esperimentodi poesia completamente nuova, in una veste lirica epistolare anticae desueta, che doveva rappresentare, nella visione del poeta, il su-peramento dei conflitti e il rinnovamento degli orizzonti della suapoetica.Proprio in questo poema incompiuto, si concentrano molti rife-
rimenti a quell’universo fiabesco che accompagna l’autore. Qui, piùche un valore testuale, hanno senso nell’ottica della meraviglia chel’opera vuol trasmettere. La materia entomologica si sposa con na-turalezza con una serie di riferimenti e di spunti fantastici che ar-ricchiscono la trama del reale. Gozzano usa immaginare e compor-re secondo schemi di fiaba. Le similitudini e i paragoni tra il Papi-lio e il cavaliere, tra la Vanessa e una principessa rivelano il desi-derio del poeta di costringere la realtà della natura in una incasto-natura fantastica che le permetta di brillare il più possibile. E così,ancora, il Parnasso sarà avvicinato ad «una principessa delle nevi /volta in farfalla per un malefizio» (55), nella forma delle crisalidi«un minuscolo drago vi ricorda / il dorso formidabile di punte»(56). Quando poi si trova ad avere tra le mani una farfalla esotica,il volo della fantasia arriva a coprire un intero paesaggio:
E la farfalla che non so pensaresui nostri fiori, sotto il nostro cielo,ben s’accorda coi mostri floreali:gnomi panciuti dalle barbe pendule,ampolle inusitate, coni lividi,evocanti la peste e il malefizio;s’accorda coi paesi della favolasopravvissuti al tempo delle origini:vulcani ardenti, moli di basalto,foreste dal profilo miocenico (57).
La trasfigurazione in senso fiabistico è potente, anche se coin-volge solamente l’aspetto esteriore della realtà descritta. Perché que-sta vena fantastica trovi autentica legittimazione e autonomia è ne-cessario rivolgere lo sguardo alle fiabe. Ogni intenditore d’arte è co-
VARIETÀ 127
(55) Ivi, p. 264.(56) Ivi, p. 259.(57) Ivi, p. 278.
sciente del fatto che un vero capolavoro spesso è contornato da unacornice che ne mette in risalto lo splendore. Essa deve essere sem-plice, per non distrarre lo spettatore dall’opera, e deve sapervisiadattare, deve contenere motivi e fregi chiari ed essenziali, che, conla loro elementarità, parlino tanto all’opera quanto a chi la osserva,per poterne sostenere lo sguardo.
ELISABETTA TONELLO
VARIETÀ128