Dalla Repubblica Napoletana all'unità d'Italia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dalla Repubblica Napoletana all'unità d'Italia
Dalla Repubblica Napoletana all’unitàd’Italia
Resoconto delle lezioni tenute dal prof. LUIGI MASCILLI MIGLIORINI nella Scuola Estiva di Alta Formazione di Apice – Estate 1997
A cura di
LUCIA GANGALE
L’EREDITÀ DEI LUMI
La pace di Aquisgrana aveva determinato due cose: 1)la parziale restituzione di autonomia politica adalcuni centri vitali della Penisola: Toscana e Regnod’Italia; 2) la decadenza di Genova e Venezia dopo leguerre di successione. A queste Venezia non avevapartecipato, eppure la sua neutralità non era segno diforza politica, ma di debolezza, come nel Settecentoebbe a scrivere il Muratori, il quale guardavaall’indietro nelle vicende storiche italiane edeuropee.Dal 1748, anno della pace di Aquisgrana, al 1796,
anno della venuta dei Francesi in Italia conNapoleone, l’Italia gode di un lungo periodo di pace.Si sviluppa la civiltà dei Lumi, grazie appunto allecondizioni esterne di pace. Tuttavia si tratta di unapace di tipo nuovo (Muratori non lo capisce), perchél’ Italia era da troppo tempo in pace, dal 1559, conCateau-Cambresis. Machiavelli dice che l’Italia nonera più allenata alla guerra e che nel suo territorionon scendevano neanche più soldati stranieri.Nel resto d’Europa, invece, si combatte. L’Italia
non richiedeva la pace, ma un reinserimento nella
12
grande politica europea, da cui era esclusa dal lungoperiodo di pace.Montesquieu dice che l’Italia è un paese ai margini
del mondo. Proprio perché tagliato fuori dalla realtàdell’equilibrio europeo. In realtà la decadenza erainiziata alla fine del Cinquecento, a causadell’apertura delle rotte atlantiche, ed avevariguardato tutto il Mediterraneo.Negli effetti determinati dalla pace di Aquisgrana
si ravvisano le origini del Risorgimento Italiano. Il1748 è l’inizio del Risorgimento italiano, dovuto alprofondo mutamento delle dinamiche politiche edell’assetto europeo, che scricchiola. Il fatto chel’Italia fosse oggetto di trattative diplomatiche nonè riduttivo, ma propulsivo delle problematiche cheesploderanno dopo il 1848, quando si capirà che tuttigli squilibri europei passano per una sistemazionedell’Italia, fatta di tanti staterelli.I problemi che si pongono a questo punto sono due:
1) la formazione degli Stati indipendenti; 2) ilreinserimento dell’Italia nell’equilibrio europeo. L’Illuminismo italiano nasce con queste premesse.
Il Risorgimento italiano si porrà tre problemi: 1)indipendenza; 2) libertà; 3) unità territoriale delpaese.Indipendenza significa indipendenza dallo straniero,
attraverso la distinzione tra cos’è italiano e cosanon lo è, ed attraverso la dotazione di soldatiautonomi. L’unità significa superamento della divisione in
Stati.Indipendenza, libertà e unità sono i tre ideali
incarnati nel Piemonte di Cavour.
12
I soggetti politici che porteranno avanti questeistanze sono diversi e se ne fanno portatori in tempidiversi. Il panorama è estremamente complesso.È errato vedere nella cultura illuminista un segno
dell’unità, ma c’è il tentativo di rifare degli Statiitaliani, cioè il tentativo di modernizzazione dellerealtà politiche all’interno degli Stati uniti dallapace di Aquisgrana. Tentativi attuati da sovranoilluminati come Leopoldo II di Toscana e Carlo III aNapoli. In questa operosità riformatrice spiccano treelementi:1) Ci sono problemi specifici nei vari Stati italiani:Beccaria li individua in Lombardia, Genovesi inCampania. E vi sono esperienze affidate ai carteggitra gli intellettuali. Ma vi sono anche problemicomuni a tutti gli Stati italiani;
2) L’Italia non è entrata nella modernità. Tra la finedel Quattrocento e l’inizio del Cinquecento nasconogli Stati europei ed inizia la differenziazione fraStato e Chiesa. Tutti questi eventi sono mancatiall’Italia. Quindi l’Italia diventa uno spazioriconoscibile, uno spazio fisico-politico espulsodalla modernità e che gli illuministi italianivogliono far entrare nella modernità.Nell’Illuminismo italiano vi è il senso di unasubalternità alle grandi capitali europee. L’abateGaliani, dopo essere stato a Parigi, afferma, unavolta tornato a Napoli, che gli sembra di esseretornato in prigione. D’altro canto vi è anche larivendicazione di un primato. Con Alfieri vi è lariscoperta del nostro Trecento e Cinquecento e lavalorizzazione di un’idea di Toscana come centrodella modernità. Vi è, cioè, un momento diriconsiderazione dell’Illuminismo italiano che non siaccontenta delle considerazioni negative. Il Principe e le
12
lettere è una lettura critica dei limiti insuperabilidel riformismo settecentesco italiano;
3) E qui entra in gioco il terzo punto. Laconsiderazione dei limiti del riformismo postula unacollaborazione tra le classi dirigenti ed ilPrincipe, tra sovrani e riformatori ed intellettuali.Però solo alcuni, come Carlo III e Pietro Leopoldo,sono dei grandi riformatori e, negli anni ’80 lapolitica di quest’ultimo si arena per tre ordini diragioni:1. Difficoltà a svolgere una politica economica chepossa essere conflittuale con la politica degliAsburgo;2. Difficoltà a costituzionalizzare il suo governo;3. Difficoltà ad opporsi alla Chiesa.Carlo III, dal canto suo, guardava in Spagna, sul
cui trono si insedierà. Quindi ha ragione Alfieriquando se la prende col Principe e rivendica all’uomodi lettere italiano il diritto di essere il soggettoriformatore, perché il Principe si rivelerà indegnoalle speranze in lui riposte dai nostri intellettuali,preferendo tornare alle vecchie alleanze, rinunciandoalla tendenza riformatrice, che si avrà solo con laRivoluzione, con l’armata francese.Dunque, a metà degli anni ’80, l’Italia è diventata
consapevole dei suoi mali, ma c’è un impasse politico.Tra l’80 e il ’90 l’Italia è disorientata, ed ha lasensazione che da sola non ce la fa. Vi è una perditadello slancio riformatore. Sarà lenta la penetrazionedella Rivoluzione Francese. Il riformismo presenta deilimiti. Si capisce che il problema unitario va risoltotutti insieme.
GLI ANNI FRANCESI
12
La crisi del riformismo settecentesco è evidentealla fine degli anni ’80.Il riformismo deve superare lo schema degli Stati
regionali, dei Principi a cui ci si era rivolti neglianni ’50 e ’60 e che pure avevano recepito le istanzedegli intellettuali. Si attende quindi qualcosa che lasocietà italiana è incapace di fare da sé. Sipercepisce l’esistenza di un limite da scavalcare conun apporto esterno.La decadenza faceva capire che c’era bisogno di
rovesciare la pelle morale degli Stati italiani.I viaggiatori stranieri e italiani concordano nel
ritenere che l’Italia va rinnovata dal punto di vistamorale, prima ancora che culturale ed economico.L’Italia è lontana dai grandi modelli culturalieuropei. Predomina la vita ecclesiastica (Montesquieula chiama “il paradiso dei monaci”), la praticareligiosa è esteriore e produce il predominio dicinismo e cicisbeismo, che sono fenomeni malati emoralmente deboli. Inoltre da troppi secoli l’Italianon combatte, quindi la civiltà non viene allenataalle armi, non c’è più il gusto della gloria,dell’orgoglio personale, che è invece proprio deglialtri Stati europei, abituati alla pratica continua,anche se poco gradevole, delle armi.Siamo negli anni ’80-’90, si aspetta una seconda
scossa dall’esterno e questa è la prova di unapatologia che l’Illuminismo non è riuscita a curare.La dipendenza dall’esterno è un elemento negativo,perché significa che anche quelli che voglionoriformare l’Italia più di tanto non possono fare.Ci sono dei mali comuni, quindi lo sforzo di riforma
deve andare al di là dei singoli Stati.Dal 1794 al 1797 si parla di unità politico-
territoriale. Si verifica, infatti, una crisi del
12
riformismo regionale cui corrispondono i primifenomeni di unitarismo. Tra questi due momenti c’è unacontiguità maggiore di quella che si è portati acredere.Lo scoppio della Rivoluzione Francese fa il resto,
perché accelera e dà una possibile soluzione allacrisi degli anni ’80, dovuta alla mancatacollaborazione tra sovrani e intellettuali. Si capisceche ora si può risolvere di slancio questo problema.Ma quale rivoluzione di Francia gli italiani ritengonoutile a risolvere i suoi problemi? Perché in Francianon c’è una sola rivoluzione, ma tante rivoluzioni. Viè la rivoluzione del 1789, che è una rivoluzionepolitico-costituzionale, diretta all’ottenimento diuna carta costituzionale, rivoluzione che fallisce difronte alle resistenze del sovrano. Vi è la repubblicademocratica vagheggiata dai girondini. La repubblicaforte dei giacobini. La repubblica direttoriale. Gliitaliani guardano ad una sorta di misto tra quello chesi sarebbe voluto fare in Francia nell’89 e quello acui la Francia approda nel ’94, cioè una repubblica distampo borghese, con attuata al suo interno laseparazione dei poteri. Quest’ultima soluzione segueil filo logico delle vicende italiane. Il modellodemocratico robespierrista verrà dopo. L’idea didemocrazia costituzionale in Italia fallisce per leresistenze dei sovrani, quindi l’ideale è larepubblica francese della costituzione del ’95, noncerto quella girondina o quella del Terrore diRobespierre e Saint-Just. Per l’Italia sarebbe giàmoltissimo arrivare alle condizioni poste a base dellaRepubblica direttoriale. Il Terrore non è necessarioall’Italia, che non è col nemico alle porte.
12
Il 1796 è un anno cruciale per l’Italia: arrivaNapoleone. L’esperienza costituzionale francese èstata ormai presa a modello di riferimento in Italia.Non sono più plausibili esperienze monarchiche, inFrancia prima ed in Italia poi.Napoleone viene salutato da tutti come liberatore.
Lo sforzo militare della repubblica francesesostituisce quello italiano. Napoleone è un generalefrancese, venuto in Italia a fare le guerre francesi.Dalla primavera del ’92 la Francia combatte per
salvaguardare le conquiste della Rivoluzione. Nel ’95sembra prossimo il raggiungimento dell’obbiettivo:raggiungere la pace, consolidare le conquiste, avereil riconoscimento della situazione da parte deglialtri Stati.La Francia sino al 1796 non ha mai pensato di
insediarsi in Italia, perché vista come zonasecondaria nello scacchiere europeo. Con Napoleoneabbiamo una complicazione del problema. In un primomomento egli segue le indicazioni del Direttorio ditenere a bada gli Austriaci nell’attesa di godere ifrutti della Rivoluzione. Ma Napoleone ha anche delleambizioni personali ed una visione tattica estrategica molto precisa del problema all’internodella situazione che si trova a vivere.Visione tattica: il fronte italiano è tutt’altro che
secondario. Infliggere una severa sconfittaall’Austria è un’operazione che va effettuata non sulfiume Reno, ma nelle pianure lombarde.Visione strategica: questa è più ampia della prima.
Nella considerazione di Napoleone l’equilibrio europeonon si risolve lasciando la penisola italiana daparte: occorre una re-immissione dell’Italia e delMediterraneo nel contesto dell’equilibrio europeo. Ilvero momento di risoluzione della Rivoluzione Francese
12
non è la pace con l’Austria, così pensa Napoleone, edinoltre questa passa attraverso un confronto conl’Inghilterra, grande potenza marinare.Vi è pertanto il problema della durata degli assetti
europei. Napoleone è il continuatore delle stirpipolitiche e militari della Rivoluzione rancese, in cuil’Italia è il modello decisivo di questorimodellamento.Napoleone III riprende la problematica del primo
Napoleone. La guerra in Crimea, l’impresa in Messico,costituiscono il quadro generale in cui si incardinala politica piemontese ed il raggiungimento dell’unitànazionale.Tra Carnot, membro del Comitato di Salute Pubblica
prima e del Direttorio poi, e Napoleone primo, ci saràuno scambio di lettere di fuoco. Carnot domanda algenerale francese cosa ancora si riprometta diottenere in Italia dopo avere conquistato il Piemontee sconfitto l’Austria, e gli dice di fermarsi. MaNapoleone, oltra ad essere un grande generale, è ancheun uomo politico di notevole intelligenza e finezzapolitica. Difatti il Direttorio, pur non tenendoall’Italia, consiglia a Napoleone di buttarsi inLombardia e di continuare la Rivoluzione, senzapreoccuparsi dell’Austria. Il fondo del ragionamentodi Napoleone e sta nella considerazione che gliAustriaci non sono ancora stati sconfitti ed hannoancora dei rinforzi. Per assediare Mantova, la cittàin cui si era rifugiato il comandante austriaco,Napoleone non esiterà a violare la neutralità dellaRepubblica di Venezia.L’altro grande nemico della Rivoluzione Francese è
lo Stato pontificio. Col Papa e col Regno di Napoli,Napoleone pensa di fare la pace nel ’96.
12
La visione del problema austriaco è ben nitida nellamente di Napoleone: finché c’è l’Austria in piedi ilproblema austriaco non può essere risolto. In questaguerra contro l’Austria l’armata francese si darà asaccheggiare e depredare la penisola, cosa dalla qualescaturiranno i malumori contro i “liberatori”. Altroelemento da tener presente è che i francesi nonconsiderano l’Italia dalla Toscana in giù.Gli effetti prodotti in Italia dai francesi
trascendono la logica italiana, ma in questo momentosi sviluppa la coscienza che bisogna fare da sé,risolvere i propri problemi senza dipendere daglialtri.Una volta che la rottura si è prodotta si capisce
che non bisogna appoggiarsi: occorre invece far levasulla rottura che si è prodotta per fare da sé.Bisogna mobilitare il popolo.Come si vede, la lezione è salutare. Gli italiani si
devono attrezzare e questo sarà il grande tema dopoCampoformio (Campoformio salva la RepubblicaCisalpina).L’esperienza delle Repubbliche del ’98-’99
(napoletana, romana, genovese), frutto dellaribellione ai Francesi, ha un duplice significato:
1.È una testimonianza morale degli italiani diemanciparsi;
2.È una prova effettiva dell’emancipazione italiana.Gli italiani le repubbliche le volevano fortemente,
perché avevano voglia di modernizzarsi e di adeguarsiai grandi modelli europei. Il Risorgimento si spieganel quadro internazionale, e l’Italia si fa trovarepreparata.Con le controrivoluzioni del ’99 cadono le
Repubbliche del ‘98-’99. Molto si deve al ritiro delletruppe francesi ed al recupero di quelle austriache.
12
Le bande popolari sono motivate alla controrivoluzionee non esiste ancora una coscienza di nazione. Dalcanto suo la Chiesa è molto infastidita dai processidi modernizzazione, cosa che succede solo in Italia,mentre negli altri Stati deve fare i conti con imodelli statali, modificando il suo comportamento.Dunque, solo in Italia la Chiesa resta ancorata a
modelli di controriformismo del Settecento,manifestando la sua tenacia conservatrice.Vi è poi il ruolo delle culture popolari, della loro
lunga durata ed esplosione nella reazione sanfedistadell’89. Vi è, cioè, il problema delle masse popolari,della mancata riforma agraria, soprattutto in Italiameridionale, come evidenzia Cuoco nel Saggio storico sullaRivoluzione napoletana del 1799. Da ciò il brigantaggio, ilquale dimostra che alcuni caratteri della storiaitaliana erano ben duri a morire.Dopo il 1800 Napoleone è in Italia definitivamente.
Gli effetti sono: 1) la disillusione definitiva; 2)l’accordo con i Francesi.Il ragionamento seguito in Italia è questo: se i
Francesi perdono, torna la conservazione in Italia,oppure questa è una buona occasione di sviluppo. Ilche equivale a dire: all’ombra della protezionefrancese cerchiamo di risolvere i nostri problemi.Facciamo crescere il popolo grazie alla protezione diNapoleone.È in sostanza il ragionamento seguito da coloro che
non accettano la delusione del 1799 e vogliono lacollaborazione dei Francesi. Cosa che si verifica nonsenza contraddizioni, come nel Foscolo, e ancor di piùnel Lomonaco, il cui caso è drammatico: dopo esserestato mazziniano e dopo la delusione delle attesegiacobine, costretto a fare il funzionario diNapoleone si suicida.
12
NELL’EUROPA ROMANTICA
Grande rilievo ha l’età napoleonica per laricostituzione della mappa territoriale italiana. Iltermine “italiano” è un termine speso negli anninapoleonici per indicare una formazione statale: laRepubblica prima ed il Regno poi. Esperienze, queste,estranee in gran parte all’Italia meridionale, perchéil Regno Napoleonico, con Giuseppe e con Gioacchino,non ha qui la capacità di attuazione pratica né dimobilitazione civile che, a partire dall’invasionedel ’96 e attraverso la Repubblica Cisalpina e ilRegno, ha in Italia centro-settentrionale.Importante è nel Regno Napoleonico, la
ristrutturazione delle circoscrizioni amministrative,i Prefetti, il rinnovamento burocratico: tutto ciò haun epicentro non nell’Italia meridionale, manell’Italia centro – settentrionale.Si tratta di conquiste che proseguiranno poi nei
regni restaurati, e lo stesso regno napoletanoadotterà non poche delle strutturazioni burocratichee giuridiche dello Stato napoleonico.A questo bisogna aggiungere una reintegrazione
dell’Italia nel mondo europeo, reintegrazione chetrova un esempio nella politica napoleonica dellestrade e con l’apertura dei valichi alpini, comel’apertura e la costruzione di strade che colleganola Pianura Padana alla Svizzera ed alla Francia.Non è questa l’origine della differenza Nord – Sud,
ma non c’è dubbio che nella redistribuzione dellegerarchie interne della nostra penisola e nellaarticolazione dei rapporti di comunicazione tra la
12
penisola e il resto dell’Europa, il nostro napoleonesvolge un ruolo decisivo. Il movimento verso l’Europaprosegue nell’età successiva con ritmo accelerato,con una integrazione dell’area centro settentrionaledel Paese verso l’Europa, nel corso dellaRestaurazione, che dà l’esempio perfetto dellapresenza dell’Austria – Ungheria nel Lombardo-Veneto(nel terzo decennio dell’800 si pone il problemadelle comunicazioni ferroviarie). La città che emerge con prepotenza dalla lettura di
Stendhal, come vero centro dell’Italia napoleonica epost-napoleonica, è Milano, dove pulsa una vita edove c’è un’adeguatezza ai tempi nuovi che non c’èneppure a Napoli, città che pure Stendhal nondisprezza, ma che anzi apprezza, soprattutto comeappassionato di musica, per il San Carlo, già allorail più grande teatro d’Europa. Tuttavia la musicamigliore già si comincia a sentire alla Scala.Vi è una ridislocazione nord – sud diversa dal
passato e che si riproduce all’inizio anche nelleprime tappe del processo risorgimentale. Si citanosempre, a questo proposito, le cospirazioni di Torinoe Napoli. Esse sono, è vero, molto importanti, madecisive sono anche le mancate cospirazioni di Milano(quella dei Berchet e dei Confalonieri) e dellaRomagna pontificia, due aree che erano stateprotagoniste dell’esperienza napoleonica.Il che significa che l’età napoleonica lascia in
eredità all’età successiva un ammodernamento dialcune parti del Paese: il centro-nord, non il sud.Non c’è dubbio, però, che col congresso di Vienna econ la fine dell’età napoleonica, l’Italia sembrirestituirsi ad una problematica precedente. Si èportati a credere che con il Congresso, con larestituzione, cioè, di vasti territori italiani ai
12
vecchi sovrani assoluti, con un preponderante ritornodegli austriaci, faccia tornare l’Italia a 23-30 anniindietro.In realtà il Congresso è molto meno definitivo di
quanto sembri. E questo per diverse ragioni.La prima è che il quadro generale di tutela della
sistemazione degli equilibri viennesi poggia suelementi della politica internazionale che nel girodi quindici anni verranno completamente stravolti.Poggia, cioè, su una depressione della presenzafrancese e su una sostanziale integrazionedell’Inghilterra liberale alle ragioni delle potenzeconservatrici, dell’Austria e della Prussia, cherispondeva alla logica dell’alleanza napoleonica, mache venuta meno la logica dell’alleanza napoleonica,non tarderà a distruggersi.Da questo punto di vista è importante la guerra per
l’indipendenza greca, perché è questo il primomomento in cui la Santa Alleanza scricchiola al suointerno, per quanto, quando si parla di Mediterraneoorientale, Austria e Prussia non avranno mai,assolutamente, lungo il corso dell’Ottocento, glistessi interessi. Per cui la sistemazione data dalCongresso di Vienna offre una garanzia internazionaleestremamente precaria.Il secondo elemento da tener presente è che la
sistemazione dell’Italia in tanti staterelli, datanel 1815, non rispecchia più la sistemazione del1789. Certo, molti soggetti sono gli stessi (sparisce la
Repubblica di Venezia, e non è cosa da poco), ma lalogica unitaria è profondamente cambiata.Prima, nell’Italia Meridionale dei Borboni vi era il
centro di forti interessi spagnoli. Ora è l’Austria
12
il soggetto decisionista di tutte le scelte post1815.Vi è una situazione squilibrata di fondo: la
penisola, guidata da un’unica potenza straniera,com’era prima del 1748, non può funzionare. Ma, inpiù, ora l’Austria offre agli Italiani un avversariopreciso. Di qui lo sviluppo di un forte sentimentoantiaustriaco. Il problema non è più se fareun’Italia repubblicana, federale o pontificia. Ilproblema prioritario diventa il raggiungimentodell’unità territoriale mediante la cacciata degliaustriaci.I primi tentativi in questa direzione sono i moti
del ’21-’21, poi ci saranno i grandi moti lombardidel ’22 e ’25, quindi l’esperienza del ’30-’31 con leprovincie unite ed il tentativo dicostituzionalizzazione dello Stato Pontificio.L’impero asburgico comincia a delinearsi come il
vero oppressore dell’Italia.Gli anni 1813-1815, anni della crisi del sistema
napoleonico, sono anni in cui Confalonieri ed ipatrioti lombardi vogliono uscire dal sistemanapoleonico, garantendo le autonomie statali al Nord.Questi tentativi falliscono: il fallimento conferma
l’impossibilità delle classi risorgimentali italianea risolvere i problemi italiani da soli. È evidenteche l’impero asburgico è il colpevole del fatto chenon si sono potute salvare le autonomie italiane.Dal 1748 al 1790 il processo si svolgerà in un
quadro europeo stabile. Dal 1815 in avanti vi è ilquadro instabile dato dal Congresso di Vienna. Il retentenna, Carlo Alberto, non è immaginabile tra isovrani settecenteschi. Le 5 Giornate di Milano nel’48 si svolgono con Carlo Alberto che tentenna adichiarare la guerra. L’Italia non è più quella del
12
1799: l’Italia ha una nuova attenzione nei confrontidell’Europa. Si ha anzi una riscoperta dell’Italia.Ricordiamo Stendhal ed i grandi viaggiatori delSettecento. Non è più solo un interessesettecentesco, soprattutto perché l’Europa èinvestita attraverso il Romanticismo da unriorientamento generale. Riscoperta dell’individuo,impasto di religione e sentimento, passioni, richiamidell’anima ai richiami dell’intelligenza, dovel’intelligenza non sarebbe tale se non fosse ancheanima.A Napoli, a Firenze, la natura italiana esprime
rapporti di natura e storia, intelligenza e cuore.L’Europa è fortemente sedotta dall’Italia e siincontra con una attenzione alle sofferenze ed aldolore sconosciuta alla civiltà del Settecento,mentre tali aspetti sono decisivi nella culturaromantica. Se non si soffre ci si precludeall’autentico, al profondo delle cose, non siconosce, si rimane in superficie. Cosa c’è di piùsofferente dell’Italia sottomessa all’Austria?Sono espressioni di questo sentimento Pellico,
Foscolo, Santorre di Santarosa, Schelling.La cultura è alla ricerca del pathos.Corinne ou l’Italie di madame de Staël è incentrata sul
personaggio di Corinne, poetessa romana, bruna ebellissima, quanto di più patetico si può immaginare.Essa viene incoronata del lauro poetico a Roma. Dilei si innamora un lord aristocratico inglese cheviene in Italia, ma lui è promesso ad una biondadiafana inglese. La lacerazione è totale. Lui lasegue. A Firenze si ritrovano insieme tra le tombe diSantacroce. Corinne incarna la sofferenza dell’Italiabellissima nazione, piena di bellezze naturali. Luideve scegliere tra la ragione del cuore e la ragione
12
delle convenienze sociali, ed essendo un inglesescegli la seconda. Corinna muore di dolore. Lui nonsarà mai felice. Attraverso Corinna è così celebratala grandezza della passione italiana, ma anche lagrandezza della decadenza, che il Settecento nonaveva riconosciuto.Nel 1830-31 si riconferma una centralità della
questione italiana nella coscienza culturale europea
IL QUARANTOTTO: MODERATI E DEMOCRATICI
Nel Risorgimento abbiamo due correnti: i moderati ei democratici. Definizioni che contengono una partedi verità.Sulle due questioni vitali, l’indipendenza (cacciare
gli Asburgo) e le libertà politiche, moderati edemocratici convergono e divergono al tempo stesso.Sull’indipendenza convergono soprattutto dopo il1830. Sulle strategie divergono.I democratici ritengono indispensabile un aiuto
esterno.I moderati fanno progetti diplomatici. Cesare Balbo
nelle sue Speranze d’Italia (1844) esprime l’idea chel’espansione dell’Impero asburgico nelle aree slava ebalcanica potrebbe essere contrappesata dall’unitàdell’Italia centro-settentrionale.La morsa dell’Austria impedisce all’Italia di
evolversi in senso moderno (costituzionale). Dopo il’48 si capisce che ciò è dovuto anche a motiviinterni. Però l’espulsione è necessaria per lacostituzionalizzazione degli Stati italiani. Bisognatogliere la cappa dell’Impero asburgico.I democratici fanno un altro discorso, e cioè una
distinzione tattica:
12
1 – Non ritengono che l’evoluzione del sistemapolitico europeo sia tale da indurre una traslazioneaustriaca. L’indipendenza non è frutto di unmutamento dell’equilibrio europeo. Non ci saràsistemazione diplomatica, ma un passaggio cruento: laguerra;2 – Dopo gli anni ’30 e ’40 non c’è nessuna potenza
europea a versare il sangue per l’Italia. Quindioccorre attrezzarsi da soli.Mazzini – interlocutore di Marx e Bakunin – esprime
l’autonomia del concetto di democrazia. Questa è unafamiglia politica autonoma nell’ambito delle famigliepolitiche che nascono in questi anni. Essa partedall’idea di uguaglianza privata:- La proprietà privata impedisce l’eguaglianza
(Rousseau);- A differenza del socialismo non ritiene che
l’uguaglianza passi attraverso la socializzazionedella proprietà privata, ma attraverso la suarimozione.
Non parla di rivoluzione sociale (collettivizzazionedei mezzi di produzione), ma dice che l’uguaglianzava restituita tramite le grandi decisioni collettive(Rousseau) grazie al suffragio universale, in cuiprevarrà l’opinione di coloro che non hanno proprietàprivata ma le braccia per il loro lavoro. Da qui ilproblema pedagogico di restituzione della fratellanzafra gli uomini. La democrazia fa leva sulla politicaper rimuovere le cause della disuguaglianza. IlRisorgimento è una delle articolazioni che lademocrazia ha ingaggiato contro la capitalizzazionein atto in Europa: i frutti del lavoro spettano allavoratore. Il profitto da capitale è però fuoridalla visione mazziniana. Giovane Italia e GiovaneEuropa non sono posizioni, ma parti di un progetto
12
importante di un liberalismo europeo e non solovisioni religiose. Il problema della sistemazionedegli Stati italiani interessa ora fino a un certopunto. Interessa l’emancipazione sociale e politica.Il soggetto che deve portare avanti questo progetto èil popolo. Però il popolo di Mazzini non hal’antagonismo del proletariato di Marx, e questo perdue ragioni:1 – Il proletariato di fabbrica di Marx non ha mai
agito da solo, ma spesso in collaborazione con altrisoggetti;2 – Il popolo di Mazzini è un soggetto politico: se
è una rivoluzione politica e non economica, mapolitica per finalità economiche, ha bisogno di unsoggetto politico. Ma la classe non è un soggettopolitico. Il popolo è un soggetto politico, quindinon molto definito. Invece la classe ha un ancoraggionelle strutture di produzione. Questo è l’elemento didebolezza del mazzinianesimo, non tanto nell’impiantoteorico, ma nell’individuazione del soggettopolitico, perché questo presupporrebbe due cose:1 – la mobilitazione di un universo urbano molto
piccolo (garzoni, camerieri) con esclusione dellacampagna. L’esistenza di questo soggetto ènumericamente scarso e solo urbano, con esclusionedelle campagne;2 – inesistenza di un a tradizione repubblicana
(democrazia repubblicana). Non sono tali né laRepubblica di Genova e quella di Venezia, né iComuni, che parlano di conflitto e non di unitàmazziniana.Con questo scarso radicamento nella realtà italiana
ecco la serie di speranze e fallimenti dellademocrazia mazziniana.
12
La società italiana è arretrata, ma in movimentoverso la modernizzazione. L’unitarismo mazziniano erauna considerazione politica che i fatti rivelaronofondata, dovuta alla percezione che una volta mossele acque era difficile fermare il processo dimodernizzazione (le richieste costituzionali sonoparte della rivoluzione mazziniana).Nel ’48 tre repubbliche combattono: Milano, Roma,
Venezia.Non abbiamo più gli episodi individuali del ’21-’21.
Quindi l’idea di Repubblica non ha i suoi sognatori,ma le sue milizie che si organizzano. La gente chearriva all’appuntamento del ’48 si è tutta formataall’interno dell’associazionismo mazziniano, chemolto più dei moti carbonari, pur con le sueillusioni e sconfitte, è legato all’associazionismoeuropeo.Nel Quarantotto napoletano gli intellettuali si
mossero intorno al Ferdinando di Borbone che avevadato la Costituzione al Regno. Vi è grande entusiasmoqui e nel ’48 toscano. Grande la delusioneconseguente. In entrambe le aree del Paese le fasceintellettuali vedono fallire il sogno di risolvere ilproblema italiano nel quadro europeo. I sovrani, comeavevano ben visto gli intellettuali soprattuttorepubblicani, non si sarebbero fatti portatori di undisegno di unità ed indipendenza del Paese.L’avvento di Napoleone aveva avuto ampie
ripercussioni in Italia.La risoluzione complessiva del problema nazionale è
impossibile. Ci riesce il Piemonte, con quell’uomogeniale che è Cavour.
DUE ITALIE
12
Il Piemonte della crisi del ’48-’49 era come ilprimo Stato ad aver dato uno Statuto, cioè il secondostatuto liberale di Carlo Alberto, che rimarrà anchenelle traversie politico-istituzionali successive.Nonostante la discutibile guerra condotta da CarloAlberto, il Piemonte fu il primo Stato ad avercombattuto contro l’Austria. Però esso era solo nelcontesto internazionale di tutta l’Europa. Bisognavaintessere una serie di relazioni internazionali piùsolide di quelle precarie di prima: si parla didecennio di preparazione. Grande artefice ne fu ilCavour. Si partiva da un sovrano d’accordonell’accettare la costituzionalizzazione di unoStato. A ciò mancava la vocazione unitaria, comunquenon era determinante. La grande politica cavourianadi certo guarda ad eliminare la casa Asburgica.Proprio a questo è diretta la costruzione di una retedi relazioni militari e diplomatiche, ma nel disegnocavouriano l’unità come appuntamento del giorno non èdato. Tuttavia l’unità è l’orizzonte della democraziaitaliana: in tale disegno rientra l’associazionismomazziniano, rientra l’insurrezione milanese del ’53ed in quest’ottica si colloca anche il tentativopisacaniano del ’57. Pisacane aveva molto riflettutosull’essenza del mazzinianesimo: in esso ravvisava ilmancato coinvolgimento delle masse contadine (ilsocialismo pisacaniano è più vicino albakunianesimo). Egli individuava nelle massecontadine il soggetto rivoluzionario per eccellenza.Il fallimento del tentativo pisacaniano è nel fatto
che il mondo contadino è lontano. La democrazia non èchiara sulla questione agraria, quindi non c’è unaspinta in massa verso la rivoluzione. Pisacanefallisce, ma anticipa l’esperienza garibaldina del’60.
12
Il moderatismo italiano deve darsi un quadro chesuperi l’espansionismo del Piemonte. Mancini,Spaventa, De Sanctis parlano di un Mezzogiorno chesta ancora con i Borboni e che deve cambiare, quindisi appella al Piemonte, “nuova Gerusalemme”. Gliintellettuali dovevano sacrificare le loro origini edancorarsi al Piemonte per permettere al Sud dicontinuare a vivere. Ecco perché loro vanno adinnamorarsi di un sovrano così poco plausibile comeVittorio Emanuele II.I Borboni sono stati incapaci di recepire le istanze
dei ceti intellettuali e dirigenti e le istanze dellamodernità.C’era la sensazione che per fare l’unità si perdeva
qualcosa del Piemonte, della Toscana, ecc. Ilmoderatismo arriva al superamento del quadropreunitario con grande difficoltà, a causa di retaggiantichi. Il Cavour vuole fare del Piemonte unsoggetto politico, attirare l’interessedell’Inghilterra e della Francia napoleonica, perprepararsi militarmente contro l’Austria.Nel ’57-’58-’59 il quadro unitario è più delineato
del ’48. Il “grido di dolore” viene lanciato daVittorio Emanuele all’apertura della CameraCisalpina. Gli accordi di Plombières non toccavanograndi soggetti della Penisola: Toscana, RegnoPontificio, Regno di Napoli. In questo quadroNapoleone III scende in campo al fianco del Piemonte.Cavour, uomo di grande finezza politica, sa che unavolta messi in moto gli eventi essi si svilupperannonel bene come nel male. Si parla di“piemontesizzazione”. La seconda guerra diindipendenza parte senza iniziativa per unificare laPenisola. La separazione tra classi dirigenti esovrani è matura. Nelle pianure lombarde le cose si
12
complicano. Le battaglie di Solferino e San Martinosono cruente. Napoleone III si spaventa. Si pensa aquesto punto ad un intervento della Prussia. Fermarsiin quel momento significa contentarsi di poco:l’Austria non esce dall’Italia ma rimane in Veneto epoi bisogna sistemare la Toscana. Infatti il governoRattazzi, dopo Cavour, non riesce a mettere mano allecose, perciò ritorna Cavour e risolleva le sorti. Lecose prendono una piega diversa. Riemerge l’idea delgrande tentativo insurrezionale del Mezzogiorno,recuperando lo spirito del Sud che Pisacane avevaintuito. Si parte dalla Sicilia, con Garibaldi.Cavour è ambiguo. Appoggia e non appoggia, fa fintadi non sapere. L’impresa di Garibaldi offre nel girodi pochi mesi il problema dell’unità perché anchel’altra metà della Penisola è liberale. Nel settembre1860 è venuto il momento di equilibrare lasituazione. Da una parte l’iniziativa regia haliberato il Centro – Nord; dall’altra l’iniziativadel popolo che ha liberato il Centro – Sud. Nelsettembre ’60 Mazzini chiede la Costituente.Garibaldi si incontra pacificamente con VittorioEmanuele II.Il garibaldinismo non è solo un condottiero valoroso
e leggendario nei suoi atteggiamenti personali ed iMille in camicia rossa: è anche, negli anni post-unitari, l’unica alternativa militare di popolo perfare l’unità. Non è folklore, ma politica.Alternativa al moderatismo. (Limiti della visionestrategica di Cavour). Mazzini non avrebbe rovesciatocasa Savoia, ma le avrebbe dato forza. Questo è ilpunto di fragilità dello Stato Unitario da cui nonsiamo mai usciti. Uno Stato con una legittimazionecostituente (voto popolare, centralità delParlamento, azzeramento nel 1860 delle posizioni
12
degli Italiani) avrebbe dato un’osmosi all’Italia. Cisono invece due Italie: moderati e democratici.Appena si incontrano si separano. Abbiamo due Italieregionali: il Sud si emancipava per via dievoluzione, il Nord deve avere l’iniziativa, reagire,ed ha il problema della piemontesizzazione. Con unPiemonte sacrificato politicamente eterritorialmente. Il Mezzogiorno non riconoscerà maial Piemonte una libertà di conquista, perché non èstato liberato da lui, ma solo il ruolo che avrà nel’60-’66 nella repressione del brigantaggio.Le due Italie sono socialmente diverse: un Nord
industrializzato ed un Sud economicamente arretrato.Ecco perché Gramsci parlerà dei limiti delRisorgimento e della questione meridionale. La causaè un insufficiente processo costituente all’indomanidelle conquiste garibaldine.La sofferenza di una democrazia in Italia ha
prodotto la divaricazione attuale.Il dualismo degli ultimi venti anni ha le sue
origini in una carenza di democrazia. È il segno piùpalese delle disfunzioni e delle patologie delsistema politico, del ruolo dei partiti, degliinteressi e della asfissia della democrazia.
12





























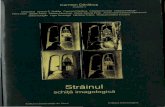
![In sacro vel publico. Tributi d'onore a personaggi eminenti tra Repubblica ed Impero, in RendPontAcc, 71, 1998-1999 [2001].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6343d96c6cfb3d406408efb7/in-sacro-vel-publico-tributi-donore-a-personaggi-eminenti-tra-repubblica-ed-impero.jpg)




![Qualités, nature et expérience des 'uomini militari' [le "métier des armes" dans la Storia d'Italia de Francesco Guicciardini]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/630be231210c3b87f409dc1d/qualites-nature-et-experience-des-uomini-militari-le-metier-des-armes-dans.jpg)









