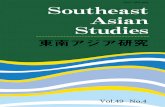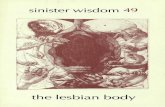Divagazioni storico giuridiche sulla Repubblica Romana del 49'
Transcript of Divagazioni storico giuridiche sulla Repubblica Romana del 49'
La Repubblica Romana e la figura di Pasquale
dè Rossi tra storia e realtà*
Indice: 1) il periodo storico; 2) il professore Pasquale
de’ Rossi; 3) il de’ Rossi politico; 4) la Costituzione romana
come esempio di democrazia; 5) la Comunità ebraica ai tempi di
Pasquale de’ Rossi; 6) la Roma del popolo; 7) considerazioni
conclusive;
----------------------------------------------
-----------------------------------
1. Il periodo storico
Negli anni della Restaurazione fino alla pubblicazione
della bolla Quod divina sapientia omnes docet di Leone XII (1823
– 1829)1 del 28 agosto 1824, l’Università o, per adoperare
la titolazione usata nell’intestazione dei documenti
prodotti dall’ateneo quasi fino al 1870, l’Archiginnasio2,
è retta secondo i principi approvati da Pio VI con il breve
Postquam divinae Sapientiae consilio del 15 luglio 1788. Il
1*E’ il testo, ampliato e con l’aggiunta delle note, della relazione presentatanell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, inoccasione del Seminario “Religione e diritto” (Dio e il popolo) per la ricorrenza del CLVIanniversario della Repubblica Romana, nei giorni 29 e 30 aprile 2005 del qualene è promotore il prof. Pierangelo Catalano. ? E. Momigliano – G.M. Casolari, Tutte le encicliche dei Sommi Pontefici, I, Milano, 1959,p. 155 ss.2 M.C. De Rigo, I processi verbali della facoltà giuridica romana 1870 – 1900, Roma, 2002
1
documento del papa Sermattei della Genga è diretta
conseguenza delle preoccupazioni avute su questo problema
essenziale da Pio VII e dal Cardinale Consalvi3. Il motu
proprio del 16 luglio 1816, infatti, all’articolo 247
stabilisce che “si rivolgeranno le pubbliche cure alla istruzione, ed alla
educazione della gioventù, primario oggetto di ogni provvido governo. Si
formeranno perciò quanto prima leggi, e regolamenti in tutto lo stato pel
sistema di università di studi, e di luoghi di pubblica educazione, per l’oggetto
non meno della religione, e della morale, che delle lettere e delle scienze”.
A questo proposito, viene varata una commissione
composta dai cardinali Della Somaglia, Litta, Pacca, Di
Pietro, Fontana e Bertazzoli, incaricata di studiare la
riforma dell’intero settore scolastico, con particolare
attenzione per quello universitario.
E’ elaborato un “Metodo di pubblica istruzione per lo Stato
Pontificio” presentato al pontefice Chiaramonti nel gennaio
1819, che avrà la sua novità di fondo, la congregazione
degli studi, (unico organo direttivo, discusso e
perfezionato), posta a fondamento della costituzione del
1824.
La bolla Quod divina sapientia omnes docet, dunque, dopo
avere stabilito il varo della congregazione, competente su
“tutte le Università, le pubbliche e private scuole di Roma, e qualsivoglia
corporazione, o individuo impiegato nella istruzione della gioventù”,
stabilisce una classificazione degli atenei. Alla prima
categoria appartengono quelli di Roma e di Bologna, con un
numero di cattedre non inferiore a 38, alla seconda quelli3 M. Petrocchi, La Restaurazione. Il cardinale Consalvi e la riforma del 1816, Firenze, 1941
2
di Ferrara, Macerata, Camerino, Fermo e Perugia con non
meno di 17 cattedre. Guida l’Archiginnasio con il titolo di
Arcicancelliere il cardinale camerlengo, mentre il rettore,
nominato in ogni università dal pontefice, ha affidata la
“vigilanza immediata riguardo alla osservazione della disciplina da osservarsi
dai professori, dagli studenti, dagl’inservienti, ed alla condotta morale e
religiosa dei medesimi”4.
E’ in questo scenario che si inserisce la figura di
Pasquale de’ Rossi il quale oltre ad aver ricoperto come
professore la cattedra di Diritto Romano nell’Università
“La Sapienza” di Roma, è stato anche, non dimentichiamolo,
membro qualificato del foro capitolino come titolare di un
avviato studio professionale5.
2. Il professore Pasquale dè Rossi
Il 14 ottobre 1847 viene emanato il motu proprio, che
organizza, preannunciata da una circolare del cardinale
Gizzi del 19 aprile 48’, la Consulta di Stato, organo
politico più che amministrativo, sottoposto a forti limiti,
e secondo la definizione ottimistica di Armando Lodolini “il
parlamento laico” dello Stato ecclesiastico composto con
elezione di terzo grado. Tra i 24 consultori nominati dal
pontefice, “attraverso terne proposte dai consigli provinciali alla
Segreteria di Stato, incaricato di esaminare leggi, debiti, dazi, appalti, tariffe,
bilanci preventivi e consuntivi dello Stato e di predisporre una nuova
4 S. Di Nardo, Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa (1534 – 1878),Città del Vaticano, 19605 M. Colagiovanni, Pasquale de’ Rossi un liberale nella Repubblica Romana del 49’, Roma, 2002
3
organizzazione degli enti locali, accanto ad un uomo dal grande futuro, Marco
Minghetti, e ad altri che avranno un ruolo non marginale nel periodo unitario,
quali Giuseppe Pasolini e il conte Pompeo di Campello, è rappresentante di
Frosinone Pasquale de’ Rossi”6. La designazione della Consulta,
salutata da una serie di manifestazioni in città e centri
minori della provincia ciociara, provoca aspettative ben
più vaste dei contenuti impressi e degli intendimenti avuti
dal pontefice7.
Solo un mese più tardi Pio IX forma un nuovo governo e
il 14 marzo viene pubblicato lo Statuto, che prevede, tra
le norme caratterizzanti, la nomina di due assemblee, di
cui una elettiva, ed altre disposizioni analoghe a quelle
previste nelle costituzioni di altri regni italiani.
L’allocuzione del 29 aprile attenuerà molti entusiasmi ma
non frenerà l’avvio della fase di irreversibile caduta del
potere temporale8.
Il 4 maggio il pontefice nomina dopo il rifiuto dei
cardinali Ciacchi ed Orioli, presidente del Consiglio un
altro porporato, il romagnolo Giovanni Soglia Ceroni.
Effettivo capo dell’esecutivo, come ministro dell’Interno,
è Terenzio Mamiani con de’ Rossi responsabile del dicastero
della Giustizia. Qualche giorno più tardi, il 10, è varato
il regolamento del Consiglio di Stato, previsto
dall’articolo 62 dello “Statuto fondamentale del governo temporale
degli Stati di S. Chiesa” promulgato nel marzo.
6 M. Alatri, Cenni biografici di Samuele Alatri scritti da suo figlio Marco, Roma, 18907 M. Colagiovanni, Pasquale de’ Rossi Professore e Colonnello nella Repubblica Romana del 49’,Roma, 20028 R. Aubert, Il pontificato di Pio IX, Roma, 200
4
L’istituto “è incaricato sotto la direzione del governo di redigere i
progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica e di dar parere
sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere al
medesimo conferito il contenzioso amministrativo”. Secondo l’ordinanza
del 10 maggio “di regola” l’organo è guidato dal ministro di
grazia e giustizia. de’ Rossi lo presiederà fino al 15
settembre 1848, fino, cioè, alla conclusione della sua
esperienza di governo.
L’avvocato - professore de’ Rossi nell’incarico
ministeriale si trova in singolare contrasto con le
posizioni espresse nelle discussioni preparatorie del
regolamento, svoltesi alla Consulta. de’ Rossi, dopo la
morte dell’avvocato Antonio Silvani, nella seduta dell’8
dicembre è eletto presidente della prima sezione, quella
legislativa. Andando a rileggere i verbali, curati dal
segretario l’avv. Luigi Ciofi, il 22 marzo 1848 l’illustre
professore comunica che è stato affidato all’organo l’esame
del progetto di legge provvisorio per il Consiglio di
Stato. Nominato relatore, il 2 aprile presenta la
relazione. “Si è questionato – riferisce il verbale – se la legge
debba determinare i casi e le materie in cui il Consiglio di Stato possa o debba
essere inteso dal Ministero. In quanto alle ordinanze e regolamenti di pubblica
amministrazione che il ministro emana senza sentire le due Camere legislative
e dove perciò manca la garanzia della discussione e deliberazione delle due
Camere, sembrò al professore De Rossi, e all’avv. Lunati che il Ministero debba
necessariamente sentire ed esplorare il voto del Consiglio di Stato; agli altri
della Sezione è sembrato che l’obbligo di sentire il Consiglio di Stato divida e
scemi la responsabilità del Ministero, la quale intera deve pesare su di esso e
perciò non doversi porre detto obbligo”.5
Sul contenzioso amministrativo il professore de’ Rossi
si era espresso nel febbraio, guidando i lavori della
sezione della Consulta, conclusasi con una proposta di
deferimento dell’intera materia al potere giudiziario
ordinario con la conseguente abolizione dei tribunali
eccezionali9.
4. Il de’ Rossi politico
L’avvocato di Vallecorsa interviene la prima volta
nella seduta parlamentare del 30 giugno: si dichiara ostile
ai grandi progetti legislativi spesso utopici e favorevole
ad una serie di innovazioni più realistiche e più rapide da
ottenere, riguardanti il pubblico ministero e la pubblicità
dei giudizi criminali. Il 6 luglio individua nella calma,
nella tranquillità e nella ponderatezza le prerogative
fondamentali di un efficace lavoro legislativo. Il 12
luglio fissa il cammino programmatico, rilevando la
necessità di predisporre un codice di polizia e di
riformare il Codice civile, criminale e di procedura,
avvertendo che “senza avere stabilito un regolare ordinamento dè
tribunali, l’edificio che vogliamo innalzare mancherebbe di base e
regnerebbero perpetuamente nelle vostre leggi la confusione e il disordine”.
E’ poi assai difficile non definire di singolare rilievo le
parole energiche, con cui, nel corso della seduta dell’Alto
Consiglio dell’8 luglio, de’ Rossi respinge l’ordine
gerarchico tra le due Camere, prospettato da un componente
9 M. Colagiovanni, Pasquale de’ Rossi un liberale nella Repubblica Romana del 49’, cit., p. 156ss.
6
il consesso di nomina pontificia (il monsignore Tommaso
Gnoli), rivendicando la “perfetta reciprocanza” tra le due
assemblee.
Il 28 luglio de’ Rossi presenta un disegno di legge
sull’abolizione dei fidecommessi e degli altri vincoli
contro la proprietà, “un autentico retaggio feudale, la cui soppressione
veniva reputata improcrastinabile da molti” e nella seduta, dopo aver
bloccato in uno dei primissimi atti, compiuti dopo
l’insediamento, “un energico proclama”, “minacciose adunanze di
plebi, furti e violenze” commessi ai danni degli ebrei, confortato
da parere espresso dal Consiglio di Stato, illustra un
progetto di legge, in base al quale tutti gli israeliti,
domiciliati nello Stato, sono “investiti del pieno possesso dei diritti
meramente civili” con esclusione di quelli politici attribuiti
dallo Statuto ai soli cattolici. Nella discussione,
svoltasi il 14 agosto, de’ Rossi si preoccupa di
rivendicare, correggendo un errore del relatore Borsari, il
merito della proposta, che ha addirittura efficacia
retroattiva.
Dopo l’abbandono di Mamiani, nonostante le voci corse
su un suo accantonamento, de’ Rossi è confermato anche con
l’esecutivo, che vede presente l’eminente Edoardo Fabbri.
La smobilitazione del programma nazionale è avviata con
questo governo di transizione (durerà in carica appena 40
giorni), indebolito anche dall’esclusione dei ministri più
vivaci, quali Pompeo di Campello e Giuseppe Galletti.
de’ Rossi, nel dichiararsi “custode” del diritto
costituzionale, nega esistano responsabilità da parte del7
ministero nell’allontanamento di Campello, e coglie
l’occasione per ricostruire l’effettivo svolgimento degli
eventi. Da ciò può agilmente cogliersi lo spirito e il
carattere liberale del giureconsulto di Vallecorsa10.
Il 16 settembre, giubilato Fabbri, entra in carica il
nuovo governo presieduto da Pellegrino Rossi. de’ Rossi
viene sostituito da Felice Cicognani e assume l’incarico di
vicepresidente della camera bassa, svolgendo le funzioni in
sedute sempre più incolori e inconcludenti, nelle quali,
però, opera con il più alto rispetto liberale
dell’assemblea.
Con l’uccisione di Pellegrino Rossi (15 novembre)11 e
la fuga di Pio IX (24 novembre)12, la situazione precipita
in un quadro di assoluta ingovernabilità fino alla
convocazione da parte dei componenti superstiti della
Giunta di Stato, varata l’11 dicembre dal Consiglio dei
deputati, e di sei ministri, di un’assemblea nazionale,
composta da 200 membri, eletta a suffragio universale da
tutti i cittadini di età superiore ai 21 anni, residenti da
oltre un anno nello Stato ed in possesso dei diritti
civili. L’elettorato passivo è riconosciuto ai maggiori di
25 anni. L’organo rappresenta “con pieni poteri” lo Stato.
Pasquale de’ Rossi il 28 gennaio 1849 è proclamato
all’8° posto tra i 12 eletti di Roma nella consultazione
10 A. Sacchetti, Vallecorsa Castello della Contea di Fondi, in Aa.Vv., La Terra Nostra Vallecorsa,Roma, 198411 L. Lacchè, (a cura di), Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1878 – 1848). Atti dellagiornata di studi, Macerata 20 novembre 1998, Milano, pp. X - 12012 D. De Marco, Il Tramonto dello Stato Pontificio, Torino, 1949
8
svoltasi una settimana prima. Raccoglie 7.706 consensi
mentre i primi due (Francesco Sturbinetti e Carlo
Armellini) ne vantano rispettivamente 16.153 e 13.175. La
sua presenza ha una brevissima durata. L’8 febbraio (la
Costituente è inaugurata il 5) è tra i pochissimi (5 su
142) ad opporsi alla richiesta di decadenza del potere
temporale ed è ancora nella esigua minoranza (10 su 143)
avversa alla proclamazione della Repubblica. Coerentemente
con il proprio indirizzo costituzionale, lontano dagli
intenti e dagli obiettivi di maggioranza, il 13 febbraio
rassegna, insieme a Curzio Corboli e a Terenzio Mamiani13,
le dimissioni.
Ancora prima di assumere la drastica posizione
politica, de’ Rossi il 22 gennaio veniva eletto, e non
nominato, con 222 voti, rimanendovi fino al 27 aprile,
comandante del battaglione universitario romano. Sue
attribuzioni sono “la guarentigia e l’ordine dè regolamenti”
dell’ateneo ed “il fornire i posti di guardia” nella sede della
Sapienza14.
4. La Costituzione romana come esempio di democrazia
Il 1848 è stato definito l’anno dei potenti, la
“primavera dei papali”15. In quell’anno i prìncipi dei vari
Stati italiani si unirono nella guerra contro lo straniero,
per affermare le idee di libertà e di patria con la
13 F. Partini, Terenzio Mamiani e i suoi tempi, Roma, 191114 M. Colagiovanni, Pasquale de’ Rossi Professore e Colonnello nella Repubblica Romana del 49’,cit. p.19 ss.15 C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia 1848 / 1948, Bari, 1974
9
benedizione del Papato16; e anche se l’esperienza non ebbe
il successo sperato, essa rappresentò, comunque, la prima
grande festa del “Risorgimento italiano”17. Come è noto, la
rivoluzione di Parigi e di Vienna, innescò le rivolte di
Milano e di Venezia (marzo 1848) favorendo l’intervento di
Carlo Alberto e la “guerra federata” contro l’Austria18. Pio IX
consentì a far partire le truppe pontificie contro il
generale Durando per il nord con l’esplicito compito di
tutelare e controllare le frontiere senza oltrepassarle19.
Di fatto, la Chiesa si poneva come nemica dell’Austria e,
indirettamente, con la sua partecipazione alle operazioni
di guerra conferiva all’impresa un carattere “cristiano”, di
“guerra santa”, in nome di una “Nazione santa”20. Nell’enciclica
del 30 marzo “Ai popoli d’Italia”, il Papa ribadiva il legame di
fede nazionale e di fede cristiana, e contribuiva a dare
alla guerra di liberazione italiana il significato di
“crociata popolare” contro i tedeschi oppressori21.
Con la guerra, la funzione del cristianesimo in seno
al nazionalismo italiano diventa finalmente esplicita:
nasce la “religione della patria” che legittima il sacrificio sui
campi di battaglia e dà un senso alla vita individuale22.
Ed ecco apparire l’esercito di cittadini costituito da
volontari dediti alla “causa nazionale”; una nuova categoria
16 G. Leti, Roma e lo Stato pontificio dal 1848 al 1870, I, Ascoli Piceno, 1991 p.15 ss.17 C. Spellanzoni, Storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, II, Milano, 193418 M. Adrani, Storia religiosa d’Italia, Firenze, 1965, p. 214 ss.19 P. Albers, Storia ecclesiastica, II, Torino, 1935, p. 55420 R. De Mattei, Pio IX, Asti, 200021 G. Martina, Pio IX, Chiesa e mondo moderno, Roma, 197622 P.S. Leicht, La legislazione ecclesiastica liberale italiana (1848 – 1914), in Aa.Vv., Chiesa eStato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra Santa Sede e l’Italia, I,: studistorici, Milano, 1939
10
di soldati che combattono per porre termine all’odiata
occupazione austriaca: guerra contro l’Austria per
l’Italia.
Va detto che il fenomeno dei volontari del ’48 si
colloca nell’orizzonte aperto della Restaurazione: la
nuova coscienza nazionale, maturata attraverso la cultura
romantica, antigiacobina23 e antirivoluzionaria, ha fatto
sorgere la figura del cittadino che corre alle armi per
difendere la Patria24. Per la prima volta si ritrovavano
insieme i vari popoli d’Italia a combattere contro il
comune nemico, offrendo al mondo lo spettacolo di un
“esercito italico e nazionale”25. E questo segnava l’affermazione
dell’ideologia neoguelfa, che per bocca del suo teorico,
Vincenzo Gioberti26, salutava nei valorosi soldati i
redentori d’Italia, che avevano saputo unire due termini da
secoli separati, la letteratura e la milizia, le idee e le
armi, la libertà e la monarchia italiana, grazie al
“magnanimo Principe riformatore e liberale”. La guerra continuò
anche dopo l’Allocuzione del 29 aprile, con la quale il
Pontefice definì la posizione della Chiesa, dichiarando di
non potersi associare alla guerra, data la sua missione
religiosa volta alla paca, e di abbracciare “tutte le genti,
popoli e nazioni con uguale studio di paternale amore”27. 23 L. Martorelli, Della monarchia. Trattato politico in cui si dimostra ch’essa è la forma di governo lapiù utile all’umana società, Roma, 1794 24 R. Romeo, Il giudizio storico sul Risorgimento, Catania, 196625 Cfr. “I progetti e la Costituzione della Repubblica Romana del 849”, a cura dell’Istituto perla documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Firenze,199926 G. Piolanti, Discussioni politico – letterarie dell’abate G. Piolanti contenenti la storia filosoficadell’ultima rivoluzione d’Italia così funesta allo Stato della Chiesa, ossia Dialogo fra l’autore e l’abateVincenzo Gioberti, Modena, 185027 G. Martina, Pio IX (1867 – 1878), Roma, 1990, p. 111 ss.
11
Ora, dati per noti gli accadimenti intermedi che hanno
caratterizzato gli ultimi mesi del ’48, la Repubblica
romana del 1849 e la sua Costituzione28, nata nel momento
stesso in cui la Repubblica moriva sotto il fuoco delle
armi francesi, sono state l’esperimento più avanzato di
democrazia fra tutti quelli che si sono prodotti nel corso
del Risorgimento italiano29. E’ sufficiente ricordare che
l’assassinio di Pellegrino Rossi, (15 novembre)30 la fuga
di Pio IX e la rovinosa fine dell’esperienza del papato
costituzionale, nonché il Monitorio papale31, con il quale,
tra l’altro, veniva comminata la scomunica nei confronti di
tutti coloro che avessero preso parte alla elezione
dell’Assemblea Nazionale, posero fine ad ogni possibilità
di ricomposizione tra il papato ed il movimento
democratico32, anche perché la posizione pontificia ebbe
l’effetto di far scomparire dalla scena politica proprio
quel partito moderato che proponeva per Roma un potere
papale costituzionale33.
La libertà e l’uguaglianza proclamate agli albori
della Costituzione Romana furono il postulato per una piena
acquisizione da parte degli Ebrei romani dei diritti civili
con la equiparazione all’interno della società civile34.
28 G. Arangio – Ruiz, Storia costituzionale del Regno d’Italia (1848 – 1898), Firenze, 189829 L. Bulferetti, Il Risorgimento nella storiografia contemporanea, in Nuove questioni di Storia delRisorgimento e dell’Unità d’Italia, Milano, 196130 L. Ledermann, Pellegrino Rossi, une grande carriere internationale au XIX siecle, avec de mombreuxdocuments inedites, Paris, 192931 A. Mozzati – P. Lombardi, Nel solco della storia, Torino, 196032 A. Muzzarelli, Dominio temporale del Papa, Roma, 178933 L. Salvatorelli, Chiesa e Stato dalla rivoluzione francese ad oggi, Firenze, 196834 G. Fubini, La condizione giuridica dell’Ebraismo italiano, dal periodo napoleonico alla Repubblica,Firenze, 1974
12
L’atteggiamento degli israeliti di Roma35 si collocò,
sempre in questo scenario di generale attesa nei riguardi
di un epilogo della situazione nazionale, in un contesto di
speranze fiduciose e di realistica saggezza36. Se il Ghetto
aveva significato separazione37, reiezione dal mondo
esterno, posizione sociale umiliata, fonte che riservava
dal di fuori amarezze quasi continue38, all’opposto aveva
anche significato una muraglia contro influenze
perturbatrici esterne, una rocca a protezione della propria
individualità, della propria tradizione e della propria
cultura. Così, anche la possibilità di una emancipazione fu
per molti segno di contraddizione: avvenimento allo stesso
tempo felice e terribile39.
Il costituente romano non solo non disponeva, come in
altri casi avvenne, di una base normativa da cui muovere,
essendo lo Statuto40 concesso da Pio IX nel marzo 184841
poco o per niente utilizzabile dal movimento democratico,
giacchè esso mitigava assai poco l’assolutismo papale, ma
per di più, nella situazione di totale vuoto di potere e di
rottura con il Papa che era venuta a crearsi, risultava
inevitabile che si vedesse, proprio nello Statuto42, un
ingombrante ostacolo politico da cui era opportuno prendere
35 D. Tama, Raccolta degli atti dell’assemblea degli Israeliti di Francia e del Regno d’Italia, Milano,198736 S. Grazyzel, Storia degli Ebrei, Roma, 196437 A. Milano, Il Ghetto di Roma, Roma, 196438 V. Colorni, Gli Ebrei nel sistema del diritto comune, Milano, 195639 G. Piperno Beer, Gli Ebrei di Roma nel passaggio dal governo Pontificio allo Stato Liberale Italiano,in Aa.Vv., La Breccia del Ghetto, Roma, 197140 G. Negroni – S. Simoni, Lo Statuto Albertino e i lavori preparatori, Roma, 199241 Checchini A., Stato e Chiesa dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana, Padova,194942 G. Audisio, Del governo rappresentativo in Piemonte e primi fatti di Pio IX, Torino, 1848
13
la massima distanza43. Si aggiunga, inoltre, che
l’Assemblea – fatto anch’esso unico – era stata eletta a
suffragio universale e con una partecipazione assai elevata
degli elettori, il che non poteva non influire nel senso di
una più marcata affermazione dei principi democratici44.
Tutto ciò suggerisce una prima considerazione: se, in
generale, la più recente dottrina è incline ad ammettere un
influsso diretto della Rivoluzione francese sul
Risorgimento italiano45, si deve convenire che, a più forte
ragione per le particolari tesi sopra esposte, tale
influenza abbia avuto un ruolo decisivo nel caso della
Repubblica romana46, nel senso che la Grande Rivoluzione e,
più precisamente, il pensiero e le posizioni politiche e
istituzionali dell’ala democratica di essa non possono non
aver costituito una fra le più importanti fonti di
ispirazione per la Costituente repubblicana47. E ciò anche
se non si può certo affermare che i democratici
disponessero della maggioranza nell’Assemblea Costituente
romana e sebbene nella Commissione incaricata il 13
febbraio 1849 di redigere il progetto, e ancor di più nella
cosiddetta Commissione mista che ebbe a formarsi (non senza
contrasti) dopo l’11 maggio, fossero rappresentate tendenze
fra loro diverse e contrastanti, da quella socialista e
43 M. Tedeschi (a cura di), Dalla restaurazione al consolidamento dello Stato unitario, Milano,198144 R. Di Cesare, I quattro Statuti del 1848, Torino, 189845 I. Raulich, Storia del risorgimento politico d’Italia, 5 voll., Bologna, 1920 - 192746 P. Mariani Biagini, I progetti e la Costituzione della Repubblica Romana del 1949, conintroduzione di Mauro Ferri, Firenze, 199947 L. Salvatorelli, Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870, 2a ed. Torino, 1941
14
democratico-giacobina, a quella liberal democratica e
liberal moderata48.
Il modello istituzionale di Roma repubblicana era
considerato riferimento ineludibile e quasi obbligato per
chi voleva si affermassero principi fortemente innovatori
in senso democratico e comunque tali da marcare il massimo
di discontinuità e di rottura nei confronti del regime
passato49.
Principio democratico, sovranità popolare, autonomia
municipale, garanzia dei diritti contraddistinguono la
concezione repubblicana posta a fondamento della
Costituzione della Repubblica Romana del 184950. Il
principio della sovranità popolare, espresso dal I dei
Principi fondamentali, e confermato dall’art. 15, titolo II
(Dell’ordinamento politico), secondo cui “Ogni potere viene dal
popolo”, si traduce nella preminenza dell’Assemblea eletta
dal popolo, che a sua volta elegge i tre consoli.
I costituenti romani del 1849 affrontarono anche il
tema delle garanzie costituzionali: a tale proposito, il
dibattito fu incentrato sull’opportunità di istituire il
tribunato, come potere moderatore e garanzia viva delle leggi
fondamentali. Il popolo era chiamato a svolgere funzioni di
garanzia tramite la partecipazione alla guardia nazionale
(art. 67) e la nomina dei Giudici del fatto, componenti del
Tribunale supremo di giustizia (art. 55). I repubblicani
del ’49, e quindi i costituenti e i legislatori, non ebbero48 A De Giuliani, L’interesse della religione nella sovranità temporale del Papa, Roma, 180049 A. Professione, Marzo 1848 – Marzo 1849, Novara, 189950 L. Bulferetti, Socialismo risorgimentale, Torino, 1949
15
una visione isolata della missione e del destino della
Repubblica e del suo popolo: i doveri della Repubblica si
estendono al miglioramento delle condizioni di vita degli
altri popoli, specie di quelli che combattono per la loro
indipendenza e “per la causa delle Nazioni e dell’Umanità”.
Dopo aver richiamato gli eventi che hanno preceduto e
preparato l’avvento della Repubblica Romana (e quindi il
governo costituzionale di Pellegrino Rossi, avverso ai
liberali, ai repubblicani e, in opposizione all’abate
Rosmini51, alla partecipazione popolare52; l’evoluzione in
senso rivoluzionario e repubblicano della stampa nel 1848,
l’attività dei circoli, l’assassinio dello stesso
Pellegrino Rossi e la fuga di Pio IX a Gaeta)53, si deve
ora porre l’accento sull’affermazione del principio
democratico, condiviso dalla quasi totalità dei membri
dell’Assemblea Costituente eletta nel gennaio 1849, fra i
quali vi era un forte nucleo repubblicano e mazziniano.
La “democrazia pura” – espressione adoperata nel
dibattito settecentesco a designare la forma di governo
repubblicana romana e greca, in contrapposizione alle forme
di governo “miste” – è adottata quale forma di governo fin
dall’art. 3 del Decreto fondamentale (9 febbraio 1849) con cui
viene dichiarato decaduto il Papato e proclamata la
Repubblica Romana54. L’inscindibilità del legame fra ideali
51 D. Zolo, Il personalismo rosminiano. Studio sul pensiero politico di A. Rosmini, Brescia, 196352 F. Traniello, Cattolicesimo conciliatorista. Religione e cultura nella tradizione rosminiana lombardo– piemontese (1825 – 1870), Milano, 196653 I. Montanelli, L’Italia del Risorgimento, Milano, 197254 G. Sabbatucci - V. Vidotto, Storia d’Italia. 1. Le premesse dell’unità, Bari, 1994
16
costituzionali, repubblicani e democratici è stato il
principio ispiratore dei lavori della Costituente romana.
Come già ricordato, la Costituzione romana del 184955
si distingue sotto diversi aspetti dagli statuti italiani
dell’epoca: votata in un’assemblea eletta a suffragio
universale, e non concessa da un sovrano; improntata al
principio democratico, pur previsto in altre costituzioni,
come ad esempio nello Statuto Albertino, ma qui assunto a
“principio esclusivo di organizzazione dello stato”; fondata sulla
sovranità popolare56.
Il principio democratico, insieme alla sovranità
popolare e alla forma di governo repubblicana, viene
esplicitamente riaffermato nel paragrafo primo della
Costituzione, la formulazione del quale venne difesa da
Saliceti, relatore del progetto presentato il 10 giugno
1849, contro quanti la consideravano in qualche modo
pleonastica57. Il saldo vincolo tra repubblica e
democrazia, individuato e consacrato nella Costituzione
della Repubblica Romana del 184958, prepara e facilita la
scelta del 1946 e la conferma nella Costituzione italiana
del 1° gennaio 1948, in cui il principio democratico, tutto
uno con quello repubblicano, espresso all’art. 1, è
55 M. Ferri, Dio e Popolo – Repubblica Romana 1849, Relazione presentata al XXISeminario Internazionale di Studi Storici “Da Roma alla Terza Roma” suRepubblica e monoteismi da Roma a Costantinopoli a Mosca, (Campidoglio, 21 – 23aprile 1999), estratto, pp. 3 - 1856 E. Crosa, La concessione dello Statuto: Carlo Alberto e il ministro Borelli, “redattore” dello Statuto,Torino, 193657 A.M. Ghisalberti, Roma da Pio IX a Mazzini. Ricerche sulla restaurazione papale del 1849 – 50,Milano, 195858 C. Selvaggi, La costituzione della Repubblica Romana, in “Studi in occasione del centenario”,I, Roma, 1970
17
adottato in via irreversibile, con la previsione dell’art.
139, che sottrae la forma repubblicana, e quindi il
principio democratico, alla revisione costituzionale59. In
particolare, il principio di sovranità popolare espresso
nell’art. 1 è una “precisa indicazione di diritto positivo”, che pure
ha faticato ad affermarsi rispetto al dogma della sovranità
dello Stato60.
Nel II dei Principi fondamentali della Costituzione romana
del 184961, contenente l’espressa abolizione di titoli di
nobiltà e privilegi di nascita, il principio democratico è
posto in relazione con i principi di libertà, uguaglianza e
fraternità62. Nel III Principio, che impegna la Repubblica
colle leggi e colle istituzioni a promuovere il miglioramento delle
condizioni morali e materiali di tutti i cittadini, emerge un elemento di
discontinuità della Costituzione della Repubblica Romana
del 1849 rispetto al modello romano antico: nel
sottolineare il riferimento ai cittadini invece che al popolo,
è stato definito ambiguo tale concetto, in quanto non esiste
se non per metafora un tutto chiamato popolo distinto dagli individui che lo
compongono63.
Il principio democratico si estende ai rapporti fra la
Repubblica Romana e gli altri popoli, che essa
“riguarda[…]come fratelli”, nel rispetto di ogni nazionalità, pur
propugnando quella italiana (IV Principio fondamentale,
59 C. Chisalberti, Storia costituzionale d’Italia 1848 / 1948 cit. p. 6360 G. Astuti, La formazione dello Stato moderno in Italia, Torino, 196761 P. Mariani Biagini, (a cura di) La Costituzione della Repubblica Romana del 1789. Testo eindex locorum, Firenze, 199862 F. Della Peruta, Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Torino, 197563 C Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia 1848 / 1948 cit.,
18
dove si recepisce la dottrina mazziniana, che pone la
Repubblica Romana a presupposto dell’unità nazionale)64.
Dal principio democratico discende altresì il
riconoscimento dei diritti dei Municipi (V Principio) e
degli interessi locali, norma del riparto territoriale della Repubblica (VI
Principio).
Nel riconoscimento dei diritti dei Municipi,
considerati come originari e limitati soltanto dalle leggi
di utilità generale dello Stato, risiede una differenza non
trascurabile tra la Costituzione del 1849 e quella della
Repubblica Romana del 1798, che istituisce presso ogni
municipio un rappresentante del governo centrale con poteri
di controllo e di annullamento degli atti contrari non solo
alle leggi, ma anche alle decisioni dell’esecutivo65.
Gli avvenimenti del 1849, l’esperienza della
Repubblica Romana, sorta sulle fondamenta di quella antica,
la sua Costituzione66, ci richiamano all’origine e al vero
significato dell’identità italiana, in cui tanta parte ha
l’antichità romana. La riflessione sul rapporto fra Roma,
la repubblica e il diritto consente di riappropriarsi di
tale identità, come già fecero verso la metà del XIX secolo
gli studenti e i professori dell’Ateneo romano67, che
interpretarono con spirito nazionale e internazionalista le
esigenze del cambiamento che agitavano la società in quegli
64 R. De Cesare, Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre, I, Roma, 190765 L. La Puma, Il socialismo sconfitto. Saggio sul pensiero politico di Pierre Leroux e Giuseppe Mazzini,Milano, 198466 A.M. Ghisalberti, Mazzini e la Repubblica Romana, ne “Il Risorgimento”, I, 1952, pp. 6 - 2767 C. De Rigo, I processi verbali della facoltà giuridica romana 1870 – 1900, Roma, 2002
19
anni, chiedendo e ottenendo riforme dell’insegnamento
universitario, e infine prendendo parte attiva alle vicende
del ‘48-’4968.
Attraverso la memoria del Risorgimento69 si rinsalda
il legame tra il presente dell’Italia unita e repubblicana
e Roma antica, anch’essa presente e viva, non solo con le
sue vestigia monumentali. Garibaldi70, che ebbe sempre
chiara coscienza del debito dell’Italia nei confronti di
Roma, lo disse con queste parole: “Se non vi fosse storia romana,
ove imparammo una patria comune; se giovane non avessi vagato tra le
macerie del gigante delle grandezze terrestri, io non saprei di essere italiano”.
5. La Comunità ebraica ai tempi di Pasquale dè Rossi
C’è da dire che la svolta vera e propria del Ghetto di
Roma si avrà solo con il 20 settembre 1870, allorché le
truppe regìe del generale Cadorna entrarono in Roma dalla
breccia di Porta Pia: allora, finalmente, il vecchio Ghetto
finì di essere tale, cioè di esistere.
Solo dopo la conquista della città di Roma la curia,
le varie istituzioni religiose e, in particolar modo Pio
IX, si chiusero tra le mura della Città del Vaticano
assumendo nei confronti del nuovo Stato italiano un
atteggiamento se non ostile quantomeno di isolamento,
invitando i cattolici a non partecipare alla vita politica
e scomunicando la casa regnante. In questo nuovo scenario
politico gli Ebrei, grazie alla mirabile opera di68 G. M. Trevelyan, Garibaldi defence of the Roman Republic, New York, 1907 69 C. Francovich, Albori socialisti nel Risorgimento. Contributi allo studio delle società segrete, 1776 –1853, Firenze, 196270 P.C. Boggio, Cavour o Garibaldi?, Torino, 1860
20
reintegrazione sociale e politica attuata dal nostro
Pasquale de’ Rossi, (l’abbiamo già detto e messo ben in
evidenza quando è stato trattato il profilo politico),
acquistarono finalmente pieni diritti di cittadinanza
italiana e vennero considerati alla pari degli altri
cittadini italiani. Tutto ciò contribuì perché la comunità
ebraica della città di Roma potesse finalmente uscire dal
Ghetto, acquistare proprietà immobiliari, esercitare le
professioni desiderate, dedicarsi allo studio ed alle
ricerche senza alcuna limitazione, intraprendere una
attività commerciale, industriale, finanziaria e
quant’altro.
C’è altresì da aggiungere come l’abbattimento del muro
del Ghetto abbia significato, nella incessante attività
svolta dal Ministro di Grazia e Giustizia Pasquale de’
Rossi, la fine delle restrizioni imposte agli Ebrei di Roma
sotto il pontificato di Pio IX e, l’inizio di una nuova
stagione imperniata di quei diritti civili che aveva avuto
nella Costituzione Romana la sua maggiore interprete.
L’articolo VII dei Principi fondamentali della Costituzione
della Repubblica Romana, proclamata il 9 febbraio 1849 così
recitava: “dal credo religioso non dipende l’esercizio dei diritti civili e
politici”; questo significava per la Comunità ebraica romana,
la piena emancipazione.
Ecco, si può partire da questo breve (ma non
certamente di scarso rilievo) articolo per affrontare il
tema della importante presenza degli Ebrei durante la
nascita della Costituente romana. Sicuramente delicato è lo21
studio dello status giuridico degli ebrei a Roma proprio in
quegli anni, condizione che si riflette nel testo
costituzionale del 1798-99 e successivamente, in quello del
1848-49.
Infatti, l’art. 6 della Costituzione della Repubblica
romana del 1798 conteneva l’affermazione in base alla
quale: “Ogni uomo nato e dimorante nella Repubblica romana, il quale
compiuti i 21 anni, si è fatto segnare nel registro civico e ha quindi dimorato un
anno nel territorio della Repubblica e paga una contribuzione diretta di fondo o
di persona, diviene cittadino romano”; ed ancora l’art. 354: “La legge
non riconosce né voti religiosi, né alcun impegno contrario ai diritti naturali
dell’uomo”.
Sempre nello stesso anno il Comandante della divisione
francese a Roma decretava che: “Gli ebrei, nei quali si riuniscono tutte
le condizioni prescritte per essere cittadini romani, non saranno soggetti che
alle sole leggi comuni per tutti i cittadini della Repubblica. In conseguenza,
tutte le leggi e consuetudini particolari relative agli Ebrei sono abolite”71.
Durante il biennio liberale, agli albori della
proclamazione della Repubblica Romana del 1849, il
contributo in termini di partecipazione della Comunità
ebraica agli eventi bellici e politici fu elevato, basti
ricordare figure come Samuele Alatri, Samuele Coen ed
Emanuele Modigliani, divenuti membri del Consiglio
comunale, oltre all’arruolamento di numerosi volontari
ebrei nella guardia civica.
71 I. Mereu, Storia dell’intolleranza in Europa, Milano, 1995
22
Tale partecipazione può senza dubbio considerarsi
determinante nelle sorti dell’esperienza repubblicana al
fianco di Mazzini e Garibaldi.
Ripercorrendo le tappe degli anni 1846-1848, si deve
notare come molta fu la speranza riposta nella pseudo
politica liberale di Pio IX dopo la morte di Gregorio XVI.
Infatti il cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti (salito
al soglio pontificio con il nome di Pio IX) si mostrò
subito di animo sensibile e generoso, pieno di nobili
intenzioni anche se privo di qualità politiche e di quel
senso realistico che forma il vero uomo di stato72.
Poiché notoriamente liberale e innovatore, gli occhi
di tutti erano rivolti a Roma con ansiosa aspettativa. I
primi atti di Pio IX, infatti, giustificarono quelle
speranze: amnistia, riforme, libertà di stampa e di
riunione, parole di pace e di progresso. Viva
soddisfazione, poi, suscitò nell’opinione pubblica la
nomina a Segretario di Stato del Cardinale Ghizzi,
considerato un riformatore. L’entusiasmo popolare perdurava
e le riunioni nelle piazze e nelle vie con il passare dei
giorni non accennavano a smettere. Entusiasmo che non
conobbe più limiti quando il Pontefice, in un messaggio al
popolo romano, sembrò affermare la sua particolare
predilezione per l’Italia concludendo con le fatidiche
parole: “Benedite, gran Dio, l’Italia!”.
In un simile clima di entusiasmo non deve destare,
quindi meraviglia che gli Ebrei dell’epoca esaltassero la72 M. Tedeschi, Cavour e la Questione Romana, Milano, 1978 spec. pp. 68 - 73
23
figura di Pio IX: il Pontefice liberale. Epigrafi,
discorsi, poesie, più o meno ispirate in italiano o in
ebraico, riflettevano le speranze e la gratitudine degli
Ebrei in quel tempo73.
La cronaca ci riporta che i rabbini delle varie città
tennero discorsi pieni di speranza e lodi, mentre gli Ebrei
di Senigallia, città natale del Pontefice, illuminarono a
giorno le finestre delle case del Ghetto. Lo stesso avvenne
a Roma: lapidi in onore del Papa furono collocate nei
Ghetti dello Stato Pontificio. E tutto andò secondo le
aspettative; l’avvento di Pio IX incise beneficamente anche
sulla vita della Comunità israelitica romana.
Tuttavia, sebbene il problema ebraico fosse posto sul
tappeto assieme a molti altri al fine di concludersi nella
tanto agognata liberazione, la benevola disposizione si
tradusse in una serie di provvedimenti di modesta e
circoscritta portata, che rientravano nel quadro di una
politica di dispotismo illuminato, affatto contraria a
modificare nella sostanza l’atteggiamento di fondo nei
confronti della Comunità ebraica.
Da questo momento in poi si cominciano a verificare
episodi di malcontento dovuti a misure, leggi, decisioni
contrarie a quell’atteggiamento di buonismo che il
cardinale Mastai Ferretti aveva fatto trasparire
all’indomani della sua salita al soglio pontificio.
73 C. Bonanno, L’età contemporanea nella critica storica, Padova, 1984, spec. p. 40
24
Il sogno di libertà però svanì del tutto al momento in
cui, Pio IX, abbandonata ogni tendenza liberale, in un
proclama datato 12 settembre 1849 richiamava in vigore il
sistema di segregazione civile e d’intolleranza religiosa
verso la Comunità ebraica romana74.
Oggi sappiamo, grazie al contributo di autorevoli
studiosi come il Laras, che Pio IX era avverso
all’emancipazione civile degli Ebrei, sia per conformazione
spirituale, sia per formazione culturale, sia per
un’intrinseca incapacità a temperare secolari atteggiamenti
di intransigenza e a filtrare, attraverso una realtà
sociale e politica premente ed incalzante, come era quella
dei suoi tempi, inveterate posizioni canoniche e papali. Ad
ogni atto del Papa, era in quei mesi attribuita una portata
che andava al di là del suo significato più ovvio ed
obiettivo, con la conseguenza di far assumere semplici atti
di umana sollecitudine e carità a veri e propri prodromi di
una linea programmatica ben definita e lungimirante.
Fu solo con l’Unità d’Italia, che gli Ebrei di Roma
raggiunsero quella piena e legittima uguaglianza dei
diritti civili e politici ottenendo la tanto agognata
emancipazione, proclamata e consacrata nelle idee
innovatrici della Rivoluzione francese75.
Se lo Statuto pontificio distingueva i diritti
politici da quelli civili, i deputati della Costituente
eliminarono questa distinzione; essi, oltre ad affermare74 A. Serafini, Pio IX dalla giovinezza alla morte, nei suoi scritti e discorsi, Città del Vaticano, 1958, p. 975 C. Michelet, Histoire de la Rèvolution francaise, tomo I°, 1952
25
che non erano riconosciuti privilegi di nascita o casta,
dichiararono esplicitamente che: “dalla credenza religiosa non
dipende l’esercizio dei diritti civili e politici”. Gli Ebrei, così,
completamente emancipati presero parte con slancio a questo
glorioso quanto purtroppo effimero spirito
risorgimentale76.
A tal proposito, come già menzionato precedentemente,
è opportuno ricordare come l’impegno profuso da Pasquale
de’ Rossi77, allora Ministro di Grazia e Giustizia, nel
riconoscimento dei diritti civili e politici all’interno
della Comunità ebraica fu fondamentale e oserei dire senza
precedenti, soprattutto in un clima di fermento quale
quello di quegli anni. E questa abile e proficua attività
politica è costantemente testimoniata dagli storici che si
sono occupati del periodo oggetto della nostra indagine.
Ecco perché, quindi, non si può non dar voce a quanto
sagacemente e rigorosamente scritto da uno dei maggiori
studiosi di Pasquale de’ Rossi (ma non solo), Michele
Colagiovanni78 il quale, attraverso un’opera certosina
presso gli archivi storici, è riuscito ad esaltare
l’operato del de’ Rossi, che io intendo quale artefice di
un evento epocale che, viceversa, sarebbe passato come
opera esclusiva di Pio IX, cosa che in verità non è stata:
l’abbattimento del muro del Ghetto di Roma avvenuto nella
notte tra il 17 e il 18 aprile 184879. Se è indubbiamente
76 G. Bedarida, Gli Ebrei e il Risorgimento Italiano, Pontedera, 1962, p. 31 ss.77 M. Colagiovanni, Pasquale de’ Rossi, un liberale nella Repubblica Romana del ’49, Roma, 2002, pp. 5- 30378 Ibidem, p. 26479 Ibidem, p. 264 nota 189
26
vero che Pio IX è stato colui il quale ha dato formale
disposizione a che le mura che circondavano il Ghetto
fossero abbattute, non può non tenersi conto di quanto la
decisione del Pontefice fosse il frutto di una politica
martellante messa in atto dal ministro di Grazia e
Giustizia Pasquale de’ Rossi, il quale, evidentemente aveva
sensibilizzato fortemente la decisione del Pontefice perché
fosse consapevole che questo evento rientrasse a pieno
titolo in quei riconoscimenti dei diritti civili e politici
presupposto necessario ed imprescindibile
dell’emancipazione del popolo ebraico. Il successivo
decreto con il quale il de’ Rossi Ministro intese chiarire
a tutta la nazione la portata del provvedimento, è solo
l’epilogo di un percorso iniziato già prima che
intraprendesse la breve avventura ministeriale proficua ed
intensissima80.
Questo è quanto ho inteso interpretare e di esternare
alla luce dei documenti (in verità pochi) che ho
consultato, ma direi sufficienti per spingermi fino a
formulare tale convincimento.
Molti, poi, furono gli Ebrei di Roma impegnati nella
difesa militare e molti di loro morirono per la causa
dell’Italia; lo stesso Garibaldi insistette perché alla
fortificazione delle mura si aumentassero gli Israeliti e che fosse alzato il
numero del contingente a 15 ebrei. Ma perché l’unione dell’Italia
potesse divenire una realtà operante anche per il popolo
ebreo, non era sufficiente una Costituzione, ma occorreva80 G. Piperno Beer, Gli Ebrei di Roma nel passaggio dal Governo Pontificio allo Stato LiberaleItaliano, in Aa. Vv., La Breccia del Ghetto, Roma, 1971
27
un processo di evoluzione culturale del popolo e di
purificazione dei privilegi, processo che solo nel corso di
molti anni avrebbe potuto consentire il raggiungimento
effettivo e concreto di quegli ideali81.
6. La Roma del popolo
Nella seduta del 12 febbraio 1849 – tre giorni dopo la
proclamazione della Repubblica, e due giorni dopo la nomina
del Comitato esecutivo – l’Assemblea Costituente Romana, su
proposta del “cittadino Filippo Tornabuoni, rappresentante della provincia
di Fermo” votò ad unanimità la seguente proposizione: L’illustre
Giuseppe Mazzini, propugnatore zelantissimo della libertà italiana, sia invitato
a Roma ed ammesso alla cittadinanza di questa nostra gloriosa repubblica82.
Subito dopo il Ministro Stermini presentò a nome del
Comitato esecutivo tre progetti di legge urgenti ed
importanti. Il primo di essi così stabiliva: Le leggi saranno
emanate, e la giustizia sarà fatta, in nome di Dio e del Popolo. Gli atti pubblici
porteranno l’intestazione: Repubblica Romana, e cominceranno colle parole: in
nome di Dio e del Popolo. L’Assemblea ammise l’urgenza e approvò
all’unanimità senza discussione la proposta83.
Coincidenza singolare e significativa. L’Assemblea
romana chiamava Mazzini a Roma e contemporaneamente
adottava la formula del pensiero mazziniano Dio e il popolo
81 R. De Cesare, Roma e lo Stato del Papa, dal ritorno di Pio IX al XX Settembre, Roma, 190782 M. Colagiovanni, Pasquale de’ Rossi, un liberale nella repubblica Romana del ’49, cit.83 Ibidem, p. 182 ss.
28
come fondamento dell’esercizio dei poteri della
repubblica84.
E’ importante notare, come si affermi il carattere
religioso in capo al principio della sovranità popolare, e
sul significato attribuito alla formula da Mazzini molto si
è discusso e molto si è scritto. Il carattere che lo stesso
Mazzini avrebbe voluto imprimere alla Repubblica era che
essa doveva essere il nucleo intorno al quale dovevano
raccogliersi le sollevazioni degli altri stati della
penisola, che avrebbero consentito la ripresa della guerra
contro l’Austria, ma non la guerra regia che si conclude
con l’armistizio Salasco, bensì una guerra di popolo che,
liberata l’Italia dallo straniero, avrebbe sancito
solennemente, con la Costituente Italiana, la Repubblica
Italiana, con Roma capitale85. Avrebbe preso corpo così il
vaticinio della terza Roma, dopo quella dei cesari e dei
papi, la Roma del Popolo, della santa alleanza dei
Popoli86.
Ma cosa intendeva Mazzini per “la Repubblica”?
E’ stato scritto, in particolare dalla storica Emilia
Morelli, che “La Repubblica democratica unitaria nazionale mazziniana è
una organizzazione essenzialmente religiosa, o meglio, morale”. A
sorreggere l’idea repubblicana di Mazzini vi era un altro
pilastro importante: Roma. La vera forza del nuovo Stato
unitario italiano trovava le sue radici nel mito di Roma,
nel quale stava la forza iniziatrice della nuova Italia.84 Ibidem, p. 18385 Ibidem, p. 18686 P. Tadini, Notizie politico – storiche sul Sinedrio degli Ebrei, Alessandria, 1987
29
Mazzini considerava fondamentale, connaturata all’idea di
Repubblica, la funzione educatrice. Scriveva a Roma nel
’49, ne “l’Italia del Popolo”, che la repubblica è “una istituzione
educatrice. Perfezionare la creatura, svilupparla più sempre nell’intelletto e
nella sua potenza d’amore, è l’intento supremo. Primo fra tutti è un’Educazione
nazionale generale per impulso governativo. Educazione…e non istruzione”.
Così Omodeo: “Il postulato repubblicano – per Mazzini – non è altro
che il corollario dell’autonomia morale del popolo cosciente della sua
missione”.
La breve vita della Repubblica Romana pur con le sue
luci ed ombre dimostrò nel popolo, nell’Assemblea, nei
governanti, nei combattenti che “in nome di Dio e del popolo” non
era una vuota formula: essa si era realizzata ed aveva
segnato in maniera indelebile la strada da percorrere per
l’avvenire.
Mazzini resterà sempre legato ai suoi romani: quando
un anno prima della sua morte darà vita con Giuseppe
Petroni, per tanti anni suo rappresentante a Roma, e con
altri fedeli amici a “La Roma del Popolo” farà uscire il primo
numero il 9 febbraio, data – scriverà nell’appello agli
Italiani – che “ricorda un periodo breve, ma splendido di gloria e
promesse, nel quale, di fronte ad una politica d’egoismo e paura prevalente in
Europa…Roma levò a solenne protesta il capo dal suo sepolcro, segnò la
protesta col sangue dei suoi migliori, e mostrò colla concordia di ogni ordine di
cittadini…quanta virtù di amore e potenza l’antica fede repubblicana varrebbe
a risuscitare un giorno nell’anima degli italiani. Una lunga scuola di gesuitismo
politico e di servile pazienza s’adoprò d’allora in poi a cancellare sotto un
colpevole oblio quel ricordo; ma in Roma le grandi memorie furono sempre30
germe di nuova vita, e se i romani non hanno mutato natura, le memorie del
1849 rifioriranno più rapidamente e più efficacemente ch’altri non pensi”.
7. Considerazioni conclusive
In questo contesto allora è naturale, direi
fisiologico, affrontare il problema del rapporto tra
modelli istituzionali antichi, in particolare dell’antica
repubblica romana e costituzione della Repubblica Romana
del 1849, premettendo una osservazione sul movimento
politico democratico e insieme eversivo dell’assetto
esistente, che mirava a realizzare l’indipendenza, la
libertà politica e l’unità d’Italia: il Risorgimento.
Risorgimento, perché, nel momento in cui si produceva
il tentativo difficile, talvolta drammatico, di costruire
un futuro italiano, nel quadro di una generale tendenza
europea all’affermazione nazionale, si sentiva l’esigenza
di fare riferimento alla passata storia d’Italia, nella
quale venivano ricercati “fatti, uomini, istituti che servissero – per
dirla con le parole di Luigi Salvatorelli – come esempio,
incoraggiamento, monito, preparazione”. Insomma, che avessero la
funzione di modello.
Quella parte della storia d’Italia che meglio si
prestava a tale scopo è naturalmente la storia romana e, in
particolare, la storia della repubblica, quella stessa
storia che ha esercitato un’influenza decisiva sul filone
di pensiero democratico della Rivoluzione francese, filone
31
che, a sua volta, ha impregnato parte cospicua del
patrimonio culturale dei pensatori politici e dei
protagonisti del Risorgimento.
Se questo è il quadro generale, e scusandoci con il
lettore per la ripetizione di cose già dette, si deve
aggiungere che nell’esperienza della Repubblica Romana del
‘48-’49 vi erano delle ragioni anche più forti e
specifiche, le quali favorivano la crescita di un
sentimento nazionale propendente, per quanto possibile, a
riallacciarsi direttamente alla tradizione e alla storia
dell’antico popolo romano87. Chi aveva ereditato la guida
dello Stato all’indomani dell’assassinio di Pellegrino
Rossi e della fuga di Pio IX88, ossia a seguito di una
rottura radicale dell’assetto politico preesistente, vedeva
nell’antica gloria di Roma e nella storia del suo popolo
una forma di legittimazione del movimento rivoluzionario e
dei suoi obiettivi politici89. I tratti peculiari insiti
nell’Assemblea Costituente Romana possono così
sintetizzarsi:
- il principio democratico del 1789 deve essere
considerato fonte essenziale a cui si è ispirato il
costituente romano del 1849;
87 M. Colagiovanni, Pasquale de’ Rossi un liberale nella Repubblica Romana del 49’, cit., p. 19888 M. Marocco, Vita e pontificato di Sua santità Pio IX, Torino (senza indicazione della data)89 M. Colagiovanni, Pasquale de’ Rossi, un liberale nella Repubblica Romana del ’49, cit., p.216: ”La verità è che l’agire del Professore – diciamo pure il suo pensieropolitico – equilibrato fino a essere accusato di immobilismo, non si prestava astiracchiamenti strumentali. In sostanza egli era stato anticipatore e poiinterprete di un Cattolicesimo aperto, conciliante, secondo le vedute del primoPio IX. Dopo aver difeso con le unghie le conquiste, aveva compreso che eranofinite nel nulla”.
32
- in modo del tutto analogo, il costituente romano si
è rifatto al Rosseau ed al modello rappresentato
dalla repubblica romana antica;
- tale modello è stato assunto in piena
consapevolezza, sulla base della convinzione che
esso fosse il più adatto e il più efficace, al fine
di garantire l’attuazione del principio
fondamentale scelto dai costituenti come cardine
dell’ordinamento della Repubblica, quello della
sovranità popolare;
- infine, e in forza di tutto ciò, si deve convenire
con quegli storici che definiscono la Repubblica
Romana del ’49 e il suo Progetto di costituzione come
l’esperimento più avanzato di democrazia fra tutti
quelli che si sono prodotti nel corso del
Risorgimento.
Tale Progetto fu presentato dal deputato Agostini,
relatore per conto della Commissione, il 17 aprile del ’49.
Esso, com’è noto, non fu mai approvato ed anzi, quello che
alla fine venne approvato si discosta fortemente dal primo
progetto proprio su alcuni dei punti più rilevanti. Il
Progetto, dimostra come il modello repubblicano di Roma
antica fosse stato assunto quale riferimento essenziale dal
costituente del ’49, il quale era riuscito a cogliere,
anche se non in tutti i casi, lo spirito più autentico di
quegli istituti e ad inserirlo nella realtà di uno Stato
contemporaneo, per molti versi diverso dall’esperienza del
33
passato. Mi riferisco al Consolato, al Tribunato, alla
Dittatura e, sebbene in modo più sfumato, alla Censura.
La Repubblica Romana non è stata una costruzione
dottrinaria, una improvvisazione di avventurieri, una
imposizione settaria90. Essa è stata, piuttosto, per
volontà e consenso di popolo non smentiti sino alla fine,
il risultato logico, organico di tutta una situazione, il
punto di arrivo di tutto uno svolgimento: situazione e
svolgimento che non erano solo italiani, ma europei. A Roma
si ebbe l’antitesi più netta, lo scontro idealmente
culminante fra l’Europa di Vienna e la nuova Europa, fra il
diritto vecchio e il nuovo. Di questo significato della
lotta, gli uomini della Repubblica (non soltanto Mazzini)
ebbero chiarissima coscienza. Fino all’ultimo non firmando
la capitolazione (che fu atto necessario del Municipio) e
promulgando all’ultimo momento la costituzione del
Campidoglio, essi opposero il diritto dell’Europa nuova
alla forza della Santa Alleanza. E perciò la Repubblica
Romana morì in piedi, tramandando ai posteri il 9 febbraio
1849 come una data capitale della storia europea91.
In tempi in cui, almeno nel nostro Paese, lo spirito
verso nuove riforme, anche per quanto riguarda le norme
costituzionali, sembra essere la ossessiva preoccupazione
di legislatori sempre più impegnati a legiferare in maniera
incontrollata, la lezione che viene dalla riflessione
90 L. Farini, Lo Stato Romano dall’anno 1815 al 1850, voll. I – IV, 3a ed., Firenze, 185391 L. Lancellotti, Diario della Rivoluzione di Roma dal 1° novembre 1848 al 1° agosto 1849, Roma,1850
34
dell’Agostini e dal Progetto di costituzione da lui proposto
potrebbe rappresentare utile materia di meditazione.
In questa breve e non certamente esaustiva analisi
degli avvenimenti storici che portarono alla nascita di una
delle repubbliche più importanti della nostra storia
italiana ed europea, non mi resta altro da aggiungere, se
non ricordare ancora una volta la figura di un personaggio,
quello di Pasquale de’ Rossi92, tanto sconosciuto quanto
determinante nella genesi della Costituzione Romana (e non
sembri una contraddizione, come abbiamo cercato di
dimostrare nelle pagine che precedono, il fatto che abbia
espresso voto contrario all’atto della nascita). Una figura
da molti dimenticata, solo da poco riportata alla luce, che
ci ha lasciato quello spirito di professionalità e umanità,
valori oggi troppo spesso messi da parte.
Faustino de Gregorio
Associato di Storia del Diritto
Canonico e Diritto Ecclesiastico
Unive
rsità Mediterranea di Reggio Calabria
92 V.G. Pacifici, Pasquale de’ Rossi, l’uomo, il professore e le pubbliche istituzioni, ( a cura dell’Amministrazione del Comune di Vallecorsa), Vallecorsa, 2001, pp. 1 - 28
35