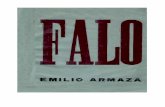Emilio Gabba storico di Pavia
-
Upload
college-de-france -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Emilio Gabba storico di Pavia
Estratto da:
BOLLETTINODELLA SOCIETÀ PAVESE
DI STORIA PATRIA
Anno CXIV2014
ISSN 2239-2254ISBN 978-88-205-1063-3
DARIO MANTOVANI
EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
1. Emilio Gabba si è spento il 12 agosto 2013 a Pavia, dov’era nato il 31 marzo 1927. La sua vita lascia un’impronta profonda, di uno storico e intellettuale italiano fra i maggiori della seconda metà del Novecento; di un professore che ha trasmesso il senso della storia antica a generazioni di studenti e allievi, dal 1958 a Pisa e dal 1974 nella nostra Università nonché nei prestigiosi Atenei dove è stato invitato a insegnare (da Berkeley a Philadelphia a Oxford); di un autorevole protagonista nel mondo accademico1; soprattutto, lascia il ricordo di un uomo compiuto, colmo dei pregi che la cultura uma-nistica può conferire quando non rimanga esteriore, ma divenga un autentico modo d’essere. Vir quo non alius doctior, quo non humanior alter.
Nel raggio amplissimo degli studi e dell’azione di Gabba rientrava anche la storia cittadina. A quest’aspetto, meno noto, ma non meno significativo della sua eccezionale personalità è dedicato il presente ricordo sul “Bollettino” di cui è stato direttore dal 1978 al 20032.
1 È stato direttore di “Athenaeum” e della “Rivista Storica Italiana”. Ha ricevu-to la laurea h.c. delle Università di Dijon, Mainz e Strasbourg. È stato membro delle principali accademie di cultura, dai Lincei all’Istituto Lombardo, dall’Accademia delle Scienze di Torino a quella di Napoli, dall’Académie des Inscriptions et Belles Lettres alla British Academy all’American Academy of Arts and Sciences.
2 Al profilo di storico dell’antichità ho dedicato un breve ricordo in “Athenae um”, 101 (2013), pp. IV-VI.
12 DARIO MANTOVANI
Mettere a fuoco Emilio Gabba quale cultore di Pavia, la sua “picco-la Patria”, sembrerebbe imporre un radicale mutamento di prospettiva rispetto all’immagine più consueta che si ha di lui, quella del profes-sore di storia antica e dell’uomo di cultura cosmopolita per relazioni e per sedi di lavoro. La distanza fra le due figure – fra lo storico dell’im-pero mondiale di Roma e lo storico locale – è invece minore di quanto si potrebbe pensare. La forma in cui ha coltivato la storia pavese corri-sponde, in effetti, a una delle principali direttrici del suo metodo, ossia all’indagine in chiave storiografica, incentrata sul modo in cui i fatti del passato sono stati tramandati. In questa prospettiva, “che cosa” non può essere separato da “come”: gli eventi da ricostruire (la storia) non possono essere disgiunti dai modi in cui sono stati rappresentati e trasmessi sino a noi (la storiografia); anzi, questi modi (a motivo della selezione e riconfigurazione che ogni racconto comporta) costituisco-no essi stessi fenomeni culturali e sociali meritevoli di essere valutati. L’angolatura storiografica, cui Gabba fu reso sensibile specialmente da Arnaldo Momigliano e che divenne a poco a poco preminente nei suoi studi sulla storia antica e sulla tradizione classica, è stata cruciale anche nell’attenzione che Gabba ha rivolto alle vicende di Pavia e ne costituisce a mio avviso il lascito più istruttivo in quest’ambito.
2. Proprio perché gli studi dedicati da Gabba a Pavia non rientra-no direttamente nel titolo della sua cattedra universitaria, sono riflessi particolarmente nitidi della sua personalità e si prestano a essere colle-gati al corso della sua vita, come cercherò brevemente di indicare.
Se si passa in rassegna la sua estesa bibliografia – più di ottocento fra libri, articoli, recensioni3 – un tema di interesse apparentemente locale fa la prima comparsa con il saggio su Le iscrizioni mediche di Pavia, pubblicato nel 1957 proprio nel “Bollettino della Società Pa-vese di Storia Patria”: nella sostanza, si tratta di un lavoro di epigrafia romana, perché le iscrizioni in questione sono due tavolette bronzee forse del III secolo d.C., conservate al Museo di Archeologia dell’Uni-versità, già edite da Theodor Mommsen (nel Corpus Inscriptionum Latinarum, V 6414 e 6415). Rispetto alla lettura e interpretazione
3 Che è registrata in due cataloghi di Bibliografia (1949-1995, a cura di An-selmo Baroni, Como, New Press, 1996; 1995-2006, a cura di Donatella Zoroddu, Como, New Press, 2007).
13EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
mommseniane, Gabba (allora trentenne) apporta notevoli progressi, chiarendo – grazie al senso pratico che gli era caratteristico e con pre-cise nozioni di botanica – che le due epigrafi sono «ricettari [...] alla mano e popolari»4, spacciati da un medico ciarlatano come risposte oracolari del numen o genius di una fonte d’acqua. Si direbbe dunque uno studio completamente immerso nell’evo antico, dove Pavia, anzi Ticinum, è coinvolta marginalmente, solo come sede del ritrovamento. Eppure affiora nell’indagine anche un’altra dimensione, che lambisce la storiografia locale (e può spiegare la scelta di pubblicare nel “Bollet-tino”). Le epigrafi mediche erano state lette dal Mommsen in occasio-ne delle due visite compiute a Pavia, nell’ottobre del 1867 e nel marzo del 1869, durante la sua perlustrazione dell’Italia a caccia di iscrizio-ni latine. Com’era allora abitudine, il sommo studioso tedesco si ap-poggiava nelle sue tappe a esponenti dei ceti colti locali, disponibili a prestargli aiuto e accesso ai documenti senza gelosie: a Pavia il suo referente era stato Giovanni Maria Bussedi, direttore della Biblioteca Universitaria, che ha immortalato l’incontro nel suo “Diario” (ricam-biato da Mommsen nel CIL V, p. 706: doctrina pariter atque modestia commendabilis)5. Dunque le due epigrafi mediche sono testimoni – ol-tre che del loro contenuto antico – anche di un episodio di storia degli studi, che rappresenta pure un tassello delle vicende civiche e culturali di Pavia (in particolare, dell’erudizione ottocentesca). Che non si tratti di un intreccio solo aneddotico lo dimostra bene una postilla al primo saggio pubblicata due anni più tardi da Gabba, Ancora sulle iscrizioni mediche di Pavia6. La visita di Mommsen a Pavia era stata studiata da Federico Ageno7, in una ricerca dedicata all’Appendix Mazochii Tici-nensis, cioè alla silloge epigrafica manoscritta unita all’esemplare degli Epigrammata Antiquae Urbis di Giacomo Mazzocchi (Roma 1521) conservato nella nostra Biblioteca Universitaria (dove l’Ageno allora era impiegato): una ricerca rimasta in buona parte inedita e che Gabba
4 EMILIO GABBA, Le iscrizioni mediche di Pavia, in “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria” [“BSPSP”], LVII (1957), p. 83.
5 Ora disponibile nell’esemplare edizione a cura di Mirko Volpi: GIOVANNI MARIA BUSSEDI, Diario 1864-1869, Milano, Cisalpino, 2013 (Fonti e studi per la storia dell’Università di Pavia. 67), p. 153; vedi anche pp. 22 s. e 28 ss.
6 In “BSPSP”, LIX (1959), pp. 111 ss.7 FEDERICO AGENO, L’Appendix Mazochii Ticinensis. I. Teodoro Mommsen a Pa-
via, in “BSPSP”, XVI (1916), pp. 53 ss.
14 DARIO MANTOVANI
– dopo la pubblicazione del suo primo saggio – ebbe modo di consul-tare tramite gli eredi dell’Ageno stesso, scoprendovi varie interpreta-zioni sulle tavolette mediche che anticipavano quelle da lui formulate. Dopo averne dato diligentemente conto nella postilla, Gabba con-cludeva: «ritengo superfluo discutere quali delle sempre interessanti proposte dell’Ageno ritengo possibili e quali, al contrario, insostenibili [...] perché è mia intenzione rendere noto quello che già l’Ageno ave-va visto da tempo, e comunque prima di me, e non approfittare delle Sue note per svolgere una discussione polemica»8. Lo stile di Gabba è inconfondibile nella sua probità. Altrettanto chiara è la presa di co-scienza di essere inserito, come interprete, in una lunga tradizione, da cui non è possibile prescindere.
In quello stesso anno 1959, l’attenzione di Gabba verso l’erudi-zione locale si manifesta anche su un altro versante, ossia la cura edito-riale degli scritti, sparsi o inediti, dedicati dal prozio Giacomo Franchi alla storia pavese, raccolti sotto il titolo Ancora alla ricerca di Pavia che fu. La figura del Franchi (1863-1939) possiede un certo rilievo civi-co. Segretario generale a Pavia della Congregazione di Carità – cioè l’ente morale istituito nel 1862 presso ogni comune del Regno, con lo scopo di curare l’amministrazione dei beni destinati all’erogazione di sussidi e altri benefici per i poveri – il Franchi aveva inteso il proprio servizio a favore della città anche come indagine sui suoi personaggi, tradizioni, vicende e istituzioni: quasi che, attraverso la memoria, si ripromettesse lo scopo politico di conservare la “Pavia che fu”, come recita il titolo della sua opera principale (edita nel 1938), titolo ripreso appunto dal nipote per designare la raccolta postuma. Quest’iniziativa segnala che l’interesse di Gabba per la storia locale era alimentato da valori etico-politici, assorbiti tramite le radici familiari9.
8 EMILIO GABBA, Ancora sulle iscrizioni mediche di Pavia, in “BSPSP”, LIX (1959), p. 113.
9 Recensendo il volume di GIANPAOLO CALVI - LUISA ERBA, Almo Collegio Borromeo, in “BSPSP”, LXXX (1980), p. 285, Gabba ricorda che all’istituzione «G. Franchi aveva dedicato nel 1896 una illustrazione storica». Al Collegio Borromeo, di cui era stato alunno il nonno Alberto, Emilio Gabba ha donato parte della sua biblioteca (parte è stata destinata all’Istituto Lombardo, cui era molto legato). Gli estratti di riviste sono stati donati alla Biblioteca Universitaria di Pavia, cui ha anche versato in più riprese (l’ultima, nel 2007) le sue carte autografe e la sua corrispon-denza.
15EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
Proprio nei mesi in cui s’occupava delle iscrizioni mediche e rac-coglieva le ricerche erudite del prozio, Gabba iniziava il suo insegna-mento di Storia greca e romana all’Università di Pisa (1958). La cat-tedra pisana era la consacrazione di una rapida ascesa. Laureatosi con Plinio Fraccaro a Pavia nel 1948 (a soli ventuno anni, avendo bruciato le tappe degli studi liceali iniziati al “Manzoni” di Milano e compiuti al “Foscolo”); impostosi al rispetto degli studiosi italiani e inglesi fin dai primi articoli sulle origini dell’esercito professionale e sulla società romana nel I secolo a.C.; entrato in rapporto con Arnaldo Momiglia-no e concluso, su suo suggerimento, il fondamentale commento al I libro delle Guerre civili di Appiano (1958), approdando alla cattedra universitaria pisana Gabba vedeva precocemente riconosciuto un ruo-lo di spicco che non avrebbe più perduto.
In riva all’Arno trascorre la fase forse più proficua della sua attività di antichista (della Facoltà di Lettere sarà anche preside, alla vigilia del ’68): un quindicennio scandito da lavori importanti, dal consolidarsi di relazioni scientifiche internazionali, dalla formazione di una sua scuola, con molti allievi avviati alla carriera universitaria. È una fase nella quale tutte le energie sono rivolte a Roma e alla Grecia, mentre la storia pavese non registra visite.
3. Il 1974 segna il ritorno a Pavia: Gabba, quarantasettenne, è chiamato alla cattedra di Storia romana nella Facoltà di Lettere e Fi-losofia. Succede a un altro allievo del Fraccaro e suo caro amico, Gian-franco Tibiletti, trasferitosi a Bologna (dove morirà prematuramente nel 1976), e affianca Aurelio Bernardi, rettore del Collegio Ghislieri, allievo egli pure del Fraccaro.
Se nel periodo pisano l’interesse di Gabba per la storia pavese era rimasto fra parentesi, già nel 1975 vede la luce uno studio che può considerarsi il primo incentrato propriamente su Pavia, ossia La sto-riografia pavese del secolo XVI e le origini di Pavia10.
10 In L’Italia settentrionale nell’età antica. Convegno in memoria di Plinio Frac-caro nel 1150° anniversario della fondazione dello Studio Pavese (Pavia, 8-10 set-tembre 1975), organizzato dall’Istituto di Storia Antica dell’Università di Pavia, Pavia, Tipografia del Libro, 1976, pp. 5 ss. Il saggio, con talune aggiunte, costituisce anche il capitolo introduttivo della Storia di Pavia. I: L’età antica, Pavia, Banca del Monte di Pavia, 1984, pp. 9 ss., ed è ripubblicato in EMILIO GABBA, Pavia. Domici-lium sapientie. Note storiche, Como, New Press, 2000, pp. 11 ss.
16 DARIO MANTOVANI
In questo, che è uno dei saggi oggettivamente più originali e im-portanti dell’intera sua opera, Gabba risponde a una domanda che era già stata sollevata da Giacinto Romano, il grande medievista fonda-tore della Società Pavese di Storia Patria e del “Bollettino” all’inizio del Novecento: perché Pavia, a dispetto della sua importanza, non ha avuto, come le altre città italiane, una cronachistica locale nell’alto e nel basso medioevo, e ha dovuto attendere il 1330 con Opicino de Canistris e poi il XVI secolo con i giureconsulti Jacopo Gualla e Ber-nardo Sacco per vedersi dedicare opere di maggior respiro, per quanto sempre legate a doppio filo con la storia ecclesiastica locale, piuttosto che incentrate sulle vicende politiche? Secondo Gabba, la risposta è da ricercare «proprio nella storia stessa, politica e civile, di Pavia, che, in quanto la città fu capitale Gotica Longobarda e Carolingia, si risol-veva nella storia più generale di quei regni, perdeva i connotati pro-pri cittadini tanto quanto assumeva dimensioni più vaste, nazionali e imperiali»11.
Rispetto a questa condizione quasi impersonale di città sede del potere, la cui esistenza specifica si confondeva e per dire così sfuma-va nella grande storia, una fisionomia più individuale poteva semmai emergere nelle vicende dell’episcopato pavese, nei conflitti con la sede ambrosiana, nelle tradizioni delle singole chiese, che costituirono ap-punto, da Opicino agli storici del XVI secolo, il filo di trama delle cronache locali.
Nel saggio del 1975 Gabba rivolge dunque il suo interesse per Pavia dall’angolatura della storia della storiografia12. Ma la circostan-za che il saggio sia stato presentato in un convegno in memoria di Fraccaro (scomparso nel 1959) L’Italia settentrionale nell’età antica, dov’era apparentemente un fuor d’opera, fornisce un’altra indicazione. Gabba tornò a interessarsi di Pavia, e dei suoi storici, come prosecu-zione delle proprie ricerche sull’Italia dei municipi, tema che proprio
11 Traggo l’eloquente sintesi da EMILIO GABBA, Faustino Gianani nella tradi-zione storiografica del clero pavese (1987), ora in GABBA, Pavia. Domicilium sapientie, cit., p. 44.
12 Questo tipo di indagine – che mette al centro l’opera di uno o più autori – sintetizzandone i contenuti e mettendone in luce gli intenti e le premesse ideolo-giche è fra i moduli più tipici di Gabba, applicato anche in vari contributi sulla tra-dizione classica: quasi un diretto riflesso delle infinite letture, condotte esplorando la sua biblioteca.
17EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
all’inizio degli anni Settanta veniva collocandosi al centro della sua riflessione antichistica13. Come Gabba stesso ha ribadito nel libro-intervista curato dal suo primo allievo pisano, Umberto Laffi – libro che, prima d’essere testimonianza di vita, è risorsa per interpretare la sua opera, dato che l’esercizio di consapevolezza storiografica e di analisi ideologica affronta la prova più difficile, quella che lo storico compie su se stesso – l’endemico frazionamento politico dell’Italia ha avuto origine nella struttura municipale dell’Italia romana, priva di un tessuto politico-amministrativo che sapesse coinvolgere i municipi in una prospettiva più generale. Da quest’assenza sono nate – questa è l’analisi di Gabba – tutte le questioni del rapporto fra l’Italia come nazione e l’Italia come Stato, ossia la forza dell’una e la debolezza dell’altro14.
L’immersione nella storiografia pavese si è poi rivelata fertile sotto vari profili. Innanzitutto da quest’esperienza nasce lo studio su Ticinum: dalle origini alla fine del III sec. d.C., che sarà edito nel 1984 nella Storia di Pavia15: un’indagine che rientra a pieno titolo nei confini dell’antichi-stica, ma che, specialmente per la ricostruzione delle fasi più remote, ove anche le fonti antiche intrecciano la verità al mito, trova chiaramente nella rassegna degli scrittori pavesi la sua premessa di metodo. Gabba, infatti, in quegli scrittori aveva soprattutto cercato notizie e interpre-tazioni sulle origini della città, e ne aveva scoperti alcuni acriticamente disposti ad accogliere i miti di fondazione (come il Gualla, secondo il quale Ticinum era stata fondata da Japhet figlio di Noé, ispirato da una colomba inviata da Dio), altri invece, come Bernardo Sacco, capaci di trarre profitto dalle stesse fonti (Catone, Polibio e Livio) cui si deve
13 Si può prendere come punto di partenza il saggio del 1972 Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell’Italia centro-meridionale del I sec. a.C. (ora ristampato in EMILIO GABBA, Italia romana, Como, New Press, 1994, pp. 63 ss.; vedi ivi, pp. 211 ss., anche l’importante recensione al libro di Salmon sui Sanniti, del 1969, che è l’occasione per Gabba di impostare già in prospettiva storiografica il tema della storia italica, come distinta dalla storia di Roma).
14 EMILIO GABBA, Conversazione sulla storia, a cura di Umberto Laffi, Pisa-Cagliari, dP, 2009, pp. 46 ss.
15 Storia di Pavia. I: L’età antica, Pavia, Banca del Monte di Pavia, 1984, pp. 206 ss. La stesura autografa dell’articolo è contenuta in un quaderno conservato in BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - PAVIA [BUPV], Autografi 23, Carte Emilio Gabba: quasi privo di cancellature e ripensamenti, reca la data 20 gennaio 1984 - 26 febbra-io 1984 ed è istruttivo sulla rapidità di ideazione e redazione.
18 DARIO MANTOVANI
rivolgere anche lo storico moderno. Nell’uno e nell’altro caso, Gabba ha riconosciuto i motivi eminentemente ideologici che – al di là della maggiore o minore dimestichezza con il metodo critico – hanno deter-minato la presa di posizione di ciascuno scrittore. Un’influenza cui non si sottraggono gli storici antichi: si noti che – per Gabba – la notizia di Plinio (n.h. 3.124), secondo cui Ticinum proseguirebbe un preceden-te stanziamento gallico ad opera di Laevi e Marici, costituisce «un più tardo recupero di tradizioni etnografiche antiche, innestate sul processo di urbanizzazione promosso da Roma»16; dunque, una rielaborazione ideologica, che non corrisponde a una precisa realtà storica. Il vaglio storiografico è ancora una volta decisivo.
La ricchezza del filone è comprovata anche dagli interventi che Gabba dedica nel corso degli anni ad ampliare o precisare qualche punto della rassegna del 1975. Acutissima è la nota che individua un’aggiunta al Sanctuarium Papie nell’edizione postuma del 1587, da cui Gabba ricava che nel frattempo – probabilmente nel sacco france-se del 1527 – fosse andata perduta la pervetusta cronaca dei vescovi di Pavia vista dal Gualla nel 1505. Un cospicuo complemento della ras-segna è poi l’esemplare lettura che Gabba propone dell’opera Gymna-sii Ticinensis historia et vindiciae a saeculo V ad finem XV, dedicata nel 1704 dal giurista Antonio Gatti alla fondazione dell’Università (che il Gatti attribuisce a Carlo Magno, aderendo così alla leggenda di fondazione che dal XVI secolo fu a lungo la più diffusa in Europa, poi oscurata dal mito moderno dell’istituzione dello Studium da parte del nipote, Lotario)17 e che contiene un’ampia premessa sull’origine della città18. Un ultimo prezioso frutto è da considerare la ripubblicazione
16 GABBA, Pavia. Domicilium sapientie, cit., p. 81.17 Sulla formazione e circolazione europea del racconto di fondazione carolin-
gio, a partire dal Catalogus de Gloria mundi (1529) del borgognone Barthélemy de Chasseneuz, già studente pavese, nonché sulla emersione del mito di Lotario nel XIX e XX secolo, DARIO MANTOVANI, Il lungo cammino dei mercanti di sapienza. Le origini dell’Università di Pavia nella storiografia dal XIV al XX secolo, in Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia. I: Dalle origini all’età spagnola, 1: Origini e fondazione dello Studium generale, Milano, Cisalpino, 2012, pp. 29 ss. Già Gabba, presentando in pubblico il secondo volume della Storia di Pavia (dattilo-scritto in BUPV, Autografi 23, Emilio Gabba, cit.) affermava: «Ed è poco male se in questo complesso quadro viene obiettivamente ridimensionato il mito dell’Univer-sità dell’imperatore Lotario».
18 Vedi, rispettivamente, Note di storiografia pavese. I: Jacobo Gualla, in “BSPSP”,
19EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
della Storia di Bernardo Sacco – opera che deve a Gabba una vera e propria rivalutazione – provvista di una magistrale traduzione italiana grazie all’ingegno di Domenico Magnino, altra straordinaria figura di umanista, legato a Gabba da una comune visione della vita e da un’in-defettibile amicizia19.
Per stilare un bilancio: il ritorno di Gabba a temi di storia locale a metà degli anni Settanta, dopo un quindicennio di pausa, è dettato da una pluralità di motivi intellettuali, messi a punto nell’ambito del suo lavoro di storico dell’antichità (la predilezione per la storia della storiografia; il tema delle origini di Ticinum romana; la configurazione dello stato municipale romano) e alimentati a loro volta da questioni del presente, in particolare il rapporto fra autonomie cittadine e com-pagine statale. Ovviamente, sulla decisione di volgersi alla storia patria avrà senz’altro influito la circostanza biografica del ritorno nella sua città d’origine, quasi che il modo più congeniale per riappropriarsene fosse apprenderne a fondo la storia.
4. Tre anni dopo la relazione su La storiografia pavese del secolo XVI e le origini di Pavia, l’attenzione per la storia locale si rafforza con implicazioni non solo intellettuali, ma anche organizzative, cioè con l’elezione di Gabba cinquantenne alla presidenza della Società Pavese di Storia Patria (16 marzo 1978) e, nell’anno seguente, con la nomina a presidente del neonato Centro per la storia dell’Università di Pavia.
Della Società Pavese di Storia Patria, che ha retto per quasi ven-ticinque anni fino al 2002, Gabba ha suscitato un’autentica fioritura20. Innanzitutto, in termini di rappresentatività: i soci, che erano poco più
XCII (1992), pp. 93 ss. e Antonio Gatti, in “Istituto Lombardo. Accademia di Scien-ze e Lettere. Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche”, CXXVII (1993), pp. 45 ss.; le due note, insieme a una terza dedicata al titolo dell’opera di Bernardo Sacco, sono riedite sotto il titolo Note di storiografia pavese, in GABBA, Pavia. Domicilium sapientie, cit., pp. 33 ss.
19 BERNARDO SACCO, Storia di Pavia, traduzione di Domenico Magni-no, Como, New Press, 1993. La segnalazione bibliografica di Emilio Gabba, in “BSPSP”, XCIV (1994), pp. 471-472, così si conclude: «Siamo grati a Domenico Magnino per questo ricupero, che veramente accresce le nostre conoscenze».
20 Ho potuto consultare, per la cortesia dell’attuale presidente dott. Cesare Re-possi, i verbali delle Assemblee e dei Consigli presieduti da Emilio Gabba, dispo-nibili a partire dal 1984. Preziosa anche la rubrica “Atti e notizie della Società” che correda ciascun volume del “Bollettino”.
20 DARIO MANTOVANI
di duecento all’inizio del suo primo mandato, alla fine erano più che raddoppiati21. Il “Bollettino” della Società, che s’era quasi arenato nel corso degli anni Sessanta e Settanta, è tornato in stampa con rego-larità annuale in corposi volumi, che documentano e interpretano la storia locale dall’antichità al XX secolo. Una riuscita che tanto più im-pressiona se si considera che nel medesimo periodo Gabba ha tenuto, con altrettanta efficacia, la direzione di “Athenaeum” e della “Rivista Storica Italiana”. I risultati sono stati ottenuti grazie anche a una forte integrazione con l’Università (è del 1984, in corrispondenza con la nuova serie del “Bollettino”, l’istituzione di una commissione scienti-fica formata da studiosi del livello di Rossana Bossaglia, Ettore Cau, Giulio Guderzo, Antonio Padoa Schioppa, Xenio Toscani, Giovanni Vigo, Dante Zanetti), ma anche valorizzando le risorse culturali del ceto colto cittadino.
Non è questa la sede per un resoconto della vita della Socie-tà Pavese di Storia Patria in quegli anni, che meglio potrebbe essere tratteggiata da testimoni diretti: anni in cui erano senz’altro lontani i contrasti di metodo e di ideologia che avevano agitato la Società ai primi del Novecento o nel secondo Dopoguerra, ma che conob-bero tuttavia il tragico crollo della Torre Civica, nel 1989, che aprì un dibattito difficile sull’opportunità o meno della ricostruzione, con divergenze d’opinione di cui è rimasta traccia negli atti della Socie-tà22. Per quanto riguarda le iniziative culturali, la Società – premiata nel 1984 dalla Città con la medaglia d’oro per pubblica benemerenza (San Siro), di cui fu nel 2000 insignito lo stesso Gabba – promuove con regolarità annuale cicli di conferenze tenute da relatori intorno a temi comuni, accanto a convegni di maggiore spessore: ad esem-pio su Defendente Sacchi nel 150° anniversario della morte (che è
21 L’andamento non è rettilineo: nel 1984 il verbale dell’Assemblea attesta che i soci sono 409 (oltre ai privati, 27 enti); 466 nel 1985, in significativa corrispondenza con la presentazione del primo volume della Storia di Pavia; 473 nel 1986; 490 nel 1987. Il numero dei soci tocca l’apice nel 1989, 538 (di cui 44 enti): nel dare conto di questa cifra all’Assemblea viene messo a verbale che nel 1901 i soci fondatori erano 183, scesi a 73 nel 1953 e saliti a 218 nel 1977, che è l’anno precedente all’inizio del-la presidenza di Gabba. Dopo il 1989 il numero degli associati dà segni di qualche flessione: nel 1996 è di 496, di 474 nel 2000, comunque più che doppio rispetto alla situazione iniziale.
22 Cfr. “BSPSP”, LXXXIX (1989), pp. 371 ss.
21EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
l’occasione per una relazione di Gabba significativamente incentrata sull’origine medievale dei comuni italiani nel pensiero di questo po-ligrafo allievo del Romagnosi)23; su Bernardino da Feltre a Pavia e la fondazione del Monte di Pietà; su Pavia nell’età di Federico II; infine sulla fondazione della stessa Società Pavese di Storia Patria, in occa-sione del centenario nel 2001. In questa ricorrenza, Gabba comunica la sua decisione di non ripresentare la propria candidatura alla guida della Società. È una rinuncia in cui si manifesta l’atteggiamento che ha caratterizzato l’ultima fase della sua vita, e che ne è stato uno dei suoi tratti più nobili e istruttivi, quello di lasciare per tempo (Gabba aveva allora settantaquattro anni) tutte le cariche e gli impegni, prima che gli divenisse gravoso onorarli e dando spazio a nuove generazioni. Non la carica, ma la consapevolezza d’avere portato a termine i propri compiti – che a pochi è consentito di gustare legittimamente – era la ricompensa più ambita. Per acclamazione, su proposta dell’amico carissimo Faustino Savoldi, viene nominato presidente onorario della Società il 18 maggio 2002.
Si può dire che Gabba abbia assolto lo scopo stesso per cui la Società Pavese di Storia Patria era stata fondata, enunciato nello sta-tuto del 1901 (riformato nel 1984 con sottolineatura dell’apoliticità del consesso), ossia di «preparare il terreno alla ricostruzione parziale o totale della storia civile, letteraria ed artistica di Pavia e del suo antico Principato». Dal 1984 al 2000, infatti, Gabba ha promosso e curato gli otto tomi della Storia di Pavia, in cui, appunto, si realizza la prima trattazione sistematica e rigorosa delle vicende politiche, sociali, eco-nomiche, letterarie e artistiche della città. Alla Storia – generosamente finanziata dalla Banca del Monte di Pavia, in particolare per iniziativa del direttore generale Oscar Casnici – hanno collaborato molti do-centi dell’Università di Pavia e studiosi non accademici, in uno sforzo collettivo di per sé foriero di un nuovo interessamento per la storia lo-cale. L’opera è aperta dalla riedizione, con poche modifiche, del saggio del 1975 sulla storiografia pavese, la cui importanza nel pensiero di Gabba si conferma cardinale; segue il già citato saggio su Ticinum, che ne è, per così dire, lo svolgimento antichistico. Nel secondo volume,
23 Defendente Sacchi e la storia dei municipi italiani, in Defendente Sacchi, filosofo, critico, narratore, Milano, Cisalpino, 1992, pp. 155 ss., ora in GABBA, Pavia. Domi-cilium sapientie, cit., pp. 73 ss.
22 DARIO MANTOVANI
dedicato all’età medievale, pubblica un saggio su Il nome di Pavia24, tema topico della storiografia locale, essendo quello pavese un caso pressoché unico di una importante città romana che (nell’età di pas-saggio fra Goti e Longobardi) cambia denominazione senza che se ne possa dare una spiegazione. Spiegazione che nemmeno Gabba si sente di avanzare, ancorché propenda per la derivazione romana del nome, con l’ipotesi che discenda da un esponente della gens Papia incaricato dopo il 49 a.C. di organizzare il nuovo municipio. Più che schierarsi, Gabba considera suo compito impostare correttamente il problema sulla base della documentazione e mettere ordine nel lungo dibattito, constatando, ancora una volta, che «il secolare svolgersi storico del problema è esso stesso un importante momento di riflessione»25.
È difficile misurare quale sia stato lo sforzo scientifico e organiz-zativo che ideare la Storia di Pavia e portare a termine l’intrapresa gli dev’essere costato. Di sicuro, si tratta di un’opera che ha contribuito non poco a dare coscienza di se stessa a una città scossa negli ultimi decenni da una minacciosa crisi economica e culturale.
5. Come si accennava, poco dopo avere assunto la guida della So-cietà Pavese di Storia Patria Gabba diviene, nel 1979, il primo presi-dente del Centro per la storia dell’Università di Pavia (CeSUP), sorto per iniziativa dell’allora rettore Alberto Gigli Berzolari, insigne fisico sinceramente interessato alla storia della scienza e della cultura e le-gato a Gabba da stima profonda26. La fondazione del Centro pavese s’inquadra in un rinnovamento della storia universitaria avvenuto ne-gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, suscitato anche dai mo-vimenti studenteschi che avevano spinto a esaminare criticamente il ruolo delle istituzioni educative. E se gli Atenei più antichi, come Bo-logna e Padova, avevano per tempo istituito Centri di studio appositi (la Commissione per la storia dell’Università di Bologna è del 1906), si deve a questo rilancio l’impulso avvertito in molte sedi di dotarsi di
24 In Storia di Pavia. II: L’Alto Medioevo, Pavia, Banca del Monte di Lombar-dia, 1987, pp. 9-18; anche in “Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche”, CXXI (1987), pp. 37-51 e ora in GABBA, Pavia. Domicilium sapientie, cit., pp. 81 ss.
25 Ivi, p. 82.26 Dell’attività del Centro è data notizia nel “BSPSP” (a partire dal vol. LXXXI
[1981], p. 323); la consuetudine si è poi interrotta.
23EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
propri Centri: uno sviluppo dettato anche dall’esigenza di radunare intorno al tema, molto sfaccettato, una pluralità di competenze di-sciplinari e di organizzare iniziative di raccolta, conservazione e edi-zione delle fonti (a cominciare dalle lauree e dai “rotoli” dei docenti). La presidenza di Gabba ha gettato le basi dell’attività scientifica e editoriale del Centro pavese, che è proseguita sotto la presidenza del contemporaneista Giulio Guderzo e ora di chi scrive. La Collana del-le pubblicazioni ha raggiunto i settanta volumi e nel 2012-13 hanno visto la luce i primi due tomi di una complessiva storia dell’Università, Almum Studium Papiense. Fra i volumi del CeSUP pubblicati sotto la direzione di Gabba non poteva mancare la raccolta delle relazioni e discorsi rettorali di Plinio Fraccaro, omaggio non solo al maestro, ma utilissima per comprendere dall’interno una fase di impetuoso, decisi-vo sviluppo dell’Ateneo27.
6. Suona quasi come un commiato dalla Società Pavese di Storia Patria il volume in cui, nel 2000, Gabba raccoglie i suoi studi di storia locale, sotto l’affascinante titolo Pavia. Domicilium sapientie. Dedicato «alla cara memoria» del prozio Giacomo Franchi «che tante vicende della nostra Pavia ricercò e narrò con vigile amore», chiude l’anello ini-ziato nel 1959.
27 Alla storia universitaria Gabba ha dedicato alcuni brevi, ma densi saggi di insieme, in particolare La cultura a Pavia negli anni 1773-1805, ora in EMILIO GAB-BA, Riflessioni storiografiche sul mondo antico, Como, New Press, 2007, pp. 249 ss.; Aspetti della vita universitaria a Pavia alla fine dell’Ottocento, ivi, pp. 257 ss. (su cui le mie considerazioni in Emilio Gabba e la storia di Pavia, in Emilio Gabba fra storia e storiografia sul mondo antico. Atti del convegno (Firenze, 15 ottobre 2009). Presentazio-ne del volume Riflessioni storiografiche sul mondo antico di Emilio Gabba, a cura di Pa-olo Desideri e Maria Antonietta Giua, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 55-66). Da segnalare anche l’intervento Riflessione sul ruolo dei collegi universi-tari pavesi, in Università e collegi. Storia e futuro. Atti del Convegno (7 marzo 1994) organizzato dal Collegio universitario S. Caterina da Siena di Pavia, a cura di Maria Pia Musatti, Milano, Cisalpino, 1994, pp. 57 ss. Sempre dalla fine degli anni ’70, e poi dal 1981 come membro del Consiglio di amministrazione, Gabba ha svolto un ruolo notevole nell’avvio e negli indirizzi culturali del Collegio Nuovo di Pavia: vedi su questo aspetto della sua attività PAOLA BERNARDI, Un gentile maestro di vita, il Collegio Nuovo e una ex-bambina irrispettosa, in EMILIO GABBA, Lezioni al Collegio Nuovo, a cura di Lucia Pick, Pavia, Fondazione Sandra e Enea Mattei, 2005, pp. 143 ss. nonché Ritratti per Emilio Gabba, a cura di Paola Bernardi, Silvia Castelli, Saskia Avalle, Pavia, Fondazione Sandra e Enea Mattei, 2007.
24 DARIO MANTOVANI
La scelta di comporre a unità una serie di saggi contraddistinti da omogeneità tematica, ma editi in tempi e sedi diverse, è pratica co-stante nell’opera scientifica di Gabba antichista, che si è praticamente sempre attenuto nelle sue pubblicazioni alla forma dell’articolo, come quella più capace di portare, in breve, un progresso di metodo o di in-terpretazione o di richiamare l’attenzione su fonti specifiche, evitando pagine e parole superflue. In Domicilium sapientie confluiscono, oltre ai saggi già ricordati più sopra, altre poche note, di varia occasione, fra le quali è da segnalare la commossa e profonda commemorazione di Faustino Gianani (il sacerdote studioso giustamente celebre per avere restituito, nel 1926-27, all’anonimo autore del Liber de laudibus civita-tis Ticinensis l’identità di Opicino de Canistris), la cui opera è inqua-drata da Gabba nella ricca tradizione storiografica del clero pavese28.
La raccolta del 2000 permette di constatare che, dalla metà degli anni Ottanta, un diretto interessamento di Gabba alla storia locale si fa raro, per non dire si spegne. Proprio per questo merita attenzione un intervento che, invece, fin dal titolo modesto, Note minime sulla battaglia di Pavia29, sembrerebbe destinato alle retrovie ed è invece di particolare valore.
La battaglia del 1525, oltre che per la sua importanza politica e militare, avendo posto fine alle mire dei re di Francia di impadronirsi dell’Italia settentrionale, è passata agli annali per l’eclatante cattura di due re, Francesco I di Francia e Enrico di Navarra. Fonti con-temporanee e successive parlano anche del caso tragico di un terzo personaggio, il «re di Scozia», riuscito bensì a sfuggire dal campo di battaglia, ma che, rifugiatosi presso un contadino, cadde a tra-dimento per mano di costui; l’omicida fu poi giustiziato dal duca di Milano. La notizia – annota Gabba30 – «è certamente singolare:
28 Citato sopra, nota 11. Restano fuori dalla raccolta un buon numero di re-censioni e schede dedicate da Gabba a libri di argomento pavese: un genere, quello del resoconto critico dei libri altrui, in cui Gabba – anche in campo antichistico – manifestava l’aggiornatissima presa sugli studi e l’apertura alla riflessione degli altri studiosi. La recensione è invece considerata irrilevante ai fini concorsuali dalle recenti norme italiane, con il risultato di scoraggiare e spegnere una delle forme più precise di dialogo e verifica all’interno della comunità scientifica.
29 In “BSPSP”, LXXXVI (1986), pp. 297 ss., ora in GABBA, Pavia. Domicilium sapientie, cit., pp. 93 ss.
30 GABBA, Pavia. Domicilium sapientie, cit., p. 94.
25EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
nessun re di Scozia era presente alla battaglia». Da questo nodo si dipana un’indagine che porta verso almeno tre possibili identità. Il primo candidato è John Stewart duca d’Albany, reggente di Scozia, che è tuttavia da escludere – nota Gabba – perché non prese parte alla battaglia di Pavia, essendo stato inviato da Francesco I a Napoli; del resto morì nel 1536, non nel 1525. Il secondo è James Hamilton, forse membro degli Hamilton conti di Arran, menzionato da Ot-tavio Ballada nel XVII secolo, la cui identificazione, come vedremo meglio, pare particolarmente fondata. Il terzo possibile candidato – segnalato a Gabba da colleghi dell’Università di St. Andrews in Scozia interpellati in cerca di lumi31 – è Richard de la Pole, duca di Suffolk, soprannominato la “Rosa Bianca” e che pare fosse chiamato anche “King of Scots”. Ma, a parte la stranezza di vedere appellato re di Scozia un leader yorkista che rivendicava il trono di Inghilterra (allora tenuto da Enrico VIII), consta che Richard de la Pole sia ca-duto nel corso stesso della battaglia, come testimonia una lapide un tempo collocata in San Pietro in Ciel d’Oro e “ritrovata” da Gabba al Castello di Belgioioso32; non si spiega allora il racconto alternativo della morte del re di Scozia per mano di un contadino.
In breve: la perlustrazione a margine della battaglia di Pavia, sulle tracce del «re di Scozia», è un piccolo gioiello, che racchiude, intorno a un episodio quasi aneddotico, i tratti migliori della personalità di Gabba. Non è l’identità del personaggio il centro intorno al quale ruo-ta lo studio, bensì il modo in cui si è venuta formando e diffondendo la notizia. In queste pagine, rivediamo l’antichista abituato a discernere fra le varie versioni d’un evento – riferite, poniamo, da Livio o da Dio-nigi d’Alicarnasso – farsi egli stesso arbitro di tre diverse versioni; lo osserviamo misurare le obiezioni che si oppongono all’una o all’altra, indagare le ragioni che le hanno portate a formarsi e che le rendono più o meno fededegne. Così, quando Gabba conclude che l’identifi-cazione con James Hamilton è la più credibile perché «connessa con la punizione giustamente inflitta all’assassino a seguito di un procedi-
31 Il carteggio, riferito nell’articolo, è conservato in originale in BUPV, Autografi 23, Emilio Gabba, cart. “Battaglia di Pavia”, insieme ad altri materiali preparatori.
32 L’iscrizione sepolcrale di due illustri caduti nella battaglia di Pavia del 24 febbra-io 1525, in “BSPSP”, LXXXVI (1986), pp. 297 ss., ora in GABBA, Pavia. Domicilium sapientie, cit., pp. 101 ss.
26 DARIO MANTOVANI
mento giudiziario a Milano, il quale avrà avuto certamente larga eco anche a Pavia: ne potrebbe venire una qualche garanzia per il nome dell’ucciso» (p. 96), riconosciamo alla base di questa sua valutazione lo stesso criterio che si segue nelle ricerche dedicate a Roma antica per dare credito alle notizie che possono essere agganciate a qualche episodio giudiziario o istituzionale.
Ancora. Negli scambi epistolari – debitamente registrati – con i colleghi scozzesi prodighi di notizie riappare il grande studioso che s’avvale della sua rete di conoscenze, di quella “società delle lettere” che è sempre stata la sua concezione dei rapporti accademici.
La nota sui “tre re” della battaglia di Pavia spicca, infine, perché Gabba ne ha lasciato una inattesa versione redatta in latino, ritrovata fra le sue carte consegnate alla Biblioteca Universitaria di Pavia; con il permesso del fratello, ingegnere Alberto Gabba, che ringrazio sentita-mente, la riproduco in Appendice. Scritta in forma di orazione, è stata pronunciata il 24 febbraio 1986, in occasione della ricorrenza della battaglia, nella piccola cerchia dei cultori di antichità pavesi che si riunivano annualmente per ricordare l’episodio; il primo destinatario – «Faustine carissume» – è Faustino Savoldi33. Questo testo ci lascia intravvedere perciò il lato per così dire conviviale di Emilio Gabba, che dell’amicizia e della conversazione era sovrano, ma che in ogni occasione conservava il tratto inarrivabile della sua cultura, come ci ammonisce lo smagliante latino. Nella sua sobria essenzialità, il testo merita di essere letto anche perché mette ancor più in rilievo il per-corso seguito sulle tracce del “re di Scozia” e fa risaltare la lezione di metodo.
Gabba storico di Pavia non è dunque diverso dal grande storico di Roma antica. Una coerenza che non stupisce: era una delle rare perso-ne che sono sempre se stesse in ogni atto della vita.
7. Nel concludere questo breve ricordo, bisogna di nuovo sotto-lineare che fra le ragioni che hanno alimentato l’attenzione di Gabba alla storia locale v’era indubbiamente il profondo radicamento della
33 Ringrazio il prof. Faustino Savoldi e il dott. Luigi Casali, presidente dell’As-sociazione “Il Parco Vecchio” di Pavia, per avere rievocato la circostanza in cui fu pronunciato il discorso (poi pubblicato solo in un opuscolo con circolazione priva-ta).
27EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
sua famiglia, dal lato materno e paterno, nella storia politica e soprat-tutto universitaria di Pavia, dai Visconti che nel Settecento raccolse-ro un’ampia biblioteca di libri professionali e libri di cultura, a Carlo Cantoni, filosofo neo-kantiano, a Giacomo Franchi, che abbiamo già menzionato; altri appartengono alla storia scientifica nazionale, da Carlo Francesco Gabba, che insegnò Diritto civile a Pisa dal 1861, a Luigi Gabba, astronomo di Brera nella prima metà del Novecento. Non si tratta, tuttavia, soltanto di un’illustre genealogia. Per Gabba costituiscono presenze vive, segnano una continuità familiare che gli ha reso presente e piena di risonanze la storia civica, cornice della sua più personale storia domestica.
Parlando delle torri medievali, segno di distinzione nobiliare, che caratterizzano il profilo urbano di Pavia (e che le sono valse l’appel-lativo di “città delle cento torri”, condiviso per la verità con altre no-bili città, come Ascoli Piceno e Praga), Gabba notava che «Di questi imponenti manufatti, che sono parte della nostra vita quotidiana, si è perduta nella memoria collettiva pavese la nozione dell’origine»34. A suscitare il suo interesse per la storia cittadina, e per quella dell’Ate-neo, è stato dunque il desiderio, quasi naturale, di trasformare per sé e per gli altri fatti e monumenti destinati a perdere di senso, se divengo-no sconosciuti, in segnali d’un passato cui guardare con comprensione e per trarne stimolo; così si spiega anche la sua attenzione speciale rivolta ai periodi della storia di Pavia in cui la città – nell’orbita politi-ca o universitaria – è stata in collegamento con le forze più vive della civiltà europea.
Ma non è detto abbastanza di lui, anche in un breve profilo come questo, se non si ricorda che la sua influenza più profonda è stata quella umana e personale. Se è stato studioso eminente, è stato soprattutto un uomo straordinario. Elegante senza essere ricercato, imperioso senza mai abbandonare il sorriso, tollerante senza muo-versi dalle sue posizioni. E se studiare la storia spesso conduce a os-servare i fenomeni più macroscopici, senza curarsi dell’individualità insostituibile di ciascun uomo, Gabba ha saputo guardare, nella vita come negli studi, al lato migliore di ciascuno. Proprio nella sua città, dove molti lo hanno conosciuto e ammirato – il che era tutt’uno – il rimpianto per la sua scomparsa si accompagna alla consapevolezza
34 Faustino Gianani nella tradizione storiografica del clero pavese, cit., p. 47.
28 DARIO MANTOVANI
che egli ha rappresentato l’indispensabile punto di convergenza di una molteplicità di persone, relazioni, affetti, interessi di ricerca, che trovavano in lui guida e stimolo. Più profondamente ancora, in lui molti cercavano e, se meritevoli, ne ricevevano un riconoscimento preciso, il senso di appartenere a una dimensione nella quale l’in-teresse per la cultura ha ancora un significato, etico e perciò civile. Anche per questo la sua impronta è profonda e altrettanto lo sono il nostro affetto e la nostra gratitudine.
29EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
APPENDICE
[Il testo dattiloscritto, con relativa traduzione, è conservato presso la Biblioteca Universitaria di Pavia, Autografi 23, Carte Emilio Gabba, cart. “Battaglia di Pavia”; aggiungo minime note esplicative; per un commento vedi supra, p. 26]
Cogitanti mihi saepenumero multosque libros lectitanti de proelio illo apud Ticinum commisso A.D. MDXXV, Faustine carissume, facile apparet non tam Gallici exercitus cladem animos mentesque perculisse hominum tunc in Europa viventium quam vincla regum proelio bellantium caedemque principum atque nobilium, quam tantam raro evenisse omnes consentiunt. Eorum nomina satis diligenter tradita in multis scriptis extant: nec est qui ignoret Franciscum Galliae regem et Henricum Navarrae captos fuisse. At in quibusdam Ticinensibus chronicis et libellis haud multo post pugnam illam exaratis monemur de diro quoque Scotiae regis exitu, qui cum e pugna evadere potuisset, Mediolanum (vel, ut quidam ferunt, Viglevanum) petere conatus est et agricolae cuidam improvide confisus, vel potius ab eo inter paludes silvasque detectus ubi occultus latere cupiebat, dolo ob auri sacram famem35 est necatus. Est in libellis agricolam illum confestim capite esse damnatum a Mediolanensi duce, iusto iure ut qui in regem manum inicere ausus esset. Testor me saepe quaesivisse quis ille fuerit qui vulgo rex Scotiae est nuncupatus, sed frustra, cum inter omnes constet regem eo tempore Sco-tiae imperitantem Ticinensi proelio non adfuisse. Nec auxilium apud graves doctosque historicos invenire potui cum ipsi inter se de ea re dissentiant.
Sunt enim qui putent Iohannem Stuartium Albaniae ducem regique Scotiae sanguine coniunctum ea appellatione vocitatum esse. Quod prorsus est credibile: at scimus eum, iussu Francisci regis, Ticini obsidionem mense Decembri prioris anni reliquisse ad occupandum Neapolitanum regnum. Ille dux pugnae interesse nequit; utcumque anno MDXXXVI eum decessisse inter omnes constat. In quibusdam additamentis italicae translationi Chronicorum Francisci Taegi insertis, quae viro in primis temporibus suis erudito Octavio Balladae ascribi possunt, Iacobus Hamiltonius est rex Scotiae denominatus. Quo de fonte hoc nomen fluxerit, ignotum operis auctori, haud perspicuum est, sed facile argui potest actionem capitalem in agricolam qui regem occidis-set eiusque fatum magnos sermones rumoresque Mediolani et Ticini suscita-visse, quod ad fidem nominis necati viri multum conferre videtur.
[p. 2] Hamiltonium illum unum fuisse puto e comitibus Arraniae re-giaeque domui Scotiae quoquo modo coniunctum, stipendiaque in exercitu
35 [Cfr. Virgilio, Eneide, 3. 57: auri sacra fames].
30 DARIO MANTOVANI
Francorum regis meruisse, ut multis Scotorum consentaneum erat. Aliter autem hoc aenigma explicuerunt quidam amici mei, in Scotorum Universi-tate nomini Sancti Andreae dicata historiae antecessores, quibus quam maxi-me me gratulabundum profero. Invenerunt enim viri illi doctissimi litteras a Legato regis Angliae apud Caesareum imperatorem missas ad cancellarium eiusdem regis S.R.E. Cardinalem Wolseium, clarissimae memoriae virum, paucis tantum diebus post pugnam Ticinensem. His enim litteris legatus certiorem facit cancellarium in ea pugna inter alios multos et famosum vi-rum cecidisse Richardum Polum, frequenter ‘ab Alba Rosa’ cognominatum, qui tamen apud Gallicum exercitum rex Scotorum perhibebatur. Richardum Polum ducem Suffolkii strenue pugnantem inter Germanos milites quos ipse duxerat occubuisse multi historici narrant, sepulchrumque eius in ecclesia Ticinensi quae titulo S. Petri in Auro Coelo appellatur, usque ad saeculum decimum octavum ostendebatur clara inscriptione ornatum36. Utilis sane et bene accepta mors eius fuit Angliae regi cum Richardus postremus heres es-set regiae domus Eboracensis (York dicunt Angli) et Henrici Octavi regnum iusto iure adfectabat. Sed tantum a litteris Legati cognoscimus miram illam appellationem ei esse adtributam, nec facile nobis est mente complecti qua de causa rex Scotiae appellatus sit, cum Angliae non Scotiae regnum occu-pare egregio viro in animo speique esset. At obscura et difficilis est historia in tam longinqua vetustate qua certa et incerta pariter obruitur. Et ad mo-derandam nostram sciendi omnia cupiditatem atque superbiam iustum est orationi meae finem imponere monendo multa nobis ignota manere. Placet tamen mihi commenticium quidam vobis proponere. Num xenodochium civitatis nostrae, cui cognomentum est ‘dei Tre Re’, originem suam ab il-lis tribus regibus repetat in bello captis vel caesis37? Maneat in incerto res. Oremus, amici, pro salute aeterna duorum vel, si mavultis, trium regum et in honorem Dei, cuius etiam in potestate sunt reges.
Aemilius Gabba
Mentre spesso rifletto, leggendo molti libri sulla battaglia di Pavia del 1525, o caro Faustino, mi pare chiaro che non tanto la disfatta dell’eserci-to Francese abbia colpito la mente e l’animo degli Europei contempora-nei, quanto la cattura dei re che avevano preso parte alla lotta e la strage di
36 [Per la collocazione attuale nel Castello di Belgioioso, vedi supra, nota 32].37 [L’Albergo dei Tre Re, in Strada Nuova, è attestato nell’Ottocento, quando
Pasquale Massacra ne dipinge l’insegna: cfr. SUSANNA ZATTI, Apparati effimeri e ar-redo urbano, in Pavia neoclassica: la riforma urbana, 1770-1840, Vigevano, Diakronia, 1994, p. 226].
31EMILIO GABBA STORICO DI PAVIA
principi e di nobili. Tutti sono d’accordo che raramente ve ne fu una così grande. I loro nomi sono tramandati con diligenza in molte opere e nessuna ignora che furono allora catturati il re Francesco I di Francia ed Enrico di Navarra. Ma in certi scritti storici pavesi del tempo e opuscoli scritti subito dopo la battaglia leggiamo anche della tragica sorte del re di Scozia. Questi, essendo riuscito a sfuggire dopo la disfatta, cercò di dirigersi verso Mila-no, o come altri dicono verso Vigevano. Affidatosi sconsideratamente ad un contadino, o forse scoperto da costui fra paludi e boschi mentre cercava di nascondersi, venne ucciso per la speranza di trovar denaro. Si dice anche che quel contadino sia stato di lì a poco condannato a morte dal Duca di Milano, giustamente per aver osato alzar la mano su di un re. Confesso che ho cercato spesso ch[i] potesse essere colui che era chiamato comunemente re di Scozia, ma invano. Si sa bene che l’allora re di Scozia non prese parte alla battaglia di Pavia. Poco aiuto potei trovare in storici pur importanti e attendibili, dato che essi tramandano versioni discordanti. Alcuni pensano che con quell’appellazione venisse chiamato John Stewart, duca d’Albany, e parente del re di Scozia, il che sarebbe pienamente comprensibile: senonchè sappiamo bene che costui per ordine del re Francesco aveva lasciato l’assedio di Pavia nel dicembre dell’anno precedente per recarsi ad occupare il regno di Napoli. Non poté quindi prendere parte alla battaglia. In ogni caso è certo che egli morì nel 1536. In alcune aggiunte, che possono attribuirsi ad un erudito che ai suoi tempi era famoso, Ottavio Ballada, e che si trovano nella traduzione italiana della Storia di Francesco Taegio, è chiamato re di Scozia James Hamilton. Donde sia derivato questo nome, ignoto all’auto-re dell’opera, non è facile dire, ma si può ragionevolmente supporre che il processo del contadino che aveva ucciso il “re” e la sua fine abbiano suscitato [p. 2] rumori e commenti a Milano ed a Pavia, il che potrebbe avvalorare quell’identificazione. Penso che quell’Hamilton fosse uno dei conti di Arran, in certo modo legato alla Casa reale di Scozia e che servisse nell’esercito di re Francesco, come era normale per molti Scozzesi. Una diversa spiegazione dell’enigma mi è stata proposta da alcuni amici che sono professori di storia nell’Università scozzese di St. Andrea, ai quali rivolgo i più vivi ringrazia-menti. Questi dotti studiosi hanno scoperto una lettera scritta poco dopo la battaglia dall’ambasciatore del re d’Inghilterra presso l’Imperatore e diretta al cancelliere di quel re, il Cardinale Wolsey, grande e insigne personalità. In quella lettera l’ambasciatore avverte il cancelliere che nella battaglia, con molti altri, è caduto anche un famigerato personaggio, Richard de la Pole, chiamato di solito ‘de la Blanche Rose’, ma che qui era appellato il ‘Re di Scozia’. Richard de la Pole, duca di Suffolk, cadde combattendo da valoroso fra i soldati Tedeschi che aveva comandato: lo dicono tutti gli storici; e il suo sepolcro, ornato da una bella iscrizione, era ancora visibile fino al secolo XVIII nella chiesa pavese di S. Pietro in Ciel d’Oro. La sua morte fu utile e ben gradita al re d’Inghilterra perché egli era l’ultimo discendente della casa
32 DARIO MANTOVANI
reale di York e con giusto titolo contendeva al re Enrico VIII il trono. Ma noi sappiamo soltanto dalla lettera del Legato che egli veniva chiamato con quella strana appellazione e non comprendiamo bene come e perché venisse chiamato re di Scozia, mentre egli pensava e sperava di conquistare il regno d’Inghilterra, non quello di Scozia.
Ma la storia è oscura e difficile in così remota antichità, che avvolge parimenti le cose certe e le incerte. E a moderare la nostra volontà e superbia di saper tutto è giusto che io concluda questa mia breve orazione ricordando che molte cose ci restano ignote. Tuttavia vorrei proporvi un’ipotesi magari fantasiosa. Forse che l’Albergo di Pavia che si chiama dei “tre Re” deriva la sua origine da questi tre re catturati e uccisi nella battaglia? Resti la cosa incerta. Preghiamo, o amici, per la salvezza eterna di quei due o, se preferite, tre Re e in onore di Dio, nel cui potere stanno gli stessi re.
Emilio Gabba