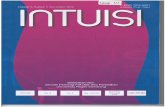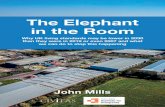PAVIA VESTIGIA DI UNA CIVITAS ALTOMEDIEVALE
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of PAVIA VESTIGIA DI UNA CIVITAS ALTOMEDIEVALE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea Magistrale in Archeologia
PAVIA: VESTIGIA DI UNA CIVITAS ALTOMEDIEVALE
Elaborato finale di: Filippo BRANDOLINI Matricola n.772533
Relatore: Prof.ssa Francesca Irma VAGLIENTI Correlatore: Prof. Paolo PIVA
Anno Accademico 2010/2011
INDICE
INTRODUZIONE 4
INTRODUZIONE 4
INQUADRAMENTO STORICO 6
Età Romana Ticinum 6
Età Gota Felix Ticinus 8
Età Longobarda Flavia Ticino10
Età Carolingia Papia caput Regni Langobardorum16
Età dei Re “Nazionali” Papia caput Regni Italiae 22
Età Ottoniana Papia civitas gloriosa 30
Età Comunale Papia civitas fedelissima 37
IL PALATIUM 51
FELIX TICINUS - EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DEL PERIODO GOTO 55
Oreficerie 63
La monetazione gota 74
FLAVIA TICINO
- EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DEL PERIODO LONGOBARDO 78
La faramannía 80
Mausolei regi longobardi 83
S. Maria Teodote (alla Pusterla) 86
S. Maria Foris Portam (alle Cacce) 94
S. Eusebio 98
S. Giovanni Domnarum 102
S. Maria della Regina (S. Felice) 108
S. Maria ad Perticas 113
S. Agata al Monte 118
S. Pietro in Ciel d’Oro 122
S. Stefano e S. Maria del Popolo 126
S. Maria del Senatore 130
S. Giovanni in Borgo 133
Oreficerie 135
La monetazione longobarda 140
PAPIA CAPUT REGNI LANGOBARDORUM - EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DEL PERIODO CAROLINGIO 145
La Sella Plicatilis 152
Il sigillo dell'Imperatore Lotario 155
La monetazione carolingia 157
PAPIA CAPUT REGNI ITALIAE - EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DURANTE I RE NAZIONALI 160
Il sarcofago della regina Adelaide 160
La monetazione dei Re Nazionali 161
PAPIA CIVITAS GLORIOSA - EVIDENZE ARCHEOLOGICHE DEL PERIODO OTTONIANO 164
Il Crocefisso della Badessa Raingarda 164
Le Arche Reliquiario del Monastero di S. Felice 166
La monetazione Ottoniana 169
CONCLUSIONI 172
INDICE DELLE IMMAGINI 178
BIBLIOGRAFIA 185
Introduzione
Pavia fu capitale altomedievale dal V secolo d.C. al 1024, data della dismissione del Palatium. In questo elaborato si è procedutoricostruendo le evidenze archeologiche della civitas. Malgrado il particolare status della città abbia condizionato la storia di Pavia per tutto il XII secolo fino alla nascita del Comune, nell'analisi non ci si è addentrati nel periodo romanico pavese, argomento troppo vasto e degno di uno studio dedicato.
Per meglio comprendere cosa sia effettivamente rimasto di tangibile del periodo regio pavese, sono stati presi in considerazione monumenti e materiali la cui realizzazione fu conseguenza, diretta o indiretta, del ruolo di capitale ricoperto dalla città. La parte più ampia dell'elaborato è occupata dai mausolei regi longobardi, per i quali si è cercato di procedere auna ricostruzione complessiva di quanto rimasto del loro passato altomedievale senza dividere le classi di materiali per tipologia,ma anzi riunendoli per ricostruire una visione globale attualizzata di ogni monumento.
La bibliografia non è stata uniformemente esaustiva per tutti gliargomenti trattati. L'approfondimento è stato più completo per il periodo goto e soprattutto longobardo che non per quello carolingio e ottoniano. I volumi di Storia di Pavia si sono rivelati fondamentali punti di partenza, integrati sopratutto dalle pubblicazioni del "Bollettino della Società Pavese di Storia
Patria" e dell' "Archivio Storico Lombardo". Molto esaurienti si sono rivelati anche gli articoli dei cataloghi delle mostre svoltenegli ultimi anni.
La ricostruzione urbanistica della città altomedievale è basata soprattutto sull'esaustiva sintesi elaborata da Donald Bullough e sui più recenti lavori di Peter Hudson, Hugo Blake e Brian Ward-Perkins. Per la parte monumentale e materiale sono risultate numericamente più consistenti le pubblicazioni di Adriano Peroni edi Gaetano Panazza. L'analisi numismatica è basata soprattutto sulle opere di Ermanno A. Arslan, Alessia Rovelli, Ernesto Bernareggi e su quanto è stato possibile ricavare dal Corpus Nummorum Italicorum.
Per la scultura, in particolare longobarda, ci si è avvalsi delle considerazioni di studiosi quali Angiola Maria Romanini, Anna Segagni Malacart, Donata Vicini e Saverio Lomartire.
I luoghi di ritrovamento del materiale esaminato e i siti, più o meno probabili, dei monumenti studiati sono riportati in una cartaarcheologica della città allegata alla fine dell'elaborato.
Il medioevo pavese, seppur spesso ricordato solo per le sue torri gentilizie e chiese romaniche, conserva tutt'ora tracce più antiche del suo passato in cui la città rappresentava uno dei fulcri del potere dell'Europa contemporanea.
Inquadramento storico
La storia medievale del capoluogo pavese non può prescindere dal ruolo di capitale ricoperto dalla città, con alti e bassi, per quasi cinque secoli. I legami con la tradizione regia gota e longobarda, infatti, avrebbero caratterizzato profondamente Papia anche nel basso Medioevo.
L’importanza di Pavia come capitale altomedievale ha avuto ripercussioni non soltanto dal punto di vista storico, ma, soprattutto, nell’ottica di sviluppo pavese in ambito culturale, politico, artistico, urbanistico e architettonico.
Età Romana – Ticinum
Pavia fu dedotta dai romani nel corso del I secolo a.C., con il nome di Ticinum, in un luogo probabilmente già frequentato da popoli italici che vi si erano stanziati durante le fasi della seconda guerra punica (1). La posizione era di importanza strategica per il controllo e lo sfruttamento della via fluviale del Ticino, da cui prese il nome la colonia romana. Sulla data precisa della fondazione di Ticinum e sulle modalità non vi sono dati certi. Insediamenti romani isolati probabilmente insistevano nell`area della futura Pavia già dal II secolo a.C. (2). Dall'analisi della centuriazione e dei resti del sistema fognario pare possibile identificare come termine post quem della fondazione l’anno 89 a.C.. La deduzione romana viene solitamente collocata in un ventaglio cronologico compreso tra la tarda repubblica e l'età augustea (3). Il centro romano si estendeva su una superficie davvero modesta rispetto a colonie ben maggiori come Mediolanum.
L'importanza del municipium di Ticinum era comunque legata alla sua funzione di nodo viario stradale e fluviale, crocevia commerciale specialmente in epoca tardo antica (4). Di contro, il ruolo politico di Pavia romana fu praticamente ininfluente in epoca imperiale (5). Nel IV secolo il ruolo logistico ticinese sipotenziò in esclusivo subordine alle esigenze di Mediolanum, allora capitale tetrarchica. Quest’ultima fu il principale centro urbano della
(1) P. TOZZI, L’impianto urbano di Ticinum romana, in Storia di Pavia, vol. I L’età antica, Società Pavese di Storia Patria, Milano 1984, pp. 192-193.
(2) E. GABBA, Ticinum dalle origini fino al III sec. d.C., in Storia di Pavia, vol. I cit., p. 219.
(3) P. TOZZI, L’impianto urbano di Ticinum romana, in Storia di Pavia, vol. I cit., p. 194.
(4) P. TOZZI, Il territorio di Ticinum romana, in Storia di Pavia,vol. I cit., pp. 159-179.
(5) G. CLEMENTE, Ticinum: da Diocleziano alla caduta dell’impero d’occidente, in Storia di Pavia, vol. I cit., pp. 256-263.
pianura padana sin dai tempi della quasi mitica fondazione celticada parte di Belloviso. Dalla conquista romana vide confermata la propria leadership sancita poi istituzionalmente dal ruolo di capitale dell’Impero Romano, ricoperto a partire dal 286 e mantenuto fino al 402 d.C. . Il ruolo economico e logistico di Ticinum in funzione milanese non dovette essere trascurabile in IVsecolo e fu preludio della crescita politico-militare che in V secolo ricoprì il capoluogo pavese. Segnale non secondario di questo graduale prestigio acquisito da Ticinum fu la presenza in territorio urbano, dall'età di Aureliano, di una zecca imperiale, che rimase attiva fino al 326 d.C. (6).
Fig. 1 Ricostruzione ipotetica dell'antica Ticinum.
Con l'abbandono della capitale Milano l’importanza di Pavia continuò a crescere. Dopo il 403 d.C., infatti, in seguito alla battaglia di Pollenzo, Onorio decise di trasferire la residenza imperiale in un luogo strategicamente più protetto e difendibile. Il ruolo di capitale fu assunto dunque da Ravenna, protetta da vasti specchi d’acqua e dotata di un importante porto militare. Milano conservò comunque la sua preminente funzione di sede episcopale, in aperta competizione con Roma, soprattutto dopo l'episcopato di Ambrogio. L’importanza strategica di Ticinum crebbe ulteriormente nel corso del V secolo in seguito all’insicurezza causata dalle campagne militari degli eserciti romani contro i sempre più incontrollabili popoli barbarici residenti entro i confini imperiali. L’urbs di Ticinum, già sede di alloggiamenti militari, era infatti ben difendibile in caso di assedio per la
(6) L. CRACCO RUGINI, Ticinum dal 476 alla fine del regno gotico, in Storia di Pavia, vol. I cit., pp. 277-279.
conformazione del territorio e soprattutto dotata di accesso diretto alle vie d’acqua. Inoltre, nel IV e V secolo d.C. a Pavia era attiva una fabbrica di archi.
Già Stilicone, nelle operazioni contro Alarico, tra 406 e 407, vi aveva trasferito parte dell' esercito, evidenziando il mutamento di ruolo assunto da Ticinum, da centro subalterno a Milano a palcoscenico principale dell'Italia settentrionale. La rivolta dell’esercito che portò alla caduta di Stilicone nel 408, ebbe proprio in Pavia il suo epicentro, segno che la colonia romana aveva ormai acquisito un ruolo determinate nello scacchiere romano. Anche gli eventi militari che provocarono l’affermazione in Italia del primo regno post-romano a opera di Odoacre ebbero inTicinum il loro principale teatro. Il 476 d.C. segna una data epocale per la città. In quell’anno, infatti, Oreste, incalzato dalla ribellione di Odoacre, vi si rifugiò, poiché confidava nellefortificazioni della città, ma questa fu assediata e conquistata, segnando, con la morte di Oreste e la deposizione del figlio Romolo Augustolo, la fine dell’impero romano d’Occidente.
Età Gota –Felix Ticinus
Il regno di Odoacre, tuttavia, ebbe breve durata. Il popolo ostrogoto, che da tempo rappresentava una seria minaccia per l’Impero di Bisanzio, venne definitivamente neutralizzato dall’imperatore d’Oriente Zenone che mise a disposizione dei Goti alcuni territori in Italia e riconobbe la sovranità del loro capo Teodorico. Quest’ultimo, secondo le fonti, ricevette per investitura la tutela del Senato
e del popolo romano. I Goti giunsero in Italia nel 489 dando inizio a un conflitto con Odoacre che venne concluso vittoriosamente solo nel 494 (7). Furono proprio le trasformazioniche coinvolsero, tra il V e il VI secolo, l’Italia settentrionale a contribuire decisamente allo sviluppo della funzione militare diPavia.
Durante la stabilizzazione del regno ostrogoto all’inizio del VI secolo d.C., infatti, Teodorico optò per l’elezione di Ticinum a sede regia insieme a Ravenna e a Verona, proprio per l’ormai consolidata rilevanza strategica assunta dal centro romano in epoca tardo imperiale (8). A Pavia nell’ambito della politica edilizia di rinnovamento e inserimento nella tradizione romana precedente voluta dal sovrano goto, Teodorico promosse la
(7) P. DE PALOL - G. RIPOLI, I Goti, catalogo mostra a cura di ID., Madrid, 1988, pp. 29 – 30; T. BURNS, A history of the Ostrogoths, Indiana Press University, Bloomington, 1984, pp.72- 80.
(8) P. MAJOCCHI, Pavia città regia. Storia e memoria di una capitale altomedievale, Roma 2008, p. 18.
costruzione e riparazione di terme, mura urbiche, anfiteatro e di un palazzo. Ulteriori lavori di restauro all’arredo urbano furono eseguiti successivamente per ordine di Atalarico (9).
Nel passaggio tra V e VI secolo, inoltre, i vescovi pavesi Epifanio ed Ennodio conferirono un ruolo ecclesiastico di grande prestigio alla sede episcopale locale, consono alla nuova dignità regia ormai assunta dall’antico centro romano. Il vescovo Ennodio,tra l'altro, come risulta dalla sua cronaca, riuscì a convivere senza contrasti con il vescovo ariano che rappresentava nella città pavese la religione tradizionale dei Goti (10).
Già nella prima metà del VI secolo, dunque, possono essere rintracciate le prime manifestazioni di competizione con Milano che avrebbe subito il sorpasso di Ticinum durante le fasi della guerra greco-gotica. Il ventennale conflitto era iniziato nel 535 in seguito a una spedizione militare guidata dal generale bizantino Belisario e volta alla riconquista dell'impero bizantinodella parte occidentale. Diversamente dai propositi iniziali, il contingente sbarcò in Sicilia per intraprendere la riconquista della Penisola, progetto fortemente voluto dall' imperatore Giustiniano. Il lungo conflitto che ne scaturì si risolse
definitivamente solo nel 555 con la vittoria imperiale. Durante loscontro avverso l’Impero bizantino le dinamiche militari portaronoalla perdita da parte dei Goti di tutte le altre capitali concorrenti al capoluogo pavese: prima tra tutte Roma e Ravenna (11).
Dal 540, Ticinum, divenne sede della corte e del tesoro reale, in quanto piazzaforte ben fortificata: qui risiedeva il condottiero goto Uraia che organizzò la resistenza dopo la caduta di Ravenna. Da qui partì anche l’offensiva gota contro Milano, controllata daibizantini nel 540-541. Ticinum fu inoltre teatro delle elezioni regie di Ildibado, Erarico e Baduila (detto Totila), assurgendo definitivamente a capitale unica del regno ostrogoto. Fra l’altro,le prime emissioni gote della zecca di Ticinum risalgono proprio alla reggenza di Totila (12).
Dopo la sconfitta inflitta ai Goti da Narsete nel luglio 552, Teiatornò nella capitale per essere eletto re e prendere possesso del tesoro. Alla morte del sovrano goto l’esercito si arrese al condottiero bizantino Narsete, ma Indulfo guidò mille irriducibilia Ticinum, da dove continuò la resistenza gota. La capitale regia fu l’ultima città a cadere nelle mani dei
(9) L. CRACCO RUGINI, Ticinum dal 476 cit., p. 308; B. SACCO, Storia di Pavia, traduzione di Domenico Magnino, edizioni New Press, Como 1993, pp. 202 – 203; N. CHRISTIE, I Longobardi, storiae archeologia di un popolo, Genova 1997, p. 75.
(10) L. CRACCO RUGINI, Ticinum dal 476 cit., p. 303.
(11) B. SACCO, Storia di Pavia cit., pp. 214 - 217.
(12) E. A. ARSLAN, La moneta dei Goti in Italia, in Goti – catalogo mostra(Milano - Palazzo Reale 28 gennaio–8 maggio 1994),Milano 1994, pp. 254 - 255.
Bizantini nel 553, rivelando come essa fosse divenuta il centro nevralgico del controllo militare della pianura padana (13).
Età Longobarda – Flavia Ticino
Prima ancora della loro discesa in Italia, i Longobardi erano già ben noti a Bisanzio che da tempo cercava di trovare rimedio alla loro bellicosità e irrequietezza lungo i confini. Come altri popoli barbarici che premevano sul fronte orientale, vennero spesso neutralizzati dall’imperatore in cambio di ingenti somme didenaro. Inoltre, i Longobardi, come i Gepidi e gli Avari, erano inquadrati nell’esercito imperiale in qualità di foederati. Durante la guerra greco gotica, infatti, come previsto da un trattato di alleanza del 552, i Longobardi prestarono servizio agli ordini di Narsete con azioni di supporto e di riserva: non sitrattava di un caso eccezionale, poiché da tempo appoggiavano Costantinopoli nelle guerre sul fronte orientale (14).
Fig. 2 Basilica di San Vitale, Ravenna. Mosaico raffigurante, alcentro, l'imperatore Giustiniano.
(13) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., p. 20.
(14) N. CHRISTIE, I Longobardi cit., pp. 47-48.
Gli avvenimenti del quindicennio compreso tra la riconquista bizantina del 553 e l’entrata in Italia dei Longobardi rivelano come il controllo militare della pianura padana da parte di Costantinopoli fosse in realtà solo teorico, malgrado nel 554 l’imperatore Giustiniano avesse emanato la Prammatica Sanzione perl’amministrazione dei territori italiani conquistati. Inoltre, le truppe imperiali stentavano a resistere alla spinta delle genti franche a sud delle Alpi. L'Italia, infatti, appena uscita dal trauma del lungo conflitto, rappresentava un facile bersaglio per le bellicose popolazioni barbariche confinanti. A tal proposito, in funzione prevalentemente antifranca, Bisanzio pare abbia favorito l'invio in Italia dei foederati Longobardi guidati dal loro re Alboino. Sin dalla loro prima discesa nella Penisola
attraverso il Friuli, avvenuta nel 568, i duchi longobardi agironoin completa autonomia dal governo bizantino, scalzando le truppe imperiali che si rifugiarono in limitati territori costieri intorno a importanti città portuali quali Roma, Ravenna e Genova. Nell'impetuosa marcia longobarda, caddero in mano dell'invasore, auna a una, tutte le principali città dell'Italia settentrionale, fatta eccezione proprio per Ticinum, che resistette a un assedio di tre anni. La città venne strenuamente difesa dai Bizantini in quanto caposaldo del collegamento fluviale tra la Pianura Padana el'Adriatico. I conflitti con i Bizantini si esaurirono solo nel 603 (15).
L’eco delle tradizioni regie ostrogote svolse un'attrattiva non indifferente nella scelta di Pavia come capitale del successivo regno Longobardo (16). Dalla seconda metà del VI secolo Pavia, unica città romana della Lombardia, affiancò al nome proprio romano di Ticinum la nuova denominazione di Papia (17).
Nei primi anni di stabilizzazione istituzionale e militare del Regno Longobardo si verificò quanto era accaduto già ai tempi del regno ostrogoto nel momento del suo consolidamento in Italia: l’instabilità della residenza regia (18), che oscillò, sino all’inizio del VII secolo, tra varie città, in concomitanza, tra l’altro, con il turbolento periodo della storia longobarda definito "dell’anarchia militare": per circa un decennio (574–584)lo spirito autonomistico dei duchi longobardi rese impossibile un’elezione regale dopo la morte di Clefi. La restaurazione della carica regia avvenne a opera di Autari che riuscì a imporre la propria autorità agli altri duchi (19). Durante questo convulso periodo la capitale del regno variò in base alla volontà del sovrano in carica. Quando Alboino scelse Verona, Pavia rimase
(15) S. GASPARRI, Pavia longobarda, inStoria di Pavia, vol. II L'Alto medioevo, Società Pavese di Storia Patria, Milano 1987, pp.20 –24: N. CHRISTIE, I Longobardi, p. 80 - 91.
(16) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 20-21; S. GASPARRI, Pavia longobarda cit., p. 25.
(17) E. GABBA, Il nome di Pavia, in Storia di Pavia vol. II cit., pp. 9-18.
(18) S. GASPARRI, Pavia longobarda cit., pp. 26 -28.
(19) G. VITOLO, Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, Firenze 2000, pp. 66-71.
comunque il principale centro militare del regno: qui si radunava l’esercito e si eleggevano i re che vi dimoravano anche a lungo. Con le preferenze di Agilulfo per Milano e di Teodolinda per Monza, il passaggio tra VI e VII secolo vide uno spostamento del centro di gravità del regno verso una zona meno legata al ricordo dei Goti e alle esperienze di Alboino, Clefi e Autari, ma più ricca di solenni memorie romane e cattoliche. Milano, infatti, poteva godere di espliciti richiami alla sua tradizione imperiale romana (20).
Pavia mantenne, tuttavia, sempre intatta la sua vocazione militareanche durante il regno di Agilulfo e fu nuovamente prescelta come residenza regia da Adaloaldo che nel 603, fu il primo sovrano longobardo a farsi battezzare con rito cattolico, dando inizio alla graduale conversione del suo popolo dall’arianesimo al cattolicesimo, non senza divisioni e scontri tra i duchi che professavano l’uno o l’altro dogma (21). Con la morte di Agilulfo nel 616, venne meno anche il ruolo di primo piano di Milano. I successori, Adaloaldo e Arioaldo, infatti, optarono per un ritornodella capitale regia a Pavia.
A sancire definitivamente il ruolo di capitale del regno longobardo dell’antica Ticinum, fu il regno di Rotari. Qui il re ricevette ambasciatori franchi e da qui partì per le campagne militari in funzione antibizantina. Pavia si avviava a divenire lacapitale stabile e pacifica di un regno in grande espansione a scapito dei territori bizantini, progressivamente strappati all'impero dalle vittorie di Rotari. Il centro pavese perse gradatamente la connotazione militare caratterizzandosi di più come snodo viario nevralgico della Pianura Padana, sia per vie
terrestri sia fluviali. La città era anche il nucleo religioso dell'arianesimo longobardo, che aveva il suo fulcro simbolico nella basilica di Sant`Eusebio. E' probabile che questa fosse uno degli ultimi capisaldi del clero ariano, soffocato dai sempre maggiori proseliti che la religione cattolica conquistava nell'aristocrazia longobarda. Il convergere dei residui dell'arianesimo longobardo su Pavia è, dunque, un altro segnale dell'accresciuto valore di capitale della chiesa pavese (22).
Milano mantenne una posizione subalterna a Ticinum, ma preminente sulle altre città del regno. Il capoluogo ambrosiano, all'epoca, conservava intatta la propria rilevanza almeno in campo ecclesiastico: qui, infatti, nel 680 fu indetta una sinodo cui parteciparono i vescovi delle diocesi suffraganee tra cui quello pavese.
La residenza del re in città implicava per Pavia, innanzitutto, il funzionamento e la manutenzione del palatium regio, centro amministrativo e culturale del regno e principale strumento di auto rappresentazione e di perpetuazione della memoria monarchica.Il
(20) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 23-24.
(21) G. VITOLO, Medioevo cit., pp. 73-74.
(22) S. GASPARRI, Pavia longobarda cit., pp. 41 - 44.
palazzo fu il fulcro dell’ideologia regia longobarda (23). Nel VIIsecolo anche la zecca di Pavia era con ogni probabilità ubicata all’interno del perimetro del Palazzo, contribuendo, con la rappresentazione iconografica su monete, alla propaganda dell’ideologia regia del regno (24). Un breve periodo di crisi perla capitale pavese si ebbe alla morte di Arioaldo, a causa dello sdoppiamento della successione dinastica fra i due figli: Godaperto preferì la sede pavese, mentre Pertarito optò per Milano. Nella disputa si inserì anche il duca di Benevento Grimoaldo. Alla fine riuscì a prevalere la fazione di Pertarito
che lo insediò sul trono pavese. Con lui e con il figlio Cunipertosi affermò definitivamente il cattolicesimo nel mondo longobardo.
Sotto il regno degli ultimi sovrani iniziò una nuova fase di rinnovamento dell’edilizia pavese. Già dai tempi di Rotari la città si era dotata di nuovi edifici: la regina Gundiperga aveva fondato la chiesa di S. Giovanni in Borgo, mentre Ariperto I avevafavorito la costruzione di S. Salvatore. Pertarito e Cuniperto promossero la costruzione delle chiese di Santa Maria ad Perticas e S. Agata, vennero poi restaurate le mura e costruita una nuova porta presso il palatium, detta appunto Porta Palacense. Il vescovo Anastasio, inoltre, negli stessi anni edificò la nuova basilica di S. Stefano, futura sede vescovile (25).
Il principale fenomeno che investì la topografia urbana di Pavia in età longobarda consiste, dunque, nella fondazione di edifici ecclesiastici. Sino al VI secolo sono attestate con certezza solo due chiese cristiane all’esterno della cinta urbica, mentre tra il569 e il 774 furono fondate almeno ventuno tra chiese e monasteri di cui otto fondazioni regie, quattro aristocratiche e una sola episcopale. L’erezione di una chiesa era divenuta dal VII secolo l’atto principale con cui la monarchia longobarda dimostrava e propagandava la propria appartenenza e adesione al mondo cattolico.
Pavia, in quanto capitale, ospitava poi la maggior parte delle sepolture regie longobarde. A partire dalla metà circa del VII secolo, infatti, i monarchi longobardi vennero tumulati in chiese in tombe dotate di una iscrizione funeraria.
La residenza regia a Pavia influenzò profondamente, infine, le vicende della sede episcopale della capitale. Sin dalla sua fondazione, nella metà del IV secolo, la diocesi pavese era stata sottoposta all’autorità della metropoli milanese, sede arcivescovile da cui erano ordinati, nei secoli V e VI, i presuli pavesi. Il regime di dipendenza del vescovo pavese da Milano entròin crisi all’arrivo dei Longobardi. In concomitanza l'arcivescovo di
(23)P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., p. 27.
(24) E. A. ARSLAN, La monetazione a Pavia. La monetazione dei gotie dei longobardi, in BSPSP,vol. XLVII, Como 1995, pp. 62 - 68.
(25) S. GASPARRI, Pavia longobarda cit., 44 - 46.
Milano riparò a Genova, in territorio bizantino, dove i suoi successori dimorarono per più di un cinquantennio. Il primo vescovo di età longobarda fu Anastasio che, nel 680, risultava ancora dipendente dall’arcivescovo di Milano. Tra la fine del VII e l’inizio del VIII secolo la diocesi pavese fu esentata dall’autorità del metropolita milanese per essere direttamente sottoposta alla sede romana, in virtù principalmente, del suo ruolo di capitale. A partire dalla reggenza di Cuniperto venne ufficializzato il ruolo centrale della chiesa pavese nel regno, che fu sino al secolo XII, la sede principale dei concili e delle sinodi, privilegio precedentemente appartenuto a Milano. Proprio nell’età di Cuniperto fu solennemente celebrata la sinodo che nel 699 pose fine allo Scisma dei Tre Capitoli e alla prima metà dell' VIII secolo risalgono le prime attestazioni dell’esistenza di una cattedrale intramurana. In questo edificio furono eseguiti lavori di ampliamento addebitabili al patrocinio del vescovo Damiano, che promosse inoltre l’edificazione del battistero di S.Giovanni ad Fontes e del palazzo episcopale. Nel corso dell' VIII secolo, di fianco alla cattedrale, fu fondata da Ansoald, aristocratico della corte regia, la chiesa di Santa Maria, successivamente unita alla cattedrale a formare una chiesa gemina,che tra VIII e X secolo fu oggetto di nuove fasi costruttive estese all'intero complesso (26).
Gli ultimi anni del regno di Cuniperto furono segnati da torbide lotte di potere tra vari pretendenti al trono. Alla fine riuscì aspuntarla Liutprando, soldato di umili origini che, seppur non godendo di alcun illustre antenato, diede inizio a una nuova dinastia ed è ritenuto il più grande re della storia longobarda. Durante i conflitti dinastici il fulcro determinante del potere
rimase sempre il palatium di Pavia. Questo era la base della forzadel re, della sua organizzazione e della sua ricchezza, nella quale un posto decisivo spettava al complesso dei beni del fisco, controllati direttamente dalla corte: intorno a Pavia esisteva unacorona di curtis regie dedite al mantenimento dei sovrani e del loro seguito.
La profonda devozione di Liutprando si tramutò, talvolta, in un freno della sua politica di espansione. Esemplare, nel 728, il caso della restituzione di Sutri non ai Bizantini, bensì "ai beatissimi apostoli Pietro e Paolo": cioè al pontefice romano. La politica estera di Liutprando era inizialmente volta a eliminare con ogni mezzo ciò che divideva i territori longobardi settentrionali da quelli meridionali; ossia l’ Esarcato e la Pentapoli bizantine che vennero rispettivamente conquistate nel 720 e nel 730. L'Imperatore d'Oriente fu costretto, pertanto, a intavolare trattative con il sovrano longobardo. Papa Zaccaria (741-752) si inserì tra i due contendenti con l'intenzione di mediare la restituzione dei territori
(26) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 30-35.
conquistati dai longobardi all’Impero d’Oriente. È in tale situazione politico-militare che il pontefice visitò la capitale longobarda pavese (27). Risale a questo periodo e proprio per diretta iniziativa regia un decisivo apporto al patrimonio delle reliquie pavesi. Se infatti in età tardo antica e gota la città disponeva soltanto delle spoglie dei vescovi pavesi come Siro, Epifanio ed Ennodio, nei secoli VII-VIII Pavia fu arricchita dellereliquie che avrebbero conferito il lustro maggiore alle sue chiese per il resto del Medioevo: così per il corpo di sant’Agostino, che fu trasportato da Cagliari alla capitale del regno per volontà di Liutprando. Qualche anno più tardi il sovranoAstolfo fu protagonista di quello che è considerato “il grande saccheggio”. Il re longobardo, durante le operazioni militari condotte contro Roma e Ravenna, non disdegnò, infatti, di prelevare nelle città conquistate un gran numero di corpi santi
per dotare le chiese della capitale (28). Con la morte di Liutprando nel 744, il regno era però entrato in una rapida fase discendente, nonostante il breve regno di Astolfo (749-756) abbiasegnato l’apice della potenza militare longobarda in Italia con laconquista di Ravenna e dell'Esarcato. I pericoli maggiori, infatti, arrivavano da Oltralpe.
Papa Stefano II, sentitosi minacciato dalla prepotente espansione longobarda, chiese l'intervento del popolo franco. Nel regno merovingio, la dinastia sovrana fu progressivamente scalzata dai maggiordomi di palazzo, veri detentori del potere militare. Nellafigura di Pipino il Breve, questa tendenza a sostituirsi al sovrano venne legittimata dall'approvazione papale di Zaccaria e dall'unzione sacra celebrata dal monaco missionario Bonifacio (29). Il nuovo sovrano franco, non esitò a intervenire in Italia in aiuto del pontefice Stefano II. Per due volte, nel 754 e nel 756, i Franchi scesero nella Penisola e in entrambi i casi Pavia fu oggetto di assedi che si rivelarono decisivi per l'esito stessodella campagna militare. I Longobardi furono costretti a cedere i territori conquistati, non più ai Bizantini, ma, ancora una volta,al pontefice.
Con Ratchis e Astolfo, successori di Liutprando, a Pavia si erano trasferiti nuovi cortigiani longobardi friulani, tra cui Paolo Diacono, autore della più importante opera storica sul suo popolo. Tra la nuova classe dirigente e gli esponenti di quella precedente nacquero presto contrasti che non aiutarono il regno longobardo, già profondamente minato dall'esterno. Nel 757 divenne re Desiderio. Già funzionario di Palazzo a Pavia e comandante in Tuscia, riuscì a impadronirsi del trono dopo aver sconfitto, grazie all'aiuto papale in cambio di concessioni territoriali, il potente rivale Ratchis. Le torbide circostanze della sua elezione
(27) S. GASPARRI, Pavia longobarda cit., pp. 51 - 56.
(28) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., p. 36.
(29) G. VITOLO, Medioevo cit., pp. 127 -128.
regia alimentarono l'opposizione nei suoi confronti. In questa situazione, Desiderio e il figlio Adelchi, spostarono parte del centro di gravità del regno verso il bresciano, seppur mantenendo Pavia capitale ufficiale. La situazione del regno di Desiderio iniziò un rapido declino nel 772. Il re longobardo aveva ottenuto una certa stabilità grazie a un'alleanza matrimoniale con i sovrani franchi tramite le nozze delle sue figlie con gli eredi diPipino, Carlo e Carlomanno. Papa Adriano I, però, rivendicava insistentemente la concessione delle terre promesse da re Desiderio. Nel contempo le morti di Pipino (768) e del figlio Carlomanno (771) fecero precipitare il quadro delle alleanze con ifranchi. Il pontefice chiese l'aiuto del nuovo sovrano franco contro Desiderio. Carlo, scese in Italia nel 773 e nel 774, dopo un lungo assedio, conquistò Pavia (30).
La preminenza di Pavia come capitale altomedievale subì un decisivo ridimensionamento con la sconfitta longobarda per mano diCarlo Magno, nel 774, che però consentì ai duchi longobardi di conservare la propria carica, sostituendoli con funzionari franchisoltanto alla morte: ciò si tradusse in una graduale integrazione con il sistema franco di governo, ma provocò cambiamenti minimi nella struttura esistente e il perdurare, almeno sul piano ideale,del Regno Longobardo. Nonostante la caduta del regno del nord Italia, sopravvissero nel sud i ducati longobardi di Benevento e Spoleto (31).
Età Carolingia – Papia caput Regni Langobardorum
La conquista franca segnò, fra l'altro, la fine del ruolo di Paviacapitale, a cui venne preferita la vicina Milano. Malgrado la perdita della sua centralità dal punto di vista istituzionale, la ex città regia longobarda mantenne comunque l’eccellenza sulle altre città padane come centro di elaborazione giuridica e notarile, così come la sua preminenza in campo culturale. La crisiistituzionale di Pavia, segnata dall’avvento dei carolingi, è leggibile nella sospensione dell’attività della zecca regia sino alla fine dell’VIII secolo a favore di quella milanese. La
resistenza militare opposta agli invasori e il lealismo dimostratoverso la monarchia longobarda provocarono anche una sorta di punizione per l’episcopato della capitale: nessun ente ecclesiastico pavese, infatti, ottenne conferme regie nell’ultimo ventennio dell’VIII secolo. Carlo Magno prediligeva, anche in questo caso, Milano, dove fu fondato il monastero di S. Ambrogio, in cui Carlo risiedette in numerose occasioni. Alla chiesa di Milano, e non a quella pavese, infine, il primo sovrano carolingio,
(30) S. GASPARRI, Pavia longobarda cit., pp. 58 - 65.
(31) N. CHRISTIE, I Longobardi cit., pp. 100 - 102.
al sopraggiungere della morte, destinò elargizioni e donazioni. Laresidenza del re fu di nuovo motivo di confronto tra le due città:non appena la capitale pavese passò in secondo piano, Milano si profilò come sede regia dei carolingi del ramo italico.
Le sepolture regie in S. Ambrogio sarebbero state considerate nei decenni successivi un privilegio della città milanese e non più di quella pavese come era stato con i sovrani longobardi (32). Nelcorso del IX secolo il monastero ambrosiano si affermò quale il mausoleo della dinastia carolingia italica. Come reazione alla predilezione di Carlo Magno e dei suoi successori per Milano, l’episcopato pavese, temendo di perdere i privilegi ottenuti in età gota e longobarda, tentò di sopperire a un primato e a una identità che erano percepiti in declino. Per reazione la chiesa pavese promosse l’elaborazione del culto civico del protovescovo Siro attraverso la composizione della Cronaca sancti Syri, un testo agiografico databile alla fine dell’VIII secolo. La mancanzadi attestazioni del culto di Siro antecedenti alla caduta del regno longobardo indicherebbe come la venerazione per il protovescovo fosse soprattutto un tentativo per riaffermare l’antico primato di Pavia. La polemica antimilanese giunse addirittura a dichiarare esplicitamente che l’evangelizzazione di Milano avvenne per opera del terzo vescovo di Pavia, Invenzio,
rivendicando in tal modo la subordinazione dell’episcopato ambrosiano a quello pavese (33).
Dal 789 Carlo Magno cominciò un graduale ma deciso passaggio istituzionale del regno longobardo all'elemento franco. I provvedimenti presi prevedevano l’istituzione di una monarchia separata per quanto comunque subordinata alla sovranità di Carlo. A questa fase andrebbero riferite anche alcune testimonianze numismatiche di denari d’argento con la
(32) A.A. SETTIA, Pavia carolingia e postcarolingia, in Storia di Pavia vol. II l'Alto Medioevo, Società Pavese di Storia Patria, Milano, 1987, pp. 73-75.
(33) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 43-44.
legenda "Carlus rex Francorum" recanti sul rovescio la dicitura "Papia". L’attività della zecca pavese riprese regolarmente ma nonprima del 793 –794, periodo dell’entrata in vigore della riforma monetaria carolingia (34). I primi titolari del regnum langobardorum furono Pipino e il figlio Bernardo, ma scarsissimi sono i dati a disposizione su questi due sovrani. Pipino morì a Milano nell' 810 e venne sepolto in Sant’Ambrogio ponendo di fattole basi per la nuova tradizione di sepolture regie nel capoluogo milanese. Più dettagliata appare, invece, la vicenda di Bernardo: sovrano d’Italia dall'813 all'817, organizzò una congiura contro suo zio e imperatore Ludovico il Pio, alla quale aderì anche l'arcivescovo di Milano. Dalle fonti, però, traspare l’idea che lefila dell'opposizione fossero tenute dalla corte pavese. Le motivazioni che spinsero Bernardo a questo gesto estremo contro l’autorità imperiale non sono determinabili con certezza. Se da unlato avrebbe potuto trattarsi di un pretesto per il tornaconto personale dei maggiorenti franchi residenti in Italia, d’altro canto è lecito pensare all’espressione di una corrente autonomistica dal sapore nazionalistico longobardo. In ogni caso, pare da fonti franche che Bernardo ebbe l’appoggio di molte città del regnum langobardorum. Malgrado ciò, la congiura venne
duramente e rapidamente soffocata dalle truppe dell’ imperatore Ludovico. Forse anche in seguito a questa vicenda, per eliminare ogni possibile eco della tradizione longobarda, i territori italici dell’impero vennero inquadrati sotto il nome di regnum Italiae (35).
Il regno carolingio continuò a gravitare prevalentemente su Milanofino all' 830 circa, quando Lotario pose definitivamente la sua residenza a Pavia che tornò a essere stabilmente la capitale del regno italico. Il nuovo imperatore, figlio di Ludovico il Pio, aveva già agito in Italia dall’822, pur senza portare ufficialmente il titolo di re. Ad aprile dello stesso anno visitò Pavia e, dall’832 all’840, risedette nella capitale pavese con unacerta frequenza. Numerosi furono gli interventi di Lotario volti aridare lustro e dignità all’antica capitale longobarda. L’imperatore intrattenne nuovamente rapporti intesi con esponenti di prestigio della città. Concesse ben quattro diplomi imperiali al monastero di S. Maria Teodote, segno di un rinato interesse peri legami con l’episcopato locale. Proprio per volontà di Lotario,il culto urbano del santo patrono trovò una sanzione definitiva con la traslazione delle reliquie del protovescovo dalla chiesa cimiteriale paleocristiana dei SS. Gervasio e Protasio alla cattedrale urbana di S. Stefano. Sempre per iniziativa imperiale, venne fondato il monastero di S. Martino Foris Portam. Anche in ambito più propriamente laico l’imperatore non trascurò Pavia. Dalle disposizioni dell’825 sul riordinamento degli
(34) A. ROVELLI, Il denaro di Pavia nell'alto medioevo (VIII-IX), in BSPSP, XLVII, Como 1995, p. 73-75.
(35) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., pp. 76-77.
studi in Italia, infatti, si apprende che alla Scuola tenuta a Pavia dall’irlandese Dungallo dovevano convenire non solo studentidi buona parte delle attuali Lombardia e Piemonte, ma anche da Genova: un distretto, dunque, di un’ ampiezza senza paragone rispetto ad altre sedi menzionate nel medesimo capitolare (36).
Dalla reggenza di Lotario, il regno italico venne inoltre associato alla corona imperiale: questa norma istituzionale ebbe conseguenze importantissime per Pavia, capitale di un regno la cuiincoronazione divenne, almeno formalmente, condizione necessaria per legittimare il potere imperiale. Con l’insediamento del nipotedi Carlo Magno il palazzo regio pavese tornò, poi, ad essere la sede stabile del sovrano e di un’amministrazione centralizzata. Questi fattori, insieme con l’antica esenzione del suo vescovo dalla autorità metropolitica ambrosiana, caratterizzarono Pavia avvicinandola al modello di capitale tardo antica che ancora sopravviveva solo a Costantinopoli. Contrariamente all’età longobarda, la presenza regia in città nei secoli IX e X era però saltuaria: a Pavia, infatti, imperatori carolingi e re italici dimoravano in determinati periodi od occasionalmente. La capitale,piuttosto, andò a configurandosi in residenza stabile dell’apparato amministrativo del regno: il Palatium fondato da Teodorico, già sede dei sovrani longobardi. Considerevole conseguenza del ruolo di capitale consisteva nel privilegio di ospitare concili ecclesiastici, tradizione inaugurata con la sinodo del 699, durante il regno longobardo. I concili erano generalmente tenuti nel palazzo regio. Elemento peculiare della capitale pavese nei secoli IX e X, riscontrabile altrimenti solo aCostantinopoli, è ora la presenza di corti episcopali e monastiche, cioè di alloggi che i vescovi e gli abati dei principali monasteri del regno possedevano nella capitale. L'esistenza delle cellae appare legata principalmente alla residenza regia della città. A partire dall'XI secolo scomparvero a poco a poco (37).
Trattenuto Oltralpe da impegni imperiali, Lotario designò come re dei Longobardi e primo imperatore italico il figlio, Ludovico II che, dopo una prima breve tappa a Pavia nell’844, ritornò l’anno seguente e nel 847 e proprio dalla capitale pavese organizzò una spedizione contro i Saraceni che imperversavano nel sud Italia. Dall’850 all’857 Ludovico II si trovò con una certa continuità a Pavia e nelle vicine corti di Aureola, Senna Lodigiana e Olona. I soggiorni dell’imperatore nella capitale e nelle corti regie
viciniori diventarono più rari dopo l’860. Si assiste, infatti, a un riavvicinamento della tradizione germanica al modello della corte itinerante: solo disponendo di un potente blocco itinerante era possibile tentare
(36) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 78.
(37) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 46-49.
di esercitare un efficace controllo sull’amministrazione pubblica e sull’insubordinazione delle forze locali.
Dopo l’870, Ludovico II tornò nell’Italia settentrionale, ma risedette più nelle corti regie che non a Pavia. Nel febbraio 875 Ludovico il Germanico, fratello di Ludovico II ed erede di Lotarioper la Marca Orientale, aveva elargito a Ermengarda di Provenza (38), figlia dell’imperatore, donazioni in Italia settentrionale. Doveva trattarsi presumibilmente di un pretesto del sovrano franco per tentare di inserirsi nella successione alla corona italica (39).
Nella competizione per il possesso del regno italico la materiale occupazione della città di Pavia e del palazzo regio che ivi si trovava, andarono assumendo un valore sempre più determinante, come dimostrano gli avvenimenti successivi alla scomparsa dell’imperatore. Alla morte di Ludovico II l’eredità del trono italico e il titolo imperiale a esso legato vennero raccolti dal figlio di Ludovico il Germanico e dal re di Francia Carlo il Calvo. Con il favore papale, ma contro le concorrenti aspirazioni dei cugini germanici, Carlo occupò Pavia già nel settembre dell'875 e subito venne riconosciuto imperatore a Roma. Nell’876, nel palatium pavese l’imperatore convocò i grandi del regno che avevano aderito alla sua causa. In loro presenza Bosone, fratello dell’imperatrice, fu nominato dux et sacri palacii archiminister, ossia rappresentante in Italia dell’imperatore. Non si istituì dunque, come ai tempi di Pipino e di Bernardo, un sottoregno, ma fu invece ripristinato allo stato puro l’unione di due corone, quella franca e quella italiana (40). Poco tempo dopo vennero
celebrate le nozze tra Bosone ed Ermengarda, figlia di Ludovico II, proprio a Pavia. Non tutti i signori d’Italia giudicarono favorevolmente la nuova dominazione imposta da Carlo il Calvo e non mancarono mal umori e tentativi di insurrezione. Nell’876, mentre Carlo si trovava a Roma da papa Giovanni VIII, Carlomanno scese di sorpresa dalla Germania.
L’imperatore preferì dapprima evitare la battaglia con il sovranogermanico ritirandosi a Tortona, da cui ripartì per tornare in terra franca valicando le Alpi, ma durante il viaggio morì. Nell’ottobre dell’877 il nuovo imperatore Carlomanno emanò una diploma a Pavia e, quasi ad affermare meglio la sua presenza nellacapitale, fece eleggere la sorella badessa di S. Maria Teodote. Per ristabilire ordine il pontefice Giovanni VIII convocò un concilio a Pavia, ma inutilmente: tra i più disubbidienti alla convocazione papale, il vescovo ambrosiano Ansperto fu tra i primia defezionare. In quegli anni il vescovo pavese era
(38) F. BOUGARD, Ermengarda, regina di Provenza, Dizionario Biografico degli Italiani (DBI) vol. IX, Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, Roma 1967.
(39) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., pp. 78-79.
(40) G. ARNALDI, Pavia e il “Regnum Italiae” dal 774 al 1024, in Atti del 4° Congresso Internazionale di Studi Sull’Alto Medioevo, ( Pavia–Scaldasole–Monza –Bobbio, 10 –14 settembre 1967), CISA, Spoleto 1969, p. 176.
divenuto l’interlocutore privilegiato del pontefice, ricevendone in cambio la riconferma dell’antica esenzione dalla autorità metropolitica milanese, con l’aggiunta di altri privilegi liturgici riservati di norma solo agli arcivescovi. Non appena, però, il pontefice romano e il metropolita milanese raggiunsero unpunto d’incontro, la strumentale valorizzazione della sede vescovile pavese venne presto ridimensionata. Nel contempo, la salute cagionevole di Carlomanno lo costrinse ben presto a lasciare ogni potere nelle mani del fratello Carlo III il Grosso
che, nell’880, fece il suo primo ingresso in Pavia. Risedette nel palazzo regio e concesse privilegi ai monasteri di S. Martino Foris Portam e S. Maria Teodote. Il nuovo sovrano dovette ben presto lasciare l’Italia per occuparsi degli attacchi dei Normannisulle sponde atlantiche dell’Impero. Nell’882, contro i Norreni, ma senza troppo successo, venne richiamato anche l’esercito italico. Carlo sarebbe tornato a Pavia per celebrare il Natale dell’884 e ridiscendere in Italia un'ultima volta, fermandosi a Pavia e Corteolona, nel marzo 886. Durante la Pasqua di quell’anno, celebrata dall’imperatore nella capitale, i cittadini pavesi diedero vita a una rivolta repressa nel sangue. Il sovrano fu costretto a ripartire subito per Parigi dove intendeva affrontare i Normanni. La reazione dei Pavesi, però, non si fece attendere, e la rabbia degli insorti si scatenò non solo contro gli imperiali, ma anche contro tutti i concittadini che li appoggiavano. In un momento in cui le divisioni politiche tra fazioni filo tedesche e filo franche erano un fatto corrente nellecittà e nelle campagne del regno italico, anche Pavia era divisa in due partiti contrapposti. Il tumulto dell’886 segnò, di fatto, la fine dell’età carolingi a in Italia: nata sotto il segno della potenza dei Franchi, tramontava ora nel disordine e nell’anarchia (41).
Nell’887, infatti, in seguito all’abdicazione senza eredi dell’imperatore Carlo III il Grosso, l’impero si frammentò in tre parti: l’area franca finì nelle mani del duca Oddone, quella germanica andò ad Arnolfo di Carinzia e infine nel regno italico un’assemblea di nobili affidò la corona a Berengario duca del Friuli (42). Le dinamiche politiche del regno italico, in seguito alla scomparsa della dinastia carolingia, mostrano come Pavia abbia conservato intatta la sua preminenza sulle altre città dellapianura Padana. L’antica capitale gota e longobarda, infatti, godeva di strutture e servizi di plurisecolare tradizione: venne pertanto scelta anche dai sovrani italici sia come sede delle elezioni regie, sia come luogo delle assemblee dell’esercito. In ogni caso, si aprì un periodo convulso, caratterizzato da una serie di re che si susseguirono in maniera assai rapida, senza che
nessuno si dimostrasse in grado di mantenere il potere per un tempo sufficiente a governare.
(41) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., pp. 79-83.
(42) G. VITOLO, Medioevo cit., pp. 165-166.
Età dei Re “Nazionali” (43) – Papia caput Regni Italiae
L’abdicazione di Carlo il Grosso senza eredi designati aprì un periodo convulso per la successione a cui avrebbero potuto legittimamente aspirare almeno in quattro, due figli legittimi della dinastia carolingia e due bastardi. La legittima discendenzapoteva essere sostenuta da Carlo il Semplice, figlio di Ludovico il Balbo e Ludovico figlio di Bosone di Provenza ed Ermengarda. Entrambi, però, erano minorenni all’epoca. Gli altri due possibilicandidati che condividevano almeno in parte il sangue carolingio erano Arnolfo di Carinzia, figlio di Carlomanno, e Bernardo figliodi Carlo III. Anche in questo caso nessuno approfittò della situazione e del proprio lignaggio per succedere a Carlo il Grosso. L’unico in età adulta dei quattro era, peraltro, Arnolfo, al quale fu affidata la Marca Germanica. Il sovrano tedesco non esitò, comunque, a infiltrarsi presto nella lotta per la successione alla corona italica per poter poi conseguire quella imperiale (44).
Nessun discendente presunto o tale di Bernardo re d'Italia avanzò legittime pretese al trono italico, che rimaneva vacante. Il vuotodi potere venne dunque colmato da coloro che, disponendo di compagini territoriali da lungo tempo consolidate, poterono mettere in campo un numero sufficiente di armati. I primi a far valere la loro forza militare per impossessarsi della corona italica furono Berengario del Friuli e Guido di Spoleto. L’unico modo possibile per legittimare il potere ottenuto con la forza eral’incoronazione nella capitale pavese. Seppur lontano dai fasti che avevano caratterizzano Pavia in epoca longobarda, l’antica Ticinum rimase uno dei teatri principali del convulso periodo storico che per quasi un secolo caratterizzò il Regno Italico.
Tra il dicembre dell'887 e il febbraio dell'anno successivo, si tenne una cerimonia ormai insolita per Pavia: per la prima volta dalla caduta del Regno Longobardo, Berengario del Friuli fu elettoe incoronato re d'Italia proprio tra le mura pavesi. Il conseguente probabile sviluppo di un sentimento di appartenenza cisalpina e italica venne stroncato sul nascere dall’incoronazione, nello stesso luogo, anche di Guido di Spoleto.La parentela più o meno prossima con i Carolingi che i due pretendenti al trono vantavano sarebbe stata politicamente utile soltanto se fosse stata sostenuta con la forza delle armi: il palazzo regio di Pavia ospitò quindi, di volta in volta, colui chepoté schierare in campo il maggior
(43) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 83.
(44) G. FASOLI, I Re d’Italia (888-962), Firenze 1949, cap. I, p.1; G. ARNALDI, Berengario I, DBI vol. IX, Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, Roma 1967, p. 14.
numero di aderenti, o meglio, chi disponeva dei mezzi per comprarne la fedeltà. Per un decennio (888-898) la contesa per il potere vide come protagonisti Berengario, Guido e suo figlio Lamberto. A essi si aggiunse ben presto anche Arnolfo di Carinzia sovrano della Marca Germanica(45). Il sovrano friulano, già pochi mesi dopo la sua incoronazione, dovette affrontare militarmente Guido in campo aperto. Lo scontro ebbe esito sfavorevole per le truppe di re Berengario, che fu costretto a scendere a patti con lo spolentino. Secondo gli accordi stipulati tra i due, il sovranofriulano avrebbe mantenuto il titolo regale ma il territorio fu diviso con Guido in due rispettive sfere di competenza (46). Berengario, successivamente, dovette sostenere il suo debole potere accordandosi proprio con il sovrano tedesco, subordinandosidi fatto alla sua autorità (47).
Nel quadro dell'accordo stipulato fra i due, il re tedesco poté disporre, nel giugno dell'889, una donazione alla vedova di Ludovico II relativa a vasti beni nel regno italico, tra i quali
erano compresi anche i monasteri pavesi di S. Martino e di S. Tommaso. In tal modo, Arnolfo creò le basi per legittimare una futura ingerenza nella lotta per la corona italica. Nel febbraio dell'889 a minare il già labile potere di Berengario si rinnovò ilpericolo rappresentato da Guido da Spoleto. I vescovi, riuniti in concilio a Pavia, avevano accolto le promesse fatte loro dallo spolentino, che aveva battuto ancora una volta Berengario in battaglia. All'ampio consenso vescovile in favore di Guido si unirono ben presto anche i maggiorenti laici. Berengario continuò a fregiarsi del titolo regale, ma preferì ritirarsi nella sua Verona, da dove si accontentò di governare solo sui suoi domini familiari (48).
Il 21 febbraio dell’891 Guido riuscì anche a conseguire la corona imperiale a Roma, seguendo il protocollo consuetudinario dei sovrani carolingi, per cui la corona italica dava diritto anche altitolo imperiale. Il re spolentino finì dunque per imporsi con prepotenza nel confuso scenario del potere nel regno italico, gettando le basi per un promettente dominio duraturo. Sempre inserendosi nella tradizione carolingia, Guido, nel febbraio dell'891, donò alla moglie Ageltrude le abbazie pavesi di S. Martino, di S. Agata, e di S. Felice “della Regina”. Da maggio a luglio, re Guido fu di nuovo a Pavia dove, associatosi al trono ilfiglio Lamberto, emanò un capitolare che riprese motivi tradizionali della legislazione carolingia e firmò importanti provvedimenti. Dimorò nuovamente nella capitale dal luglio dell'892 e nell'aprile dell'anno dopo (49).
(45) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p.83; G. FASOLI, I Re d’Italia cit., pp. 2-9.
(46) G. ARNALDI, Berengario I, pp. 15-16.
(47) Ivi. p. 16.
(48) G. FASOLI, I Re d’Italia cit., pp. 9 -15; G. ARNALDI, Berengario I, pp. 15-17.
(49) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 84 ; G. FASOLI, I Re d’Italia cit., pp. 18– 24; G. ARNALDI, Berengario I cit., p. 18.
Nell’893 Arnolfo di Carinzia venne sollecitato dal papa e da Berengario a intervenire in Italia contro Guido (50). Il re tedesco inviò pertanto un esercito sotto il comando del figlio Sventiboldo che si unì alle truppe berengariane per poi marciare uniti su Pavia. Guido, preparatosi allo scontro, aveva munito di uomini e fortificazioni la roggia della Vernavola. Dopo alcuni giorni di combattimento senza esito per entrambe le fazioni, Guidosi liberò degli avversari versando una congrua somma di denaro. Ciò che risulta maggiormente, anche in questa occasione, è come lacapitale venisse strenuamente difesa piuttosto che ceduta senza opporre resistenza, ulteriore segnale dell’importanza strategica ma soprattutto legittimante per gli aspiranti sovrani alla corona italica.
Nell’894Arnolfo scese in Italia di persona alla guida di un formidabile esercito e, dopo aver conquistato Bergamo, puntò direttamente su Pavia. Questa volta la capitale venne rapidamente abbandonata da Guido, che preferì evitare di opporsi alla superiorità dell’armata tedesca. In breve tempo, Arnolfo iniziò adatteggiarsi come nuovo Carlo Magno. La sua prepotenza finì per inimicargli Berengario e la maggioranza degli altri signori italiani, che gli rivolsero contro i loro armati. Arnolfo, accerchiato, non poteva né dirigersi a Roma per conseguire la corona imperiale, né battere in ritirata verso la Germania. Il re tedesco fu costretto a riparare nella capitale pavese ma anche quii pericoli non mancarono: una rivolta dei cittadini causò non poche vittime tra le fila dell'esercito tedesco. Arnolfo riuscì a ritirarsi in Borgogna dopo una non facile traversata della Valle d'Aosta. Con la sua ritirata e il sopraggiungere improvviso della morte di Guido, Berengario si affrettò immediatamente a raggiungere la capitale per riappropriarsi del Regnum. Determinante ancora una volta fu la volontà dei signori italici, che preferirono abbandonare Berengario per sostenere le aspirazioni di potere del figlio di Guido, Lamberto. Avendo valutato superiore la forza militare del nemico che stava sopraggiungendo a Pavia, Berengario decise di lasciare la capitale
per ritirarsi ancora una volta nella sua Verona. Lamberto, nel gennaio dell'895, prese legittimo possesso di Pavia nel nome del defunto genitore (51).
Non era ancora trascorso un anno che Arnolfo di Carinzia, sollecitato all’intervento da papa Formoso e riavvicinatosi a Berengario, decise di scendere di nuovo in Italia. Nel dicembre dell’895 Arnolfo giunse a Pavia. Nell’occasione rilasciò un diploma alla badessa
(50) G. FASOLI, I Re d’Italia cit., p. 26.
(51) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 85; G. FASOLI, I Re d’Italia cit., p. 27-32; G. ARNALDI, Berengario I, pp. 18-19.
di S. Maria Teodote e inoltre avrebbe coniato denari nella zecca pavese (52). Questa volta Arnolfo riuscì a conseguire senza problemi la corona imperiale a Roma, ma la cinse per pochissimo tempo poiché fu vittima di un attacco apoplettico che gli stroncò la vita. Suo fedele alleato rimase comunque il conte di Milano Manfredo, che rivolse le sue armate contro le città vicine, tra cui Pavia. Egli venne ben presto catturato e giustiziato come monito ai nemici di Lamberto. I due re, Lamberto e Berengario, infatti, ristabilita la caotica situazione alla guida del regno italico sopraggiunta con la morte di Arnolfo, si incontrarono a Pavia dove si accordarono: Berengario sarebbe rimasto a Verona, mentre nella capitale avrebbe continuato a regnare Lamberto (53). I patti vennero tuttavia infranti già nell’898 quando il marchese di Toscana Adalberto, alleato di Berengario, provò ad attaccare disorpresa Pavia, ma senza successo. Lamberto morì nell'ottobre dello stesso anno lasciando ancora una volta la situazione in manoal suo rivale di Verona. Berengario, infatti, approfittò del vuotodi potere per recarsi a Pavia e assicurarsi il titolo regale. Cinta per l’ennesima volta la corona del Regnum, re Berengario dovette affrontare una minaccia ben peggiore dei pretendenti al trono. Nel 899 un esercito di Ungari investì il nord Italia imperversando senza tregua per città e campagne. Il sovrano
italico tentò invano di opporsi all'invasore magiaro, ma venne sconfitto sul Brenta nel settembre dello stesso anno. Gli Ungari infuriarono liberamente in Italia per circa un anno prima di scendere a patti con Berengario che, nel frattempo, si era rifugiato a Pavia (54). In questi anni, proprio a causa del pericolo ungaro, le mura della capitale vennero rinforzate e restaurate. I lavori alla cinta urbica furono ritenuti necessari anche dal vescovo Giovanni che, in vece del re, curò parte dei restauri. La persistente preoccupazione della minaccia ungara diede origine anche a una cerimonia destinata a perdurare nei secoli successivi. Si tratta della processione detta "delle crocette", che percorreva il circuito urbico cittadino e ne benediceva le porte invocando l'aiuto divino contro il terribile nemico. La processione si svolgeva ogni primo venerdì dopo Pasqua,data che tradizionalmente corrispondeva con il momento in cui i Magiari giunsero nell'899 a Pavia. Le invasioni ungare, tra l’altro, accelerarono, anche nel pavese, il fenomeno dell'incastellamento nelle aree rurali, pratica per altro avviata da tempo e destinata soprattutto alla protezione di corti e di chiese isolate. Una frammentazione del potere in tante piccole unità locali di certo non favoriva il sorgere di un forte potere centralizzato.
(52) C. BRAMBILLA, Monete di Pavia raccolte ed ordinatamente dichiarate, Arnaldo Forni Editorie, Pavia 1883 pp. 140-141.
(53) G. FASOLI, I Re d’Italiacit., p. 38-40.
(54) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 86; G. ARNALDI, Berengario I cit., pp. 22-23.
Le gravi preoccupazioni provocate dall'incursione magiara del biennio 899-900 offrirono lo spunto ai grandi d'Italia per rinnovare la guida del regno sollevando contro Berengario un nuovocompetitore. La scelta cadde su Ludovico III di Provenza, nipote dell'imperatore Ludovico II, che entrò a Pavia nell’ottobre del 900 e venne eletto da tutti i vescovi e maggiorenti laici della
città. Berengario riparò, come d’abitudine,a Verona, mentre Ludovico III si preparava a ricevere la corona imperiale a Roma. Tra i diplomi emanati dal nuovo re e imperatore ci furono ulteriori donazioni al monastero di S. Maria Teodote (55).
Nel 902, Berengario provò per l’ennesima volta a inserirsi nella contesa per la corona italica. Dopo aver ricostruito una rete di alleanza e contando anche sull’appoggio di contingenti magiari, marciò contro Ludovico III, che preferì evitare lo scontro rinunciando al trono senza difenderlo. Berengario entrò di nuovo trionfalmente a Pavia, ma il suo regno fu nuovamente minacciato daLudovico, che riorganizzò le proprie forze. Nel 905, infatti, anche approfittando di una malattia che aveva colpito Berengario, il signore della Provenza riuscì a insediarsi a Pavia e a Verona, scalzando momentaneamente il rivale che, però, ristabilitosi, riconquistò il potere. Ludovico III venne catturato e accecato, magli fu consentito di ritirarsi per il resto della vita nei suo domini in Provenza (56). Si aprì un periodo di relativa pace e stabilità in cui per un decennio Berengario poté regnare quasi indisturbato. Unica minaccia in questi anni fu solo l’effimero tentativo di detronizzazione portato da Ugo di Vienne nel 907. Berengario, nel 915, riuscì, dopo anni, a cingere anche la corona imperiale. Dal 908 al 920 fu molto presente a Pavia, dove concessedonazioni e diplomi a monasteri quali S. Giovanni Domnarume S. Maria Teodote (57).
Soltanto nel 921 gli avversari interni di Berengario, guidati da Ermengarda d'Ivrea, riuscirono a istigare contro di lui un nuovo pretendente al trono, Rodolfo II di Borgogna. Berengario fu costretto ancora a ripiegare su Verona. Rodolfo sconfisse l'imperatore duramente a Fiorenzuola d’Arda e poi si diresse a Pavia per cingere la corona regia prima di ritornare in Borgogna. Proprio approfittando della sua assenza, Berengario assoldò un esercito di Ungari che scagliò contro Pavia. La violenza dei magiari si scatenò sulla capitale che, oltre a essere saccheggiata, fu data alle fiamme e la sua popolazione duramente decimata. Accontentatisi di un lauto bottino i mercenari Ungari
tolsero l'assedio all'ormai devastata Papia e si diressero verso la Borgogna (58). Ogni pretesa sulla corona
(55) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 87.
(56) G. ARNALDI, Berengario I cit., p. 25; G. FASOLI, I Re d’Italia cit., pp. 55-70.
(57) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 88.
(58) Ivi., pp. 89-90.
italica da parte di Berengario si spense con il suo assassinio, avvenuto il 7 aprile 924 proprio nella sua Verona, dove aveva sempre trovato riparo (59).
Morto il principale rivale, Rodolfo ritornò a Pavia dall’agosto del 924 al dicembre del 925. La sua lunga permanenza è indice che non tutto andò distrutto dall'incursione ungara e che gli apparatiamministrativi continuarono ancora a funzionare. Anche le coniazioni della zecca non cessarono e sotto Rodolfo II si contanoalmeno due emissioni monetali (60).
I volubili sostenitori del re borgognone ben presto gli voltarono le spalle. Prima tra tutti fu Ermengarda d'Ivrea, la quale, dopo aver chiamato Rodolfo in Italia, capeggiò il dissenso a lui ostile. Tra il 925 e il 926 i ribelli si impadronirono di Pavia, costringendo Rodolfo alla ritirata. Il sovrano borgognone non si diede per vinto e tentò di riconquistare la capitale con la forza:il suo tentativo fallì miseramente costringendo Rodolfo a tornare in Borgogna. Per nulla abbattuto, il sovrano mandò in Italia nel 926 il suocero Burcardo di Svevia che, dopo aver raggiunto l'arcivescovo ambrosiano a Milano, fu sconfitto da un esercito di ribelli italici composto soprattutto da pavesi.
Sollecitato da alcuni potenti, si riaffacciò sulla scena politica italica Ugo di Vienne, non nuovo come aspirante alla corona. Sbarcato a Pisa, si diresse a Pavia dove, nel 926, si impadronì del titolo di re che mantenne per un ventennio, nonostante molti
tentativi di detronizzazione. La prima congiura ai suoi danni fu ordita nel 927 da avversari interni alla stessa Pavia. Si trattavadei due giudici Valperto ed Everardo Gezone. Pare che il movente fosse un desiderio di vendetta di Valperto per la figlia divenuta concubina del re. Venuto a sapere della congiura, Ugo dapprima optò per il dialogo, poi, sfruttando l'alleanza con il vescovo cittadino e Sansone, un nobile avverso a Everardo, con uno stratagemma condusse fuori città i congiurati che vennero catturati e giustiziati (61). Nel 931 Lotario venne associato al potere a Ugo che in tal modo spianava la strada per una eventuale e sicura discendenza.
Venuti meno i patti stretti a suo tempo con l’ormai defunto Berengario I, i Magiari ripresero le loro violente incursioni in Italia. Ugo riuscì a evitare lo scontro con gli Ungari in due occasioni, tra il 936 e il 937. Frattanto un altro pericolo finì per minacciare seriamente anche Pavia. Alle incursioni magiare, infatti, si aggiunsero quelle dei Saraceni, pirati musulmani che costituivano la seconda e non meno pericolosa minaccia per l’intera Europa mediterranea del tempo (62). I Saraceni agivano interritori non lontani dalla capitale pavese, come a Genova o ad Acqui, incutendo non poco timore per la sicurezza del
(59) G. FASOLI, I Re d’Italia cit., pp. 93–95; G. ARNALDI, Berengario I cit., p. 29.
(60) C. BRAMBILLA, Monete di Pavia cit., pp. 148-149.
(61) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 91; G. FASOLI, I Re d’Italia cit., pp. 116-119.
(62) G. VITOLO, Medioevo cit., pp. 149-151.
Regnum. Ai comuni nemici di tutto il mondo cristiano dell’epoca, per Ugo se ne aggiunsero altri personali. Si trattava del duca Arnolfo di Baviera, penetrato ostilmente nella valle dell'Adige sino a Verona. Sconfitto in breve tempo il nobile bavarese venne fatto prigioniero e portato a Pavia insieme al vescovo veronese
Raterio che si era schierato dalla parte dell'invasore. Problemi interni al regno sorsero anche a Milano dove si verificarono scontri talvolta armati contro le forze dell'arcivescovo (63).
Il lungo regno di Ugo non annovera solo avvenimenti violenti. Sotto la sua guida l’antica Papia godette di una relativa rinnovata prosperità. Un evento favorevole alla comunità pavese fu senza dubbio il trasferimento da Bobbio alla capitale delle reliquie di San Colombano che richiamarono in città folle di fedeli. Interventi di rinnovamento coinvolsero soprattutto l’edilizia cittadina. Il re promosse la ricostruzione e il restauro degli edifici danneggiati dall'incendio del 924, a cominciare dal palazzo regio. Vennero poi riconfermati privilegi ai monasteri di S. Pietro in Ciel d'oro, S. Maria Teodote, dei SS.Martino e Leone e di S. Giovanni Domnarum. Ugo promosse anche una sorta di circolo culturale intorno alla sua figura di sovrano. La presenza di Liutprando da Cremona è solo un esempio del rinnovato vigore per gli studi letterari e giuridici nella capitale. Con la presenza di Odone alla corte di Ugo, infine, iniziò la penetrazione cluniacense a Pavia. Le capacità di regnante di Ugo non riuscirono comunque a evitare che le irrequietezze dei grandi maggiorenti italici prendessero di nuovo il sopravvento. Il pericolo arrivò stavolta dall'interno del suo entourage (64).
Berengario, già marchese d'Ivrea e nipote di Berengario I, frequentava da tempo la corte del re. Ugo, però, sospettando sue aspirazioni alla corona, ne ordinò la cattura ma Berengario riuscìa fuggire grazie alla sua amicizia con l’erede al trono Lotario. Riparato in Germania, con l'aiuto di Ottone di Sassonia organizzò l'offensiva contro Ugo, coagulando intorno a sé il malcontento generale dei signori d’Italia nei confronti del re. Non riuscendo a venire a capo della rivolta, Ugo nel 945 scese a patti con Berengario, dividendo il regno in due sfere d'influenza. Di fatto il potere era nelle mani di Berengario II che deteneva il titolo pretestuoso di "sommo consigliere" del re. L’effettivo potere del nuovo sovrano fu tutt’altro che effimero come conferma anche la tradizione che tramanda che il sovrano, intorno al 947, dovendo versare un tributo agli Ungari, nel tentativo di frenarne i
ripetuti saccheggi, ricorse all'artificio di indebolire la moneta,aggiungendo alla lega una certa
(63) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 92; G. FASOLI, I Re d’Italia cit., pp. 131-136.
(64) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 93.
percentuale di rame. Una riforma monetaria del genere non poteva che essere emanata da una autorità che godeva di un certo potere eprestigio (65).
Nel 947 Ugo lasciò il regno al figlio Lotario. Dal 949 al 950 re Lotario fu presente a Pavia, dove rilasciò gli abituali diplomi a monasteri pavesi tra cui quello di S. Maria del Senatore. Nel 949, su iniziativa di Berengario II, fu inviato a Costantinopoli come ambasciatore il diacono Liutprando che, imbarcatosi a Pavia, raggiunse navigando la capitale dell'Impero d'Oriente (66).
Nel 950 Lotario scomparve prematuramente, lasciando la giovane moglie Adelaide da poco dichiarata consors regni, titolo che avrebbe non poco condizionato la sua vita futura, in quanto pretesa in moglie dagli aspiranti al trono italico. Il trono pavese rimase vacante solo per pochi giorni. Il 15 dicembre del 950, nella chiesa di S. Michele, vennero incoronati re Berengario II e il figlio Adalberto (67). I due re rilasciarono, nel 951, un diploma in concessione al monastero di S. Maria del Senatore. La vedova di Lotario, Adelaide, fu inizialmente fatta prigioniera da Berengario II, ma riuscì a fuggire. Nel frattempo Ottone di Sassonia decise che era il momento di rendere conto dei favori concessi in precedenza all'attuale re d'Italia. Varcate le Alpi con un poderoso esercito, Berengario e Adalberto fuggirono e non si opposero al sovrano sassone, che legittimò il suo potere appenaacquisito celebrando nella capitale pavese le sue nozze con Adelaide. Egli si fregiò del titolo di re dei Franchi e degli Italici (68). Ottone I rimase a Pavia fino al febbraio 952 per poitornare in Germania con Adelaide e con rappresentanti di spicco della schola pavese, che in quegli anni aveva assunto rinnovata
importanza. Rimase sul posto, a presidio, Corrado di Lorena. Berengario, però, dopo aver reso formale atto di sottomissione a Ottone, rientrò in Papia pretendendo di esercitare l’antico potere. Negli anni seguenti, si acuirono quindi nuovamente i contrasti tra Ottone I e i due re Berengario e Adalberto, che nei momenti di crisi lasciavano opportunamente Pavia per riparare in una qualche fortezza curtense, meglio difendibile. Nel 956 giunse in Italia il figlio di Ottone, Liudolfo, che venne accolto senza contrasti a Pavia. Berengario riacquistò repentinamente il possesso della città, ma fu nuovamente costretto a ripiegare altrove quando, nel 961, fece il suo trionfale ingresso nella capitale Ottone I in persona. Dopo aver cinto la corona imperiale a Roma, Ottone soggiornò a Pavia con una certa continuità dalla Pasqua del 962 a quella dell'anno seguente. L’attenzione del sovrano tedesco era rivolta a un riordinamento
(65) A. ROVELLI, Il denaro di Pavia cit., pp. 76-83.
(66) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 93.
(67) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., p. 64.
(68) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 94.
definitivo del potere in Italia. Si mosse quindi lungo il Po alla volta di Ravenna, diretto alla munitissima rocca marchigiana di S.Leo, dove Berengario aveva organizzato la sua ultima resistenza. Insieme al figlio Adalberto, infatti, aveva lì concentrato le forze superstiti delle rocche dell’Italia settentrionale. Con la morte di Berengario II, ultimi tentativi di recuperare il trono perduto furono promossi ancora da Adalberto, che nel 964 arrivò adattaccare Pavia con schiere di mercenari Saraceni. Ogni tentativo si dimostrò tuttavia vano: l’identità del Regnum venne progressivamente assorbita e annullata nell’Impero (69).
Età Ottoniana – Papia civitas gloriosa
Fallito ogni tentativo di Adalberto di riconquistare il trono pavese, Ottone I poté tranquillamente soggiornare a Pavia dove si trattenne fino al gennaio 965, rilasciando diplomi in favore di S.Pietro in Ciel d'Oro e di S. Maria Teodote. Dal 967 l’imperatore riprese il costume tipicamente germanico della corte itinerante più atta al controllo del territorio. Oltre a privilegiare Verona per la rapidità di collegamento attraverso la Val d'Adige, e Roma,sede pontificia, sotto Ottone si istituì una sorta di bipolarismo tra Pavia e Ravenna. I collegamenti tra le due città erano assicurati fin dall'antichità da un efficiente sistema fluviale, protetto ora da potenti feudatari filoimperiali come Attone di Canossa (70). Pur perdendo la sua esclusività di dimora imperiale in età ottoniana, Pavia sembrò godere comunque di un periodo di benessere e sviluppo. L’antica capitale longobarda si distinse dagli altri centri della pianura padana per la sua fondamentale funzione di crocevia di importanti commerci, sia di derrate alimentari sia di oggetti di lusso. I traffici commerciali vennerofavoriti soprattutto dall’accesso alle stesse vie d’acqua utilizzate dall’imperatore per i suoi spostamenti: dal Ticino si raggiungeva facilmente il Po, asse diretto con il mare Adriatico ei traffici marittimi. Inoltre, con l’avvento degli Ottoni, Milano perse nuovamente importanza a favore di Pavia, la cui preminenza venne sancita, tra l’altro, dalle coniazioni della zecca, che già dalla reggenza di Ludovico il Pio recavano il simbolo del potere civile, il palatium, mentre a Milano le monete erano decorate con il tempio tetrastilo, simbolo della dignità metropolitica della chiesa ambrosiana (71).
(69) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., pp. 95–96; G. FASOLI, I Re d’Italia cit., pp. 195-204. (70) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 96. (71) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., p. 50-53.
Il patrocinio regio sulla coniazione della zecca di Pavia favorì la progressiva affermazione del denaro pavese, non solo in ambito regionale, a scapito della moneta milanese. Sotto gli Ottoni le coniazioni pavesi si impongono per la purezza dell’argento e del
peso su ogni altra moneta italiana, un prestigio che si sarebbe mantenuto molto a lungo in tutto il regno (72).
Ottone I tornò a Pavia nel luglio del 969 e vi soggiornò ancora daNatale sino alla Pasqua del 970. Durante la permanenza dell’imperatore nella capitale gli enti monastici pavesi furono soggetti a un’intensa opera di rinnovamento, grazie anche alla partecipazione di Maiolo, prestigioso abate di Cluny, fortemente sostenuto dal papato. Alla corte di Ottone I confluirono personalità di spicco del panorama culturale dell’epoca, tra cui Liutprando, divenuto nel frattempo vescovo di Cremona. L’assembleadel regno tornò a riunirsi nella capitale nel 971, quando venne emanato l’edictum Papiense de duello. L’imperatore si soffermò in Papia per l’ultima volta nel luglio e nell’agosto del 972. Ottone I morì nel marzo del 973 lasciando il trono al figlio omonimo. Dopo la morte del primo degli Ottoni, Pavia fu assiduamente frequentata dai membri femminili della casata imperiale, divenendoper qualche tempo una sorta di “capitale delle regine”. Di frequente, infatti, risedettero in città la vedova e imperatrice Adelaide insieme alla nuora Teofano, moglie del nuovo imperatore Ottone II. Le due principesse, avvalendosi delle competenze di Maiolo di Cluny, si impegnarono nella rifondazione e nel restauro di alcuni conventi e abbazie pavesi, come S. Salvatore Foris Portam e S. Martino Foris Portam. Le preoccupazioni principali delle sovrane, spesso in contrasto fra loro, erano rivolte soprattutto alla gestione economica del palazzo regio, che ancora perdurava in Pavia quale fulcro del potere imperiale (73). Adelaide, inizialmente in dissidio anche con il figlio Ottone II oltre che con Teofano, esercitò da Pavia una vera e propria reggenza del regno italico (74). La riconciliazione fra la regina madre e il figlio venne mediata dell’autorevole abate cluniacense Maiolo e si concretizzò proprio nel centro pavese nell’anno 980. Durante gli anni della reggenza di Ottone II, figura di rilievo nella capitale fu il vescovo locale Pietro, che ricopriva anche lacarica di cancelliere imperiale. Il prelato non esitò ad approfittare della posizione privilegiata e dei lunghi periodi di
assenza del sovrano per allargare la propria sfera di potere in città, soprattutto a danno dei monasteri regi. Ben presto Pietro
(72) V. CAPOBIANCHI, Il denaro pavese e il suo corso in Italia nelXII secolo, in Rivista Italiana di Numismatica IX, Milano 1896, pp. 21-60. (73) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 97. (74) G. ARNALDI, Adelaide, imperatrice, DBI vol. I, Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, Roma 1960, p. 248.
godette di un prestigio tale da poter espandere la propria influenza anche oltre le mura pavesi. Il presule pavese raggiunseil culmine della sua carriera nel 983, quando ascese al soglio pontificio con il nome di Giovanni XIV (75). Nello stesso anno Ottone II ritornò a Pavia e vi soggiornò ad aprile e a maggio. Fu l’ultima volta che l’imperatore mise piede nell’antica capitale italica: nel dicembre del 983 la morte lo colse mentre si trovava a Roma. Con la dipartita del giovane imperatore, il potere venne nuovamente esercitato dalla componente agnatizia e femminile dellafamiglia imperiale: Adelaide, che si trovava a Pavia, continuò a mantenere una sorta di reggenza italica, forte anche di benefici derivati da alcune pubbliche entrate nell’Esarcato. Nel 984, la regina madre ricevette a Pavia la visita della nuora Teofano, giunta con il piccolo Ottone III, sotto tutela per la minore età. Il 18 luglio dell’anno successivo Adelaide presiedette un placito in Pavia: fu l’ultimo provvedimento della regina, che poco dopo rientrò in Germania insieme a Teofano. Le due principesse riuscirono a strappare a Enrico II di Baviera la tutela del piccolo Ottone, garantendo così la successione imperiale (76). Il connubio tra Adelaide e la nuora non durò però a lungo e ben presto Teofano si sostituì alla regina madre, tanto nella reggenzadel regno italico quanto nella tutela del figlio. Adelaide era ancora a Pavia nell’aprile del 990, ma già dal maggio successivo il suo posto venne preso dalla vedova di Ottone II. L’imperatrice Teofano affidò la gestione finanziaria del palazzo regio al suo consigliere Giovanni Filagato, vescovo di Piacenza e futuro antipapa, al quale si debbono sciagurati interventi amministrativi
che portarono a una rapida dilapidazione del patrimonio regio (77). Con la morte di Teofano, sopraggiunta nel 991, le circostanze favorirono ancora una volta Adelaide, che ritornò ad assumere un ruolo politico determinante. Assistita dalla figlia Matilde e dall’arcivescovo di Magonza, l’imperatrice assunse la reggenza dell’impero in nome del nipote ancora minorenne. Nel 995 Ottone III raggiunse la maggiore età e poté finalmente cingere la corona imperiale, segnando di fatto il definitivo allontanamento di Adelaide dalla politica: la regina madre si trasferì nel monastero di Selz in Alsazia dove morì nel dicembre del 999. Nei suoi ultimi anni di vita, seppur lontana dalla capitale, non disdegnò di concedere ripetute donazioni e conferme al monastero di S. Salvatore di Pavia al quale aveva dedicato assidue cure qualche decennio prima (78).
Già nel maggio del 995 la gestione del potere era stata affidata al giudice Alberico, che agiva a Pavia in qualità di messo imperiale di Ottone III. Il giovane imperatore soggiornò
(75) A.A. SETTIA, Pavia carolingiacit., p. 97. (76) G. ARNALDI, Adelaide, imperatrice, cit., p. 248. (77) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 98. (78) G. ARNALDI, Adelaide, imperatrice, cit., pp. 248-249.
personalmente nella capitale nell’aprile del 996, quando ricevettela rinnovata fedeltà dei grandi del regno italico. Vi ritornò nell’agosto e vi rimase per oltre un mese, durante il quale dispensò un diploma imperiale a S. Maria Teodote prima di riprendere la via di Germania. Nel suo incessante peregrinare, Ottone III presiedette una sinodo a Pavia nei primi giorni di febbraio del 997 e vi tornò per trascorrere il Natale. Nel settembre e ottobre del 998 la città pavese ospitò ancora l’imperatore che, nell’occasione, confermò i beni del monastero diS. Martino Foris Portam prima di raggiungere Ravenna attraverso la solida via fluviale (79).
Da alcuni anni la parte occidentale del regno italico era sconvolta da ripetute sollevazioni nobiliari promosse da Arduino
marchese d’Ivrea, la cui giurisdizione comprendeva probabilmente anche il comitato di Lomello e quindi toccava da vicino la città stessa di Pavia. I contrasti tra Arduino, conte della Marcha d’Ivrea, e l’Impero erano prevalentemente di natura giurisdizionale. I vescovi eporediesi, infatti, agivano in osservanza delle disposizioni di Ottone III, la cui intenzione erarinsaldare la presenza imperiale nella regione. La molla che spinse Arduino ad agire è rintracciabile nel suo proposito di operare una ricostruzione integrale della posizione politica, economica e giuridica del marchesato in assoluto contrasto con l’aumento del potere vescovile, soprattutto all’interno delle muracittadine. Nel biennio 996– 997 il contrasto tra Arduino e l’Impero si concretizzò nello scontro con il vescovo di Vercelli, Pietro: il Marchese d’Ivrea aveva infatti deciso di irrompere nella città vescovile con i suoi armati nella primavera del 997. Non sono ben chiare le fasi dell’attacco di Arduino a Vercelli, mai cronisti dell’epoca attribuiscono alla mano del marchese l’omicidio del vescovo Pietro, il cui cadavere venne dato alle fiamme all’interno della cattedrale cittadina. I violenti fatti diVercelli del 997 e i reiterati attacchi di Arduino contro i successori di Pietro, in particolare con il vescovo Varmondo, indussero Ottone III a intervenire direttamente schierandosi dallaparte dei vescovi. Nel 999 Arduino fu giudicato da una sinodo in S. Pietro a Roma alla presenza dell’imperatore e di papa SilvestroII. Il pontefice, sollecitato anche dai vescovi della Marcha d’Ivrea, emise una scomunica contro il marchese, definendolo hostis publicus. Malgrado fosse sostenuto da molti seguaci, la scomunica costrinse Arduino a lasciare il marchesato nelle mani dell’omonimo figlio, detto Ardicino, e ritirando si in attesa della riscossa (80).
(79) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 98. (80) G. ARNALDI, Arduino, re d’Italia, DBI vol. II, Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, Roma 1967, pp. 53-58.
Frattanto, nel 999, a Pavia, per precisa disposizione imperiale, il conte palatino Bernardo II, accusato di sostenere la causa
arduinica, venne rimosso dalla carica comitale dalla quale venneroesclusi anche tutti i suoi discendenti. Fino ad allora i conti delpalatium erano appartenuti alla dinastia dei Bernardingi, le cui origini risalivano a Bernardo I, figlio di Pipino il Gobbo, primogenito di Carlo Magno e primo titolare del regnum langobardorum. L’imperatore Ottone III designò nuovo conte palatino Ottone, già erede della contea di Lomello ottenuta nel 966 dal padre Cuniberto al termine di un’illustre carriera da giudice esercitata proprio nel palazzo regio pavese (81).
Dopo una visita a Ravenna, Ottone III si recò per l’ultima volta nella capitale pavese nell’ottobre del 1001 per presiedere un placito in cui si decise del possesso del monastero “della Regina”in favore del giudice Lanfranco. Infatti, sin dai tempi del nonno Ottone I, a Pavia il vivace movimento riformatore rivolto agli enti religiosi non era rimasto limitato ai soli membri della famiglia reale, ma aveva coinvolto anche privati cittadini di altorango. Nel 967, per iniziativa del giudice Gaidolfo, nacque il primo nucleo di quello che sarebbe diventato in seguito il monastero di S. Maiolo. Intorno al 989 un altro giudice, Gualtieri, diede vita alla canonica che avrebbe portato il suo nome. Nel 976, invece, il conte Bernardo fondò la canonica della SS. Trinità, e infine Aginolfo, fratello del conte palatino Ottone, diede vita, all’inizio del XI secolo, al monastero di S. Bartolomeo (82).
La morte di Ottone III sopraggiunse prematuramente nel gennaio del1002, aprendo di fatto la strada alla riscossa di Arduino d’Ivrea.Il trono pavese rimase vacante per appena ventidue giorni. Arduino, infatti, approfittò della situazione per dirigersi subitoverso Pavia. Il 15 febbraio l’ex marchese d’Ivrea fu incoronato dal vescovo Guido re d’Italia nella chiesa di S. Michele “et vocatus caesar ab omnibus regnum perambulat universum, regio iure cuncta pertractans”. Arduino dunque riuscì non solo a farsi eleggere re, ma preparò addirittura una sorta di successione allacorona imperiale attribuendosi il titolo di “caesar ”. L’incoronazione di Arduino assunse un significato importante per la storia della capitale pavese (83). Per tutta la durata dell’età
ottoniana, infatti, il regno italico, associato all’Impero, non necessitò istituzionalmente di alcuna cerimonia di investitura specifica, che infatti non venne più celebrata. Quella di Arduino fu la prima incoronazione avvenuta a Pavia dai tempi di BerengarioII. Per il ribelle marchese d’Ivrea si trattava tra l’altro di un
(81) B. DRAGONI, Il Comune di Pavia fra il mille ed il milleduecento, in BSPSP, vol. XXIX, fasc. 1-4 (giu, 1929), Pavia 1930, p. 94; B. DRAGONI, I conti di Pavia e i conti palatini di Lomello nella prima formazione dell'antico Comune pavese, in BSPSP, vol. II, fasc. 1–2 (dic, 1948), Pavia 1948, pp. 34-36. (82) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 99. (83) G. ARNALDI, Arduino, re d’Italia cit., p. 58.
necessario espediente per legittimare la sua ascesa al trono (84).Il nuovo re, seppur eletto con un colpo di mano e grazie al sostegno di pochi fedelissimi, riuscì subito a inserirsi con efficacia nella tradizione regia pavese. Tra i suoi interventi in favore di enti ecclesiastici cittadini, subito dopo l’elezione, ilsovrano provvide a confermare i privilegi del monastero pavese diS. Salvatore, fondato dall’imperatrice Adelaide. Sempre a Pavia ilnuovo re emanò altri due diplomi, nel 1002 e nel 1003. Riprendendoin parte l’azione di Ottone III, Arduino concesse privilegi e confermò beni anche ad altri enti ecclesiastici dell’Italia Settentrionale.
La scarsa base di consenso su cui si basava il potere di Arduino cominciò a sgretolarsi per mano dei principali oppositori: tra loro l’arcivescovo di Milano e i vescovi di Cremona, Piacenza e Brescia riconobbero controvoglia Arduino, mentre l’arcivescovo di Ravenna e i vescovi di Verona, Modena e Vercelli non mancarono di manifestare apertamente la loro ostilità. Al partito antiarduinicoaderì, addirittura, lo stesso vescovo pavese Guido che, se in un primo tempo aveva sposato la causa del re neo eletto, ben presto approfittò della situazione politicamente incerta per tentare un’estensione della sua egemonia sui monasteri esenti di S. Pietroin Ciel d’Oro e del Senatore. I nemici di Arduino, capeggiati dal
vescovo di Vercelli Leone, attraverso ambascerie cercarono di convincere Enrico II, re di Germania dal 1002, perché scendesse inItalia a spodestare l’usurpatore. Il re sassone in un primo momento si limitò a mandare nella Penisola una piccolo contingentemilitare guidato dal duca Ottone di Carinzia che venne facilmente sconfitto da re Arduino. Dopo un anno di tregua, Enrico II decise di scendere personalmente a capo del suo poderoso esercito per sconfiggere una volta per tutte Arduino e i suoi seguaci. Nella primavera del 1004, il re tedesco attraversò le Alpi e con un abile diversivo circondò le truppe di Arduino che si arresero senza combattere (85). Enrico II si aprì facilmente la strada verso Pavia, dove il 12 maggio venne eletto re d’Italia durante una cerimonia d’incoronazione tenuta in S. Michele dall’arcivescovo di Milano Arnolfo (86).
Non passò nemmeno un giorno dall’elezione del re tedesco al trono italico che avvenne un fatto quanto mai inaspettato: i cittadini pavesi, nella notte, si armarono e si diressero contro il palazzo regio dove risiedeva Enrico II. Il palatium venne assaltato dai ribelli che probabilmente speravano in un rapido successo, visto che il grosso dell’esercito imperiale era acquartierato fuori dalle mura cittadine. In breve tempo, però, l’esercito tedesco riuscì comunque a penetrare in città e ad avere ragione dei rivoltosi che furono duramente
(84) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., p. 64. (85) G. ARNALDI, Arduino, re d’Italia cit., pp. 58-60. (86) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit.,p. 65.
repressi. Il re Enrico si ritirò in una fortificazione presso S. Pietro in Ciel d’Oro, dove accolse alcuni pavesi ribelli superstiti a cui concesse il perdono grazie soprattutto all’intervento dell’abate di Cluny Odilone (87).
Prima di allontanarsi dall’Italia per tornare in Germania, Enrico tenne un’assemblea a Pontelungo, fra Pavia e Milano, durante la quale riconfermò i beni di S. Pietro in Ciel d’Oro. Il sovrano lasciava dietro di sé un regno solo apparentemente pacificato,
dove si vide ben presto risorgere la fortuna politica di Arduino, destinata a durare un decennio. Enrico, infatti, ritornò nella Penisola soltanto nel dicembre del 1013: mentre trascorreva le feste natalizie a Pavia, il re di Germania fu raggiunto da messi di Arduino che gli offrirono la rinuncia definitiva alla corona regia, in nome proprio e dei figli, in cambio della concessione diuna contea. La proposta venne respinta da Enrico che, attraverso Ravenna, proseguì il suo viaggio diretto a Roma per cingervi la corona imperiale. Arduino attaccò ancora Vercelli e Novara, ma il suo tentativo di far vacillare il potere imperiale venne represso dai maggiorenti italici fedeli a Enrico. Definitivamente sconfitto, l’ex marchese d’Ivrea di ritirò nel monastero di Fruttuaria dove morì il 14 ottobre 1014 (88).
La fine di Arduino non coincise tuttavia con la fine degli scontri: nel 1016 il vescovo Leone di Vercelli, divenuto principale sostenitore della parte imperiale, invocò con forza la necessità che un esercito tedesco scendesse in Pavia, provvedimento che l’imperatore Enrico si rifiutò di assumere. Nello stesso anno il vescovo pavese, insieme con i presuli di Novara e Vercelli e ai marchesi Aleramici, partecipò all’assedio di Santhià, superstite roccaforte degli arduinici. Negli stessi anni in cui veniva definitivamente risolta la questione del trono italico, la preponderanza milanese si accentuò soprattutto in campo civile, quando nel 1015 a Erlembardo, definito “miles SanctiAmbrosii”, venne congiuntamente affidata la giurisdizione sui comitati di Milano, Seprio e Pavia. L’imperatore discese un’ultimavolta in Italia nell’inverno del 1021 e fu presente, insieme con papa Benedetto VIII, alla solenne sinodo tenuta in Pavia nell’agosto successivo. Durante la reggenza di Enrico le monete coniate a Pavia, così pure come quelle battute da Arduino, mantennero la purezza dell’argento e del peso che da tempo connotavano il conio pavese come il più apprezzato per le transazioni commerciali in tutta Italia.
La morte di Enrico II sopraggiunse nel luglio del 1024. Appena a Pavia giunse la notizia del decesso dell’imperatore, i cittadini, che da tempo ormai mal sopportavano la presenza regia in città,
assaltarono il palatium e lo distrussero dalle fondamenta sino all’ultima
(87) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., p. 100. (88) G. ARNALDI, Arduino, re d’Italia cit., p. 61.
pietra, stabilendo che nessun re d’allora in poi avrebbe avuto residenza in città. Anche se un tale atto non cancellò ogni traccia dell’amministrazione regia a Pavia, fu il segno evidente di un profondo cambiamento (89). Esistono numerose e variegate interpretazioni storiografiche su questo avvenimento epocale per la capitale altomedievale pavese. Sembra comunque plausibile che il palazzo regio sia stato demolito poiché, in seguito alla dismissione dell’organizzazione gravitante intorno alla antica sede regia, la burocrazia palatina, in passato vantaggiosa per lacittà, aveva finito per divenire un peso che limitava gli interessi cittadini. Il palazzo regio venne distrutto dunque perché era un ostacolo alle aspirazioni cittadine in espansione. Proprio questo desiderio di indipendenza decisionale, favorito anche dall’assenza e dall’effimero controllo dei sovrani tedeschi sul regno italico, avrebbe propiziato la nascita dei comuni nell’Italia settentrionale. Anche Papia stava, a suo modo, cavalcando quel processo di indipendenza cittadina già in atto in altri centri del regno italico, ma con qualche eccezione. Nonostante la demolizione del palazzo regio, infatti, Pavia non mise mai in discussione il riconoscimento dell’istituzione imperiale in quanto tale e soprattutto la fedeltà dei pavesi a essa (90).
Età Comunale – Papia civitas foedelissima
La demolizione del palazzo regio consentì anche alla capitale pavese di cavalcare quel processo di affermazione delle prerogative cittadine già in atto, seppur con modalità diverse da città in città, in molti altri centri dell’Italia settentrionale. La particolarità del cammino che portò Pavia a costituirsi come
libero Comune fu, però, la sostanziale fedeltà del capoluogo pavese all’Impero e ai suoi rappresentanti. La dismissione del palatium non ebbe, infatti, l’obiettivo di eliminare l’esistenza dell’ufficio comitale, ma di inibire per il futuro la sua presenzatra le mura cittadine. È quindi probabile che l’insurrezione del 1024, pur non mancando di ledere i diritti dei conti, si proponesse soltanto di eliminare radicalmente, una volta per tutte, la burocrazia palatina. Il conte di palazzo, che riassumevain sé anche le cariche di conte di Pavia e di Lomello, fu così costretto a riparare proprio nella sua roccaforte lomellina, da cui continuò a sorvegliare la gestione interna della
(89) A.A. SETTIA, Pavia carolingia cit., pp. 101-102. (90) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 70-72.
capitale pavese esercitando attraverso subalterni la propria autorità comitale che non fu, di fatto, mai revocata ufficialmenteper molto tempo ancora (91).
Dopo la morte dell’imperatore Enrico II, il successore divenne Corrado II di Franconia, incoronato re di Germania a Magonza nel settembre del 1024. I rappresentanti pavesi si recarono alla dietadi Costanza per riconoscere il nuovo sovrano al quale offrirono doni e giurarono fedeltà, adducendo motivazioni pretestuose all’abbattimento del palazzo. Alla richiesta dell’imperatore di ricostruire un palazzo a Pavia, però, i pavesi si opposero. Corrado II dichiarò dunque Pavia città al bando dell’Impero. Nel 1026, quando il sovrano tedesco varcò le Alpi per ricevere la corona d’Italia dall’arcivescovo di Milano Ariberto, la capitale pavese subì un duro assedio da parte delle truppe milanesi fedeli alleate dell’imperatore. Fu determinante l’intercessione dell’abate Odilone di Cluny e del vescovo Rainaldo che convinsero Corrado a togliere l’assedio facendo leva sul tradizionale lealismo dell’episcopato pavese nei confronti del potere imperiale(92). La questione tra l’antica capitale pavese e l’Impero venne risolta nel 1026 con la stipulazione di un compromesso che soddisfece entrambe le parti: i pavesi ottennero che un palazzo
regio non sarebbe mai più stato edificato entro le mura cittadinema concessero l’allestimento di una nuova dimora regia extra moenia, presso il monastero di S. Salvatore (93).
Dopo gli accordi del 1026, a Pavia diversi poteri coesistevano in concorrenza fra loro. La superstite presenza regia si adattò a convivere con un indubbio potere di fatto del vescovo e con una certa libertà d’azione dei cittadini, raccolti in un organismo nonancora definibile con chiarezza (94). Al di là della crescente figura del potere vescovile all’interno del governo della cosa pubblica, è certo che la dismissione della burocrazia regia rese disponibile per altri incarichi un personale di cancelleria specializzato, detentore dello ius regale dell’autenticazione, cheprobabilmente fornì esperienza e competenza all’embrionale governocomunale (95). Dai pochi documenti dell’epoca emerge come nella capitale pavese continuò a esistere una non precisata domus regis nella quale si concedevano a pagamento beni fiscali, come mulini,o addirittura vescovadi. La tesoreria regia, forse ricostruita dopo il 1024, non venne mai meno. Del resto, le monete coniate nella zecca pavese continuarono a mantenere la loro bontà e la loro diffusione sino a buona parte del XII secolo e ciò poté
(91) A.A. SETTIA, Pavia nell’età precomunale, in Storia di Pavia, vol. III Dal libero Comune alla fine del Principato indipendente,Società Pavese di Storia Patria, Milano 1992, pp. 11-12. (92) B. DRAGONI, Il Comune di Pavia cit., pp. 46-47. (93) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 72-73. (94) A.A. SETTIA, Pavia nell’età precomunale cit., p. 13. (95) G. ARNALDI, Pavia e il “Regnum Italiae” cit., pp. 186– 187.
evidentemente avvenire poiché l’autorità imperiale continuò a esercitare un controllo diretto su un’attività di così grande importanza (96).
La città, dopo la dura ma breve contrapposizione del biennio 1025–1026, rimase sostanzialmente fedele alla parte imperiale durante l’intero XI secolo. Tuttavia i soggiorni dei re tedeschi si fecerosempre più rari e Corrado II e il suo successore Enrico III
dimorarono in Pavia solo occasionalmente. Oltre ad alcuni uffici, Pavia mantenne intatte anche certe prerogative di capitale altomedievale, prima tra tutte quella di ospitare concili regi. Nel corso dell’XI secolo, durante il lungo regno di Enrico IV, il centro pavese sembrò recuperare per breve tempo alcuni tratti del suo antico ruolo di capitale. A differenza dei predecessori, infatti, Enrico IV risiedette in città per cinque lunghi periodi. Malgrado quest’ultima felice parentesi, Pavia perse progressivamente qualsiasi effettiva prerogativa istituzionale di capitale altomedievale. Il suo antico prestigio sopravvisse nelle simboliche cerimonie di incoronazione come emblema della legittimareggenza italica dei sovrani germanici (97).
Un solido legame fra la corona e la città era comunque costituito dai numerosi e ricchi monasteri regi che mantennero uno stretto rapporto con l’istituzione imperiale sino a tutto il XII secolo. Persino nel 1026, cioè nella fase più acuta del conflitto che oppose allora Pavia a Corrado II, l’imperatore concesse diplomi a S. Martino Foris Portam e a S. Salvatore, segno di un rapporto chenon venne meno neppure nei momenti di scontro aperto. Anche altri monasteri ottennero benefici e donazioni imperiali come S. Giovanni Domnarum, S. Maria Teodote, S. Maria del Senatore, S. Felice o della Regina, S. Marino. S. Pietro in Ciel d’Oro, il più importante dei monasteri pavesi, dopo la distruzione del palazzo sembrò addirittura ereditarne alcune funzioni: presso il monastero, almeno dal terzo decennio del secolo, era attiva una schola, forse erede di quella palatina e, inoltre, è possibile che in un palazzo adiacente all’ente abbiano dimorato i re durantealcuni soggiorni pavesi (98).
L’autorità che ancora legittimamente governava la città era il conte palatino che risiedeva a Lomello e nessun’altra subentrò ufficialmente o usurpò le funzioni comitali, neppure quella vescovile. Innegabilmente la figura del vescovo pavese acquistò un’influenza politica grandissima, costituendo un punto di riferimento indispensabile per la cittadinanza e condizionandone la crescita istituzionale. Una testimonianza documentata del nuovo
prestigio acquisito dalla carica vescovile pavese è una sentenza emanata per S. Pietro in
(96) A.A. SETTIA, Pavia nell’età precomunale cit., p. 14. (97) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 75-76. (98) A.A. SETTIA, Pavia capitale del "Regnum" nel secolo XI, in BSPSP, Vol. XLII, Como 1990, pp. 19-20.
Verzolo nel 1084: al cospetto dei quattro corpi cittadini, il primo firmatario, per preminenza d’onore, fu appunto il vescovo cittadino (99).
L’intero XI secolo fu condizionato dalle figure di tre vescovi peri quali si possono intravedere ambizioni di dominio. Sin dalla fine del X secolo il vescovo si era circondato di clientele armatee assai precoce è l’attestazione di suoi rapporti con il populus Papiensis. Sotto il lungo episcopato di Guglielmo (1067–1102), la potenza vescovile raggiunse il livello più elevato, giovandosi dell’appoggio dell’imperatore nel quadrodel conflitto che lo contrapponeva alla Chiesa di Roma. Elemento significativo, indice del grado di simbiosi che era stato raggiunto al tempo di Enrico IV fra vescovo e cittadinanza, fu senz’altro l’edificazione della torre campanaria della cattedrale, la cui fondazione parrebbe riconducibile proprio al vescovato di Guglielmo. Inoltre, al vescovo pavese fu anche affidato il comando dell’esercito cittadino (100). Il rapporto del popolo pavese con l’autorità vescovile divenne più saldo anche per motivi strettamente funzionali. Venendo a mancare il tradizionale fulcro di riunione cittadina all’indomani della distruzione del palatium, i pavesi iniziarono a gravitare attorno al broglio di S. Siro, piazza prospiciente alla cattedrale. Prima utilizzata come semplice puntoin cui si erano concentrati i traffici e i negozi civili, la piazza finì per divenire il centro ordinario di convocazioni dell’assemblea cittadina che poteva decidere e deliberare anche con il consiglio e l’assistenza del vescovo in persona: si trattava però di una eventualità non necessaria ai fini della
gestione della res pubblica cittadina, poiché il vescovo ufficialmente non deteneva su di essa alcuna autorità (101).
Agli albori della fase comunale il governo della città si trovava dunque conteso tra il labile potere dei conti palatini di Lomello, usurpato a poco a poco ed esercitato in proprio da queglistessi funzionari minori già incaricati di gestirlo per conto del signore, e il vescovo cittadino che, intra moenia, godeva di un prestigio notevole, seppur non investito ufficialmente di alcuna carica. A questa già complicata organizzazione del potere cittadino si aggiunse l’azione del popolo pavese che andava strutturandosi in proprie forme istituzionali. I cittadini pavesi avevano mostrato sin dal X secolo, spiccate capacità di decisione autonoma e di iniziativa militare. Già gli eventi del 1024 avevanopalesato l’insofferenza della popolazione alla burocrazia regia e non sarebbero mancati in seguito altri esempi della fiera presa diposizione dei pavesi contro alcune direttive imperiali. Nel 1059 la città si oppose all’insediamento a Pavia di un vescovo tedesco nominato da Enrico IV
(99) B. DRAGONI, Il Comune di Pavia cit., pp. 36-37. (100) A.A. SETTIA, Pavia nell’età precomunale cit., pp. 16-17. (101) B. DRAGONI, Il Comune di Pavia cit., pp. 48-49.
perché avrebbe costituito una seria minaccia per gli interessi cittadini. I pavesi si rifiutarono categoricamente di accoglierlo,ricordando che il diritto esclusivo di elezione vescovile apparteneva congiuntamente al popolo e al clero locali sin dall’anno 1000 (102). Arrogandosi il diritto di praticare una sorta di politica estera autonoma i pavesi, dopo aver resistito per due anni a Corrado II, furono in grado anche di condurre a metà del secolo una guerra biennale contro Milano e, nel 1084, contro Piacenza, probabilmente a difesa dei diritti sull’Oltrepò. In tutti questi casi, accanto ai liberi cittadini in armi agirono verosimilmente anche i milites vescovili, ennesimo segnale del forte connubio che si era instaurato tra la cittadinanza e il vescovo (103). Fu proprio attraverso le guerre sostenute dalla
città che il popolo, nucleo centrale dei pedites della milizia cittadina, acquisì gradualmente coscienza di sé e della propria importanza politica. Si innescò dunque un processo che portò a determinare una nuova stratificazione dei ceti sociali in base al loro maggiore o minore grado di potenzialità economica e di importanza politica. Alla fine dell’XI secolo il popolo pavese si presentava distinto in cives maiores (mercanti, proprietari fondiari, nuovi possessori di ricchezze acquisite nei commerci) e i cives minores (artigiani, piccoli negotiatores, piccoli allodieri). A poco a poco questi due corpi finirono per livellarsie a assorbirsi reciprocamente in una nuova categoria di cives mediani, una sorta di patriziato comunale. Al rinnovamento internoal governo cittadino contribuirono anche esponenti della minore aristocrazia feudale che si erano avvicinati all’antica capitale del regno adattandosi a ricoprire uffici subalterni alla corte di palazzo. Le minori cariche civili, militari e amministrative, verosimilmente, sin dal X secolo, furono ricoperte dai nobili della città coadiuvati dai piccoli signori rurali. I feudatari minori furono anche funzionari vescovili, avvocati delle chiese e dei conventi, investiti di benefici ecclesiastici e nobili dello stesso ordine furono anche conti rurali e il visconte, che, già inquadrati nell’esercito regio, ebbero la responsabilità dell’amministrazione della città e del contado. La rivolta del 1024 spezzò violentemente la continuità delle antiche istituzioni feudali facendo venir meno le funzioni inerenti al ministero comitale. All’indomani della dismissione del palazzo regio, però, questi ex funzionari palatini fornirono il nerbo fondamentale all’organizzazione del nuovo governo cittadino che fu rapidamente in grado di sopperire a ogni necessità urbana e di opporsi al volere dell’imperatore Corrado II. Continuarono, infatti, a esercitarvi le loro mansioni i giudici e i notai, intervenendo neiplaciti imperiali e nelle sentenze rese sotto la presidenza dei messi regi o con l’assistenza del vescovo.
(102) ivi. p. 39. (103) A. A. SETTIA, Pavia capitale del "Regnum" cit., pp. 24-25.
Inoltre, non smise mai di adunarsi il concilium civitatis per deliberare sugli affari più urgenti, una sorta di progenitore del Parlamento o Consiglio minore, organo depositario della sovranità comunale. La prima reggenza cittadina del secolo XI, dunque, fu costituita dai piccoli feudatari che, stabilitisi in città come funzionari palatini, si unirono per comuni interessi alla media nobiltà cittadina. La morte di Enrico III di Germania, avvenuta nel 1056, lasciò il trono in mano al giovane Enrico IV, guidato dauna tutela debole. L’allentamento del controllo imperiale permise a molte città dell’Italia settentrionale di trovare facilmente la via per consolidare un proprio governo cittadino autonomo. Nella seconda metà dell’XI secolo anche la costituzione interna di Paviasi avviò molto rapidamente verso l’autonomia cittadina. Ben prestole classi cittadine minori iniziarono a partecipare in varia misura alla gestione politico-amministrativa della città (104).
Malgrado questo caotico ostacolarsi e sovrapporsi di poteri e competenze più o meno legittime all’interno del governo della città, Pavia mantenne inalterato il suo prestigio culturale, commerciale e monumentale che l’aveva caratterizzata nell’epoca precedente. Dal 1023 al 1033 la diocesi di Acqui fu retta da Durone, diacono della Chiesa pavese. Bernardino da Pavia, cardinale diacono dal 1060 al 1078, fu legato papale di Gregorio VII in Germania e Boemia in un delicato momento di lotta fra impero e papato. Raggiunse grande notorietà per le vicende in cui venne coinvolto anche il pavese Pietro Mezzabarba, vescovo di Firenze nel 1067. Altro illustre vescovo fu Guido, che occupò la cattedra di Pisa, città all’epoca protagonista nel Mediterraneo, eche venne ricordato da “Wido Papiensis” in epigrafi del duomo. Curiosa è la definizione riportata da Landolfo Seniore in un celebre proverbio contemporaneo: “Mediolanum in clericis, Papia indeliciis, Roma in aedificiis, Ravenna in ecclesiis”. Nelle suo opere, invece, il geografo arabo Edrisi, verso il 1150, definì Papia “città ragguardevole” e “Metropoli del paese di Lombardia”. Dal punto di vista urbanistico, la città si era rinnovata molto. Oltre al consolidamento di una nuova cinta muraria resa necessariadall’ampliamento dei confini cittadini per il notevole sviluppo
dei sobborghi, la città si stava dotando di imponenti torri private, simbolo del prestigio e della distinzione crescente delle nobili famiglie pavesi (105).
I radicali cambiamenti politici al proprio ordinamento interno, dunque, non avevano sostanzialmente mutato la situazione socio-culturale di Pavia: la città continuava a prosperare, forte di una moneta apprezzata in tutte le transazioni commerciali della Penisola, ammirata per le sue bellezze urbanistiche e per i suoi uomini di cultura. Tuttavia,
(104) B. DRAGONI, Il Comune di Pavia, pp. 52-70. (105) A.A. SETTIA, Pavia nell’età precomunale cit., pp. 22-24.
sin dal X secolo, per quel che riguarda la politica estera, l’antica capitale pavese aveva dovuto ben presto fare i conti con la prepotente ascesa di Milano che emerse rapidamente come soggetto politico, militare ed ecclesiastico vocato all’egemonia nella pianura padana. Nel passaggio tra IX e X secolo il capoluogo milanese era saldamente nelle mani degli arcivescovi che, grazie ai beni acquisiti in ambito ecclesiastico, si erano assicurati l’appoggio di un ceto di vassalli episcopali giungendo a esercitare un vero e proprio dominio temporale e militare sulla città. Una volta ottenuto il potere in città, gli arcivescovi milanesi avevano diretto le proprie mire sulle città viciniori. L’arma principale della politica estera dell’arcivescovado milanese consisteva nella sanzione della superiorità metropoliticadella sede ambrosiana sugli episcopati delle città padane, attraverso l'imposizione del diritto di intervento dell'arcivescovo nella nomina dei vescovi suffraganei. Grazie alladignità metropolitica acquista nel passato, infatti, Milano era superiore a tutte le altre sedi episcopali lombarde e questo permetteva agli arcivescovi di intervenire legittimamente nella nomina vescovile delle diocesi soggette: si trattava di un formidabile mezzo di interferenza nella vita politica delle città lombarde concorrenti. In tale quadro, Pavia godeva di una controffensiva sufficiente a scongiurare qualsiasi intervento
milanese nella nomina vescovile pavese: l'esenzione dalla metropoli ambrosiana e la sottomissione diretta alla sede romana. Questa particolare condizione garantiva all'antica capitale di evitare intromissioni dirette della vicina Milano sin dall'età longobarda e, da allora, tale provvedimento non venne mai mutato otanto meno abrogato. Pavia, per la sua completa indipendenza dal controllo dell’arcivescovo milanese e forte di una lunga tradizione di antica capitale dell’Italia settentrionale, finì benpresto per divenire la principale rivale di Milano. Il confronto tra le due principali città padane inizialmente si limitò solo a questioni ecclesiastiche, ma ben presto sfociò nello scontro armato. Il sempre più latente controllo imperiale sul regno d’Italia lasciò mano libera alle città che miravano ad estendere il proprio dominio sul contado circostante “et extra” (106). In poco tempo, a causa anche della crescente potenza di Milano, le città della Lombardia si divisero in due schieramenti principali: da un lato Milano, con Crema, Piacenza, Tortona e Brescia, e dall’altro tutti i comuni direttamente minacciati dalla politica espansionistica milanese, ossia, Pavia, Lodi, Cremona, Novara.
Gli scontri armati veri e propri tra Papia e Milano cominciaronoa divampare nella prima metà dell’XI secolo, in occasione delle discese degli imperatori in Italia. Le due città
(106) http://www.historia.unimi.it/sezione/fonti/corsodiritto1/a-d/costanza.htm, Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV, T.I, Hannoverae 1893.
sfruttarono questi episodi per schierarsi, a seconda delle condizioni del caso, dalla parte del sovrano tedesco contro la vicina rivale. Al confronto politico, economico, militare tra le due città se ne aggiunse uno ideologico. Pavia godeva da secoli diun prestigio superiore rispetto agli altri centri della pianura padana per la sua dignità di capitale del regno, sede delle incoronazioni italiche necessarie ai sovrani tedeschi per conseguire il titolo imperiale. Con la distruzione del palazzo regio nel 1024, Milano cercò di usurpare la prerogativa
dell’incoronazione regia. Il primo tentativo risalirebbe al 1026, quando l’arcivescovo ambrosiano incoronò Corrado II. L’apice delloscontro tra Pavia e Milano si concretizzò però durante la lotta dell’imperatore Federico I contro i ribelli Comuni lombardi (107).Da questa contesa tra Impero e comuni Pavia avrebbe tratto un importante impulso allo sviluppo della propria autonomia comunale.
Nel complesso, il Barbarossa risiedette nel capoluogo pavese per tredici anni in diversi periodi. Numerose, pertanto, furono anchele soste dell'intera corte imperiale nell'antica capitale altomedievale. La lunga residenza dell'imperatore e del suo entourage a Pavia fu caratterizzata da una serie di richiami espliciti al ruolo e alla memoria della città nel passato, connotando la seconda metà del XII secolo come un vero e proprio revival dei fasti della capitale del regno.
Federico rilasciò numerosi diplomi ai ricchi monasteri regi pavesi, utili alleati nel controllo del territorio e nella politica ecclesiastica dell'imperatore. Inoltre, venne ulteriormente sancita l'alleanza tra il comune pavese e l'autoritàimperiale nell’edificazione del duomo, che ospitava le spoglie delsanto patrono Siro. La cattedrale longobarda, che già aveva subìtouna nuova fase edificatoria in X secolo, venne interamente ricostruita in forme romaniche tra XI e XII secolo. Durante i suoifrequenti soggiorni pavesi lo Svevo, inoltre, dimorò in un palazzopresso il monastero di S. Salvatore. La particolarità evidente, rispetto all'antica sede occupata dai sovrani goti e longobardi, risiede nel fatto che il nuovo palatium era posto fuori dalla città e non intra moenia, rispettando dunque la precisa volontà espressa dai pavesi nel 1026. Questa nuova sede regia venne mantenuta anche dai successori di Federico: in particolare, vi dimorarono Enrico VI, Ottone IV e Federico II. Altro potente richiamo alla secolare tradizione regale della città pavese evocato dal Barbarossa fu la sinodo dei vescovi filoimperiali convocata nel 1159, l'ultimo capitolo dell’antica prerogativa regia di Pavia di ospitare concili (108).
(107) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 77-96.
(108) ivi. pp. 98-105.
Il conflitto militare tra Impero e Comuni, capeggiati da Milano, si prolungò per vent’anni, dal 1158 al 1178, risolvendosi definitivamente con la pace di Costanza del 1183 che sancì il riconoscimento delle autonomie locali (109). Durante la guerra di Federico I contro le città lombarde coalizzate, i Pavesi si schierarono sempre dalla parte imperiale. Nella antica capitale l’imperatore venne incoronato re il 17 aprile del 1155 durante unasolenne cerimonia tenutasi in S. Michele (110). Nel 1170, però, anche Pavia, come già avevano fatto altre città lombarde rivali diMilano, fu costretta dagli eventi a entrare nella Lega Lombarda, forse per timoroso rispetto dell’autorità della sede pontificia che aveva assunto apertamente la tutela dell’alleanza dei liberi Comuni. Non meno determinante furono anche le pressioni esercitatedalle confinanti città alleate di Milano. La tarda e non convinta adesione alla Lega Lombarda non impedì comunque a Pavia di coadiuvare il Barbarossa quattro anni dopo, nell’assedio di Alessandria (111).
L’alleanza con l’Impero e la dichiarata fedeltà finironoper giovare notevolmente alle aspirazioni di indipendenza comunale di Pavia. Fino ad allora il potere in città era ancora formalmente detenuto dai conti palatini di Lomello: per quanto esautorata ed estromessa, l’autorità comitale non era mai stata revocata e avevasempre vigilato a mezzo dei suoi minori rappresentanti. I consoli cittadini, dunque, menzionati in documenti ufficiali della città già nel 1105 e nel 1112, non potevano esercitare certe funzioni pubbliche appunto perché ancora legittimamente riservate al contepalatino. Si trattava di un ostacolo alla piena applicazione dei poteri comunali. Durante uno degli scontri armati che si susseguirono contro Milano tra il 1100 e il 1150, i pavesi approfittarono dello scarso interesse dell’Impero per la situazione in Italia per attaccare e distrugge una volta per tuttela rocca di Lomello. La dismissione della roccaforte palatina dovette avvenire nel biennio 1147-48 e il conte fu obbligato a prender dimora in città, dove mantenne per qualche tempo ancora il
titolo di signore territoriale e di conte di Palazzo, ma solo per esercitare funzioni minori all’interno del governo cittadino. La città riuscì formalmente a eliminare ogni residuo vincolo di dipendenza dal conte di palazzo ottenendo nel 1164 dal Barbarossa,come ricompensa alla fedeltà dimostrata all’Impero, un privilegio che sanciva in modo inequivocabile il nuovo assetto istituzionale (112). Il decreto imperiale dell’8 agosto 1164, infatti, eliminò completamente ogni autorità palatina dal governo cittadino e riconobbe alla cittadinanza il diritto alla libera elezione dei consoli con la sola clausola che costoro
(109) G. VITOLO, Medioevo cit., pp. 297-302. (110) P. VACCARI, Pavia nell’età comunale, in Storia di Pavia, vol. III cit., p. 28. (111) A. GROSSI, L'adesione di Pavia alla Lega lombarda, in BSPSP, vol. XCVIII, Como 1998, pp. 7-17. (112) B. DRAGONI, Il Comune di Pavia, pp. 73- 84.
giurassero e facessero giurare al popolo fedeltà all’Impero e ricevessero dall’Imperatore, o suo rappresentante in Italia, l’investitura e la conferma della carica. Nel caso il sovrano o nessun suo subalterno fossero presenti nella Penisola, i nuovi consoli avrebbero dovuto recarsi di persona in Germania per ottenere la conferma del loro ministero (113). I benefici concessidal Barbarossa vennero riconfermati in un privilegio del 7 dicembre 1191 emanato dal nuovo sovrano Enrico IV, che riconobbe ai pavesi anche il diritto di eleggere notai e di impedire che sorgessero nel distretto pavese, compreso a Lomello, castelli e munitiones. La città conseguì sicuro dominio su un vasto distrettoche, nel diploma del 1164, abbracciava non soltanto la Lomellina el’Oltrepo’ attuale, con le terre tra Pavia e Milano, ma anche una vasta zona del territorio Tortonese. Con la riconferma dei privilegi da parte di Enrico IV i consoli, definiti “consules de communi et iustitia”, ottennero anche tutte le funzioni giurisdizionali appartenute al conte palatino (114).
La seconda metà del XII secolo fu caratterizzata da un rinnovamento della vita cittadina che interessò aspetti economici e culturali. Pavia, proprio in questi anni, conobbe forti contrasti religiosi. La lotta antichiesastica che era già divampata in altre città durante il XII secolo, si manifestò anchea Pavia e perdurò fino agli inizi del XIII secolo. Questa fase coincise col primo avvento del Popolo nel governo cittadino. Da tempo i ceti artigiani si erano andati organizzando e di fronte alceto dominante rivendicavano una maggiore
(113) P. VACCARI, Pavia nell’età comunale cit., p. 29. (114) B. DRAGONI, Il Comune di Pavia, pp. 90-91.
partecipazione al governo cittadino. L’immunità tributaria di cui godevano i possessi ecclesiastici appariva in contraddizione stridente coi bisogni finanziari del Comune, costretto a guerre didifesa frequenti e impegnato a soddisfare i crescenti bisogni della cittadinanza.
La prima affermazione della parte popolare, quindi, si manifestò in Pavia con provvedimenti contro chierici e monasteri. Forse anche per cercare una tregua nella lotta antichiesastica che imperversava in città, durante il XII secolo a Pavia fu promosso un programma edilizio per la costruzione delle mirabili chiese romaniche. La città rinnovò i suoi templi maggiori con l’armonia delle forme romaniche: venne ricostruito S. Michele, adornandone la facciata di bassorilievi: poi fu la volta di S. Teodoro, S. Pietro in Ciel d’Oro, S. Lazzaro, S. Primo, S. Maria in Betlem, S.Giovanni in Borgo, S. Maria del Popolo, S. Stefano, tutte restaurate secondo i dettami della nuova corrente artistica (115).
Nel 1219 fu la volta di Federico II che confermò ancora una volta quanto l’avo aveva concesso all’antica capitale italica per la fedeltà dimostrata nel sostenere le ragioni dell’Impero sul campo di battaglia. Lo Stupor Mundi entrò per la prima volta in Pavia nel 1212 e il suo ingresso in città fu celebrato trionfalmente. Come era già accaduto con Federico I, la permanenza dello Svevo in città significò la ripresa di antiche tradizioni regie proprie
della capitale altomedievale. Il sovrano, come di consuetudine, rilasciò diplomi a enti ecclesiastici locali e soggiornò nel palazzo presso il monastero di S. Salvatore (116).
Attraverso le concessioni di Federico I, Enrico IV e Federico II, Pavia, nel corso del XII secolo ottenne la legittimazione ufficiale del nuovo potere comunale. Il governo della città inizialmente venne gestito da una serie di istituzioni. Fra esse, le più antiche furono il Parlamento e il Consiglio Minore o di Credenza che sin dai primordi si affiancarono ai
(115) P. VACCARI, Pavia nell’età comunale cit., pp. 31-33. (116) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 133-134.
consoli con funzione di organo di consulta generale e speciale. IlParlamento perse gradualmente importanza ed efficacia così da essere convocato solo per l’elezione annuale dei consoli, finché verso la fine del XII secolo, l’istituto fu abbandonato del tutto.Il Consiglio minore o di Credenza, invece, mantenne inalterata la propria funzione ancora per molto tempo: deteneva il potere politico e delegava i consoli, che, tra l’altro venivano scelti tra i propri membri. Funzione del Consiglio di Credenza fu quella di coadiuvare e sorvegliare l’attività dei consoli che non potevano liberamente decidere della cosa pubblica senza autorizzazione della consulta. Il consolato rappresenta l’istituzione più caratteristica del comune. All’inizio dovevano essere solo una sorta di rappresentanti designati dai corpi cittadini a trattare nel comune interesse gli affari generali, confunzioni amministrative e in parte giudiziarie. Le concessioni imperiali del 1164, del 1191 e del 1219 finirono per aumentare enormemente il potere dei consoli ai quali vennero affidate prerogative un tempo proprie dei conti palatini. Fin dal 1145 il consolato venne raddoppiato. L’elezione avveniva al cospetto di tutte le forse cittadine nel brolio di S. Siro. I consoli di giustizia, invece, non erano altro che una derivazione del consolato maggiore. In Pavia esistevano già dal 1145. La loro competenza si ampliò gradualmente fino a comprendere tutti gli
atti di giurisdizione civile (117). Alla guida del governo comunale, tuttavia, fu la magistratura podestarile quella che acquistò carattere di preminenza. Questo nuova istituzione nacque negli ultimi anni del XII secolo dal seno della stessa gerarchia consolare, con la quale condivise un periodo di convivenza prima di assumere in esclusiva il governo comunale con la sola assistenza del Consiglio di Credenza. E’ in questo periodo, inoltre, che il Comune poté provvedere a una nuova sede, più consona alla sua accresciuta potenza. Durante il XII secolo i consoli tenevano placito normalmente nel brolio di S. Siro presso la cattedrale, ma non ebbero mai sede permanente nel palazzo vescovile.
(117) B. DRAGONI, Il Comune di Pavia, pp. 91-107.
In un’ala attigua alla chiesa, vi era posta ancora nella metà del XII secolo la domus dei conti palatini che, quando il Comune acquistò con il primo diploma federiciano la piena autonomia, fu occupata dai consoli. Un accordo stipulato con il vescovo Rodobaldo nel 1236 consentì al Comune di acquistare gran parte della domus episcopi, che venne trasformata nella sede del governocittadino. Posto accanto alla cattedrale e alla torre civica, il palazzo podestarile di Pavia, che assunse il nome di Broletto, è forse il più antico fra i palazzi comunali di Lombardia (118).
Alla fine del XII secolo Pavia godeva ancora di una buona prosperità economica. Il prestigio delle famiglie nobiliari pavesi continuava a essere ostentato dalla costruzione di alte e slanciate torri private. L’inurbamento continuo comportò l’estensione dei confini della città con la costruzione di una nuova cinta muraria. Malgrado ciò, Pavia, dalla fine del XII secolo militarmente riuscì solo a difendere il proprio territorio,andando incontro a un progressivo indebolimento della propria efficacia bellica cui fece seguito, abbastanza rapidamente, la perdita della libertà con la dominazione di Milano. Nel 1315 le truppe milanesi guidate da Matteo Visconti riuscirono per la prima
volta a penetrare nelle mura dell’antica capitale pavese. Nel novembre del 1359, dopo tre anni d’assedio, la
(118) P. VACCARI, Pavia nell’età comunale cit., pp. 34-35.
popolazione abdicò definitivamente a favore di Galeazzo II Visconti, riconoscendolo nuovo signore di Pavia (119).
(119) P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., pp. 189-191.
Il Palatium
Il palazzo regio di Pavia può essere considerato il trait d'union di tutto l'altomedioevo pavese. Fondato nel V secolo per iniziativa del sovrano goto Teodorico, rimase uno dei centri di potere principali in Italia Settentrionale almeno fino ai primi anni dell'XI secolo. In questo lungo periodo Pavia ha rappresentato una delle capitali europee più prestigiose. Purtroppo del palazzo regio pavese non rimane alcuna traccia poiché venne completamente smantellato (1024) dalla popolazione insofferente del costante controllo imperiale sulla città e desiderosa di affermare le proprie aspirazioni di indipendenza comunale. L'esatta ubicazione del palatium, dunque, costituisce uno dei principali problemi nella ricostruzione della topografia altomedievale di Pavia. E' sorto un dibattito vivace tra chi sostiene che il palazzo pavese fosse ubicato nel quartiere sud orientale (120) della città e chi invece nel quartiere nord-orientale (121). In ogni caso tutti gli studiosi sembrano concordinell'individuare il sito del palatium a est di quella che doveva essere la città antica, all'interno del tessuto urbano a ridosso delle mura romane. A causa dei pochi dati a disposizione, ricavabili per ora esclusivamente da fonti scritte, risulta difficile un riconoscimento dell'area esatta. Inoltre, il palatiumdoveva essere composto da più edifici in zone diversificate, pertanto è probabile che occupasse un'area molto ampia che si
estendeva su entrambi i lati del decumano massimo di Ticinum, corrispondente all'attuale Corso Mazzini (122).
I limiti possono essere ricavati attraverso notizie indirette pervenute da fonti scritte. Hudson ricorda come nell'Historia Longobardorum il palazzo viene collocato presso la Porta Palacense, situata su via Scopoli, e la chiesa di S. Romano Maggiore, all'angolo tra Corso Mazzini e Via Defendente Sacchi. A sud del palatium vero e proprio si apriva il giardino del palazzo:le due chiese medievali di S. Nicolò e di S. Maria, infatti, eranodenominate "in Verzario" perché probabilmente sorte nelle immediate vicinanze del viridarium del palazzo (123). Dalle tavoletopografiche riportate da Hudson e da Maiocchi, nel tessuto urbanoodierno si potrebbero tracciare i limiti di quella che, a grandi linee, doveva
(120) D. BULLOUGH, Urban Change in Early Medieval Italy: the Example of Pavia, in "Papers of the British School at Rome", n. 34, Roma 1966, p. 92. (121) P. HUDSON, Archeologia urbana e programmazione della ricerca: l'esempio di Pavia, Firenze 1981, p. 24. (122) P. HUDSON, Pavia: evoluzione urbanistica di una capitale altomedievale, in Storia di Pavia, vol. II - l'Alto Medioevo, Società Pavese di Storia Patria, Milano, 1987, p. 242. (123) P. HUDSON, Archeologia urbana cit., p. 24.
essere l'area del complesso palatium-viridarium. Si delineerebbe un quadrilatero delimitato a ovest da Via Porta Luigi - Via Foro Magno, a nord da Via Foro Magno - Via Spallanzani e a est da Via Porta Palacense. A sud, l'area del palazzo terminava probabilmenteall'altezza della Torre Belcredi (124).
(124) P. HUDSON, Archeologia urbana cit., Tavv. 2-3; P. HUDSON, Pavia: evoluzione urbanistica cit., pp. 308-311; P. MAJOCCHI, Pavia città regia cit., Tav. 13-14.
Se l'identificazione dell'ubicazione del palazzo è molto dubbia, ancor più lacunosa è la ricostruzione delle fasi architettoniche
che la sede regia subì nel corso dei secoli. Per quando riguarda l'epoca gota, secondo l'Anonimo Valesiano il palatium fu fondato da Teodorico all'inizio del VI secolo. La medesima notizia viene riportata anche in epoca longobarda da Fredegario e da Paolo Diacono. Da Agnello di Ravenna, invece, fonte di IX secolo, si apprende che nel palazzo pavese esisteva un mosaico rappresentanteil sovrano goto Teodorico (125).
Sopravvivono pochi indizi per ricostruire la forma del palazzo in epoca longobarda. In quel periodo è lecito pensare che la zecca ticinense fosse ubicata all'interno del perimetro palaziale. Una delle poche notizie certe di interventi edilizi all'area del palatium risale a re Pertarito che, in VII secolo, promosse la costruzione della Porta Palacense, nuovo ingresso monumentale allacittà realizzato inglobando un arco augurale romano (126). L'anfiteatro romano, restaurato in epoca gota, non viene più citato dopo il 529 e, verosimilmente, venne smantellato e la sua area fu annessa al viridarium del palazzo. Durante la dominazione longobarda, tra l'altro, pare che il complesso del palatium fosse dotato anche di terme
(125) MAJOCCHI, Pavia città regia cit., p. 27. (126) B. WARD-PERKINS, Urban public building in northern and central Italy ad 300-850, in ID., From classical to antiquity in Middle Ages, Oxford University Press, New York 1984, pp. 168-169.
private a uso esclusivo della famiglia reale. Nel medesimo periodofurono aggiunte le carceri. Si sa infine che re Liutprando fondò nel palazzo regio una cappella dedicata a S. Salvatore (127).
In età carolingia e postcarolingia il palatium era articolato in un complesso di edifici atti a ospitare la residenza degli imperatori e del seguito in città. Inoltre, avevano sede nel palazzo la cancelleria, gli uffici amministrativi del regno, la zecca e il tribunale regio. Vi erano poi una o più cappelle, un carcere, un emporio commerciale, ampi cortili dove si tenevano i placiti, e un viridarium popolato di animali esotici. Il fulcro
del palazzo era la sala del trono dove l'imperatore amministrava la giustizia (128).
I placiti tenuti nel palatium sono quasi unicamente l'unica fonte a disposizione per conoscere l'articolazione e le fasi costruttivedei vari ambienti. Nel 924 il palazzo regio subì seri danni durante un incendio appiccato nel corso di un assedio portato dagli Ungari. Dal placito del 927 si apprende che non si svolse nei consueti ambienti, forse perché inagibili o in fase di ristrutturazione. Altri documenti ufficiali del 935 e del 945 invece nominano il palazzo regio come "noviter aedificatum", indizio utile a ritenere che la sede regia venne effettivamente riparata e ripristinata (129).
I lavori vennero eseguiti probabilmente durante la reggenza di Ugo e Lotario II. Si trattò di una ricostruzione quasi radicale visto che molti ambienti citati prima del 924 non compaiono più nei documenti degli anni successivi. Ad esempio, non vengono più nominati gli spazi esterni del viridarium, forse alienati a favoredi un ente ecclesiastico. L'area complessiva del palatium si era progressivamente contratta nel corso del X secolo. E' noto, per esempio, che nel 947 Lotario II donò terre, precedentemente appartenenti al palazzo, site nel luogo chiamato "carcer ", alla chiesa vescovile di Reggio Emilia (130).
Dopo una prima rivolta nel 1004, il popolo pavese, approfittando della morte dell'imperatore, assaltò e distrusse il palatium nel 1024.
(127) P. HUDSON, Pavia: evoluzione urbanistica cit., pp. 255 - 256. (128) C. BRUHL, Das Palatium von Pavia und die "Honorantie civitatis Papiae", in Pavia capitale di regno, Atti del IV Congresso Internazionale di Studi Sull’Alto Medioevo (Pavia– Scaldasole -Monza–Bobbio, 10–14 settembre 1967), CISAM, Spoleto 1969, pp. 189 -206. (129) P. HUDSON, Pavia: evoluzione urbanistica cit., pp. 260-261. (130) Ivi, pp. 262-263.
Felix Ticinus - Evidenze archeologiche del periodo goto
L’arrivo degli Ostrogoti in Italia segnò per Pavia l’inizio del suo ruolo di capitale altomedievale. Il regno goto, durato meno diun secolo (489 –553 d.C.), però, non ha lasciato copiose ed eclatanti testimonianze di sé, esclusi i reperti rinvenuti nelle capitali del regno (Ravenna, Verona e Pavia) e in qualche strategica roccaforte, soprattutto in Romagna e nelle provincie adriatiche (131).
Dei capoluoghi regi, Pavia è, tra l’altro, quella che ha restituito meno tracce del passato ostrogoto. Soprattutto dal punto di vista monumentale, della Ticinum gota non resta praticamente nulla. È possibile ricostruire idealmente quella che doveva essere l’urbanistica della città tra V e VI attraverso scarni ritrovamenti e dalle indicazioni fornite da cronache, come quella dell’Anonimo Valesiano. Una volta sconfitti gli Eruli di Odoacre, gli Ostrogoti promossero una politica edilizia di rinnovamento e abbellimento delle principali capitali, tra cui appunto Ticinum (132). L’intervento goto più significativo e duraturo per il destino urbanistico e storico di Pavia fu la costruzione del palazzo regio. L’edificio venne edificato sotto reTeodorico e utilizzato ininterrottamente dal V secolo d.C. al 1024dai vari sovrani che nei secoli avrebbero regnato in Pavia sino alla svolta comunale della città. La sua ubicazione rappresenta tuttora uno dei principali problemi della topografia altomedievaledi Pavia e le soluzioni proposte non vanno oltre ipotesi incerte (133).
Gli interventi edilizi teodoriciani interessarono anche strutture d’epoca romana, ancora in uso e fondamentali per la vita della città. Prima di tutto furono restaurate e, probabilmente, rinforzate le mura romane di Ticinum, ormai centro nevralgico della Pianura Padana. Erroneamente Fagnani (134) aveva pensato chegli interventi goti riguardassero un’estensione dalle mura fino alfiume, mentre si trattò piuttosto di un restauro della cinta muraria antica con solo un eventuale inglobamento parziale della zona extraurbana sud-orientale (135). Il materiale impiegato per i
lavori probabilmente fu ricavato dallo spoglio di edifici romani ormai in disuso. Le mura gote, inoltre, dovevano presumibilmente ricalcare il modello
(131) V. BIERBRAUER, Archeologia degli Ostrogoti in Italia, in I Goti cit., pp. 174 -175. (132) B. WARD-PERKINS, Urban public building cit., p. 30. (133) D. BULLOUGH, Urban Change cit., p. 92; P. HUDSON, Archeologia urbana cit., p. 24. (134) F. FAGNANI, Il tracciato delle mura romane di Ticinum, in BSPSP, vol. XI, Pavia 1959, p. 34. (135) P. HUDSON, Pavia: evoluzione urbanistica cit., p. 242.
romano tardo imperiale ed essere perciò dotate di torri in vari punti e di un fossato lungo il perimetro esterno. Una di queste torri sopravvisse, inglobata nel monastero di S. Maria Teodote (136). Negli anni ’50 del secolo scorso, invece, durante lo scavo per una cantina in Corso Garibaldi al civico n. 27, venne rinvenuta una struttura muraria tuttora conservata in situ. Datato a un periodo compreso tra V e VI secolo d.C., questo lacerto, secondo alcuni, costituirebbe un avanzo della prima cortina muraria della città (137) (N.5 nella carta archeologica).
Altri interventi di restauro promossi da Teodorico furono rivolti in particolare alle terme e all’anfiteatro di Ticinum. Del restauro dell’edificio ludico ci resta un’importante testimonianzaepigrafica di re Atalarico, segno che i lavori furono proseguiti anche dai successori di Teodorico.
Fig. 10 Stele di Atalarico, Musei Civici di Pavia.
L’epigrafe celebra i lavori all’anfiteatro sostenuti tra il 528 e il 529 ed è realizzata riutilizzando la lastra di un sarcofago romano databile al terzo venticinquennio del II sec. d.C. (138), come risulta evidente dallo stile e dalle decorazioni accessorie: tra i motivi ancora leggibili, infatti, vi sono due eroti che sorreggono la tabula ansata e una cornice modanata, da riferire senza dubbio a un momento più antico della dominazione gota. Restaimpossibile riconoscere la sua ubicazione originaria. Notizie
frammentarie, però, sostengono che l’epigrafe fosse posta sulla facciata della chiesa di S. Secondiano fino al 1564 e, successivamente, portata a S. Maria in Verzaro fino a metà ‘700. Dopo essere stata parte della collezione del marchese Beccaria, passò in eredità al marchese Malaspina e, nel 1896, fu donata dall’Amministrazione Provinciale al Museo Civico (139). L’anfiteatro doveva
(136) D. BULLOUGH, Urban Change cit., pp. 89-90. (137) H. BLAKE, Archeologia Urbana a Pavia - parte prima, Pavia 1995, p. 20. (138) C. SALETTI, La civiltà artistica, in Storia di Pavia, vol. I cit., p. 324. (139) G. PANAZZA, Lapidi e sculture paleocristiane pre-romaniche di Pavia, in Arte del Primo Millennio, Atti el II° Convegno per loStudio dell’Arte dell’Alto Medio Evo tenuto presso l’Università diPavia nel settembre 1950, Torino 1953, p. 234.