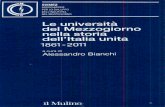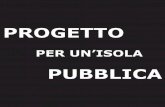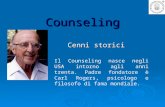Lo specchio di un progetto politico: l'antichità nella Repubblica giacobina romana (new link)
Transcript of Lo specchio di un progetto politico: l'antichità nella Repubblica giacobina romana (new link)
Lo specchio di un progetto politico: l’antichità nella Repubblica giacobina romana
di Maria Pia Donato
Negli ultimi anni la storiografia si è rivolta con interesse, dopo il lavoro pionieristico di H.
T. Parker1, ad un particolare aspetto della cultura politica francese della Rivoluzione: ilculto dell'antichità.
Il tema non è nuovo per la storiografia filosofica, che da tempo ha individuatonell'immagine dell'antichità durante il XVIII secolo un «luogo di rinnovamento delle idee
e dei valori»2, sebbene sia ormai assodato che l'interesse degli illuministi per le anticherepubbliche non equivalse all'elaborazione di una teoria della democrazia, con l'eccezione
almeno parziale dell'opera di J.-J. Rousseau3. In sede storiografica, il superamento di unatradizione critica che, da Volney fino a Marx, ha visto nell'anticomania rivoluzionaria divolta in volta un errore di prospettiva o un orpello ha richiesto più tempo, fino a che storicidella Rivoluzione come J. Godechot, storici del diritto come J. Bouineau, e antichisti comeP. Vidal-Naquet e C. Mossé non hanno precisato il contorno di un mito che divennevettore di senso nella creazione dell'«uomo nuovo» rivoluzionario, almeno nella sua
componente borghese4.
Meno fortunati sono stati i repubblicani romani, sui quali pesa ancora un giudizio diinadeguatezza politica e culturale, di cui la retorica dell'antico sarebbe al tempo stesso
segno e maschera5: destino quasi paradossale in una Roma che era stata la capitale
europea del Settecento antiquario e neoclassico, lo «specchio vivente del mondo»6.
La letteratura critica sulla cultura del Settecento romano, pur nel giudizio generalmentenegativo, concorda sulla rinascita delle arti e dell'estetica, sulla vivacità del dibattitointorno all'arte e alla storia antiche, di cui l'opera di Winckelmann fu insieme sintesi e
nuovo inizio7. La munifica iniziativa di Pio VI Braschi (1775-1799) accelerò la diffusionedel gusto neoclassico con i grandi cantieri della città, le campagne di scavi, lasistemazione del museo Pio-Clementino, strumenti attraverso i quali il ponteficeperseguiva il fine quasi rinascimentale dell'affermazione dell'autorità della curia romana in
un secolo tormentato e il proprio prestigio personale di aristocratico provinciale8. Lenumerose accademie romane, prima fra tutte l'Arcadia, furono i centri in cui si articolò un
linguaggio dell'antico moderatamente razionalistico e innovatore9, socializzato nei salotti,
nelle conversazioni, nei caffè dove il movimentato ambiente neoclassico internazionaleincontrava i letterati romani. I periodici eruditi come le Effemeridi letterarie di Roma, il
Giornale delle Belle Arti, i Monumenti antichi inediti10, informando i lettori sullepubblicazioni d'antiquaria e sui ritrovamenti archeologici, diffondevano l'immagine diun'antichità del buon governo e della coesione sociale, che si riverberava nelle opere degli«illuministi» romani F. M. Cacherano di Bricherasio, F. Milizia, F. M. Renazzi, N.
Corona11.
A parziale correzione del giudizio storiografico corrente, le coincidenze di personaggi e ditemi tra il vivace mondo neoclassico della Roma di Pio VI e la Roma giacobinapermettono di ipotizzare che anche nella capitale della cristianità, nel corso del XVIIIsecolo, il mito dell'antichità, coltivato in ambienti piuttosto vasti di artisti, filologi, critici,ma anche di uomini di legge, economisti dilettanti, aristocratici inquieti, abbia agito comecatalizzatore delle esigenze di rinnovamento che andavano lentamente maturando, per poifiorire nella breve stagione della Repubblica.
Del resto, che il culto dell'antichità potesse essere un vocabolario politico era già statodimostrato nel 1794: mentre la Francia repubblicana iniziava la sua espansione versol'Europa, un manipolo di artisti ed artigiani nel cuore della Roma neoclassica ordì una
congiura per «tornare in libertà come gli antichi romani»12. Quattro anni più tardi, il 15febbraio 1798, sotto la protezione delle armi francesi, un gruppo di romani si radunò nelForo Romano per ascoltare il discorso di Nicola Corona e quindi si diresse in corteotrionfale verso il Campidoglio per proclamare l'Atto del Popolo Sovrano: Res Publica
rediviva13.
Indubbiamente, il permanere di un'idea repubblicana legata, con alterne fortune, allamemoria dell'antichità o alla storia comunale non è un fatto nuovo né a Roma né in Italia,
e in proposito sono state scritte pagine illuminanti14. Si tratta ora di considerare l'antico intermini di cultura politica, di «attrezzatura mentale», i suoi usi e le sue funzioni nelconcreto dispiegarsi della dialettica politica della Roma giacobina; contemporaneamente,sulla scorta della storiografia francese, si vuole utilizzare il «prisma ottico» dell'antichitàper mettere a fuoco le contrapposizioni tra «radicali» e «moderati» a Roma, dove piùdifficile, a causa della peculiare natura dello Stato della Chiesa, appare l'interpretazione supunti come il rapporto tra riformismo e rivoluzione, tra religione e laicizzazione, tra
borghesia e «popolo»15.
1. Un'assemblea di Greci e di Romani
L'ambito da cui è opportuno intraprendere lo studio dell'uso politico dell'antico è l'attività
degli organi legislativi della Repubblica, Tribunato e Senato16. Un filo ininterrotto legainfatti il discorso dei Lumi sul Legislatore e le assemblee rivoluzionarie grazie all'esempio
dell'antichità17.
Molti dei deputati romani, nella maggior parte borghesi delle libere professioni18,condividevano un'analoga memoria dell'antico, frutto dell'educazione classica ricevuta neicollegi scolopici e gesuiti. La familiarità di studio e di pratica forense con il dirittoromano, considerato ancora il massimo esempio di coerenza legislativa, contribuìpotentemente alla definizione di un vero culto dell'«antichità-legge», che si ricongiunge
con il pensiero giuridico illuminista19. Di conseguenza, l'antichità viene citata in primoluogo nel quadro di riflessioni sulla legge in quanto categoria metagiuridica mettendo in
luce quella che J. Bouineau ha definito la primarietà del diritto20.
Il «progetto di risoluzione per l'istituzione di un burò delle ipoteche», presentato daitribuni Bassi, Gambini, Riccardini e Martelli nella seduta del 19 fiorile a. VI offre unsaggio dell'immagine della civiltà classica, con la sua periodizzazione e le suecontraddizioni, su cui si proiettò la tensione riformatrice dei Rappresentanti del Popoloromano: «Nei primi tempi di Roma, allorché i patrizi dominavano spietatamente la plebe,e che la libertà non era che un'ombra vana ed un nome, essi avevano coperto d'un velomisterioso il libro delle leggi accessibile ad essi soli, che ne conoscevano esclusivamentele formole, e l'applicazione. Gl'imperatori resero la giurisprudenza venale, giornaliera, evariabile alla volontà d'un favorito, o d'una prostituta». Contro il dispotismo imperiale epontificio («ubi solitudinem faciunt, pacem appellant») l'opera legislativa dellaRepubblica aspirava a porsi in ideale continuazione dell'età aurea della storia romana:«[...] La concordia, che vuole tutti istruiti da (sic) loro diritti e doveri, perché ciascuno sicontenga dentro i limiti stabiliti dal patto sociale; la Repubblica, dissi, esigge che le leggisiano pubbliche, chiare, intellegibili a ciascuno, e che siano tenute come in Atene ed in
Roma in tavole di bronzo sul foro, e nella mente e nel cuore di tutti i cittadini»21.
La legge come abitudine e pratica di vita, appresa sulle pagine di Cicerone, di Plutarco, diTacito, di Valerio Massimo, e la legge come garanzia di libertà ritorna continuamente nellediscussioni di tribuni e senatori. L'atteggiamento verso l'antichità appare globalmente
caratterizzato dallo sforzo di penetrare lo «spirito delle leggi» delle civiltà classiche22, alfine di riutilizzare quell'esperienza storica nel consolidamento del regime repubblicano diRoma moderna, secondo un modello epistemologico che risente dell'influsso diMontesquieu, ma che si riscontra in molta della riflessione politologica dell'Illuminismo,da Rousseau a Gibbon, da Mably a Volney, costantemente rivolta alle repubbliche antiche
come ad una sorta di «laboratorio storico»23.
Già all'interno del campo semantico dell'antichità-legge emergono però le primesignificative differenziazioni tra i legislatori romani.
L'iter del decreto di amnistia dei condannati per opinioni politiche e per delitti minoriillustra bene la contrapposizione tra un uso più tradizionalmente tecnico-giuridico deldiritto romano ed un dialogo con la classicità per una riformulazione dei principi
fondamentali della legislazione24. L'articolo I del progetto di risoluzione («Tutti i reicondannati, detenuti, o contumaci nel passato Governo per opinioni politiche, e per delitticarnali senza qualità gravante, o di stupro immaturo, o di violenza siano gratis assoluti,
dimessi e liberati»25), ipotizzando l'amnistia di pene comminate da tribunali ecclesiastici omisti, poneva inevitabilmente il problema della laicizzazione etica; un tribuno chieseinfatti di abolire la dizione «delitti», sostenendo che «la congiunzione di due sessi non puòchiamarsi giammai delitto, non essendo vietato dal gius di natura, e che tale era solo
tenuto dal passato Governo, in cui era in tanto pregio il celibato»26. La proposta nonpassò, e in questo caso l'antichità assunse le sembianze di una auctoritas del diritto,Modestino: «In libere mulieris consuetudine nuptiae non concubitus intelligendae sunt,
dummodo corpore quaestum non fecerit»27.
Tuttavia, anche l'approccio interpretativo verso l'antichità richiedeva un adeguamento alle«odierne filosofiche cognizioni»: e al tribuno che protestò l'inopportunità dell'amnistiasulla base dell'irrevocabilità di ogni legge «come costumavano gli antichi Magistrati dellaRepubblica romana, che nessuna grazia mai concessero», venne risposto bruscamente«che se duemila anni fa non si accordava alcun perdono agli infelici si potrà accordare ad
essi il medesimo»28.
Virtù antica e lumi moderni... Un meccanismo analogo entrò spesso in funzione nelladiscussione di quei progetti legislativi che espressero il cauto riformismo razionalisticodella maggioranza, come l'istituzione di un registro ipotecario, l'amnistia, il riordinamento
della professione notarile29, la riforma della scuola. A questi provvedimenti si aggiunserole istanze maturate nell'esperienza rivoluzionaria francese: la responsabilità degli
amministratori30, la questione degli emigrati31, l'organizzazione della Guardia nazionalesedentaria.
Su quest'ultima questione, di cui anche l'opinione pubblica patriottica si era sollecitamente
occupata32, il tribunato si divise in due schieramenti. E sin dal primo dibattito si può
osservare come per alcuni tribuni il principio greco-romano di partecipazione alla difesadella patria quale esercizio dei diritti politici del cittadino si intrecci con una concezionedell'esercito quale esperienza egualitaria e forza propulsiva della Rivoluzione; per questi«radicali», antichità e Rivoluzione offrono l'una l'orizzonte teorico, l'altra il riferimento
politico33.
E che? se i Romani dal distrutto dispotismo sono stati fin qui tenuti nell'inerzia enell'avvilimento, per infame politica, vi dovranno restare per sempre? [...] E l'Europa el'Universo dovrà sentire che i romani, figli di quei valorosi eroi, che formavano l'ammirazione ditutte le età e di tutte le nazioni, ricusano per mollezza di prestarsi al sagro dovere di vegliare duoo tre giorni al mese alla difesa della Patria e della pubblica sicurezza? Così diverremmo ildisprezzo delle nazioni, e la repubblica avrà breve esistenza. Noi abbiamo bisogno di rivendicare
l'onore del nome romano avvilito abbastanza dal costume fin qui tenuto34
ammoniva un tribuno, forse il promotore del progetto di legge Luigi Lamberti (e non
sarebbe estranea la sua profondissima cultura classica a tale veemenza)35. A chi propose laselettività dell'arruolamento venne replicato che: «L'istituto della Guardia nazionalesedentaria [...] non è solamente diretto a provvedere alla pubblica sicurezza, ma anche adavvicinare e a fraternizzare i cittadini che, finora divisi in ceti, si credevano quasi di specie
diversa, ad istruirsi vicendevolmente e diffondere lo spirito della democrazia»36.
I punti contestati nella prima seduta, cioè l'obbligo universale, l'età di coscrizione,l'arruolamento dei religiosi, si riproposero durante la tormentata elaborazione della legge
nei mesi successivi37. Il servizio personale degli ecclesiastici, per esempio, fu sancito in
Tribunato dopo accese dispute in virtù dell'aconfessionalità della Costituzione38; masubito dopo, in Senato, l'opposizione fu trascinata da un discorso di F. M. Renazzi,pronunciato nella seduta del 6 germile a. VI, che offre un saggio eloquente di un uso
insieme retorico, giuridico ed ideologico del riferimento all'antichità39, e che portòall'affossamento del progetto di risoluzione.
2. Leges Agrariae
In materia sociale ed economica, l'immagine rurale delle antiche repubbliche, di Roma in
particolare40, ebbe grande potere evocativo sui deputati giacobini.
Il giudizio storiografico negativo sulle assemblee della Repubblica romana si basaprincipalmente sulla constatazione dell'inefficacia dei provvedimenti economici e sociali
ivi discussi, e il frugalismo anticheggiante è stato spesso liquidato come residualitàideologica di un ceto di professionisti incapaci di promuovere una modernizzazione
decisamente borghese41. Pur prescindendo da una discussione generale sull'evoluzionesocio-economica dello Stato pontificio, sulla quale la storiografia più recente è ormai datempo alla ricerca di soluzioni meno schematiche, e, per quanto riguarda il dibattitoteorico, più attente alle specificità di una tradizione autoctona ancora viva nel
Settecento42, le contraddizioni ideologiche e politiche che frenavano la possibilità diazione di tribuni e senatori possono essere meglio comprese analizzando singole concretequestioni.
L'abolizione dei fedecommessi, per esempio, venne proposta nella seduta del 5 germile a.VI da Francesco Pierelli perché «contrari alla libertà e al diritto di proprietà» ed ai principidemocratici, accrescendo «l'ineguaglianza inevitabile di fortuna riconcentrando in pochemani le ricchezze, con evidente pregiudizio dell'agricoltura e forse con pericolo della
Repubblica»43: una figura tipica della retorica di libertà della modernizzazione borghese,che tuttavia non sa rinunciare ad una preoccupazione ridistributiva. Quando però GouvionSaint-Cyr, con il decreto del 30 marzo, abolì indistintamente tutti i contratti di enfiteusi
stipulati dal governo pontificio44, il Tribunato si trovò a fare fronte alle richieste deglienfiteuti di correggere un provvedimento che, pur in linea con l'abolizione dei vincolifeudali per il passaggio alla forma proprietaria moderna, mirava nel caso specifico adaccrescere la quantità dei beni nazionali disponibili alla vendita a beneficio delle cassefrancesi. L'opzione prevalente nel lungo dibattito che ne seguì sostenne una concezioneconfusamente fisiocratica dell'agricoltura, e il miraggio di una società rurale di piccolicoltivatori proprietari dai contorni virgiliani. Nell'impossibilità, concreta o ideologica, direalizzare la divisione del latifondo, i tribuni speravano di affidare le sorti dell'agricolturae la felicità della Nazione ad enfiteuti garantiti dall'esosità e temporaneità dei contratti di
affitto45. Il poeta non mancò di essere citato «Laudato ingentia rura/ exiguum colito».
(Georg., III, 412-13)46.
Ad un siffatto progetto sociale fungeva da corollario il frequente richiamo alla frugalitàvirtuosa delle antiche repubbliche. Secondo A. Brizi, in quei tempi lontani: «[...] ilcommercio e l'agricoltura arricchivano l'erario comune, e le altre sociali virtùimpoverivano il privato. Ma da che le regie moli lasciarono poco spazio all'aratro, e leasiatiche mollezze snervarono il vostro coraggio, e fomentando l'egoismo intiepidironol'amor della Patria coll'accrescere i bisogni della vita, si moltiplicò il numero dei vostri
mali»47. E nella seduta del 10 germile a. VI Nicola Corona chiese l'istituzione di leggisuntuarie argomentando che: «Fondamento primo di questa [la Repubblica] essere devonole virtù morali, che il lusso tende continuamente a distruggere. Il caduto dispotismo, che
mancava di quelle, coltivava questo, ed impiegava così le particolari ricchezze adimpoverire la nazione ed a corrompere i costumi.[...] Finché furono dal lusso lontane,furono grandi ed indomabili le Repubbliche Greca e Romana. Le ricchezze ed il lusso
dell'Asia rovinarono ambedue»48. L'immagine della Roma antica rurale e felice nonmancò di illustrare anche la proposta «sulla maniera di corregere l'infezione delle
campagne per via della piantagione», presentata da Feliciano Scarpellini49.
Al di là di analogie ed assonanze, però, la materia economica introdusse distinzioniprofonde tra i Rappresentanti del Popolo romano, sulle quali occorre ora soffermarsi. Perun consistente numero di eletti, infatti, l'antico sembra essere soprattutto un modellorassicurante. Regno della virtù e della moderazione, esso viene invocato in ognidiscussione che generi frizione, sia essa tra due opzioni politiche o sociali, tra repubblica ereligione, o tra modelli comportamentali. Non è forse casuale che i due tribuni che conmaggior evidenza usarono questo riferimento rassicurante sono due religiosi, Marco
Faustino Gagliuffi50 e Damaso Moroni51.
Di Gagliuffi risuonò presto l'appello alla prudenza: «il nome tribunizio in noi rinnovatodopo tanti secoli possa emulare l'antico nella gloria per la difesa della libertà, e dellasovranità del popolo, e lo possa sperare [sic] nella saviezza, nella moderazione, enell'esercizio di tutte le virtù repubblicane», senza gli eccessi degli antichi tribuni che«affettando un'impetuosa fermezza contro la potestà esecutiva de' consoli posero a
pericolo la patria»52. Il tema della moderazione e della virtù trova ampio riscontro nei suoi
numerosi interventi giornalistici53. Il perugino Moroni, dal canto suo, invocò spessol'esempio dei repubblicani antichi, proponendo pene severe contro i malversatori odeplorando la furia iconoclasta contro i simboli religiosi: «[La democrazia] nonnell'esterno delle case, ma nel cuore de' Cittadini deve essere radicata. Così i Romani nontemettero di conservare il nome di re perché ben capirono quanto poco ciò influisse nella
condotta de' cittadini»54.
Moroni è un esempio interessante di illuminismo cattolico, coltivato nelle accademielocali e messo di fronte alle contraddizioni del nuovo regime. Ma un'immagine idealizzatadelle società antiche, in definitiva ristretta allo stereotipo di virtù tramandato dallatradizione cattolica, si può ricostruire anche dall'intervento di vari altri deputati, con unasignificativa coincidenza tra ortodossia e tirocinio arcadico. Si consideri per esempio A.Brizi (ed alcune sue idee sono simili a quelle del suo amico ed ex-compastore G. B.
Agretti55), o ancora F. M. Renazzi. In Senato, Savi, Frasca, Colli, Aleandri56 evocaronosempre un'antichità senza conflitti, che diventa normativa solo quando induce allaprudenza. La semplicità di una vita rustica dedita al lavoro dei campi costituisce un
elemento integrante di questo quadro moraleggiante dell'antichità, senza che questocomporti un ripensamento dei rapporti sociali e politici della Roma contemporanea. I topoidei moralisti, soprattutto Fénélon,si combinano allora solo con il vagheggiamento
pastorale57.
Nonostante questa tendenza dominante, la società antica composta di liberi proprietari chenon disdegnano il lavoro nei campi, lo stile di vita contadina «dei Cincinnati e deiScipioni», potè rappresentare anche una fonte di ispirazione per il consolidamento dellenuove e fragili istituzioni repubblicane in una prospettiva più decisamente politica. NicolaCorona, Francesco Pierelli, ed in misura minore P. Piranesi, T. Benedetti, T. Bouchardsono gli esponenti di una cultura politica che, pur con tutte le cautele storico-critichenecessarie, si può definire radicale, e che si serve dell'esempio delle repubbliche antichecombinandolo con l'esperienza rivoluzionaria francese. Per questi patrioti, la richiesta diuna legislazione agraria non implica la volontà di sovvertire l'ordine sociale, né è
l'espressione di un compiuto programma di trasformazione socio-economica58. Alcontrario, il problema della terra è un problema tutto politico: l'esercizio della libertà edella sovranità presuppongono l'autosufficienza produttiva del cittadino, mentre, dal puntodi vista della comunità, la ripartizione della proprietà fondiaria assicura l'uguaglianza nellalibertà contro gruppi particolari e interessi parziali.
Il pensiero di Nicola Corona illustra bene lo slittamento della questione della terra da un
orizzonte economico al piano politico59. Prima della Rivoluzione francese, infatti, lacritica del latifondo aveva già cominciato ad essere espressa da alcuni scrittori economicidello Stato pontificio, intrecciandosi in maniera multiforme con le reminiscenze
dell'antichità e le battaglie del dispotismo illuminato europeo60. «Niente di più funestonell'agricoltura della sproporzione nella divisione delle terre... Platone fra le altre leggidella sua repubblica richiedeva che le terre fossero egualmente distribuite. La egualità è unsogno ma si può e si debbe desiderare che non regni perpetuamente la troppasproporzione», scriveva nel 1779 Alessandro Aleandri, più tardi senatore della
Repubblica61. Cacherano di Bricherasio si era richiamato alla memoria dei Gracchi nelproporre la divisione dell'agro romano e l'istituzione diinsediamenti contadini ispirati alla
Roma repubblicana e alla Chiesa primitiva62.La bonifica della pianura pontina intrapresanel 1779 da Pio VI incoraggiava allora le speranze dei riformatori: le terre strappateall'acquitrinio avrebbero potuto essere concesse in enfiteusi a laboriosi agricoltori senzaricorrere all'esproprio. Le pubblicazioni encomiastiche verso l'opera di Pio VIrinnovavano i fasti dell'agricoltura di Roma antica, e persino sulla stampa letteraria veniva
timidamente sostenuta l'opportunità di una legge agraria63. Negli anni Novanta del secolo,però, la convergenza funesta degli avvenimenti internazionali e dell'aggravamento della
crisi economica e finanziaria dello Stato pontificio determinò un brusco cambiamento di
clima. Fabrizio Ruffo fu dimesso dal Tesorierato nel 179464. La gestione nepotistica deigià deludenti risultati della bonifica si trasformò in un'ennesimo motivo di malcontento; il
papa fu segno di proteste ed insulti in varie occasioni65. Sul piano del dibattito teorico,l'Esatta pratica del cristianesimo dell'abate Tocci fu liquidata senza possibilità di
appello66, e le accademie georgofile in varie città dello stato furono chiuse67.
Le Riflessioni economiche, politiche e morali sopra il lusso, l'agricoltura, la popolazione,
le manifatture e il commercio dello Stato pontificio68 che Corona pubblicò nel 1795 sottolo pseudonimo di Stefano Laonice si muovevano ancora in una prospettiva di politicaeconomica, sebbene la polemica contro il lusso assumesse un forte contenuto politiconell'insistenza sul tema della libertà e nelle critiche appena velate a persone e scelte ben
identificabili del governo69. Durante la Repubblica, invece, il contenuto sociale delle sueproposte si comprende a partire dalla necessità di rafforzare la democrazia. In TribunatoN. Corona propose dapprima la divisione delle rendite superiori ai 500 scudi: «LaDemocrazia non avrebbe mai bene allignato in un paese, ove esistesse una estremadisparità di ricchezze. [...] senza parlare per ora di ciò, che potrebbe ledere il diritto diproprietà già acquistato [Corona] propose di formare una legge, onde impedire che lasproporzione delle ricchezze divenisse maggiore [...] Non sostenne già l'eguaglianza delle
possidenze praticata a Sparta, ma quel minimum di differenze possibile»70. Già nellaseduta del 21 fiorile a. VI egli tornò sull'argomento con la questione agraria. Messe daparte le cautele, propose che si obbligassero i proprietari a dare in colonia perpetua iterreni che eccedessero le 100 rubbia. L'istituto della colonia gli permetteva di aggirare laspinosa questione della proprietà, ma al fine di realizzare l'ideale «all'antica» di contadiniproprietari, lo Stato sarebbe dovuto intervenire per facilitare l'acquisto del terreno da partedel colono. Egli chiedeva inoltre che «Il vicino possa coltivare a proprio vantaggiol'incolto campo del vicino, il proprietario fornisca il colono di case ed utensili, sienoabolite le decime, le caccie riservate, sieno distrutte le palombaie, e finalmente si eriga unmonte di gratuiti imprestiti frumentari, si stabiliscano accademie georgofile con premi, si
eriga un tribunale di censura agraria per ogni dipartimento»71; quest'ultima idea sembrarifarsi ai dispositivi graccani per la lottizzazione prevista dalla Lex Sempronia.
Corona non restò isolato. Com'è noto, varie proposte di una legislazione per la limitazionedella proprietà fondiaria circolarono a Roma negli ambienti radicali, consideraticoncretamente in sedi come il Circolo costituzionale, in stretto rapporto con l'evolversi
della situazione politica72.
Nella Grammatica repubblicana di Nicio Eritreo motivi di primitivismo russoiano si
confondono con le reminiscenze della Roma classica: «La Repubblica romana, checonobbe l'importanza della eguale distribuzione di terreni, fece su di lei delli ottimistabilimenti. Or questo esempio, dovrebbe essere da tutti i popoli imitato». Spettava ai«regolatori della repubblica» regolamentare la proprietà per fare in modo che «non alligniné mai prenda piede nel suo stato una notabile ineguaglianza nell'acquisto e nella
distribuzione delle terre»73.
Il pensiero di Vincenzio Russo rappresenta il punto estremo di un progetto politico che siserve della legge agraria per realizzare un ideale di democrazia. Per Russo la Romaprimitiva è il modello di vita agricola e frugale, ma anche la forma democratica che nonconosce diritto superiore a quello della collettività sovrana: «I primi Romani non avevanoaltro diritto nel testamento se non quello d'indicare un successore. Il popolo nelleassemblee doveva approvarlo: era nullo il testamento, se il popolo lo disapprovava. Iltestamento allora diventava un atto sovrano, col quale il popolo condiscendeva allapermanenza della proprietà in prò di uno dei suoi individui. Dopodiché divenne dominante
l'oligarchia in Roma, si dié per legge la facoltà di testare»74. La democrazia si configuracome l'unione dei liberi produttori indipendenti: «Il solo possidente è libero, perché egli èindipendente. Chi ha braccia e suolo, non dee più mendicare la sua sussistenza da altri: l'hada se stesso. Allora finalmente non è egli in soggettamento di alcuno, allora può senzasperanze e senza timori far uso ragionevole delle intere sue facoltà.[...] Basta tornarci in
mente la vita di alquanti grandi uomini dell'antica Roma»75.
Le idee di Russo sono forse l'espressione più coerente del nesso democrazia-riformasociale; ma si diffusero in quell'élite politica che con Russo condivideva le sedi didiscussione, conquistando anche patrioti che erano stati precedentemente contrari alla
legislazione agraria76. Al Circolo costituzionale e alle riunioni di patrioti reclamava lalegge agraria la «profetessa» Clotilde Labrousse, che, pur con qualche ambiguità,
affrontava la questione insieme a quella delle elezioni e del controllo dei magistrati77.Analoghe richieste avanzava C. D'Alos, considerando che l'agricoltura è «l'arte propria del
uomo libero»78. Pietro Paolo Baccini proponeva la divisione dell'Agro romano e
l'abolizione della proprietà ecclesiastica come contraria ai puri insegnamenti evangelici79.
Dalle pagine del Monitore Francesco Piranesi, con molta cautela, l'auspicava80, e sul
Banditore della verità Michele Mallio81.
Secondo Mallio, le virtù contadine di Cincinnato sarebbero potute rinascere solo se gliagricoltori romani fossero stati messi in grado di praticarle concretamente: le terredovevano quindi essere divise in colonie perpetue con attribuzione di bestiame e diattrezzi agricoli. L'intervento coercitivo dello Stato era giustificato da Mallio sull'esempio
spartano, con il diritto-dovere dell'autorità sovrana di costringere i cittadini alla propria
felicità82. Mallio compose per il teatro repubblicano la tragedia Agide83, metafora dellevicende romane incentrata sulle vicende del re lacedemone restauratore della legislazionelicurghea. Nel momento di climax l'eroe esclama con parole largamente ispirate all'arringa
di un altro grande riformatore antico ritratto da Plutarco, Tiberio Gracco84: « Rimiraintorno / spopolate le ville e le campagne; / se questi un palmo solo possederan di terra /noi li avremmo pur anco. Il vedi pure / che ognun ricusa di pugnar. E come / espor la vitaper la patria, s'essi / sol la trovano matrigna? Se non hanno / casa che a lei si stringa, unfocolare / un terreno a difendere. Sol pochi / tutto ingoiano. / Tal diseguaglianza rende il
popol vile»85.
Negli interventi di altri giacobini romani la questione della «democrazia economica» sisovrappone spesso a motivi più moralistici sulla frugalità, e non sempre il nesso politica-riforma sociale emerge con chiarezza. Le sedi in cui queste riflessioni vennero espresse, laposizione verso le autorità costituite, la rappresentazione della dialettica tra opinionepubblica e potere (patrioti-magistrature) trasforma però i richiami alla frugalità inargomentazioni politiche sulla democrazia. «Voi, che predicate la libertà, che sieteDemocratici, invece di seguire nel lusso le frascherie puerili dell'oziosi, e dell'Aristocratici[...] impiegate in sollievo di questi onesti infelici l'importo esorbitante di tant'inutiliadornamenti, e mostrerete di essere veri, e perfetti Democratici», declamava Pietro
Roppoli al Circolo costituzionale86; la storia romana, le vicende delle guerre civili finoallo scontro tra Cesare e Bruto, piuttosto che gli eroi innocui dei primi secoli, gli servivanoa dimostrare che: «il troppo lusso è nemico, anzi diametralmente opposto alla democrazia.Tutto ciò che rende un uomo al caso di soverchiare un altro è contrario alla libertà,all'uguaglianza». Sottoscrizioni volontarie, controllo degli stipendi dei funzionari, gratuità
del servizio alla patria chiedevano altri patrioti membri del Circolo87. Insomma, lafrugalità è ben diversa a seconda di chi la propugna, e per chi.
Tutto ciò diffonde nuova luce sulla funzione che per i «radicali» ebbe il riferimentoall'antichità, eventualmente attraverso la mediazione di Rousseau: il modello di piccoloproprieterio, o di eroe virtuoso e frugale è soprattutto un prototipo di cittadino. Taleattenzione verso le condizioni dell'esercizio della libertà politica di tutto il popolo (pur contutte le aporie che contiene la rappresentazione illuminista del popolo) si espresseconcretamente nella partecipazione di questi «radicali» alle sedi politiche non istituzionali(Circolo costituzionale, riunioni di patrioti, stampa periodica), per quanto esigui fossero
gli spazi lasciati aperti dal governo direttoriale88. I «moderati», invece, rivelano unaconcezione più rigida del rapporto tra governanti e governati, rifiutando le premesserussoiane della naturale bontà dell'uomo e restando più legati all'antropologia cattolica. E
il più delle volte essi non andarono oltre gli appelli alla virtù ed alla rigenerazione morale,esigenza profondamente sentita, ma non esente da un esito oggettivamente conservatore.Gli eroi antichi sono per i «moderati» soprattutto gli eroi della moderazione e della
disciplina, gli Scevola e gli Scipioni89, in tutto simili ai romani e greci che con pocaconvinzione invitavano la popolazione di Roma alla calma e all'obbedienza nei proclami
delle autorità francesi di occupazione90. Illuminismo cattolico e radicalità rivoluzionariafiniscono, su alcuni punti fondamentali, per divergere e con essi l'immagine dell'antichitàproposta dagli uni e dagli altri.
3. Una palestra di virtù per la Repubblica rigenerata
Le ipotesi finora formulate possono essere verificate sul tema dell'educazione. Già nellaFrancia rivoluzionaria il dibattito sulla riforma della scuola e le feste nazionali aveva vistoun uso diffuso delle reminiscenze antiche nell'elaborazione del sistema pedagogicorivoluzionario, tanto era stretto, da Platone a Rousseau, il binomio antichità-educazione.
L'intreccio di istanze e motivi di derivazione diversa è già evidente nel dibattito svoltosinelle sedi istituzionali quali l'Istituto nazionale, come mostra chiaramente il Piano per lescuole primarie della Repubblica Romana, redatto dalla commissione composta daPessuti, Moncada, Gagliuffi, Calandrelli, Nicola Corona (ma al dibattito parteciparono
certamente altri membri dell'Istituto)91. Le reminiscenze spartane del Piano non silimitano agli esercizi ginnici per i maschi alla presenza delle compagne che li incitano coninni patriottici e nella divisione militaresca delle classi (per altro ricalcata sul modellodelle classi gesuite), ma sono nel fine generale dell'educazione: la scuola è soprattutto unascuola di patriottismo. Le punizioni permesse sono, oltre alla temporanea esclusione daigiochi e dalla ginnastica, l'esposizione di un cartello con la scritta: «NN forse saràincapace di onorare e difendere la Repubblica Romana», mentre genitori e maestri devonocollaborare ad addestrare i fanciulli anche «nell'agricoltura o in qualche arte meccanicaonde possano meritare il nome di Cittadini Romani». Gli insegnanti sono punibili conl'esilio in caso di contravvenzione ai loro doveri pedagogici, e sono «sospetti per pocopatriottismo» i genitori che non mandino i figli a scuola (estremo tentativo di riparareall'assenza di obbligo scolastico). L'antichità contribuisce anche a formare la materiad'insegnamento: l'Istituto avrebbe indetto un concorso per i nuovi libri di testo che«insegnando a leggere agli allievi, servano a formare loro di concerto lo spirito e il cuore,e a sviluppare in essi i preziosi germi delle vere virtù morali e repubblicane». Quando inprimavera il concorso fu bandito, si rese noto ai concorrenti che: «L'Apologo, i fatti storicidelle più famigerate antiche repubbliche, sempre però porporzionati all'intelligenza deiteneri fanciulli, la spiegazione accompagnata dai dovuti e ragionati elogi di alcuneprincipali disposizioni della nostra sublime Costituzione, potranno egualmente servire a
somministrare materia a siffatti libri»92.
Virtù morali e repubblicane: la scuola immaginata dai membri dell'Istituto nazionale è unmisto di pedagogia cattolica, dove si insegnano i doveri verso Dio, sé stessi, gli altri, ed unlaboratorio di educazione patriottica laica, in cui vorrebbe prevalere un ideale dipartecipazione attiva alla vita comunitaria e di dedizione alla patria. È molto difficilecapire a chi si debbano attribuire gli elementi di laicizzazione e quelli di maggiorecontinuità con il sistema educativo tradizionale. Secondo il Monitore la prima posizioneera propugnata da Gagliuffi e Visconti, e la seconda dal matematico Calandrelli; secondo
Sala i novatori erano Visconti, Angelucci, Panazzi, Petrini e Gagliuffi93.
Visconti può probabilmente essere considerato uno dei fautori della laicizzazione«all'antica». Già nella lettera che scriveva nel 1797 a Dionigi Strocchi a Milano sul pianod'istruzione per la Cisalpina si può notare l'esclusione degli insegnamenti religiosi se non
come storia delle religioni per il corso superiore di diritto94. Sala scrive di lui :«Quell'empio del Console Visconti ha proibito a tutta la gente di casa sua di nominar Iddio
e li Santi, e fa portare ai suoi figli li berretti coll'iscrizione 'libertà o Morte'»95: persinotroppo facile, in una figura come Visconti, collegare l'insofferenza verso il cattolicesimo al
culto dell'antichità96. Risulta più complicato, invece, definire la posizione del gruppettodegli Scolopi in seno all'Istituto. L'aconfessionalità della Costituzione appare convinzioneradicata in Gagliuffi, ma egli non propose l'abolizione l'insegnamento del catechismo ascuola come credeva Sala, ma piuttosto di adeguare l'insegnamento della morale
evangelica all'età dei fanciulli e di purificarlo da «certe frivole superstiziose pratiche»97:riforma del culto, più che laicizzazione della scuola, quindi. I collegi scolopici, comunque,continuarono a funzionare, e sembra senza sostanziali differenze con il passato, compresol'insegnamento del catechismo. Quando nel giugno 1799 su iniziativa del ministro degliInterni Antonio Franceschi furono avviate le Scuole Normali della Traspontina, esse
furono affidate ai Padri Scolopi98. Invano, dunque, Matteo Bouchard aveva reclamato dal
banco tribunizio l'immediata sostituzione dei maestri99: le cose andarono moltodiversamente, e i religiosi continuarono a prevalere, sia nell'elaborazione che nella prassipedagogica.
In uno dei progetti di riforma della scuola presentati alla commissione dell'Istituto, quello
del domenicano Alberto Muscella100, per esempio, l'esempio della Grecia antica siconcretizza nell'Atene dei Filosofi dediti all'educazione del popolo (nel duplice senso delladiffusione delle norme morali e della custodia della memoria nazionale) e nella Spartadell'esercizio fisico e dell'educazione in comune. Il piano sembra improntato alla completalaicizzazione dell'insegnamento in armonia con la riforma della scuola francese; poi si
legge la postilla: «Si ricorda che lo studio della Religione dev'essere lo studio di tutte leetà». Furono religiosi o ex-religiosi a parlare ai ragazzi, ad ammonirli alla virtù, a scriverei catechismi repubblicani per la gioventù. Si legga la bella Allocuzione ai giovani
romani101, l'«orazione» di Giuseppe Vera o il «Dialogo» di Gaspare Gasparini per laAccademia patriottica tenuta dagli scolari del Collegio romano il dì 7 fiorile anno VIrepubblicano, oppure, sempre di Vera, il discorso per l'innalzamento dell'albero della
libertà al Collegio romano102. Nella stessa occasione, F. Battistini, dopo aver elencato lasoda cultura e il valore civile di Bruto, Appio Claudio, Gallo Sulpicio, avvertì gli studentiche «Questi ed altri esempi de' nostri maggori vi deve ricordare la vista continua di questosimbolo della libertà, che abbiamo oggi qui collocato. Questo vi deve ritrarre daidissipamenti, e dai trastulli, ed ogni volta che l'effervescenza dei spiriti giovanili vitrasporta a seguire apparenze sollazzevoli, e fallaci, volgete l'occhio a quest'albero: questo
vi rammenti la severità, che conviene a chi della vera libertà è figlio»103. Altro esempio
eloquente è l'operetta di G. Mangiatordi, Il giovinetto istruito per la democrazia104.
Si tratta in tutti questi casi di personaggi che si sforzano di dimostrare la compatibilitàdella Repubblica con l'insegnamento della Chiesa. Riescono a farlo al prezzo di svalutarneil contenuto propriamente politico e di garantirsi della continuità sul piano del modellocomportamentale: analogo procedimento di altri scritti composti nel tentativo di conciliare
la religione cattolica e le istituzioni repubblicane105. La virtù repubblicana si confonde nelrichiamo morale alla carità e all'autocontrollo; i Greci e i Romani servono altrettanto benecome exempla virtutis nei collegi gesuiti che nelle classi della Repubblica.
Anche per i repubblicani «radicali» la storia antica offre una galleria di esempi da imitare.Il fondamento morale della vita associata non è negato dai questi patrioti, né tanto meno illegame educazione-virtù e il ruolo pedagogico degli intellettuali ereditatodall'Illuminismo; esso però si arricchisce dell'elemento più propriamente politico.
[...] Sarei io di parere fargli insegnare in primo luogo la geografia, le istorie, specialmente quellade' Romani e dell'antichi Greci. Questi studi sono per i fanciulli dilettevoli ed anche di sommoutile. [...] L'utilità poi che da questi studi possono i giovani ricavare è di sua natura visibile edinfinita perché apprendendo essi dalle istorie in quale modo si siano regolati i popoli ne' tempiantichi, con quali mezzi abbiano regnato, e per quali vizi ed accidenti siano poi dalla grandezzaloro decaduti, vengono con questi lumi ad imparare l'arte di governare ancor essi le città loro e
di reggere e mantenere altresì le proprie famiglie106.
L'istruzione diventa garanzia della possibilità di uguaglianza tra i cittadini nell'eserciziodei diritti politici. Si leggano le pagine dei Pensieri politici di Vincenzio Russo dedicate
all'istruzione: «Non sarà mai eguaglianza di capacità politica fra gli uomini, se non sirenda generale l'istruzione. Altrimenti il picciol numero della gente illuminata sarà ilmagistrato per natura del resto della nazione, grossolano e rozzo. Noi lo vediamo al
presente: se non si rende generale l'istruzione, si vedrà sempre»107. Ragionamenti simili
espose un altro aderente al Circolo costituzionale, Cristofaro D'Alos108. In queste idee ilriferimento all'antichità non passa attraverso i teorici dell'educazione, che sono gli autoriaristocratici del IV secolo a. C., ma attiene alla realtà storica della democrazia del VI
secolo, è nostalgia per quella omogeneità culturale109. L'accento posto dai democraticiradicali sull'idea rivoluzionaria di «educazione permanente» non si limitò ai discorsi e imembri del Circolo costituzionale organizzarono lezioni gratutite aperte a tutti i
cittadini110.
Sulla questione dell'educazione pubblica e delle società patriottiche si può constatare laconvergenza tra i gruppi radicali e i due più importanti periodici della Repubblica, ilMonitore di Roma e il Banditore della Verità.
Ancora durante le poche settimane di vita della Società degli Emuli di Bruto, M. Mallioscriveva:«Una delle più belle prerogative della nostra libertà è quella sicuramente diradunarci in circoli, ed in assemblee. [...] In esse si dibattono i grandi soggetti della felicitàdel popolo, della consolidazione della Repubblica, di tutto ciò che può riguardare il
politico, l'economico, ed il morale»111. Al momento della chiusura del Circolo
costituzionale, e contro i detrattori112, Mallio scrisse che in una città come Roma,prigioniera dell'analfabetismo, i clubs potevano fornire istruzione e lumi politici, poichésolo l'uguale istruzione dei cittadini aveva permesso alla Grecia antica di vivere in
democrazia113. Nelle pagine del Banditore l'antichità rappresenta un modello di virtù e dicoesione sociale secondo il quale tutti i cittadini, comprese le donne, agiscono nell'unica
considerazione del bene collettivo114.
Nella difesa del Circolo costituzionale non fu da meno il Monitore, o meglio l'ex-scolopioUrbano Lampredi, uomo di profondissima cultura classica, che ne fu il fondatore e
l'animatore115. Egli riprese motivi analoghi a quelli di Mallio sull'istruzione permanente e
sul confronto politico116. La fiducia nella forza progressiva dell'istruzione, tuttailluminista, si volge verso il fine politico della libertà, con argomenti che a tratti siavvicinano a quelli di Russo:
Per dimostrare che non vi è alcun pericolo, ma grandissimo vantaggio nell'avvertire un popolodegli sbagli, dell'ingnavia, e ancora dei difetti politici dei suoi rappresentanti, potrei citare
l'esempio dei sommi Oratori di Atene, e di Roma, i quali nelle pubbliche arringhe palesavano alpopolo quelli tra i suoi magistrati, che erano o indolenti o sospetti, o traditori, senza che lapubblica tranquillità fosse punto disturbata. [...] Mi si dirà forse che questi popoli erano piùistruiti dei moderni, e più adulti nella libertà, e però meglio ne conoscevano il pregio. O voi checosì ragionate ditemi un poco: I Ministri e le altre Autorità costituite della nuova Repubblicaromana cosa hanno fatto fin qui, o piuttosto, vincolati da tristissime circostanze, cosa hannopotuto fare perché il popolo di Roma conosca il pregio della riacquisita libertà? Il popolo nonascolta un discorso astratto e metafisico, ma chiede panem et circenses. Or ditemi è migliorata laprivata economia dei cittadini, abbiamo abbondanza dei generi di prima necessità, e del loro
rappresentante?»117.
Per Urbano Lampredi l'antichità rappresenta un ideale di vita, l'ideale oraziano dellacensura ironica dei costumi, che può diventare la veemenza di Demostene in difesa della
democrazia118. Il diritto-dovere di critica è parte insostituibile della vita democratica119, ei protagonisti della storia antica sono gli strumenti con cui Lampredi e i suoi più stretticollaboratori condussero la loro battaglia contro la corruzione e il malgoverno: di fronteall'inadeguatezza e alla disonestà di governanti e amministratori, Roma e la Grecia furono
un modello di devozione al bene comune, di rettitudine, di frugalità, insomma, di virtù120.
Ecco il nodo: la virtù. Quale virtù per la rigenerata Repubblica?
I democratici radicali romani, e tanto più un religioso come Lampredi, non rifiutarono lanecessità di una rigenerazione etica del cittadino, a qual fine la religione, o meglio la fedenell'immortalità dell'anima poteva essere il più potente stimolo al bene. L'esempio degliAntichi serviva infatti a Lampredi anche per dimostrare la necessità di una fede
religiosa121. Dunque si chiuderebbe il cerchio, tornando nell'alveo del pensiero cristiano?Non lo credo, anche se esistono notevoli differenze tra la posizione di Lampredi e il
pensiero di Russo, che rappresenta per molti versi l'estremo della morale laica122;piuttosto ci avviciniamo alla religiosità dell'Essere Supremo robespierrista o alla
teofilantropia, come modelli di religione purificata123. Infatti l'ideale di cristianesimo delleorigini propugnato da Lampredi, e inseparabile dalla tolleranza religiosa (anch'essamutuata dagli antichi Greci e Romani), finisce per uscire dal cattolicesimo nel sensogenerale del rapporto istituzioni umane - divinità. Licurgo e Numa, per così dire, finisconoper prendere il sopravvento su S. Tommaso d'Aquino.
4. Stoicismo ed eroismo
Il problema del rapporto tra culto dell'antichità e religione cattolica è assai delicato e
complesso. Negli ultimi anni, la questione è stata ampiamente dibattuta dalla storiografiasulla festa rivoluzionaria, che per alcuni aspetti fu forse la più compiuta espressione di unuso dell'antico nel tentativo di rifondare simbolicamente il legame sociale (grazie anche alcontributo degli artisti neoclassici, a Roma rappresentati da Giuseppe Barberi, Andrea
Vici, Andrea Bargigli, Giovan Battista Comolli, Felice Giani)124. Per quanto riguarda laFrancia, M. Ozouf ha considerato il sostituirsi del riferimento all'antichità classica al ritocattolico nelle feste rivoluzionarie francesi come un «transfert di sacralità» verso unmodello familiare ma conosciuto tanto superficialmente da poter essere reinterpretatosenza che la festa nel suo complesso uscisse dalle strutture del sacro come esse erano state
elaborate dal cristianesimo125. La prospettiva antropologica di tale interpretazione nonappare estensibile con profitto allo studio della Repubblica romana, almeno nell'ambitoproblematico che forma l'oggetto del presente contributo. Il problema che a Roma misembra aver dominato sugli altri fu la separazione della sfera politica dalla sfera religiosa,la sottrazione agli ecclesiastici del controllo dell'amministrazione, anche se non si può nonsottolineare ancora una volta come nel dibattito confluì una gamma amplissima di opzioni,e di diversi sincretismi. Per quanto riguarda la «religiosità» delle cerimonie repubblicanecredo ci si trovi di fronte più ad un'assonanza strutturale che ad una corrispondenzafunzionale, per quanto forte fosse la tendenza della classe dirigente romana ad utilizzaregli eroi della classicità come fonte di legittimità al tempo stesso innovativa e rassicurante.
Non che il ricorso all'antichità non fosse reinterpretabile in chiave anticattolica tout court.Un tale atteggiamento si riscontra con più frequenza in sedi come il Circolo
costituzionale126, e contribuisce insieme ad altri indicatori alla formulazione di ungiudizio di «radicalità» per alcuni patrioti piuttosto che per altri. Il rapporto tra religione eRivoluzione aveva assunto i connotati di un conflitto insanabile già da anni. E per cosaaveva rappresentato il potere temporale della Chiesa a Roma, i repubblicani che volevanoessere coerenti con il proposito di laicizzare lo Stato si trovarono immediatamentecollocati all'interno di uno dei due poli opposti.
Tra i patrioti che ricoprirono incarichi direttivi nell'organigramma della Repubblica uncaso interessante è forse quello di Giuseppe Martelli, legale originario di Cascia, membrodella prefettura provvisoria di Giustizia e polizia nei primi giorni della Repubblica, poitribuno e infine ministro di Giustizia e polizia dal 18 settembre 1798 al 16 aprile 1799.Martelli si distinse per il suo zelo nel controllo degli ecclesiastici, sostenuto da Antonio
Franceschi all'Interno127. Sala lo definisce «uomo di fieri sentimenti» nei confronti di
emigrati e religiosi128, e Fortunati racconta come egli, con altri patrioti, si recasse nelmarzo 1799 dai Consoli e dall'ambasciatore Bertolio per ottenere la sospensione delle
celebrazioni della Settimana santa129; dal canto suo, Valentinelli sostiene che egli fu un
convinto fautore della parificazione degli ebrei130. Giudizio severo esprimeva su di luinell'anno VIII Bertolio, definendolo «patriote exclusif» insieme a Bruner, Jacoucci,
Lamberti, esuli romani arrivati a Marsiglia131.
La ricerca di un nuovo quadro di riferimento sembra riflettersi nell'immagine dell'antichitàche Martelli utilizzò nella sua attività, pur nell'ambito fortemente caratterizzato del suoministero. Per denunciare il controllo sociale esercitato dal «dispotismo clericale», eglicitò volentieri la storia antica, preferendo l'immagine di una società fondata sulla legge esulla virtù, piuttosto che la menzione di singoli eroi. Proibendo l'uso delle maschere per ilCarnevale dell'anno VII, per esempio, si dilungava in riflessioni sulla decadenza dellefeste d'ancien régime, che delle tradizioni classiche avevano saputo imitare solo iBaccanali: «La ricordanza delle Antiche Feste, che si trovavano consacrate dai modernicon nomi diversi, era un omaggio forzato, che si rendea all'antichità, ma le stesse ne eranoalterate, ed avvilite dal loro primero istituto». Obiettivo delle feste repubblicane, invece,doveva essere il ristabilimento delle Leggi di natura, dopo che «la Libertà civile è sparita
con l'era de' Greci, e de' nostri Maggiori»132. L'«educazione alla cittadinanza» emerge daiproclami di Martelli come tratto caratteristico del mondo classico, in cui la conoscenzagarantisce la libertà del singolo contro gli arbitri delle autorità e lo mette in grado dicompiere il proprio dovere come fosse una «dolce e facile abitudine»: «I Greci, i Romanile tenevano sculte nel Foro, e le confidavano alla memoria dei fanciulli. Età felice, in cuipoche, uniformi Leggi erano sufficienti a diriggere, ed a raffrenare le passioni dei
Conquistatori del Mondo!»133. Di Martelli abbiamo un articolo sul Monitore sulla
questione teatrale134, e simile intento riformatore egli dimostrò nell'energico intervento
presso l'Arcadia romana, descritto nella «memoria giustificativa» del custode Godard135.
D'altra parte, per quanto riguarda in generale la gestione delle feste repubblicane è a mioavviso fuorviante immaginare l'esistenza di una classe dirigente separata e contrapposta aisemplici patrioti, l'una moderata e neoclassica, gli altri anticlericali e carnevaleschi. Lecose furono più complesse, almeno in città: i patrioti organizzarono manifestazioni
semiprivate che utilizzavano l'alfabeto dell'antico136, e nelle feste centrali fu determinanteil ruolo degli «attivisti», come il Pietro Guerrini della Festa dell'Abbruciamento del Librod'oro, in cui si manifestò la tensione tra una carica liberatoria scomposta e virulenta, e
l'intento didattico di una simbolica purificazione mediante il fuoco137.
È interessante notare che il modello classico fu utilizzato da alcuni patrioti non solo nelladottrina politica, ma anche come modello comportamentale alternativo alla tradizionecristiana, come sistema dell'etica laica della virtù patriottica.
Vincenzo Ondedei pronunciò al Circolo costituzionale un discorso Sopra lo stoicismo138
che rappresenta in un certo senso il manifesto della nuova etica: «Lo Stoicismo è quellasana morale, è quell'esercizio delle più sode virtù, che professavano i Stoici.[...] Lostoicismo non è che una forte passione per tutte le virtù sociali». Stoici erano CatoneUticense, Bruto, Porzia, e «se voi tutti ardentemente bramate, come non ne dubito, lafermezza, e la perpetuità di questa nostra Repubblica, non dovrete porporvi altri modelli,ed altri Maestri in tutte le vostre azioni, che Zenone, Antipatro, Panezio, Possidonio,Epitteto, e tutti gli altri virtuosi propagatori dello Stoicismo».
Si è già visto come nel Circolo costituzionale si parlasse spesso contro il lusso, e dalleparole si passò ai fatti. Vincenzio Russo offrì per la Cassa dei poveri il suo orologiod'argento «unica cosa di qualche pregio, che nella sua povertà possiede»; anche Baccini sitolse l'oro dal cappello e «fu un dolce spettacolo veder seguito il di lui esempio, e vederenon solo l'oro tolto dai cappelli, ma altresì da' pantaloni. Echeggiò allora la sala di replicatievviva la Libertà Latina; evviva Roma, o Liberi o morire; e Bruto, ad una sì luminosa
prova di patriottismo Romano... Bruto sorrise»139. Indubbiamente, in questi gesti, lafrugalità repubblicana si sovrappone alla carità cristiana, ma non si può ignorare il fatto
che i patrioti si richiamassero esplicitamente agli eroi romani, e non ai buoni cristiani140.Lo stesso Baccini si offrì come difensore gratuito dei rei, un gesto che il Monitore
paragonò all'impegno civile di Demostene141. Il Monitore racconta anche l'episodio delcittadino Luigi Cola che voleva imporre a suo figlio i nomi di Aristide Attico Bruto, nomi
che un curato rifiutò come «divinità dei Pagani»142; la notizia può essere certamente
un'invenzione satirica di Lampredi, ma venne ripresa con commenti indignati da Sala143.Questo episodio e l'altro molto noto dell'architetto Giuseppe Barberi sono gli unici esempidi nominazione anticheggiante che si trovano nelle fonti narrative. Sarebbe interessantestudiare i libri parrocchiali delle parrocchie più «giacobine» di Roma (S. Lorenzo inLucina, S. Marcello, S. Maria in Via, S. Stefano del Cacco), per verificare se ci furonoaltri episodi, anche se non ci si può aspettare nulla di paragonabile con il fenomeno
francese144.
Se la Rivoluzione rappresentò una rottura nel modello comportamentale almeno dei gruppimilitanti, nel processo di definizione delle virtù patriottiche e dell'eroismo repubblicano ècerto possibile rintracciare riferimenti ai personaggi della classicità, mediati dal
neoclassicismo prima e dalla propaganda rivoluzionaria poi145. Ecco, per esempio,l'aristocratico reatino Francesco Canali che assiste all'innalzamento dell'albero della libertàa Rieti impettito sul suo cavallo, e con i compagni improvvisa un corteo trionfale dopo
aver repubblicanizzato una località del circondario146. O ancora una madre che come lespartane di Plutarco e di Valerio Massimo offre all'esercito repubblicano due figli, dopo la
morte dei primi due147.
La vita militare sembrò offrire la possibilità di esprimere il desiderio di emulare gli antichieroi: «È incredibile l'ardore con cui concorre ad iscriversi la gioventù romana bramosa dirisuscitare l'antico valore e coraggio di questo Popolo bellicoso, ed a questo fine siesercitano ogni giorno nelle evoluzioni militari sotto la brava direzione dei nostri
Liberatori nella Villa Barberini»148. Nella battaglia di Otricoli contro la retroguardianapoletana, la Legione romana, per quanto esigua, combatté con valore, e i generaliDallamagne e Vial ne diedero atto in un proclama, elogiando soprattutto i colonnelli
Santacroce e Borghese149.
Non furono solo gli aristocratici che risentirono il fascino del protagonismo guerriero. Lospeziale di Marino Bartolomeo Bona, dopo aver guidato i Francesi contro le comuni ribellidei Castelli Romani, venne nominato nel giugno 1798 Comandante della Guardia
nazionale sedentaria150. Il proclama che egli fece pubblicare in quell'occasione è uncapolavoro di retorica dell'eroismo, l'esaltazione dell'eroe di un mese:
Cittadini romani, che già serviste d'esempio a tutto il mondo, assoggettato al valore delle vostreArmi, risvegliate ne' petti l'antico vostro coraggio. Scorrete la strada della Gloria, rintracciandole orme de' vostri Maggiori. Vi sovvenga la lunga schiavitù, che vi ha oppressi, e la Libertà, chericuperata avete mercé l'aiuto de' vostri Fratelli, de' generosi Francesi.[...] Fate a gara di militaresotto la bandiera della Nazione, insuperbite di scorrere in pattuglia per la Città alla difesa della
libertà151.
Il commento di Sala: «Egli si è fatto subito sentire con una rodomentesca Allocuzione al
Popolo di Roma. Questa sorta di Eroi non sanno parlare altro linguaggio»152; stesso
sarcasmo per Pietro Piranesi, «cognito patriota», al momento della sua nomina153.
Nell'eroe «all'antica» sembra prendere corpo l'ideale di una vita come avventuraprometeica elaborato dall'Illuminismo, mentre la morte trova un significato nuovo e laiconel bene della Patria e nel ricordo dei posteri. Così, nel dicembre 1798 Luigi Bruni,patriota di lunga data che aveva partecipato ai tentativi di rivoluzione del 2 agosto e del 28
dicembre 1797154,si suicidò per non cadere in mano agli Insorgenti155.Qualche mese piùtardi l'anonimo estensore delle Memorie per servire al diario di Roma riferisce del tentatosuicidio con veleno di un patriota arrestato dai francesi nel settembre 1799, e aggiunge: «[è] una delle mode dei Figli di Bruto di portarlo sempre in saccoccia, per morire
all'occasione piuttosto che andare in mano di un tiranno»156. L'autore del gesto può forse
identificarsi in Giuseppe Jacoucci, o nello speziale Francesco Mutarelli, entrambi arrestatiper aver dimostrato vivaci dissensi verso la politica dei Francesi nei confronti della
Repubblica romana in pericolo157. Il primo, originario di Veroli, frequentatore del Circolo
costituzionale, animatore dell'innalzamento dell'albero della libertà a piazza del Popolo158,era stato commissario dipartimentale del Tevere, e l'animatore di un burò di giudizio
patriottico; Sala lo descrive come uomo ferocemente anticlericale159. Finirà per emigrarecon i Francesi. Il secondo, suo inseparabile collega, figura in una lista di patrioti
sequestrata al console Pierelli come protagonista dei fatti di dicembre 1797160, ed era statoamministratore dipartimentale del Tevere, ed «uno dei capi della rivoluzione ed in tutto iltempo della Repubblica, portò sempre una berretta con l'iscrizione a lettere d'oro: o libertà
o morte»161.
Vero o falso che sia, l'episodio rivela comunque l'opinione dei conservatori nei confrontidei giacobini, ritenuti capaci di gesti eroici dal sapore stoico (oltre a confermarci il gradodi disillusione raggiunto nei circoli radicali romani verso i Francesi). La terribilealternativa, Libertà o morte, veniva ripetuta, giurata, meditata. I suicidi di Socrate e diCatone, illustrati dalla pittura, dal teatro, dai discorsi rivoluzionari fornivano l'esempio
glorioso dello sprezzo della morte per la libertà162. Certo, si tratta di rari accenni, di indiziisolati, spunti che incoraggiano ricerche future sui canali di diffusione e di socializzazionedei modelli e dei valori.
Al di là dei gesti eroici, è però certo che alcuni patrioti scelsero l'antico anche comeespressione di un'appartenenza politica che ben chiara doveva apparire ai contemporanei.Bastavano segni minimi, come la capigliatura «alla Brutus». Il repubblicano SaverioPediconi si mostrava in città con i «bragaloni, coi capelli alla Brutus, coi scopettoni e colbastone»; simile acconciatura portava Pio Camillo Bonelli, e la cosa doveva essere diffusa
tra i giacobini romani163, tanto che il Monitore ammonì i patrioti a non lasciare che i
capelli decidessero della fede politica164. Il berretto frigio, a volte con l'iscrizione «Libertà
o morte», doveva anche essere frequente165. E se la coccarda era stata resa obbigatoria,
non lo erano i bottoni con lo stemma della Repubblica o con l'effigie di Bruto166.
È da sottolineare la selettività di questi segni: essi assumono un significato preciso nelladialettica tra moderati e radicali. Nel sistema simbolico già articolato che venne impostoalla totalità della popolazione, alcuni gruppi sentirono la necessità di una ridondanza disegni per marcare l'appartenza ad una élite politica. All'interno di queste élites, nondefinite in base alla provenienza sociale, ma piuttosto dalla partecipazione alla rete disociabilità repubblicana che si strutturava intorno al Circolo costituzionale e ad alcuni
caffè di Roma (tra gli altri quelli «degli Specchi», «della Barcaccia», la spezieria dellaRegina), in case private (di Bonelli, di Tommaso Lamberti), ma anche a teatro e alle feste,l'antico fu investito di un nuovo significato politico.
Il culto di Bruto, in particolare, si manifestò attraverso oggetti di ogni tipo, come busti ed
incisioni. Un busto di Bruto venne coronato nel cortile dell'ospedale S. Spirito167, e ancoraSala riporta la notizia che i «patriotti», dopo la chiusura del Circolo costituzionale,discussero l'idea di portare il busto di Bruto in processione per l'anniversario del 14
luglio168. Per quanto riguarda le incisioni, presso il Gabinetto nazionale delle stampe sonoconservati due ritratti di Bruto; le modeste dimensioni di uno di essi (mm. 112 x 85)
suggeriscono che era destinato ad una collezione privata169.
Su Bruto, eroe e simbolo di un progetto politico ed etico, ricadde il rifiuto anti-repubblicano all'indomani dell'invasione napoletana: «Questa mattina una truppa dipopolo ha estratto dal Palazzo Vaticano il busto di Bruto, che servì per la Festa Patriotticadel primo Vendemmiale, lo ha collocato sopra un carrettino, e lo ha portato in giro per lacittà, facendolo vedere anco agli Ebrei sulla Porta del Ghetto. In ultimo lo ha gettato nel
Tevere, dove pure ha avuto sepoltura lo stendardo tricolore [...]»170.
Abbreviazioni
ASR: Archivio di Stato di Roma.
BAV: Biblioteca Apostolica Vaticana.
BNR: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II, Roma.
Assemblee: Assemblee della Repubblica Romana (1798-99), a cura di Vittorio E. Giuntella,Bologna, 1954; Roma, 1977.
Collezione: Collezione di Carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzionitendenti a consolidare la rigenerata repubblica romana, Roma, 1798-1799, anno I-II dellaRepubblica Romana.
Fortunati: Avvenimenti sotto il pontificato di Pio VI dall'anno 1775 all'anno 1800 raccolti dallabo.me. Francesco Fortunati, BAV, codd. Vat. lat. 10730-10731.
Galimberti: Memorie dell'avv. Antonio Galimberti dell'occupazione francese in Roma dal 1798alla fine del 1802, BNR, mss. Vittorio Emanuele 44-45.
Sala: Scritti di Giuseppe Antonio Sala pubblicati sugli autografi da Giuseppe Cugnoni, Roma,1882-1888; ristampa anastatica a cura di V.E. Giuntella e R. Tacus Lancia, Roma, 1980.
Valentinelli: Valentinelli Francesco (attribuito), Memorie storiche sulle principali cagioni ecircostanze della rivoluzione di Roma e di Napoli,[s.l.], 1800.
Note
1. H.T. Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries, Chicago, 1937. Già il librodi M. Badolle, L'abbé J.J. Barthélémy et l'hellenisme en France dans la seconde moité duXVIIIe siècle, Paris, 1927, dedicava una parte alla questione.
2. B. Baczko, L'Utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'etàdell'Illuminismo, Torino, 1979, p. 85. La bibliografia è ricchissima, anche di contributi suisingoli pensatori; rimando solo a P. Gay, The Enlightenment: an Interpretation. The rise ofmodern Paganism, New York, 1968; E. Rawson, The Spartan Tradition in European Thought,Oxford, 1969; L. Guerci, Libertà degli antichi e libertà dei moderni. Sparta, Atene e i'philosophes' nella Francia del Settecento, Napoli, 1979; e al recente libro di una studiosaprematuramente scomparsa, M. Raskolnikoff, Histoire romaine et critique historique dansl'Europe des Lumières: la naissance de l'hypercritique dans l'historiographie de la Romeantique, Roma, 1992. Sull'aspetto più propriamente artistico cfr. R. Rosemblum, Trasformazioninell'arte. Iconografia e stile tra Neoclassicismo e Romanticismo, Roma, 1984.
3. J.M. Goulemont, Du républicanisme et de l'idée républicaine au XVIIIe siècle, in F. Furet -M. Ozouf (sous la direction de), Le siècle de l'avènement républicain, Paris, 1993, in particolarep. 46. Cfr. anche la messa a punto di Y. Touchefeu, Les institution politiques romaines comme«modèle» démocratique au XVIIIe siècle, en France, de Rollin à Rousseau, comunicazionepresentata al XII seminario internazionale di studi storici Da Roma alla terza Roma, Roma, 21-23 aprile 1993, Antichità e Rivoluzioni da Roma a Costantinopoli a Mosca.
4. J. Godechot, L'influence de l'Antiquité gréco-romaine à l'époque révolutionnaire, in «Index»,n. 7, 1977, pp. 45-57; J. Bouineau, Les toges du pouvoir, ou la révolution du droit antique 1789-1799, Toulouse, 1986; P. Vidal-Naquet, Tradition de la démocratie grecque, pref. alla trad.francese di M.I. Finley, Démocratie antique et démocratie moderne, Paris, 1976, e con N.Loraux, La formation de l'Athènes bourgeoise. Essai d'historiographie, in R.R. Bolger (ed.),Classical Influence on Western Thought, AD 1550 - 1870, Cambridge, 1978, pp. 169-222; C.
Mossé, L'Antiquité dans la Révolution française, Paris, 1989; e i contributi riuniti in La Greciaantica. Mito e simbolo per l'età della grande Rivoluzione, Milano, 1991.
5. Cfr. l'autorevole giudizio di V.E. Giuntella, La giacobina Repubblica Romana, in «Archiviodella Società romana di storia patria», a. LXXIII, (1950), pp. 11 ss.
6. La definizione è tratta dall'opera di R. Assunto, Specchio vivente del mondo. Artisti stranieriin Roma 1600-1800, Roma, 1978.
7. Su Roma nel Settecento cfr. V.E. Giuntella, Roma nel Settecento, Bologna, 1971, e perl'ambiente neoclassico l'ancora utilissimo L. Hautecoeur, Rome et la renaissance de l'antiquité àla fin du XVIIIe siècle, Paris, 1912.
8. S. Pinto, La promozione delle arti negli Stati italiani dall'età delle riforme all'Unità, in Storiadell'arte italiana, t. VI**, Torino, 1982, pp. 793-1079, sullo Stato pontificio pp. 889 ss.; C.Pietrangeli, Scavi e scoperte di antichità sotto il pontificato di Pio VI, II, Roma, 1958, purtroppolimitato agli anni 1775-1780. La figura di Pio VI meriterebbe di essere studiata piùapprofonditamente, poiché il fervore apologetico inficia le sue pur numerose biografie. Rimandoin ogni caso al classico L. von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del medioevo, vol. XVI, Pio VI(1775-1799). Versione italiana di Pio Cenci, Roma, 1934.
9. A. Cipriani, Contributo per una storia politica dell'Arcadia settecentesca, in «Arcadia. Atti ememorie», s. III, vol. V, fasc. 2-3, 1971, pp. 101-166; L. Felici, L'Arcadia romana traIlluminismo e neoclassicismo, ivi, pp. 167-182; A. Costamagna, Agesia Belaminio (G.G.Bottari) e l'accademia dell'Arcadia nel Settecento, in «Quaderni sul Neoclassico», n. 3, 1975,pp. 43-63.
10. Per un elenco dei periodici a Roma cfr. O. Vercillo, Periodici romani dal 1700al 1814 , in«L'Urbe», 1949, fasc. 6, pp. 19-28; cfr. anche L. Felici, Il giornalismo romano tra Arcadia eneoclassicismo, in «Studi Romani», n. 19, 1971, pp. 236-273.
11. Ampie selezioni delle loro opere sono state pubblicate ed annotate in Illuministi italiani. t.VII: Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato Pontificio e delle Isole, acura di G. Giarrizzo, S. Torcellan, F. Venturi, Milano-Napoli, 1965.
12. Cfr. i documenti del processo che ne seguì pubblicati da C. Trasselli, Processi politici romanidal 1792 al 1798, in «Rassegna Storica del Risorgimento», a. XXV (1938), fasc. 11-12, pp.1495-1613.
13. Sulla Repubblica romana occorre rimandare a A. Dufourcq, Le régime jacobin en Italie.Étude sur la République Romaine (1798-99), Paris, 1900; V.E. Giuntella, La giacobinaRepubblica Romana, in «Archivio della Società romana di storia patria», a. LXXIII (1950), fasc.1-4; A. Cretoni, Roma giacobina. Storia della Repubblica Romana del 1798-99, Roma, 1971.
14. F. Venturi, Utopia e riforma nell'Illuminismo, Torino, 1970, e più in generale A. La Penna,La tradizione classica nella cultura italiana, in Storia d'Italia, vol. V**, I documenti, Torino,1973, pp. 1321 ss.
15. Colgo l'occasione per esprimere il mio debito verso il prof. F. Pitocco, sotto il cui impulsoquesta ricerca ha visto la luce. Alla dott.ssa S. Nanni vanno i miei ringraziamenti per le suepuntuali e sempre stimolanti osservazioni.
16. Gli atti del parlamento della Repubblica romana sono stati parzialmente editi a cura di V.E.Giuntella, Assemblee della Repubblica Romana (1798-1799), Bologna, 1954, e Roma, 1977. Idue volumi comprendono le sedute del Tribunato I-XCVII dal 30 ventoso al 29 messifero a. VI.Gli atti del Tribunato per le sedute I-LVII dal 26 brumale al 27 ventoso a. VII sono conservatipresso la Biblioteca del Senato della Repubblica (Leg. Antichi Stati 303); per il Senato iresoconti delle sedute I-XL dal 30 ventoso al 19 messifero a. VI e I-LIII dell'anno VII si trovanopresso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea (21. 8. F. 11-12). Il prof. Giuntella staattualmente curando la pubblicazione di questa serie di processi verbali. Per un giudiziocomplessivo sui risultati dell'attività legislativa del parlamento della Repubblica cfr.l'introduzione dello stesso V.E. Giuntella, La crisi del potere temporale alla fine del Settecento ela parentesi costituzionale del 1798-99, in particolare p. LXXXI ss.
17. P. Vidal-Naquet, Il posto della Grecia nell'immaginario degli uomini della Rivoluzione, inLa Grecia antica, cit., pp. 15-38; cfr. anche J. Bouineau, op. cit., pp. 139 ss.
18. Secondo il principio censitario sancito dalla Costituzione francese dell'anno III e ribaditodalla Costituzione romana, la condizione per l'eleggibilità era un reddito imponibile pari a 150giornate di lavoro (art. XXV). Nel Senato abbiamo notizie sulla professione di diciassettemembri; di questi 5, ma più probabilmente 7, esercitavano professioni connesse allagiurisprudenza, e uno, Renazzi, insegnava alla Sapienza; sedevano inoltre tra i senatori 4 medici,1 proprietario terriero, 3 intellettuali, 1 membro di famiglia commerciante, e 3 nobili, di cui uno,Bufalini, era stato diseredato e si era rivolto alla carriera militare. In tribunato troviamo 25uomini di legge, forse 27, e tra essi Moroni insegnava Diritto civile all'Università di Perugia; 5medici; 3 proprietari terrieri; 8 intellettuali (di cui 5 erano religiosi); un grande commerciante edarmatore; 5 aristocratici; 1 religioso (Angelo Angelucci, fratello del più famoso Liborio), 1libraio, 1 incisore. Non sono stati presi in considerazione i membri nominati nel maggio 1799; si
consideri però che la laurea in utroque iure era considerata il naturale coronamentodell'istruzione delle classi dirigenti, e quindi altri tribuni e senatori avevano verosimilmenteconseguito tale diploma. Come base per queste statistiche ho utilizzato il vecchio articolo di T.Casini, Il Parlamento della Repubblica Romana del 1798-99, in «Rassegna Storica delRisorgimento», a. III (1916), fasc. V-VI, pp. 517-572, integrandolo con altre fonti e repertoribiografici, quali il «Dizionario biografico degli Italiani»,Roma, 1960-(1992). Si tengano tuttaviapresenti le precisazioni metodologiche sulle classificazioni sociologiche per l'ancien régime diB.G. Zenobi, Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccolanobiltà fra '500 e '700, Bologna, 1976, pp. 31 ss.
19. Cfr. C. Nicolet, L'idée républicaine en France 1798-1924: essai d'histoire critique, Paris,1982, p. 335. Accanto all'ammmirazione per la tradizione giuridica repubblicana, occorresottolineare che, al contrario, la giurisprudenza giustinianea era stata oggetto di una ferocecritica che accumunò i giuristi illuministi in tutta Europa. Cfr. R. Bonini, Giustiniano nellastoria: il mito e la critica nel Settecento illuminista, Torino, 1991.
20. J. Bouineau, op. cit., p. 161.
21. Assemblee, vol. II, p. 589. Il ricordo di Cicerone (de Leg., II, 23, 59) e le leggi delle XIItavole cantate dai fanciulli «ut carmen necessarium» è evidente.
22. Di questo parere è anche P. Alvazzi del Frate, La «romanité» dans le système juridique de laRépublique romaine (1798-1799), comunicazione presentata al XII seminario internazionale distudi storici Da Roma alla terza Roma, Roma, 21-23 aprile 1993, Antichità e Rivoluzioni daRoma a Costantinopoli a Mosca.
23. G. Cambiano, Montesquieu e le antiche repubbliche greche, in «Rivista di Filosofia», vol.LXV, 1974, pp. 93-144. Sul rapporto tra storiografia e politica cfr. G. Benrekessa, La politique esa mémoire. La politique et l'historique dans la pensée des Lumières, Paris, 1983. Y. Touchefeu,art. cit., scrive ancora in proposito:«L'intérêt de la Rome antique n'était pas tant de proposer desinstitutions dont les modernes pourraient directement s'inspirer. Il était plutôt d'inviter à réfléchiraux principes qui régissaient cet édifice institutionnel. En s'attachant à cette réflexion, leshommes des Lumières mettaient à jour des questions capitales qui préparaient le chemin de larépublique». Su Montesquieu cfr. Montesquieu et la Révolution, n. monografico di «Dix-huitième siècle», n. 21, 1989. P. Berselli Ambi, L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano,Firenze, 1960, p. 210, sostiene invece che le Considérations sur les causes de la grandeur desRomains et de leur décadence furono lette in Italia solo da un ristretto pubblico di studiosidell'antichità. Su Gibbon cfr. M. Baridon, Edward Gibbon et le mythe de Rome. Histoire etidéologie au siècle des Lumières, Paris, 1977, e i vari interventi di A. Momigliano, soprattutto
quelli raccolti in Contributo alla storia degli studi classici, Roma, 1955, e Sesto contributo allastoria degli studi classici e del mondo antico, Roma, 1980. Su Mably, considerato dalla criticacontrorivoluzionaria il maggiore responsabile dell'anticomania repubblicana, cfr. il breve mapuntuale articolo di T. Schleich, Mably e le antiche costituzioni, in «Quaderni di storia», n. 23,1986, pp. 173-197.
24. Assemblee, vol. II, p. 391. Il testo del primo progetto di risoluzione alle pp. 525-526.
25. Ivi, vol. II, pp. 575-576.
26. Ivi, vol. II, p. 714.
27. Ibidem.
28. Assemblee, vol. II, p. 627.
29. Il Senatore Santarelli, parlando contro la proposta di riservare la professione notarile aiconiugati o vedovi, invocava le leggi «ampie, per così dire non coattive» di Atene e Roma;quest'ultima, che non si attenne sempre a questo principio, «ebbe a pentirsi di aver riservatoall'ordine equestre la pretura, che sotto le loro mani divenne un tempo la spada de' prepotenti, ilbanco della pubblica violenza, la mercatura delle leggi». Senato, seduta XIV del 18 piovoso a.VII.
30. Nella seduta VIII (9 germile a. VI) Sertori invocò una legge che «imponga freno agliamministratori della Cassa Nazionale». Moroni propose di richiamare in vigore le leggi romanede Ambitu, de Peculatu, de Residuis, al fine di «ristabilire l'antica gloria del nome romano, ed aquesto coopereremo rendendo al suo vigore la forza delle sue savie leggi». Il presidenteGagliuffi ricordò che i commissari francesi erano al lavoro per redigere il codice penale: essi«sceglieranno le migliori fra le antiche leggi romane e riformeranno le altre, conformandole alcostume di questi tempi e prevalendosi delle odierne filosofiche cognizioni». Assemblee, vol. I,pp.78-79.
31. Seduta LXIX del 28 pratile a. VI, progetto di risoluzione per richiamare gli emigrati, che«freddi ed insensibili al glorioso Risorgimento della Patria loro, fratelli degeneri da quelliantichi eroi non solo, che per essa e per la romana libertà sudarono, ma da quelli eziandio, chenella seguita rigenerazione di essa il coraggio e l'attaccamento emularono dei Bruti». Assemblee,vol. II, p. 586.
32. Il Monitore di Roma n. IX del 21 marzo 1798 parla di una petizione contro la possibilità dipagare 4 paoli per l'esenzione dal servizio personale: la disposizione disonorava infatti il nomeromano.
33. Cfr. C. Mossé, L'antiquité dans la Révolution française, cit., pp. 73 ss. e 82 ss. È da notareche questo aspetto di «apprendistato democratico» del servizio nella Guardia nazionale fu quelloche maggiormente colpì gli osservatori coevi, fossero essi ostili o favorevoli alla Repubblica,come si deduce dai commenti riportati da A. Cretoni, op. cit., p. 147.
34. Assemblee, vol. I, p. 106. Interessante anche la risposta alle obiezioni sulla fatica del serviziopersonale: «Siano pure effemminati i corpi e deboli gli spiriti, sia vasta la città e scarsa lapopolazione, sia l'aria malsana, pure si superavano tutti questi ostacoli dai romani, per l'addietro,ad oggetto di consumare le notti nei festini, nelle veglie e nei passeggi notturni; si superavano inquelle lunghe processioni da una basilica all'altra per servire la politica dei tiranni, e non sisupereranno per servire alla Patria, per procurare la propria sicurezza?» (Ibidem).
35. Luigi Lamberti, 1759-1813, di Reggio Emilia, poeta e filologo, dopo aver interrotto gli studilegali, si trasferì a Roma dal 1787, dove fu impiegato come segretario di Marcantonio Borghese;fu ascritto in Arcadia (Musonio Filagense) e all'Accademia degli Aborigeni, frequentandosoprattutto E.Q. Visconti, con il quale condivise la scelta repubblicana, l'Istituto nazionale einfine, temporaneamente, l'esilio parigino.
36. Assemblee, vol. I, p. 106.
37. Cfr. soprattutto le accese sedute XIX e XX del 23 e 24 germile a. VI, nonostante il fatto cheil nuovo progetto di risoluzione avesse accolto molte delle obiezioni che erano state mosse alprecedente, come si legge in Assemblee, vol. I, pp. 130-132.
38. Assemblee, vol. I, p. 173.
39. F.M. Renazzi, Discorso del Cittadino avvocato Filippo Renazzi senatore, pronunciato nellaseduta dei 9 fiorile anno VI dell'Era repubblicana e per decreto del Senato reso pubblico collestampe, [snt]. Sull'opera di Filippo Maria Renazzi, 1742-1808, di Roma, avvocato e professoredi Istituzioni criminali alla Sapienza, in Arcadia Darinto Piseo, cfr. M.R. Di Simone, La«Sapienza» romana nel Settecento.Organizzazione universitaria e insegnamento del Diritto,Roma, 1980, pp. 208 ss.
40.Vidal-Naquet e N. Loraux, La formation de l'Athènes bourgeoise, cit., hanno chiarito per la
Francia il senso dell'evoluzione dell'immagine di Atene ricca e commerciante rispetto alla Spartaagraria e frugale di Rousseau, di Mably e di molti robespierristi. Nel caso della Repubblicagiacobina romana i riferimenti alla Grecia sono di scarsa importanza in materia sociale edeconomica ma la Roma primitiva assunse il ruolo che era stato di Sparta nel dibattito francese.
41. «Allo stesso modo si affrontano i problemi sociali [con il suggerimento di espedientiestraordinari ed empirici]; ci si accontenta di riaffermare solennemente i grandi principi equalche volta si prospettano audaci riforme; manca però la volontà e la capacità di trovare lesoluzioni sul terreno politico e legislativo», V.E. Giuntella, art. cit., in Assemblee, p. LXXIII.Diversamente motivato ma pur sempre critico il giudizio di R. De Felice, Aspetti e momentidella vita economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX, Roma, 1965, sulla Repubblicapp. 153 ss.
42. Mi limito a rimandare alle ricerche di M. Caffiero, in particolare L'erba dei poveri.Comunità rurali e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX), Roma, 1982.Per una critica alla teoria della modernizzazione occorre rifarsi all'ormai «classico» R. Bendix,Tradition and Modernity reconsidered, in «Comparative Studies in Society and History», IX,1967, 3, pp. 292-346. Cfr. anche S.N. Eisenstadt, The Sociological Theory and the Paradigm ofModernisation and Development, in «History and Theory», XXIII, 1974, 3, pp. 225-252.
43. Assemblee, vol. I, p. 68-69. Francesco Pierelli, nato nel 1757 ad Ancona, esercitava laprofessione legale nella Capitale, dove era in contatto con il gruppo di uomini di legge legati alduca Pio Camillo Bonelli (Bassi, Maggiotti, Benoffi, Gabrielli); soggiornò ad Ancona nei giornidella Repubblica anconitana per organizzare un gruppo di patrioti; a Roma fu membro dellaMunicipalità provvisoria di Roma, tribuno, ministro di Giustizia e polizia, ministro presso laRepubblica ligure e infine console. Alla caduta della Repubblica fu arrestato a Roma dovecontinuava a nascondersi e processato dalla Giunta di Stato per la sua attività politica primadell'arrivo dei Francesi. Cfr. ASR, Giunta di Stato 1799-1800, b. 13, fasc. 169. Su Bonelli cfr. lavoce curata da R. De Felice nel «Dizionario biografico degli Italiani», vol. XI.
44. Collezione, vol. I, p. 254.
45. Sulla fortuna settecentesca dell'enfituesi come strumento di intervento statale cfr. G.Giorgetti, Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agraridal secolo XVI a oggi, Torino, 1974, pp. 97 ss.
46. Assemblee, vol. II, p. 769. In modo analogo, quando si trattò di regolare le modalità dipagamento dei contratti stipulati anteriormente al decreto di svalutazione delle cedole decretatoda Dallamagne il 25 marzo 1798, nel Tribunato venne in luce la tendenza a favorire gli
agricoltori affittuari «utili alla Repubblica» e le classi lavoratrici, penalizzando piuttostobanchieri e proprietari terrieri; cfr. Assemblee, vol. I, p. 88-92.
47. Senato, seduta VI, 8 germile a. VI. La versione a stampa del discorso è leggermente diversada quello riportata nel processo verbale. Cfr. A. Brizi, Discorso fatto in senato dal cittadinosenatore Antonio Brizi sull'inopportunità delle enormi spese ideate per le disposizioni della gransala delle sedute in Campidoglio, Roma, [sd]. Antonio Brizi, 1753-1826, di Perugia, avvocato,era stato attivo con i riformatori perugini dell'Accademia dei Forti (A. Cocchi, A. Mariotti, F.Danzetta, G.B. Agretti) con i quali partecipò poi al governo provvisorio di Perugia. Nominatosenatore e poi console, alla caduta della Repubblica fu graziato per aver salvato l'archivio dellaCongregazione di Propaganda Fide prendendone il palazzo in affitto come abitazione. Cfr. lavoce curata da L. Gennari in «Dizionario biografico degli Italiani», vol. XII.
48. Assemblee, vol. I, p. 82. Su Nicola Corona cfr. il profilo biografico e critico di F. Venturi inIlluministi italiani, cit., pp. 671 ss.
49. F. Scarpellini, Mozione con progetto di legge del cittadino tribuno Feliciano Scarpellinisulla maniera di corregere l'infezione delle campagne per via della piantagione, [snt]. FelicianoScarpellini, 1762-1840, di Foligno, era professore di Fisica alla Sapienza; membro delleaccademie degli Aborigeni e Esquilina, dopo la Repubblica diede vita all'accademia dei NuoviLincei.
50. Marco Faustino Gagliuffi, 1765-1834, dell'ordine dei Chierici regolari delle Scuole Pie,aveva insegnato in vari collegi dell'ordine, ed era celebre come poeta e latinista, in ArcadiaChelindo Epirotico. Alla caduta della Repubblica partì con i Francesi e fu espulso dall'ordine,ma rientrò presto in Italia. Su di lui cfr. l'articolo, comprensibilmente reticente sul periodorepubblicano, di L. Picanyol, Un insigne latinista, Marco Faustino Gagliuffi. Pubblicazione perla ricorrenza del primo centenario della morte, in «Parva bibliotheca calasanctiana», n. XI,1934, pp. 3-48, e, più recentemente, D. Armando, Gli scolopi e la repubblica giacobina romana:continuità e rotture, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 1, 1992, pp. 223-258.
51. Nato nel 1762 a Perugia, Damaso Moroni era canonico del Capitolo della cattedrale diPerugia e professore di diritto civile. Era stato municipalista provvisorio di Perugia; nominatotribuno si distinse per l'impegno moderatore verso la Chiesa, diventando il principale accusatoredi Claudio Della Valle per il tentativo di quest'ultimo di privare le autorità ecclesiastiche delpotere di nomina dei parroci. Alla caduta della Repubblica, fu arrestato e accusato di attivitàsediziosa prima dell'arrivo dei Francesi, e di aver scritto testi blasfemi, cioè una Oratio adpetendam Libertatem in Capitolio, interessante sintesi tra il rito cattolico e la storia antica. Ilpensiero di Moroni cambiò sensibilmente con l'evolversi della situazione: in un altro discorso
allegato al processo, probabilmente letto all'Istituto nazionale nella primavera del 1799, siinsinuava il dubbio che la «protezione» francese si limitasse, come la conquista della Grecia daparte dei Romani, ad una invasione brutale se non permetteva all'Italia tutta di vivere la propriaritrovata libertà nella vera democrazia. ASR, Giunta di Stato 1799-1800, b. 3, fasc. 50. Suicattolici repubblicani di Perugia cfr. il contributo sull'altro perugino Fabio Danzetta di C.Minciotti, Un perugino tra due rivoluzioni: Fabio Danzetta. (1769-1837, in «Bollettino dellaDeputazione di Storia Patria per l'Umbria», vol. LXX (1973), pp. 91-145.
52. Assemblee, sedute I e II del 30 ventoso e 1 germile a.VI, vol. I, p. 56 e 58. Evidente in questefrasi l'ambiguità della tradizione sul Tribunato della plebe, già delineatasi in età classica. Inproposito cfr. G. Grosso, Appunti per una valutazione del tribunato della plebe nella tradizionestoriografica conservatrice, in «Index», 7, 1977, pp. 157-161.
53. Si veda per esempio Monitore di Roma del 21 caldifero a. VI; Gazzetta di Roma, 21 febbraio1798. Cfr. anche il suo discorso alla cerimonia funebre per il generale Duphot, in Collezione,vol. I, p. 39.
54. Assemblee, vol. II, p. 736.
55. G.B. Agretti, Catechismo repubblicano tratto dal francese dal Cittadino Gio. Battista AgrettiPrefetto Consolare presso i Tribunali del Trasimeno per uso de' suoi figli, Assisi, 1798. GiovanBattista Agretti, 1775-1830, di Perugia, esercitò l'avvocatura a Roma e a Perugia, dove fupromotore della colonia dei Forti; fino a che divenne processante della Consulta a Roma e vi sistabilì definitivamente. Coinvolto nel tentativo insurrezionale che portò alla morte di Duphot nel1797, esulò nella Repubblica Cisalpina fino all'invasione francese dello Stato pontificio.Divenne allora vicepresidente della municipalità perugina e poi prefetto consolare delTrasimeno. Alla caduta della Repubblica abbandonò l'Italia.
56. Alessandro Aleandri, 1762- 1838, di Bevagna, dopo aver seguito gli studi legali, ebbeincarichi nel governo di varie località dello Stato pontificio, e si guadagnò fama di novatore conalcuni scritti quali Dell'ingrandimento dell'agricoltura e delle arti nello Stato Pontificio (1789),Degli orfanatrofi e delle pubbliche case di lavoro (1793), Dell'Annona (1794). Fu senatore e poiconsole della Republica. Su di lui V.E. Giuntella in «Dizionario biografico degli Italiani», vol.II. Di Aleandri si legga anche la relazione della commissione d'inchiesta sull'incostituzionalitàdella seduta straordinaria tenuta da alcuni membri del Senato nel convento di Monte Marcinopresso Perugia il 2 dicembre 1798, durante la prima invasione napoletana (s. V del 21 nevoso a.VII). In questo caso, come nel caso di altri conflitti (tra Tribunato e Senato, tra Esecutivo eLegislativo, tra autorità romane e francesi) l'evocazione dell'antichità svolge una funzionemoderatrice; permette di formulare le critiche senza farle uscire da un ben delimitato ambito
retorico.
57. G. Maugain, Documenti bibliografici e critici per la storia della fortuna di Fénélon in Italia,Paris, 1910, pp. 27 ss., fino al 1800 conta 33 traduzioni in prosa italiana, 4 in poesia, 6 edizioniin lingua francese stampate in Italia e 2 edizioni poliglotte. Su Fénélon in generale cfr. A.Chérel, Fénélon au XVIII siècle (1715-1810). Son prestige, son influence, Paris, 1917, (l'elencoin appendice è incompleto). Il successo di queste opere non accennò a diminuire nei primidecenni del XIX secolo.
58. Cfr. D. Cantimori, postfazione a Giacobini italiani, vol. I, Bari, 1956, p. 408. Cfr. anche gliappunti di G. Galasso, A proposito della definizione di giacobinismo, in «Atti dell'AccademiaNazionale di Scienze morali e politiche di Napoli», vol. LXXIV, 1963, pp. 32-41.
59. Per una recente sintesi sulla questione della legge agraria durante la Rivoluzione francesecfr. F. Gauthier, Loi agraire, in Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815), 2.Notions-concepts., Paris, 1987, pp. 65-98.
60. Cfr. soprattutto F. Venturi, Settecento riformatore, vol. II, La Chiesa e la Repubblica entro iloro limiti 1758-1774, Torino,1976.
61. Citato da V.E. Giuntella, in Assemblee, vol. I, p. XXXI.
62. «Non valuto io molto le declamazioni della maggior parte degl'istorici, i quali hanno fatto agara per far concepire pessima idea de' Gracchi, tacciandoli come cittadini torbidi, violenti emossi da talento di perniciose novità ed autori di sedizioni. Scrissero que' dotti quando già eraspenta la repubblica, e, volendosi distruggere per sino la memoria e l'immagine di libertà, eranoproscritte, come delitti, le idee popolari, in tempi ne' quali la vile adulazione e la bassezza eranodi sola moda. [...] A Tiberio Gracco mancarono circostanze favorevoli. Nato in tempicorrottissimi fu riputato pessimo cittadino. La legge sempronia, forse il solo mezzo che rimaneaper salvare la repubblica, perché proposta in tempi infelicissimi accelerò la sua caduta e fu ilsegnale dello spargimento del sangue», F.M. Cacherano di Bricherasio, De' mezzi per introdurreed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione dell'Agro romano, Roma, 1785,parzialmente riprodotto in Illuministi italiani, cit., pp. 601-625 (cit. a p. 601). Sull'opera diCacherano, cfr. anche S. Bordini, Un'ipotesi di razionalizzazione tardo-illuminista: i 'villaggiagrari' della campagna romana, in «Quaderni sul Neoclassico», n. 3 (1975), pp. 64-96.
63. Cfr. Effemeridi letterarie di Roma, n. XI del 1777; i nn. XIV- XVI del 1786 con larecensione dell'opera di F.M. Cacherano di Bricherasio; i nn. XXVIII-XXIX del 1789
sull'Origine della popolazione di San Leucio, e suoi progressi fino al giorno d'oggi colle leggicorrispondenti al buon governo di essa (Napoli, 1789) utopia cristiano-spartana dell'allora re-filosofo Ferdinando IV.
64. Cfr. E. Piscitelli, La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani , Milano, 1958, pp. 53ss. Fabrizio Ruffo era stato Tesoriere generale dal 16 febbraio 1785 al 25 febbraio 1794.
65. Fortunati, 22 ottobre 1795; 18 novembre 1797.
66. Effemeridi Letterarie di Roma,n. I del 7 gennaio 1797. Su Tocci cfr. D. Cantimori, Utopisti eriformatori italiani 1794-1847. Ricerche storiche, Firenze, 1943, pp. 20 ss.
67. Cfr. R. De Felice, Aspetti e momenti della vita economica, cit., p. 25.
68. Riflessioni economiche, politiche e morali sopra il lusso, l'agricoltura, la popolazione, lemanifatture e il commercio dello Stato pontificio, Roma, 1795, parzialmente riprodotte inIlluministi italiani, cit., pp. 685-717.
69. Sulla polemica tra Corona e Vergani cfr. L. Dal Pane, Lo Stato Pontificio e il movimentoriformatore del Settecento, Milano, 1959, pp. 467-489.
70. Seduta XXIX (8 fiorile a. VI); le citazioni sono tratte dal Monitore di Roma, n. XLVIII del16 caldifero a. VI (3 agosto 1798).
71. Assemblee, vol. I, p. 247.
72. Non si può essere completamente d'accordo con Renzo De Felice quando afferma, nel suoimportante saggio, che fu l'invasione napoletana ad aprire gli occhi ai repubblicani romani sullanecessità di una riforma agraria. Se si guarda alla data di pubblicazione della maggior parte degliscritti da lui citati ci si accorge che la questione maturò ben prima, nell'alveo della riflessionepolitica sulla Rivoluzione. Cfr. R. De Felice, Aspetti e momenti della vita economica, cit., pp.167 ss.
73. Nicio Eritreo, Grammatica repubblicana di Nicio Eritreo dedicata al generale in capodell'armata di Roma, Gouvion de Saint-Cyr, (snt), quasi interamente riprodotta in Giacobiniitaliani, cit., pp. 99-154, cit. a pp. 153-154; su Nicio Eritreo cfr. D. Cantimori, Utopisti eriformatori italiani, cit., pp. 83 ss. Nel processo contro Angelo Angelucci (ASR, Giunta diStato, 1799-1800, b. 1, fasc. 9) è allegato un piano di divisione dell'agro pontino, di cui
purtroppo ci restano solo le premesse generali. Secondo R. De Felice, Aspetti e momenti dellavita economica, cit., p. 172, il progetto era collegato alla mozione di Nicola Corona del 21 fiorilea. VI e fu scritto nel 1799. Esso però reca l'indicazione «anno VI» e mostra molte assonanze conle teorie di Nicio Eritreo; potrebbe dunque essere legato all'attività di Angelucci al Ministerodell'Interno nelle prime settimane di governo repubblicano sotto la direzione di Claudio dellaValle, che lo stesso De Felice identifica con Nicio Eritreo (in Italia giacobina, Napoli, 1965, pp.241 ss.). In questo scritto l'età aurea da cui trarre ispirazione è un immaginario Medioevo, dovele comunità locali esercitano il controllo della proprietà comuni.
74. V. Russo, Pensieri politici, Roma, 1798; ristampato in Giacobini italiani, cit., pp. 255-377;cit. a p. 296.
75.Ivi, p. 307-308.
76. Così si esprimeva Mario Pagano alla Società di Agricoltura, Commercio e Arti: «Due sonopure le necessarie operazioni che dobbiamo proporci: una, che nei nostri cittadini nasca questonuovo spirito, quest'amore dell'agricoltura e delle arti: l'altra, che abbiano essi necessari mezzida porre in opra la volontà.[...] Io non oso profferire il nome di un'odiosa e perturbatrice leggeagraria. Odo intonarmi all'orecchio: Come si possono in un democratico governo garantire idiritti dell'uomo con ledere le proprietà de' cittadini? Le convulsive leggi agrarie non venneroaltrimenti nelle antiche repubbliche incise ne' pubblici bronzi, che in sanguinosi caratteri. IGracchi, i quali ne pronunziarono in questo suolo le prime voci, furono vittime della violenza,divisero in partiti la repubblica, che poi, debole e fiaccata, fu preda di un despota... Io non vogliorispondere, come altri per avventura farebbe, che noi sovente ci facciamo illudere da' Nomi, chechiamiamo proprietà l'usurpazione e diritto la violazione di ogni diritto; che le vaste possessionesovente non sono che l'aggregato di tanti patrimoni, de' quali la violenza ha spogliato i deboli.L'urtare contro all'interesse armato dall'opinione, sostenuto dalla fallacia legale, è semprepericoloso. Contro degl'invecchiati mali adopriamo delle blande medicine», cioè l'abolizione deitestamenti come aveva già proposto Russo. Riprodotto in D. Cantimori - R. De Felice (a curadi), Giacobini italiani, vol. II, Bari, 1964, pp. 367- 376.
77. S.C. Labrousse Courcelle, Discours prononcés par la citoyenne Courcelle Labrousse auClub de Rome, dans les mois de floréal de l'an VI, faits et revus par elle même, Roma, [sd], pp.77 ss. e 119 ss. Sulla figura della Labrousse cfr. R. De Felice, Note e ricerche sugli 'Illuminati' esul misticismo rivoluzionario (1789-1800), Roma, 1960.
78. C. D'Alos, Discorso II sull'occupazione degli oziosi del cittadino Cristofaro D'Alos,pronunziato nel Circolo Costituzionale il giorno 10 germile an. VI dell'Era repubblicana (v. s.30 marzo 1798), [snt].
79. P.P. Baccini, Ragionamento politico sopra la rivoluzione di Roma del cittadino Pietro PaoloBaccini. Roma, anno I della Repullila (sic), pp. 55 ss.
80. Cfr. Monitore di Roma, n. LVII del 16 fruttifero a. VI (2 settembre 1798); e supplemento aln. XII del 9 brumale a. VII (30 ottobre 1798), che si ricollega al dibattito sulla rescissione degliaffitti agricoli.
81. Il redattore del Banditore, Michele Mallio, è personaggio per molti aspetti ambiguo: nato inprovincia di Ascoli nel 1756, Mallio andò a Roma per completare gli studi di legge; poeta escrittore, fu segretario di Tiberio Soderini uditore della S. Rota. Allo scoppio della Rivoluzionefu l'iniziatore ed il principale redattore di uno dei più accesi fogli antirivoluzionari, gli Annali diRoma, attività che proseguì tranquillamente con l'avvento del governo repubblicano con Ilbanditore della Verità. Sala lo liquida con una battuta: «colui, che come scrisse per fame gliAnnali di Roma, così ora per far quattrini ha intrapreso questo nuovo lavoro» (vol. I, p. 85) Lecose sono forse più sfumate: Mallio è in molti sensi rappresentativo di quel sottobosco diprofessionisti intellettuali che dalla provincia affluivano a Roma in cerca di un impiego e dellafama letteraria; egli esprimeva anche parzialmente le esigenze di quegli intellettuali dirinnovamento culturale, (che nel suo caso si concentravano sulla riforma del teatro, cfr. Annali diRoma, gennaio 1790), che non sempre Roma riusciva a soddisfare; a quegli stessi, la Repubblicasembrò forse offrire una buona occasione per mettere a frutto il proprio talento.
82. Il banditore della Verità, nn. XXXVI e XXXVII.
83. M. Mallio, Agide, tragedia di Michele Mallio, Roma, a. VI. Fu rappresentata al teatroArgentina il 29 luglio 1798.
84. Cfr. Plut, T. Gracco, 9.
85. Agide, cit., III, 6.
86. P. Roppoli, Discorso V sopra i perniciosi progressi del lusso del cittadino Pietro Roppolipronunziato nel Circolo Costituzionale il giorno 13 germile a,. VI dell'era Repubblicana (v. S. 2aprile 1798), [snt].
87. G. Jacoucci, Discorso III agli amanti del pubblico bene del cittadino Giuseppe Jacouccipronunciato nel Circolo Costituzionale il giorno 11 germile an. VI dell'era repubblicana (v. S.31 marzo 1798) , [snt], in cui chiedeva anche un sistema fiscale progressivo; P.P. Baccini,Progetto del cittadino Pietro Paolo Baccini, prefetto consolare al tribunale d'appello. A tutti i
buoni cittadini della Repubblica Romana, [snt]. Che gli stipendi dei funzionari fossero tenui,«dovendosi ognuno affaticare più per il comun bene dei Cittadini, che per il proprio, come ànnopratticato i nostri Antichi Repubblicani», sosteneva B. Conversi, 10 marzo anno I dellaRepubblica Romana una e indivisibile. Nuove idee di Economia Politica per estinguere il debitodello Stato, e far rifiorire il credito pubblico esposte dal Cittadino Conversi Bernardino, Roma,1798, anno I della Repubblica romana.
88. Cfr. M. Formica, Forme di sociabilità politica nella Repubblica romana del 1798, in«Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 1, 1992, pp. 73-88.
89. Si ricorderà come l'episodio di Scipione a Cartagena narrato da Valerio Massimo, ( IV, iii, 1)e il comportamento stoico dell'autocontrollo vennero reinterpretati dalla tradizione cristiana neitermini della continenza, ed il tema ebbe enorme successo anche nel teatro di collegio gesuita.Scipione è l'esempio migliore di un eroe della virtù, un cattolico in costume romano. Per ilrepertorio iconografico cfr. A. Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zurIkonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, Budapest, 1974 II, vol. II, pp. 424 ss. e per unrepertorio del teatro musicale F. Stieger, Opernlexikon, Tützing, 1975, II, pp. 1106; le variantipittoriche di questo episodio sono discusse da R. Rosemblum, op. cit., pp. 91 ss.
90. Maestro di un tale uso della retorica dell'antico fu l'ambasciatore Bertolio: cfr. per esempiol'invito alle contribuzioni volontarie in Collezione, vol. IV, p. 17.
91. Piano per le scuole primarie della Repubblica Romana, snt [Roma, 1798]. Per i membridella commissione cfr. Monitore di Roma, n. LX del 19 messifero a. VI (7 luglio 1798).
92. Cfr. Monitore di Roma, n. III del 9 germile a. VII.
93. Monitore di Roma, n. XXVIII del 7 pratile a. VI; Sala, 31 luglio 1798, vol. II, p. 58.
94. Lettera pubblicata da G. Sforza, Ennio Quirino Visconti e la sua famiglia, Genova, 1923, p.128-129.
95. Sala, 26 agosto 1798, vol. II, p. 112.
96. Già le precedenti vicende biografiche di Visconti (di cui si ricorderà certamente il rifiuto diintraprendere la carriera religiosa) lasciano intravedere la tensione tra l'insofferenza verso ilgoverno ecclesiastico (cfr. anche il suo «Stato della Romana letteratura», in Due discorsi ineditidi Ennio Quirino Visconti con alcune sue lettere e con altre a lui scritte che ora per la prima
volta vengono pubblicate, Milano, 1841, significativamente composto per quell'inquietoaristocratico che fu Sigismondo Chigi), e l'inserimento nel mondo accademico e cortigiano dicui egli era esponente centrale. Per quanto riguarda l'esperienza repubblicana, poco chiarerestano le vere responsabilità di Visconti nella conduzione della politica monetaria dellaRepubblica, e la sua posizione nella crisi di settembre 1798 in cui venne destituito anche inseguito alle Litanie di Pasquinocomposte contro il Consolato da Lampredi. Dopo ladestituzione, Visconti si ripresentò all'Istituto nazionale, ma N. Corona ne chiese la sospensione(cfr. Monitore di Roma, n. II del 27 settembre 1798). In un'edizione di Lugano, 1849 delle Opereinedite e rare di Vincenzo Monti curata da Urbano Lampredi, si leggono però alcune noteautobiografiche del curatore sull'esperienza repubblicana e sul rapporto Lampredi-Visconti,forse viziate dalla reverenza per un personaggio ormai famoso: «[...] Trattandosi di pubblicafortuna, era un dovere, parmi, il non mostrarsi complice nel delitto del più forte. [...] Ho taciuto,è vero, intorno ad un mio articolo politico nel Monitore Romano, apertamente ingiurioso omordace, nel quale fu assalito da me, o piuttosto dalla mia arma favorita (l'ironia) il più grande eprofondo archeologo del nostro secolo Ennio Quirino Visconti; ma tutti gli Utopisti che nelfamoso 99 traghettarono da Civitavecchia a Marsiglia con me, e con quel valent'uomo, viderobene, che durante il tragitto noi fummo inseparabili, e ch'io stava leggendo il mio Orazio,giovandomi di molte osservazioni e note del Visconti preziosissime» (pp. 78-79).
97. Monitore di Roma, n. XXVIII, cit.
98. Cfr. D. Armando, art. cit., e l'altro suo contributo Gli scolopi nelle istituzioni dellaRepubblica Romana del 1798-1799, in «Studi Romani», a. XL, nn. 1-2, 1992, pp. 37-55.
99. Cfr. Tribunato, seduta XXII del 28 germile a. VI
100. A. Muscella, Piano d'istruzione del Cittadino Alberto Muscella, Roma, 1798, anno I dellaRepubblica romana. Alla caduta della Repubblica Muscella ritrattò.
101. Allocuzione ai giovani romani, [snt].
102. G. Vera, Inalzandosi nel Collegio romano l'albero della libertà per ordine e spese delcittadino Toriglioni ministro dell'Interno, [snt].
103. F. Battistini, Discorso recitato dal cittadino Francesco Battistini professore di umanelettere nel Collegio Romano, essendovi ivi eretto l'albero della libertà, Roma, 1798.
104. G. Mangiatordi, Il giovinetto istruito per la democrazia da un cattolico democratico, con
una lettera in fine del Generale Bonaparte. Opuscolo del Cittadino Giuseppe Mangiatordiprofessore di Giurisprudenza nella Sapienza, Roma, 1798, anno I della Repubblica romana.
105. Cfr. per esempio F. Brunetti, Discorso pronunciato dal Cittadino Avvocato Brunetti alPopolo Romano in occasione di un'innalzamento d'albero di libertà, in Collezione, vol. I, p. 21;G.B. Agretti, Catechismo repubblicano, cit.; P. Cristallini, Istruzione che fa il cittadinoCristallini Pietro a suoi concittadini. A 25 fiorile anno primo della Repubblica Romana, Roma,1798; La religione cattolica amica della Democrazia. Istruzione d'un teologo filantropo al Cleroe al popolo romano, Perugia, 1798; A. Cometi, Discorso del cittadino Alessio Cometi, [snt].Sulla questione ancora aperta del rapporto tra cattolici e istituzioni repubblicane cfr. V.E.Giuntella (a cura di), La religione amica della democrazia. I cattolici democratici nel Trienniorivoluzionario (1796-1799), Roma, 1990; M. Rosa (a cura di), Cattolicesimo e lumi nelSettecento italiano, Roma, 1981; ipotesi diverse avanza R. De Felice, L'evangelismo giacobino el'abate Claudio Della Valle, in Italia Giacobina, cit., pp. 169-287. In generale rimando allarecente sintesi Pratiques religieuses, mentalités et spiritualités dans l'Europe révolutionnaire(1770-1820), actes du Colloque, Chantilly 27-29 nov. 1986, Turnhout, [1988]; per Roma, L.Fiorani, Città religiosa e città rivoluzionaria (1789-1799), in «Ricerche per la storia religiosa diRoma», 9, 1992, pp. 65-154, oltre ai vari contributi ivi contenuti.
106. Nicio Eritreo, Grammatica repubblicana, cit., pp. 123-124.
107. V. Russo, Pensieri politici, ed. cit., p. 289 e pp. 322 ss.; cfr. anche l'articolo di «Istruzionepubblica» sul Monitore di Roma, n. X del 3 brumale a. VII (24 ottobre 1798); nel n. V del 7ottobre il richiamo alla situazione delle università italiane era anche una larvata critica aiFrancesi, i quali, non migliorando l'istruzione pubblica, impedivano agli italiani di esercitare lapropria sovranità.
108. C. D'Alos, Discorso I sulla pubblica educazione del cittadino d'Alos pronunziato nelCircolo Costituzionale il giorno 8 germile an. VI dell'Era repubblicana (v. S . 28 marzo 1798),[snt].
109. Cfr. le osservazioni di M.I. Finley sulla democrazia ateniese in La democrazia degli antichie dei moderni, Roma-Bari,1973.
110. Cfr. Il banditore della Verità, n. LXXXIII del 1 pratile a. VI (21 maggio 1798). Le lezionierano così ripartite: D'Alos: commercio ed economia; Roppoli: filosofia morale; Russo:Costituzione; Viviani: storia; Jacoucci: agronomia; Tommaso Lamberti: diritto naturale; Vaccari:facoltà dell'uomo.
111. Il banditore della Verità, n. XXIV del 15 marzo 1798.
112. G. Liverzani, Riflessioni sopra la condotta dei Club ben spesso opposta alla Democrazia eNuovo Piano di riformarli per coloro che ne credono indispensabile l'erezione. Del cittadinoGiuseppe Liverzani romano, [Roma] anno I della Repubblica. La risposta di Mallio provocò unaltro intervento di Liverzani: Il Banditore della bugia opposto al Banditore della verità delMallio, ossia Risposta alle sciocche, e calunniose ciarle, che si leggono sul giornale num. 42contro le Riflessioni su i Club; e prospetto della condotta del Mallio nel passato governo, e dellapresente, da servire d'istruzione agli associati di detto giornale. Del citadino GiuseppeLiverzani, Roma, 1798, I, repubblicano, che, come annuncia il titolo, rinfacciava a Mallio il suopassato zelo controrivoluzionario.
113. Cfr. Il banditore della Verità, n. XLII del 14 germile a. VI (3 aprile 1798).
114. Mallio fu particolarmente insistente su questo tema del contributo femminile, rifiutando ilprototipo sentimentale-domestico per un ideale di fermezza guerriera lacedemone; cfr. Ilbanditore della Verità , nn. XLIV del 16 germile a. VI; CVI del 28 pratile a. VI; CXVI del 10messifero a. VI; CXXXVIII del 6 termifero a. VI.
115. Per qualche cenno autobiografico, cfr. la breve presentazione in Biografie autografe edinedite di illustri italiani di questo secolo pubblicate daD[emetrio Emanuele] Diamillo, Torino,1853, pp. 197-207, molto reticente sugli anni repubblicani.
116. Cfr. per esempio Monitore di Roma, nn. II e III del 24 e 28 febbraio 1798; n. V del 7 marzo1798; n. XLIV del 3 caldifero a. VI , in cui si serve tra l'altro del ricordo di Socrate per ricusarele troppo facili accuse di empietà e ateismo. Secondo Valentinelli, p. 225, Lampredi fu ilpromotore di uno dei primi circoli politici della Repubblica: «Lo scolopio Lampredi aprì uncongresso ossia club in casa d'una celebre democratica titolata, il suo scopo era la censuramordace dei buoni costumi e della vera religione»; la «celebre democratica titolata» non credosia altri che la principessa Giuliana Santacroce.
117. Monitore di Roma, n. XIX del 25 aprile 1798.
118. Cfr. Monitore di Roma, n. XVII del 18 aprile 1798.
119. Cfr. tra tutti il n. LXI del 29 fruttifero a. VI (15 settembre 1798), che contribuì alla cadutadel primo consolato. «Rappresentanti... tremate», scriveva Lampredi, «La nostra penna sicangerà ben tosto nel tremendo pugnale di Bruto, noi vi trafiggeremo il petto, e la nostra voce
diventerà il fragoroso tuono della vendetta Repubblicana».
120. Cfr. per esempio il dialogo di Cicerone, Lucullo e Giusti negli Elisi, nel n. XL del 19messifero a. VI, dove i personaggi della storia romana sono gli strumenti della critica. L'articoloforse più eloquente sulla questione dei funzionari subalterni è quello contenuto nel n. LXII delIII complementare a. VI.
121. Cfr. soprattutto i nn. XLVII del 13 caldifero a. VI; LII del 29 caldifero a. VI, Un esempiodel ragionamento è fornito da Michelangelo Vassalli, di Macerata, di cui sa solo ciò che eglistesso rivela nella lettera introduttiva del suo Primo discorso filosofico-politico-morale su laprosperità e la caduta delle nazioni, ove si dimostra qual'è il mezzo di render grande unarepubblica ed un impero e viceversa qual'è la causa della decadenza e ruina d'un popolo delcittadino Michelangelo Vassalli dedicato ai Consoli della Repubblica romana, Macerata, l'annoVII dell'Era repubblicana. Nelle 64 pagine che formano l'opuscolo, Vassalli si sforza didimostrare che l'unico principio della vita politica è la virtù, e che solo dalla virtù dipendono lesorti degli Stati. Poi, però, volendo dimostrare che «la virtù e il vizio non d'altro generalmenteparlando possono avere un efficacia e universale Sanzione, che dalla persuasione di un Dio, edella vita futura», ricorreva ad esempi (i Legislatori delle origini: Solone, Licurgo, Numa,Minosse) ed autori antichi (e a Rousseau e Montesquieu), e si pronunciava piuttosto per unareligione civile, con l'unico dogma dell'immortalità dell'anima e dell'esistenza di Dio. Cfr. ancheG. Mauri, Alle supreme autorità, ai novelli giudici della Repubblica Romana. Ragionamento delCittadino Gregorio Mauri, Roma, 1798.
122. Cfr. D. Cantimori, Vincenzio Russo, il 'Circolo Costituzionale' a Roma nel 1798, e laquestione della tolleranza religiosa, in «Annali della R. Scuola Superiore di Pisa (Lettere,Storia, Filosofia)», s. II, vol. XI (1941), pp. 179-200.
123. Cfr. le osservazioni di C. Mossé, op. cit., pp. 125 ss. Sulla teofilantropia, A. Mathiez, Latéophilantrophie et le culte décadaire, Paris, 1904. Da notare incidentalmente che secondoMathiez aveva aderito alla teofilantropia Saint-Martin, segretario della Commissione Francese aRoma, e anche quel Jullien fils che fu il tramite tra il robespierrismo e molti patrioti italiani.
124. Sulle feste nella Repubblica romana cfr. A. Pinelli, La Rivoluzione imposta, o della naturadell'entusiasmo. Fenomenologia della festa nella Roma Giacobina, in «Quaderni sulNeoclassico», n. 4, 1978, pp. 97-136; Il teatro e la festa. Lo spettacolo a Roma tra Papato eRivoluzione, catalogo della mostra, Roma 13 giugno-30 settembre 1989, Roma, 1989
125. M. Ozouf, La festa rivoluzionaria (1789-1799), Bologna, 1982, pp. 409 ss.
126. D. Cantimori, Vincenzio Russo, il Circolo Costituzionale, cit.
127. Antonio Franceschi era un medico romagnolo stabilitosi a Narni. Alla proclamazione dellaRepubblica egli fu membro della municipalità provvisoria, poi prefetto consolare, e infine fuchiamato a Roma al ministero, forse grazie agli Scolopi che a Narni avevano un collegio. Eglichiamò alla direzione della ripartizione per l'istruzione pubblica e i culti Claudio Della Valle,sotto la cui diretta ispirazione pubblicò le due circolari del 7 febbraio 1799 (cfr. Collezione, vol.III, 378 e 379, pp. 463 ss.) che in sostanza stabilivano il controllo diretto degli organi municipalisul culto e sui suoi ministri, realizzando in parte il progetto originario di Della Valle perl'elezione popolare del parroco, già respinto nell'aprile 1798 dal Tribunato. I due ministri siimpegnarono a fondo anche sulla questione del giuramento, cosa di cui Franceschi si pentì nellasua Ritrattazione del dottore Antonio Franceschi stato Ministro dell'Interno nella sedicenteRepubblica Romana, [snt]. Su questa questione cfr. A. Cretoni, op. cit., pp. 245 ss. Ringrazio ildott. D. Armando per le notizie sulla provenienza di Franceschi.
128. Sala, 18 aprile 1799, vol. III, p. 15.
129. Fortunati, 18 marzo 1799.
130. Valentinelli, pp. 266-267.
131. Cfr. le missive di Bertolio pubblicate da V.E. Giuntella, in Gli esuli romani in Francia allavigilia del 18 Brumaio, in «Archivio della Società romana di Storia patria», a. LXXVI (1953), s.III, vol. VII, pp. 225-239; i quattro erano colpevoli di aver fatto parte del «parti tribunien»durante la crisi costituzionale dell'estate 1799.
132. Collezione, vol. III, 344, proclama del 4 piovoso a. VII. Tornava sul tema annunciando lafesta della Rigenerazione, il 26 piovoso a. VII, nel giorno in cui i cittadini romani avevanoriconquistato «il diritto di portare il Nome Romano», risorgendo alla «morale esistenza», cfr.Collezione, vol. III, 403; e ancora, dopo la Festa, si congratulò con la Guardia nazionale, i cuimiliti «emoli essi de' nostri Antenati dimostrano non essere ancora estinti fra noi i germi degliEroi, e dei sostegni della Repubblica», cfr. Collezione, vol. III, 407.
133. Collezione, vol. IV, 29.
134. Monitore, 9 piovoso a. VII. Su questo aspetto cfr. A. Cretoni, op. cit., pp.176 ss.
135. Biblioteca Angelica, Roma, Archivio dell'Arcadia, Atti arcadici, vol. 7, ff. 91-93. Nel
piovoso a. VII Martelli spedì una biglietto ai pastori d'Arcadia, che cominciava così: «Le musenate e cresciute nel suolo della libertà sembra che siano di lor natura stessa destinate a trattarargomenti Repubblicani. Gl'inni di Tirteo presso i Greci, quello de' Marsigliesi presso i Gallihanno infiammato i cuori giovanili per sacrificare alla Patria nella battaglia la loro stessaesistenza. Degeneri noi dalle antiche e recenti istituzioni Repubblicane, snerviamo il coraggiodei giovani, con assuefarli a cantar gli amori di Fille, o a corromperne lo spirito, ed il buon sensofra i deliri, e i sogni imbecilli del fanatismo». Il ministro chiedeva agli Arcadi, tra l'altro, dicelebrare l'anniversario della morte di Luigi XVI.
136. Si pensi alla festa dell'innalzamento dell'Albero della libertà a piazza del Popolo,organizzata da alcuni patrioti a loro spese (relazione nella Gazzetta di Roma del 5 fruttifero a.VI, 22 agosto 1798), o alla festa in onore di Bruto la cui Relazione di una festa patriottica adonor di Bruto nel Collegio Nazareno, [snt], ci trasmette l'esaltazione di giovani cresciuti nelculto della tradizione classica.
137. Festa dell'abbruciamento del libro d'oro, processi del S. Ufficio, e de' Patriotti progettatadal cittadino Pietro Guerrini, ed eseguita dal cittadino Gio. Battista Comolli scultore, Roma,[sd]. Guerrini fece parte della Società degli Emuli di Bruto, fu commissario alle contribuzioninei luoghi pii e membro dell'Alta Pretura. La festa si svolse a Piazza di Spagna, dove G.B.Comolli aveva preparato una complessa struttura piramidale che doveva essere arsa dal fuococon grande fumo e lasciar vedere un gruppo allegorico rappresentante la Verità in atto dispargere i suoi raggi sulle Repubbliche francese e romana. Ogni parte della macchina eradecorata con complesse composizioni allegoriche. Cfr. il piano della festa in Collezione, vol. II,pp. 309-321. Francesco Piranesi bruciò la patente di cavaliere, Francesco Santacroce eFrancesco Borghese l'albero genealogico delle loro famiglie, e Barberi cambiò formalmente ilsuo nome in quello dell'ateniese Tisifonte. Davanti al rogo si ballò poi la carmagnola. Cfr. Sala,vol. II, p. 33; Galimberti, 17 luglio 1798.
138.V. Ondedei, Discorso VI sopra lo stoicismo del cittadino avvocato Ondedeipronunziato nelCircolo Costituzionale il giorno 30 germile an. VI dell'Era Repubblicana (v. s. 19 aprile 1798),Roma, [s.d].
139. Monitore di Roma, n. XXVII del 4 pratile a. VI.
140. Un episodio di generosità antica, la donazione dei gioielli delle donne romane per coprire ilvoto di Camillo per la vittoria su Veio (Plut., Camil., 10) era già stato il modello per unaconcreta azione di patriottismo rivoluzionario, quando nel 1789 alcune cittadine francesiavevano offerto i propri gioielli all'Assemblea Nazionale. Cfr. R. Rosemblum, op. cit., pp. 114ss.
141. Monitore di Roma, n. II del 6 vendemmiale a. VII.
142. Monitore di Roma, n. XVI del 14 aprile 1798.
143. Sala, vol. I, p. 144.
144. Per la Francia cfr. J. Bouineau, op. cit., pp. 51 ss.
145. Per la Francia cfr. le osservazioni M. Vovelle, La mentalità rivoluzionaria.Società ementalità durante la Rivoluzione francese, Roma-Bari, 1987, pp. 125 ss. Sull'importanza delleraccolte di atti patriottici e virtuosi, cfr. Ph. Goujard, Une notion-concept en construction:l'heroisme révolutionnaire, in Dictionnaire des usage socio-politiques, cit., pp. 9-23.
146. ASR, Giunta di Stato, b. 14, fasc. 190. Francesco Canali era nato nel 1776; a Rieti avevafrequentato prima dell'arrivo dei Francesi F. Bisiotti, futuro redattore del Tribunato, e a Romaaveva partecipato al tentativi insurrezionali del 1797. Durante la Repubblica, aveva frequentatoil Circolo costituzionale.
147. Monitore di Roma, n. II, 6 germile a. VII.
148. [Diario romano], Museo centrale del Risorgimento, c. 27v, citato da A. Cretoni, op. cit., p.151. Nel Cod. Vat. Ferraioli 910, f. 103 presso la BAV è conservato il prospetto del battaglionede Carolis, sezione Pompeo della Guardia nazionale sedentaria, capitanato da Filippo AurelioVisconti, fratello di Ennio Quirino. Il battaglione contava in tutto 62 volontari: sonorappresentate tutte le attività artigianali.
149. Cfr. Collezione, vol. III, pp. 301.
150. Cfr. Galimberti, 3 giugno 1798. Il Bona venne poi esiliato dalla Giunta di Stato. Purtopponon rimangono carte del suo processo, tranne le interessanti notizie che si traggono dal fasc.235, b. 17, registro delle lettere, ff. 323 ss. Il caso di Bona fu infatti oggetto di un conflitto dicompetenze tra la Giunta e il Delegato apostolico. Nella b. 4, fasc. 75 ci sono invece le carte delprocesso relativo ad un congiunto di Bartolomeo, Paolo, forse suo fratello, che dopo essere statoesattore per la municipalità di Marino, si era rifugiato a Roma per sfuggire all'insorgenza.
151. Collezione, vol. II, pp. 80 ss.
152. Sala, 4 giugno 1798, vol. I, p. 246.
153. Sala, 12 luglio 1798, vol. II, pp. 111-112. Un certo Ilari, in un suo Discorso recitato dalcittadino Ilari in occasione di un pranzo fatto dall'uffizialità della sezzione della Subburra il dì27 fruttifero anno VI repubblicano, [snt], invitava gli ufficiali a prendere come esempi Camillo,gli Orazi, Muzio, e l'«indefesso, amorevolissimo» Generale Piranesi.
154. ASR, Giunta di Stato 1799-1800, b. 16, fasc. 231.
155. Cfr. Monitore di Roma, n. XXII del 28 glaciale 1798.
156. BAV, Cod. Vat. Lat. 10629, c. 148.
157. Cfr. Fortunati, 25 settembre 1799.
158. Cfr. Galimberti, 17 agosto 1798.
159. Sala, 26 settembre 1798, vol. II, p. 173.
160. ASR, Giunta di Stato, b. 16, fasc. 231.
161. Fortunati, 19 novembre 1798.
162. Dopo la riabilitazione politica dei Girondini, anche le versioni incise della loro mortevolontaria circolarono ampiamente nell'Europa rivoluzionaria, fino alla grande serie incisa daBerthault per i Tableaux historiques de la Révolution Française. Cfr. M. Vovelle, (éd.), LaRévolution française. Images et récit, Paris, 1989, vol. V, pp. 314 ss.
163. ASR, Giunta di Stato 1799-1800, rispettivamente b. 9, fasc. 142, parte I, e b. 14, fasc. 184,dove Bonelli viene giudicato francamente «un mostro» a causa del suo aspetto. Si incontraancora il caso di Baldassarre Botti, fasc. 90 e fasc. 177. Vestivano «alla montanara» ancheGiuseppe Fidanza, curiale (b. 15, fasc. 203), Agostino Guerrini, droghiere (b. 1, fasc. 1),Antonio Lozzano (b. 15, fasc. 202), e a Palombara Luigi Egidi (b. 16, fasc. 219). Capelli «allaBrutus» portava anche Mario Pagano (v. il ritratto in La rivoluzione napoletana del 1799illustrata con ritratti, vedute, autografi ed altri documenti figurativi e grafici del tempo, Napoli,1899, rist. Napoli, 1969, tav. XXV).
164. Cfr. Monitore di Roma, n. LIV del 6 fruttifero a. VI.
165. Abbiamo già visto i giovani Visconti e Mutarelli portarlo, così il curiale Carlo Caterini(ASR, Giunta di Sato 1799-1800, b. 3, fasc. 34). Verri annota in proposito: «Taluno de' principiromani, lasciando ogni fasto, girava con la berretta in capo e le vesti a foggia degli sbracati diFrancia, accomunandosi alla plebe, con lei bevendo e motteggiando per le vie e nelle taverne»,cit. da A. Cretoni, op. cit., p. 133.
166. Nelle carte della Giunta di Stato ne abbiamo notizia per Francesco Pierelli, (b. 13, fasc.169), Vincenzo Greco (b. 15, fasc. 203), Raffaele Coraccini (b. 12, fasc. 157).
167. Cfr. Sala, 24 febbraio 1798, vol. I, p. 57.
168. Sala, vol II, p. 28.
169. Gabinetto nazionale delle stampe, Roma, nn. inv. 50180 e 13628.
170. Sala, vol. III, p. 116.
















































![S. Bettini, "Giacomo Ranuzzi, Progetto per San Petronio" [2001]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313c5895cba183dbf073f9d/s-bettini-giacomo-ranuzzi-progetto-per-san-petronio-2001.jpg)