Principi di semio-design. Forme dell’innovazione e teoria del progetto
Transcript of Principi di semio-design. Forme dell’innovazione e teoria del progetto
No. 106/2010
Principi di semio-design. Forme dell’innovazione e teoria del progetto. Dario Mangano e Gianfranco Marrone UNIVERSITÀ DI PALERMO L’innovazione è un espressione centrale nell’ambito del design, che è stata per anni pervasa da una certa ambiguità concettuale. Innovazione è creazione di nuove configurazioni, ma anche distruzione di quelle pre-esistenti che perdono il loro significato; per questo motivo non può essere considerata dal mero punto di vista tecnologico e fisico. Attraverso e grazie alla riflessione semiotica diventa possibile identificare e chiarire i processi attraverso i quali si arriva alle nuove forme di design e a creare un modello dei processi di innovazione che ne spieghi le differenze interne, ma anche e soprattutto le dinamiche trasformative.
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
2
1. Trovate, pratiche, invenzioni1 Recentemente, in occasione della festa di San Valentino del 14 febbraio, Perugina ha proposto sul mercato i suoi celebri “baci” in un tubo serrato con catenaccio e chiavi al seguito; oppure i cioccolatini erano stipati dentro un contenitore plastico a forma di chiavistello. Ecco un’idea di marketing che fa capo a un progetto di design. Il quale a sua volta fa ovvio riferimento a un romanzo e al film relativo, ma anche alle tante pratiche giovanili che quei due testi scimmiottano, nonché alle innumerevoli discussioni giornalistiche, dentro e fuori il web, sugli usi e consumi negli amori adolescenziali. Idea nuova, progetto originale? Difficile esprimersi con certezza, se è vero che, da un lato, la creazione ex nihilo stenta ad affermarsi ormai anche fra i più ostinati seguaci di Ratzinger, e che, d’altro lato, ai lucchetti di Moccia non ci crede più nemmeno un dodicenne di provincia. Delle due nessuna: sappiamo bene che l’innovazione non è mai fine a se stessa ma va misurata sempre e comunque a partire da precisi contesti, da esplicite regole di pertinenza e da ben individuati obiettivi progettuali; ma al tempo stesso facciamo fatica a credere sino in fondo, come ciclicamente ci viene ripetuto, che tutto sia stato detto e già stato scritto, di modo che l’unica forma di originalità sta dalle parti della banalità mal celata. Vediamo perciò altri casi di innovazione progettuale, molto diversi fra loro, che prendono comunque spunto da pratiche d’uso ‘dal basso’, per reinventarle, codificarle, istituzionalizzarle. Nei Collegi studenteschi di Urbino progettati da Giancarlo De Carlo i percorsi sono infiniti, quasi labirintici: stanze, aule, mense, bar e sale comuni si possono raggiungere da più parti, salendo e scendendo le scale, attraversando ballatoi, percorrendo vialetti, transitando in corridoi d’ogni larghezza e lunghezza. Eppure, molti degli utilizzatori di quei luoghi hanno preferito calpestare le aiuole per trovare varchi alternativi, risparmiando qualche metro, rompendo schematismi di comportamento più o meno coscienti. Così, a poco a poco l’erba è andata via, e si sono formati alcuni sentieri in terra battuta che, per quanto talvolta scoscesi, hanno invitato ulteriori passanti a calpestarli. Finché qualcuno dell’amministrazione non ha deciso di ammattonarli, quei sentieri, rendendo più comodo il cammino ma indirettamente autorizzando il calpestio delle aiuole. Da qualche anno a questa parte le edicole dei giornali sono stipate sino all’inverosimile, e i quotidiani hanno finito per diventare più una silente giustificazione della loro esistenza che non un prodotto in vendita: libri, dischi, film, cd musicali, giocattoli e quant’altro era dapprima offerto come straordinario allegato a giornali e riviste è diventata da tempo merce a sé stante. Finché Mondadori non ha deciso di lanciare per franchising in tutto il territorio Edicolé, una catena di edicole/ librerie/discherie/giocattolerie etc. (manca ancora il nome comune che le designi) che ha trasformato uno stato di fatto in una situazione di diritto, con tanto di marchio registrato e filiera di punti vendita. E sembra che altri grossi distributori stiano tentando la medesima strada. Gli esempi, come sarà chiaro, potrebbero moltiplicarsi, allargando sempre di più l’orizzonte dello sguardo: si pensi ai centri commerciali, che da serie di negozi sono diventati punti di ritrovo; alla moda di strada ripresa dai grandi stilisti. Insomma, 1 Sono redatti da Mangano i paragrafi 2 e 3; da Marrone il paragrafo 1.
ticonzero No. 106
3
viene da pensare che questo tipo di dell’invenzione, questa forma del progetto sia la norma piuttosto che l’eccezione. E in questo la linguistica e la semiotica possono venirci in aiuto. La semiotica? Ancora lei? Quella dei segni e dei codici, dei lessici e dei segnali? Non avevamo da tempo capito che i modelli linguistici e le metafore strutturali ingabbiano il dinamismo della cultura e delle società? Ma ovviamente non è di ciò che stiamo parlando, soprattutto quando proponiamo questa prospettiva di studio come riflessione pertinente per una teoria del progetto e dell’innovazione nel design. Un lungo giro di discorso sarà allora necessario per introdurne il senso e spiegarne l’efficacia.
2. Verso l’innovazione Il concetto di innovazione gode di un’indiscussa centralità nell’ambito del design. L’una e l’altro sembrano essere collegati in modo talmente stretto da finire talvolta per coincidere: c’è innovazione dove c’è design e viceversa. A fronte di una tale importanza, tuttavia, la riflessione che si è prodotta intorno a questo concetto, al di là di alcuni contributi specifici, è stata caratterizzata da una certa vaghezza. L’innovazione passa come un’ovvietà, come qualcosa che sappiamo riconoscere intuitivamente quando la vediamo e che dunque il progettista può perseguire facendo riferimento al buon senso accoppiato a una particolare sensibilità: scatola nera insondabile che riduce a poco o nulla le possibilità di pervenire a una formulazione teorica o a un metodo che consenta un approccio strutturato. O almeno, così è per quegli aspetti che hanno più a che fare con il prodotto, mentre più standardizzabile sembrerebbe essere tutto ciò che riguarda la produzione e la distribuzione, in cui l’efficienza può essere misurata in termini esatti. Ma perché innovare dovrebbe essere così importante? Tenendo da canto questioni filosofiche molto generali riguardanti il senso di nozioni come innovazione, invenzione, creatività, progresso, crescita, sviluppo, linearità e irreversibilità temporale, avanzamento e simili (sulle quali pure un giorno occorrerà soffermarsi con attenzione), i motivi che possiamo individuare sono tanti e a essi corrispondono altrettante peculiarità del processo di innovazione. Cambiano i modelli di vita e con essi ciò che percepiamo come necessario. Da quando si è abbandonato il cavallo per l’automobile e si sono costruite città sempre più grandi, quello che viene definito un bisogno generico di spostamento ha assunto di volta in volta forme diverse, concretizzandosi in bisogni derivati specifici: dall’automobile alla metropolitana, fino ad arrivare alla recente rivoluzione del telelavoro che ha messo in crisi l’intero sistema del terziario. Se da un lato l’innovazione di prodotto è legata a un modo specifico di intendere una certa attività, dall’altro essa ha direttamente a che fare con le caratteristiche dei mercati globalizzati, nei quali essa diventa un fattore chiave di competitività, un’arma per combattere la concorrenza e rimanere sul mercato. Oggi è infatti relativamente facile abbattere i costi delocalizzando la produzione e non ci sono modi efficaci per difendersi dall’imitazione dei propri prodotti, pertanto una delle principali vie per mantenere una quota di mercato costante è rinnovare continuamente la propria offerta mantenendo sempre attivo il processo di innovazione. Il designer, in quanto operatore di tale processo, assume una funzione strategica per l’impresa e non più occasionale, una trasformazione culturale profonda che fa
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
4
parlare oggi di una “cultura del design”. Ma in cosa consiste l’innovazione e come la si può individuare e perseguire? In una cultura del design i suoi confini risultano molto più ampi che nel passato. Come spiegano Celaschi e Deserti (2007, p. 29), “se lo slogan del disegno industriale risiedeva nel rapporto tra forma e funzione, nel design contemporaneo si attesta intorno al rapporto tra consumatore e senso della merce”. Non si tratta dunque soltanto di inventare una sedia più comoda di un’altra, più resistente, più leggera, o anche più economica – ammesso che ci sia mai stato un tempo in cui l’innovazione si potesse misurare solo in questi termini – i confini si allargano molto e lo fanno nella direzione di un territorio infido (almeno all’apparenza) come quello del senso. Innovare significa cambiare il significato di un artefatto, quanto e come questo si possa tradurre in precise variazioni nella forma rimane tutto da capire. Se questo è il design e queste sono le coordinate che regolano i processi di innovazione, come gestirli concretamente? Come, per dirla in termini semplici ma efficaci, farsi venire delle idee che funzionino, in grado di fare presa sui mercati? Le metodologie tradizionali mostrano presto i loro limiti. È facile conoscere le cosiddette esigenze implicite ed esplicite dei consumatori, in quanto essi stessi ne sono consapevoli e possono dunque verbalizzarle, lo è meno avere informazioni su quelle cosiddette attraenti, che sono poi le più importanti per la soddisfazione del cliente ma che rimangono inconsce (Celaschi e Deserti 2007, p. 101). Non possono manifestarsi perché il bene o il servizio cui fanno riferimento non esiste e non può facilmente essere immaginato. Ciò che può fare da propulsore per un processo innovativo dunque è anche ciò che è più difficile da determinare. Come procedere allora? L’unico approccio possibile è quello qualitativo, che ricava nuove possibili vie di sviluppo a partire da un’analisi dell’esistente compiuta integrando gli strumenti del marketing con le variabili tipiche del design (materiali, forme tecnologie etc.). Un lavoro da bricoleur che consiste nel ricavare da ciò che possiamo vedere oggi intorno a noi ciò che sarà domani attraverso collegamenti più o meno arditi. Così, guardando ai tapis roulant si può pensare ad una piscina “monoposto” che funziona sullo stesso principio, facendo muovere l’acqua sotto al nuotatore; oppure dopo aver riflettuto sulle modalità di creazione dei contenuti presenti nel web, immaginarne strumenti software particolarmente intuitivi che consentano agli utenti di crearne e i contenuti diventando loro stessi gli autori di quanto leggeranno/ascolteranno/vedranno (il celebre web 2.0). Ora però, se siamo disposti ad ammettere che è il senso della merce a guidare il design e con esso, per discendenza diretta, il processo innovativo, allora una teoria della significazione può contribuire non solamente a chiarire lo statuto del sistema che ci circonda, ma anche consentirci di individuare nuove vie di sviluppo. Uno spunto importante diventa allora quello che forniva Maldonado già negli anni Settanta quando ne La speranza progettuale esprimeva un pensiero all’apparenza semplice ma carico di conseguenze: “l’innovazione è sempre contro qualcuno” (Maldonado 1970,p. 111). Detto in altri termini, la carica innovativa di un artefatto, il suo valore, viene percepito – e diviene dunque misurabile – in relazione a qualcosa che esisteva precedentemente e che con l’emergere del nuovo perde il suo status. Con questa semplice mossa, ovvero evidenziando la natura polemica del progresso, Maldonado, più o meno consapevole che ne fosse, ha gettato le basi per un approccio al problema dell’innovazione che oggi consideriamo di tipo narrativo. Come insegna la narratologia, infatti, la polemica è il fondamento di ogni storia, sia essa quella che vede protagonista un principe e un drago o quella di qualcuno che
ticonzero No. 106
5
tenta di usare il suo nuovo telefonino. L’innovazione insomma, non può essere percepita come tale se non si manifesta insieme ad una forma di reazione. La formalizzazione teorica che cerchiamo, il tanto desiderato metodo che ci consenta di farci venire delle idee, si basa dunque su un doppio movimento: affinché si manifesti un’innovazione – si realizzi cioè un’ascendenza – qualcos’altro deve subire un destino opposto, quello cioè di decadenza. Situazioni del genere nella storia si sono ripetute di continuo: il motore a scoppio ha scalzato la trazione animale, il web 2.0 sta sostituendo il “vecchio” 1.0, il telefono mobile in pochi anni è riuscito realizzare un’inversione di ruoli con quello domestico e così via. Nasce così l’idea di una profondità enunciativa2 che si applica al sistema degli artefatti con i quali conviviamo e che ci circondano. Come nel giornalismo la notizia emerge quando si staglia su un opportuno sfondo costituito dalla normalità (che assume i suoi connotati proprio grazie a ciò che la trasgredisce), così l’innovazione si manifesta solo in relazione a qualcosa il cui statuto antiquato si pone come tale nel momento stesso in cui viene superato. Facciamo un esempio: quando è stato inventato il Compact Disk, il supporto musicale fino a quel momento più diffuso era il vinile e accanto a questo la cassetta magnetica. Quest’ultima, in particolare, non aveva mai avuto successo come veicolo per la distribuzione della musica, ma come supporto “secondario”, ovvero per incidervi brani che provenivano dai Long Playing. Con il prendere piede dei CD, il vinile ha cominciato a ridurre la sua presenza fino a scomparire del tutto, schiacciato, almeno apparentemente, dalla maggiore qualità sonora ottenibile attraverso il supporto ottico (con particolare riferimento al ben noto fruscio) e dalla sua superiore maneggevolezza (disco più piccolo, meno sensibile alla polvere e ai graffi etc.). Una ascendenza che si realizzava a spese di una decadenza le cui ragioni erano appunto la qualità e la praticità. L’audiocassetta rimase ancora un po’ di tempo in quanto consentiva di creare preziose compilation che tanta presa avevano su potenziali morose e morosi (Mangano, 2009), e comunque solo fino a quando i computer non furono in grado di gestire contenuti multimediali e di incidere nuovi CD assemblando pezzi provenienti da altri. A quel punto, e per un certo tempo, il CD è stato dominatore incontrastato del panorama musicale, l’unico supporto venduto nelle grandi catene musicali, almeno fino a quando non è avvenuta la rivoluzione legata all’Mp3, a Internet e ai lettori multimediali come l’iPod. Ma ancora una volta, la loro ascendenza non è potuta avvenire che insieme ad una discendenza. In questo caso le dimensioni coinvolte sono state quelle della qualità sonora (che con l’Mp3, si sa, non può mai essere superlativa) e ancora una volta la praticità, in quanto la memoria di questi lettori può ospitare migliaia di brani musicali. La particolarità di questa nuovo slancio innovativo sta nel fatto che per una sorta di effetto collaterale ha finito per far recuperare proprio il vecchio supporto in vinile e il giradischi, che infatti stanno tornando a farsi vedere sugli scaffali dei negozi. Giradischi, è bene dirlo, sui quali il design è intervenuto massicciamente rinnovandone le forme (Mangano 2009). Un fenomeno singolare che dimostra come l’innovazione possa prendere le forme di un ritorno al passato quando le condizioni del sistema socio-tecnico sono tali per cui viene ridefinito il sistema di valori nel quale un certo oggetto può esistere. Nel caso specifico, il giradischi torna di moda nel momento in cui la qualità di ascolto viene riconsiderata (e il fruscio diventa non solo tollerabile ma quasi gradito, anche in ragione del suono più “caldo” della sorgente analogica) e il bisogno di interazione 2 Con enunciazione si intende il passaggio da un insieme di virtualità (ad esempio la lingua nella sua interezza) a un oggetto concreto o enunciato (la frase singola così come viene pronunciata dal parlante) . L’enunciato è dunque il risultato di un’enunciazione che diventa uno strumento di mediazione tra un insieme di possibilità e la loro realizzazione [N.d.R.].
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
6
fisica con il “supporto” – del tutto eliminata dall’informatica – recuperato. Per paradossale che possa sembrare, l’innovazione è oggi proprio il vecchio giradischi riveduto e corretto, secondo un modello di recupero che in campi come quello della moda che abbiamo avuto occasione di evocare, non desta alcuna meraviglia. Proprio come nella moda allora, più che parlare di ciò che è attuale, o, mutatis mutandis, innovativo e all’avanguardia, sembra opportuno guardare alle procedure che lo rendono tale. Per dirla con le parole del celebre linguista Roland Barthes, a ciò che rende la moda di moda e dunque a ciò che rende l’innovazione innovativa, trattandosi in entrambi i casi più di un effetto di senso che di una creazione dotata di un qualche tipo di valore assoluto (1967). Più che concentrarsi sul prodotto e su caratteristiche di innovatività presupposte intrinseche e immodificabili, risulta allora utile guardare alle modalità attraverso cui tali caratteri si producono. Ne deriva un approccio profondamente rivoluzionato ai sistemi di artefatti in cui il grado di “attualità” di qualcosa è frutto del modo in cui qualcos’altro lo rende pertinente. In altre parole, ciò che un approccio all’innovazione attento ai processi di costruzione di senso mette in discussione è l’esistenza stessa di ogni artefatto, che viene rivista nei termini di una esistenza semiotica legata al modo in cui ognuno viene reso pertinente all’interno di un più ampio sistema. O, per usare un linguaggio più tecnico, enunciato. Proviamo con un nuovo esempio a capire cosa intendiamo.
3. Il caso dei cellulari La pagina pubblicitaria con la quale è stato lanciato Aura (fig. 1) è uno di quegli esempi di comunicazione che per catturare l’attenzione del lettore crea un mistero. Lo spazio del foglio è ricoperto nella sua totalità da una immagine fotografica che mostra una grande forbice da sarto insieme ad una riga in metallo poggiata su un cartoncino compatto sul quale una matita ha tracciato alcune linee. Quasi all’angolo inferiore destro, in uno spazio lasciato libero dalle carte e significativamente illuminato da un raggio di luce, si trova il piccolo oggetto cromato che è chiaramente il prodotto pubblicizzato. Le sue forme sono quelle di un basso parallelepipedo i cui lati superiore e inferiore sono due perfetti semicerchi. In particolare, il lato superiore segue il profilo di un luccicante quadrante rotondo in vetro, simile a quello di un orologio da tasca, all’interno del quale sono ben leggibili i numeri che individuano le principali ore del giorno. Tutto ci farebbe pensare che si tratti proprio di una “cipolla”, se non fosse che il marchio che ritroviamo impresso sull’oggetto e ripetuto nella parte verbale dell’annuncio è quello di Motorola, il celebre produttore di telefoni cellulari. E infatti, dopo qualche ricerca sul sito internet, puntualmente indicato nella pagina e divenuto ormai sempre più spesso l’approdo al quale veniamo traghettati dalla pubblicità tradizionale, scopriamo trattarsi del primo cellulare-gioiello del famoso marchio.
ticonzero No. 106
7
FIGURE 1 –Annuncio pubblicitario del Motorola Aura FIGURE 2– Annuncio pubblicitario del Tissot Touch Ma come siamo arrivati a questo ibrido? che cosa è diventato il telefono perché si producesse un’innovazione del genere? cosa ne è (e ne sarà) dei gioielli? E degli orologi? È evidente che il modello di Motorola è solo la punta di un iceberg di un processo di innovazione complesso che coinvolge numerosi artefatti ed è al centro di pratiche articolate. Le forme (semiotiche) dell’innovazione sarebbero dunque originate dal modo in cui diverse entità oggettuali contribuiscono a costruire tra loro – ricostruendolo poi continuamente – un insieme coerente di relazioni all’interno del quale è la stessa attività umana a prendere forma. Concentriamoci un attimo sui telefoni cellulari. Essi sono certamente una delle più importanti innovazioni degli ultimi due secoli: offrono la possibilità di parlare con chiunque nel globo ovunque ci si trovi, trasformando profondamente grandezze fondamentali come lo spazio o il tempo. Eppure sarebbe estremamente riduttivo considerare soltanto l’innovazione tecnico-funzionale come misura del reale cambiamento che hanno portato (Marrone 1999). Certo, ci sono voluti enormi progressi per rendere realizzabile un sistema di telefonia mobile come quello esistente, ma ciò che è più interessante per un designer è valutare le trasformazioni sistemiche cui tale innovazione ha dato la stura e che hanno riguardato un numero insospettabilmente ampio di artefatti. Mentre la tecnologia in evoluzione chiedeva forme che la ospitassero e interfacce che consentissero di utilizzarla, un’intera configurazione stava cambiando, facendo sparire certi oggetti e facendone ricomparire altri, aprendo possibilità evolutive, e “contagiando” settori merceologici molto diversi. Ebbene, fenomeni di diffusione dell’innovazione come quelli che si sono verificati nel caso della telefonia mobile possono risultare inspiegabili se considerati da un punto
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
8
di vista unicamente tecnologico. L’evoluzione non ha nulla di lineare. Non soltanto compie ogni tanto dei salti, quelli che Kuhn (1962) chiama cambiamenti di paradigma, ma, come ha spiegato Darwin, non si muove neppure sempre nella stessa direzione: talvolta torna indietro, altre scarta in modo imprevedibile. Osservare questi cambiamenti attraverso la lente della semiotica, e dunque considerando l’esistenza stessa di un artefatto non in senso ontologico, fisico, ma come il prodotto della sua presenza presupposta all’interno di una struttura discorsiva popolata da altri artefatti, aiuta a riconsiderare i processi attraverso cui si perviene a nuove configurazioni socio-tecniche.
FIGURE 3 –Motorola Dynatac 8000 X (1983) FIGURE 4 –Motorola Startac (1996) FIGURE 5– Apple iPhone (2007) Vediamo più nel dettaglio come hanno funzionato storicamente le cose nel mondo dei telefonini. Le forme che per prime accolgono l’innovazione rimandano direttamente a ciò che era già noto: come le prime automobili facevano esplicito riferimento al landò, così i primi telefoni mobili non sono altro che una cornetta dal profilo tradizionale enormemente sviluppata in modo da contenere l’elettronica necessaria al suo funzionamento (fig. 3). Ingombranti e pesanti, questi telefoni erano utilizzati solo da coloro che avevano bisogno di una reperibilità continua, come medici, uomini d’affari, gente che aveva bisogno di comunicare decisioni o pareri in tempo reale e non poteva avvalersi del più leggero e pratico cercapersone che li avrebbe costretti a perder tempo cercando un telefono pubblico. Nasce il telefono cellulare dunque, e di colpo, almeno per coloro che potevano permetterselo – ma come sappiamo ben presto per tutti – il cercapersone non ha più ragione d’esistere, non ha più senso. Come smettono di averne anche i telefoni pubblici, le cabine sparse per la città che erano state a lungo un elemento costitutivo del paesaggio urbano (nel caso di Londra sono diventate addirittura un simbolo), ospitando insieme all’apparecchio telefonico ogni genere di spia, fidanzato e rapitore, oltre che, naturalmente, i vandali per i quali erano un formidabile oggetto d’attrazione. Qualcosa emerge e qualcos’altro sparisce: emerge il telefono mobile e il telefono fisso comincia a perder terreno, a declinare insieme alle sue emanazioni come la cabina e il cercapersone. Non scompare, almeno per il momento non lo ha fatto, ma cambia il suo ruolo, con l’inversione che conosciamo, per cui mentre oggi
ticonzero No. 106
9
tutti possiedono un telefono mobile, solo pochi si concedono anche il “lusso” di un fisso. Il quale, peraltro, anche lui si trasforma fisicamente. Non soltanto è sempre wireless, ma per di più è dotato dell’ormai irrinunciabile display cui siamo stati abituati proprio dai telefoni cellulari. Basta guardare Aladino, il telefono “tradizionale” prodotto da Telecom Italia e fornito d’ufficio ai nuovi abbonati, in tutto simile a un cellulare, fin nelle molteplici melodie che possono essere utilizzate al posto del tradizionale squillo. Anche le suonerie, peraltro, sono frutto di un progetto e come tali sono soggette al meccanismo evolutivo che stiamo esaminando che prevede forme di recupero dal passato. Pensiamo al recente e diffuso fenomeno tecno-sociale del “ritorno al trillo” che ha portato migliaia di utenti a impostare come suoneria il sobrio trillo tradizionale al posto delle melodie in voga fino ad un passato recente: dalla babele delle musichette fai da te dritti nella notte in cui tutti i trilli sono uguali. Ma torniamo al cellulare. Sarebbe impossibile in questa sede fare una storia dell’evoluzione dei modelli a partire dal Dynatac (fig. 3), tuttavia non possiamo fare a meno di esplicitare alcuni passaggi. Progetti che hanno cambiato il modo di usare questi apparecchi e con esso non soltanto il suo ruolo, ma anche quello di numerosi altri oggetti. Lo Startac di Motorola (fig. 4), per esempio, a lungo primatista quanto a dimensioni e leggerezza, grazie alla possibilità di ripiegarsi (flip), è stato il primo telefono davvero tascabile. A quel tempo la scommessa tecnologica era la miniaturizzazzione, e si arrivò ben presto a vincerla, con modelli dalle dimensioni davvero ridottissime che il palmo di una mano conteneva comodamente. Tuttavia, come spesso accade, ciò che sembra un valore finale, una volta raggiunto perde significato. Così i produttori di telefoni (e gli utenti), una volta pervenuti a modelli da fare invidia ad un agente segreto, hanno cambiato la direzione di sviluppo spostando l’innovazione sulle funzionalità e ritornando letteralmente indietro sugli aspetti legati alla dimensione. Nel frattempo però si è innescato un altro meccanismo trasformativo, quello stesso che evocavamo all’inizio di questo paragrafo e che ha coinvolto, fra gli altri, l’orologio. Con il cellulare che ci segue ovunque (ormai indipendentemente dalle dimensioni) e che è perfettamente in grado di dirci che ore sono, diventa del tutto inutile portare qualcosa al polso. Se lo facciamo è solo perché gradiamo quel tipo di ornamento, perché ha per noi un significato altro rispetto a quello banalmente pratico. Forse anche perché il tempo che passa ha un altro sapore se viene scandito da due lancette che ruotano anziché da fredde cifre digitali. Fin qui niente di nuovo, alla Swatch c’erano arrivati da tempo al fatto che gli orologi sono qualcosa di più di uno strumento per misurare il tempo, quello che è meno evidente è l’altro passaggio che evocavamo, ovvero che a un certo momento i cellulari sarebbero diventati dei gioielli, proprio come l’Aura. Ma cosa comporta far diventare un cellulare un gioiello? Come si opera affinché un oggetto di natura funzionale diventi “prezioso”, cambiando così la sua valorizzazione in senso opposto a quello pratico? Il primo passo è ovviamente quello del materiale, e così l’involucro esterno, normalmente di plastica, viene qui realizzato in uno splendente metallo cromato. Il paradosso è che proprio mentre la gioielleria scopre i materiali poveri (tubi di gomma, guarnizioni, vetri colorati, stoffe, carta etc.) i “nuovi gioielli” vanno verso la tradizione, quella del metallo, del lucido contrapposto al sempre più diffuso opaco. Ma il lusso, si sa, spesso si manifesta come vero e proprio antifunzionalismo: si pensi a crinoline e paniers negli abiti femminili del Settecento e Ottocento che impedivano alle dame qualunque attività. In questo caso, l’antifunzionalismo si concretizza in un display di forma rotonda che mal si presta, in confronto al classico rettangolo, a rappresentare i
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
10
lunghi elenchi della rubrica, così come le immagini fotografiche. Infine, anche se non per ultimo, il valore dell’oggetto viene costruito attraverso ciò che non si vede ma si può percepire attraverso altri sensi come il tatto. Il peso di una collana ha grande importanza nella costruzione del suo valore, anche se è chiaro che questa informazione riguarda chi la indossa più che chi la vede dall’esterno. È una forma di autocompiacimento derivante dalla sensazione propriocettiva del contatto con certe superfici, o dal sentire certi pesi su di noi. Nel caso del cellulare in esame, non soltanto abbiamo un peso leggermente più alto di molti suoi concorrenti (141 grammi contro una media di 100) e il metallo striato dell’involucro esterno che offre una sensazione tattile molto diversa da quella cui le plastiche ci hanno abituato, ma, più importante di tutto ciò, un singolare meccanismo di apertura che fa scivolare in un attimo una sull’altra le due metà di cui è composto l’apparecchio. Un insieme di ingranaggi, si badi, non una semplice molla, che, infatti, vengono esibiti nella parte posteriore dell’apparecchio attraverso un’apposita finestra circolare che mostra le ruote dentate, proprio come avviene in certi orologi (fig. 6). A completare il quadro, la copertura del display circolare in vetro zaffiro, perfettamente antigraffio come quello degli orologi più prestigiosi e una modalità di vendita esclusiva attraverso la quale si fa in modo che il cliente non possa rivendere a sua volta l’apparecchio a qualcun altro senza passare nuovamente attraverso Motorola.
FIGURE 6 – Motorola Aura, particolare della parte posteriore e vista del cellulare aperto Aura è senz’altro un progetto originale che istituisce al contempo un nuovo modo di considerare, e dunque di progettare, il telefono portatile, ma che è inevitabilmente il prodotto di un contesto socio tecnico mutato rispetto a quello riscontrabile solo pochi anni or sono, del quale fa parte, come abbiamo visto, anche la gioielleria. L’innovazione contenuta in questo progetto dunque va oltre i confini di una categoria merceologica, si fa discorso nel momento in cui investe altre tipologie di artefatti sollevando problemi e indirizzando verso soluzioni spesso ibride. Cosa ne sarà per esempio degli orologi dopo Aura? È evidente che dovranno cambiare per non scomparire. E se i cellulari spingono sul fronte dell’estetica essi non potranno che farlo su quello opposto, valorizzando la praticità, per esempio ereditando
ticonzero No. 106
11
proprio dai cellulari certe funzionalità o anche delle modalità di interazione. Come quelle del Touch Expert di Tissot (fig. 2) nel quale anziché attivare le funzioni attraverso la pressione di uno o più pulsanti posti lateralmente come è stato a lungo uso, è possibile toccare il quadrante in corrispondenza di certe zone come si fa con i touch screen dei cellulari di ultima generazione. Veniamo a questo punto all’ultimo passaggio evolutivo nel mondo dei cellulari, quello che ha nell’iPhone di Apple il suo campione (fig. 5). A questo punto la dimensione non è più un problema, contano maggiormente le funzioni disponibili, tra le quali sono ormai immancabili l’agenda, l’ascolto di brani musicali, la ripresa e la visione di filmati e fotografie, la consultazione di pagine web e il navigatore satellitare. Ingombro e peso sarebbero insomma compensati dal fatto di avere tanti oggetti riuniti in un unico chassis, anche se, come sappiamo bene, questo difficilmente fa in modo che le nostre tasche siano vuote. Per quanto il cellulare riesca a produrre buone immagini, infatti, non offre la qualità di una macchina fotografica digitale, e anche il GPS non è paragonabile a quello dedicato. Non è un caso allora se il mercato delle borse e delle custodie non è stato mai così prospero: tra protezioni per gli apparecchi, zaini (sia nella versione monospalla che in quella classica), marsupi, borsette di ogni tipo da allacciare alla cintura etc. Un altro dei grandi ritorni, anzi, è proprio quello del borsello da uomo: messo da parte per lunghi anni, si ripresenta adesso in varie fogge e dimensioni. A sparire (almeno per il momento) sono state le agende elettroniche, fino a qualche tempo considerate favorite nella sfida con il cartaceo oggi non si vedono praticamente più mentre Moleskine e compagne sembrano godere di perfetta salute, progettate come sono per offrire possibilità pratiche e sensazioni difficili ottenere con un marchingegno elettronico. Un paradosso che non stupisce se consideriamo che nell’era della comunicazione virtuale e dell’accesso (e dei problemi energetici e di inquinamento), si prendono molti più aerei di quanto non si sia mai fatto in passato, cercando sempre la ricchezza dell’esperienza “faccia a faccia”. Lo stesso principio che ha decretato il successo dei post-it che non fanno che proiettare la nostra agenda sulle cose che abbiamo ogni giorno sott’occhio, dandoci la possibilità di accartocciare e buttare nel cestino un impegno alla volta. La contraddizione tra funzioni avanzatissime, dematerializzazione, miniaturizzazione, gestione automatizzata, e, dall’altro lato, contatto fisico, borse che si riempiono, accartocciamenti vari è solo apparente. L’innovazione sembra anzi nutrirsene, e questo perché l’esistenza di un artefatto più che a una sua presupposta funzione o alla sua presenza fisica, come dicevamo è legata al senso che esso assume. Nel prossimo articolo si approfondirà il concetto di design attraverso lo sguardo semiotico.
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
12
BIBLIOGRAFIA
CELASCHI, F. e DESERTI, A. 2007, Design e innovazione. Strumenti e pratiche per la ricerca applicata. Roma, Carocci.
FONTANILLE, J. e ZILBERBERG, C. 1998, Tension et signification, Mardaga, Liège.
GREIMAS, A. e FONTANILLE, J. 1991, Sémiotique des passions. Des états des choses aux états d’âmes, Seuil, Paris,; trad. It., Semiotica delle passioni. Dagli stati di cose agli stati d’animo, Bompiani 1996, Milano.
KUHN, T. 1962, The structure of Scientic revolutions. Chicago, University of Chicago, trad. It. La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi 1999, Torino.
MALDONADO, T. 1970, La speranza progettuale. Einaudi, Torino.
MANGANO, D. 2008, Semiotica e design, Carocci, Roma.
MANGANO, D. 2009, I-Pod and you?, in Mangano, Mattozzi, (a cura di), 2009.
MANGANO, D. e Mattozzi, A., (a cura di), 2009, Il discorso del design. Pratiche del progetto e saper faresemiotico. E|C, nn. 3/4.
MARRONE, G. 1998, Estetica del telegiornale, Meltemi, Roma.
MARRONE, G., 1999, C’era una volta il telefonino, Meltemi, Roma.
MARRONE, G. 2003, Retorica della notizia. Prassi enunciativa nel telegiornale; in Documenti di lavoro e pre-pubblicazioni, 320-322, del Centro internazionale di semiotica e linguistica di Urbino.
No. 106/2010
Principi di semio-design. Forme dell’innovazione e teoria del progetto - 2 parte Dario Mangano e Gianfranco Marrone UNIVERSITÀ DI PALERMO Dopo aver introdotto il tema dell’innovazione nell’ambito del design, l’articolo presente vuole attraverso la riflessione semiotica identificare e chiarire i processi attraverso i quali si arriva alle nuove forme di design.
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
2
1. Incursione teorica per il semio-design1 Entra qui finalmente in gioco la semiotica, che a partire dai casi proposti può proporre un nuovo modello dei processi di innovazione che ne spieghi non solo le differenze interne ma anche e soprattutto le dinamiche trasformative. Numerosi sono ormai gli studi che, superati i primi amori fra semiotica e design, e superati altresì i successivi reciproci disinteressi fra le due discipline, hanno messo a fuoco il modo e il motivo per cui esse hanno ragione di confrontarsi e rendersi vicendevolmente complementari (cfr. da ultimo Mangano 2008; Mangano e Mattozzi eds. 2009). Quel che emerge da queste ricognizioni, molto in sintesi, è il principio per cui, da un lato, la semiotica può fornire modelli per ricostruire le articolazioni di senso inscritte nel progetto di design (di prodotto, di grafica e comunicazione, d’interfaccia o altro) e, dall’altro, essa può altresì provare a esplicitare il saper fare implicito del progettista, contribuendo già alle fasi di ideazione e di elaborazione tecnica. In cambio, il design permette allo studio della significazione di allargare ulteriormente il proprio campo d’azione, fornendo casi-studio pertinenti e problematiche ad hoc a partire da cui essa può definitivamente abbandonare ogni dipendenza linguistica, aprendosi alla dimensione delle tecnologie e dell’esperienza, dell’oggettualità e dei modelli abitativi. La nozione di testo che troppo spesso viene tuttora ancorata – in semiotica e non – alla dimensione letteraria riemerge così in tutta la sua operatività, quale modello forte di spiegazione della significazione umana e sociale, entro cui la teoria e la prassi del design trova, per così dire, naturale collocazione. Per quel che ci riguarda in questa sede, vorremmo provare, a partire dalla problematica sopra esposta della innovatività progettuale, ad allargare ulteriormente l’area di dialogo delle due discipline, prendendo in considerazione la dimensione della cultura e della storia che, per forza di cose, vengono tirate in gioco dalla nozione stessa di innovazione. Punto di partenza, manco a dirlo, è ancora una volta la celebre dicotomia saussuriana langue/parole o, meglio, il suo progressivo superamento. Secondo il linguista ginevrino Ferdinand de Saussure, ogni sistema di segni è, appunto, un sistema, un insieme strutturato di regole astratte e formali, collettivo e condiviso (langue), a partire da cui riesce possibile l’atto individuale di produzione di senso, sia esso linguistico o d’altra natura (parole). Tale sistema, però, non è previsto in anticipo da una qualche entità superiore o evento contrattuale, ma si costituisce a partire dalla serie infinita delle parlate individuali, è la risultante generale dei singoli atti di parole. La langue e la parole sono così in dialettica costante, uno dipendente dall’altro, in presupposizione reciproca. Io parlo a partire da una lingua. La lingua esiste perché io la parlo. Molti studiosi successivi hanno però ridimensionato questa dicotomia saussuriana, che lascia ben poco spazio di libertà – di innovazione, se si vuole – al singolo parlante, il quale in fondo sembra costretto a sottostare alla dimensione sovraindividuale del sistema collettivo di regole, pena l’incomunicabilità. Émile Benveniste, per esempio, ha progressivamente mostrato come a metà strada fra la langue e la parole si dia una terza dimensione: quella del discorso, del modo in cui, cioè, il parlante si appropria delle regole linguistiche producendo la comunicazione sociale vera e propria (o enunciazione); ma anche, e parallelamente, del modo in 1 Sono redatti da Mangano il paragrafo 3; da Marrone i paragrafi 1 e 2.
ticonzero No. 106
3
cui la lingua prevede al suo interno tali modi di appropriazione, di fatto grammaticalizzando – ossia prospettando in anticipo – l’immagine dei soggetti linguistici. I pronomi personali, i modi e i tempi verbali, gli avverbi di luogo, per esempio, sono regole grammaticali mediante cui si delinea la figura concreta di chi parla (e dice io, qui e ora) e di chi ascolta (a cui si dice tu, là e ora). Si riduce in tal modo la costrittività delle regole linguistiche, aumentando lo spazio d’azione dei soggetti linguistici, i quali si rivelano essere allo stesso tempo soggetti fatti di lingua, costruiti grazie e attraverso i processi di comunicazione e di significazione. Analogamente, Luis Hjelmslev ha fatto presente – dando voce empirica alle intuizioni del linguista Wittgenstein, e aprendo di fatto la strada alle ricerche della cosiddetta pragmatica linguistica – che fra langue e parole si pone tutta la dimensione dell’uso. Per questo autore infatti all’interno della nozione saussuriana di langue si ritrovano quanto meno tre fenomeni diversi: questioni di forma pura (o schema) che determinano le entità linguistiche secondo opposizioni date solo in negativo (un fonema si oppone a un altro, a prescindere dal modo in cui viene reso a livello sonoro, grafico, gestuale etc.); questioni di forma materiale (o norma) che determinano le entità linguistiche secondo opposizioni anche in parte sonore (un fonema si oppone a un altro per alcune sue specifiche proprietà); questioni di prassi abituale (o uso) che determinano le entità linguistiche secondo il modo in cui per lo più si manifestano sonoramente (un fonema si rende riconoscibile in quanto tale, e al tempo stesso diverso da altri). Altro aspetto è poi la pronuncia individuale di ciascuno, che fa propri gli usi sociali della lingua, rendendo questa volta identificabile il suo modo specifico di parlare. Si tratta insomma di quattro diversi livelli di percezione linguistica, di cui effettivamente soltanto due – lo schema formale e l’uso sociale – sono oggetto pertinente della linguistica. Su questa scia si sono posti recentemente Fontanille e Zilberberg (1998), che hanno chiaramente distinto fra fatti di lingua (generativi) e fatti di storia (genetici), proponendo un percorso che dai primitivi della virtualità linguistica (schema) passa alla loro predisposizione attualizzante (norma) per infine realizzarsi in una certa sostanza (parole), per tornare poi, sul versante storico, alle consuetudini socio-linguistiche, ad atti di parole ripetuti sempre nel medesimo modo, che potenzialmente potrebbero dar luogo a nuovi primitivi. Da cui lo schema della cosiddetta prassi enunciativa:
Ci sarebbe una specie di movimento circolare che parte (per convenzione) dal sistema virtuale, passa per l’attualizzazione e arriva alla realizzazione (ed è il movimento della significazione). Da qui ha inizio la storia, ossia il fatto che, grazie all’uso, dalla realizzazione si passa alla potenzializzazione, ossia alla costituzione di prassemi enunciativi, che possono contribuire al riaggiustamento del sistema grazie alla virtualizzazione. Si possono indicare in tal modo quattro ‘operazioni elementari’ della prassi enunciativa, due delle quali di carattere ascendente – l’emergenza (dalla virtualizzazione all’attualizzazione) e l’apparizione (dall’attualizzazione alla realizzazione) – e due di carattere discendente – il declino (dalla realizzazione alla
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
4
potenzializzazione) e la scomparsa (dalla potenzializzazione alla virtualizzazione). Nel discorso concreto però, osservano Fontanille e Zilberberg (1998), non ha mai luogo una sola operazione ma come minimo due: un’operazione, per es., di emergenza di una data grandezza semiotica si accompagna al declino di un’altra che stava al suo posto, o viceversa. Da qui la formulazione di una combinatoria delle operazioni elementari, che rende conto della tensione tra due movimenti della prassi enunciativa:
Quando un’apparizione si associa a una scomparsa si ha una rivoluzione, ossia la sostituzione di un elemento con un altro (per es., il cambio radicale di un logo o di un nome di marca); quando un’apparizione si associa a un declino c’è una fluttuazione, ossia la compresenza entro il medesimo discorso di un elemento tradizionale con uno del tutto nuovo (per es. l’estensione di una marca di moda a un ambito molto lontano come il cibo). Più delicate le altre due operazioni: quando un’emergenza si associa a un declino c’è una distorsione, dove la compresenza riguarda un elemento che sta per affermarsi e un altro che sta invece per scemare (per es. l’affermarsi di certe forti tendenze al cambiamento entro un panorama momentaneamente stabile della moda); quando un’emergenza si associa a una scomparsa c’è un rimaneggiamento, ossia l’affermarsi di una nuova tendenza che sta per prender piede di contro a un’altra che viene meno (per. es. il riposizionamento di una marca nel posto lasciato vuoto da un’altra). Così, la prassi enunciativa prevede che in un discorso ci siano quanto meno due grandezze: una di esse è realizzata, data, effettivamente percepibile; l’altra è percepibile invece solo in modo indiretto, secondario, come sullo sfondo: essa è quindi attuale (se si tratta di una possibilità in qualche modo prevedibile ma non ancora realmente presentatasi), oppure è potenziale (se si tratta di qualcosa che ha avuto suoi momenti di realizzazione, essendo stata per un certo periodo una soluzione adottata e riconosciuta, e adesso è come in stand-by, fra parentesi, ma pronta a tornare a galla). Insomma, approfondendo la metafora visiva, nel discorso c’è sempre un primo piano e uno sfondo che grazie alla prassi enunciativa possono scambiarsi i ruoli nel corso del tempo. In tal modo, i contenuti testuali non rispondono solo a relazioni sistematiche o logico-narrative, ma hanno anche un diverso grado di presenza nel discorso, sono più o meno ‘in servizio’, vi insistono in misura maggiore o minore. Grado di presenza che si costituisce in una tensione essenziale, e in una messa in prospettiva, degli elementi testuali dati: che divengono virtuali, potenziali, attuali o realizzati l’uno in relazione all’altro. Così, una marca può affermare i propri contenuti mettendoli in relazione più o meno palese con quelli di altri discorsi concomitanti, oppure può progettare una propria trasformazione interna giocando in modo calcolato fra emergenze discorsive e paralleli declini. Può produrre al proprio interno forme più o meno fittizie di enunciazione, a partire dalle quali prendere posizione e arricchirle, oppure può
ticonzero No. 106
5
moltiplicare le voci e i contenuti sino a esplodere o a dissolversi. Trovano qui risistemazione teorica e metodologica pratiche come quella del cobranding, dove una marca si staglia in funzione di un’altra e viceversa, costituendo forme momentanee di alleanza discorsiva prima ancora che economica. Con questo modello possono altresì ricevere una nuova definizione abitudini come quelle della sponsorizzazione, dove il marchio si inserisce in eventi, circostanze e discorsi altri, articolandosi con essi in una qualche gerarchia. E si reintepretano in questo quadro tattiche di marca come la presa in carico di problematiche sociali o ambientali, circostanze belliche, disastri naturali, questioni etiche, ideologie politiche, religioni. Prendendo posizione rispetto a tutto ciò, il discorso di marca si risemantizza, acquista o perde senso a seconda del grado di presenza con il quale riesce a imporsi nelle sue prassi enunciative.
2. Gradualità e rivoluzione nell’innovazione Non sembri, questa lunga incursione nella linguistica, un’ennesima, implicita dichiarazione di sudditanza al modello verbale, una sorta di ulteriore logocentrismo insomma. Del resto, gli esempi che sopra abbiamo proposto, relativi all’universo del branding, lasciano già intendere le enormi possibilità di applicazione di questo modello semiotico. Difatti, si coglie meglio il senso, e tutta la importanza operativa, della nozione di prassi enunciativa proprio nel momento in cui la si adopera nel campo della comunicazione e della significazione sociali. Dire che esistono usi linguistici che stabilizzano lo schema formale in prassi abituali, di fatto rendendo funzionali certe regole e non funzionali certe altre, è in fondo una relativa ovvietà. Più interessante è invece constatare, come fanno Greimas e Fontanille (1991) studiando la dimensione passionale del senso, che le predisposizioni d’animo previste formalmente da una determinata cultura a livello virtuale non danno affatto luogo a configurazioni emotive realizzate storicamente: se per es. a livello logico-semantico avarizia e generosità si oppongono, nel Seicento e nel Settecento è solo la prima a essere considerata una passione socialmente rilevante, mentre la seconda è tutt’al più una blanda tendenza caratteriale. Analogamente, studiando un fenomeno molto diverso qual è quello della costruzione delle notizie nel discorso giornalistico, è emerso molto chiaramente come l’evento del giorno (la notizia, appunto, realizzata) cambi completamente di senso a seconda che si stagli sullo sfondo di alcuni contenuti informativi virtuali piuttosto che altri: una cosa è un suicidio di un certo personaggio politico per ragioni politiche, altra cosa il medesimo suicidio per ragioni sentimentali, o per ragioni giudiziarie. Così, sono le prassi giornalistiche concrete a dar senso alle regole virtuali dell’informazione, e non viceversa (Marrone 1998). In questo caso allora l’uso, per tornare alla terminologia hjelmsleviana, predomina sia sulla lingua come schema formale o norma materiale, sia sull’atto individuale di parole. A dirigerci, sarà pertanto il seguente quadrato semiotico, che – differenziandosi sia da quello presente in Greimas e Fontanille (1991) sia da quello già ripensato in Mangano (2009) – riassume quanto detto sinora, donandoci altresì la ricchezza della sua intrinseca operatività. I termini che esso articola, com’è noto, sono esiti delle relazioni di contrarietà, contraddizione e complementarità nonché delle operazioni di negazione e affermazione che lo dinamizzano.
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
6
3. Un’applicazione pratica del modello Proviamo ora a tornare sui processi trasformativi che, come abbiamo visto nel paragrafo 3, a partire dall’invenzione del telefono cellulare hanno interessato il sistema socio-tecnico, per capire come un modello come quello appena proposto possa offrirci l’occasione di sistematizzarli, offrendoci al contempo nuove suggestioni. Ad un certo momento, il cellulare da astrazione (l’ideale telefono senza filo) quale era stato a lungo, e dunque da una forma di esistenza virtuale, fa la sua comparsa sul mercato. All’inizio è ancora un oggetto per pochi e tuttavia comincia già a destabilizzare alcuni equilibri. Fino a quel momento il problema delle chiamate urgenti era stato risolto con il cercapersone (solo marginalmente con le radio ricetrasmittenti su cui torneremo), una tecnologia che aveva però numerosi svantaggi, primo fra tutti quello di non risolvere il problema del filo fino in fondo: l’importante medico poteva essere rintracciato ovunque, e tuttavia per poter sentire quale fosse il problema e proporre una eventuale soluzione, doveva pur sempre trovare un apparecchio tradizionale. Con la comparsa del cellulare dunque, il sistema socio-tecnico comincia a muoversi. Attenzione però, sarebbe un errore credere che il rapporto sia di tipo uno a uno, o uno a due, ovvero tale per cui il cellulare ascende facendo la sua comparsa e il cercapersone o il telefono fisso discendono finendo per scomparire. Come abbiamo accennato, nel caso degli artefatti la tensione ha luogo fra molti elementi e dunque bisogna parlare di riconfigurazione di un sistema socio tecnico nel suo complesso. La nuova invenzione mette in difficoltà il vecchio cercapersone, negando la sua congiunzione con quel sistema cui fino a quel momento poteva dirsi congiunto e dunque realizzato per fargli assumere una più vaga posizione di oggetto attuale, ovvero qualcosa che è lì come una competenza inespressa, qualcosa che potrebbe funzionare ancora ma che nessuno più ha intenzione di utilizzare. Facciamo notare che la lessicalizzazione con cui si indica questo stato di esistenza semiotica non è del tutto felice: nel linguaggio comune infatti attuale rimanda ad un concetto di validità nel presente che nel nostro caso non si dà. D’altronde, il concetto hjelmsleviano di norma a cui lo abbiamo associato in questo nostro modello, suggerisce una certa idea di staticità e di inattualità che invece ben si adattano a quanto abbiamo visto. Tuttavia questa trasformazione non è che la punta di un iceberg, perché a partire da questa molte altre ne conseguono, dando vita ad un complesso processo di innovazione a cascata che interessa oggetti apparentemente eterogenei. Gli orologi tradizionali innanzitutto, che, ormai incorporati nei cellulari, non devono più essere macchine per scandire il tempo ma sempre più accessori da indossare. L’orologio passa così dallo stato di realizzato a quello di attuale. Diventa, è il caso di dirlo, la norma. Un
ticonzero No. 106
7
tale spostamento, però, offre la possibilità di una nuova trasformazione che puntualmente si verifica: è quella che fa sì che i cellulari diventino gioielli come l’Aura, frutto di un movimento dal potenziale al realizzato. In questo caso, quello che era un uso accessorio, ovvero consentire di leggere l’ora, prende il sopravvento e nel farlo dirotta la pertinenza dell’oggetto nel suo complesso verso il gioiello: il quadrante diventa tondo, i materiali preziosi etc. Semioticamente diremo che un uso diffuso ha stimolato un processo creativo dando il via alla realizzazione di qualcosa di nuovo, un ibrido che prende il posto di ciò che esisteva prima. Un movimento che provoca una pronta risposta dei produttori di orologi che, capita l’invasione di campo, restituiscono pan per focaccia, mutuando la tecnologia touch screen proprio dalle interfacce dei cellulari e incorporandola in un orologio come il Tissot. Ma i confini del processo innovativo posso essere allargati ancora. Alle cabine telefoniche per esempio, che a buon diritto entrano nella partita. E tuttavia nel loro caso la sorte è stata meno benevola: dopo aver passato qualche anno nel limbo dell’attuale, ovvero di una esistenza inattiva, hanno finito col venire smontate divenendo veri e propri oggetti virtuali le cui uniche forme d’uso sono ormai quelle leggermente devianti di coloro che le inseriscono fra gli arredi di locali alla moda. Potremmo continuare a lungo individuando movimenti sul quadrato che rendono conto del modo in cui nuovi prodotti scaturiscano da realtà preesistenti e tuttavia quello che ci preme mostrare è la coerenza sistematica di tali trasformazioni. Prendiamo il borsello da uomo. In voga fino agli anni Settanta, dopo quel periodo è stato utilizzato solo da pochi nostalgici rimanendo a lungo chiuso in uno stato di esistenza virtuale. In seguito alla necessità di portarsi dietro tutta la tecnologia che ci accompagna quotidianamente però, dapprima si è cominciata a riprendere l’abitudine a portarlo con sé (potenziale), ed in seguito i produttori hanno preso a disegnare modelli per le “nuove” esigenze (realizzato). Se l’esempio del borsello dovesse sembrarci troppo ai margini dell’innovazione principale, ovvero quella del parlare senza alcun filo e ovunque, facciamo notare come da pochissimo tempo alcune aziende stiano cercando di rilanciare la tecnologia a radiofrequenza per le comunicazioni. Non sappiamo ancora se andrà a buon fine l’operazione, ma Brondi sta spingendo in questa direzione pubblicizzando ricetrasmittenti nei termini di una alternativa ai telefonini. Una campagna che fa leva non soltanto sul vantaggio tecnologico, che consiste nell’essere in condizione di trasmettere anche dove non c’è copertura della rete telefonica, o economico, visto il costo nullo della chiamata, ma anche sociale, in quanto con i walkie talkie si può parlare contemporaneamente a più di una persona. Poco utile nella vita quotidiana forse, ma molto nel contesto di una vacanza in barca a vela come quella rappresentata nell’immagine (fig. 7). Per non parlare del fascino tanto infantile quanto efficace di dover dire “passo” alla fine di ogni frase. Tutto questo per dire che l’innovazione si nutre di passato, riporta in vita, trasforma, difficilmente “crea” ex nihilo, e non per la ragione che comunemente si tende ad assumere, ovvero perché ciò che c’era prima era in qualche modo più razionale, più essenziale, e per questo in definitiva migliore di ciò che ci offre la contemporaneità, ma per un motivo di ordine ben diverso che ha a che vedere con il senso di quell’artefatto. Il giradischi torna di moda quando nasce l’iPod e la musica comincia a essere gestita completamente attraverso il computer (Mangano 2009). Ciò che avrebbe dovuto porre fine una volta e per tutte a un supporto imperfetto, troppo delicato, complesso da maneggiare e archiviare, e che, per di più, ci spinge ad un ascolto sequenziale dei brani che ci fa “perder tempo”, in realtà lo resuscita, e per delle ragioni che hanno a che vedere proprio con tali abissali differenze. A darcene prova è il declino, molto lento ancora ma perfettamente prevedibile, che sta subendo il Compact Disk, ovvero l’invenzione
Dario Mangano, Gianfranco Marrone
8
che, a suo tempo, aveva detronizzato l’LP. Il giradischi insomma torna pertinente nella veste rinnovata dei modelli contemporanei (il passaggio è virtuale>> potenziale>>realizzato), grazie al manifestarsi del suo nemico perfetto, proprio come aveva suggerito Maldonado.
FIGURE 7 – Pubblicità a stampa delle ricetrasmittenti Brondi (2009). Lo sguardo semiotico ci obbliga allora a mutare l’approccio comunemente adottato in riferimento al fenomeno dell’innovazione. In primo luogo perché ci spinge a leggerlo sempre come un processo sistemico, in cui sono intere configurazioni a cambiare e non singoli oggetti; ma anche, e forse soprattutto, perché sposta la nostra attenzione sul fatto che la mutazione non scaturisce da un miglioramento valutabile nei termini di un mero calcolo ingegneristico, ma da qualcosa che ha a che vedere con una forma di efficacia che, con Levi-Strauss, diremmo simbolica. Da ciò l’importanza che i modelli che hanno consentito di descrivere e spiegare tali forme di azione possono avere su un’altra forma di azione come quella dell’inventare. Il prossimo telefonino? La casa del futuro? Per sapere come saranno fatti non ci resta che guardare ai sistemi di relazione nei quali stanno nascendo, osservando lo statuto di esistenza semiotica di ciò che ci è noto e ipotizzando le possibili trasformazioni. Le possibilità sono molte naturalmente, ma non infinite. Un livello profondo, tanto astratto quanto universale, è presente. Quanto al telefono bisognerà allora interrogarsi sul modo in cui si costruiscono le identità, su come comincia e finisce una storia d’amore, mentre per la casa, prima ancora di fare considerazioni sul bilanciamento energetico e sull’uso di materiali riciclabili, bisognerà interrogarsi sulla natura in quanto modello culturale.
ticonzero No. 106
9
BIBLIOGRAFIA
CELASCHI, F. e DESERTI, A. 2007, Design e innovazione. Strumenti e pratiche per la ricerca applicata. Roma, Carocci.
FONTANILLE, J. e ZILBERBERG, C. 1998, Tension et signification, Mardaga, Liège.
GREIMAS, A. e FONTANILLE, J. 1991, Sémiotique des passions. Des états des choses aux états d’âmes, Seuil, Paris,; trad. It., Semiotica delle passioni. Dagli stati di cose agli stati d’animo, Bompiani 1996, Milano.
KUHN, T. 1962, The structure of Scientic revolutions. Chicago, University of Chicago, trad. It. La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi 1999, Torino.
MALDONADO, T. 1970, La speranza progettuale. Einaudi, Torino.
MANGANO, D. 2008, Semiotica e design, Carocci, Roma.
MANGANO, D. 2009, I-Pod and you?, in Mangano, Mattozzi, (a cura di), 2009.
MANGANO, D. e Mattozzi, A., (a cura di), 2009, Il discorso del design. Pratiche del progetto e saper faresemiotico. E|C, nn. 3/4.
MARRONE, G. 1998, Estetica del telegiornale, Meltemi, Roma.
MARRONE, G., 1999, C’era una volta il telefonino, Meltemi, Roma.
MARRONE, G. 2003, Retorica della notizia. Prassi enunciativa nel telegiornale; in Documenti di lavoro e pre-pubblicazioni, 320-322, del Centro internazionale di semiotica e linguistica di Urbino.





















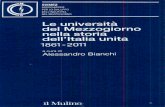






![S. Bettini, "Giacomo Ranuzzi, Progetto per San Petronio" [2001]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313c5895cba183dbf073f9d/s-bettini-giacomo-ranuzzi-progetto-per-san-petronio-2001.jpg)













