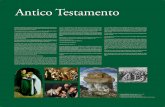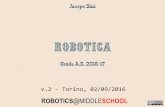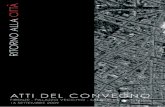Rosantico. guida alla mostra
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Rosantico. guida alla mostra
coordinamento editoriale maria sapio
redazione tiziana la marca
art directorenrica d’aguanno
impaginazione francesca aletto
coordinamento tecnicostefania milanochristian bocciuolo
finito di stamparenel................2013
stampa e allestimento..................
arte’m è un marchio registratoprismi editrice politecnica napoli srlcertificazioni qualità ISO 9001: 2008etica SA 8000: 2008www.arte-m.net
stampato in italia© copyright 2013 byprismieditrice politecnica napoli srltutti i diritti riservati
ROSANTICOnatura, bellezza, gusto, profumitra paestum, padula e velia
Paestum, Museo Archeologico Nazionale 23 marzo - 31 ottobre 2013
guida breve a cura diMaria Laura ChiacchioLaura Del Verme
ideazione e cura della mostraAdele Campanelli
coordinamento generaleMarina CiprianiGiovanni Avagliano
coordinamento esecutivoLaura Del Verme
allestimento e graficaMichele Iodice, Francesco Della Femmina, Paolo Maria Russo, Matilde Lepore
selezione dei reperti archeologiciMarina Cipriani, Giovanni Avagliano, Francesco Sirano, Adele Lagi, Elena Laforgia, Renata di Lascio, Daniela Maiorana
restauriLaboratorio di restauro del Museo Archeologico Nazionale di PaestumPietro Stasi, Franco Calceglia, Raffaele Cantiello, Francesco Marino, Maria Palia Voza
Laboratorio di restauro del Museo Archeologico Nazionale dell’Antica CapuaCiro Napolitano, Giuseppe D’Amodio, Carmine D’Andrea, Luigi Russo
referenze fotograficheSoprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e CasertaLeonardo Vitola, Giovanni Grippo, Francesco Valletta, Ortensio FabozziLuciano Pedicini / Archivio dell’Arte Arturo Piera
© per le immagini: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Museo Archeologico Nazionale di PaestumMuseo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua di Santa Maria Capua Vetere
laboratori didattici e visite guidateConsorzio arte’m netLe Nuvole
enti prestatoriSoprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e PompeiMuseo Archeologico Nazionale di Napoli
si ringraziano per la collaborazione il personale di accoglienza e di vigilanza della sede di Paestum e il personale ALES
rosanticonatura, bellezza, gusto, profumitra paestum, padula e velia
guida [breve]
4 ADELE CAMPANELLI IL BELLO DELLA ROSA 5
La bellezza della rosa, il suo profumo sono immediatamente connessi alla bellezza femminile che gli artisti classici hanno fissato nelle armoniose forme di Venere e, nel vasto campo di simboli che legano Venere alla nascita, anche il sorgere del giorno è associato, in alcune metafore letterarie, al manifestarsi di Venere in un giardino profumato di rose. Dunque accanto ai roseti di Paestum, famosi anche quando non esistevano più, e quindi al paesaggio che caratterizzava la città antica e il suo terri-torio, abbiamo voluto porre, in questa esposizione, che festeggia le nuove rose del Parco Archeologico, le rappresentazioni che l’archeologia ci offre della dea più bella (cui le rose erano sacre) e il mito della sua nascita, perenne metafora della primavera che riconduce al profondo legame tra la donna giovane e seducente e la capacità della natura di riprodursi, in un miracolo ciclico di fiori, frutti, colori e profumi. Al modello della divina bellezza di Venere si ispirarono per lungo tempo le donne dell’antichità, che con trucchi e profumi accrescevano le loro capacità seduttive. Il mito narra infatti come l’uso degli unguenti profumati rendesse la dea poten-tissima: la sua arma evanescente e inafferrabile, penetrando attraverso qualsiasi difesa, arrivava direttamente nel cuore. L’importanza degli aromi nel rapporto amoroso dell’antica Grecia è del resto documentata dalle Adonie, la festa in cui si piangeva l’amante di Afrodite.Tra i profumi, quello estratto dalle rose era certamente fra i più graditi: il segreto della sua produzione e il suo successo nel mondo antico sono stati rivelati da scavi e ricerche che proprio qui a Paestum hanno evidenziato l’esistenza di una bottega di
Il bello della rosa
Adele CampanelliSoprintendente per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta
in copertinaelaborazione grafica daGiovan Battista LusieriVeduta dei templidi PaestumBroomhall, collezione Elgin
Lawrence Alma-TademaLe rose di EliogabaloMessico, colección Pérez Simón
Afrodite CallipigeNapoli, Museo Archeologico Nazionale
6 ADELE CAMPANELLI
Questa piana rivedrà ben presto /ornare le sue rose celebrate;/ma il cielo ha qualche rosa, ora, e stasera la loro brevità è fulminea.[Giuseppe Ungaretti, La rosa di Pesto]
Così Giuseppe Ungaretti, che attende-va, come noi oggi, che le rose pestane tornassero a fiorire, coglieva nella rosa l’accordo cromatico tra la terra e il cie-lo, quel senso di effimero, eppure me-raviglioso, che la natura regala all’uomo che, altrettanto effimero, vive per go-derne i doni. Caduca è la rosa che pre-sto sfiorisce, bisogna coglierla, presto! La vita sfugge, la bellezza si dilegua… e poi rinasce.E la rosa non poteva che essere sacra al-la dea della bellezza, Afrodite, Venere: i miti ne raccontano la storia, le storie… la rosa si colora di rosso col sangue: il sangue di Adone, amante ferito, op-pure col sangue della stessa Afrodite, graffiata dalle spine nella sua corsa di-sperata verso l’amato. La rosa è dunque bellezza, desiderio, passione…
Quali rose stamane/ho visto sbocciare! Stavano ancora nascendo e non tutte insieme. /La prima mostrava/i corimbi in boccio,/l’altra ergeva con slancio le creste scarlatte,/la terza non spalancava per intero/la sua corolla,/la quarta, insieme, risplendeva aprendo la gemma del fiore./Mentre una solleva/il suo capo,/l’altra scioglie il suo nodo,/finché il loro virgineo pudore non prende a scolorire./Raccogli le rose/al mattino, perché/non si sciupino:/presto la vergine appassisce.[poeta latino anonimo]
La rosa pestana, la damascena bifera, cantata dai poeti, celebrata in presenza e in assenza, fioriva due volte… due prima-vere, due nascite, due volte la natura ge-nerosa offriva i suoi colori, i suoi odori di-segnando il paesaggio, un paesaggio che l’uomo aveva già segnato con la sua ma-no d’architetto. Ritornerà presto la rosa a colorire la piana pestana, tornerà, come un tempo, ad animare i grandi templi, tornerà ad offrirsi allo sguardo di quanti nella bella stagione scelgono di riscopri-re la storia, di godere insieme di natura e cultura, tornerà per fondere il suo rosso intenso col rosso del disco solare che tra-monta nell’acqua del mare.
profumiere nei pressi del foro. Appena fuori dalle mura, un complesso edificio sacro in località Santa Venera documen-ta, anche attraverso la persistenza del toponimo, un luogo di culto dedicato al-la dea dell’eros. La vicinanza al mare, che lambiva il lato occidentale delle mura – occupato da una vasta laguna – sug-gerisce che la divinità era inizialmente l’Afrodite Ericina al cui culto sarebbero da riferire spazi ed oggetti relativi alla pratica della prostituzione sacra.A questa combinazione di argomenti si ispira il tema della mostra Rosantico, che vuole sottolineare una nuova occa-sione per apprezzare Paestum, dove la primavera del 2013 è festeggiata dalla fioritura del roseto all’ingresso del Parco Archeologico, realizzato in col-laborazione con il Parco del Cilento, e dal catalogo che raccoglie le riflessioni di alcuni studiosi di varia estrazione ispirate al tema della rosa. I saggi, co-me petali, si schiudono ad una idea di comunicazione interdisciplinare dove lo spunto (la rosa) non è che un avvio di dialogo tra competenze diverse, teso a interessare un pubblico non pre-selezionato, per renderlo disponibile all’approfondimento, e-ducarlo allo studio, aprirgli le porte della conoscen-za, svelargli il piacere del sapere come atto di volontà individuale.Fiorisce, oggi, il nuovo roseto di Paestum,
ricordo della famosa rosa bifera di plinia-na memoria, in un Parco Archeologico che, lontano dalla retorica del ventennio fascista, propone la cura dell’accoglien-za del pubblico, vero protagonista degli istituti culturali, inaugurando una nuova stagione, che segue quella di ricerche e studi di fondamentale importanza, nella quale i siti archeologici, saranno oggetto di attività finalizzate a migliorarne la fru-ibilità, la percezione, la facilità di uso, per favorirne una frequentazione più ampia, e non tanto per aumentare il numero degli utenti (non occorrono ‘visitifici’ alla società contemporanea), ma per consen-tire a tutti di avvicinarsi al patrimonio culturale, e di goderne non solo, come è stato detto, per conservarne la memoria “ma per realizzarne le speranze”.
ROSANTICO 7
La rosa di Paestum
8 TITOLO ROSANTICO 9
Aveva un ramo di mirto e gioivae un fiore bello di rosa.[Archiloco, Liriche]
Statua di Afroditeda Mondragone (antica Sinuessa)II secolo a.C.Napoli, Museo Archeologico Nazionale
“La divinità è rappresentata nel momento in cui si accin-ge, forse, ad entrare nell’ac-qua: ma, improvvisamente, l’himation, il velo leggero che la ricopre, scivola verso il basso e allora la dea, con spontaneo gesto di pudore e di femminilità, stringe le gambe, onde impedire che il panneggio, cadendo, la riveli nella sua piena nudità; ma il movimento delle gambe,
per quanto deciso, è tardivo e la mano destra corre quin-di, a prendere l’himation che scivola giù, mentre la mano sinistra cerca di ricoprire il ri-goglioso seno”. [Mario Napoli]
L’archeologo Mario Napoli data l’Afrodite da Sinuessa al 120 a.C., considerandola una statua originale di scuo-la attica. La scultura è stata ritrovata a Mondragone nel 1911, inglobata tra le mura di un podere moderno.
Né alcun tempo, più della primavera è appropriato a Venere: a primavera il suo-lo risplende, a primavera il campo è soffice; ora spun-tano i fili d’erba attraverso la terra infranta, ora il tral-cio mette le gemme fuori dalla sgonfia scorza: e Venere bella è degna della bella stagione.[Ovidio, Fasti]
Anfora del pittore di Afroditeda Paestum, necropoli di Licinella, tomba 13340-330 a.C.Paestum, Museo Archeologico Nazionale
La racconta Ovidio, l’identi-tà tra bellezza e primavera, la dipinge il pittore di Afro-dite, insieme a Dioniso, dio del vino e del desiderio ero-tico… Afrodite e Dioniso, divinità dell’eterno ritorno alla vita: la primavera, la rinascita della natura, la stagione degli amori, la vi-ta che non può fare a meno di sbocciare, di fiorire. La scena principale dell’an-fora ha come protagonista una figura femminile di pro-spetto, in volo tra due ero-ti, in una cornice che rap-
presenta l’apoteosi di una donna consacrata ai miste-ri dionisiaci o la nascita di Afrodite. La dea compare e, alla sua presenza, la natu-ra rifiorisce in un parossi-smo di elementi floreali: na-stri, viticci e girali, freschi e spontanei, fanno da cornice al gruppo in volo; quasi pro-tagonisti della scena, diven-tano lo spunto di una narra-zione viva e realistica della natura. Il complesso siste-ma floreale, che introduce la nascita della dea, lascia pre-supporre la volontà di rap-
presentare un inno all’eter-no rinnovarsi dell’energia vitale nel ciclico avvicendar-si della primavera. Come un ricamo leggero, i deco-ri infarciscono il largo cor-po dell’anfora, correlando in un insieme armonico la na-scita di un essere divino e l’ambiente dionisiaco che si sviluppa sull’altra faccia del vaso monumentale.
Venere è la più degna a reggere l’intero universo, ella ha un potere non inferiore a quello di alcun dio, e dà leggi al cielo, alla terra, e al mare da cui è nata e per sua ispirazione fa esistere tutte le specie. Ella creò tutti gli dei – lungo sarebbe enumerarli – ella diede origine agli alberi e ai seminati, ella raccolse in coesione i rozzi animi degli uomini, e a ognuno insegnò a unirsi con la sua compagna. Che cosa genera tutte le varietà degli uccelli se non il soave piacere? Né si accoppierebbero gli animali del gregge senza il dolce amore. Cozza il feroce ariete con altro ariete, ma esso medesimo si guarda dallo scalfire la fronte della diletta agnella; il toro
Lawrence Alma-TademaUna domandaMessico, colección Pérez Simón
Afrodite da Sinuessa (Mondragone)Napoli, Museo Archeologico Nazionale
Anfora del Pittore di AfroditePaestum, Museo Archeologico Nazionale
Strabone informa della presenza presso il tempio di Afrodite sull’Acrocorinto di oltre mille schiave al ser-vizio della divinità, le “iero-dule”. Ateneo riporta che durante le guerre persiane, dopo una vittoria, i Corinzi eressero statue in onore delle prostitute sacre che avevano aiutato i solda-ti con le loro preghiere, e i loro nomi vennero incisi su una tavoletta che ven-ne donata al tempio. Ma quando il culto di Venere venne importato a Roma – racconta lo storico francese George Dumezil – fu rigo-rosamente romanizzato e la prostituzione sacra non venne più praticata.
Ma i cani eccitati non toccarono la salma di Ettore, perché di notte e di giorno sollecita la figlia di Giove, la Citerea Afrodite li allontanava e ungeva il cadavere di una celeste essenza di rose che impediva l’offesa al corpo trascinato. [Omero, Iliade]
Per l’olio dell’atleta, per il profumo degli dei, per il rito funebre, per la crema, per le
cure del corpo, per il profu-mo delle relazioni amorose, per il balsamo medicinale, per il filtro magico...
Unguentari e balsamaricentodue contenitori per profumi dal giardino romano di PaestumIII-II secolo a.C.Paestum, Museo Archeologico Nazionale
Quali i segreti della bellez-za nell’antichità? Molti ri-correvano a decotti di fiori, olii ed essenze profuma-te. Vanità e lusso, cosmesi e benessere, a base di una rosa che ha incantato poe-ti e intellettuali. La magia di un’essenza conservata in centinaia di contenitori, tutti uguali, esposti su un tappeto di mirto e petali. Nonostante i flaconi di ter-racotta nell’antichità non fossero ritenuti i conteni-tori migliori per i profumi, la loro diffusione all’inter-no delle città costituisce una traccia importante per individuare le botteghe, i luoghi di culto, le dispense, le fabbriche, il mondo del-la produzione artigianale di queste essenze che per
Plinio erano più preziose e costose dell’oro. Ampolle di argilla per profumi sono state rinvenute in gran nu-mero anche nelle aree fu-nerarie, dove erano impie-gate nella cerimonia che segna l’ultimo saluto della comunità al defunto.
Quante corone di viole e di rose e di salvia ti ponevi sul capo (eri là, vicino a me); che intrecci di ghirlande al collo delicato – erano fatte dei fiori della primavera![Saffo]
Alla dea dell’Amore: l’incen-so profumato per seduzio-
ROSANTICO 1110 ROSANTICO
che tutte le balze e tutti boschi temono, deposta la sua natura selvaggia segue la giovenca; la stessa forza conserva tutti gli esseri che vivono sotto le distese marine e riempie di innumerevoli pesci le acque. [Ovidio, Fasti]
Statua di Veneredal teatro di Teanum Sidicinuminizi I secolo d.C.Teano, Museo Archeologico di Teanum Sidicinum
“Il mantello scende sul-la coscia in grandi piegoni paralleli, rigonfi, con bor-di arrotondati e piegoline interne ripetute con estre-ma precisione ma con una certa monotonia. Riprodu-ce una variante di una fa-
mosa Venere attribuita al genio artistico di Prassitele, definita tipo Arles”. [Francesco Sirano]
Tante lacrime versa la dea di Cipro, quanto di sangue versa Adone: e tutto, cadendo al suolo si trasforma in fiore: il sangue fa nascere la rosa, le lacrime l’anemone.[Bione di Smirne, Epitaffio di Adone]
Statue di Venereda Paestum, Santuario di Santa VeneraII secolo d.C.Paestum, Museo Archeologico Nazionale
Le cinque statuine che raf-figurano la dea della bel-
lezza sono state ritrovate in un’area sacra fuori le mura di Paestum, dedicata alla dea. In questo santua-rio, che ha una vita lun-ghissima, dal VI secolo a.C. fino all’età tardo-imperia-le, è sempre stata venerata la dea dell’amore, Afrodite prima, Venere poi. Doni votivi, queste piccole e de-licate sculture, descrivono i diversi gesti rituali di una divinità che, rappresentan-do il canone della bellezza, si individua nell’arco dei se-coli per l’ostentata nudità.
Venere dal teatro di Teanum SidicinumTeano, Museo Archeologico di Teanum Sidicinum
Statue di VenereI secolo a.C.-I secolo d.C.Paestum, Museo Archeologico Nazionale
UnguentariPaestum, Museo Archeologico Nazionale
ROSANTICO 13
forma del contenitore, che nei secoli ha assunto nomi diversi. Gli antichi profumie-ri, chiamati unguentari, non conoscevano la distillazione. Una giovane donna greca o romana usava il suo profu-mo preferito spalmandolo sul corpo.
Balsamari da Paestum, Santuario settentionale
Unguentario a piede calzato da Paestum, tomba 496 di Arcioni
Balsamario a testa di Acheloo da Paestum, tomba 369 di Arcioni
Balsamari, anforiskoi, alabastra ed aryballoi da Paestum, area funeraria di Laghetto
Così sedeva, così era adorna,così filava gli stami, così fluiva la chioma rilasciata sul collo, così erano i lineamenti, questi erano stati i suoi accenti, tale l’incarnato,tale l’aspetto, tale la grazia del volto.
[Ovidio, Fasti]
La signora degli oriUna giovane donna di Vol-cej, le sue gioie, il suo pro-fumo e gli accessori per la cosmesi.
Specchio in argento; un-guentario d’argento; set da trucco (aghi in argento e conchiglia); set da toilet-te in argento; pendagli a testina in argento; strigi-le in argento; bracciale in oro; orecchini in oro; due anelli in oro; collana in oro; due borchie in oroda Buccino, area funeraria di Santo Stefano, tomba 270fine IV secolo a.C.Buccino, Museo Archeologico Nazionale di Volcei
Dall’alto del colle di Volcej si vedeva in lontananza il mare di Paestum e facile
era il collegamento con la valle del Sele, lungo il quale in una giornata di cammino si poteva arrivare all’antica Paestum. Il mondo greco coloniale esercita un gran-de fascino per queste co-munità che ne adottano sti-li, mode e comportamenti. Morta all’età di circa venti-cinque anni, la signora degli ori fu seppellita con tutti gli oggetti rappresentativi del-la sua condizione di donna aristocratica – lo specchio, i preziosi gioielli – ma com-plessa ed enigmatica, la donna portò con sé anche oggetti tipici del mondo maschile come lo strigile.
12 ROSANTICO
ne e bellezza dai santuari e dalle tombe di Paestum
Donna fioredal Santuario settentrionale di Paestum e dal Santuario di Foce Selefine IV-inizi III secolo a.C.
Bottiglia a figure rosse, statuetta di Afrodite, donna fioreda Paestum, Santuario meridionalefine IV-inizi III secolo a.C.
Lekythos da Paestum, area funeraria di Tempa del Prete, tomba 8/1953III secolo a.C.
Alabastron dall’area funeraria di Andriuolo, tomba 21VI secolo a.C.Paestum, Museo Archeologico Nazionale
La donna fiore è un brucia-profumi in argilla, uno dei doni votivi più diffusi nei santuari di Paestum, com-posto da un busto o da una testa di donna coronati da una raffigurazione schema-tica del giglio selvatico che ancora oggi cresce tra le du-ne di sabbia del Cilento. Lekythos o bottiglia, alaba-stron o ampolla sono i no-mi antichi di flaconi, spesso decorati con scene del mito, che contenevano unguenti e pozioni profumate.
Quando l’annuserai chiederai agli dei, o Fabullodi farti tutto naso.[Catullo, Carme XIII]
Filtri magici di bellezza: olii alla lavanda, rosa, gel-somino, neroli, mughetto, iris dalle aree funerarie di Poseidonia-Paestum.
Narra il mito che Afrodite consegnò al barcaiolo Faone la prima boccetta di profu-mo, per ringraziarlo di averla traghettata sulla sua imbar-cazione senza voler nulla in cambio. La sua miracolosa essenza lo avrebbe trasfor-mato nell’uomo più attraen-te e desiderato del mondo. Due sono gli elementi fon-damentali per la preparazio-ne del profumo: il liquido e l’essenza, esaltata attraver-so l’uso di specifici aromi. La base di queste essenze, fat-ta di olio, di oliva o di man-dorle amare, di cera d’api, di sesamo, dava una diversa densità al prodotto condi-zionando di fatto anche la
Donne fioredal Santuario di Foce Sele
UnguentariPaestum, Museo Archeologico Nazionale
Collana in orodalla tomba 270, località Santo StefanoBuccino, Museo Archeologico Nazionale di Volcei
ROSANTICO 15
tomba a camera con pa-reti dipinte. Una delle sce-ne più raffinate è quella che rappresenta il suo in-contro con Caronte nell’ol-tretomba. Il ricco corre-do funerario, composto da una rara parure di oggetti d’osso e di bronzo di pre-giata fattura, ha restitu-ito anche quattro flaconi per profumo, in alabastro. Donna raffinata ed altolo-cata, non lascia nulla al ca-so e, nella scelta dei conte-nitori per i suoi profumi, porta con sé nell’ultimo viaggio, oggetti preziosi adeguati a conservare l’in-tensa fragranza del loro contenuto per l’eternità.
Ad Atene, sull’acropoli, c’è un recinto di Afrodite, det-ta dei giardini, ed è lì che le giovani fanciulle atenie-si svolgevano i rituali per propiziare il momento del-le nozze; la dea aveva un giardino profumato nell’i-sola di Lesbo dove corone di rose e di viole, ghirlan-de di fiori e prati rugiado-si accolgono le fedeli. Giar-dini fioriti e profumati sono dedicati, tra gli altri, a Dio-niso, Eros, Adone e Zeus; è nel giardino di Afrodite che fu concepito Eros. L’idea del giardino restituisce dunque l’immagine del luogo feli-ce, dove profumi, fiori ed er-be favoriscono la vita, ma ri-
flette anche un nesso molto stringente tra uomo e cultu-ra, dove emerge la capacità dell’uomo di controllare, or-dinare, regolare la natura. E l’auspicio è che questa abili-tà possa essere essa stessa, ancora per questo tempo, un rinnovato dono degli dei.
14 ROSANTICO
Ella per prima liberò gli uo-mini dai loro feroci costu-mi: da lei provennero la fi-nezza e la linda cura di sé… Ella suscitò mille arti; per desiderio di piacere furono scoperti molti espedienti prima sconosciuti.[Ovidio]
Cofanetto portatrucchi; pettine in osso da Orta di Atella; specchio da Orta di Atellada Orta di Atella, area funeraria di Sant’Arpino, tomba 1II secolo a.C.
Grazie al suo profumo, l’o-lio di rosa era ricercato per la pulizia del corpo. I petali seccati e ridotti in polvere si applicavano sulla pelle, subi-to dopo il bagno, mescolati in uguale quantità con sali di ammonio e un composto di incenso, nitro e gomma,
sciolti nel miele con finoc-chio e mirra. Sono questi i preziosi cosmetici che do-veva contenere la cassetta eburnea di Atella: colore per le palpebre, creme per la pel-le, specchi per il viso e stru-menti per un accurato truc-co raccontano antiche storie di vanità.
La Bellezza allo specchio mentre Eros scocca l’arcoda PaestumIV secolo a.C.
Skyphos con giovane satiro e donna con specchio da Paestum, area funeraria di Andriuolo, tomba 27Pelike con Eros e donna con specchio presso louterion da Paestum, area funeraria di Gaudo, tomba 1
Lekythos con amorino tra elementi vegetali da Paestum, area funeraria di Tempa del Prete, tomba 13attribuito al Pittore di AfroditePaestum, Museo Archeologico Nazionale
Va’, bella rosa, va’ con treccia soave cingi d’Apollinar la chioma; e quando sarà bianca d’incoronarla non ti scordare. Passi gran tempo E sempre t’ami Venere, rosa mia.[Marziale, Epigrammi]
La bella Stallia
Frammenti di cassettina, in osso; quattro balsamari in alabastro; due lekythoi; olletta; brocchetta miniaturisticada Santa Maria Capua Vetere, via Cupa degli Spiritifine II secolo a.C.Santa Maria Capua Vetere, Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua
Stallia, donna aristocra-tica dell’antica Capua, fu sepolta in una magnifica
Balsamari dalla tomba di StalliaSanta Maria Capua Vetere, Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua
Giovan Battista LusieriVeduta dei templi di PaestumBroomhall, collezione Elgin