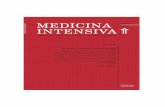Impacto de la formación en medicina narrativa en medicina ...
Pannelli mostra L'olio Lux Cibus Medicina
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pannelli mostra L'olio Lux Cibus Medicina
La prima menzione dell’olivo nell’Antico Testamento è quella del ritorno della colomba all’arca di Noé con in bocca un ramoscello d’olivo, segno della cessazione del Diluvio universale e dell’avvenuta pacificazione fra Dio e l’umanità:
“E la colomba tornò da lui verso sera; ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d’ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra.” (Genesi 8, 11)
La raffigurazione di quest’episodio assai frequente nel periodo medievale, lo si trova infatti in molti codici e mosaici od oreficerie, o fonti battesimali, o portali, ed ancora presente in qualche ciclo ad affresco quattro-cinquecentesco tende però a scomparire nel mondo moderno. Una bella eccezione è sicuramente il dipinto del preraffaellita John Everett Millais del 1850 conservato all’Ashmolean Museum di Oxford, con due fanciulle che accarezzano la colomba appena rientrata nell’arca.
Nell’Antico Testamento l’olio è l’indispensabile medium per realizzare l’unguento con cui consacrare profeti o re o sacerdoti; nel libro dell’Esodo (30, 22-33) è Dio stesso a rivelare a Mosé le precise istruzioni circa la preparazione di tale unguento cerimoniale:
22 Il Signore parlò a Mosè: 23 «Procùrati balsami pregiati: mirra vergine per il peso di cinquecento sicli, cinnamòmo odorifero, la metà, cioè duecentocinquanta sicli, canna odorifera, duecentocinquanta, 24 cassia, cinquecento sicli, secondo il siclo del santuario, e un hin d’olio d’oliva. 25 Ne farai l’olio per l’unzione sacra, un unguento composto secondo l’arte del profumiere: sarà l’olio per l’unzione sacra. 26 Con esso ungerai la tenda del convegno, l’arca della Testimonianza, 27 la tavola e tutti i suoi accessori, il candelabro con i suoi accessori, l’altare del profumo, 28 l’altare degli olocausti e tutti i suoi accessori; la conca e il suo piedestallo. 29 Consacrerai queste cose, le quali diventeranno santissime: quanto le toccherà sarà santo. 30 Ungerai anche Aronne e i suoi figli e li consacrerai perché esercitino il mio sacerdozio. 31 Agli Israeliti dirai: Questo sarà per voi l’olio dell’unzione sacra per le vostre generazioni. 32 Non si dovrà versare sul corpo di nessun uomo e di simile a questo non ne dovrete fare: è una cosa santa e santa la dovrete ritenere. 33 Chi ne farà di simile a questo o ne porrà sopra un uomo estraneo sarà eliminato dal suo popolo.
ed è proprio Aaronne il primo ad essere “unto” da Mosè stesso:
“Versò l’olio della unzione sul capo d’Aaronne e unse Aaronne, per consacrarlo” (Levitico, 8, 12) “Mosè prese quindi dell’olio dell’unzione e del sangue che era sopra l’altare; spruzzò Aaronne e i suoi paramenti, i suoi figli e i loro paramenti; così consacrò Aaronne e i suoi paramenti, i suoi figli e i loro paramenti con lui” (Levitico 8, 30) e anche “Poi prenderai l’olio dell’unzione, lo verserai sul suo capo e lo ungerai”. (Esodo, 29, 7), “Prenderai del sangue che è sull’altare, dell’olio dell’unzione e ne spruzzerai su Aaronne e sui suoi paramenti, sui suoi figli e sui paramenti dei suoi figli con lui. Così saranno consacrati lui, i suoi paramenti e insieme a lui i suoi figli e i loro paramenti” (Esodo 29, 21) .e ancora “12 Poi farai avvicinare
Aronne e i suoi figli all’ingresso della tenda del convegno e li laverai con acqua. 13 Farai indossare ad Aronne le vesti sacre, lo ungerai, lo consacrerai e così egli eserciterà il mio sacerdozio. 14 Farai avvicinare anche i suoi figli e farai loro indossare le tuniche. 15 Li ungerai, come il loro padre, e così eserciteranno il mio sacerdozio; in tal modo la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne, per le loro generazioni». (Esodo, 40, 12-16).
Tale unzione non fu però oggetto di interpretazioni iconografiche, mentre sotto questo aspetto ebbero molto più successo le unzioni successive dei re d’Israele, ed in particolare quella di Davide, in quanto l’esegesi vide nel giovane pastore, una prefigurazione del Cristo, unto del Signore.
Samuele prese il corno dell’olio e lo consacrò con l’unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. (1Samuele, 16, 13)
Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l’ho consacrato (Sal 88, 21)
e lo stesso Davide dice nel salmo 22
cospargi di olio il mio capo (v. 5).
In territorio bergamasco si conosce un solo dipinto in cui è raffigurato tale episodio: trattasi di una tela nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo, di anonimo seicentesco romano non lontano da Gerolamo Troppa. Meno frequenti sono iconograficamente le altre unzioni ricordate dalla Bibbia: quella di Salomone è testimoniata ad esempio da un affresco della Loggia detta di Raffaello nei Palazzi Vaticani, successivamente inciso da Orazio Borgianni e da uno di Pietro da Cortona in Palazzo Mattei a Roma, quella di Iehru da un esagono del pavimento marmoreo del Duomo di Siena.
Un miracolo relativo all’olio è quello che vede coinvolti il profeta Elia e la vedova di Sarepta di Sidone:
“Allora la parola del SIGNORE gli fu rivolta in questi termini: 9 «Àlzati, va’ ad abitare a Sarepta dei Sidoni; io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare». 10 Egli dunque si alzò, e andò a Sarepta; e, quando giunse alla porta della città, c’era una donna vedova, che raccoglieva legna. Egli la chiamò, e le disse: «Ti prego, vammi a cercare un po’ d’acqua in un vaso, affinché io beva». 11 E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: «Portami, ti prego, anche un pezzo di pane». 12 Lei rispose: «Com’è vero che vive il SIGNORE, il tuo Dio, del pane non ne ho; ho solo un pugno di farina in un vaso, e un po’ d’olio in un vasetto; ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio; la mangeremo, e poi moriremo». 13 Elia le disse: «Non temere; va’ e fa’ come hai detto; ma fanne prima una piccola focaccia per me, e portamela; poi ne farai per
te e per tuo figlio. 14 Infatti così dice il SIGNORE, Dio d’Israele: “La farina nel vaso non si esaurirà e l’olio nel vasetto non calerà, fino al giorno che il SIGNORE manderà la pioggia sulla terra”». 15 Quella andò e fece come Elia le aveva detto; lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. 16 La farina nel vaso non si esaurì, e l’olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il SIGNORE aveva pronunciata per bocca d’Elia”. (1 Re 17, 8-16).
Lo si può vedere ad esempio in un dipinto di Bernardo Strozzi conservato al Kunstistorisches Museum di Vienna.
Un altro concerne invece Eliseo e la vedova secondo la narrazione riportata dal Secondo Libro dei Re (4, 1-7)
“1 Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo, e disse: «Mio marito, tuo servo, è morto; e tu sai che il tuo servo temeva il SIGNORE. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi». 2 Eliseo le disse: «Che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» La donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d’olio». 3 Allora egli disse: «Va’ fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti; e non ne chiedere pochi. 4 Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli, e versa dell’olio in tutti quei vasi; e, a mano a mano che saranno pieni, falli mettere da parte. 5 La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli; questi le portavano i vasi, e lei vi versava l’olio. 6 Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Egli le rispose: «Non ci sono più vasi». E l’olio si fermò. 7 Allora lei andò e riferì tutto all’uomo di Dio, che le disse: «Va’ a vender l’olio, e paga il tuo debito; e di quel che resta sostèntati tu e i tuoi figli»”.
Questo racconto è assai raramente oggetto di raffigurazione artistica: ricordiamo ad esempio una grande tela di Giovanni Andrea Carlone in Santa Maria del Carmine a Genova.
Di un ramoscello d’ulivo è talvolta munita infine l’eroina biblica Giuditta di ritorno dall’uccisione notturna di Oloferne, come si vede nel celebre dipinto di Sandro Botticelli agli Uffizi.
1 John Everett Millais, Il ritorno della colomba nell’arca di Noè2 Giovan Battista Carlone, Eliseo e la vedova3 Bernardo Strozzi, Elia e la vedova di Sarepta di Sidone4 Aurelio Luini, Il ritorno della colomba nell’arca di Noè5 Orazio Borgianni (da un affresco delle Logge Vaticane di Raffaello), Unzione di Salomone
1 3 4
52
Antico Testamento
La presenza dell’olio nel Nuovo Testamento è tutto sommato abbastanza ridotta e pochi sono gli episodi in cui esso compare a pieno titolo.
Nella parabola delle dieci vergini raccontata dal solo Matteo (25, 1-13) esso riveste ovviamente un ruolo fondamentale:
1 Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 2 Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3 le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; 4 le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi. 5 Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. 6 A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! 7 Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 8 E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. 9 Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. 10 Ora, mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 11 Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! 12 Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. 13 Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.
Se tale parabola ebbe grande successo iconografico nel periodo medievale, grazie anche all’esegesi che ne diede Sant’Agostino nelle Enarrationes in Psalmos, successivamente parve interessare meno gli artisti, eccezion fatta per il catino absidale della Steccata a Parma di Parmigianino e qualche tela di artisti fiamminghi di fine Cinquecento, anche se nel diciannovesimo secolo, grazie in particolare ai Nazareni, essa ritrovò nel clima simbolista-letterario fin de siècle una rinnovata fortuna, testimoniata da molti dipinti assai interessanti.
Nel territorio bergamasco si conservava nella sacrestia della chiesa di Poscante di Zogno un dipinto settecentesco con questo tema, alquanto rovinato, che purtroppo non è più rintracciabile.
Nella parabola del Buon Samaritano, l’uomo malmenato viene curato con un impasto di olio e vino, segno dell’uso medicinale-curativo dell’olio. Racconta infatti Cristo, secondo quanto riportato nel Vangelo di Luca (10, 34) che:
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui.
Numerose sono le testimonianze figurative inerenti tale parabola, una delle più note di tutto il racconto evangelico, nelle quali il Buon Samaritano viene spesso raffigurato mentre si china sul corpo nudo riverso del malcapitato e vi versa da una ciotolina o da una fiala il medicamento a base di olio e vino; in tutto il territorio bergamasco, oltre al dipinto della Carrara attribuito a Giovambattista Langetti qui esposto, si conosce però un solo dipinto, di fattura modesta nella parrocchiale di Ponte San Pietro.
L’olio in forma di unguento ritorna poi prepotentemente con la figura della peccatrice che in casa di Simone il Fariseo unge i piedi a Cristo nel racconto di Marco (14, 3-9)
3 Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò l’unguento sul suo capo. 4 Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: «Perché tutto questo spreco di olio profumato? 5 Si poteva benissimo vendere quest’olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di lei. 6 Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un’opera buona; 7 i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. 8 Essa ha fatto ciò ch’era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 9 In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto».
probabilmente lo stesso episodio raccontato anche da Matteo (26, 6-13) e da Luca (7, 36-38) e con maggior precisione da Giovanni, che identifica la donna in Maria di Betania (12, 1-8):
1 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 2 E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 3 Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento. 4 Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 5 «Perché quest’olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?». 6 Questo egli disse non perché gl’importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. 7 Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 8 I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me».
Questa figura femminile si fuse poi nella tradizione popolare cristiana con Maria di Magdala, ovverosia Maria Maddalena, che venne spesso raffigurata per l’appunto col vasetto dell’unguento fra le mani o accanto a sé; per quel che più attiene alla presente mostra abbiamo selezionato, tra le molte immagini magdaleniche della diocesi bergamasca, il dipinto di Domenico Carpinoni nella chiesa del Paradiso di Clusone che ritrae da sola la santa ed una scena dell’unzione dei piedi a Cristo. conservata a Sorisole di anonimo artista seicentesco.
Ancora con il vasetto di unguenti troviamo Maria Maddalena, da sola nella frequentissima scena del Noli me tangere o assieme alle altre due Marie, allorquando si reca ad ungere il corpo morto del Redentore già deposto nel sepolcro, come nel dipinto attribuito a Giuseppe Roncelli a Stezzano o nelle più rare scene in cui si sta procedendo all’Imbalsamazione del corpo di Cristo, ad esempio in una celebre tavola di Giovanni Bellini alla Pinacoteca Vaticana, o nel momento in cui si reca ad acquistare il vasetto di unguenti da un venditore, come in un dipinto di Paolo Gerolamo Piola, transitato sul mercato antiquariale romano nel 2002.
Se poco risalto ha l’olio nel Nuovo Testamento, i rami di ulivo e gli ulivi in generale segnano quasi simbolicamente tutto il percorso della Passione di Cristo: dall’ingresso di Cristo in Gerusalemme fino alla sua cattura nella serata di giovedì presso il Getsemani.
Cristo entrando in città viene infatti acclamato dalla gente, e come riportano tre dei quattro
evangelisti la folla stende sulla strada rami e fronde, probabilmente d’ulivo, anche se non specificato esattamente, considerato che l’ingresso avvenne nei pressi del Monte degli Ulivi:
La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via (Matteo 21, 8)E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, che avevano tagliate dai campi (Marco 11, 8)Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando (Giovanni 12, 12-13)Di questa scena in Bergamasca, oltre al dipinto palmesco di collezione privata qui esposto, ricordiamo i dipinti di Giuseppe Cesareo a Calolziocorte e a Martinengo, in cui donne e bambini staccano dagli alberi rami di ulivo, per poi agitarli davanti al Cristo sull’asino.
Dopo la Cena Cristo si reca sul Monte degli Ulivi a pregare e lì viene catturato dalle guardie inviate dai sommi sacerdoti e baciato da Giuda, come tutti e quattro gli Evangelisti ricordano
Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cèdron, dove c’era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli (Giovanni, 18, 1)Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani (Matteo 26, 36)Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani (Marco 14, 32)Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi (Luca, 22, 39)
e non dimentichiamo che il nome Getsemani (gath shemanim) significa per l’appunto “torchio d’olio” e presuppone dunque la presenza in quel giardino di un oliveto, e di un relativo pressoio e che addirittura i commentatori rabbinici postulavano che il ramoscello portato dalla colomba a Noè venisse giustappunto da lì.In Bergamasca molte sono le scene che raffigurano sia il momento dell’agonia con il Cristo in preghiera, sia quello successivo della sua cattura. Per quanto concerne il primo menzioniamo, oltre a quello qui esposto di Francesco Capella a Villongo, un dipinto di Gian Paolo Cavagna ad Ardesio, uno di Vincenzo Angelo Orelli a Fiorano al Serio, ed un altro settecentesco in Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo, mentre del secondo ricordiamo un dipinto tardo-seicentesco ad Adrara San Martino ed una tela settecentesca in Curia a Bergamo.
Il ramo d’ulivo è inoltre presente talvolta nella scena dell’Annunciazione a Maria retto dall’arcangelo Gabriele, in particolare in opere d’arte del territorio senese in voluta contrapposizione col più consueto giglio mariano, presente nello stemma della rivale Firenze, e anche, assai raramente, in quella dell’Annuncio ai pastori nelle mani dell’angelo in volo di notte sopra Betlemme, come nella tavola del pittore senese Paolo di Giovanni Fei alla Pinacoteca Vaticana.
Un ramoscello d’ulivo è addirittura tenuto in mano da un Gesù Bambino benedicente sopra il globo terrestre nel bel dipinto di Elisabetta Sirani oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e ne brandisce, un altro, insieme al più consueto vessillo scudo-crociato, il Cristo mentre sta risorgendo in una tavola del senese Sano di Pietro oggi al Museo di Colonia.
1. Vasily Perov, Cristo in preghiera nell’orto del Getsemani2. Artista bergamasco seicentesco, Le vergini sagge e le vergini folli, Poscante di Zogno3. Teofilo Patini, Il buon samaritano4. Artista bergamasco della fine del Seicento, Cattura di Cristo nell’orto del Getsemani, Adrara San Martino5. Giovanni Bellini, Imbalsamazione di Cristo morto
1 2
Nuovo Testamento
I SantiL’ulivo ricorre come segno distintivo-attributo di alcuni santi anche se è raro che essi vengano raffigurati insieme al ramoscello.
Ad esempio i santi della congregazione degli olivetani, ed in primis il loro fondatore Bernardo de’ Tolomei; l’ulivo compare comunque in maniera sporadica ad accompagnare il santo, talvolta come parte dello stemma olivetano, più raramente tenuto dal santo stesso, come ad esempio nella tavola di Girolamo Marchesi da Cotignola oggi alla Gemäldegalerie di Dresda, o recatogli in dono dal Bambin Gesù come nella tela di Giovan Battista Natali del Museo Civico Ala Ponzone di Cremona, datata 1674, o posto alle sue spalle come nell’affresco di Giulio Quaglio in San Paolo d’Argon.
Talvolta è in mano anche a san Norberto di Xanten, vescovo e fondatore dei Canonici regolari Premostratensi, a san Bruno, fondatore dei certosini, che in una stampa tardo-cinquecentesca è accompagnato anche dal verso Ego sicut oliva fructifera in domo Dei, tratto dal salmo 51, 10, alla martire Restituta, al beato agostiniano Antonio Torriani e alla beata agostiniana Veronica Negroni da Binasco, come nel dipinto di Luigi Scaramuccia a Binasco.
Di un ramoscello d’ulivo è munita talvolta santa Marta, per intingerlo a mo’ di aspersorio nel secchiello con l’acqua benedetta, contro la tarasca da lei soggiogata, come si può vedere in una tavola di Ambrogio da Fossano detto il Bergognone oggi alla Carrara.
L’attributo della lucerna ad olio è talvolta associato invece a santa Lucia, la martire siciliana il cui attributo è quasi sempre quello dei propri occhi su un piattino o infilzati in uno spillone: con una lucerna di forma tronco-conica in mano viene raffigurata in una tavola assegnata alla scuola del pittore veneziano tardo-quattrocentesco Bartolomeo Vivarini nella parrocchiale di Ranica.
Un piatto di olive, come simbolo estremo di parca frugalità, accompagna il giovane Filippo Neri, nei suoi digiuni, come si può vedere in un’incisione su disegno di Pietro Antonio Novelli, incisa da Innocente Alessandri compresa in un volume della fine del Settecento dedicato al santo fiorentino.
Nei primi secoli dell’era cristiana una delle torture preferite era quello di calare il corpo del martire in un pentolone di olio bollente, o di versaglielo addosso, tormento che però in nessun caso ha portato alla morte del santo, e questo avvalora ancor più il valore comunque positivo dell’olio; fra i santi che subirono tale pena il più famoso fu sicuramente san Giovanni Evangelista, secondo il racconto che ne fece Tertulliano verso il 200, nel suo De praescriptione haereticorum quando Domiziano verso il 92 d.C lo convocò a Roma e dopo averlo fatto rasare i capelli in segno di scherno, lo fece immergere in una caldaia di olio bollente davanti alla porta Latina. Tale episodio rappresentato in maniera assai frequente conta anche nella Bergamasca svariate raffigurazioni fra cui vanno ricordate la splendida tela di Giuseppe Maria Crespi a San Paolo d’Argon, quella attribuita a Gaetano Peverada a Ponte San Pietro ed un affresco a Gromo.
Altri santi ad essere torturati nell’olio bollente furono: Felice e Fortunato, secondo quanto ricorda una Passio redatta verso il V secolo, e come si vede in un dipinto di Angelo Trevisani a Chioggia, Crispino e Crispiniano, protettori dei calzolai, li si veda sullo sfondo di un dipinto a loro dedicato a Gandino, Lucia, stando alla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, cui venne versata addosso una grande quantità di olio bollente, come ben si vede nell’affresco di Altichiero nell’oratorio di San Giorgio a Padova, dove viene preparato il pentolone per poi riversarglielo addosso, Veneranda Parasceve martirizzata sotto Antonino il Pio verso il 160, Agapito, Martina, Cristina, Rufina e Seconda, Giorgio come si vede in un riquadro ad affresco nella volta della sagrestia della parrocchiale di Ardesio della seconda metà del Seicento, Pantaleone ad esempio in un dipinto di Gaetano Peverada a Redivo di Averara e in un altro attribuito a Francesco Salmeggia a San Pantaleone a Scanzorosciate, e Cecilia, di cui è nota una celebre incisione di Marcantonio Raimondi tratta da un’invenzione di Raffaello, o un bell’affresco di Gervasio Gatti nella chiesa di San Pietro al Po a Cremona, o una tela di Camillo Procaccini in San Niccolò de’ Tolentini a Venezia.
Molteplici sono del resto gli eventi miracolosi che hanno a che fare con l’olio ed in particolare con quello contenuto nelle lampade che ardono nelle chiese e nei santuari davanti a venerate immagini o al di sopra di monumenti funebri di santi: dalle lampade che bruciano miracolosamente senza mai spegnersi, all’olio in esse contenuto che opera miracoli per virtù di qualche santo o da esse prelevato per essere ingerito o applicato ai malati, dal convertirsi dell’acqua in olio, all’improvviso apparire-moltiplicarsi di olio all’interno di un recipiente, all’olio che trasuda dalle reliquie dei martiri o da immagini miracolose della Vergine, a quello che sgorga improvvisamente dal terreno.. Fra quelli più noti ne segnaliamo alcuni che hanno avuto una rilevanza iconografica significativa: il miracolo di san Nilo che guarisce un indemoniato con l’olio di una lampada, in un celebre affresco a Grottaferrata di Domenichino, il miracolo dell’olio di san Diego d’Alcalà, prelevato da una lampada che ardeva davanti ad un altare dedicato alla Vergine col quale il santo guarisce bambini, storpi e/o ciechi, presente in molte tele d’inizio Seicento, fra cui una di Carlo Baciocchi a Quinzano, nel Bresciano, il miracolo di santa Chiara d’Assisi del vaso ricolmo d’olio, ad esempio nel dipinto di Franz Sebald Unterberger nel monastero delle Clarisse a Bressanone o ancora il miracolo di san Narciso vescovo di Gerusalemme che trasformò l’acqua in olio per le lampade della sua chiesa il giorno di Pasqua.
Vanno ricordati inoltre l’episodio di san Remigio di Reims, al quale secondo Incmaro, un angelo, in forma di colomba, avrebbe portato una fiala ripiena d’olio per ungere la fronte di Clodoveo I, primo re dei Franchi, al suo battesimo e quello del già ricordato san Pantaleone di Nicomedia, che venne martirizzato legato ad un albero di ulivo ed un tronco di ulivo germogliò miracolosamente quando la testa del santo decapitato cadde a terra (lo si veda ad esempio nella tela di anonimo artista locale seicentesco della parrocchiale di Averara, in cui attorno all’albero è un cartiglio con la scritta OLIVA FRUCTIFERA IN TRONO DEI e in quella attribuita a Francesco Salmeggia a San Pantaleone di Scanzorosciate).
Ben due sante donne inoltre portano il nome di Oliva; una di Anagni, l’altra, assai più nota, patrona di Palermo..
In merito all’uso medicamentale dell’olio come base per unguenti, i santi medici, oltre al Pantaleone già menzionato, che hanno ovviamente più a che fare con tali prodotti sono ovviamente Cosma e Damiano, il cui culto in Bergamasca non è molto diffuso e poche sono le raffigurazioni in cui siano presente i preziosi contenitori dei loro unguenti: ricordiamo un affresco votivo a Clusone nella chiesa di Sant’Anna e di San Defendente di anonimo bergamasco della fine del Quattrocento, un affresco frammentario della parrocchiale di Sarnico della fine del Quattrocento, un dipinto della prima metà del Seicento in cui compaiono insieme a san Pantaleone a Viandasso di Ranica, la tela, una di una serie di tre, a Scano al Brembo, ascritta a Giovanni Raggi e bottega, una paletta tardo-settecentesca a Sala di Calolziocorte con la Vergine col Bambino e i due santi, una tela di Mauro Picenardi a Verdello, in cui un angelo in volo reca un vasetto, appoggiato su una nube.
In merito poi a medicamenti operati sui santi ricordiamo il celebre episodio relativo a san Sebastiano curato da Irene e da altre figure (un angelo-alcune pie donne), in cui in alcuni dipinti qualcuno tiene vasetti contenti unguenti medicamentosi o quello di san Pietro che in carcere cura sant’Agata dopo il martirio, riapplicandole i seni recisi con un unguento miracoloso, il cui vasetto è talvolta retto da un angelo, che accompagna il santo.
Per quanto concerne infine il rapporto fra la Vergine e l’ulivo, va innanzitutto ricordato che una delle litanie lauretane è proprio Quasi oliva speciosa in campis (Ecclesiaste 24, 19), che da per l’appunto il titolo al celeberrimo dipinto eseguito dal ligure Niccolò Barabino ed esposto all’Esposizione Nazionale di Belle Arti nel 1887 e poi acquistato dalla regina Margherita, di cui oggi non si conosce l’ubicazione, replicato successivamente l’anno successivo per l’altare della chiesa di Santa Maria della Cella a Sampierdarena, di cui qui si espone un bozzetto preparatorio, e che ben presto divenne una sorta di vero e proprio santino, tanto da essere riprodotto e replicato in svariati modi e mezzi.Rami di olivo accompagnano spesso la Vergine a partire dal Cinquecento, in particolare nelle scene dell’Immacolata Concezione, ove talvolta è raffigurata anche la litania sopra ricordata.Per quanto riguarda l’arte bergamasca va rammentata a tal proposito una tavola di Andrea Previtali alla National Gallery di Londra con la Madonna col Bambin Gesù, in cui la Vergine è raffigurata nell’atto di piegare verso il figlio un ramoscello d’ulivo ed una di Pietro Ronzelli oggi alla Carrara con l’Ascensione di Maria ove campeggia a destra un frondoso ramo d’ulivo.
1. Giuseppe Maria Crespi, Martirio di san Giovanni Evangelista, San Paolo d’Argon2. Anonimo ceramista cinquecentesco (da un’incisione di Marcantonio Raimondi), Martirio di S. Cecilia3. Francesco Caivano, SS. Trinità, san Bruno e altri santi certosini4. Anonimo bergamasco seicentesco, I santi Pantaleone, Cosma e Damiano, Viandasso di Ranica5. Sisto Badalocchio, Irene cura san Sebastiano
1
2
3 5
4
Mitologia e Letteratura
1. Giuseppe Santi, Filemone e Bauci offrono olive a Giove e Mercurio travestiti2. Noël Hallé, Contesa tra Atena e Poseidone3. Cornelis Bloemaert il giovane (da un affresco di Pietro da Cortona), Atena insegna a Cecrope l’arte di piantare l’ulivo4. Francesco Monti, Allegoria della Pace, Grumello del Monte5. Vincenzo Angelo Orelli, Allegoria della Fama, Alzano Lombardo6. Francesco Savanni, Allegoria della Fede, Tavernola Bergamasca
2 4 5
1
Quanto l’ulivo fosse fondamentale per la cultura greco-romana lo può a sufficienza dimostra-re la sua presenza in svariati episodi tratti dalla mitologia e dalla letteratura ad essa correlata.
L’episodio probabilmente più celebre, narrato da tanti scrittori fra cui Ovidio, Apollodoro, Servio e Probo, è quello della disputa fra Atena e Poseidone per il possesso della città che prenderà il nome di Atene, vinta dalla dea creando per l’appunto l’olivo, che gli abitanti della città considerarono più utile del cavallo o della fonte d’acqua salata, creato da Poseidone. Da questa vicenda Atena avrà l’ulivo come uno dei suoi simboli distintivi, con il quale è spesso contrassegnata dall’arte antica a quella rinascimentale fino ai giorni nostri, ad esempio sul recto delle 100 lire, emesse dalla Repubblica Italiana a partire dal dopoguerra.
Direttamente collegato a quest’episodio è poi quello della stessa Atena che insegna a Cecrope l’arte di piantare l’ulivo, soggetto che Pietro da Cortona ha trattato in un affresco nella sala di Giove di Palazzo Pitti a Firenze, successivamente divulgato per via incisoria da Cornelis Bloemaert il Giovane.
Un piatto con olive viene offerto da Filemone e Bauci, come racconta Ovidio nelle Metamor-fosi (libro ottavo) ai due viandanti, in realtà Zeus e Mercurio mascherati, come segno di ospi-talità e di mensa alquanto povera; tale particolare è poco ricordato dagli artisti, ma vi sono interessanti eccezioni, che val la pena ricordare: le troviamo in bella vista in un affresco in una sala del Palazzo del Giardino a Sabbioneta, ascritto a Bernardino Campi e in un dipinto ascritto a Giuseppe Santi, databile verso il 1798 circa, di proprietà della Fondazione Sorgente Group di Roma.
Ancora dalle Metamorfosi ovidiane (libro settimo) è tratto il racconto di Medea ed Esone, che mescola con un ramo d’ulivo la pozione che farà letteralmente ringiovanire Esone, come si può vedere nel dipinto di Girolamo Macchietti nello Studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio a Firenze, in quello di Pietro Bellotti all’Accademia dei Concordi a Rovigo o in un’incisione di Giuseppe Asioli tratta da un affresco bolognese di Pellegrino Tibaldi, in cui il ramoscello è dentro il pentolone fumante.
Un celebre episodio legato all’olio per lampade è ovviamente quello in cui Psiche fa scivola-re sul corpo dell’amato Amore un goccio di olio bollente che fa ridestare e scappar via Eros dal talamo in cui aspettava la giovane Psiche; tema derivato dalle Metamorfosi di Apuleio è stato uno dei più rappresentati del ciclo della favola di Amore e Psiche ed è in pratica sempre presente nei cicli affrescati aventi a tema tale soggetto e ritorna spesso anche autonomamente in svariati dipinti.
In ulivo massiccio era inoltre intagliato il letto di Ulisse, come pure d’ulivo era la mazza che Ercole porta con sé a partire dalla sua prima fatica. E ancora Polifemo venne accecato con un ramo d’ulivo ed un ramoscello accompagna talvolta Periandro, secondo tiranno di Corinto.
Il ramoscello d’ulivo è inoltre attributo distintivo di una serie quanto mai ampia di allegorie; la più significativa è ovviamente la Pace, per il territorio bergamasco ricordiamo un affresco di Francesco Monti a Grumello del Monte del 1754, uno di Carlo Innocenzo Carloni a Ta-gliuno di Castelli Calepio ed un monocromo di Filippo Comerio a Gorlago, a ricordo della biblica colomba mosaica, e spesso raffigurata in atto di abbracciare, baciare od incoronare d’ulivo la Giustizia, come in un affresco settecentesco a Grandosso, o di calmare la Guerra, disarmandola o calpestandone le insegne.
Lo ritroviamo in rari casi anche associato alla virtù teologale della Fede –ha infatti il capo coronato d’olivo in un affresco di Francesco Savanni a Tavernola Bergamasca.
A detta della normalizzazione operata da Cesare Ripa, esso connota inoltre la Beatitudine, la Clemenza, la Concordia, la Conservazione, il Contento, il Dispregio del mondo (ad esempio in un affresco di Vincenzo Angelo Orelli ad Alzano Lombardo), l’Economia, la Fama buona (in un affresco dell’Orelli ad Alzano Lombardo), la Gagliardezza, la Grassezza, la Grazia di-vina, il Governo della repubblica, l’Incostanza d’amore, la Magnanimità, la Mansuetudine, la Misericordia (in un affresco dell’Orelli a Ranica e in uno ad Arcene), la Riconciliazione (ancora in un affresco dell’Orelli ad Alzano Lombardo), la Sapienza, la Sicurezza, l’Unione Felice e la Vittoria.
Esso è anche attributo di alcune regioni italiane, sempre a detta di Cesare Ripa, ovverosia la Puglia, la Marca Trevigiana e la Sardegna.
Con una lanterna accesa in mano è raffigurata l’allegoria della Vigilanza, in un dipinto sei-centesco a Gandino, dal particolare formato stretto e verticale, a ricordo del riferimento della parabola evangelica delle vergine sagge, che attesero la venuta dello sposo con la lanterna debitamente accesa.
Come elemento medicamentoso ritroviamo poi il vasetto d’unguento a base oleosa in alcuni celebri episodi tratti dall’epica antica, che ebbero un forte riscontro dal punto di vista ico-nografico: i più celebri sono indubbiamente Angelica che cura Medoro, tratto dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e Tancredi medicato da Erminia e Vanfrino dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso.
In merito a presenze letterarie specificatamente dedicate all’olivo bisogna attendere fino al 1901 quando Giovanni Pascoli editò sulla celebre “Rivista Ligure” n. 30, a. VII, il suo Inno all’Olivo, peraltro corredato da una bella incisione di Plinio Nomellini, artista di stile liberty, che lavorava insieme ad altri artisti come Giorgio Kienerk nel campo della grafica pubblici-taria delle maggiori ditte olearie del primo Novecento, in primis la Sasso di Imperia, allora della famiglia Novaro, che era anche la massima finanziatrice della rivista di cui sopra.
Paesaggi e Nature morteSe sparute raffigurazioni di alcuni olivi possono essere riscontrate nell’arte paesaggistica fin dal tardo Medioevo, per lo più come elementi di sfondo, o all’interno di composizioni assai articolate, è però soltanto dalla metà del diciannovesimo secolo che l’olivo inizia a suscitare un forte e singolare interesse fra i pittori di paesaggio; per ciò che concerne il panorama ita-liano i pittori che più ritrassero campi o boschi con ulivi furono per ovvie ragioni di presenza di queste coltivazioni, quelli liguri, i toscani e i siciliani, anche se non mancarono raffigura-zioni anche in altri contesti culturali, ad esempio collegate ai laghi di Garda, e d’Iseo, o nel napoletano a Capri, o alla campagna romana nei pressi di Tivoli,
Molti furono anche i pittori stranieri che trattarono questo tema; ricordiamo fra i più noti gli Uliveti di Van Gogh, quelli di Monet realizzati nel suo soggiorno a Bordighera, di Renoir, di John Singer Sargent, Charles Daubigny, Mary Cassat, Elihu Vedder, Andrè Derain, Georg In-nes, Georges Braque, Nikolaj Ge,William Merritt Chase, Henri Harpignies, Joan Mirò, Henri Matisse, Pierre Bonnard, e Frederick Edwin Church e Vasily Polenov sulle colline di Geru-salemme.
Una certa fortuna iconografica l’ebbe anche la scena della raccolta delle olive; già presente nell’arte romana antica, in mosaici e in decorazioni fittili, la si ritrova poi nel Medioevo, in alcune miniature dei Tacuina sanitatis o nell’illustrazione dei lavori agricoli di alcuni cicli di mesi, ad esempio per il mese di Novembre nel celebre tondo in terracotta invetriata di Luca della Robbia oggi al Victoria and Albert Museum di Londra, o nel pavimento musivo romani-co della Cattedrale di Bobbio, per poi trovare un discreto successo nella pittura della seconda metà dell’Ottocento, maggiormente interessata a ritrarre in maniera realistica i vari lavori dei campi.
Tra gli esempi più noti in Italia, oltre ai dipinti in mostra del fiorentino Luigi Bechi e dell’a-bruzzese Francesco Paolo Michetti, ricordiamo analoghe scene del monzese, ma attivo in Liguria, Pompeo Mariani, del fiorentino Niccolò Cannicci, del livornese Adolfo Tommasi, probabilmente la più interessante anche per le notevoli dimensioni oggi al Museo di Livorno, del fiorentino Arturo Faldi, purtroppo perduta ed intitolata Un dubbio, del fiorentino Tele-maco Signorini, del genovese Rubaldo Merello, del lombardo, ma attivo in Toscana, Angelo Torchi, dei siciliani Francesco Lojacono, Antonino Leto, Mario Mirabella e Michele Catti, del bolognese Adolfo Bignami, del romagnolo, ma attivo a Napoli, Attilio Pratella, fino ad arrivare al tunisino-livornese Moses Levy e più tardi già nei primi decenni del Novecento ad esempi di Mino Maccari, Ardengo Soffici e Gerardo Dottori.
La più interessante raccolta di opere dedicate espressamente a questo tema la realizzò però Arnaldo Ferraguti, in alcune illustrazioni che corredano il contributo Il raccolto delle ulive – disegni di Arnaldo Ferraguti, compreso nel n. 48, del 26 novembre 1899, annata XXVI, dell’allora celebre rivista Illustrazione Italiana, edita dai Treves di Milano, in cui l’artista ritrasse alcune lavorazioni del ciclo dell’ulivo da lui realizzate durante un suo soggiorno in Abruzzo.
Assai rara invece è la raffigurazione di frantoi; li si può ritrovare in alcuni incisioni che cor-redano volumi di divulgazione scientifica sette ed ottocenteschi, ma molto più significativa è l’incisione eseguita da Jan Van der Straet (Giovanni Stradano), compresa entro la raccolta Nova Reperta, commissionatagli da Luigi Alamanni tra il 1587 ed il 1589 e poi incisa da Phi-lip Galle, in cui si raffigura tutta la fase della raccolta e della spremitura delle olive. Un uomo intento a girare un frantoio è inoltre incluso dallo stesso Stradano nel dipinto il Laboratorio dell’Alchimista eseguito nel 1570 per lo Studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio a Firenze.
Un posto a se stante va riservato inoltre al dipinto intitolato la Danza delle olive, di Giusep-pe Ferdinando Piana, del 1906, donato da Eugenia Mylius alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, che raffigura una sorta di trasposizione allegorica del nostro tema. Lo stesso artista raffigurò alcuni ulivi in un grande dipinto conservato alla Fondazione Mariani a Bordighera, intitolandolo allegoricamente Visione di pace, lo stesso titolo che il toscano Giulio Cesare Vinzio diede ad un suo dipinto analogo.
Ben minore fortuna hanno avuto invece l’oliva e l’olio nella raffigurazione delle nature mor-te; alimento poco in uso nella dieta alimentare dei secoli passati l’oliva è rimasta relegata a frutto esotico e così la sua presenza nelle tavole imbandite dipinte è alquanto episodica. Nel contesto italiano sono assai rari gli artisti che rappresentano le olive; è il caso ad esempio di Francesco Codino, in realtà un artista tedesco, Franz Godin, trapiantato in Italia, di cui co-nosciamo alcune opere in cui sono presenti olive, ad esempio due tavole conservate ai Mu-sei Civici di Padova ed una alla Carrara, di Paolo Antonio Barbieri, fratello del più celebre Guercino, di Nicola Levoli, di Carlo Maria Magini e di Giacomo Nani, pittore napoletano settecentesco, in alcune opere al Museo della Reggia di Caserta.
Nelle tavole del nord-Europa invece è più facile ritrovare qualche oliva sparsa sulla tavola o in bella vista su piatti d’argento: ad esempio in dipinti di pittori olandesi quali Osias Beert, Peter Claesz, Willelm Claesz Heda, Adriaen Craen, Floris van Schooten, belgi come Clara Peeters, Jacob van Foppens, svizzeri come Albrecht Krauw, tedeschi come Peter Binoit,Ge-org Flegel, spagnoli come Juan van der Hamen y Leon, Juan Bautista de Espinosa, fino a giungere alla bottiglia con olive in salamoia di Jean-Baptiste Chardin del 1760, e agli orci con olive presenti in alcuni dipinti di Cezanne.
Uno scartoccino pieno di piccole olive nere è inoltre appoggiato rovesciato su un ripiano in un dipinto allegorico di Jusepe De Ribera intitolato Allegoria del gusto, oggi allo Wadsworth Atheneum Museum of Art di Hartford.
Una boccettina con olio ed una con aceto sono presenti in una bella natura morta realizzata da Giacomo Ceruti, ed oggi esposta alla Pinacoteca di Brera a Milano, mentre un’oliera in me-tallo è raffigurata in una Natura morta di Carlo Magini oggi nella collezione della Carifano di Fano.
Alcuni piatti con olive si possono inoltre ritrovare anche in alcune raffigurazioni dell’Antico Testamento, ad esempio nella scena di Esaù vende la primogenitura del caravaggesco olan-dese Hendrick ter Brugghen oggi al Museo Thyssen di Madrid o di pasti evangelici: ad esem-pio in un’Ultima Cena di Alessandro Allori in Santa Maria Novella a Firenze e in una Cena in Emmaus di Jean-Baptiste de Champaigne al Museo di Gand e in una di Abraham Bloemaert al Museo di Bruxelles.
1. Antonino Leto, Raccolta delle olive2. Adolfo Tommasi, Raccolta delle olive3. Telemaco Signorini, Ulivi a Settignano4. Jusepe de Ribera, Allegoria del gusto5. Franz Godin (Francesco Codino), Natura morta con piatto di olive
1
53
2
4
La torchiatura dell’OlioNell’antichità l’olio si produceva localmente torchiando diverse qualità di semi, dalle olive ai cereali, alle noci, ai vinaccioli (residui della torchiatura dell’uva), al ravizzone, al lino. Nella bergamasca la coltivazione dell’ulivo era possibile solo in Valcalepio e in Valle San Martino, ma la produzione era scarsa, ampiamente insufficiente perché l’olio d’oliva era indispensabile anche per la lavorazione dei panni lana e per i filatoi di seta. L’olio di vinaccioli si produceva solamente per le lampade ed era inadatto all’uso commestibile.
L’olio che si otteneva dalla spremitura delle ghiande era usato per la lavorazione e la colorazione delle pelli; a Romano le ghiande si torchiavano al mulino della Rasica ed era richiesto dai numerosi pellettieri che in particolare producevano i «caligar», gli stivaletti alla spagnola. L’olio di origine animale (ossa, pelle, grassi) era utilizzato soltanto per gli attrezzi (ruote di carri e carrozze, perni e trasmissioni di vario genere).
Di altro tipo era certamente l’olio commestibile usato anche per usi farmacologici o artigianali (falegnameria, vernici e colori per le opere d’arte pittorica); Romano produceva olio commestibile in quantità sufficiente per la popolazione mediante torchiatura di semi di lino, di ravizzone e di noci. L’olio di ravizzone conteneva una componente acida di sapore poco gradevole, serviva pertanto per allungare altri tipi di olio. Quello di noci era molto gradevole ma la produzione era scarsa; prevalentemente restava pertanto l’olio di lino per l’utilizzo in cucina.La coltivazione del lino da fibre fino a tutto il ‘700 era molto praticata nelle nostre campagne, favorita dal clima temperato-umido e da notevoli possibilità di irrigazione. Veniva coltivato soprattutto il lino da fibra, si seminava a primavera e raccoglieva a luglio-agosto. Non aveva bisogno di molta umidità.
Ogni cascina aveva il suo «macero» nel quale venivano poste le fibre perché si ammorbidissero; le donne poi battevano i mazzi di pianticelle per sgranarlo. Infine con grandi pettini di ferro, la fibra di lino, ormai pronta, veniva pulita dalle scorie e accantonata per la filatura che veniva fatta nelle lunghe veglie invernali al caldo tepore delle stalle e alla luce delle candele e delle lampade.
I fusti centrali del lino da fibra, dopo la fioritura e la formazione del seme, erano usati anche per costruire finissime scope da usare nelle case del borgo; erano perciò soggetti a facili ruberie, tanto da giustificare un capitolo di divieto negli “Statuti dei danni datti” approvati nell’anno 1598.Era coltivato anche il lino da seme, che aveva bisogno di poca umidità. I semi erano utilizzati prevalentemente per produrre olio. L’olio di lino allora serviva per tutti gli usi: per arrostire il pesce, per condire l’insalata, per fare le pappine, per curare le bestie e gli uomini, per preparare medicamenti, creme e profumi.
Due erano i torchi per olio di Romano di cui abbiamo conoscenza, uno di proprietà congiunta tra le famiglie Turizeni e Pedruolo, l’altro di proprietà dei fratelli Suardi; questi ultimi poi lo mettevano in vendita “alla botega d’oglio de S.ri Gabriele e f.lli Sovardi” le cui vetrine si aprivano sotto i portici antistanti al Palazzo della Comunità in Piazza Grande.
Ma l’olio di lino era il prodotto meno importante in termini commerciali, limitato com’era a una vendita locale; ben più importante economicamente era il commercio del lino per produrre tessuti; affluiva sul nostro mercato grandi quantità di prodotto dal cremonese tramite il consueto e tollerato contrabbando. Acquistato dai commercianti romanesi il lino era avviato al grande mercato della città e da qui il prodotto grezzo prendeva la via delle valli, soprattutto la Valseriana, per essere trasformato nei famosi panni bergamaschi, o «bergamini», esportati in Germania, Ungheria, Friuli, Regno di Napoli, Grigioni e ancora più lontano fino al Mar Nero.Il mercato del lino di Romano aveva luogo negli stessi giorni del mercato pubblico; gli era riservato un luogo privilegiato, cioè «la Loggia del Pubblico Palazzo». In quel luogo si riunivano i «Trafficanti di lino» o «Linaroli» per contrattare le merci. A trattativa conclusa le merci erano pesate sopra la «pesa del lino», collocata appunto sotto i portici del Palazzo nello stesso posto in cui aveva luogo il mercato.
I SacramentiLAMPADAL’uso della lampada per il culto è di ogni tempo e luogo, rispondente alla necessità di illuminare gli edifici sacri; e poiché la cera di api fu sempre molto costosa, si ricorse facilmente all’olio raccolto in lampade dalle forme e dalle decorazioni più varie, perché nella Chiesa fu consuetudine rendere pure simbolico ciò che era nato dalla necessità. Le vigilie notturne, i vespri esigevano l’accendersidi numerose lampade: l’uso di esse ogni sera suggeriva anzi l’offerta della luce a Dio accompagnata dal canto del lucernario.L’illuminazione di una cattedrale esigeva un’attrezzatura non indifferente: per questo troviamo presso ogni chiesa più «cicendelari» (da «cicindela», tubetto metallico riempito di olio e lucignolo con il quale venivano accese le 1ampade), uno dei quali doveva trovarsi sempre nella sacrestia per essere pronto al suo ufficio. Le lampade erano isolate ovvero raggruppate sulla «corona pharalis », ovvero «gabata ». Il loro uso è testimoniato e precisato già dall’inventario di Cirto (Algeria) del 303 (cf. DACL, lnventaires, VII, I, col. 1396 sgg.), dai canoni d’Ippolito (n. 4), da molte notizie sparse nel Liber Pontificalis ed in modo curioso da Beroldus, Ordo della Chiesa milanese del sec. XII. Seguendo l’uso frequentissimo fra i pagani, già i primi cristiani usarono porre lampade sulle tombe, ma a differenza dei pagani, essi le accendevano per accentuare il simbolismo ivi racchiuso di un’altra vita. Ciò avveniva più frequentemente sulle tombe dei martiri. Ne è documento interessantissimo la raccolta di ampolle, conservate nella basilica di Monza, recate da Roma dall’abate Giovanni alla regina Teodolinda, con gli olii che, per concessione del Papa, egli raccolse dalle lampade che ardevano nei cimiteri suburbani innanzi alle varie tombe dei martiri. Nella liturgia del Sabato Santo è conservata la benedizione del fuoco nuovo sprigionato dalla pietra e raccolto da una lampada, portata in alcune chiese, nelle processioni pasquali e solitamente sospesa a fianco dell’altre onde prendervi il fuoco da accendere le candele.Il Codice di diritto canonico (can. 940), stabilisce: «Davanti al tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucaristia, brilli perennemente una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia onorata la presenza di Cristo».
ARTECon i mutati indirizzi artistici nel basso medioevo, anche la forma delle lampade si va modificando, come lasciano intendere soprattutto le rappresentazioni che se ne hanno in affreschi e miniature. Per tutto il periodo romanico e gotico si usò frequentemente materiale prezioso e le lampade divennero raffinatissimi oggetti delle arti industriali. Per la maggior parte esse furono a sospensione: in Oriente si ebbero lampade in vetri colorati, in alabastro, in avorio (uno splendido esemplare con montatura d’argento e pietre preziose è nel Tesoro della basilica di S. Marco a Venezia) e in ferro battuto (specie a Siena nei secco XIII-XIV). Anche le lampade portatili ebbero vasta produzione, e al tipo comune a due o tre becchi per una duplice o triplice fiamma, con un anello in alto per infilarvi il dito indice, si aggiunsero esemplari più complessi ed elaborati, a volta vere e proprie opere d’arte (begli esempi sono al Louvre, al British Museum, all’Ashmolean Museum di Oxford, al Bargello). A Venezia nel sec. xv si afferma l’uso delle lampade in vetri soffiati. Si ricordino quelle bellissime dipinte dal Carpaccio nella Presentazione e nel Sogno di s. Orsola e quella del Basaiti nella Vergine dell’Accademia.
OLIO SACRO Il termine, anche in diritto canonico (can. 847), si applica. a prodotti vegetali, animali o mistificati, aventi somiglianza con l’olio; ma in senso proprio e canonico indica il liquido, spremuto dalle olive mature, consacrato per servire come materia in alcuni Sacramenti e nelle consacrazioni. “Dato, poi, che l’olio d’oliva, quale fino ad ora era prescritto per la validità del sacramento, in alcune regioni manca del tutto o può essere difficile procurarlo, abbiamo stabilito, su richiesta di numerosi vescovi, che possa essere usato in futuro, secondo le circostanze, anche un olio di altro tipo, che tuttavia sia stato ricavato da piante, in quanto più somigliante all’olio d’oliva.” (Costituzione Apostolica di Paolo VI sul sacramento dell’Unzione degli infermi, 30.11.1972).Nella letteratura, nell’arte, nel simbolismo religioso, l’olio è adoperato spesso come figura di abbondanza, letizia, forza, soavità, fecondità e incorruttibilità; è preso pure per indicare alcune realtà di ordine soprannaturale, la Grazia, la misericordia, l’effusione dei carismi dello Spirito Santo. Per questo fin dall’antichità fu usato nel culto sacro, come nella consacrazione di altari, vasi e luoghi (Gen. 28,18; 35, 14; Es. 30, 24 sgg.; 40,9, sgg.), dei sacerdoti (ibid. 29,7 sgg.; Lev. 8,11), dei re (I Re 10,1; 16,13); nei sacrifici e nelle oblazioni delle primizie (Lev. 2,1 sgg.; Deut. 14,23); nella purificazione dei lebbrosi (Lev. 14). Il Salvatore è detto «Cristo» (Unto) per antonomasia. Nel Nuovo Testamento l’olio è usato per sanare i malati, nel sacramento dell’Unzione degli infermi, mescolato ad aromi per onorare gli ospiti (Lc. 7,46; Gv. 11,2), nella sepoltura (ibid: 19,40; Mc. 16,1), ecc. L’olio sacro, distinto dall’olio per le lampade e da quello benedetto ad uso dei fedeli, è olio benedetto di benedizione costitutiva con rito solenne dal Vescovo. La Consacrazione si distingue dalla benedizione per l’uso dell’olio sacro. Questo è di tre specie: 1) olio sacro degli infermi (oleum infirmorum): è la materia del sacramento dell’Unzione degli infermi, usato anche per benedire esternamente le campane; 2) olio sacro dei Catecumeni (Sanctum oleum, Oleum catechumenorum): usato nel sacramento del Battesimo, per ungere le mani del neosacerdote, per versare nel fonte battesimale; 3) olio del S. Crisma (olio mescolato con balsamo): materia del sacramento della Cresima, usato in tutte le consacrazioni, da versare nel fonte battesimale, sul capo dei neobattezzati e dei neovescovi, cui inoltre si ungono le mani.Essenziale è la benedizione, compiuta di solito il Giovedì Santo dal Vescovo; questi può delegare a un sacerdote la facoltà di benedire l’olio degli infermi (can. 999), facoltà usata in modo ordinario dai sacerdoti orientali. Per la liceità si esige che gli oli sacri siano recenti, cioè dell’anno in corso, ma in caso urgente si possono usare entro i quattro anni gli oli sacri vecchi, purché non corrotti. Si devono conservare in chiesa in luogo distinto, in vasetti sigillati e ben chiusi; per necessità possono tenersi in casa. Il parroco deve sollecitamente procurarseli dal proprio Vescovo.In senso improprio, si suole chiamare oli sacri anche un liquido, simile all’olio proveniente dalle tombe o dalle reliquie di alcuni santi, detto anche «oleum martyris» o «manna».
Pietro Antonio Novelli, Battesimo Pietro Antonio Novelli, Confermazione Pietro Antonio Novelli, Ordinazione sacerdotale Pietro Antonio Novelli, Estrema Unzione
Nicola Poussin, Estrema Unzione
La Collezione GuatelliLA COLLEZIONE DI LATTINE STORICHEDI TIZIANA GUATELLI
Nei primi anni del Novecento, in Liguria si registrò un forte incremento nella produzione di olio d’oliva, fenomeno dovuto all’introduzione della chimica, che permise di rendere com-mestibili anche quegli oli che risultavano essere inadatti al consumo alimentare.
Imperia, in questa nuova realtà, rivestì un ruolo di primissimo piano, in quanto nell’arco di pochi anni, si concentrarono i più importanti stabilimenti per la produzione e la raffinazione dell’olio d’oliva.
Vennero raggiunti livelli tali che si andò ben oltre quelle che erano le esigenze nazionali, per-tanto si decise di esportare questo prezioso ingrediente all’estero.
Per mantenere inalterata le qualità e le caratteristiche organolettiche, si scelse di confezionar-lo in contenitori di banda stagnata, materiale che, grazie alle sue peculiarità, consentiva un ottimale condizionamento del prodotto.
Nel giro di pochissimi anni, si registrò lo sviluppo di importanti opifici dediti alla produzione di packaging per l’industria italiana dell’olio d’oliva.
Accanto ai grandi stabilimenti dell’imballaggio, come ad esempio l’azienda Domenico Ren-zetti e C. o la Solertia, per citarne solo alcuni dei più conosciuti, si concentrarono tutta una serie di piccole e medie aziende a conduzione familiare.
L’anno 1861, che rappresentò per l’Italia il raggiungimento dell’unità tanto desiderata, e che era costata grande impegno e sacrificio, segnò anche l’inizio di un fenomeno che avrebbe inesorabilmente cambiato le sorti della nazione e non solo: l’emigrazione all’estero.
Non dimentichiamo che il nostro paese, appena costituito, registrò un triste primato, divenen-do il protagonista del più grande esodo migratorio della storia moderna.
Per molti espatriati, la scelta di allontanarsi dal paese d’origine non fu da intendere come un ripudio dell’Italia. Le mete privilegiate furono essenzialmente l’Australia, l’America del Nord, il Canada e i paesi dell’America Latina.
Nei nuovi stati si formarono comunità nelle quali molte attività erano gestite da conterranei; nelle maggiori città vennero pubblicati giornali in italiano, si istituirono società di fratellan-za e di aiuto– ad esempio i Figli d’Italia - tutto questo favorì ampiamente il costante sbarco d’immigrati che, oltre alla concezione del lavoro, portarono con loro musica e cibo.
Le comunità italiane all’estero cercarono di colmare quel senso di nostalgia, andando alla ri-cerca dei sapori culinari che immediatamente erano riconducibili alla Patria lontana.
Nei nuovi paesi trovarono quasi tutti gli ingredienti necessari per la preparazione dei piatti nostrani, ad eccezione dell’olio d’oliva.
Per tale ragione si iniziò ad importarlo. Ma se la qualità del prodotto era garantita dall’impor-tatore- che era sempre di origine italiana- i nostri connazionali all’estero vollero una lattina che doveva ricordare la terra d’origine.
L’imprenditoria ligure, con largo anticipo rispetto a quelli che sarebbero stati gli sviluppi del commercio internazionale, comprese che per rendere il proprio prodotto più apprezzato dai potenziali consumatori, non solo doveva essere ottimo, ma soprattutto avere una confezione accattivante, in grado di incontrare i desideri e le aspirazioni dei suoi acquirenti.
Per soddisfare le richieste del mercato internazionale, in Liguria si iniziarono a produrre con-tenitori per la commercializzazione dell’olio prodotto nell’intero territorio nazionale, con ef-
figiate tutte quelle immagini che meglio rappresentavano il nostro Paese.
Fu indispensabile, pertanto, rivolgersi all’arte grafica, in particolare ai giovani designer che, usciti dalle varie Accademie e specializzati in disegno industriale, trovarono impiego presso gli stabilimenti di banda stagnata litografata.
Nonostante il loro encomiabile lavoro, come si può evincere dalla qualità dei progetti realiz-zati per i diversi imballaggi, poco si conosce circa la loro identità.
Furono affiancati anche da importanti disegnatori che si dedicarono alla rappresentazione grafica delle lattine, come ad esempio Gino Boccassile, Aurelio Craffonara, Plinio Nomellini e più tardi Armando Testa.
Iniziò quel felice connubio fra progresso tecnologico-industriale e ricerca artistica che portò a risultati eccellenti, non solo dal punto di vista commerciale ma anche come strumento di trasmissione del gusto e dei nuovi linguaggi dell’arte, che permise di raggiungere un pubblico sempre più vasto.
L’aspetto grafico univa sia la necessità di una ricerca artistica che stava sperimentando nuovi spazi per una comunicazione più integrata con le dinamiche sociali e quella di una cultura im-prenditoriale che aveva l’esigenza di veicolare i prodotti attraverso le “novità” e le variazioni delle immagini che li pubblicizzavano.
Inizialmente fecero figure semplici, solo successivamente iniziarono ad essere effigiati quei personaggi o avvenimenti, relativamente recenti, che avevano scosso profondamente l’opi-nione pubblica.
La registrazione delle mode non fu sempre immediata, pertanto i disegnatori attinsero indi-scriminatamente sia dalla tradizione ottocentesca, sia dalle ricerche Liberty e dell’Art Decò: lo scopo era di conquistare i consumatori in maniera più coinvolgente, con un piglio moder-no, rinnovando e modificando, secondo le occasioni, la decorazione dei contenitori.
Per i prodotti destinati alle comunità italiane all’estero, i designer lavorarono alla litografia come fosse carta pregiata, creando contenitori dai colori sfumati e raffinati, non solo per l’olio ma anche per il tonno, cercando di riprodurre marchi e simboli che meglio potevano alleviare la nostalgia della lontana Italia.
Ogni contenitore presentava titoli e descrizioni in due lingue, quella d’origine e quella del nuovo paese, e, nel tentativo di renderle più simili, la traduzione nell’idioma d’origine era approssimativa. Esemplare, a tale proposito, la parola inglese packed tradotta con il termine italiano impaccato. Inoltre, in quel periodo, l’olio non prendeva il nome del suo produttore, ma si richiamava a immagini e nomi che ricordavano la Patria.
E se oggi, osservando la latta olio Garibaldi, si sorride pensando a come l’Eroe dei due Mon-di possa essere divenuto una rinomata marca di olio d’oliva o di tonno, a quei tempi, presso le comunità italiane, era considerato un fatto normale.
La maggior parte di questi contenitori in banda stagnata litografata, realizzati intorno alla prima metà del Novecento, compongono il patrimonio dell’Associazione Culturale Guatelli.
Fondata nel 2006, per iniziativa del presidente Tiziana Riva Guatelli, grande appassionata e collezionista di imballaggi, con l’ausilio del marito Riccardo Guatelli, erede di una delle più importanti aziende di packaging, oggi la raccolta consta di oltre 6000 pezzi unici, tutti pro-dotti unicamente in Liguria.
La collezione, in continua crescita, è ospitata e in parte esposta presso un antico frantoio a sansa del XVII secolo, nell’immediato entroterra di Imperia; inoltre, è stata considerevol-mente incrementata grazie alla donazione della famiglia Renzetti, che ha voluto contribuire devolvendo la loro cospicua serie di lattine di banda stagnata litografata.
Oltre ai contenitori, sono presenti un considerevole numero di bozzetti e affiches pubblicitari, che le più importanti aziende olearie commissionavano agli artisti.
Le latte, con ogni probabilità, sono databili ai primi decenni del secolo scorso, purtroppo la scarsità, ad oggi, di documenti impedisce di avanzare una cronologia precisa.
Inoltre è necessario specificare che la maggior parte dei pezzi presenti in collezione sono fogli di banda stagnata litografata, si tratta cioè della fase precedente la realizzazione dei contenitori, questo perché durante la lavorazione, le lamine subivano il processo litografico e, una volta completato, si passava alla piegatura per conferirgli la tipica forma pronta per il riempimento. Lungo le antiche pareti del frantoio, si estende un dedalo di colori che colpisce il visitatore. La raccolta è stata oggetto di un attento lavoro di schedatura e catalogazione.
Nell’ambito di questo riordino, si è tentato di individuare alcuni soggetti che ricorrono più frequentemente sulle lattine. Sicuramente la figura femminile ricopre un ruolo privilegiato. Viene rappresentata alternativamente nei panni della donna-angelo, come ad esempio nell’o-lio Madonna, nel quale la protagonista appare avvolta in un morbido peplo, secondo la tipica rappresentazione liberty che permetteva di sveltire le immagini e imprimere loro uno slancio elegante di forme con simboli grafici floreali o astratti; non mancano, però, rappresentazioni tipiche della Belle Epoque, caratterizzate da vite sottili e décolleté generosi, vistosa sinuosità delle forme come nel caso dell’olio Odalisca, oppure quelle che fanno riferimento alla tra-dizione popolare contadina come ad esempio nell’Olio Tana, in cui la donna appare effigiata con il tipico costume folcloristico siciliano.
Tra i temi dominanti non mancano quelli che celebravano l’Unità d’Italia. In particolare, grande spazio è riservato ai patrioti, ai quali si riconosceva il merito di aver trasformato l’I-talia da mera espressione geografica a vero Stato unitario.
Emblematico il già citato caso dell’Olio Garibaldi. Uomo dotato di grande intuito strategico, fu celebrato da molti artisti diventando così un personaggio universale, pertanto, appare del tutto normale, che venga impiegato quale testimonial d’eccezione per l’industria del packa-ging alimentare.
Ricchissima la serie legata ai personaggi simbolo del nostro paese: troviamo ad esempio l’O-lio Verdi, Giuseppe Mazzini, D’Annunzio, Tasso e l’Olio Caruso e Giotto, per citarne solo alcuni.
Sono presenti, inoltre, le marche che rievocavano le grandi opere teatrali, come ad esempio olio Norma, Romeo e Giulietta, Tosca e Olio Aida. Non mancano le lattine che celebrano le tradizioni popolari italiane come l’olio Ambriola, Sicilian girl, Rosalia, la Romanella e quel-le che evocano gli eventi storici del nostro paese nei primi del Novecento come ad esempio l’olio Duce, Edda, Vittoria Tripolitana e Faccetta Nera.
Numerose sono, inoltre, quelle che rendono omaggio ai luoghi simbolo dell’Italia nel mondo: come ad esempio l’ Olio Grotta Azzurra oppure le città e i loro monumenti, come ad esempio l’Olio Milano Arco della pace, l’ olio Sanremo, olio Mole Antonelliana, e molti altri.
Un posto di grande rilievo è, infine, riservato alla rappresentazione e celebrazione dell’Italia. Sulle confezioni in latta per l’olio, il nostro paese viene rappresentato, quasi sempre, nelle sembianze di una giovane donna avvolta in un peplo come una figura classica, ispirata alla Nike o alle divinità greche.
Frequentemente è posta ai margini della composizione, in posizione seduta, munita dello scu-do sabauda e della tipica corona turrita, come ad esempio nella latta Olio La Patria.
Nell’olio La Libertà, invece, è ritratta nei panni di una donna guerriero dotata di elmo che, emulando il celebre dipinto del maestro francese Eugène Delacroix, personifica la libertà. Presenta una posa esortatrice ed è monumentale anche se in movimento impetuoso.
Daniela Lauria
1. Annibale Carracci (e scuola), San Diego d’Alcalà guarisce un malato con l’olio della lampada 2. Andrea Previtali, Madonna col Bambin Gesù3. Bartolomeo Vivarini (scuola di), Santa Lucia
1
3
2
1. Filippo Bigioli, San Narciso di Gerusalemme trasforma l’acqua in olio per le lampade2. Anonimo artista settecentesco, Guarigione di Maria de Oliveira con l’olio della lampada3. Artista settecentesco, San Remigio di Reims battezza Clodoveo re dei Franchi
3
1
2