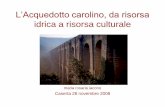L'uso privato dell'Acqua Vergine dalla realizzazione della nuova rete idrica alla revisione generale...
Transcript of L'uso privato dell'Acqua Vergine dalla realizzazione della nuova rete idrica alla revisione generale...
Le reti deLL’acquadaL tardo cinquecento aL settecento
r M c
XVi, 2008/2
roMa Moderna e conteMporanea
Redazione Stefano andretta, LiLiana Barroero, Martine Boiteux, Marina Caffiero, franCeSCa Cantù, CarLo feLiCe CaSuLa, PaoLo d’aChiLLe, MarCo de niCoLò
irene foSi, Sergio guarino, antonio Martini, giuSePPe MonSagrati, roBerta MoreLLi, giaCoMina nenCi, Maria LuiSa neri, Maria ioLanda PaLazzoLo, Maria grazia PaStura, PaoLa Pavan, aLBerto raCheLi †, doMeniCo roCCioLo,antoneLLa roMano, eugenio Sonnino,Bruno toSCano, CarLo M. travagLini,orietta verdi, Maria antonietta viSCegLia
Corrispondenti scientificiangeLa BoCCi gireLLi, oLivier Bonfait, PhiLiPPe Boutry, Catherine BriCe,rita d’erriCo, Saverio franChi, Luigi gogLia, eLiSaBeth Kieven, Lutz KLinKhaMMer, aLexander KoLLer, Luigi Londei, giovanna MeroLa, Stefania nanni, Laurie nuSSdofer,Sergio Pagano, guido PeSCoSoLido,Lidia PiCCioni, fauSto PioLa CaSeLLi,andrea riCCardi, Mario roSa,ingrid rowLand, donateLLa Strangio,giuSePPe taLaMo †.
Manoscritti, libri, proposte di contributi e recensioni vanno inviati a Carlo M. Travaglini, redazione di «Roma moderna e contem-poranea» presso: CROMA-Università degli studi Roma Tre, Via Ostiense, 139 | 00154 Roma | Tel. 06.57334016 | Fax 06.57334030 | [email protected] | Tutti i contributi sono sottoposti a valutazione anonima di referees.
Segreteria di RedazioneSaBina Mittiga
La rivista è pubblicata con il patrocinio e il sostegno di
Direttore Carlo M. travagLini
Editore: Università degli studi Roma Tre, Via Ostiense, 159 - 00154 RomaAbbonamento annuo 2010: Italia euro 50,00; Estero euro 75,00; Sostenitore: euro 100,00Gli abbonamenti vanno sottoscritti a «CROMA-Università Roma Tre», via Ostiense, 139 | 00154 Romatel 06.57334016 | fax 06.57334030 | [email protected] | I versamenti possono essere effettuati sull’ International Bank Account Number (IBAN) IT53W 03002 03252 000400014281 - BIC: BROMITR1108 intestato a Università Roma Tre, indicando sempre la causale di versamento. Per l’acquisto di singoli fascicoli ci si può rivolgere a CROMA-Università Roma Tre, via Ostiense, 139 | 00154 Romatel 06.57334016 | fax 06.57334030 | [email protected]
Redazione e amministrazione: CROMA - Università degli studi Roma Tre, Via Ostiense, 139 - 00154 Roma Tel. 06.57334016 | Fax 06.57334030 | [email protected]
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in:HISTORICAL ABSTRACTSAMERICA: HISTORy ANd LIFEIBZ (Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur)
Autorizzazione del Tribunale di Roma n.668 del 19-12-1992
Il fascicolo è stato chiuso in tipografia il 06/09/2010. Stampa presso SpedalgrafStampa srl, - via F. Bartolozzi, 13 - 00133 Roma
Progetto grafico: Emiliano Martina. Impaginazione: Anna Rosa Angiò e Emiliano Martina. © 2010 Università Roma Tre-CROMA
I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi
I sommari e gli abstracts di «Roma moderna e contemporanea», a partire dal primo fascicolo, sono consultabili via internet all’indirizzo:www.croma.uniroma3.it
Roma modeRna e contempoRaneaRivista interdisciplinare di storia
R M CRoma modeRna e contempoRanea
Rivista interdisciplinare di storia
R M CRoma modeRna e contempoRanea
Rivista interdisciplinare di storia
anno XVI, 2008 fasc. 2, luglio-dicembre
A. Antinori, Introduzione.……..........………….....…...............................
A. Antinori, L’uso privato dell’acqua Vergine dalla realizzazione della nuova rete idrica alla revisione generale del 1631......................................................
M. tAbArrini, La rete urbana dell’acqua Paola: il ramo del Gianicolo..........
F. Di MArco, Raguzzini, l’acqua Felice e il Campidoglio: «Cose fievoli ma molto laboriose»......................................................................................................
S. ZAni, Acque e fontane nel primo Seicento a Velletri: ornato e pubblica utilità
P. buonorA, Gli acquedotti del papa: restitutio o innovazione?.......................
pag. 227
» 231
» 273
» 293
» 307
» 323
» 335
» 355
» 367
LE RETI DELL’ACQUA DAL TARDo CInQUECEnTo AL SETTECEnTo
a cura di Aloisio Antinori
Saggi
M. Lucci, Sul corteo funebre di Lucrezia Tomacelli Colonna in una sconosciuta rappresentazione di Matteo Greuter................................................................
Note e discussioni
i. FoSi-A. KoLLer, A proposito di un libro recente: la legazione bavarese a Roma nella prima età moderna...............................................................................
Schede
Architetti e ingegneri a confronto. L’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII a cura di E. Debenedetti - (E. Ciciotti); D. Del Pesco, Bernini in Francia, Paul de Chantelou e il Journal de voyage du Cavalier Bernin en France - (M. Marandola).............................................................................
Abstracts
Pubblicazioni ricevute
Riferimenti Autori
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINEDALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE IDRICA
ALLA REVISIONE GENERALE DEL 1631*
L’intenzione più volte manifestata dai pontefici di dare una risposta al crescente bisogno di acqua di una città che, superato il trauma del Sacco, aveva ripreso e ac-celerato il suo sviluppo, si concretizza, com’è noto, soltanto nel 1561. Nell’aprile di quell’anno Pio IV ordina alla Camera apostolica di affidare all’impresa dell’«architet-to» Antonio Trevisi di Lecce1 i lavori di ripristino dell’allacciamento dell’acquedotto Vergine alle sorgenti di Salone2, la località prossima al tracciato della via Collatina e distante circa 15 chilometri da Roma, dove poco prima del 1525 il cardinale Agostino Trivulzio aveva scelto, di certo anche per la presenza di quelle sorgenti, di costruire la propria villa progettata da Baldassarre Peruzzi. Il 3 giugno dello stesso 1561, nella sessione pubblica del Consiglio Capitolino si annuncia che:
* L’idea di questa ricerca è nata in occasione del Congresso dell’Associazione Italiana di Storia Urbana su “La città e le reti”, tenutosi a Milano nel febbraio 2009. All’Associazione, e in particolare a Donatella Calabi, va dunque il mio ringraziamento. Sono anche grato ad Augusto Roca De Amicis, che ha incoraggiato e accompagnato il lavoro, e inoltre a Giuseppe Bonaccorso, Paolo Buonora, Fabrizio Di Marco, Gilberto Marconi, Salvatore Monda, Elisabetta Mori, Marisa Tabarrini, per l’aiuto che in vario modo mi hanno offerto. Per rendere più agevole la lettura dei documenti, nella trascrizione si sono adeguati all’uso moderno gli accenti, gli apostrofi e la punteggiatura.
1 L’anno precedente Antonio Trevisi si era fatto conoscere pubblicando a Roma, presso lo stampatore camerale Antonio Blado, un’opera di argomento idrologico intitolata Fondamento del edifitio nel quale si tratta con la Santità de N. S. Pio Papa IIII. Sopra la innondatione del Fiume. Dove se declara l’origine et quali-tà delle acque, celeste, terrestre e maritime e la loro distantia... Su questa non molto nota figura di architetto e ingegnere, la cui attività nell’impresa della nuova acqua Vergine non sembra aver avuto buon esito, si veda P.A. Vetrugno, Antonio Trevisi architetto pugliese del Rinascimento, Fasano di Puglia, Schena, 1985.
2 I relativi «Capitoli et conventioni», datati 18 aprile 1561, e la documentazione di natura legale che sulla questione si produsse nei giorni e nei mesi successivi, si conservano in ArchiVio di StAto di romA (d’ora in avanti ASR), Notai della R.C.A., 453 (Hieronimus de Tarano), cc. 146r-156r. Una parziale trascrizione ne fu pubblicata in C. d’onofrio, Acque e fontane di Roma, Roma, Staderini, 1977, pp. 618-619.
«Roma moderna e contemporanea», XVI, 2008, 2, pp. 231-272 ©2010 Università Roma Tre-CROMA
232 ALOISIO ANTINORI
Sono alquanti giorni che n[ost]ro S[igno]re ne fa intender che la mente sua era di far cose ma-gnanime, et utili a q[uest]a Città, et per darvi princ[ipi]o ha pensato di far condur l’acqua di Salone in Roma, ché, pensa, ne risultarà grandezza alla Città, et benefitio a q[uest]o Po[polo], et per questo s’è fatto un appalto, et instr[ument]o con un architetto il q[ua]le si è obligato con dar bonissime sigurtà di condurre dett’acqua a tutte sue spese sino alle caole di Treio per ducati ventimila di cam[er]a da pagarsene otto mila al p[rese]nte et mille ogni mese sino all’integro pagamento de’ quali ventimila ducati. S[ua] S[anti]tà ne vuole pagar sei mila, cinque mila il Collegio di Rev.mi Car[dina]li, tre mila la Cancellaria, et il restante sino a detta somma che provegga il Popolo3.
L’intervento avviato nel 1561, permettendo di condurre a Roma una grande quantità di buona acqua potabile, rendeva in prospettiva necessario un generale rin-novamento dell’antica e malandata rete idrica della città, che avrebbe potuto essere ampliata verso i rioni lungo il fiume4.
La diffusione nell’intero abitato sulla riva sinistra del Tevere della nuova acqua di Salone finalmente giunta fino ai piedi del Pincio, prende avvio all’inizio del decen-nio successivo, quando si progettano, probabilmente nel 1570 o nei primi mesi del 1571, le «grandezze de’ condutti che si haveranno da fare per le strade di Roma acciò si possa pigliar tutta l’acqua di Salone dal condutto della Trinità et per condurla pro-pertionatamente per tutte le piazze e strade con la sua capacità che sarà necessaria»5, e si affida poco tempo dopo, il 17 maggio 1571, la realizzazione del primo tratto della rete allo scultore Guglielmo Della Porta6.
Cinque anni più tardi gli atti di concessione, a titolo oneroso o gratuito, di ac-qua Vergine a privati (lettere patenti) cominciano ad essere regolarmente registrati. Mentre procede lo sviluppo della nuova rete idrica, l’autorità capitolina controlla che tutti i privati che fanno acquisto di acqua realizzino correttamente e nei tempi pre-
3 ArchiVio Storico cAPitolino (d’ora in avanti ASC), Camera Capitolina, cred. I, t. XXI, cc. 86r-87v. Altri riferimenti al progetto di condurre a Roma l’acqua Vergine di Salone, e specialmente alle molte questioni connesse al finanziamento dell’impresa, sono ivi, cc. 97v, 116r-117r, 119v-120r, 120v, 126v, 130v-131v, 147v, 163r-v, 169r-170r, 183v, 189v-190r, 193r-194r, 211r-v, 226v, fino alla data del 26 febbraio 1563.
4 Secondo C. d’onofrio, Acque e fontane, cit., p. 25, nota 12, che utilizza come fonti le Antiquita-tes Urbis di Andrea Fulvio e le opere di Alessandro Petronio – il De aqua Tiberina del 1552 e specialmen-te il De victu Romanorum et de sanitate tuenda del 1581 – l’acqua detta di Trevi, che neanche durante il Medioevo aveva cessato di immettersi nella rete urbana dell’antico acquedotto Vergine, giungeva a Roma non da Salone, come era avvenuto nell’antichità, ma dalla località detta Bocca di Leone, anch’essa prossima alla via Collatina. Fin dall’inizio del Cinquecento questa risorsa idrica appariva ormai insod-disfacente per quantità e per qualità.
5 Il documento in ASC, Fondo Boccapaduli, arm. II, mazzo IV, fasc. 64 (busta 104b), cc. 1048r-v, è trascritto in C. d’onofrio, Acque e fontane, cit., pp. 619-620.
6 Le «Capitulationes super fabricatione ductus aquae virginis per urbem inter Ill.os d[omi]nos Car[dina]les Montepolitianum et Ursinum deputatos ac alios d[omi]nos de congreg[ation]e ex una et R. Fratrem Gulielmum de la porta del piombo partibus ex altera» sono in ASR, Notai del Tribunale delle Acque e Strade, 6 (Octavius Gracchus), cc. 183v-186r, parzialmente trascritto in C. d’onofrio, Acque e fontane, cit., pp. 620-621.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 233
visti le relative condutture in entrata e in uscita, che sono a loro spese, e inoltre che non danneggino o alterino nel funzionamento le fontane e gli altri impianti pubblici ai quali si connettono7.
Già prima della fine degli anni Settanta la nuova acqua Vergine raggiunge il cuore del rione Ponte8 (fig. 1), dall’inizio dei Novanta si diffonde nel rione Regola9, e poco dopo la metà dello stesso decennio arriva a servire l’intero rione Sant’Angelo10. I lavori di costruzione della nuova rete sono a quel punto sostanzialmente terminati, mentre si comincia a dover talvolta intervenire per controllare e reprimere abusi commessi dagli utenti, così come accade il 29 luglio 1597, quando il camerlengo Enrico Caetani scrive11:
Confidando nelle buone qualità della persona de m.r Octavio Mascarino Architetto, per tenore delle p[rese]nti d’ordine hauto a bocca da N[ostro] Sig[no]re et per l’autorità del n[ost]ro off[ici]o del camerlengato, deputiamo il d[ett]o m.r Octaviano n[ost]ro commissario con carico e fa-cultà amplissima di livellare il condotto o ver bottino dell’acqua posto in Roma nella piazza di Branca et rivedere tutte le fistole, che fussero da alcuno de’ participanti alterate, et con rogito dell’infr[ascritt]o not[ar]o et secretario, et assistentia dell’esecutore, levare l’acqua dalli lavatori, tanto sopra a terra quanto nelle cantine, et di fare tutte altre cose che in ciò saranno necessarie in d[ett]o bottino.
La diffusione della nuova acqua Vergine: la procedura per la concessioneLa prima creazione di una Deputatio aquae Virginis risale probabilmente a un’ini-
ziativa di Pio V, che aveva incaricato i cardinali Giovanni Ricci e Flavio Orsini, af-fiancati dai conservatori e da tre rappresentanti del Popolo romano, di sovrintendere all’opera di ristrutturazione e ampliamento della rete idrica e alla distribuzione della nuova acqua di Salone per mezzo di nuove fontane pubbliche e private, e in un secondo momento aveva accostato alla commissione cardinalizia anche i «maestri di strade»12. Nel 1576 risulta far parte della Congregazione anche il priore dei capo-rioni. In questo primo periodo, dunque, la delibera dei rappresentanti del sovrano è soggetta, almeno formalmente, all’approvazione di un nutrito gruppo di esponenti
7 Si veda a riguardo la lunga serie di «monitori» e «precetti» che sono emessi il 14 marzo 1584 dopo una «Visita dell’Aquedutti particolari»: ASC, Camera Capitolina, cred. IV, t. 103, cc. 41v-43r.
8 Ne dà testimonianza la data (1579) dell’iscrizione della fontana pubblica in piazza di San Salvatore in Lauro, qui riportata alla nota 18 dell’appendice documentaria.
9 Sono indicative a riguardo le date delle concessioni al Farnese per il suo palazzo, al Savelli per la Curia in via Monserrato e ai Planca Incoronati per le loro case: cfr. le note 41 (Farnese), 43 (Savelli) e 47 (Planca Incoronati) dell’appendice documentaria.
10 Nel 1597, infatti, Clemente VIII offre due once d’acqua in vendita agli esponenti della comunità ebraica: cfr. più avanti nel testo e alla note 34 e 35.
11 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 164r.12 I due decreti di Pio V sono riportati in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Giovar-
diana di Veroli: cfr. G. ScAcciA ScArAfoni, L’antico statuto dei «Magistri stratarum» e altri documenti relativi a quella magistratura, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», L, 1927, pp. 239-308, in particolare pp. 259-261, dove non se ne precisa però la data.
234 ALOISIO ANTINORI
Fig. 1 - Roma, fontana pubblica addossata alla facciata del convento di San Salvatore in Lauro, 1579. L’iscrizione celebra in forma poetica l’arrivo della nuova acqua Vergine e rende omaggio al pontefice regnante Gregorio XIII.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 235
dell’autorità municipale: i tre conservatori, il priore dei caporioni, i due viarum ma-gistri, e inoltre una commissione composta inizialmente da tre e più tardi da quattro gentiluomini, che era nominata ad hoc dal Popolo romano.
Un interessante scritto riferibile alla mano di Prospero Boccapaduli e databile al 1575 o 1576, quando la nuova acqua è appena giunta a Roma, c’illumina sulle questioni che furono oggetto di discussione in merito ai criteri della sua concessione ai privati13:
Capitoli, modi, prezi et quantità da concedersi a’ Particolari dell’acqua di Salone.Havendo la Ill.ma et Rev.ma Congregatione sopra l’acqua di Salone eletto il S.r Thomao del Cavalieri al p[rese]nte uno delli S.ri Conservatori di Roma, li S.ri M[astr]i di strade et Prospero Boccapaduli uno delli tre deputati dal Po[pulo] Ro[mano] ad considerare il modo, prezo et quantità da concedersi a’ particolari della sopradetta acqua, et volendo li detti S.ri M[astr]i separatamente considerare sopra di ciò, è parso alli altri sopradetti doi deputati unitamente per loro debito mettere in carta le infrascritte considerationi capituli et ordini rimettendosi sempre ad ogni meglior inditio et parere.Et perché per la esperientia fatta da loro si è visto che meza oncia di acqua come qui sopra appare [in cima al foglio sono disegnate tre corone circolari del diametro di un’oncia, mezza oncia e un quarto di oncia, NdA] è quantità assai notabile per li particolari, hanno indicato espediente che non sia licito a persona di qualsivoglia stato, grado o conditione comprare o havere più de una fistula di detta acqua per una casa over luogho, della sopradetta misura o minore ad loro arbitrio, pagandola proportionalmente secondo la quantità che se li concederà, eccettuando però l’Ill.mi et R.mi S.ri Cardinali et altri ad arbitrio di detta Congregatione, purché in tutto non si ecceda la misura di una oncia.La qual meza oncia di acqua si debbia concedere per prezo di scudi quaranta a tutti quelli che la vorranno et sarranno vicini alli condutti publici da tre canne in giù, et alli altri che saranno più distanti concedendoglila se li difalchi mezo scudo per ciasche canna andante de distantia sino al numero di cinquanta canne et da quel numero in su non si minuisca prezo ma resti di scudi quindici a qualsivoglia lunga distantia.Et la cannella della sopradetta quantità di acqua si facci di metallo sigillata col sigillo del Po[pulo] Ro[mano] et trapanata con un trapano qual sia di detto Populo et sigillato col mede-simo sigillo, il quale debbia stare in Campidoglio secondo tutte le altre misure stanno et debon stare, acciò non si possa alterare; alla qual cannella attaccata al condutto maestro si attacchi il condutto de’ particolari largo ad loro arbitrio.Che tutte le spese che occorreranno farsi nelli condutti de’ particolari per condursi l’acqua debiano farsi alle loro spese, connumerandoci li mattonati delle strade dove anderanno disfatti o forse occorresse farli di nuovo in tutto overo in parte secondo il iuditio et ordine delli S.ri M[astr]i di strade, et che detti particolari nel cavare per haver detta acqua non possino essere impediti da alcuno, intendendo però cavando nel publico et non in luoghi de’ privati.Che vicino al condutto maestro ad una canna non sia licito a persona alcuna accostarsi sotto qualsivoglia pretesto, etiam per acconciare, sensa intervento delli deputati, sotto pena.Et inoltre che tutti li compratori di detta acqua di qualsivoglia stato, grado o conditione, de-biano dare cedula di diposito in atti del notario del prezo convenuto da pagarsi subito fattoli la concessione con la consignatione.Et che di tutte le sopradette cose se ne facci scrittura publica con patenti overo altro sopra di ciò necessario, de’ quali ne resti memoria autentica in un libro grosso qual resti sempre nello
13 ASC, Fondo Boccapaduli, arm. II, mazzo IV, fasc. 63 (busta 104b), cc. 1042v-1045r: del docu-mento si conserva la minuta e la stesura definitiva.
236 ALOISIO ANTINORI
archivio delle scritture del Po[pulo] Ro[mano].Et acciò il tutto si osservi inviolabilmente si procuri di havere da N[ostro] S[ignore] una con-firmatione di tutte le sopradette cose, et anche acciò sua S[anti]tà ricordevole di detta confir-matione difficilmente ci deroghi etiam ad instantia di qualsivoglia persona.
Della riduzione del prezzo proposta da Boccapaduli e Cavalieri per rendere meno oneroso l’acquisto d’acqua da parte di chi non risiede nell’immediata prossimità dei condotti, non c’è traccia nella successiva documentazione d’archivio, e la decisione di non concedere questa agevolazione avrà, come vedremo esaminando il documento del 1631, conseguenze non trascurabili nella distribuzione delle utenze all’interno della città. Quanto ai modi e ai tempi del pagamento, entra effettivamente nella pro-cedura il versamento della somma dovuta presso un banco depositario, ma si impone all’acquirente di effettuare tale versamento prima del rilascio della concessione, e non subito dopo, come suggerito dai due gentiluomini. È recepita invece la loro proposta di redigere per ogni concessione una «scrittura pubblica» e di registrare tutti questi atti in un apposito «libro grosso». Questo è, certamente, proprio il volume n. 2 del fondo Presidenza degli acquedotti urbani dell’Archivio di Stato di Roma, l’analisi del quale ha fornito una gran mole di dati alla nostra ricerca14.
La prima patente per la concessione di acqua registrata nell’apposito «libro grosso» porta la data del 26 maggio 1576. Rilasciate dalla Congregazione dopo una supplica formale rivolta al papa dal richiedente, le lettere patenti portano di norma la firma dal cardinale camerlengo e del notaio segretario della Congregazione o del suo delegato15. Il primo di questi atti16 è la concessione gratuita – da parte della Congregazione for-mata, oltre che dalle autorità municipali, dal camerlengo Luigi Cornaro e dai cardinali Alessandro Sforza, Flavio Orsini e Ferdinando de’ Medici, «olim per s[anc]tae me-
14 Nel corso di questo studio si sono esaminati con particolare attenzione i volumi più antichi (il n. 1, che è una raccolta di chirografi papali e ha inizio il 13 giugno 1606, e i nn. 2 e 3, che sono appunto i registri delle lettere patenti inviate dalla Congregazione a partire dal 26 maggio 1576) del fondo Pre-sidenza degli Acquedotti Urbani dell’ASR (sul quale si veda m. morenA, La Presidenza degli acquedotti urbani, in M.G. PASturA ruggiero, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi, secoli XV-XVIII, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1987, pp. 118-128), e inoltre una serie di volumi, che via via s’in-dicheranno in nota, del fondo Camera Capitolina dell’ASC, questi ultimi contenenti i verbali delle riunioni del Consiglio Capitolino.
15 Intorno all’assegnazione di questa carica si accese tra il 1577 e il 1590 una vivace controversia, sulla quale si veda D. SiniSi, I Notarii Magistrorum Stratarum nel ’500: nascita di un ufficio notarile privativo per le magistrature di acque e strade, «Roma moderna e contemporanea», IV, 1996, 2, pp. 363-378, in particolare pp. 373-374. Il notaio della Congregazione che «subscribit et registrat» le lettere pa-tenti in ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, è inizialmente Ottavio Gracco (Octavius Gracchus), poi Manilio Gracco (Manilius Gracchus) dal marzo 1577. Dal 2 maggio 1586 sono Alessio Boccamazza (Alexius Buccamatius) e più raramente Flavio Celestini (Flavius Celestinus) a firmare le lettere patenti in rappresentanza («pro») del notaio del Tribunale di Acque e Strade e segretario della Congregazione, che è Ermete Gracco (Hermes Gracchus) fino al dicembre 1594 e poi Domenico Boccamazza (Dominicus Buccamatius) dal gennaio 1595. Soltanto dal 30 dicembre 1610 Alessio Boccamazza assume personal-mente quella carica, che occupa poi fino al settembre 1618.
16 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 1r-v.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 237
moriae Pium Quintum et nuper per sanctissimum d[omi]num n[ost]rum Gregorium divina providentia Papam XIII sub distributione Aquae Virginis pro fontibus publicis et privatis in alma urbe construendis specialiter deputati» – di un’oncia d’acqua a Luca Peto per le sue case situate «in via recta Trinitatis», cioè nella strada che, di lì a poco, comincerà ad essere chiamata anche nei documenti ufficiali «via conductorum». Luca Peto è il commissario17 che «per annos decem et ultra […] in reducendo ad urbem Aquam fontis Virginis et illius aqueductum restaurando invigilavit, studiumque et operam suam libenter et gratis impendit»: l’oncia d’acqua che gli è assegnata può perciò essere considerata un compenso per il lavoro svolto. Trattandosi della prima patente registrata, ci si preoccupa di precisare che la concessione d’acqua è «ad men-suram unius rotundi digiti seu diametri unius rotundae unciae palmi quo Architetti [sic] utuntur inferius describendi», e si inserisce accanto al testo il disegno di una circonferenza del diametro di un’oncia (un dodicesimo di palmo romano, pari a cm. 1,86), che costituisce l’unità di misura della portata d’acqua.
Durante il pontificato di Sisto V, nel quadro della crisi che nel tardo XVI seco-lo investe le istituzioni capitoline18 in relazione al progressivo accentramento dei poteri nella persona del sovrano, si registrano delle novità nella composizione del-la Congregazione preposta alla concessione d’acqua ai privati. Già dal 1586, della Congregazione cominciano a far parte non più tre ma cinque cardinali più il ca-merlengo19, e il 22 gennaio 1588, nell’ambito della grande riforma amministrativa sancita con la bolla Immensa aeterni Dei, Felice Peretti crea la nuova Congregatio super viis, pontibus et fontibus formata da sei cardinali, alla quale attribuisce le competenze prima distinte su strade e ponti e sulla rete idrica. Sulla distribuzione della nuova ac-qua Vergine, tuttavia, continua a sovrintendere negli ultimi anni del pontificato sisti-no una specifica deputazione, formata da un numero variabile di cardinali: sei nella primavera del 1588 (Albani, Simoncelli, Canani, Spinola, Sforza e Caetani, che è il camerlengo), cinque nel secondo semestre di quell’anno e per quasi tutto l’anno suc-cessivo (Albani, Salviati, Spinola, Sforza e il camerlengo Caetani), sette dal novembre del 1589 (Albani, Canani, Salviati, Spinola, Sforza, del Monte e il procamerlen-go Giustiniani) e ben otto dal febbraio 1590 (Albani, Simoncelli, Canani, Salviati,
17 Su Luca Peto e sul ruolo direttivo che egli ricoprì sotto Pio V e Gregorio XIII sia nei lavori per condurre a Roma l’acqua delle sorgenti di Salone e nella soluzione dei problemi tecnici che l’impresa comportò, sia in altre importanti opere pubbliche come la riparazione di ponte Sisto, si veda ora G. Simoncini, Roma. Le trasformazioni urbane nel Cinquecento, I, Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII, Firenze, Olschki, 2008, pp. 230, 240-241.
18 Su questo processo storico: M. frAnceSchini, Dal Consiglio pubblico e segreto alla Congregazione economica: la crisi delle istituzioni comunali tra XVI e XVII secolo, «Roma moderna e contemporanea», IV, 1996, 2, pp. 337-362.
19 La prima patente in cui i cardinali membri della Congregazione sono sei è quella del 2 maggio 1586, per mezza oncia concessa a Romolo Cesi vescovo di Narni, in ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 22v-23v.
238 ALOISIO ANTINORI
Spinola, Sforza, del Monte e il procamerlengo Giustiniani). Quando nell’estate di quell’anno ci si deve occupare di un membro della Congregazione, ossia Francesco Sforza20, l’intervento del camerlengo Enrico Caetani mantiene a otto il numero dei cardinali «specialiter deputati» a pronunciarsi «super fontibus».
Intanto il riferimento ai rappresentanti dell’autorità capitolina diviene, nel testo delle lettere patenti, sempre più fugace, tanto che verso la fine del 1588 si comincia a non precisarne più i nomi. Dalla fine del 1593, infine, dunque ormai sotto Clemente VIII, si afferma l’uso21 di citare nelle patenti non più i nomi di tutti i cardinali mem-bri della Congregazione, ma soltanto quello del camerlengo.
In tutte le lettere patenti la concessione onerosa di acqua Vergine a privati è fin dall’inizio accompagnata da una formula giustificativa, che nel corso del tempo si trasforma significativamente. Nei primi decenni dopo il suo arrivo a Roma, la nuova acqua di Salone è concessa, contestualmente al procedere dei lavori di costruzione della nuova rete, a chiunque ne faccia richiesta. Durante tutto questo lungo periodo iniziale, dunque, la vendita d’acqua ai privati è un fatto ordinario che si verifica con continuità, e nelle lettere patenti può essere genericamente motivata «pro subventione fabricae publicorum fontium Urbis». Un’espressione che nel luglio 1588, quando le nuova rete è ormai avanti nella realizzazione, si modifica leggermente in «pro subven-tione et manutentione fabricae publicorum fontium».
Una prima innovazione di questa prassi si rileva nel 1610, quinto anno del pontificato di Paolo V, quando è camerlengo – già dal 1599 – il cardinale Pietro Aldobrandini. La formula giustificativa di rito inserita nelle lettere patenti rimane im-mutata, ma ad essa comincia ad essere aggiunto il testo – in volgare – del chirografo che il papa ha inviato al camerlengo per la specifica circostanza, e nel quale com-paiono indicazioni circostanziate sull’impiego delle somme versate da chi acquista l’acqua. Inoltre il prezzo per oncia passa in questo momento da ottanta a cento scudi. I primi atti che presentano questa nuova struttura sono tre patenti del 26 gennaio 161022, nelle quali è riportato il testo del medesimo chirografo papale:
Ci siamo contentati che si vendano doi oncie d’acqua Verg[ine] una a Fidele Ruggia alla chia-vica del Bufalo, e l’altra a Cesare Rodiano nella strada delli Condotti, o ad altri che le vorranno comprare in detti luoghi [mezza oncia sarà acquistata di lì a poco da un Giovanni Vigevano, NdA], acciò il prezzo d’esse se n’habbino a pagare le spese fatte nel condotto di legno, che di nuovo ordine è stato fatto per modo di provisione a Bocca di Lione per la rottura seguita alli dì passati nel condotto presente. Però, pagato che si haveranno il prezzo cioè scudi cento per oncia, a detto effetto con n[ost]ro ordine ne li spedirete le patenti necessarie, che tale è mente nostra non ostante la prohibitione fatta per n[ost]ro Breve, et ogni altra cosa facesse incontra-rio, alle quali tutte per questa volta deroghiamo.
20 Cfr. più avanti nel testo e alla nota 4 dell’appendice documentaria. 21 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 116v.22 Ivi, 2, cc. 236r-237v.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 239
Dopo una patente del 21 febbraio 161223, nella quale Paolo V concede gratui-tamente un’oncia d’acqua Vergine all’architetto misuratore Giovanni Antonio De Pomis, che sappiamo attivissimo in quel periodo nei cantieri del papa e in quelli di suo nipote Scipione Caffarelli Borghese24, il nuovo uso di citare in ogni lettera paten-te il chirografo papale che precisa la destinazione del relativo introito appare ormai consolidato. Il testo di tali decreti è sempre esplicito e piuttosto dettagliato. In quello del 3 agosto 161225 si legge per esempio:
Havendo bisognio di restauratione li condotti che portano l’acqua Vergine dal Bufalo a piazza Colonna, n’essendoci denari di d[ett]a acqua medianti li quali possino restaurarsi, habiamo reso-luto si venda un’oncia di d[ett]ta acqua. Però per la presente vi ordiniamo che vendiate un’oncia di detta acqua a una o più persone che vi saranno nominate da mons. Biscia Chierico di Camera per il solito prezzo de scudi cento di m[one]ta l’oncia, et pagato che sarà d[ett]o prezzo in mano del n[ost]ro depositario gen[era]le in conto a parte da spendersi in restauratione de d[ett]i con-dotti a dispositione di d[ett]o Monsignor Biscia, ne li farete spedire patente solite.
Quest’ultimo chirografo presenta due importanti novità: in primo luogo la vendi-ta è deliberata, anticipando una prassi che diverrà stabile a partire dal pontificato di Gregorio XV, in favore di soggetti ancora da individuare; inoltre fa la sua comparsa una nuova figura di soprintendente agli acquedotti, incarico affidato in questa fase all’abile amministratore Lelio Biscia, protagonista della politica urbana di Camillo Borghese e poi cardinale dal 162626.
Dall’agosto 1622, cioè diciotto mesi dopo l’ascesa al soglio di Alessandro Ludovisi, si instaura dunque una nuova procedura per la concessione di acqua Vergine ai privati. Invece di emettere chirografi ad personam, per deliberare cioè la vendita di una piccola quantità d’acqua a un singolo individuo o a un ristretto numero di soggetti che ne hanno fatto richiesta, il papa comincia ad autorizzare nei suoi decreti – emessi di tanto in tanto e in riferimento a circostanze precise – l’offerta di una quantità fissa di dieci once di acqua ad acquirenti ancora non individuati. In ogni chirografo sono esplicitate le motivazioni dell’iniziativa, sempre legate alla gestione della rete idrica, e il testo del chirografo è poi riportato in ognuna delle lettere patenti relative alla vendita di quelle dieci once. In altre parole, ogni volta che si presenta la necessità di effettuare sulla rete un intervento di riparazione o di manutenzione straordinaria, questo è finanziato attraverso la messa in vendita di dieci once d’acqua, così da ricavarne, almeno potenzialmente, un’entrata pari a 1.000 scudi. Il primo dei chirografi di questo tipo è emesso il 30 agosto 162227:
23 Ivi, 2, c. 238r.24 Su De Pomis: R. lefeVre, Un architetto minore del primo Seicento romano: G.A. De Pomis, «L’Urbe», 5,
1971, pp. 1-13; A. Antinori, Scipione Borghese e l’architettura, Roma, Archivio Guido Izzi, 1995, passim.25 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 241v.26 Uno studio di Tommaso Manfredi sulla figura e sul ruolo di Lelio Biscia apparirà nel volume di
prossima pubblicazione dal titolo: Roma nel primo Seicento. La città di Paolo V Borghese nella veduta di Greuter, a cura di Augusto Roca De Amicis.
27 Il chirografo è trascritto in ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 1, s.n., 30 agosto 1622. Il
240 ALOISIO ANTINORI
Ill.mo Cardinal Lodovisio n[ost]ro nipote e della S.R.E. Camerlengo. Dovendosi visitare et ac-comodare li condotti per l’acqua Vergine che portano l’acqua alla fontana di Trevi e per Roma et dovendosi fare diverse altre spese per servitio di d[ett]a acqua, però vi diamo facoltà con la presente di vendere et alienare di detta acqua Vergine sino alla somma di oncie diece a favore di quelle persone che voi nominarete, da pigliarsi da i luochi che deputarete più comodi, et vi ordiniamo che gli ne spediate le patenti sopra ciò necessarie.
Allo stesso modo, il 22 ottobre 1624 il nuovo pontefice Urbano VIII emette un chirografo28 che autorizza la vendita a privati di dieci once «dovendosi pagare le spese che si doveranno fare per raccommodare li condotti de l’aqua Vergine guasti e ruinati nel luogo chiamato Bocca di Leone», cioè nel sito delle sorgenti che avevano alimentato l’acquedotto dall’inizio del Medioevo fino al suo riallaccio con quelle di Salone. Dopo una pausa di quasi quattro anni, il 29 agosto 1628 il papa autorizza con un nuovo chirografo la vendita ai privati di altre dieci once d’acqua, stavolta per «pagare diverse spese fatte e da farsi sì per finire la fontana principiata nella piazza della Trinità de’ Monti, come anco in servizio dell’accomodamento delli condotti dell’acqua Vergine in diversi luoghi guasti et rotti». Il 28 febbraio 1629 un altro chi-rografo autorizza con identiche motivazioni la vendita di ulteriori dieci once, «perché il prezzo da essa [dalla prima vendita, NdA] retratto non basta alle d[ett]e spese» 29.
Mentre dunque la vendita d’acqua Vergine ai privati si configura ormai come una risorsa alla quale si fa ricorso periodicamente per finanziare la manutenzione e talora il miglioramento della rete, chirografi ad personam continuano a essere emessi solo nei casi – peraltro non rari – in cui l’acqua non è venduta, ma concessa gratuita-mente. A questo riguardo, è opportuno considerare i diversi modi in cui l’acqua può essere concessa in uso a un privato.
La diffusione della nuova acqua Vergine: le forme e i destinatari della concessione
La concessione a titolo onerosoIl tipo di concessione più frequente, soprattutto durante i pontificati di Gregorio
XIII e di Sisto V, è quella onerosa, assimilabile a una compravendita. Il prezzo della nuova acqua Vergine è, come si è detto, di 80 scudi l’oncia fino al 1610, e in seguito di 100 scudi l’oncia. La persona o l’istituzione interessata può chiedere che gli sia concesso l’uso privato di una o più once, oppure, come avviene nella maggior parte
relativo gruppo di lettere patenti, in ciascuna delle quali è sempre riportato il testo del chirografo, è ivi, 3, dalla c. 1v alla c. 13r e va – dopo la riunione della congregazione «super viis, pontibus et fontibus» tenutasi nel palazzo del cardinal del Monte l’11 marzo 1623 – dall’aprile 1623 al settembre 1624.
28 Il chirografo è trascritto ivi, 1, s.n., 22 ottobre 1624. Le relative lettere patenti, che vanno dal novembre 1624 fino al dicembre 1626, sono ivi, 3, dalla c. 13r alla c. 31v.
29 I due chirografi sono trascritti integralmente ivi, 1, s.n. Le relative lettere patenti vanno dal set-tembre 1628 (ivi, 3, c. 31v) fino al 29 ottobre 1630 (ivi, 3, c. 70r), vale a dire circa due mesi e mezzo prima della stesura del documento che qui si pubblica. La successiva patente è emessa soltanto nel luglio 1635 (ivi, 3, cc. 70v-71v).
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 241
dei casi, di una frazione di oncia (fig. 2), vale a dire mezza, un quarto e talora perfi-no un mezzo quarto. Prima dell’ottenimento della concessione, il richiedente deve versare presso il banco depositario la somma corrispondente alla quantità richiesta. Sotto Gregorio XIII e ancora fino al 1587 il banchiere depositario è Bartolomeo Bonamici, mentre dal 1588 Sisto V utilizza il «banco delli heredi delli Ubertini» o «heredum q[uondam] Jo[hannis] Bapt[ist]ae Ubertini»30. A partire almeno dal 16 marzo 1595, forse dopo un breve periodo in cui il banchiere depositario è Alessandro Doni31, il banco Ubertini è sostituito da quello di Tiberio Ceuli. Dopo la morte di Tiberio Ceuli nell’agosto 1605 e il fallimento del suo banco che segue di lì a poco, il banchiere depositario diviene, sotto Paolo V, Roberto Primi. Gregorio XV utilizza invece il banco di Palaggi e Falconieri e Urbano VIII quello della famiglia Sacchetti.
I soggetti che chiedono di acquistare acqua per uso privato appartengono a ceti diversi. Essi sono certamente in maggior numero esponenti della nobiltà e alti eccle-siastici, ma spesso anche notai o medici, e non raramente titolari di esercizi commer-ciali. Questi ultimi richiedono acqua sia per uso presumibilmente solo privato, come «Fidele mercante de legna» o «Pietro Bartoli setarolo», che il 26 novembre 1586 ne acquistano rispettivamente mezza oncia e un’oncia32, sia talvolta per le necessità di un locale pubblico, come nel caso di «Ambrosio de Luccatelli hoste in piazza de Sciarra», che ne compra lo stesso giorno un quarto di oncia33. Un caso particolare di un certo interesse è quello che si verifica tra l’autunno del 1597 e i primi mesi del 1598, quan-do Clemente VIII offre in vendita «universitati et factoribus hebreorum» due once della nuova acqua Vergine, che finalmente aveva raggiunto il Ghetto. L’acqua è acqui-stata, nella quantità di un quarto o di mezzo quarto di oncia, da «Meluccio hebreo», «Santoro del Sestiero hebreo», «Salamone Corcos», «Giuseppe hebreo», «Giuseppe Toscano», «Lazzaro Viterbese», «i Deputati delle Scuole Ceciliane» e «Bonhomo de Nela», mentre una delle lettere patenti è redatta lasciando in bianco il nome dell’ac-quirente. Gli acquisti avvengono quasi tutti in due momenti, cioè nel mese di set-tembre del 1597, e poi, in tre casi, il 21 febbraio 159834. Soltanto un ultimo mezzo quarto di oncia è venduto a un Leone Ambrosi il 15 giugno 159835.
La nuova acqua Vergine è richiesta dai privati in prevalenza per alimentare fontane
30 Ivi, 2, c. 30r e c. 39v.31 Ivi, 2, c. 140r: il nome di Alessandro Doni è cassato e sostituito per mezzo di un’annotazione a
margine da quello di Tiberio Ceuli.32 Ivi, 2, cc. 24v-25r e c. 25r.33 Ivi, 2, c. 25v. Questa e quelle della nota precedente fanno parte di un consistente gruppo di pa-
tenti – rilasciate tutte il 26 novembre e registrate insolitamente in forma sintetica e in italiano – nel testo delle quali si precisa che l’acqua è tratta «dal condotto che parte da piazza Colonna et va al arco de Ca-migliano». Si tratta quindi probabilmente di un ramo della rete che era entrato in funzione di recente.
34 Ivi, 2, cc. 165r-169v.35 Ivi, 2, cc. 172r-v. Poiché soltanto i primi due acquirenti di quest’acqua offerta alla comunità ebrai-
ca ne richiedono un quarto di oncia, mentre gli altri otto si limitano ad acquistarne la minima quantità di mezzo quarto, sembra di poterne dedurre che le due once non vengono interamente attribuite.
242 ALOISIO ANTINORI
Fig. 2 - Tavola illustrativa della gamma dimensionale delle fistole per la vendita dell’acqua ai privati, con i relativi prezzi calcolati in ragione di 80 scudi l’oncia, ca. 1576 (Roma, ASC, Fondo Boccapaduli, fasc. 66, b. 104b, c. 1096r). Si noti che la misura del diametro dei condotti non cresce in modo esattamente proporzionale alla portata d’acqua, che è compresa tra un quarto di oncia e cinque once.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 243
situate nelle abitazioni e negli attigui giardini. Talvolta, però, è destinata anche alla valorizzazione di un’area urbana ancora inedificata, come quella che il cardinale Flavio Orsini, membro della Congregazione, acquisisce nel 1576 in Campo Marzio presso l’Ospedale degli Incurabili36, oppure all’irrigazione di terreni extraurbani, come nei casi di Lelio Camaiano e di Agostino Pinelli, che il 10 dicembre 1586 acquistano acqua – Pinelli ben 4 once – per le rispettive «vigne fora di porta del Popolo»37.
La concessione a titolo gratuitoI casi di concessione gratuita – tale è quella appena citata in favore di Flavio
Orsini – sono tutt’altro che rari in ogni periodo del più che ventennale processo di diffusione della nuova acqua di Salone, e durante il pontificato di Clemente VIII giungono a superare nel numero le vendite. I soggetti ai quali il cardinale camerlen-go – in molti casi presumibilmente per volontà del pontefice – decide di donare una certa quantità di acqua (la formula di rito usata nelle lettere patenti è «concedimus et gratiose elargimur») sono molteplici, e possono essere distinti in tre principali categorie:
- esponenti dell’aristocrazia e cardinali ai quali s’intende in tal modo fare un omaggio, oppure funzionari pubblici di varia qualifica che si vuole per qualche mo-tivo gratificare;
- persone compensate per aver in qualche modo prestato la loro opera nella rea-lizzazione della nuova rete idrica, tra le quali possiamo includere gli stessi cardinali membri della Congregazione;
- chiese, conventi, collegi e istituti religiosi in genere.I numerosi beneficiati del primo gruppo vanno dal già ricordato architetto mi-
suratore Giovanni Antonio De Pomis all’avvocato concistoriale Coronato Planca Incoronati, che il 5 marzo 1591 ottiene in concessione gratuita due once e mezza di acqua Vergine per la sua dimora nel rione Regola38; dal cardinale Alessandro d’Este, al quale Urbano VIII appena eletto dona il 19 dicembre 1623 un’oncia e mezza d’acqua da condursi al palazzo de Cupis in piazza Navona39, dove il prelato risiede, fino alla regina Caterina de’ Medici, madre del re di Francia, alla quale Sisto V concede il 25
36 Nella lettera patente registrata ivi, 2, cc. 1v-2v, si concedono gratuitamente tre once di acqua Vergine al cardinale Flavio Orsini per la «aream sive campum quem proxime emit seu conduxit d[ict]us Flavius Car[dina]lis in reg[io]ne Campi Martis et reg[io]ne eccl[es]iae sive hospitalis incurabilium de Urbe ut fabricandi causa ad ornatum Urbis». Alla fine del documento gli spazi per la data sono lasciati in bianco, ma l’anno è certamente il 1576. Per una descrizione del giardino di Flavio Orsini presso l’Ospedale degli Incurabili, cfr. R. lAnciAni, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità, I-IV, Roma, Loescher, 1902-1912, II, pp. 17-19. Lanciani erra sul nome del cardinale Orsini, che chia-ma Domenico anziché Flavio (o Fulvio).
37 Entrambi le concessioni sono in ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 26v.38 Cfr. le voci n. 137 e n. 138 del documento del 1631 riportato in appendice, e la relativa nota
47.39 Cfr. la voce n. 95 del documento riportato in appendice, e la relativa nota 30.
244 ALOISIO ANTINORI
maggio 1587 ben quattro once d’acqua Vergine «ad effectum illam ducendi ad eius palatium in Reg[ion]e S[anc]ti Eustachij et platea nuncupata de Madama situm»40.
Del secondo gruppo fanno parte funzionari come il già ricordato Luca Peto; arti-sti come Pietro Bernini, al quale il 30 gennaio 1625, per volontà di Urbano VIII, il camerlengo Ippolito Aldobrandini dona un’oncia d’acqua «per remunerarlo delle sue fatighe fatte in beneficio di d[ett]o condotto di d[ett]a aqua»41; un pubblico ufficiale come Alessio Boccamazza, che per molti anni e in diversa posizione firma le lettere patenti della Congregazione42; numerosi cardinali, infine, che nel corso del tempo fanno parte di quel dicastero, come il già ricordato Flavio Orsini (donazione ricevuta nel 1576), Benedetto Giustiniani (1587)43, Enrico Caetani, che è anche camerlengo (1588)44 (fig. 3), e Francesco Sforza (1588 e 1590)45.
Per quanto concerne le decine di concessioni gratuite a chiese e conventi, cite-remo soltanto, per la sua esemplarità, il caso dei Domenicani di Santa Maria sopra Minerva, ai quali il 1° dicembre 1587 è concessa gratuitamente un’oncia d’acqua Vergine a seguito di una supplica al papa e dell’intercessione del cardinale Montalto. Il testo della supplica è riportato nella lettera patente:
Beatis.mo P[ad]re, il Priore et frati del Convento di S[an]ta Maria della Minerva supplicano hu-milmente la S[anti]tà V[ostra] che voglia concedergli un’oncia di quel aqua che viene da Piazza Colonna et passa vicino al Collegio delli Giesuiti, atteso che ne hanno grand[issi]ma necessità per usu del lor convento, né si trova per hora comodità di far la spesa per comprarla; di questa gratia, ancora concessa a molti altri loghi pii, restaranno oblig[atissi]mi a V[ostra] Beatitudine et faranno sempre horation per Lei che N.S. Idio per lungho tempo la conservi felice46.
Un caso di concessione gratuita di carattere particolare è infine quello riguardante Paluzzo Mattei, che possedeva a Capo le Case un lavatoio (fig. 4) in attività già prima dell’arrivo a Roma della nuova acqua di Salone. Nel dicembre 1593 gli è consentito di mantenere senza alcuna spesa il possesso dell’acqua Vergine «existentem in eius la-vatorio posito Romae in Regione Trivij et in capite domorum, exeuntem ex quatuor
40 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 27v-28r. La stessa concessione è poi registrata una seconda volta – in forma sintetica e in volgare – in una data imprecisata di giugno: «Fu concessa patente in nome della Ser[enissi]ma Regina madre del re Christianissimo al S.r Inbasciatore di poter pigliare dal condotto che passa a piazza di san Luigi quattro oncie di acqua per condurla nel palazzo in piazza madama di essa Ser[enissi]ma Regina per residenza delli S.ri Inbasciatori delli Regi Christianissimi»: ivi, 2, c. 28r.
41 «Habiamo fatta gratia a Pietro Bernino Architetto da noi deputato sopra il condotto della aqua Vergine di una oncia di d[ett]a aqua Vergine per disporre a suo piacere da pigliare dal condotto, et luogho che da noi li sarrà assegnato, però li ne spedirete patenti gratis atteso che gli ne facciamo libera donatione per remunerarlo delle sue fatighe fatte in beneficio di d[ett]o condotto di d[ett]a aqua»: il chirografo papale è ivi, 1, s.n., alla data indicata; la lettera patente è ivi, 3, cc. 25v-26v, ed è registrata anche, tra documenti di epoca anteriore, ivi, 2, c. 342v.
42 Cfr. supra la nota 15.43 Cfr. la nota 50 dell’appendice documentaria.44 Cfr. la nota 72 dell’appendice documentaria.45 Cfr. la nota 4 dell’appendice documentaria.46 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 40r-v.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 245
Fig. 3 - Pianta del piano nobile dello scomparso palazzo Caetani all’Orso, poi collegio dei Celestini, ante 1629 (ASR, Disegni e piante, I, cart. 87, f. 544). Si noti la grande «fonte di acqua Vergine» situata nel cortile settentrionale verso il Tevere. Per concessione del MiBAC, aut. ASR 28/2010.
caulis seu foraminibus lapidum et per ipsum ab immemorabili tempore possessam ac ad praesens in pacifica et quieta possessione existentem».
Il permesso è concesso anche in considerazione del fatto che Mattei, in ottempe-ranza alle disposizioni delle autorità, ha adeguato il suo impianto alla nuova moderna rete idrica «in reducendo dicta foramina ad caulas aeneas seu metalli»47. Il caso è interessante, perché c’informa sul tipo di atteggiamento che, presumibilmente non solo in questa circostanza, fu adottato dalle autorità nei confronti dei privati che usu-fruivano già, spesso «ab immemorabili tempore», della ‘vecchia’ acqua Vergine.
La concessione in convenzioneUn terzo tipo di concessione, piuttosto frequente e particolarmente importante
per il legame che instaura tra l’interesse dei «particolari» e lo sviluppo economico ed edilizio della città, è quello che possiamo definire in convenzione, quando cioè l’ac-
47 Ivi, 2, cc. 126r-v.
246 ALOISIO ANTINORI
Fig. 4 - Roma, il tratto superiore dell’antica via “in capite domorum”, oggi via Francesco Crispi, in una fotografia del 1865 ca. (da J.h. PArker, Historical Photographs: a Catalogue of 3300 Photographs of Antiquities in Rome and Italy, London, E. Stanford, 1879, n. 1349). I panni stesi rivelano la presenza di un lavatoio, molto probabilmente lo stesso che nel 1593, quando apparteneva a Paluzzo Mattei, subì un adeguamento tecnico in seguito all’arrivo della nuova acqua Vergine della sorgente di Salone.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 247
qua è concessa a un privato in cambio di un’opera di pubblica utilità che questo si im-pegna a far eseguire a sue spese. Per esempio, il 20 dicembre 1580 la Congregazione stabilisce48 «che il condotto si seguiti fino in capo della strada di S. Anna, poi volti alla piazza delli Matthei, nella qual piazza si debba far la Fonte, che era destinata in piazza Giudea, con che il S.r Mutio Matthei si oblighi a fare mattonare detta piazza a sue spese, et tener netta la Fonte».
A queste condizioni, «si concede al detto Sig. Mutio Matthei tutta l’acqua che uscirà da detta Fonte, et se ne possa servire, con rimandarla nella chiavica massima». Invece «Alessandro Ximenes spagnolo» ottiene il 26 novembre 1586 tre once, «due pagate nelle mani delli heredi dell’Ubertino depositario et l’altra donatoli dalla Ill.ma Congr[egazio]ne, con patto che debba fare a sue spese doi fonte publice, una nella piazza delle monache de S.to Silvestro et l’altra nella piazza Vecchia de d[et]to San Silvestro»49.
Cinque anni più tardi, poi, il 13 luglio 1591, gli eredi di Ximenes ottengono di poter utilizzare per le loro pubbliche fontane – qui definite più esplicitamente «lavatorii» – «aquam ex aqueductu pub[lic]o fontis Trivij redeuntem prope ipsos lavatorios»50. Analogamente al fiorentino Simone Boscaglia, che possiede «in Urbe, ad publicam commoditatem», un lavatoio «prope arcum Portugalli, et via cursus, ad quod exercendum opus sit aquam ex acquaeductu publico fontis Trivij redeuntem prope ipsum lavatorium», si concede il 14 febbraio 1590 di «apponere et retinere ta-bulam immersam et infusam in ipsis aquis», in modo da interrompere parzialmente il flusso dell’acqua e riempire le vasche del lavatoio, ma obbligandolo ad attenersi a criteri tecnici tali da permettere che le acque sporche possano poi defluire in modo ottimale51. Diverso è il caso di Francesco Strada, il quale, avendo speso 38,50 scudi per riparazioni alle tubature che passano davanti alla sua casa in via dei Condotti, e apprestandosi a compiere un altro analogo intervento nello stesso luogo, invece di essere risarcito per le spese sostenute e da sostenere, ottiene dal camerlengo Caetani il 4 giugno 1598 un’oncia d’acqua Vergine in concessione gratuita52. Roberto della Genga, che aveva acquistato per la sua casa «posita in Regione Campi Martij in via ut d[ict]a dei Condotti» – è il palazzo all’attuale n. 60 di via della Fontanella Borghese, in angolo con via del Leoncino – una prima oncia d’acqua il 4 luglio 159253, ottiene gratuitamente altre due once il 5 febbraio 1597, con l’accordo che avrebbe costru-ito a sue spese una fontana pubblica «ante eius domum, pro servitio et comoditate publica»54: la piccola fontana è tuttora esistente (fig. 5). E ancora, nel 1616 il ca-
48 ASC, Camera Capitolina, cred. IV, t. 103, c. 10r. Ivi, alla c. 12v, ci sono poi i «Capitoli et conven-tioni dell’opera della Fonte di piazza Matthei».
49 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 26r. 50 Ivi, 2, cc. 106r-v.51 Ivi, 2, cc. 76r-v.52 Ivi, 2, cc. 171v-172r.53 Ivi, 2, c. 116r.54 Ivi, 2, cc. 157r-v. La fontana è certamente quella addossata al palazzo, proprio in angolo tra via
248 ALOISIO ANTINORI
nonico della basilica di Santa Maria Maggiore Odoardo Santarelli ottiene un’oncia d’acqua – si tratta però in questo caso di acqua Felice – per la sua nuova abitazione in prossimità della basilica, ma s’impegna in cambio a far eseguire a sue spese i lavori di sterro, diretti da Gaspare De Vecchi, necessari a regolarizzare la piazza fra la colonna proveniente dal Templum Pacis e la chiesa di Sant’Antonio55.
La concessione come indennitàUn ultimo tipo di concessione è quella che si può definire indennità di esproprio,
della quale nei registri esaminati abbiamo rintracciato un solo caso, verificatosi nel maggio del 1629. Nel relativo chirografo leggiamo56:
Ill.mo Cardinal Camerlengo. Habbiamo fatto gratia, et donato a Cristoforo Carena Piacentino per sé, suoi heredi, e successori qualsivoglia, quattro once di acqua Vergine da pigliarsi in Roma nei luoghi che voi deputarete più commodi, in ricompenza di quella quantità d’acqua che godeva nella peschiera e sua vigna posta fuori di Porta Pinciana in luogo detto sotto li Monti di Pariolo confinan-te con Bartolomeo Quadri, li canneti, et altri suoi confini, quale si li è levata. Con questo però, che da lui se intenda renuntiato a qualsivoglia ragione, et attione che havesse possuto, o potesse havere sopra d[ett]a acqua levatagli, né per d[ett]a causa possa mai per alcun tempo pretendere la restitu-tione di d[ett]a acqua, o altra qualsivoglia cosa. Però gli ne spedirete le patenti conforme al solito.
Va rilevato infine che l’acqua ottenuta da un privato sia per acquisto, sia in con-cessione gratuita o in convenzione, poteva da questo essere rivenduta in tutto o in parte, previa licenza della Congregazione, ad altri soggetti, così come fa ad esempio Alessio Boccamazza ripetutamente57, oppure Orazio Cianti nel 158158. Questo dirit-to è formalmente riconosciuto e regolato dall’autorità capitolina nella riunione del 20 dicembre 1580, quando si stabilisce59 «che le Patenti dell’acqua che si harranno a fare alli Particolari, si facciano secondo il solito, et volendo alcuno vendere o cedere l’acqua, non possa senza licentia della Ill.ma Congregatione».
La revisione straordinaria del 1631: il censimento degli utentiAll’inizio del 1631 Urbano VIII e il cardinale camerlengo Ippolito Aldobrandini
decidono di effettuare una revisione generale della rete idrica dell’acqua Vergine che era stata realizzata, dopo il ripristino del collegamento con le sorgenti di Salone, negli ultimi tre decenni del secolo precedente.
L’intento è quello di «rifare parte delli condotti di nuovo, et parte accomodare».
della Fontanella Borghese e via del Leoncino.55 A. rocA de AmiciS, L’area di Santa Maria Maggiore all’epoca di Paolo V Borghese: canonici, privati
e strategie di riqualificazione urbana, «Città e storia», 1, 2006, pp. 67-72, in particolare p. 69.56 ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 1, s.n., 30 maggio 1629.57 Cfr. la nota 67 dell’appendice documentaria. 58 ASC, Camera Capitolina, cred. IV, t. 103, c. 11v, 4 giugno 1581: «Si concede alli Figlioli del
quondam Sig. Antonio Gabriele di posser comprar l’acqua da ms. Horatio Cianthi suo vicino per ser-vitio della casa sua dove habita».
59 Ivi, c. 11r.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 249
Fig. 5 - Roma, fontana pubblica addossata al palazzo della famiglia della Genga, in angolo tra via di Fontanella Borghese e via del Leoncino, 1597. La fontana fu realizzata da Roberto della Genga in cambio della concessione gratuita di due once di acqua Vergine.
250 ALOISIO ANTINORI
La direzione tecnica dell’impresa è affidata a Gian Lorenzo Bernini, che aveva ere-ditato l’incarico di architetto dell’acqua Vergine dal padre Pietro, morto due anni prima. Per coprire le ingenti spese per l’esecuzione dell’opera, si decide di tassare tutti coloro che possiedono fontane private in proporzione alla quantità d’acqua di cui possono disporre, misurata come sempre in once, cioè in relazione al diametro del condotto privato, o fistola.
L’imposizione prevista è di 25 scudi per oncia. Per poterla applicare equamente alla generalità dei soggetti interessati, Bernini fa eseguire un censimento di tutte le utenze private di acqua Vergine collegate ai condotti compresi nel piano d’interven-to, vale a dire all’intera rete costruita durante i pontificati di Gregorio XIII, Sisto V e Clemente VIII per distribuire la nuova acqua di Salone nei rioni Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant’Eustachio, Pigna e Sant’Angelo. Ne deriva un elenco di 319 utenze, per ciascuna delle quali si indica – con poche lacune – il pro-prietario dell’unità immobiliare, il conduttore della stessa se diverso dal proprietario, la quantità d’acqua a disposizione, il conseguente importo della tassa.
Si tratta di un documento di notevole interesse da almeno due diversi punti di vista. Da un lato, infatti, ci fornisce una grande quantità di informazioni sulla distri-buzione degli spazi per la residenza e per il lavoro presso un’ampia parte dei ceti più abbienti della Roma di Urbano VIII: sulle proprietà immobiliari e sulle abitazioni di un gran numero di più o meno noti esponenti della nobiltà, dell’alto clero e delle professioni borghesi; sulle sedi di molte comunità religiose di ogni tipo; sulla loca-lizzazione dei più diversi esercizi commerciali. Si tratta di dati ai quali si è cercato di prestare attenzione, con esiti necessariamente frammentari e incompleti, nelle note. Ma soprattutto il censimento del 1631 ci presenta, a sessant’anni esatti dall’inizio della costruzione del nuovo acquedotto urbano, un quadro particolareggiato di come l’acqua di Salone fosse andata diffondendosi in una città che nello stesso arco di tem-po non aveva smesso di crescere e trasformarsi. E c’induce a riflettere sul rapporto tra il disegno della rete idrica e le scelte insediative dei soggetti sociali emergenti, i quali, nel dotarsi di dimore adeguate al nuovo status – così come li incoraggiava a fare la Quae publice utilia di Gregorio XIII, significativamente datata 1574 – rappre-sentarono il principale motore di quel rinnovamento urbano in articolata relazione con le iniziative dei pontefici. Anche se valutazioni definitive intorno a questo tema saranno possibili solo incrociando i dati sul consumo di acqua Vergine con quelli relativi all’acqua Felice e all’acqua Paola, i cui apporti, nel corso degli stessi decenni, erano andati ad aggiungersi in alcune aree della città – e certamente anche in alcune delle residenze del nostro elenco – a quello dell’acquedotto più antico.
La grande maggioranza degli utenti elencati nel documento del 1631 dispone di una quantità d’acqua Vergine compresa tra un quarto di oncia e un’oncia. Si tenga presente che mezza oncia era considerata «quantità assai notabile per li particolari», e perciò non superabile, nella memoria redatta da Boccapaduli e Cavalieri verso il
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 251
1575: una prescrizione prudenziale che era peraltro rimasta del tutto inattuata. I soggetti che dispongono di 3 o più once d’acqua Vergine sono 27, così suddivisi: 19 famiglie dei diversi gradi dell’aristocrazia (i Borghese, i Peretti, gli eredi del car-dinale Acquaviva, i Sacchetti ancora residenti in palazzo Sforza, gli Aldobrandini, i Rucellai, i Farnese, Crescenzo Crescenzi, i Vittori, i Giustiniani, gli Orsini di Bracciano, i Lancellotti, i Massimo del ramo di Antonio, gli Altemps, i Montoro, i Nari, i della Genga, i Manfroni, i Boccalini), quattro istituti religiosi (il collegio dei Celestini nel palazzo già Caetani, il convento di San Salvatore in Lauro, la chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, il monastero di Santa Chiara), una sede pubblica (la Cancelleria), una sede diplomatica (il palazzo di Firenze), un lavatoio pubblico (quello «nel cortile dei Matriciani», appartenente agli «heredi di Jacomo de Ferrari»), una struttura utilitaria privata (le scuderie dei Borghese).
Quasi tutte queste utenze sono situate lungo il percorso di uno dei rami maggiori dell’acquedotto urbano, o in sua prossimità: una circostanza che ben si spiega in rap-porto al fatto che le spese per la derivazione dell’acqua dai condotti principali erano sempre state a carico dei privati. Le dimore patrizie, per la maggior parte palazzi costruiti o trasformati negli ultimi decenni del XVI secolo o nei primi del XVII, si concentrano particolarmente in due aree. La prima è nel rione Campo Marzio, lungo l’asse dell’attuale via della Fontanella Borghese – prolungamento di via dei Condotti – e nel tratto del Corso prossimo al punto d’incrocio con quell’asse, cioè l’odierno largo Goldoni. La seconda è nella zona intorno al confine tra il rione Sant’Eustachio e il rione Pigna, vale a dire tra via della Scrofa, il Pantheon e la vecchia Dogana.
Si può anche rilevare che le residenze che consumano cospicue quantità di acqua Vergine sono meno numerose nei rioni Ponte e Regola, cioè lungo via dei Coronari, via Giulia e via di Monserrato (ma queste ultime strade dal 1613 erano raggiunte anche dall’acqua Paola), e del tutto assenti nell’ampia area di Parione compresa tra il convento dei Filippini e il lato occidentale di piazza Navona, una zona di edilizia minuta distante dai condotti e abitata in prevalenza dal ceto più modesto.
Quasi tutti i sette edifici che dispongono della maggiore quantità di acqua Vergine – da 5 once a salire – hanno una storia che in relazione a questo vantaggio appare significativa. Tra essi troviamo infatti:
- le dimore degli eredi dei tre ultimi pontefici di grande rilievo: i Borghese, che ricevono ben 25 once per il palazzo in Campo Marzio (voce n. 244), più altre 4 per l’antistante palazzo delle scuderie (n. 243); il principe Peretti, che nella sua dimora presso San Lorenzo in Lucina ne consuma 12 (n. 257); gli Aldobrandini, che nel loro palazzo davanti a San Luigi dei Francesi dispongono di 6 once (n. 147);
- due edifici che erano stati in passato le residenze di cardinali molto presenti nelle fasi iniziali della diffusione dell’acqua di Salone: il palazzo oggi Sacchetti in via Giulia (n. 9), che apparteneva a Giovanni Ricci al tempo in cui questo era stato posto da Pio V, insieme a Flavio Orsini, a capo della prima Deputatio aquae Virginis, e il palazzo
252 ALOISIO ANTINORI
Sforza in Ponte detto poi anche della Cancelleria Vecchia (n. 5), abitato da Francesco Sforza quando questo cardinale, membro della Congregazione super fontibus, aveva ottenuto ripetutamente dai suoi colleghi, nel 1588 e nel 1590, concessioni gratuite di acqua, la seconda volta avvantaggiandosi della rinuncia a costruire nella platea Pontis una fontana pubblica inizialmente prevista ma poi ritenuta inutile60;
- un palazzo che, oltre a essere situato nel punto della prima importante bifor-cazione delle condutture provenienti dalla platea Trinitatis, era appartenuto fino al 1583 a Francesco Jacobilli, gentiluomo di origine folignate probabilmente coinvolto, per le sue competenze di ingegnere idraulico, nella progettazione della nuova rete: il palazzo poi Rucellai e Ruspoli (n. 274)61.
S’impone all’attenzione il gran numero di commercianti e artigiani che nel 1631 possono disporre, nelle loro residenze quasi sempre in affitto e presumibilmen-te coincidenti in molti casi con il luogo di lavoro, di una piccola fontana privata. Scorrendo il documento incontriamo setaroli, speziali e droghieri, sarti, barbieri, ricamatori, vetrai e specchiai, «coronari», pellicciai, guantai, candelai, fornai, pastic-ceri, indoratori, saponai, «ogliarari», vinai, «pupazzari», spadai, «vermicellari», vendi-tori di neve e via dicendo, oltre a vari «mercanti» senza specificazioni e naturalmente diversi osti e albergatori. I lavatoi pubblici citati sono una decina, con disponibilità di acqua compresa tra mezza oncia e tre once. Quanto agli edifici con funzioni di pubblica utilità, va rilevato che ricevono tutti – inclusi gli ospedali di San Giovanni dei Fiorentini e di San Rocco e le carceri di Tordinona e di Corte Savella – quantità d’acqua relativamente modeste (una o al massimo due once), con l’eccezione della Cancelleria apostolica (4 once), che è però anche la lussuosa residenza del cardinale vicecancelliere Ludovico Ludovisi.
Aloisio Antinori
60 Cfr. la nota 4 dell’appendice documentaria.61 Cfr. la nota 89 dell’appendice documentaria.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 253
APPENDICE
ASR, Presidenza delle Strade, 446[c. 48r]Adì 10 Genaro 1631Tassa e contributione fatta per la spesa che si deve fare nel rifare parte delli Condotti di nuovo, et parte accomodare secondo che farà de bisogno, cominciando alla Botte nella Piazza della S.ma Trinità di Monti et seguitarli per Strada di Condotti, Scrofa, S.to Agostino, Coronari sino alla Chiavica di S.ta Lucia e per Banchi, Piazza Navona, verso corte Savella, la Rotonna e verso la Ciambella, conforme il decreto fatto da Mons. Cicalotto Aud[ito]re del Sig. Card[ina]le Camerlengo e l’ordine dato a bocca da N[ostro] S[ignore] al med[esi]mo Monsig.re Cicalotto et il Sig.r Cavagliere Bernino Architetto e diputato di d[ett]a opera, e scandaglio della spesa che si doverà fare; fatto dal medesimo Sig.r Cavagliere Bernino, all’infrascritti padroni che imboccano le loro fistole nelli Condotti Publici et si tassano […] de sc. 25 per oncia, fatta da me sottoscritto Architetto Deput[at]o et SS.ri Deputati.
Monte Giordano1. Anibale Manescalco, tiene l’oste della Spada 0½ sc. 12:50
Torna alla Chiavica di S.ta Lucia rincontro la Chiesa di S.to Stefano1
2. Lodovico Galluccio, hab. lui 0½ sc. 12:503. Guido Palaggio, spigionata 1 sc. 254. Gio. Battista Biondi nepote del Patriarca Biondi2, hab. Felice de Todis Notaro3 1 sc. 255. SS.ri Sacchetti, habitano loro, per il Palazzo delli SS.ri Sforzi4 6 sc. 1 506. Pietro Pescatore per doi fistole, hab. lui e Gio. Pavolo Posterla mercante 1 sc. 25[c. 48v]7. Cosimo Morelli, hab. lui rincontro S. Biascio in strada Giulia 0½ sc. 12:508. Camillo Curto per doi fistole, ha una hab. lui in strada Giulia,
1 Si tratta dell’antica chiesa di Santo Stefano in Piscinula, situata in via dei Banchi Vecchi, quasi di fronte a Santa Lucia in Piscinula. Trasformata nella prima metà del XVIII secolo e presente nella pianta del Nolli, fu demolita poco prima del 1870: cfr. Parione («Guide Rionali di Roma»), I-II, a cura di C. Pericoli Ridolfini, Roma, Fratelli Palombi, II, p. 58.
2 Su Fabio Biondi, l’ecclesiastico marchigiano molto vicino a Sisto V, che lo elevò al cardinalato nel 1588 con il titolo di patriarca di Gerusalemme, si veda la voce non firmata in Dizionario Biografico degli Italiani, 10, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968, pp. 526-527.
3 Felice de Todis (Felix de Totis) è attivo tra i segretari e cancellieri della Camera apostolica dal 1614 al 1633. 4 Nel 1631 i Sacchetti abitano ancora nel palazzo degli Sforza, cioè l’antica Cancelleria apostolica
costruita da Rodrigo Borgia a metà del XV secolo. Il 30 giugno 1590 il cardinale camerlengo Enrico Caetani decide di donare al cardinale Francesco Sforza per il suo palazzo «in Regione Pontis», «aquam iam destinatam pro fonte iam non tunc amplius [construendo], ob incapacitatem loci et alias dignas postea consideratas causas et impedimenta, in Platea Pontis, inanem et nemini inservientem»: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 85v-86r. La quantità dell’acqua non è precisata. La donazione è ribadita a nome dall’intera Congregazione – formata, oltre che dal camerlengo Caetani, dai cardinali Albani, Simoncelli, Canani, Salviati, Spinola, Giustiniani e del Monte, e della quale anche lo Sforza in questo periodo fa parte – il successivo 13 luglio (ivi, cc. 89r-v). Francesco Sforza aveva già ottenuto gra-tuitamente tre once d’acqua Vergine il 10 luglio 1588: ivi, cc. 52r-v. L’interessante episodio fu segnalato in C. d’onofrio, Acque e fontane, cit., p. 100 e nota 18.
254 ALOISIO ANTINORI
et l’altra casa Stefano del Grillo mercante 1 sc. 259. Mons.r Acqua Viva in Strada Giulia5 7 sc. 1 7510. Camilla Scarlati, hab. Silvestro Matioli setarolo nella strada che va in Banchi 1 sc. 2511. Contessa Spada, hab. Pavolo Todeschi 0½ sc. 12:5012. Heredi di Marcantonio sartore, hab. loro 0¼ sc. 6:2513. Heredi di Filippo Tassini, hab. Defendi de Vecchi mercante 0¾ sc. 18:7514. Heredi di Tomasso Brancavaglieri setarolo, hab. loro 0½ sc. 12:5015. Heredi di Beni del Bene6 rincontro il vicolo de’ Cimatori in d[ett]a strada, hab. Clemente Guiducci spetiale 0½ sc. 12:5016. Giulio Buratti7, S.ta Caterina della Rota et Moniche delle Convertite, hab. il Banco de Scaglia a S. Gio. de’ Fiorentini 1 sc. 2517. Horatio Falconiere, hab. Gio. Maria Angelini sartore nella strada che viene in Banchi 1 sc. 2518. Heredi de Geremia Ghelfi, hab. loro in strada Pavolina 1 sc. 2519. Iacomo Antonio Camaiano, hab. li Palaggi 1 sc. 2520. Ospidale di S. Gio. de’ Fiorentini8, acqua nova 1 sc. 2521. Heredi del Galletto dove è la fontanella rincontro a d[ett]o, hab. la Sig. Bona Bona 0½ sc. 12:50[c. 49r]22. Congregatione de Propaganda Fide, hab. li SS.ri Del Nero rincontro la Zeccha 0½ sc. 12:5023. Pietro Antonio Catalone per doi fistole, hab. lui et il Mosca9 notaro et altri per doi fistole 2 sc. 50
5 Si tratta del grande edificio oggi noto come palazzo Sacchetti. Il cardinale Ottavio Acquaviva d’Aragona l’aveva acquistato nel 1608 e vi aveva abitato fino alla sua morte nel dicembre 1612. Più tardi il palazzo era stato ceduto in affitto al cardinale Paolo Camillo Sfondrati, e si era più volte considerata la possibilità di venderlo. Tuttavia – sebbene un Avviso del 7 luglio 1618 riferisca di un acquisto da parte del cardinale Giovanni Battista Leni – nel 1631, quando è redatto il documento in esame, l’edificio apparteneva ancora agli eredi Acquaviva, che lo venderanno soltanto nel 1649 ai Sacchetti. Il motivo per cui il palazzo gode di una così cospicua dotazione di acqua va probabilmente cercato nel fatto che nell’ottavo decennio del Cinquecento, quando prende avvio la realizzazione del-la nuova rete dell’acqua Vergine, il palazzo apparteneva a Giovanni Ricci (che l’aveva acquistato nel 1552 da Orazio di Antonio da Sangallo), ossia proprio al cardinale che, insieme al suo collega Flavio Orsini, era stato posto da Pio V a capo della prima Deputatio aquae Virginis: cfr. supra nel testo. Sul palazzo si veda l. SAlerno, Palazzo Sacchetti, in l. SAlerno-l. SPezzAferro-m. tAfuri, Via Giulia, cit., pp. 288-313; ch.L. frommel, L’architettura, in Palazzo Sacchetti, a cura di S. Schütze, Roma, De Luca, pp. 45-75.
6 Gregorio «Bene in bene» (Benimbeni) aveva acquistato un quarto di oncia il 7 dicembre 1576: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 13r-13v.
7 Si tratta certamente del ben noto ingegnere militare che, nato nel 1577 a Senigallia, si era trasferito all’inizio del secolo a Roma, affermandosi in breve tempo come specialista di fortificazioni. Su di lui si veda P. SPAgneSi, Castel Sant’Angelo. La fortezza di Roma, Roma, Fratelli Palombi, 1995, pp. 57-88.
8 L’ospedale dei Fiorentini era stato parzialmente ricostruito da Carlo Maderno tra il 1607 e il 1610 o poco dopo. Fu demolito nel quarto decennio del secolo scorso per l’apertura della strada in asse con il nuovo ponte Principe Amedeo: H. hibbArd, Carlo Maderno and Roman architecture, 1580-1630, Lon-don, Zwemmer, 1971, ed. it. Carlo Maderno, a cura di A. Scotti Tosini, Milano, Electa, 2001, p. 191.
9 Anche Arsenio Mosca (Arsenius Musca) è, come Felice de Todis (cfr. supra la nota 3), prossimo alla fine di una lunga carriera: egli era stato infatti notaio del Vicario nel 1611 e poi notaio del Tribunale
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 255
Banchi24. Pirro Mattei per tre parte et per una parte li SS.ri Can[oni]ci di S. Pietro, hab. il Belgio notaro10 A.C. 1 sc. 2525. Il Cavagliere Scarlati per la casa dove stava l’Amadeo11 notaro spigionata, et nella botega hab. il barbiere 1 sc. 2526. Felice Scarlati per la casa dove sta il Banco di S. Spirito12 1½ sc. 37:5027. S.ma Anunziata in compagnia con il Sig. Marchese Giustiniano, hab. Belardino Capponi et altri 1 sc. 2528. Heredi di Pavolo Alberini13, hab. Mons. Fagnani e Tiburtio Valentini spetiale et altri 2½ sc. 62:5029. Botega spigionata ataccato il guantaro dell’Aquila 0¼ sc. 6:2530. Pietrozzi Altoviti14 in Ponte et per la casa delli SS.ri Accioli e Martelli ass.me 2½ sc. 62:50
Strada che da Banchi va alli Coronari31. Domenico Lini sarto, hab. lui 0½ sc. 12:5032. Gio. Battista Ariotti, hab. lui et Antonio recamatore 0¼ sc. 6:25
dell’Auditor Camerae dal 1612 al 1631.10 Francesco Giacomo Belgio iunior (Franciscus Iacobus Belgius) è notaio del Tribunale dell’Auditor
Camerae dal 1630 al 1653. Suo nonno Francesco Giacomo Belgio senior aveva ricoperto lo stesso inca-rico dal 1587 al 1601.
11 Domenico Amadeo (Dominicus Amadeus) aveva rogato come notaio del Tribunale dell’Auditor Camerae dal 1602 al 1629.
12 Nel 1607, l’anno dopo la sua istituzione da parte di Paolo V, il Banco di Santo Spirito era stato sistemato in una «casa» in Banchi di proprietà di un Annibale Guerra: cfr. E. Ponti, Il Banco di Santo Spirito, Roma, Banco di Santo Spirito, 1941, pp. 59-63. Il Felice Scarlati citato nel nostro documento potrebbe dunque essere un successivo proprietario dello stesso edificio, oppure il Banco, contrariamente a quanto afferma Ponti, potrebbe essersi trasferito prima del 1631 in un’altra sede nella stessa zona.
13 Si tratta certamente del palazzo che Raffaello aveva progettato per Giulio Alberini tra il 1514-1515 e il 1518. Dopo la morte di Raffaello nel 1520, la costruzione dell’edificio era proseguita per qualche tempo sotto la direzione di Giulio Romano, ma, arrestatasi subito dopo il quarto asse del fronte su via dei Banchi, verrà portata a termine solo nel settimo decennio dell’Ottocento. Sulla storia dell’edi-ficio: ch.l. frommel, Der Römische Palastbau der Hochrenaissance, I-III, Tübingen, Wasmuth, 1973, II, pp. 1-12; P.N. PAgliArA, Palazzo Alberini, in Raffaello architetto, catalogo della mostra (Roma 1984), a cura di Ch.L. Frommel-S. Ray-M. Tafuri, Milano, Electa, 1984, pp. 171-188. Paolo Alberini acquista un’oncia di acqua Vergine per il suo «palatium positum Romae in Regione Pontis» il 10 giugno 1597: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 160r-v.
14 Il grande palazzo Altoviti sorgeva sulla platea Pontis e fu demolito nel 1888 per la creazione del Lungotevere. Era stato acquistato al tempo di Leone X dal banchiere fiorentino Antonio Altoviti e rinnovato e ampliato intorno alla metà del XVI secolo da suo figlio, il celebre mecenate Bindo. Dal rife-rimento all’attigua «casa delli SS.ri Acci[iaiu]oli e Martelli assieme» si comprende che si concentravano in quel punto le proprietà immobiliari di tre delle più importanti famiglie fiorentine. Su una circostanza significativa del rapporto di solidarietà che legava gli Altoviti ai Martelli, si veda anche E. mori, «Tot reges in urbe Roma quot cives». Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento, «Roma moderna e contemporanea», IV, 2, 1996, pp. 379-401, in particolare p. 393. Cfr. anche ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 26v-27r: «Altra simile patente fu spedita in persona de Mons. Ill.mo et Rev.mo Agustino Cusano Aud[ito]re della Rev.a C[amera] Ap[osto]lica de mezza oncia di acqua per il pa-lazzo delli Acciaioli dove al p[rese]nte habita, da pigliarsi dal condotto che porta l’acqua in ponte overo da quello che la [sic] presa l’Ill.mo et Rev.mo Card.le Lancellotto», in data 29 aprile 1587. Sul palazzo Altoviti: P. PortogheSi, Roma nel Rinascimento, s.l., Milano, Electa, 1971, pp. 443-444.
256 ALOISIO ANTINORI
33. Felice S. Pietro, hab. Francesco Arigo pasticero in d[etto] 0½ sc. 12:50
[c. 49v]Strada de Panico34. Heredi di Bartolomeo Veltrini droghiero in Ponte 0½ sc. 12:5035. Li Preti di S. Celso in Banchi 0½ sc. 12:5036. Gio. Battista Martino spetiale 1 sc. 2537. Heredi di Gio. Pietro bicchieraro in Panico, hab. lui 0½ sc. 12:5038. Gio. Battista Fascianello medico rincontro la fontanella nel vicolo che non ha riuscita, hab. Vincenzo oste 1½ sc. 37:50
Strada de’ Coronari39. Horatio Bonetti, hab. il fondico di S. Marco 0½ sc. 12:5040. Marliani Canonico di S. Maria in via Lata, hab. Cesare recamatore 0½ sc. 12:5041. Francesco Mancinelli, hab. Gio. Battista Gioria 0¼ sc. 6:2542. Pietro specchiaro, hab. la stufa de Panico 0½ sc. 12:5043. S. Iacomo dell’Incurabili, hab. Gio. Andrea barbiere 0½ sc. 12:5044. Heredi di Massei, hab. Monsig. Vecchiarello et altri 0½ sc. 12:5045. Monsig. Vecchiarelli15, hab. Gio. Andrea et Gioseppe et altri 1 sc. 2546. Daniello Paletto, hab. Pietro Gorti 0½ sc. 12:5047. Monsig. Lanuvio, hab. lui 1 sc. 2548. Ottavio Celio nel cantone rincontro la Madonnella, hab. lui 0½ sc. 12:50
[c. 50r] Seguita per li Coronari49. Casa della S.ma Ternità de Ponte Sisto, hab. Anibale Gagliardo 0½ sc. 12:5050. Il Curato di S. Simone Giuda per doi parte et per un’altra parte della S.ma Madonna della Consolatione, hab. Daniello Porto 0½ sc. 12:5051. Sig. D. Pavolo Giordano per il Palazzo16 3 sc. 7552. Casa rincontro a d[ett]o del S.mo Salvatore del Lauoro, hab. Girolimo coronaro vecino cartonaro 0¼ sc. 6:2553. Il Sig. Card.le Caetano per il lavatore all’Orso 1 sc. 2554. Tordinona di S. Girolimo della Carità17 1 sc. 2555. Frati del S.mo Salvatore del Lauoro per il convento18 et altri 4½ sc. 1 12:50
15 Si tratta probabilmente del palazzo tra San Salvatore in Lauro e l’attuale piazza dei Coronari co-struito al tempo di Gregorio XIII dal nobile reatino e abbreviatore apostolico Mariano Vecchiarelli.
16 Il palazzo del duca di Bracciano Paolo Giordano II Orsini a Montegiordano riceve una quantità relativa-mente modesta di acqua Vergine perché è raggiunto anche dall’acqua Paola. Era anzi quest’ultima ad alimentare dal 1615 o 1616 la grande fontana nel cortile maggiore del complesso disegnata da Antonio Casoni e rappre-sentata da Giovanni Battista Falda. Quando è redatto il nostro documento, il palazzo del duca di Bracciano era abitato dal cardinale Maurizio di Savoia, che l’aveva affittato nel 1622. Tuttavia già dal 1627 l’Orsini meditava di venderlo: k. triff burgArd, Two Seventeenth-Century Plans of the Palazzo di Monte Giordano in Rome, «Mit-teilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XLII, 1998, pp. 511-523, in particolare p. 515.
17 Il reclusorio ‘governativo’ di Tor di Nona, il maggiore della città, era sotto il controllo dell’Arci-confraternita di San Girolamo della Carità dal 1568, quando Pio V aveva ordinato alla Camera aposto-lica di vendere al sodalizio l’ufficio del Soldanato o Capitanato di quel carcere: A. Antinori, La magni-ficenza e l’utile. Progetto urbano e monarchia papale nella Roma del Seicento, Roma, Gangemi, 2008, pp. 20-21 e pp. 50-52, con precedente bibliografia.
18 Su questo importante convento: c. AStolfi, Storia del Convento e Chiesa di S. Salvatore in Lauro
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 257
56. Frati della S.ma Ternità di Monti al Fico, hab. Francesco Grossi 1 sc. 25
Coronari57. Casa de Roncalli, hab. Zimenes dove stava il Bursalto 1½ sc. 37:5058. Desiderio Baldi rincontro a d[ett]o, hab. Iacomo coronaro 0¼ sc. 6:2559. Antonio del Drago, hab. Bartolameo Scorno e Pozzi Bonelli 1½ sc. 37:5060. Scipione Ancillotto19 per doi fistole 3 sc. 7561. Felice S. Pietro, hab. Giovanni Carinello 0½ sc. 12:5062. S.r Duca Acqua Sparta20 2 sc. 5063. La forbicina, hab. Margherita vedova acanto Lancillotto 0¼ sc. 6:2564. Antonio Celli rincontro Lancillotto 0½ sc. 12:5065. Heredi di Giulio Bona Ventura21, hab. loro, et il vetraro 1 sc. 25[c. 50v]66. Heredi di Rafael Tudolfi, hab. Agostino Croce et altri 0½ sc. 12:5067. Ferrante Bigierro22, hab. lui 0½ sc. 12:5068. Alisandro Palavicino, hab. lui 0½ sc. 12:5069. Francesco Guerra, hab. lui 1 sc. 2570. Antonio Lucatelli23 notaro al Vicario, hab. Simone pellicciaro 0½ sc. 12:5071. La S.ma Consolatione, hab. Martino falegniame et altri 0½ sc. 12:5072. Francesco Baltronelli ottonaro, hab. il pellicciaro 0¼ sc. 6:2573. Felice S. Pietro, hab. lui 1 sc. 2574. Marchese Olgiati24, hab. Monsig. Raimondo 2 sc. 50
oggi S. Maria di Loreto dei Marchegiani, «Rassegna Marchigiana», XI, 1933, 5-7, pp. 3-75; P. hoff-mAnn, San Salvatore in Lauro, Roma, Carucci, 1979. È interessante l’iscrizione apposta nel 1579 sulla piccola fontana pubblica addossata alla facciata del convento verso la piazza per celebrare l’arrivo dell’acqua Vergine e rendere omaggio a Gregorio XIII: UT LUPUS IN MARTIS CAMPO MANSUETIOR AGNO / VIRGINEAS POPULO FAUCE MINISTRAT AQUAS / SIC QUOQUE PERSPICUAM CUI VIRGO PRAESIDET UNDAM / MITIOR HIC HOEDO FUNDIT AB ORE LEO / NEC MIRUM DRACO QUI TOTI PIUS IMPERAT ORBI / EXEMPLO PLACIDOS REDDIT UTROSQUE SUO / MDLXXVIIII.
19 Il cardinale Scipione Lancellotti aveva avviato la trasformazione dell’antica residenza della sua famiglia lungo via dei Coronari nel 1591, affidandone il progetto a Francesco da Volterra, che nel 1594 era morto ed era stato sostituito da Carlo Maderno. Tuttavia già il 1° ottobre 1584 il cardinale aveva ottenuto per la sua dimora le tre once di acqua Vergine che qui risultano. Sulla storia della costruzione del palazzo, tuttora non completamente chiarita, si veda P. cAVAzzini, Palazzo Lancellotti ai Coronari, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1998, pp. 13-37.
20 Nella scarsa e superficiale bibliografia sul palazzo nel rione Ponte costruito dai Gaddi probabil-mente tra il secondo e il terzo decennio del XVI secolo e acquistato poi nel 1567 da Angelo Cesi, si può vedere Il Palazzo Cesi di Via della Maschera d’Oro, Roma, s.e., 1998, in particolare pp. 5-16.
21 Il palazzetto Bonaventura (poi Latini e Diamanti Valentini) è agli attuali nn. 26-29 di via dei Coronari, presso la piazzetta di San Simeone.
22 Si tratta quasi certamente di quel «Ferrante Beger» al quale è concessa gratuitamente mezza oncia d’acqua Vergine l’8 gennaio 1607 per la sua casa «sita in Regione Pontis in via prope templum Pacis»: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 225r-v.
23 Antonio Lucatelli (Antonius Lucatellus) era notaio presso gli Uffici della Curia del Vicario già dal 1612, e avrebbe continuato a rogare fino al 1648.
24 Nel 1590 Settimio Olgiati aveva acquistato – derivandola dall’acquedotto in costruzione «a Platea Agonis ad Campi Floris [sic]» – mezza oncia d’acqua per la propria residenza (ASR, Presidenza degli Acque-dotti Urbani, 2, c. 84r) e la stessa quantità per quella di una Faustina Muti, anch’essa situata in Parione: ivi, cc. 86r-87r. In quella data dunque Settimio Olgiati doveva già abitare il palazzo nell’attuale piazza Fiam-metta, anche se l’acquisto dai precedenti proprietari, i Ruiz, è formalizzato soltanto il 3 dicembre 1605: f.
258 ALOISIO ANTINORI
Torsanguigna75. Pavolo Bovardino25 fondico, hab. Gioseppe spetiale et altri 1¼ sc. 31:2576. Heredi di Gioseppe Cassiano, hab. Baldo Baldotto, et il guantaro 0½ sc. 12:5077. Heredi d’Oratio Ceruti tra pasticeri, hab. Camillo Curti 1 sc. 2578. Gaspero Alberi per l’ostaria del Cavalletto 0½ sc. 12:5079. Felippo Alborghetti mercante del Moro 1 sc. 2580. S.r Vermigliola, hab. lui, acqua nova 1 sc. 2581. Heredi di Francesco dell’Orto, hab. Francesco Baretto oste dell’Orso 1 sc. 2582. Cavagliere Cervone all’Orso con il lavatore, hab. nel Corso vecino strada Vittoria dove è il pizzicarolo 1 sc. 25[c. 51r]83. Massimo de’ Massimi26, hab. il Marchese Palavicino 3 sc. 7584. Pietro Emilio Poggi rincontro il Palavicino 0½ sc. 12:5085. Lavatore nel vicolo dell’Altemps 0½ sc. 12:5086. Sig.r Duca Altemps27 3 sc. 7587. MM. RR. PP. della Polinara28 per doi fistole 2 sc. 5088. Gio. Battista Tovaglia per il fondico negrone che fa cantone verso Navona 0½ sc. 12:5089. [a questo numero non corrisponde alcuna voce]90. Heredi di Livia Baghattina, hab. il magazzino alla Polena 0½ sc. 12:50
Quelli che hanno l’acqua cominciando nella strada a capo Piazza Navona et seguitarla per d[ett]a verso S. Pantaleo, Campo di Fiore, Palazzo del Duca verso Corte Savella sino al Palazzo dove hab. il Sig. Card.le Verile29, a mano dritta e mano manca di d[ett]a strada Si tassa91. Mutio Coltre quale era del Sig. Lelio di Magistris, hab. Marcurio candelottaro 0½ sc. 12:50
eleuteri, Le residenze dei Corsini a Roma, «Quaderni di Storia dell’Architettura e Restauro», 4-5, 1990-1991, pp. 43-45; A. Antinori, Su Onorio Longhi (1568-1619), «Quaderni del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico», XI (2001), 21-22, pp. 45-78, in particolare p. 74.
25 Un’oncia di acqua Vergine era stata venduta a «Bartolomeo Buvardino mercante a Torsanguignia» con chirografo di Paolo V del 27 maggio 1611: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 240v.
26 Si tratta della «domus Antonii de Maximis» che nella pianta di Roma di Leonardo Bufalini del 1551 occupa l’isolato di via dell’Orso più prossimo a quello di Sant’Antonio dei Portoghesi. Oggi al n. 28 della stessa strada, il palazzo ha dimensioni notevoli ed è tuttora dotato di un cortile con ninfeo.
27 Appartenuto ai Riario Sforza e poi al cardinale Francesco Soderini da Volterra, questo palazzo presso Tor Sanguigna era stato acquistato nel 1568 dal cardinale Marco Sittico Altemps, figlio del conte Wolfgang Hohenems (Altemps) e di Chiara Medici, sorella del papa Pio IV (1559-1565). Mar-co Sittico l’aveva fatto completamente rinnovare a partire dal 1572 su progetto di Martino Longhi il Vecchio: f. ScoPPolA, Memoria della casa. Architettura: dalla composizione al restauro in Palazzo Altemps. Indagini per il restauro della fabbrica Riario, Soderini, Altemps, a cura di F. Scoppola, Roma, De Luca, 1987, pp. 9-142. In ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, è registrata in data 5 marzo 1590 (cc. 98r-v) la donazione fatta da Gregorio XIV al cardinale Marco Sittico Altemps di quattro once di acqua Vergine per la sua vigna fuori porta del Popolo, ma non è presente un analogo docu-mento relativo al palazzo urbano.
28 È il palazzo di Sant’Apollinare, che nel 1574 era stato assegnato da Gregorio XIII ai Gesuiti del Collegio Germanico Ungarico.
29 Luca Antonio Virili era stato creato cardinale da Urbano VIII il 19 novembre 1629, dopo aver ricoperto la carica di uditore di Rota. Più avanti, alla voce n. 138, è chiarito che il palazzo in cui abita è uno di quelli dell’insula dei Planca Incoronati.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 259
92. Casa di Leandro dove stava l’orvietano 0½ sc. 12:5093. Heredi di Cristofano Anselmi, hab. loro e Pavolo calderaro 0¼ sc. 6:2594. Casa dell’Anima, hab. l’avocato Mandosio, acqua nova 1½ sc. 37:50[c. 51v]95. Francesco de Cupis, hab. il Sig. Card.le Caetano30 2¾ sc. 68:7596. Heredi di Statilio Pacifici, hab. Francesco Ferretti et altri 1 sc. 2597. Heredi di Campritio Carnevaglia acanto d[ett]o 1 sc. 2598. S. Jacomo degli Spagnoli31 per quatro fistole 4 sc. 1 0099. Gaspero Rinaldo 1 sc. 25100. Teodosio de Rossi32, hab. lui 1 sc. 25101. Herede di Baldassar Bonadies, hab. Monsig. Umellino rincontro S. Agnesa 1 sc. 25102. Casa acanto d[ett]a N…, hab. Monsig. Baldeschi et altri 1 sc. 25103. Marchese Tassi a Pasquino 1½ sc. 37:50104. Gasparo Gailardo a Pasquino 0½ sc. 12:50105. Heredi de Baldassarre Guglielmi, hab. loro al bichiero de Pasquino 0½ sc. 12:50106. S.r Duca Gio. Antonio Orsino, tiene le botege N. Maria apaltatore della piazza 1 sc. 25107. Sig. Card.le Torres33 con quella della casa in Tor Sanguigna, habitano mercanti 1½ sc. 37:50108. Heredi di Teofilo Sartorio in piazza Navona, hab. il Duca di Zagarolo e Francesco stagnaro 1 sc. 25
[c. 52r]Quelli che hanno le fistole in piazza Navona109. SS.ri Capranica, hab. il Sig. Card.le Gessi34 1 sc. 25
30 Nei primi decenni del XVII secolo il grande palazzo de Cupis tra via dell’Anima e piazza Navo-na, costituitosi attraverso successivi accorpamenti intorno a un iniziale nucleo tardoquattrocentesco, è abitualmente ceduto in affitto a cardinali. Nel momento in cui è redatto il documento in esame vi abita il cardinale Luigi Caetani, mentre sette anni prima, alla fine del 1623, vi risiedeva il cardinale Alessandro d’Este. Cfr. infatti il chirografo papale trascritto in ASR, Presidenza degli Acquedotti Ur-bani, 1, s.n., 19 dicembre 1623: «Rev.mo Card.l Camerlengo. Habbiamo concessa al R.mo Card.l d’Este una oncia d’Acqua Vergine da pigliarsi dal Condotto publico nel loco, che gli assegnarà Mons. Biscia per condurla, et servirsene, nel Palazzo de Cuppis, dove esso Cardinale habita». Un secondo chirografo è emesso il 23 gennaio 1624, ivi, per precisare che l’oncia d’acqua è concessa «gratis, et senz’alcun pagamento, ché gli ne facciamo pura, et libera donatione»; la relativa lettera patente, del 29 gennaio 1624, è ivi, 2, cc. 325v-326v.
31 Dopo i Celestini nel palazzo ex Caetani nel rione Ponte, adibito tuttavia a collegio, e i frati del convento di San Salvatore in Lauro, i Padri della chiesa della Nazione spagnola sono i religiosi che di-spongono nel 1631 della maggiore quantità di acqua Vergine.
32 Cfr. ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 1, s.n., 12 marzo 1624: «R.mo Cardinal Camerlen-go. Habbiamo fatto gratia a Theodosio de Rossi da Piperno di un’oncia d’Acqua Vergine da pigliarla dal condotto publico di Navona, et dal loco che gli assegnarà Mons.r Biscia. Però gli ne spedirete la solita Patente gratis, et senza pagamento alcuno, atteso che gli la donamo, et così esseguirete». La relativa lettera patente, emessa il giorno successivo, è ivi, 3, cc. 10r-11r.
33 Cosimo de Torres era stato creato cardinale da Gregorio XV il 5 settembre 1622. 34 È il bolognese Berlinghiero Gessi, maestro di casa di Gregorio XV e poi di Urbano VIII fino a
tutto il 1624, e finalmente cardinale dal 1626.
260 ALOISIO ANTINORI
110. Sig. Card.le Ludovisio per la Cancelleria35 4 sc. 1 00111. Li Cosceri alla Valle incontro al Biscia 1 sc. 25112. Casa di N..., hab. Monsig. Pirovano acanto d[ett]o 0½ sc. 12:50113. Francesco Biscia36, hab. lui 1½ sc. 37:50114. PP. delle Scole Pie37 con l’ostaria della Cuccagna 1¼ sc. 31:25115. Herede di Fabbio Mandosio attaccato Mons. Pirovano incontro al Biscia 0½ sc. 12:50116. Fabrizio de’ Massimi38, hab. lui 1 sc. 25117. Massimo de’ Massimi39, hab. lui 2 sc. 50
Seg[ui]ta a S. Pantaleo118. Heredi di Manini, hab. Monsig. de Rosi et altri 1 sc. 25119. Antonio Griffi, hab. Gioseppe Cornaro arte bianca 1 sc. 25120. Valentini rincontro a d[ett]o, hab. loro 0¼ sc. 6:25121. Marchese de’ Massimi alla Valle 1 sc. 25122. Heredi di Geronimo de’ Pichi40 con il lavatore rincontro il Marchese de’ Massimi 1½ sc. 37:50123. Antonio Ciampino ortarolo in Campo de Fiore 0½ sc. 12:50[c. 52v]124. Sig. Duca de Parma per il Palazzo e Casa nella piazza d[ett]a41 4 sc. 1 00125. Sig. Duca d’Alatri a strada Giulia, hab. la Sig.ra Settimmia Magalotti 2 sc. 50126. Guido Palaggi in d[ett]a strada, hab. Giorgio nepote del Rotoli 2 sc. 50127. Coleggio dell’Inghilesi42 1 sc. 25
35 Il cardinale Ludovico Ludovisi, nipote di Gregorio XV, occupava la carica di vicecancelliere dal 1623, quando era subentrato ad Alessandro Damasceni Peretti. L’avrebbe mantenuta fino alla sua morte nel 1632.
36 È tuttora visibile nella chiesa di San Pantaleo la lapide sepolcrale di Laudomia Brancaleoni, morta nel 1577 e moglie di un Francesco Biscia, forse nonno di quello citato nel documento in esame.
37 Nel 1612 Giuseppe Calasanzio, fondatore della Congregazione degli Scolopi e delle Scuole Pie, aveva avuto dai coniugi Ludovico de Torres e Vittoria Cenci la possibilità di risiedere con i suoi seguaci nel palazzo già Muti situato alle spalle della chiesa di San Pantaleo. Due anni più tardi il Calasanzio aveva ottenuto da Paolo V anche la chiesa: g. SPAgneSi, San Pantaleo («Le chiese di Roma illustrate», 94), Roma, Marietti, 1967, in particolare pp. 19-24.
38 Fabrizio «de Massimis» aveva acquistato, al prezzo consueto di 120 scudi, un’oncia e mezza di acqua Vergine in un giorno non precisabile della primavera 1590. Nella lettera patente manca l’indicazione del ri-one dove è situata la casa per la quale è acquistata l’acqua, tuttavia questa è derivata «ex aqueductu publico faciend[o] a Platea Agonis ad Campum Floris»: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 79v-80r.
39 Un’oncia di acqua Vergine era stata acquistata da Massimo de’ Massimi, al prezzo ormai accresciu-to di cento scudi, il 23 gennaio 1626: ivi, 3, cc. 27r-28r.
40 Questa oncia e mezza di acqua Vergine per il loro palazzo «ad viam Vallis et conspectu palatij dd. de Maximis» era stata donata da Sisto V agli eredi di Girolamo Pichi il 27 luglio 1590: ivi, 2, cc. 87r-v. Sul palazzo di Girolamo Pichi: S. VAltieri, Il palazzo del principe, il palazzo del cardinale, il palazzo del mercante nel Rinascimento, Roma-Reggio Calabria, Gangemi, 1988, pp. 75-98.
41 Si tratta delle quattro once che Alessandro Farnese aveva acquistato il 13 giugno 1590: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 84v-85r. Ma al palazzo dei Farnese giungeva dal secondo decennio del secolo anche una certa quantità di acqua Paola: si veda a riguardo, qui, il saggio di Marisa Tabarrini.
42 Il Collegio degli Inglesi in via Monserrato ottiene un’oncia di acqua Vergine come dono da parte dei Conservatori il 12 luglio 1590 (ivi, 2, cc. 89v-90r) e un’altra come dono del nuovo papa Gregorio XIV il 20 aprile 1591: ivi, 2, c. 99v. Su questa rilevante istituzione, che Gregorio XIII aveva rifondato nel 1577 in funzione antianglicana, si veda soprattutto V. VeSey, Il progetto di papa Gregorio XIII per il
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 261
128. Camillo Curto rincontro a d[ett]o, hab. lui 0½ sc. 12:50129. Corte Savella de’ SS.ri Savelli43 1 sc. 25130. Heredi di Livia Baghattina rincontro la depositeria, hab. loro et l’indoratore 1 sc. 25131. Casa de N..., hab. Girolimo Vivaldi vecino al Rocci 1 sc. 25132. Antonio Rocci44, hab. lui con la casa del Crivello 2 sc. 50133. Tomasso Florido rincontro il Sig. Card.le Verile 1 sc. 25134. Heredi di Monsig. Orsino, hab. Marcantonio Vittorio 1 sc. 25135. Heredi di Giulio Ricci45, hab. Monsig. Benini, in più lochi 2½ sc. 62:50136. Lo Spirito Santo in strada Giulia46 2 sc. 50137. Cesare Incoronati47 2 sc. 50[c. 53r]138. Cesare et Angelo Incoronati, hab. il Sig. Card.le Verile 2 sc. 50139. Ottavio Diaz hab. lui et Alesandro Pelegrino 1½ sc. 37:50
Collegio Inglese di Roma, «Opus», 6, 1999 (2000), pp. 173-206.43 Il duca Savelli acquista mezza oncia di acqua Vergine per la Curia Savella il 29 aprile 1591: ASR,
Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 102r-v. Sull’antico tribunale con carcere annesso gestito dai Savelli nell’attuale via Monserrato, e sulle vicende della sua definitiva chiusura nel 1652: A. Antinori, La magnificenza e l’utile, cit., pp. 49-74.
44 I Rocci erano una famiglia di origine cremonese trasferitasi a Roma nel secolo precedente. Nel 1590 Bernardino Rocci aveva acquistato un’oncia d’acqua Vergine per la «domum suam sitam in d[ict]a Urbe in Regione Arenula»: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 83r-v. Ciriaco Rocci, già governatore di Viterbo e di Ferrara e nunzio in Svizzera, aveva conseguito nel 1629 la nomina al cardinalato in pectore (pubblicata poi nel 1633), e nello stesso anno l’esponente laico della famiglia, l’Antonio Rocci qui citato, era stato eletto conservatore. Nella storia del palazzo, all’attuale n. 25 di via Monserrato, ebbero un ruolo Francesco da Volterra e più tardi Carlo Maderno, al quale fanno riferimento Baglione e Martinelli: oltre a H. hibbArd, Carlo Maderno, cit., p. 290, si veda ora f. nicolAi, Un esempio di ‘nuova nobiltà’ nella Roma del ’600. I Rocci di Cremona, in Vecchia e nuova aristocrazia a Roma e nel Lazio in età moderna. Strategie economiche e del consenso, a cura di D. Galla-votti Cavallero, Roma, Nuova Argos, 2006, pp. 133-173, in particolare pp. 133-145.
45 Si tratta del palazzo, costruito nel primo Cinquecento forse per la famiglia Calcagni, che forma angolo sull’attuale piazza dei Ricci. Celebre per la sua facciata decorata a fresco da Polidoro da Caravaggio intorno al 1525, l’edificio era stato acquistato nel 1577 da Giulio Ricci, della famiglia originaria di Montepulciano alla quale era appartenuto il cardinale Giovanni: l. SAlerno, Palazzo Ricci-Paracciani, in l. SAlerno-l. SPezzAferro-m. tAfuri, Via Giulia, Roma, Staderini, 1973, pp. 382-391; P. Perfetti, Le vicende costruttive del palazzo Ricci-Paracciani a Roma, «Rassegna di architettura e urbanistica», XXIII, 69-70, 1989-1990, pp. 55-62; A. bruSchi, Palazzo Ricci a piazza de’ Ricci: una poco nota fabbrica del giovane Antonio da Sangallo, ivi, pp. 50-54.
46 La chiesa dedicata allo Spirito Santo, nel sito che Gregorio XIII aveva donato nel 1574 alla Nazio-ne napoletana, era stata completamente ricostruita con intervento di Ottaviano Mascherino negli ultimi due decenni dello stesso secolo: M. tAfuri, S. Spirito dei Napoletani, in l. SAlerno-l. SPezzAferro-m. tAfuri, Via Giulia, cit., pp. 392-400.
47 «Coronatus Planca de Incoronatis nobilis Romanus advocatus consistorialis» riceve in dono il 5 marzo 1591 due once e mezza di acqua Vergine per la sua casa «in Regione Arenula […] et proprie in via tendente a platea Ser[enissi]mi Ducis Parmae et Placentiae ad eccl[esi]am Sanctae Luciae et Banchi»: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 98v-99r. Non è possibile precisare se quest’acqua sia da riferire alla residenza registrata in questa voce, a quella della voce successiva, che nel gennaio 1631 è affittata al cardinale già uditore di Rota Luca Antonio Virili, oppure ad entrambe. Sull’antica insula dei Planca Incoronati in via Giulia, che si presenta oggi profondamente alterata, si veda L. SPezzAferro, Il monte dei Planca Incoronati, in l. SAlerno-l. SPezzAferro-m. tAfuri, Via Giulia, cit., pp. 369-381.
262 ALOISIO ANTINORI
140. Giuseppe herede del Renzi, hab. lui nella strada de’ Capellari dove è la piazzetta 1 sc. 25141. Marchese Montorio48 nel vicolo de Corte Savella, hab. loro 3 sc. 75
Retorna al Con[ven]to di S. Agostino e nella Piazza di S. Lovige de Franzesi, viene alla Rotonda et tira nella strada dritta della Ciamella a mano dritta e manca142. S. Lovige de Franzesi49 2½ sc. 62:50143. Heredi di Francesco Contarello di d[ett]o S. Lovige 1 sc. 25144. Marchese Giustiniano50 in più lochi 3½ sc. 87:50145. Antonio Carcaraso rincontro a d[ett]o 0½ sc. 12:50146. Lovige Grippa mercante alla Dogana 0½ sc. 12:50147. SS.ri Aldobrandini51 6 sc. 150148. Rapacciolo alla Rotonda, acqua nova 0½ sc. 12:50149. Heredi di Gio. Battista Bellomo, hab. li Bolognetti 1 sc. 25150. Arcipede Galasso rincontro alla Madalena, per il lavatore 1 sc. 25[c. 53v]151. Ottavio Barrato alla Rotonda, droghiero 0¼ sc. 6:25152. Moniche de Campo Marzio per l’ostaria della Volpe 0½ sc. 12:50153. Mario Vitozzi, ostaria del Sole 0½ sc. 12:50154. Compagnia del Crocefisso, ostaria del Biscione 0½ sc. 12:50155. Marchese Giustiniano in compagnia con il Rosario, tiene l’albergatore in Capranica 1 sc. 25156. Pietro Catucci ogliararo 1 sc. 25157. Crescenzo Crescenzi52 in più lochi et il ritorno dell’acqua della piazza che va al lavatore 4 sc. 1 00
48 È il palazzo nell’attuale via di Montoro, che nella prima metà del sec. XVIII – quando i Montoro, già divenuti Montoro Chigi, si fondono prima con i Patrizi e poi con i Naro – sarà dotato, attraverso una serie di accorpamenti, di un fronte di ben 19 assi di finestre.
49 L’acquisto di una prima oncia d’acqua Vergine da parte della chiesa di San Luigi dei Francesi era stato autorizzato con chirografo di Paolo V il 3 agosto 1612 e la vendita era avvenuta, al prezzo consueto di cento scudi, in un giorno non precisato dell’ottobre seguente: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 238v-239r. Un nuovo chirografo di Gregorio XV del 3 agosto 1622 aveva autorizzato la vendita di una seconda on-cia, che era stata poi ratificata sotto Urbano VIII l’8 marzo 1624 (ivi, 2, cc. 328v-329r e ivi, 3, cc. 11r-12r).
50 Si tratta del palazzo che Giuseppe Giustiniani, dopo avervi abitato per qualche tempo, aveva acqui-stato da Pietro Vento nel 1590, quattro anni dopo che suo figlio Benedetto era stato nominato cardinale da Sisto V: I. toeScA, Note sulla storia del Palazzo Giustiniani a S. Luigi dei Francesi, «Bollettino d’Arte», XLII, 1957, pp. 296-308. Cfr. ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 28v: «Fuerunt concessae l[itte]rae patentes Ill.o et Rev.o D. Bened[ett]o Iustiniano S.R.E. Card.li, concessionis unius unciae cum dimidia aquae Virginis recipien[tis] ex aquaeductu publico fontis Plateae Rotundae ducen[tis] ad Palatium Ill. D. Petri Venti positum in Reg[ion]e S. Eustachij sub die 25 Junij 1587, quae concessio fuit facta gratis».
51 È il palazzo situato quasi davanti a San Luigi dei Francesi e risultante dall’accorpamento, realizza-to nel corso del 1605, di una casa appartenente a Olimpia Aldobrandini con edilizia adiacente apposi-tamente acquisita. Sul palazzo, che nel 1642 sarà venduto ai Patrizi: J. WASSermAn, The Palazzo Patrizi in Rome, «Journal of the Society of Architectural Historians», 27, 1968, pp. 99-114.
52 Sono tassate cumulativamente le disponibilità di acqua Vergine delle diverse proprietà immobiliari («più lochi») di Crescenzio Crescenzi nel rione Sant’Eustachio. In una delle proprietà funzionava un lavatoio pubbli-co, per il quale si utilizzava l’acqua che defluiva dalla fontana di piazza della Rotonda. Questo privilegio era stato attribuito ai Crescenzi il 20 dicembre 1580 (ASC, Camera Capitolina, cred. IV, t. 103, c. 11r): «Si concede tutta l’acqua che casca dal vaso grande della fontana della Ritonda al Sig. Cavalliere Ottaviano Crescenzi, nel modo et con quel peso però che dichiararanno li Sig. Conservadori, iuxta mentem Ill.mae Congregationis».
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 263
158. Gio. Battista Franzi saponaro, hab. lui 1 sc. 25159. Compagnia delle Stimate, hab. il ciamellaro alla Minerba et altri 1½ sc. 37:50160. PP. della Minerba53 per doi fistole 2½ sc. 62:50161. Iacomo de’ Massimi in strada che va a S. Macuto 1 sc. 25
Torna alla Rotonda162. Giulio Roco Bello, hab. Mario droghiero 0¼ sc. 6:25163. Casa acanto d[ett]a N…, hab. Ludovico droghiero del cantone, acqua nova 0¼ sc. 6:25164. Marcantonio della Porta dove hab. la condotta 1 sc. 25165. Belardino Nari, hab. il caviadenti con altri 0½ sc. 12:50166. Gio. Battista Crescenzi54 1 sc. 25[c. 58r, le cc. 54-57 sono state interposte successivamente] 167. Marchese Marchiorre55, hab. lui 1 sc. 25168. Arcolano, hab. il Caporale che vende il vino d’Orvieto 1 sc. 25169. Heredi di Giulio Trontarello rincontro al ciamellaro alla Minerba 0½ sc. 12:50170. Casa de N…, hab. Monsig. Bolgarino alla Minerba 1 sc. 25171. Heredi di Cesare Palombo ogliararo in d[ett]o loco 0½ sc. 12:50172. Coleggio de’ Neofati, hab. il pupazzaro 1 sc. 25173. Gio. Battista Crescenzi, hab. il fornaro vecino alla Rotonda 0½ sc. 12:50
Torna alla Dovana174. Cristofano e Felice Cenci, hab. Monsig. Tesauriere et altri56 1 sc. 25175. Sig. Card.le Conti57 2 sc. 50176. Belardino Nari58, hab. loro 3 sc. 75
53 Cfr. supra nel testo.54 Il riferimento a Giovanni Battista Crescenzi e la contiguità con il palazzo Melchiorri indicano in
modo certo che si tratta del palazzo Crescenzi in via della Rotonda che Giovanni Battista Mola attri-buisce al valtellinese Niccolò Sebregondi e che fu centro dell’attività del nobile artista-imprenditore: L. SPezzAferro, Giovanni Battista Crescenzi, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXX, 1984, pp. 636-641, con bibliografia precedente; id., Un imprenditore del primo Seicento: Giovanni Battista Crescenzi, «Ricerche di storia dell’arte», 26, 1985, pp. 50-74; m. PuPillo, La committenza Crescenzi e gli architetti, in Il palazzo Crescenzi alla Rotonda. Storia e restauro, a cura di L. Donadono, Roma, Gangemi, 2005, pp. 15-32; l. donAdono, La storia della costruzione, ivi, pp. 33-38.
55 Si tratta del palazzo costruito tra l’ottavo e il nono decennio del Cinquecento dalla famiglia Melchiorri, originaria di Recanati, che si era trasferita a Roma dopo la metà del XVI secolo e nel 1585 era giunta ad acquistare dagli Orsini il feudo marchionale di Torrita. Non conosciamo ancora il nome dell’architetto che progettò l’edificio.
56 Si tratta certamente dell’importante palazzo progettato da Giulio Romano tra il 1520 e il 1524 per Cristoforo Stati. Dal 1561 il palazzo apparteneva ai Cenci. Dopo l’uccisione di Francesco Cenci, la condanna a morte nel 1599 dei suoi figli Giacomo e Beatrice e il sequestro dei beni della famiglia, la vedova di Giacomo, Ludovica Velli, era riuscita a ottenere per sé e per i figli la restituzione del patri-monio. Il palazzo risulta affittato al governatore di Roma già nel 1596 e poi nuovamente nel settembre 1599, poco dopo l’epilogo della tragica vicenda. Sul palazzo si veda ch.L. frommel, Der Römische Palastbau, cit., II, pp. 322-326; id., Palazzo Stati Maccarani, in Giulio Romano, Milano, Electa, 1989, pp. 294-295.
57 Il romano Carlo Conti, già vescovo di Ancona, era stato creato cardinale da Clemente VIII il 9 giugno 1604.
58 Fabrizio Naro aveva acquistato per le sue proprietà in Campo Marzio («domum seu domunculam
264 ALOISIO ANTINORI
177. Heredi delli Maropini ataccato il Viceregente 1 sc. 25178. Heredi di Giustiniano Sevarolo in contro Conti, hab. il barbiere et altri 1 sc. 25179. Monsig. Condi rincontro la fornace de’ bichieri 0½ sc. 12:50[c. 58v]180. Moniche di S. Chiara59 per tre fistole 4 sc. 1 00181. Monsig. Ancrosilla, hab. lui 1 sc. 25182. Heredi di Monsig. Pavolini acanto d[e]tto, hab. N… mercante 1½ sc. 37:50183. Oratio Manino rincontro il Sig. Card.le Gesso 1 sc. 25184. Pietro della Valle60, hab. lui 1 sc. 25185. Marcantonio Vittorio61 et altri 4 sc. 1 00186. Heredi di Rafaello di Rossi, per il lavatore all’arco della Ciambella 0½ sc. 12:50187. Compagnia di S. Benedetto 0¼ sc. 6:25188. Giovanni Rizzi nella strada della Ciamella 1 sc. 25189. Pavolo Cordiano all’arco d[ett]o 0¼ sc. 6:25190. Heredi di Girolamo Vacca all’arco d[ett]o62, hab. Giuseppe Benci 0½ sc. 12:50191. Heredi di Rotilio Puro, hab. l’oste della Ciambella 0½ sc. 12:50192. Leon Strozzi63 0¼ sc. 6:25193. Heredi di Pavolo Alberini, hab. l’avocato Portio 1 sc. 25194. Costauti64, quale pigliano l’acqua nel d[ett]o condotto 1 sc. 25
et viridarium») mezza oncia di acqua Vergine il 24 luglio 1599: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 175r-v. Si tratta dell’edificio in piazza di Santa Maria in Campo Marzio, sul quale si veda A. An-tinori, Giovanni Antonio De Rossi in palazzo Nari. Note sul primo borrominismo, «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’architettura», N.S., 14, 1989, pp. 43-54. Un altro quarto di oncia è poi acquistato sempre da Fabrizio Naro nel 1624: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 3, cc. 24r-25r.
59 Il monastero di monache francescane che sorge sull’area delle antiche terme di Agrippa (preci-samente nel secondo isolato a sud del Pantheon) aveva goduto della protezione del cardinale Scipione Borghese, che negli anni 1627-1628 vi aveva fatto eseguire consistenti lavori di rinnovamento.
60 Il 17 settembre 1597 Valerio della Valle aveva ottenuto gratuitamente mezza oncia d’acqua Vergi-ne «ad commoditatem eius Palatij siti in reg[io]ne S. Eustachij, et in loco detto la strada Papale»: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 164r-v. Sulla storia del palazzo della Valle: ch.L. frommel, Der Römische Palastbau, cit., II, pp. 336-354.
61 Si tratta del palazzo della famiglia Vittori o Vettori in via Monterone, che passerà nel 1698 in proprietà ai Sinibaldi. Il palazzo è ricordato anche nell’elenco dei maggiori palazzi romani al tempo del pontificato Aldobrandini pubblicato in P. tomei, Un elenco dei palazzi di Roma del tempo di Clemente VIII, «Palladio», III, 1939, pp. 163-174 e pp. 219-230, in particolare p. 223.
62 È probabilmente la casa di fronte alla chiesa di Santa Maria in Monterone, che era appartenuta allo scultore e antiquario Flaminio Vacca: R. lAnciAni, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità, I-IV, Roma, Loescher, 1902-1912, III, pp. 271-272.
63 La «casa del Sig. Leone Strozzi», di fronte alla chiesa delle Stimmate nel luogo dell’attuale palazzo Besso, è citata nell’elenco dei palazzi romani del tempo di Clemente VIII in P. tomei, Un elenco dei pa-lazzi di Roma, cit., p. 173. Sulla storia dell’edificio e delle sue trasformazioni: m.b. guerrieri borSoi, Palazzo Besso, Roma, Colombo, 2000, pp. 13-54.
64 Il palazzo Costaguti in piazza Mattei era stato costruito all’inizio del secolo da Carlo Lambardi per il tesoriere della Camera apostolica Costanzo Patrizi. Subito dopo la morte di questo nel 1623, i suoi eredi avevano venduto il palazzo ad Ascanio e Prospero Costaguti, esponenti di una famiglia di banchieri genovesi trasferitasi a Roma nel tardo Cinquecento, che avevano promosso ulteriori lavori di ampliamento della residenza: l. lotti, I Costaguti e il loro palazzo di Piazza Mattei in Roma, Roma, Ars Grafica, 1961. Una mezza oncia d’acqua Vergine era stata acquistata da Ascanio Costaguti alla fine del 1624: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 337r-338v e 3, cc. 21v-22v.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 265
195. Astrubale Matei65 in d[ett]o loco per il suo palazzo 1 sc. 25196. Papilio Capizucchi alli Cesarini, hab. lui et altri 0½ sc. 12:50197. Marchese Olgiati, hab. il Sig. Card.le Spinola66 2 sc. 50
[c. 59r]Torna a cominciare alla Piazza de Matriciani, S. Agostino e segue per la Scrofa, Campo Marzo, Strada de’ Condotti, parte nel Corso et altre strade contigue sino alla botte nella piazza della Ternità de’ Monti198. Heredi di Jacomo de Ferrari67 per l’acqua del lavatore nel cortile de’ Matriciani68, tiene Diana fontaniera 3 sc. 75199. Casa de N… Gessi setarolo, hab. Gio. Maria chiavaro rincontro l’ostaria delle cinque lune 0½ sc. 12:50200. Batista Luvatelli per doi fistole, l’ostaria delle cinque lune, hab. Rugero 2 sc. 50201. Onorato Reale, hab. Cliarcho69 notaro de Rota et il colloraro 0½ sc. 12:50
65 Il palazzo di Asdrubale Mattei, marchese e poi duca di Giove, era stato realizzato su progetto di Carlo Maderno nella porzione sud-orientale della grande insula dei Mattei al rione Sant’Angelo tra il 1598 e il 1618: G. PAnofSky Sörgel, Zur Geschichte des palazzo Mattei di Giove, «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», XI (1968-69), pp. 109-188; H. hibbArd, Carlo Maderno, cit., pp. 57-60 e pp. 148-161; C. VArAgnoli, Eredità cinquecentesca e apertura al nuovo nella costruzione di palazzo Mattei di Giove a Roma, «Annali di Architettura», X-XI (1998-99), pp. 322-334. Non mi è stato possibile rintracciare la lettera patente relativa all’acquisto di acqua Vergine da parte di Asdrubale Mattei. Invece sull’acqua Felice, che il palazzo pure riceveva, si veda ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 1, s.n., 17 agosto 1622: «Ill.mo Card. Camerlengo. Essendo d’ordine nostro datovi a bocca state messe tutte a un paro le fistole nella botte novamente fatta nella piazza o cortile di Campidoglio la quale riceve l’acqua dalle fontane essistenti nel d[ett]o luoco, et per far detta botte et altri lavori essendosi fatta spesa di sc. 360 in circa, et per il pa-gamento havendoci supplicato li muratori, scarpellini et altri che hanno fatti detti lavori che non possono haver satisfatione se non si vende una quantità di detta acqua, et d’haver trovato il compratore di essa qual è il Marchese Asdrubale Matthei, però essendo quest’opra per benefitio publico vi diamo libera facoltà di poter vendere di dett’acqua quella quantità che a voi parerà necessaria per il pagamento di dette spese, purché non passi la somma di oncie doi, a favore del d[ett]o Marchese e sui heredi et succ[esso]ri e ne gli spedirete le patenti opportune ogni volta che vi costerà che nel banco del Palaggo o Falconieri nostri depositarij habbiano pagati e posti li denari che voi converrete col d[ett]o compratore».
66 Si tratta del palazzo di proprietà di Settimio Olgiati nel rione Pigna nel quale in data non certa – forse verso il 1620 – era intervenuto Carlo Maderno. Poco dopo la data del documento in esame, la residenza sarà ceduta in affitto agli Strozzi, che l’acquisteranno infine nel 1649: H. hibbArd, Carlo Maderno, cit., p. 287; m.b. guerrieri borSoi, Palazzo Besso, cit. Radicalmente ristrutturato alla fine del sec. XIX, il palazzo appartiene oggi alla Fondazione «Marco Besso» e prospetta su largo Argenti-na. Il cardinale genovese Giandomenico Spinola era stato elevato alla porpora da Urbano VIII il 19 gennaio 1626.
67 Giovanni Giacomo De Ferrari aveva acquistato un’oncia d’acqua Vergine da Alessio Boccamazza, che ne aveva appena ottenute due in dono, il 16 dicembre 1594 (atto ribadito il 24 gennaio 1595): ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 138r-v. Un’identica situazione si era verificata poi il 10 febbraio 1597 (ivi, cc. 156r-157r): il precedente 27 gennaio Boccamazza aveva ricevuto due once in concessione gratuita «in remunerationem suorum laborum offitij computistae», e di queste De Ferrari ne aveva acqui-stata una per la «sua domus posita in reg[io]ne Pontis, in angulo dictae plateae Ecclesiae S. Apollinaris iuxta bona collegij Germanici, et ad alias suas domos ibi proximas in reg[io]ne S. Eustachij» (ibidem).
68 Si dava il nome di cortile dei Matriciani a un vicolo che usciva da piazza Lombarda, nella zona tra piazza Madama e via di Sant’Agostino poi completamente alterata dall’apertura di corso Rinascimento: U. gnoli, Topografia e toponomastica di Roma medioevale e moderna, ed. Foligno, Edizioni dell’Arquata, 1984, p. 159.
69 Clearco Boschi (Clearchus Buschus) è titolare dell’Ufficio I del Tribunale della Sacra Rota dal
266 ALOISIO ANTINORI
202. Gregorio Bertolli, hab. lo spadaro all’arco della Polinara 0 ½ sc. 12:50203. Flavio Ghedetti, hab. loro et il sellaro rincontro la porticella della Polinara tra pianellari 0½ sc. 12:50204. Agnesa Drosilla, hab. Fabbio Sanità acanto d[ett]o 0½ sc. 12:50205. Compagnia di S. Antonio, hab. il pasticero del Moro alla Madalena 1 sc. 25206. Sig. Card.le Roma70 dove hab. S. [?] 2 sc. 50207. Agostino Bon Giovanni, hab. lui 1 sc. 25[c. 59v] 208. Jacomo de’ Massimi dietro a S. Salvatore delle Copelle, hab. Monsig. Monaldeschi 1 sc. 25209. Marchese Giustiniano acanto Pietro Catucci 1 sc. 25210. Francesco Pinelli, hab. Portia Pinelli dietro a S. Salvatore delle Copelle 1 sc. 25211. Cavagliere Ceruzzi [?], hab. lui nella strada dritta della Scrofa 0½ sc. 12:50212. Francesco Pegna, ostaria della Scrofa 0½ sc. 12:50213. PP. di S.to Agostino per doi fistole nel convento 2½ sc. 62:50214. Marco Casale, hab. lui 1½ sc. 37:50215. PP. di S.to Agostino, hab. il bancherotto alla Scrofa 0¼ sc. 6:25216. Antonio Grotti, hab. lui 1 sc. 25217. Francesco Franchino, hab. lui 0½ sc. 12:50218. Bastiano Vari, hab. lui 0½ sc. 12:50219. Fabritio Marchetti, hab. lui 0½ sc. 12:50220. Gaspero Scapucci71, hab. lui 2 sc. 50221. Michele magazzino alla Scrofa 0½ sc. 12:50222. Gio. Battista Guastamiglio spetiale alla Scrofa 0¼ sc. 6:25223. Frati di S.to Eusepio e Celestini al palazzo che era de’ Gaetani72 6 sc. 150[c. 60r]224. Heredi di Angelo Antonio, hab. l’auditore di Mons. Gabrielli 1 sc. 25225. Moniche di S.ta Apolonia, hab. Ascanio magazzino de vino del cantone della Scrofa 1 sc. 25
giugno 1616 al febbraio 1658: cfr. ASR, Notai del Tribunale della Sacra Rota (1568-1870). Inventario, a cura di E. Gerardi, 1980, p. 1.
70 Si tratta del cardinale milanese Giulio Roma, creato da Paolo V l’11 gennaio 1621 e titolare, all’epoca del documento in esame, della chiesa di Santa Maria sopra Minerva. La sua residenza non è identificabile con certezza.
71 È il palazzo in angolo tra via dei Pianellari e via dell’Orso, che include una ben riconoscibile torre quattrocentesca. Era stato rinnovato e ampliato all’inizio del secolo secondo un progetto che Giovanni Bat-tista Mola attribuisce nella sua guida a Giovanni Fontana. Le due once d’acqua Vergine qui registrate erano state acquistate da Francesco «Scappuccio» per la sua «domus posita in Regione Campi Martij prope Plateam nuncupatam della Scrofa» nel maggio 1601: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 182v-183r.
72 Il 20 maggio 1588 il cardinale Enrico Caetani, assurto l’anno precedente alla carica di camerlengo, aveva ricevuto in dono 3 once di acqua Vergine per il suo palazzo «in Regione Pontis»: ivi, 2, cc. 46r-v. Si tratta cer-tamente del grande palazzo, dotato di una loggia e di un giardino verso il fiume, che appartenne ai Caetani dal 1550 al 1629. Soltanto due anni prima del documento in esame l’edificio era stato acquistato dai Celestini, che vi avevano insediato un collegio, utilizzando come cappella l’attigua chiesetta di Santa Maria in Posterula. Sia il palazzo sia la chiesa furono demoliti alla fine del XIX secolo per la realizzazione dei nuovi argini del Tevere. Sul palazzo – estesamente descritto in P. tomei, Un elenco dei palazzi di Roma, cit., p. 168 – si veda g. cAetAni, Do-mus Caietana: storia documentata della Famiglia Caetani, I-III, Sancasciano, Stianti, 1927-1933, in particolare II, Il Cinquecento, p. 327. Ce ne resta anche una pianta seicentesca (fig. 3), nella quale è visibile una grande fontana di acqua Vergine al centro del giardino: ASR, Disegni e piante, coll. I, cart. 87, f. 544.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 267
226. Heredi di Alesio Boccamazzo73, hab. Gio. Pietro Valletto 0½ sc. 12:50227. Pietro Sghinardi franzese rincontro il Palazzo de Fiorenza 1½ sc. 37:50228. S. Antonio de Portoghesi74 1 sc. 25229. Doi case alla Scrofa di S. Lovige de’ Franzesi 1¼ sc. 31:25230. Compagnia de Monserrato per la casa incontro S. Lucia della Tinta 1 sc. 25231. Anibale Cardelli75, hab. lui 1½ sc. 37:50232. Heredi di Jacomo Zacchia, hab. Antonio magazzino alla Scrofa 0½ sc. 12:50233. Ostaria della Campana delle Moniche di Todi 0½ sc. 12:50 234. Urbano…, hab. Giorgio candelottaro alla Scrofa 0½ sc. 12:50235. Monsù de Morus acanto le stalle del Sig. Card.le Biscia 0¼ sc. 6:25236. Palazzo dove hab. il Sig. Card.le Biscia76 1½ sc. 37:50237. S.r Duca d’Alatri per l’ostaria del Monte de Brianza 1 sc. 25[c. 60v]238. Heredi di Mutio Velli acanto il Colleggio Clementino 1 sc. 25239. Sig. Ambasciatore de Fiorenza77 per doi fistole 4 sc. 100240. Moniche de Campo Marzo78 per il monasterio 2½ sc. 62:50
73 Alessio Boccamazza (Alexius Buccamatius), sul quale cfr. la nota 15 del testo, aveva ottenuto in concessione gratuita un’oncia d’acqua Vergine il 24 agosto [?] 1590 (ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 96v), altre due in un giorno non precisato del 1594 (ivi, 2, cc. 137r-v), e ancora altre due once il 27 gennaio 1597 (ivi, 2, cc. 155v-156r). Nel 1594 e nel 1597 aveva subito venduto una delle due once ottenute a Giovanni Giacomo De Ferrari: cfr. supra nel testo e alla nota 67 di questa appendice documentaria. Un’ulteriore quantità di acqua Vergine gli era stata concessa nel 1601, ma la c. 186 di ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, dove secondo la rubricella doveva trovarsi la relativa lettera patente, risulta asportata dal registro.
74 La chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi aveva ricevuto mezza oncia in dono da Clemente VIII in un giorno non precisato del 1604 (ivi, 2, cc. 200r-v) e un’altra mezza oncia da Gregorio XV il 1° giugno 1623 (ivi, 2, cc. 323r-v).
75 Costruita all’inizio del XVI secolo, la domus magna dei Cardelli era stata radicalmente rinnovata con lavori avviati da Francesco da Volterra tra il 1592 e il 1596 e proseguiti poi in più riprese sotto la direzione di altri architetti nel corso dei primi decenni del Seicento. L’8 agosto 1602 Alessandro Cardelli aveva ricevuto in dono da Clemente VIII due once d’acqua Vergine per il suo palazzo «prope plateam Nicosiam»: ivi, 2, c. 191v: G. ScAno, Palazzo Cardelli, «Capitolium», XXXVI, 1961, 10, pp. 22-26; C. benocci, Palazzo Cardelli, in Campo Marzio («Guide Rionali di Roma»), I-VII, Roma, Fratelli Palom-bi, 1994, V, pp. 83-88.
76 Il palazzo nel quale risiede il cardinale Lelio Biscia – il principale ispiratore della politica urbana di Paolo V, che dal 1612 l’aveva incaricato anche di sovrintendere alla gestione e alla manutenzione della rete idrica – è probabilmente il palazzo già d’Aragona e più tardi Negroni e Galitzin. A partire dalla seconda metà del Cinquecento, e anche dopo l’acquisto da parte del cardinale Scipione Gonzaga nel 1591, questa residenza era ceduta in affitto a persone di rango, e diversi cardinali vi avevano abitato: ch.L. frommel, Der Römische Palastbau, cit., I, pp. 130-131 e pp. 162-163.
77 Si tratta del palazzo di origine quattrocentesca rinnovato e abbellito da Baldovino del Monte tra il 1552 e il 1555 e poi rivendicato alla proprietà della Camera apostolica da Pio IV, che nel 1561 lo aveva infine donato ai Medici: G. AurigemmA, Palazzo Firenze in Campo Marzio, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007.
78 Il monastero di Santa Maria in Campo Marzio aveva ottenuto in dono il primo quarto di oncia di acqua Vergine il 17 novembre 1605: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 217r-v. Sull’im-portante complesso e sui ripetuti interventi architettonici di cui è oggetto nel corso della prima metà del XVII secolo, si veda f. borSi, L’antico convento di Santa Maria in Campo Marzio, in Santa Maria in Campo Marzio, Roma, Editalia, 1987, pp. 5-100; c. benocci, Campo Marzio («Guide Rionali di Roma»), I-VII, Roma, Fratelli Palombi, 1994, V, pp. 26-69.
268 ALOISIO ANTINORI
241. Parocchia di S. Benedetto alli Catinari per il lavatore del Monte d’oro 1 sc. 25242. Dionisio Sada rincontro alla leona 1 sc. 25243. Sig. Card.le Borghese79 per le stalle 4 sc. 1 00244. Sig. Principe Borghese80 in più Case e Palazzo 25 sc. 625245. Heredi di Mutio Masera nel vicolo de’ Schiavoni 1 sc. 25246. S. Jacomo de Spagnoli nel vicolo de’ Schiavoni 0½ sc. 12:50247. Boccalina alla lupa in campo marzo, hab. lei 1 sc. 25248. Francesco…, ostaria del Monte d’oro 0½ sc. 12:50249. Casa de Francesco Causei [?] dove stava l’ostaria del Monte d’oro 0½ sc. 12:50250. Heredi di Girolamo Biella in strada de’ Condotti 2 sc. 50251. Heredi di Francesco Strada81 in strada de’ Condotti 1 sc. 25252. Conte della Genga82, hab. Pietro Muti strada de’ Condotti 3 sc. 75253. Cristofono fornaro 2 sc. 50[c. 61r]254. Allaleoni, hab. loro 1 sc. 25255. Domenico Guidarello, hab. Angelo sensale de Ripa acanto lo spadaro in strada de’ Condotti 0¾ sc. 18:75256. Casa accanto il Palazzo dove hab. il Sig. Card.le Borgia di N..., hab. Fausto Verdelli 1 sc. 25257. Sig. Principe Peretti per il suo Palazzo83 12 sc. 300258. PP. di S. Lorenzo Locina 1½ sc. 37:50259. Heredi di Antonio Porzio rincontro a Zacchia 1 sc. 25260. L’ospedale di S. Rocco84 2 sc. 50
79 Un grande edificio di stalle e rimesse era stato costruito poco prima dell’anno in cui è redatto il documento in esame sul lato settentrionale di piazza Borghese, nel luogo dove sorge oggi il palazzo sede della Facoltà di Architettura «Ludovico Quaroni» dell’Università di Roma «La Sapienza».
80 Il cardinale Pietro Dezza riceve in dono per il suo palazzo in Campo Marzio – il futuro palazzo Borghese – un’oncia d’acqua Vergine il 20 agosto 1590 (oltre alle due – si specifica nella lettera patente – già concesse al precedente proprietario del palazzo Giovanni del Giglio) e una il 1° novembre 1599 (ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 93r e c. 173v). Il 21 luglio 1606 Paolo V, eletto da meno di un anno, dona ben cinque once d’acqua Vergine ai suoi fratelli Francesco e Giovanni Bat-tista per «commoditate eorum Palatij novi olim nuncupati de Dezza existen[tis] in reg[ione] Campi Martij»: ivi, 2, c. 216r.
81 Cfr. supra nel testo.82 Cfr. supra nel testo.83 Si tratta del palazzo che include l’antica residenza dei cardinali titolari di San Lorenzo in
Lucina. L’ultimo di questi ad abitarlo era stato Alessandro Damasceni Peretti di Montalto, nipote di Sisto V (1585-1590) e cardinale dal 1621 al 1624, che l’aveva scelto come residenza per sé e per suo fratello Michele, principe di Venafro. Morto il cardinale Alessandro, Urbano VIII ordina alla Camera Apostolica di vendere il palazzo a Michele Damasceni Peretti, che vi fa eseguire importanti lavori di ampliamento. È questo il momento del documento in esame. In seguito l’edificiò passerà a Costanza Pamphili moglie di Nicolò Ludovisi principe di Piombino, e poi dagli eredi di questa, nel 1690, a Marco Ottoboni duca di Fiano, il nipote di Alessandro VIII. Da quest’ultimo l’edificio prende il nome di palazzo Fiano con il quale è oggi generalmente indicato. Lo studio più consistente sulla storia del palazzo resta quello di c. d’onofrio, Palazzo Fiano-Almagià, in Via del Corso, Roma, Staderini, 1961, pp. 162-169.
84 L’Ospedale di San Rocco aveva ricevuto una prima oncia d’acqua Vergine in dono da Gregorio XIII «pro servitio et usu eiusdem hosp[ita]lis et illius pauperum infirmorum» il 27 luglio 1580 (ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 21v-22r) e una seconda oncia da Paolo V, anche questa in
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 269
261. S. Carlo al Corso85 2 sc. 50262. Moniche della Porificatione, hab. un portoghese 0½ sc. 12:50263. Lettarati86 2 sc. 50264. Marcantonio Bellone vermicellaro alla Clausura delle Moniche de S. Silvestro 0½ sc. 12:50265. Heredi di Arcangelo Mandosio 0½ sc. 12:50266. Lodovico de Quartis sopra la chiavica di Portogallo 0½ sc. 12:50267. Ambrosio Pagano, hab. lui 0½ sc. 12:50268. Domenico Bassano 0½ sc. 12:50269. Antonio Manfrone87, hab. lui 3 sc. 75[c. 61v]270. Bartolo Lambardi 0½ sc. 12:50271. Heredi di Fausto Bartoli strada fratina, hab. Bonifatio 1 sc. 25272. Caterina Boccalina88, hab. lei 3 sc. 75273. Heredi di Ugo Boncompagni, hab. l’oste del Gancero in strada fratina 0½ sc. 12:50274. Heredi di Ferdinando Rucellai per tre fistole, con il Palazzo dove hab. il Sig. Card.le Borgia89 5 sc. 1 25
dono, con chirografo del 3 agosto 1612 (ivi, 2, cc. 239v-240r, concessione formalizzata il 7 gennaio 1613).
85 La ricostruzione dell’antica chiesa dei Lombardi sul Corso era stata avviata, per iniziativa del cardinale Paolo Emilio Sfondrati e con progetto di Onorio Longhi, nel 1611, cioè subito dopo la canonizzazione di Carlo Borromeo: A. Antinori, Su Onorio Longhi (1568-1619), «Quaderni del Di-partimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico», XI (2001), 21-22, pp. 45-78, in particolare pp. 70-71; A. bortolozzi-m. olin, Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in Rom: Meisterwerke der Baukunst von der Antike bis heute. Festgabe für Elisabeth Kieven, a cura di Ch. Strunck, Petersberg, Imhof, 2007, pp. 333-338.
86 La pia istituzione detta Venerabile Società dei Fanciulli Letterati aveva ricevuto in dono da Paolo V queste due once d’acqua Vergine l’8 ottobre 1605: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 216r-217v.
87 Antonio Manfroni aveva acquistato nel 1627 per la somma di 20.500 scudi il primo nucleo del suo palazzo, situato sul Corso tra via Frattina e via Borgognona. Nel 1634 la residenza sarà ingrandita con l’acquisto e l’accorpamento della confinante casa di Caterina Boccalini (cfr. la nota seguente). Sul palazzo Manfroni: G. curcio, Microanalisi della città tra Ripetta e Trinità dei Monti: la Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, in L’angelo e la città, I-II, catalogo della mostra (Roma, settembre 1987-gennaio 1988), Roma, Fratelli Palombi, 1987, II, La città nel Settecento, pp. 233-234.
88 Cfr. la nota precedente. La casa dei Boccalini sul Corso era stata acquistata dall’architetto Gio-vanni Boccalini, originario di Carpi e padre del grande letterato Traiano, probabilmente qualche tempo prima del 1576, quando aveva ottenuto la cittadinanza romana. Il 7 gennaio 1577 Giovanni Boccalini aveva comprato per la sua nuova casa romana la prima mezza oncia di acqua Vergine: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 9r. Su Giovanni e su Traiano Boccalini si vedano le rispettive voci, en-trambe redatte da L. firPo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 11, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1969, pp. 6-8 e pp. 10-19, con amplissimi riferimenti alle fonti e alla bibliografia.
89 È il grande palazzo la cui costruzione era stata avviata da Francesco Iacobilli poco dopo la metà del XVI secolo, passato poi ai Rucellai nel 1583 e in corso di acquisizione da parte dei Caetani proprio al tempo del documento qui in esame. Sulla storia dell’importante edificio e del suo contesto urbano, si veda specialmente S. benedetti, L’architettura, in Palazzo Ruspoli, a cura di C. Pietrangeli, Roma, Editalia, 1992, pp. 139-184. Iacobilli, che era competente di ingegneria idraulica, doveva aver avuto un ruolo nella progettazione della nuova rete dell’acqua Vergine fino alla sua morte avvenuta nel 1575. Orazio Rucellai acquista la prima oncia d’acqua il 20 gennaio 1578 (ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, c. 23v), la seconda in un giorno non precisato del dicembre 1586 (ivi, 2, c. 26r), altre due il
270 ALOISIO ANTINORI
275. Girolamo Vigeveno90 al vicolo dell’ostaria della Serena 1 sc. 25276. Antonio Manfrone in strada de’ Condotti 1 sc. 25277. Tomassino Pittore, hab. lui in d[ett]a strada 0¾ sc. 18:75278. Fulvio Maffei nel Corso rincontro S. Carlo 0½ sc. 12:50279. Gio. Battista Veraldi, hab. li Cortesi rincontro a S. Carlo 1 sc. 25280. Herede di Pomponio, hab. l’oste della Serena 0½ sc. 12:50281. Girolimo Olivelli, hab. loro in d[ett]o vicolo 0½ sc. 12:50282. Heredi di Diana Mangona, hab. Antonio vende la neve nel Corso 0½ sc. 12:50283. Heredi di Gio. Mangone91, hab. loro nel vicolo della Serena 0½ sc. 12:50[c. 62r]284. Heredi di Michele Ceradino acanto il Rodiano 0½ sc. 12:50285. Gio. Battista Sella, ostaria della Fontana 1 sc. 25286. Heredi di Bartolomeo Mariotto, hab. la camera locanda all’insegna de’ tre Gigli 1 sc. 25287. Cavagliere Fabrino spigionata, acanto d[ett]o 1 sc. 25288. Frati della Ternità di Monti in strada de’ Condotti 1 sc. 25289. Jacomo Antonio Rodiani, hab. l’agente di Modana 1½ sc. 37:50290. Conte Fabritio Avogardi, hab. Andrea Labia 1½ sc. 37:50291. Heredi di Gio. Antonia de Tomasi 1 sc. 25292. Heredi di Nicolò Scaglione nella strada che da’ borgognoni va a strada fratina 0½ sc. 12:50293. Francesco Fratino, hab. Francesca spagnola, e sarto 0½ sc. 12:50294. Heredi di Mutio de Quartis acanto d[ett]o 0½ sc. 12:50295. Religgione de Malta92, hab. Madalena Gazzarri et altri 2½ sc. 62:50296. Pietro Matta eredi del Cavag.re Olivieri, hab. il medico 1 sc. 25297. Stefano de Nobali per l’eredi d’Antonio de Tonis acanto le case della Religione de Malta 1 sc. 25298. Francesco Sistolo, hab. spagnoli 2 sc. 50
13 giugno 1587 (ivi, 2, c. 35v) e infine un’ultima il 30 ottobre 1603 (ivi, 2, cc. 198r-v). Il potente car-dinale spagnolo Gaspare Borgia, elevato alla porpora da Paolo V il 17 agosto 1611 su richiesta di Filippo III, era sempre stato un attivo rappresentante degli interessi del suo sovrano presso la Santa Sede.
90 Un Giovanni Vigevano aveva acquistato un’oncia di acqua Vergine al prezzo da poco maggiorato di 50 scudi il 26 gennaio 1610, aggiungendosi agli acquirenti previsti nell’apposito chirografo papale: ivi, 2, cc. 236r-v, cfr. supra nel testo. I 50 scudi erano stati versati da Vigevano, «pro subventione fabri-carum priv[atorum] et publ[icorum] fontium Urbis, in manibus D. Flaminij Pontij Architecti presenter fabricarum deputati» (ivi, 2, c. 236r).
91 Si tratta probabilmente dei discendenti del noto architetto e scultore Giovanni Mangone, origi-nario di Caravaggio in Lombardia e molto attivo a Roma – come misuratore della Camera apostolica e collaboratore di Antonio da Sangallo il Giovane, ma anche come progettista autonomo – nel secondo quarto del XVI secolo: G. gioVAnnoni, Giovanni Mangone architetto, «Palladio», 3, 1939, pp. 97-112.
92 Antonio Bosio, grande studioso di antichità cristiane e agente della Religione Gerosolimitana a Roma aveva ereditato dallo zio Giacomo, autore di una storia dell’Ordine, una proprietà nell’isolato compreso tra via dei Condotti, via Bocca di Leone, via delle Carrozze e via Mario de’ Fiori. Antonio aveva nominato i Cavalieri di Malta suoi eredi universali, così che, alla sua morte nel 1629, il palazzo dei Bosio era divenuto la residenza del nuovo agente dell’Ordine, Carlo Aldobrandini: r.u. montini, L’Ordine di Malta in Roma. Il palazzo magistrale a via Condotti, «Capitolium», XXX, 1955, pp. 15-20. Proprio nel 1631, una lapide tuttora visibile con iscrizione in ricordo e in ringraziamento dei due Bosio è posta da Carlo Aldobrandini per desiderio dell’Ordine sul cantonale del palazzo, tra via dei Condotti e via Bocca di Leone.
L’USO PRIVATO DELL’ACQUA VERGINE 271
299. Agnelo Roscelli, hab. franzesi, in d[ett]a strada 1 sc. 25[c. 62v]300. Gismondo Attavanti, hab. lui 1 sc. 25301. Casa accanto d[ett]o N…, hab. Jacomo Fumagallo 0½ sc. 12:50302. Jacomo Magalotti, hab. lui 0½ sc. 12:50303. Dottor Pamiliano Bombello in strada fratina 0¼ sc. 6:25304. Federigo Merangoli in strada fratina 1 sc. 25305. Monsig. Monaldeschi per il Palazzo del Ambas[ciato]re di Spagna93 0½ sc. 12:50306. Vergilia del Conte per il lavatore accanto d[ett]o 2 sc. 50307. Abate Maroscelli94, hab. lui in strada de’ Condotti 0½ sc. 12:50308. Venerino Venerini, hab. il marciaro della fontanella 0¼ sc. 6:25309. Girolimo Galluzzi, hab. Chiara Stella 0¼ sc. 6:25310. Isabella figlia de Remiggio95 notaro sotto il fornaro, hab. spagnoli 0½ sc. 12:50311. Capitan Simione Asavelli in compagnia con un franzese in strada della Croce 1 sc. 25312. Lucia moglie del Remiggio notaro passato la fontanella rincontro al Baglione 1 sc. 25313. Cavaglier Baglione96 1 sc. 25314. Vincenzo Compagni, hab. Girolimo rincontro a d[ett]o 1 sc. 25315. Moniche di S. Silvestro, hab. il Capitan Aquilano 2 sc. 50316. Francesca erede di Timoteo medico, hab. spagnoli 1 sc. 25[c. 63r]317. Heredi di Gio. Maria Bonazzini97, hab. lo spetiale rincontro la Barcha 1 sc. 25318. Herede de Dom[eni]co Forapane nella d[ett]a piazza 0½ sc. 12:50
93 Il palazzo destinato a diventare la sede stabile dell’ambasciatore di Spagna, realizzato su progetto di Carlo Lambardi tra il 1592 e il 1600, era stato acquistato dal protonotario apostolico Nicolò Monal-deschi nel 1624: A. AnSelmi, Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, Roma, De Luca, 2001, in particolare pp. 37-50.
94 L’abate Giuliano Marucelli aveva ottenuto gratuitamente mezza oncia d’acqua Vergine, «ad eius favorem, et commoditatem ac commoditatem suae domus positae Romae in Reg.ne Campi Martij in via conductorum», il 24 settembre 1597: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 164v-165r. Sul palazzo Marucelli in via Condotti e sulla trasformazione che subirà all’inizio del XVIII secolo: e. ben-tiVoglio, Palazzo Marucelli a Roma. Architettura di Sebastiano Cipriani, in L’architettura da Clemente XI a Benedetto XIV: pluralità di tendenze («Studi sul Settecento romano», 5), a cura di E. Debenedetti, Roma, Multigrafica, 1989, pp. 15-32.
95 «Remiggio notaro» è certamente il notaio di Rota Remigio Mola. Nel settembre 1594 e nel gen-naio 1596 Mola aveva ottenuto per due volte da «Henricus tituli S. Pudentianae Presb[yter] Card. Ca-etanus S.R.E. Cam[erari]us, super distributione aquae virginis pro fontibus publicis ac privatis in alma urbe instituendis a S. D. N. Papa specialiter deputatus», la quantità di mezza oncia d’acqua Vergine «ad commoditatem et utilitatem suae domus positae Romae in regione Campi Martij et in via nuncupata de Condotti»: ASR, Presidenza degli Acquedotti Urbani, 2, cc. 134r-135v e c. 148v.
96 Sulla biografia del celebre pittore e storiografo d’arte si veda C. guglielmi fAldi, Giovanni Baglione, in Dizionario Biografico degli Italiani, 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1963, pp. 187-191. Alla sua casa ai Condotti si accenna in: m.g. AurigemmA, Del cavalier Baglione, «Storia dell’arte», 80, 1994, pp. 23-53.
97 Giovanni Maria Bonazzini era stato un architetto soprastante e misuratore molto presente – anche in virtù del suo legame di parentela con Flaminio Ponzio, che ne aveva sposato la sorella – nei cantieri romani del tempo di Paolo V: A. Antinori, Scipione Borghese e l’architettura, Roma, Archivio Guido Izzi, 1995, p. 75.
272 ALOISIO ANTINORI
319. Bastiano Migliani, hab. lui 1 sc. 25320. Andrea Balestrucci alla selciata 0½ sc. 12:50 _______________ once 176¼ sc. 4406:25 67½ sc. 1687:50 68¼ sc. 1706:25 97 sc. 2425 _______________ 40998 sc. 10225:00
[Seguono quattro firme di “Deputati”, poi:]Io Gio. Lorenzo Berninj Arc[hitett]o dell’acqua di vergine mano pp.aIo Gio. Pietro Moraldi Architetto Dep[uta]to mano pp.a
[Alla c. 64v:]10 Genn.o 1631Tassa per fare et accomodare li condotti dell’acqua Vergine
98 Questo totale e il relativo importo di 10.225 scudi sono quelli scritti in prima stesura sul docu-mento, e sono esatti. Per un motivo non chiaro – forse un riconteggio errato – sono però successiva-mente corretti in 410 once e 10.250 scudi. Nella trascrizione del documento non si sono riportate le somme parziali.