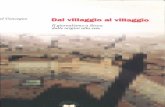CHIANTERA P (2014). Realisti, ma anche idealisti : la geopolitica e le Relazioni internazionali...
Transcript of CHIANTERA P (2014). Realisti, ma anche idealisti : la geopolitica e le Relazioni internazionali...
Il realismo politico
Figure, concetti, prospettive di ricerca
a cura di Alessandro Campi e Stefano De Luca
Rubbettino
© 2014 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - tel (0968) 6664201
www.rubbettino.it
Lo studio dell’origine del paradigma realista, che caratterizza la posizione teo-
rica della disciplina di Relazioni Internazionali, inaugurata u�cialmente con Hans
Morgenthau nel convegno di Washington del 1954 sponsorizzato dalla Rockfeller
Foundation1, non può prescindere dall’analisi di una letteratura precedente, già
classi�cata come anticipatrice dei maggiori temi che saranno oggetto del nuovo
ambito di ricerca. In particolare, come vedono fra gli altri Nicolas Guilhot e In-
derrjeet Parmar nel libro �e invention of International Relations theory, prima del
«momento fondatore» della conferenza sulla teoria delle Relazioni internazionali,
esiste una costellazione di approcci, di correnti appartenenti a varie discipline, che
insieme costituiscono lo spettro dello studio dei rapporti fra gli Stati2.
Nicolas Guilhot si so!erma sul rapporto fra le scienze sociali e le Relazioni
internazionali3 ripercorrendo la faticosa separazione della «disciplina» IR dalle
scienze sociali e l’opposizione di Hans J. Morgenthau all’assorbimento dello stu-
dio dei rapporti fra gli Stati all’interno della sociologia e delle scienze politiche.
Il campo scienti�co che riguardava le relazioni interstatali avrebbe avuto dei li-
miti abbastanza de�niti, individuati nell’approccio realista, e cioè lo studio della
«realtà e!ettuale della cosa politica» – come a!ermava Morgenthau riferendosi
chiaramente a Machiavelli – che costituiva uno degli assiomi che caratterizzavano
il nuovo campo scienti�co; nell’irriducibilità dello studio della politica fra gli stati
alla politica domestica e al paradigma behaviourista e nella considerazione dello
stato come un attore politico irriducibile ai suoi singoli componenti – che fossero
individui, gruppi o associazioni4. In tal modo, Morgenthau, ma anche William T.
1. Vedi sul tema fra gli altri il contributo di b. c. schmidt, �e Rockfeller Foundation Conference
and the long Road to a �eory of International Politics, in n. guilhot (a cura di), �e invention of
International Relations �eory, Columbia University Press, New York 2011, pp. 79-96.
2. i. parmar, American Hegemony, the Rockfeller Foundation and the rise of Academic International
Relations in the United States, ivi, pp. 182-209 e n. guilhot, �e Realist Gambit: Postwar American
Political Scince and the Birth of IR �eory, ivi, pp. 128-161.
3. Idibem e n. guilhot Introduction: One Discipline, Many Histories, ivi, pp. 1-32.
4. Vedi su questo tema l’opera fondamentale di h. j. morgenthau, Politica tra le nazioni. La lotta
per il potere e la pace, il Mulino, Bologna 1997 (ed. or. 1985).
Patricia Chiantera-Stutte
Realisti, ma anche idealisti : la geopolitica e le Relazioni internazionali prima di Morgenthau
248 patricia chiantera-stutte
R. Fox e Arnold Worfers, tutti partecipanti alla conferenza del 1954, sancivano
la �ne del progetto del Social Science Research Council del 1948 di assorbire le
Relazioni internazionali nella scienza sociale5. Il tentativo – mai coronato da un
successo de�nitivo, secondo Guilhot, Gri"ths e Guzzini6 – di delineare il campo
disciplinare delle Relazioni internazionali emergeva in contrapposizione, allora,
con la riconduzione dello studio delle relazioni di politica estera (Aussenpolitik)
nell’ambito disciplinare sociologico, orientato alla spiegazione dei fenomeni sociali,
dei comportamenti individuali o dell’opinione pubblica. Da questo punto di vista
hanno ragione Guilhot, Pichler e Scheuerman7 a sottolineare le radici tedesche
non solo delle idee di Morgenthau, ma della de�nizione, promossa da questi, di un
campo strettamente politologico di studi, riservato all’analisi degli Stati e della loro
reciproca interazione. Il realismo era, infatti, impensabile senza il riferimento alla
cultura tedesca e in particolare ad autori come Max Weber e come Carl Schmitt, che
isolavano il «politico» da altre sfere di azione umana e lo studiavano come un tema
a sé, irriducibile ad altri ambiti. Il primato della politica estera e la considerazione
dello stato come «unità» costituiscono, infatti, alcuni dei motivi principali della
ri%essione �loso�ca e storicistica tedesca già prima di Weber, e cioè con Ranke e,
ancor prima, con la letteratura romantica.
Le scienze sociali non rappresentano, tuttavia, l’unico termine di confronto da
cui emerge per contrapposizione il �lone realista delle IR. A"anco ad esse, si svi-
luppa, sempre a partire dagli anni Venti e �no agli anni Cinquanta del Novecento,
un �lone che stranamente viene spesso dimenticato e che, probabilmente, permette
di �ssare una diversa genealogia della disciplina delle Relazioni internazionali. Sto
parlando degli studi geopolitici, sviluppati a Yale, presso lo Yale Institute for Interna-
tional Studies, sotto la direzione di Nicholas Spykman, direttore dello stesso istituto
dal 1935 al 1940. Citerei anche, però, le opere di Isaiah Bowman, che non ebbe solo
incarichi accademici, ma fu un grande e in%uente organizzatore politico sia sotto
la presidenza di Wilson, sia sotto quella di Roosevelt – la sua brillante biogra�a
scritta da Neil Smith lo presenta nel titolo come il «geografo di Roosevelt»8. In�ne è
5. Nel 1948 il Social Science Research Concil organizzava un Committee on International Relations
che avrebbe mirato a rinforzare la sinergia tra lo studio delle Relazioni internazionali e i metodi delle
scienze sociali. Tale iniziativa, promossa fra gli altri da Frederick Dunn, fu abbandonata all’inizio
degli anni Cinquanta, quando emerse invece l’orientamento, da parte di un gruppo di politologi, di
ritagliare un campo disciplinare appropriato allo studio dei rapporti interstatali. Su questo sviluppo
cfr. fra gli altri n. guilhot, Introduction, op., cit.
6. Ibidem, n. griffiths, Realism, idealism and International Politics, Routledge, London 1992 e s.
guzzini Il realismo nelle Relazioni internazionali, Vita e pensiero, Milano 2008.
7. h. k. pichler !e Godfathers of Truth. Max Weber and Carl Schmitt in Morgenthau’s !eory of
Power Politics, in «Review of International Studies», 24, 1998, pp. 185-200; w. e. scheuermann, Hans
Morgenthau. Realism and Beyond, Polity Press, Cambridge 2009.
8. n. smith American Empire. Roosevbel’s Geographer and the Prelude to Globalisation, University
of California Press, Berkeley 2003.
249Realisti, ma anche idealisti
necessario includere in questa piccola lista, che non esaurisce sicuramente gli autori
che si dedicarono nel primo Dopoguerra allo studio delle Relazioni internazionali
da un punto di vista geopolitico, il grande «padre» dell’approccio anglosassone alla
geopolitica, Halford Mackinder. Questi, con il suo libro del 1919 Democratic Ideals
and Reality, dà una lettura molto più moderna e complessa dei rapporti interna-
zionali rispetto a quella più nota dello scritto del 1904 su !e geographical pivot of
History. Questi autori sono signi#cativi per tre motivi: essi non solo rappresentano
le Relazioni internazionali fra le due guerre e negli anni Quaranta, quando non è
ancora delineata una disciplina speci#ca di IR. Alcuni di essi «agiscono» nell’am-
bito delle relazioni fra stati, e cioè svolgono una funzione politica – mi riferisco
in particolare a Bowman e a Mackinder. Questi intellettuali, inoltre, in&uenzano
direttamente alcuni autori, protagonisti della «rivoluzione paradigmatica» di IR, e
cioè Edward Mead Earl, William Fox, autore di !e superpowers: !e United States,
Britain and the Soviet Union e Arnold Worfers, che continuerà a usare nei suoi studi
un approccio geogra#co e geopolitico.
La lettura delle loro opere permette di risalire la storia delle Relazio-
ni internazionali #no al punto in cui le dicotomie – per alcuni «costruite» e
«stereotipizzate»9 – proprie dell’approccio di Morgenthau si iniziano ad abbozzare,
non essendo ancora termini contrapposti ed escludenti. Mi riferisco in particolare
a due opposizioni, una metodologica e una valoriale: la prima è quella che esiste
fra l’approccio tipico del determinismo ambientale (environmental determinism
secondo Lucian M. Ashworth10) e la teoria dell’azione o della decisione11; la secon-
da separa il realismo e l’idealismo. Come vede bene Ashworth, l’opera dei primi
esperti geopolitici delle Relazioni internazionali si situa in una linea di tensione
fra questi opposti, senza però escludere nessuno dei due termini antitetici: il loro
approccio «può essere considerato come correlato al realismo classico, nel senso
speci#co secondo cui una delle maggiori caratteristiche del realismo di Carr e Herz
è la presupposizione che la buona politica internazionale è prodotto dell’equilibrio
fra il pensiero realistico e quello idealistico»12.
L’analisi di questa letteratura permette di trovare più facilmente i riferimenti
delle Relazioni internazionali sviluppati in America con le teorie dello Stato europee,
sviluppatesi prima della Grande guerra mondiale e nel periodo tra i due con&itti
mondiali, e in particolare di rintracciare i collegamenti con alcune teorie che, in
9. Cfr. m. griffiths, op. cit.
10. l. ashworth, Mapping a New World: Geography and the Interwar study of International Relations,
in «International Studies Quarterly», 57, 2013, pp. 138-149.
11. Ashworth usa il termine human voluntarism che contrappone al determinismo. In questa se-
de è preferibile invece contrapporre la teoria dell’azione o della decisione al determinismo, poiché
l’elemento soggettivo della volontà umana manca nelle teorie che vengono esaminate, o meglio, è
riconducibile non a soggetti umani dotati di volontà, bensì agli Stati, considerati come unità di analisi.
12. Ivi, p. 138.
250 patricia chiantera-stutte
Europa, già all’inizio del Novecento, costituivano dei modelli usati per spiegare le
relazioni fra stati e per prevedere gli sviluppi politici sulla base di fattori geogra�ci,
storici ed economici. Mi riferisco, in particolare, alle teoria geopolitiche di Friedrich
Ratzel e di Halford Mackinder. Quest’ultimo può essere considerato, in questo sen-
so, un autore centrale in questa ricostruzione. Egli è uno dei fondatori del nuovo
metodo geopolitico di studio delle relazioni fra gli Stati, e pertanto appartiene alla
«prima» generazione geopolitica, il cui pensiero è connotato apparentemente da
un più smaccato determinismo ambientale, e cioè dalla spiegazione delle dinami-
che politiche in base a fattori ambientali. Esemplare di questa fase deterministica
dell’approccio di Mackinder è la sua opera del 1904 sul perno geogra�co della sto-
ria13. Allo stesso tempo, egli è anche protagonista nel cambiamento metodologico
che caratterizza la letteratura di Relazioni internazionali e la visione geopolitica
nel primo dopoguerra: con Democratic Ideals and Reality del 1919 trasforma la sua
concezione geogra�camente determinista in un’idea possibilista del rapporto fra
l’ambiente geogra�co ed economico e la realtà politica14 e radica la sua interpre-
tazione delle Relazioni internazionali nel con!itto storico, mai deciso, fra idealisti
e organizzatori. Tale dicotomia, come vedremo, è facilmente traducibile in quella
fra idealisti e realisti, presente nei lavori di Bowman e di Spykman.
1. Fra il determinismo ambientale e la decisione politica
Mackinder è un autore abbastanza famoso – e ora ritornato in auge – per la
sua ricostruzione del 1904 della storia mondiale da una prospettica geopolitica:
!e geographical pivot of History. In questo intervento egli contrappone le potenze
terrestri (Landpowers) a quelle marittime (Seapowers), in una lettura che risente sia
dell’approccio neolamarckiano15, sia delle teorie tedesche sulla geogra�a politica
ratzeliana, sia, in�ne, dell’opera del generale Maham16. La maggiore preoccupa-
zione di Mackinder era l’accumulazione di potere delle prime, e cioè della zona
al cuore del continente Euroasiatico, l’area pivot: se la Russia, un vasto impero di
terre impenetrabili dalle navi – e pertanto dai Seapowers anglosassoni – avesse
13. h. j.mackinder, Il perno geogra"co della storia, in m. bertozzi et al. (a cura di) Elementi di
geopolitica, Ed. sapere, Padova 1997 (ed. or. 1904).
14. Su un approccio diverso e originariamente meno determinista della geopolitica si veda il co-
siddetto possibilismo francese, elaborato originariamente da Vidal de la Blache. Su questo tema cfr.
fra gli altri g. parker, Ratzel, the French School and the birth of alternative Geopolitics, in «Political
Geography», 19, 2000, pp. 957-969.
15. Sull’importanza del neolamarckismo cfr. fra gli altri n. j. a. Campbell, d. n. livingstone, Neo-
Lamarckism and the development of Geography in the United States and Great Britain, in «Transactions
for the Institute of British Geographers», 8, 3, 1983, pp. 267-94.
16. a.t. maham, !e in#uence of Sea Power upon History, Little Brown, Boston 1890.
251Realisti, ma anche idealisti
avuto uno sbocco sul mare, e cioè se si fosse realizzata l’alleanza fra la Germania e
la Russia, fra gli Slavi e i Teutonici, il mondo sarebbe stato in pericolo. La lotta che
contrassegnava lo sviluppo mondiale era quella della civiltà – europea, anglosas-
sone e teutonica – contro la barbarie slava, e cioè contro le orde dei predatori del
deserto. Il Novecento chiudeva la parentesi paci�ca che aveva registrato l’equilibrio
fra mondo civile e barbaro, dovuto alla conquista del potere sui mari da parte delle
potenze anglosassoni. Esso riportava l’umanità civile a uno scenario pregiudizievole
per il mondo libero: la minaccia di un «mondo-impero» dominato dalle potenze
terrestri diventava più tangibile con lo sviluppo tecnologico, e cioè con le ferrovie,
che mettevano in comunicazione le zone impervie e isolate delle aree desertiche
russe, riducendo la potenza degli imperi marittimi, che si espandevano sulle ac-
que. Lo schema mackinderiano risentiva, come si è detto, dei modelli previsionali
e storici elaborati in area anglosassone dal generale Mahan nel suo famosissimo
In�uences of Sea Power upon History del 1890, e anche dell’approccio geopolitico
sviluppato in Germania con la geogra�a politica di Friedrich Ratzel17. Ratzel, infatti,
in una sua opera meno conosciuta, aveva individuato nella conquista dei mari il
prerequisito indispensabile per la sviluppo dello Stato di potenza18.
Gli scritti di Mackinder ebbero un impatto fondamentale al di là dei circoli
scienti�ci. Il geografo inglese, infatti, deteneva una posizione di prestigio non solo
nel dibattito accademico, ma anche nella politica concreta dell’Impero Britannico,
i cui settori militari e politici avvertivano già all’inizio del Novecento la paura in-
combente della perdita del potere globale, guadagnato in modo monopolistico dal
Grande Impero Britannico19. In altre parole, Mackinder non scriveva solo in riferi-
mento al suo pubblico accademico e alla Geographical Royal Society che dirigeva,
ma interveniva attivamente nel dibattito politico, sia assumendo una posizione a
favore del partito che avrebbe potenziato la !otta, sia organizzando la sua attività
politica e, nel primo dopoguerra, presiedendo un’importante missione in Russia.
Insomma, i suoi scritti, che erano destinati a un pubblico più vasto, avevano un
intento educativo e politico più ampio di quello accademico: erano rivolti alla classe
dirigente e ai politici, mirando alla spiegazione delle dinamiche politiche reali. È forse questa una delle ragioni per cui nel dopoguerra Mackinder si «convertì» dal determinismo ambientalista a una teoria decisionale e volontaristica nella lettura dei rapporti intrastatali20.
17. Sulla geopolitica anglosassone e sulla sua relazione con la geogra�a tedesca mi permetto di rin-viare a p. chiantera-stutte, Il pensiero geopolitico. Spazio potere e imperialismo fra Otto e Novecento, Carocci, Roma 2014.18. f. ratzel, Das Meer als Quelle der Völkergrösse: eine politisch-geographische Studie, Helmot, München 1911.19. Cfr. fra gli altri r. a. bultin, "e Pivot and imperial defence policy in b. blouet (a cura di), Global
Geostrategy. Mackinder and the Defence of the West, Frank Cass, London 2005 pp. 36-54.20. Vedi g. kearns, Geography and Empire, Oxford University Press, Oxford 2009.
252 patricia chiantera-stutte
La Prima guerra mondiale e, soprattutto, il riassetto territoriale deciso «a ta-
volino» negli accordi di Parigi, condizionarono profondamente le concezioni di
Mackinder, che scrisse nel 1919 Democratic ideals and reality. In esso espressamente
ripudiava il determinismo e il darwinismo, dichiarando la sua fede nell’internazio-
nalismo e nella Lega delle Nazioni. Egli a!ermava lapidariamente che se la distribu-zione delle risorse, la posizione geogra"ca dei paesi, e cioè i «fatti della geogra"a»
rimanevano uguali, cambiava la prospettiva geogra"ca e pertanto l’interpretazione
di questi «fatti»21. In tale visione, l’uomo era tale – e la politica era tale – perché tra-
scendevano le limitazioni naturali, forzando gli assetti esistenti verso una situazione
di pace e di equilibrio, evitando il con&itto e la guerra22. Per tale ragione, Mackinder
ripudiava in parte la concezione precedentemente espressa nel 1904 sulla stretta
dipendenza della politica dalla posizione geogra"ca di una nazione: la politica
non era più una strategia da elaborare entro dei limiti stretti dati dalla natura, ma
implicava la cosciente forzatura di questi limiti per a!ermare degli ideali di libertà.
Nell’ambito della politica internazionale, l’ideale del «politico» Mackinder era,
allora, la Lega delle Nazioni: egli credeva nell’internazionalizzazione della politica
inglese e mondiale. Nello stesso tempo, però, Mackinder non poteva abbandonare
completamente la sua originaria formazione e le radici neolamarckiane della sua
idea di società: il «geografo» Mackinder, infatti, indicava chiaramente le di+coltà
di garantire, anche per un breve lasso di tempo, la pace fra le nazioni, proprio per
quella fondamentale disparità geopolitica che aveva condotto alla Prima guerra
mondiale, e cioè per la sperequazione nella posizione delle nazioni, che le rendeva
di!erenti nella distribuzione delle risorse23.
Non bastava, allora, l’esistenza di un’organizzazione internazionale per assi-
curare la pace, sia per la reale disparità degli stati nella detenzione delle risorse e
nella posizione geogra"ca, sia per lo stato di anarchia della politica internazionale.
Pertanto la vecchia politica diplomatica e l’ideale del balance of power, che erano
stati garantiti solo in parte prima della Grande guerra, non potevano essere com-
pletamente ripudiati in virtù della creazione di organismi legislativi internazionali.
Mackinder promuoveva lo sviluppo di una soluzione mista, che avrebbe coniugato la
vecchia politica di sicurezza con lo sviluppo della politica dei trattati internazionali,
e che avrebbe assicurato delle garanzie per l’e!ettiva difesa della pace. L’elemento
di novità del nuovo assetto internazionale sarebbe stato rappresentato dal ruolo di
garanzia di alcuni Stati rispetto agli altri: «Così come fra gli individui è invocato
il potere dello Stato per preservare la giustizia, allo stesso modo […] dobbiamo
riconoscere che ci debba essere un potere, o una sanzione, come dicono i giuristi,
21. h. j. mackinder, Democratic ideals and reality, Holt, New York 1919.
22. Ivi p. 5.
23. Ivi p. 5 sgg.
253Realisti, ma anche idealisti
per preservare la giustizia fra le nazioni»24. La posizione di “garanti” di alcuni attori politici – Gran Bretagna e USA – avrebbe fornito per Mackinder una continuità fra la vecchia e la nuova politica internazionale e avrebbe assicurato la giustizia fra le nazioni. Mackinder, nel solco della tradizione geopolitica, traduceva la sua idea di giustizia politica e armonia in una rappresentazione cartogra�ca della nuova Europa, caratterizzata dalla coesistenza di piccole e grandi nazioni e dall’intangi-bilità degli «stati cuscinetto» che garantivano l’inaccessibilità delle grandi potenze di terra al mare e all’espansione.
La Lega delle Nazioni non bastava da sola ad assicurare la pace, ma pote-va avviare una dinamica politica positiva a livello internazionale. La sua politica andava pertanto protetta dalla possibile prevaricazione delle potenze di terra, e cioè dalle mire espansionistiche della grande area asiatica, sede di una rivoluzione
«barbara» – e cioè dello stato bolscevico. Le potenze di mare – Gran Bretagna e
USA – erano i garanti ideali di questo equilibrio: non avrebbero mai mutato l’e-
quilibrio mondiale, sia per la loro naturale delimitazione territoriale nel mare, sia
perché erano interessate politicamente ed economicamente a preservare una situa-
zione di armonia fra grandi e piccoli Stati all’interno dell’Europa. Esse avrebbero
assicurato la difesa contro la tirannia del mondo, assicurando che la «minaccia alla
libertà del mondo» proveniente «dalla cittadella della world-island» fosse sventata25.
Così nel 1919 Mackinder sembrava suggerire, pur senza apertamente dichiararlo,
una specie di garanzia dell’ordine internazionale da parte dei sea-powers, e cioè di
quegli stati che per de�nizione avevano interesse alla stabilità e alla pluralità degli
stati nel Vecchio Continente.
Questa idea venne riecheggiata nel libro del geografo americano Isaiah
Bowman, che durante la Prima guerra mondiale aveva organizzato il primo think
tank americano (la commissione Inquiry) e che aveva partecipato alla delegazione
wilsoniana inviata per i trattati di Parigi. Nel suo famoso libro !e new world pub-
blicato a due anni di distanza da Democratic ideals and reality, Bowman difendeva
il ruolo di garante delle potenze marittime, sconfessando il suo antecedente ap-
proccio geopolitico, fortemente in!uenzato dalla lettura del geografo Ratzel e del
primo Mackinder26. Bowman, che condivideva con Mackinder sia la formazione
accademica ancorata nella geogra�a tedesca e nella geogra�a politica di Ratzel, sia
l’impegno nella Prima guerra mondiale contro le potenze mitteleuropee e la pro-
mozione dell’idealismo wilsoniano, riprendeva nella sua analisi del nuovo assetto
mondiale e della guerra i temi maggiori di Democratic ideals. Il geografo americano,
però, sottolineava aspetti diversi nella considerazione delle cause della guerra: esse
erano individuate nei con�ni non esattamente delimitati (grey zones) esistenti in
24. Ivi p. 6.
25. Ivi, p. 140.
26. Cfr. i capitoli iniziali di n. smith, op. cit.
254 patricia chiantera-stutte
Europa, nei metodi di lavoro non trasparenti della diplomazia europea e nei fattori
geogra�ci ed economici che rendevano le nazioni diseguali nella competizione.
L’oggetto della contesa fra le nazioni si spostava così dalla loro posizione geogra�ca
alle risorse economiche: questo slittamento permetteva di slegare la competizione
economica – e politica – dal territorio. Come vede bene lo storico Neil Smith nella
sua biogra�a su Bowman, �n dal libro di questi del 1921 veniva testimoniato quel
processo storico della deterritorializzazione della competizione per la ricchezza e
per il potere che avrebbe contrassegnato l’epoca contemporanea. L’egemonia ame-
ricana sul mondo – o, in termini wilsoniani, la garanzia di pace – non era veicolata
dalla politica territoriale, ma dall’espansione economica, e pertanto dal controllo
sulle risorse. Smith descrive bene come il percorso di Bowman, che passò nel corso
degli anni da un determinismo ambientalista di matrice ratzeliana all’idealismo
liberale wilsoniano proprio durante la sua missione politica a Parigi, rispecchiasse
un processo storico-politico più vasto, e cioè la riformulazione dell’egemonia glo-
bale. Bowman «andò a Parigi in cerca dell’ordine mondiale […] e tornò con una
visione del mondo»27 caratterizzata dalla convinzione che l’economia mondiale si
doveva aprire al capitalismo occidentale.
La nuova visione del mondo di Bowman poneva al centro della storia, l’uomo e
il suo agire politico. La sua concezione geopolitica ed economica può essere svelata
in una massima, espressa dal geografo americano dopo la Prima guerra mondiale,
secondo cui «anche gli spazi vuoti del mondo non sono più non-politici»28. Tale
frase poteva essere intesa nel senso della pervasività dell’azione politica umana.
Tuttavia essa celava anche un altro signi�cato: un territorio è «politicizzato» quando
appartiene a uno Stato, e cioè quando è soggetto alla sovranità di uno Stato. Da tem-
po, però, non vi erano più, come già aveva a�ermato Mackinder nel 1904, territori
da «conquistare» nell’epoca postcolombiana: il mondo era chiuso e i territori erano
stati tutti distribuiti fra le nazioni colonialiste nel 1921. La frase di Bowman andava
letta, allora, in un modo ulteriore: la politica a cui faceva riferimento Bowman
era quella dell’idealismo liberale wilsoniano, che vedeva nel mondo uno spazio
aperto ai commerci e ai tra�ci commerciali. Gli spazi vuoti non erano, in tale
chiave di lettura, spazi non-politici, ma spazi apparentemente lontani dai centri
di potere economico. Erano spazi, cioè, super�cialmente marginali, ma in realtà
interdipendenti in quello che oggi chiameremmo con il linguaggio di Wallerstein,
il «sistema-mondo»29. Quello che Bowman testimoniava in tutta la sua opera di
geografo e di consigliere politico era la dissoluzione del rapporto fra il potere po-
litico ed economico e la territorialità: un qualsiasi territorio, indipendentemente
dalla sua appartenenza politica e dalla sua marginalità nel mercato e nell’economia
27. Ivi, p. 169.
28. Two works of political geography, in «Geographical Review», 14, 1924 p. 666.
29. i. wallerstein, Alla scoperta del sistema-mondo, Manifestolibri, Roma 2010.
255Realisti, ma anche idealisti
internazionale, faceva parte – o meglio doveva far parte – di un mondo in possibile espansione globale, e cioè del mondo che oggi diremmo economicamente globa-
lizzato. Gli spazi del commercio e dell’economia erano aperti e tendenzialmente
universali, globali, al contrario degli spazi politici. L’idea di deterritorializzazione
del potere globale di Bowman non era singolare, ma costituiva un tema di ri�es-
sione comune a pensatori profondamente diversi. Anche Carl Schmitt, nello scritto
Terra e mare30 del 1942, avrebbe delineato con estremo schematismo e chiarezza
la di!erenza fra la conquista territoriale-politica e quella marittima-economica
riconducendole ai domini rispettivamente delle potenze di terra e di mare.
Insomma, Bowman ripudiava «scienti"camente» il determinismo ambientale,
abiurando la lezione determinista ratzeliana e, con esso, ri"utava politicamente
l’idea di una politica di potenza che si esplicava nella mera conquista territoriale.
La geogra"a e con essa la cartogra"a diventava un progetto di studio internazio-
nale, che mirava a individuare non solo i condizionamenti geogra"ci, ma anche
e soprattutto i �ussi economici e demogra"ci, fornendo così le coordinate allo studio delle Relazioni internazionali. La politica e la diplomazia dovevano mu-tare, di conseguenza, i loro scopi e il loro modo di agire: il loro "ne non era più l’espansione territoriale, bensì la creazione di rapporti commerciali ed economici capillari, che necessitavano del mantenimento di uno spazio economicamente aperto e disponibile31. L’a!ermazione di Wilson, secondo cui il "ne della lotta delle potenze americana e britannica nella Prima guerra mondiale era stato di «rendere il mondo un posto sicuro per le democrazie» mostrava in controluce, nell’opera di Bowman, il suo risvolto egemonico: laddove non vi era più possibilità di praticare l’espansionismo territoriale, era possibile l’espansione mondiale del free trade. Il geografo americano insisteva, infatti, sia sulla divergenza tra l’imperialismo violento e aggressivo europeo e continentale, e l’espansionismo economico positivo ameri-cano32, sia sulla funzione di garanzia dei poteri liberali marittimi – Gran Bretagna e USA. «È probabile – scriveva – che i corridoi marittimi e punti strategici distanti sul margine (rim) della civilizzazione possano essere tenuti solo se vi è una �otta potente e mobile»33. Tale �otta era stata nella Prima Guerra Mondiale e sarebbe stata in futuro quella delle potenze marittime.
Nel 1942 dopo il secondo con�itto mondiale, un altro autore, ritenuto uno dei padri fondatori delle Relazioni internazionali, Nicholas Spykman, darà il suo sostegno come Makinder e Bowman a una politica anti-isolazionista da parte dell’America riformulando le idee dei due geogra" anglosassoni. In America’s
30. c. schmitt, Terra e mare, Adelphi, Milano 2002 (ed. or. 1942).31. Su questo tema cfr. c. galli, Spazi politici, il Mulino, Bologna 2001.32. i. bowman, !e New World. Problems in Political Geography, Yonkers on Hudson, New York 1921 p. 22 sgg.33. Ivi, p. 12.
256 patricia chiantera-stutte
World Strategy34, un’opera ampiamente di!usa presso il pubblico e lodata da
Bowman35, Spykman difendeva il vecchio modello del balance of power e, insie-
me, proponeva il suo ra!orzamento con una società internazionale che potesse stabilizzare il precario equilibrio dei poteri. La realtà degli Stati era quella della lotta di potere e della politica di potenza: il nuovo ordine del dopoguerra non sa-rebbe di!erito, secondo Spykman, da quello precedente, perché gli stati avrebbero perseguito sempre un politica estera che massimizzava il loro potere. Tale potere era legato fortemente alla loro posizione geogra$ca: «L’area geogra$ca dello Sta-to – scrive Spykman – è la base territoriale da cui esso opera nel tempo di guerra e la posizione strategica che occupa durante quell’armistizio temporaneo chia-mato pace. È il fattore che è più condizionante della formulazione della politica nazionale, poiché è quello più permanente. Poiché le caratteristiche geogra$che degli Stati sono relativamente stabili e immutabili, le pretese geogra$che degli stati rimarranno le stesse per secoli, e poiché il mondo non ha ancora raggiunto quello stato felice in cui i desideri di qualcuno non contrastino con quelli degli altri, quelle pretese causeranno con*itti»36.
La realtà delle relazioni degli Stati era innervata da rapporti di forza e potere e a livello internazionale vigeva uno stato anarchico fra gli attori politici: questo stato di fatto suggeriva al politologo Spykman, come più di vent’anni prima al ge-ografo Mackinder, una certa cautela riguardo alle aspettative circa i bene$ci dell’i-stituzione delle società internazionali. L’esperienza della Seconda guerra mondiale ra!orzava questo scetticismo: Spykman ritornava a valutare il balance of power come il fondamento di qualsiasi organismo di garanzia e di qualsiasi legislazione internazionale: esso era la condizione per la sicurezza collettiva. «Un equilibrio di forze inerentemente instabile – scriveva in America’s strategy – sempre mutevole e variabile non è un modello ideale di potere per una società internazionale. Ma, se possiamo deplorare i suoi limiti, dovremmo far bene a ricordare che esso è un elemento indispensabile per un ordine internazionale basato su stati indipenden-ti. Incoraggia la cooperazione, la conciliazione, e l’implementazione della legge ed è probabilmente promotore di pace e di giustizia, più di qualsiasi altro tipo di distribuzione»37.
L’America non poteva evitare di riconoscere la preminenza del suo ruolo in un sistema globalizzato in cui il crollo del balance of power europeo avreb-be causato gravi scompensi a livello globale: il suo interesse stava, allora, nel rifiuto dell’isolazionismo per preservare la pace ed evitare effetti domino pe-
34. n. j. spykman, America’s Strategy in World Politics, Transaction, New Brunswick 2008, (ed. or. 1942).35. i. bowman, Political geography of power, in «Geographical Review», 32, 1942, p. 352.36. n. j. spykman, Geography and foreign policy, in «American Political Science Review», 32, 1938, p. 29.37. n. j. spykman, America’s Strategy, cit., p. 472.
257Realisti, ma anche idealisti
ricolosi – un interesse squisitamente politico e non economico, come nel caso dell’interpretazione di Bowman. Le riflessioni di Spykman re-introducevano la geopolitica al cuore della riflessione sulle Relazioni internazionali: il com-portamento degli stati era condizionato da fattori geografici e dalla loro posi-zione strategica; i modelli di conflitto interstatale (conflict-patterns) fornivano costellazioni ricorrenti di potere e legate ai tipi di frontiere e al loro modo di espandersi; la strategia militare, che determinava come ultima ratio i conflitti interstatali, veniva determinata dalla geopolitica.
2. Idealismo e realismo: opposti o complementari?
Al superamento dello schema geopolitico determinista, si accompagnava negli autori trattati la tematizzazione di un’opposizione politica, che sembrava essere slegata dalla dicotomia metodologica fra il determinismo e il decisionismo, ma, come vedremo, ne era invece la conseguenza. L’opposizione a cui si deve far rife-rimento è quella fra il realismo e l’idealismo, che avrà una lunga storia e successo
soprattutto nella lettura successiva a partire da Hans J. Morgenthau.
Secondo Mackinder gli stati marittimi svolgevano la funzione di garanti esterni
dell’equilibrio europeo: il loro interesse era nella preservazione dell’equilibrio eu-
ropeo. In altre parole, la loro funzione #n dal 1917 era conservativa riguardo alla
pluralità delle nazioni e all’equilibrio del potere. Dopo l’entrata degli Stati Uniti in
guerra e dopo la rivoluzione bolscevica, diventava evidente che lo scontro fra le
potenze di mare e quelle di terra avrebbe acquistato un signi#cato non solo stra-
tegico, ma anche morale: «abbiamo lottato» a$ermava Mackinder, riprendendo le
parole di Wilson «per fare del mondo un posto sicuro per le democrazie»38. La lotta
fra potenze di mare e di terra conservava nell’opera del 1919 lo stesso valore che
aveva nello scritto sul perno geogra#co del 1904: quello del con%itto per la civiltà
e per la democrazia. Se nel 1904 la guerra degli imperi di mare era considerata
nella sua accezione geopolitica e strategica, nel 1919, quando Mackinder appog-
giava apertamente l’idealismo wilsoniano, essa acquistava un valore meramente
morale e universale. Mackinder de#niva a tal proposito i due fronti principali,
che sembravano stemperare la connotazione geopolitica de#nita nel 1904: la con-
trapposizione era nel 1919 fra gli idealisti e gli organizzatori. Tuttavia, Mackinder
ricollocava poi questi due «tipi-ideali» nella sua mappa geopolitica, attingendo
dall’antica separazione fra sea-powers e land-powers. Gli idealisti, che venivano de-
#niti in età moderna come rivoluzionari, immaginativi e orientati nella loro azione
a difendere dei principi etici, erano perlopiù democratici: «la democrazia – scrive
Mackinder – ri#uta di pensare in modo strategico #n quando non vi è costretta per
38. h. j. mackinder, Democratic ideals, cit., p. 78.
258 patricia chiantera-stutte
difendersi […] il democratico pensa con i principi che siano […] ideali, pregiudizi o leggi economiche. L’organizzatore, dall’altro lato, piani�ca e deve considerare la base delle sue costruzioni e i materiali di cui sono fatte»39. Questi, infatti, era, secondo
il geografo inglese, un «manager della macchina sociale»40, e cioè un realista, che piani�cava, organizzava, classi�cava e pensava strategicamente. La dicotomia fra idealismo e realismo non riguardava solo un comportamento politico, ma era an-corata culturalmente e «collocata» geogra�camente da Mackinder nelle due nazioni che rappresentavano per antonomasia il sea-power e il land-power e che avevano combattuto �n dall’inizio del secolo per l’egemonia globale. L’Inghilterra, promo-trice del free trade e campione della democrazia, si contrapponeva alla Germania, caratterizzata dalla mentalità organizzativa e dalla difesa della Kultur, intesa come
insieme di valori etici territoriali. Il comportamento politico veniva, in tal modo,
«naturalizzato» da Mackinder: le di"erenze fra idealisti e realisti diventavano un
fatto geogra�co, culturale, geopolitico e storico. Anche se alla �ne del libro, Ma-
ckinder difendeva l’ideale di un completamento dei due aspetti – quello idealista
e quello organizzatore – la contrapposizione fra i sistemi politici, le mentalità e le
politiche economiche riprendeva, così, l’antica dicotomia fra sea- e land-power
presente nell’opera geogra�ca di Mackinder.
Se in Mackinder la bilancia non era ancora del tutto sbilanciata verso gli imperi
di mare e verso l’idealismo, proprio per il suo tentativo �nale di instaurare un’ar-
monia fra le due «culture» mondiali, in Bowman e Spykman la decisione per un
corno dell’alternativa era più netta. Per Bowman la Grande Guerra rappresentava
il momento in cui era possibile ridisegnare il «nuovo mondo» – e per ridisegnarlo
occorreva l’idealismo. La «prammatica dell’idealismo» wilsoniano penetrava pro-
fondamente nella visione politica di Bowman, che promuoveva l’internazionalismo.
Tuttavia l’internazionalismo e l’idealismo non costituivano l’unica assicurazione
della pace mondiale: il ruolo delle potenze marittime, in particolare degli Stati
Uniti, era quello di garantire l’equilibrio asiatico ed europeo. L’idea del balance of
power, della naturale limitazione dell’idealismo, che doveva essere ancorato a una
realtà di equilibrio di potenze, non veniva dimenticato dal geografo americano:
«Giacché è abitato da esseri umani imperfetti, il mondo vedrà sempre motivi per
il con(itto […] I saggi si devono adattare a questo stato di cose, ma il successo
completo non sarà mai raggiunto»41. La guerra, la politica di potenza era una realtà
dei fatti, dovuta alla di"erenza di risorse e di posizione geogra�ca. Tuttavia, con
uno slancio che trascendeva la sua coscienza scienti�ca di geografo e di osserva-
tore strategico, Bowman sceglieva l’idealismo e la fede nella futura risoluzione dei
con(itti internazionali: «Se è importante a"rontare questi fatti [la competizione fra
39. Ivi, p. 33.
40. Ivi p. 14.
41. i. bowman, !e new World, cit. p. 11.
259Realisti, ma anche idealisti
stati e la guerra], è ancora più importante che gli spiriti umani debbano rivolgersi
alla sperimentazione riguardo ai piani di cooperazione»42.
Per Spykman, che scriveva dopo il secondo tragico fallimento della politica di
accordi internazionali, il realismo era, invece, l’unico fondamento di una politica
sensata (sound policy): la realtà stava nella politica di potenza degli stati e nei loro
con"itti determinati dalla loro situazione geopolitica. Tutti, anche gli USA, erano
coinvolti nei con"itti, che ormai si sviluppavano a livello globale, con l’utilizzo
dello spazio aereo e marittimo: una politica sensata americana doveva accettare la
realtà della globalizzazione politica. L’idealismo celava, in verità, per Spykman, una
svalutazione moralistica dell’analisi e dello studio della politica e del potere. Esso
promuoveva la cecità politica sulla realtà globalizzata delle Relazioni internazionali
e insieme, l’ignoranza scienti#ca riguardo allo studio dei processi politici interna-
zionali. Il ri#uto dell’idealismo non signi#cava, in sede squisitamente politica, che
Spykman rigettasse la fondazione di una società internazionale e di una legislazione
che favorisse la collaborazione fra le nazioni. Egli piuttosto metteva in guardia
contro la semplicità di questa soluzione: qualsiasi società internazionale doveva
fondarsi sul balance of power, che a sua volta era temporaneamente mantenuto
grazie non solo alla diplomazia, ma anche all’assicurazione di equilibri geogra#ci e
geopolitici43. Non è un caso che Spykman si riferisse all’antico scritto di Mackinder
del 1904 e costruisse su di esso – e cioè su un’interpretazione geopolitica della storia
e della politica – la sua «cartina» dell’equilibrio europeo. Insomma, pur difendendo
il progetto degli «idealisti», Spykman lo radicava fortemente in una concezione
politica e geopolitica ispirata alla vecchia diplomazia europea44.
3. Conclusioni
Dopo l’affermarsi del paradigma scientifico rivoluzionario delle Relazioni
internazionali, le opere di questi autori precedenti, riconosciute generalmente
dalla letteratura del loro tempo come scritti di Relazioni internazionali, sono
state quasi dimenticate. Le ragioni di questo oblio vengono acutamente spiegate
da Ashworth nel un suo articolo del 201345. Secondo la lettura proposta in questo
intervento, questi autori non solo sono i «progenitori» attualmente dimenticati
della disciplina IR: essi costituiscono la base su cui è possibile considerare in
42. Ibidem.
43. Tuttavia Spykman non accetta incondizionatamente l’idea di balance of power: per lui esiste
una percezione soggettiva del balance of power, che deve essere tale per ogni Stato da permettergli di
pensare di essere in una posizione di limitata superiorità. Sul tema vedi r. rogowski, International
Politics: !e Past as Science, in «International Studies Quarterly», 12, 4, pp. 394-418.
44. n. j. spykman, America’s Strategy, cit., p. 128 sgg.
45. l. ashworth, op. cit.
260 patricia chiantera-stutte
modo prospettico la «rottura» metodologica di Morgenthau. In altre parole,
Morgenthau fonda la sua scienza in contrapposizione non solo con i metodi e i
presupposti delle scienze sociali, come studiano Guilhot e Waever46, ma anche
con le metodologie dello studio delle Relazioni internazionali, sviluppate e
disperse in varie correnti metodologiche. Le opere di Mackinder, di Bowman
e di Spykman, opere che risentono fortemente dell’approccio geopolitico, sono
parte integrante dell’universo in cui origina il paradigma rivoluzionario di
Morgenthau.
Inoltre le idee di Morgenthau e dei protagonisti della rivoluzione delle RI pre-
sentano delle fondamentali continuità con l’approccio di questi autori, che, pertanto,
sono metodologicamente e ideologicamente molto a�ni alla visione scienti�ca
e valoriale asserita da Morgenthau. In particolare, lo Stato è considerato da tutti
questi autori come un individuo, un’unità, le cui azioni non possono essere spie-
gate in base al comportamento degli individui che lo compongono. Vi è, insomma,
una insanabile discontinuità fra la politica estera e quella interna, fra le Relazioni
internazionali e la politica statale. Inoltre lo Stato agisce in rapporto con gli altri
Stati in un ambiente tendenzialmente anarchico: le regole, vigenti a livello della
politica domestico, non forniscono dei parametri entro i quali lo Stato si comporta
nella politica estera. La guerra è, in questo campo, l’ultima ratio, l’ultima prova di
forza: non un eccezione o un malfunzionamento delle società internazionali, ma la
realtà ultima che dà un senso a tutti i rapporti interstatali. Insomma, la possibilità
della guerra conferisce ai rapporti fra gli stati i limiti e la ragion d’essere, sia per la
paura del con�itto e il desiderio di evitarlo, sia per la minaccia costante della prova
di forza di uno stato in condizioni di anarchia internazionale. In questa situazione
la vecchia diplomazia e l’idea prudenziale di scienza, insieme con la concezione
del balance of power, non devono essere abbandonate, ma ancora invocate come
unico possibile limite alla guerra fra gli stati. Tutti questi autori, come Morgenthau,
guardano con scetticismo al ruolo della scienza per prevenire i con�itti: la teoria
delle Relazioni internazionali è in essi – e in Morgenthau47 – una prasseologia, non
una scienza astratta. Essa si pone al con�ne fra un sapere scienti�co e una guida
politica per un bravo uomo di Stato. Non è un caso che tutti gli autori a cui si è
accennato conferiscono al loro lavoro un valore educativo per i politici e – diver-
samente – per le masse.
Al di là, però, di queste analogie, che evocano un’a�nità tra le teorie geo-
politiche e l’idea politica di Morgenthau, rimane un profondo tratto comune a
queste teorie geopolitiche e all’idea di società del fondatore del realismo nelle IR.
Secondo un’ipotesi che in questa sede può solo essere accennata, la genealogia
46. n. guilhot, Introduction, op. cit. e o. waever, !e Speech Act of Realism, in n. guilhot, op. cit.,
pp. 97-127.
47. Vedi su questo punto n. guilhot, Introduction, cit., p. 22.
261Realisti, ma anche idealisti
delle concezioni di tutti questi autori sta nella loro idea del «politico» come di
una lotta fra gli uomini. La lotta per lo spazio, che contraddistingueva la conce-
zione ratzeliana, non viene sostanzialmente abbandonata né nell’interpretazione
dei tre autori considerati, né nella concezione di Morgenthau. La politica trova
per quest’ultimo il suo fondamento nel doppio impulso alla sopravvivenza e al
riconoscimento48. Mentre il primo spiega i comportamenti di difesa, il secondo
dà origine alla competizione e alla lotta. Sebbene il fondamento psicologico e
antropologico del «politico» venga trascurato nelle opere successive alla prima
guerra mondiale, in Morgenthau esso costituisce la nota sottostante della sua
concezione di politica internazionale. Come dimostrano in modo diverso Pichler,
Williams e Scheuermann49, il collegamento fra il «primo» Morgenthau, studioso
di Schmitt e della radice psicologica e �loso�ca della politica, e il «secondo» Mor-
genthau, fondatore della disciplina di Relazioni internazionali, è da ritrovare nella
sua idea, mai abbandonata, del valore fondamentale della lotta e competizione
per la spiegazione del «politico». L’immutabilità della psicologia umana, da cui
deriva la «costanza» e una certa prevedibilità del comportamento politico, non
spiega da sola, però, la storia umana: il determinismo, e cioè la ricorrenza dei
comportamenti di lotta e competizione non prevale in Morgenthau, che pro-
muove la ricerca della pace fra le nazioni50. Tuttavia, il fondamentale impulso
all’a�ermazione violenta segna una radicale separazione fra essere e dover esse-
re, fra determinismo e azione politica, fra realismo e utopia. Questo dualismo
contrassegna la lettura politica di Morgenthau, che, come gli autori «geopolitici»
trattati, pur di�dando di qualsiasi soluzione de�nitiva alle questioni della guerra,
e ostentando il suo scetticismo nei confronti del potere del diritto internazionale
di paci�care gli Stati, cerca comunque rimedi contingenti e a lungo periodo alla
questione dello sviluppo armonico della comunità internazionale.
Si potrebbe ipotizzare, allora, che il punto di incontro fra Mackinder, Bowman,
Spykman e Morgenthau sia nella loro comune eredità culturale, e cioè nel condi-
videre una concezione darwinista antropologica, che determina in parte il loro
approccio. Tuttavia la rivoluzione realista non si pone solo in continuità con le
teorie della geopolitica. Essa esaspera quelle dicotomie presenti ma non risolte
nel pensiero di questi autori fra realismo e idealismo e fra determinismo e teoria
decisionale dell’azione: essa isola uno dei corni delle opposizioni e concentra la sua
interpretazione sull’opposizione con l’altro termine. In tal modo la teoria realista
riprende e rielabora antiche temi, propri della letteratura europea e in particola-
48. h. j. morgenthau, L’origine del politico, in id., Il concetto del politico, a cura di A. Campi e L.
Cimmino, Rubettino, Soveria Mannelli 2009 (ed. or. 1930).
49. pichler, op. cit., scheuerman, op. cit., m.c. williams, !e realist Tradition and the Limits of
International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
50. h. j. morgenthau, L’origine del politico, cit.
262 patricia chiantera-stutte
re tedesca, facendoli interagire con i temi e i metodi della letteratura scienti�ca
americana. La s�da di Morgenthau di fondare una scienza delle RI assorbendo e
rielaborando i temi della letteratura europea e tedesca è stata, per alcuni, infrut-
tuosa. Tuttavia la storia dello sviluppo delle Relazioni internazionali mostra un
esempio signi�cativo del passaggio e del confronto di temi e di metodi accademici
dal vecchio al nuovo mondo.