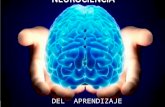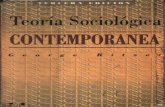Elementi per una teoria della democraticità delle organizzazioni internazionali
Transcript of Elementi per una teoria della democraticità delle organizzazioni internazionali
ELEMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UNA TEORIA DELLADEMOCRATICITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Susanna Cafaro
Sommari o: 1. Introduzione; 2. Lo stato dell’arte; 3. Ladomanda crescente di democrazia; 4. Elementi per lacostruzione di una teoria: a) la nozione dilegittimazione, b) la nozione di accountability; c) lanozione di inclusività; d) Dalla scomposizione allaricomposizione; 5. Un ingrediente essenziale: lasopranazionalità
1. Le organizzazioni internazionali sono oggicomunemente considerate come i tassellifondamentali di un sistema- per quanto parzialee imperfetto- di global governance1. In assenzadi un global “government” in grado difronteggiare sfide di portata planetaria qualiil mantenimento della pace, il global warming, lastabilità finanziaria, il controllo di armi didistruzione di massa (solo per fare alcuniesempi) o la gestione di beni pubblici globali2,
1 Si tratta di una formula in uso soprattutto tra glistudiosi di relazioni internazionali. Sulle definizioni e idifferenti fondamenti teorici posti dalle diverse scuole dipensiero a monte di tale assetto istituzionale si rinvia aM. P. KARNS, K.A. MINGST, International Organizations. The Politics andProcesses of Global Governance, Boulder, 2010, p.3 e ss.2 Ovvero "Issues that are broadly conceived as important tothe international community, that for the most part cannotor will not be adequately addressed by individual countriesacting alone and that are defined through a broadinternational consensus or a legitimate process of
1
la comunità internazionale ha creato -dalsecondo dopoguerra in poi- una serie di enti eistituzioni funzionalmente preposti alperseguimento di specifici obiettivi, dotati distrumenti e di poteri più o meno incisivi. Afronte di una rapida accelerazione dei processidi globalizzazione, tuttavia, questeorganizzazioni evolvono lentamente, lasciandouna serie di domande ancora senza risposta3. Ladomanda di cui si cercherà di dar conto inquesto contributo attiene alla lorodemocraticità.Numerosi autori hanno evidenziato la tensionecrescente e irrisolvibile tra sovranità statale,progressiva globalizzazione dell’economia egaranzie democratiche ed il rischio che a farele spese di tale inconciliabilità possano essereproprio queste ultime.4 Le difficoltà insite nel
decision-making", come definiti a p. 13 del Final Reportdella International Task Force on Global Public Goodscreata nel 2003 da un accordo tra Francia e Sveziael, del2006 reperibile sul sito http://www.sweden.gov.3 Per una sintesi delle “questioni irrisolte” si rinviaall’efficace sistematizzazione operata da T. G. WEISS, R.THAKUR Global Governance and the UN, Bloomington, 2010, p. 7 ess. Gli autori identificano cinque tipologie di “gaps” inglobal governance: i) knowledge gaps; ii) normative gaps;iii) policy gaps; iv) institutional gaps; v) compliancegaps.4 Da ultimo, si veda D. RODRIK, in The Globalization Paradox, NewYork, 2011. L’Autore fonda la propria analisisull’impossibile coesistenza di democrazia, sovranitànazionale e globalizzazione economica. La scelta - lasciataagli Stati - consente di perseguire a suo avviso dueobiettivi su tre. A nostro avviso la soluzione possibile eauspicabile è nella riduzione di sovranità elaborando nuoveformule per salvaguardare la democrazia, come si dirà.
2
trasferimento a livello globale di quei dirittidemocratici oggetto di compressione a livellostatuale sono purtroppo evidenti. Pur senza ambire a quadrare il cerchio dellademocrazia globale riteniamo che il tema dellademocraticità possa essere affrontato conqualche risultato utile nei sub-ordinamentirappresentati dalle organizzazioniinternazionali (OI).La premessa logica da cui muovere è l’assenza diun impianto concettuale condiviso in dottrinache permetta di valutare la democraticità di OI5.La difficoltà parte proprio dalle definizioni:cosa significa democratico e quando una OI puòdefinirsi democratica? Un limite evidente è nell’impossibilità diapplicare sic et simpliciter un modello didemocraticità concepito a partire dal XVIIIsecolo per lo Stato, così come di traslare ilmodello rappresentato dall’Unione europea,formula sui generis che potrebbe trovareapplicazione al più nelle organizzazioniregionali di integrazione, assunto tuttaviasmentito in “climi culturali” differenti daquello europeo6.
5 Non si vuole qui negare l’esistenza di importanti studi inquesto senso, ma solo l’inadeguata diffusione esedimentazione di valutazioni condivise in dottrina, pur afronte di tentativi isolati (e perciò ancor più meritori)di sistematizzazione. Si segnala in proposito il bel volumedi A. KUPER Democracy Beyond Borders, Oxford, 2004, e lavalutazione critica in esso operata sulle teorie espresseda J. RAWLS. The Law of Peoples, Cambridge, 1999. Entrambi gliautori si collocano in un filone che vede le sue origininel pensiero di I. KANT, vedi infra, par. 2 e nota 15.
3
Tuttavia, quella che qui si propone non è unaformula per la democrazia globale - che appareallo stato ancora irrealistica - quanto unapproccio metodologico che consenta diintrodurre tanto alcuni parametri di valutazionedella democraticità delle organizzazioniinternazionali, quanto di studiare possibiliriforme in linea con le aspettative didemocraticità di un’embrionale società civileglobale.Sarà a questo punto ben chiaro che l’assunto dacui si parte è l’accettazionedell’irreversibilità dei processi diglobalizzazione in atto nonché la necessità cheessi siano completati da istituzioni checombinino in misura crescente efficacia elegittimità. La difesa della democrazia trova autorevolipaladini anche nel differente campo di quantivogliono restaurare la centralità dello statoquale unico possibile garante dei diritti deicittadini, una posizione altrettanto legittimama a nostro avviso (paradossalmente) oggi benpiù utopistica7.
6 Si veda in proposito P. PENNETTA in Il regionalismo multipolareasiatico, Torino, 2003. 7 D. RODRIK, in op.cit., fonda la propria analisisull’impossibile coesistenza di democrazia, sovranitànazionale e globalizzazione economica. La scelta - lasciataagli Stati - consente di perseguire a suo avviso dueobiettivi su tre. A nostro avviso la soluzione possibile eauspicabile è nella ulteriore erosione della sovranità cheproceda di pari passo con l’elaborazione di nuove formuleper salvaguardare la democrazia, come si dirà.
4
Come si tenterà di dimostrare, tuttavia, il piùgrave vulnus alla democraticità rimanel’intergovernatività strettamente intesa, vale adire il tradizionale rapportarsi degli statialla organizzazione internazionale per il solotramite del proprio apparato di governo –assunto ben radicato nel diritto internazionaleclassico – che sottende l’incapacità degliStati non democratici8 di farsi portavoce diinteressi e istanze dei propri cittadini. Ildiritto internazionale preferisce ignorare ildato per il quale il difetto di legittimazionedello Stato si riverbera sulle posizioni cheesso esprime e sugli organismi a cui partecipa.Si tratta di un problema considerato a lungoinsolubile in sede di diritto delleorganizzazioni internazionali, salvo il caso incui un’organizzazione richieda ai suoi membri,come fa l’Unione europea, il requisito dellademocraticità. È evidente come, nelleorganizzazioni a vocazione universale talelimite non sia superabile per mezzo di requisitidi ammissione.9 8 O meglio di Paesi con un basso tasso di democrazia Siritiene che la democrazia sia in sé nozione imperfetta e sipossa più correttamente parlare di livello più o menoelevato di democrazia, il Democracy index calcolatoannualmente dal settimanale The Economist, per esempio,distingue tra democrazie complete, imperfette, regimiibridi e regimi autoritari, sulla base di punteggi minimi emassimi all’interno di ciascuna categoria. Le democraziecomplete risultano essere solo 26 su 167 Paesi presi inconsiderazione. Il Global democracy ranking invece, divide iPaesi del mondo in 5 fasce sulla base della qualità dellerispettive democrazie.9 Sul conflitto irriducibile tra democrazia eglobalizzazione e la sua non superabilità attraverso unariforma in senso democratico delle Nazioni Unite si rinviaa A. BALDASSARRE Globalizzazione contro democrazia, Bari, 2002.
5
Come vedremo, non è impossibile l’introduzionedi elementi di democraticità nell’OI che - senon si pone quale soluzione a tale vulnus- neattenua, in qualche modo, la sostanzialegravità.Ne consegue che uno studio sulla democraticitàdelle organizzazioni internazionali non può cheessere de iure condendo, ovvero, lungi dal volersistematizzare e definire una realtà statica,deve cogliere delle possibili linee di tendenzadella società verso modelli più democratici esupportare l’elaborazione di formuleistituzionali che meglio rispondano alleesigenze che in essa si esprimono.
2. Alcune premesse logiche perché si possanodefinire come democratici dei contesti normativiinternazionali sono senza dubbio condivise indottrina e sono riconducibili al parametro delrispetto della rule of law. Le organizzazioni internazionali sono chiamate arispondere a questo parametro di legittimitàtanto da una prospettiva esterna dunque deldiritto internazionale generale quanto interna,intesa come osservanza, nel loro agire, deirispettivi trattati istitutivi.10
Le OI, nel loro essere anzitutto un insieme diorgani, procedure, regole condivise, sono ilrisultato più riuscito di quella
10 “the focus of legal minds has rather been on the rule oflaw” A. VON BOGDANDY, The European Lesson for International Democracy:The Significance of Articles 9-12 EU Treaty for International Organizations,European Journal of International Law, vol. 23, no. 2, 2012, p. 318.
6
giuridicizzazione delle relazioni internazionali- in ambiti circoscritti, siano essi geograficio settoriali- che è stata senza dubbio unpassaggio fondamentale nella costruzione apartire dal secondo dopoguerra dell’ordineglobale che oggi conosciamo. Proprio questagiuridicizzazione è pietra angolare a partiredalla quale è oggi possibile l’esistenza didefinizioni e modelli condivisi in dottrina. Nescaturiscono due elementi tipici del dirittodelle organizzazioni internazionali: la rinunciadei consociati a farsi giustizia da sé el’accettazione di norme comuni, siano esseobiettivi, regole di condotta, procedure eassetti organizzativi. Quanto al primo, troviamoun efficace esempio nell’art. 2 della Cartadelle Nazioni Unite, ma anche nel proliferare dicorti internazionali, in molti casi inconnessione con organizzazioni internazionali oancora nella previsione di procedureprestabilite per la soluzione in via diplomaticadi eventuali conflitti.Quanto al secondo elemento, ogni statuto, cartao trattato istitutivo di organizzazioniinternazionali attesta l’esistenza di normeappartenenti a tutte le categorie menzionate.Questo tuttavia vale per le forme associativefondate sull’hard law e appare in forma attenuatain quelle di soft law. La ripartizione nelle duecategorie non appare sempre così netta e latransizione da un modello all’altro è possibile.La democraticità di una OI non è peròriconducibile sic et simpliciter al rispetto della ruleof law, sia perché questa legittima anche le
7
organizzazioni intergovernative edificate sulrapporto di forza o di potere esistente tra iconsociati11 sia perché essa non contempla ilrapporto che può esservi (o non esservi) tral’OI e gli individui. Occorrono dunque, acompletamento di questa legittimazione di naturaformale, degli elementi di democraticitàsostanziale, come appare evidente dallacrescente attenzione prestata in dottrina allostudio dei valori condivisi atti a formarne ilsubstrato, proprio per evitare che la crescentenormatività degli organismi internazionalifinisca per essere null’altro che un paraventoalla loro sostanziale non democraticità.
Importanti scuole di pensiero affrontano daangolazioni diverse tali temi: si vedano iparadigmi dello statismo o del cosmopolitismo12,ma anche della democrazia transnazionale13, di
11 Si veda, a titolo di esempio, la Comunità di Statiindipendenti (CSI) che riunisce, insieme alla FederazioneRussa Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kirghizistan,Kazakistan, Moldavia Tagikistan e Uzbekistan, nonché ilTurkmenistan in veste di associato. Le burrascose vicendedella CSI, con la fuoriuscita di Georgia e Ucraina che viavevano inizialmente aderito sono dovute al rapporto diforza all’interno dell’organizzazione, nettamentesbilanciato a vantaggio della Russia che esercita un ruoloevidentemente egemone.12 Si vedano sul tema i numerosi scritti di D. ARCHIBUGI, daultimo Cosmopolitan Democracy: a Restatement in Cambridge Journal ofEducation, vol. 42, no. 1, March 2012, pp. 9-20.13 Per un quadro sintetico ma esaustivo dei paradigmiproposti per una nozione di democrazia globale ointernazionale (la scelta dei termini non è irrilevante) sirinvia a I.A. SCHOLTE, Reinventing Global Democracy, in EuropeanJournal of International Relations, May 29, 2012. Sul tema si veda
8
rado però tali studi che si focalizzano sulpiano filosofico e politologico si traducono inpercorsi di analisi e revisione dell’esistente14.La filosofia e la teoria generale del diritto,d’altronde, si sono da lungo tempo interrogatesulla struttura ideale della società globale,quella in grado di consentire all’essere umanodi superare guerre e divisioni. L’idea di ungoverno globale democratico, fondato su unassetto federale, fa la sua comparsa nel volume“La pace perpetua” di Immanuel Kant (1795)15 eriaffiora più volte nel corso del XIX secolotanto nella storia del pensiero16 quanto neimovimenti d’opinione17, non mancherà d’altrondedi ispirare prima l’istituzione della Societàdelle Nazioni, poi la stessa Carta ONU e piùrecentemente la Corte penale internazionale.Non mancano però, anche nel campo piùstrettamente giuridico e calate nella
anche S. MARKS, Democracy and International Governance in TheLegitimacy of International Organizations, a cura di J. M. COICAUD V.HEISKANEN, Tokyo; New York; Paris 2001, p. 52 e ss.14 Anche se vi sono autorevoli eccezioni, si veda J. HABERMASThe Crisis of European Union. A Response, Cambridge, Oxford, Boston,2012.15 E prima ancora nel saggio del 1784 Idea per una storia universalein un intento cosmopolitico, la cui quinta tesi recita. “Per ilgenere umano il problema più grande alla cui soluzione lanatura lo costringe è il conseguimento di una societàcivile che amministri universalmente il diritto.”16 Ci limitiamo a citare, tra i filosofi, Karl-Heinz Krauseall’inizio del XIX secolo e Bertrand Russell nel XX, maanche illustri pensatori come Albert Einstein, WinstonChurchill, Mahatma Gandhi.17 Il World Federalist Movement si è ufficialmentecostituito nel 1947, ma una “Campaign for World Government” erain atto già tra le due guerre.
9
contemporaneità, scuole di pensiero che siinterrogano su un tema così cruciale. Traqueste, merita di essere menzionata per prima lacorrente di pensiero nota come globalconstitutionalism, che identifica principi e valoricostituzionali nell’ambito del dirittointernazionale sia per interpretare con illinguaggio del diritto costituzionale le lineedi tendenza presenti nella comunitàinternazionale, che per ravvisare i deficit deldiritto internazionale, che – infine - persuggerirne i rimedi, a partire dal deficit dilegittimazione.18 Sulla stessa scia, sebbene con diversaprospettiva, si muove il global administrative law, cheosserva le istituzioni internazionali comeentità regolatorie soggette ad un emergentediritto amministrativo globale, ravvisando lanecessità che ad esse si applichino gli stessiprincipi di trasparenza, partecipazione esoprattutto responsabilità che operano nelle piùmoderne amministrazioni.19
18 Sul tema è esemplare l’articolo di A. PETERS The Merits ofGlobal Constitutionalism, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 16n.2 (summer 2009), pp. 397-436. Come bene spiega M.KOSKENNIEMI, l’impiego del linguaggio costituzionale, con lasua pregnanza concettuale (auto-determinazione, dirittifondamentali, divisione dei poteri, responsabilità),consente di evidenziare i limiti dell’esistente, che unanodino linguaggio tecnico potrebbe pragmaticamente (orealisticamente) far passare per immodificabile ordinariaamministrazione: Constitutionalism as a Mindset: Reflections on KantianThemes About International Law and Globalization, in Theoretical Inquiries inLaw. Vol. 8, Issue 1, pp. 9–36 19 Si vedano, a titolo di esempio, B. KINGSBURY, N. KRISCH, R.B. STEWART, ‘The Emergence of Global Administrative Law’, 68:3-4 Law &Contemporary Problems (2005), pp. 15-61.
10
Inutile dire quanto sia controversa in dottrinala stessa esistenza di questi valori democraticinel tessuto connettivo del dirittointernazionale. Proprio l’assenza di unalegittimità democratica propria degli entiinternazionali è il tallone d’Achille delcostituzionalismo internazionale, la lacunaevidenziata tanto da chi propone talecostruzione concettuale quanto da chi necontesta la validità.20 Allargando il quadro al diritto delleorganizzazioni internazionali, si vede che iltema del deficit democratico affiora in saggi emanuali ed è oggetto di differentisistematizzazioni in dottrina, a seconda chel’attenzione si appunti sull’assenza dilegittimazione paragonabile a quella elettiva afronte di processi di natura quasi-legislativa osull’assenza di efficaci meccanismi di checks andbalances o ancora sulla mancata garanzia di
20 C. TOMUSCHAT, campione del costituzionalismointernazionale, ne ha chiarito in più sedi tale limite pursenza ritenere che esso menomi l’intero impiantoconcettuale. In realtà, l’assenza di una legittimitàdemocratica originantesi in un popolo è un ostacolotemporaneo poiché è ben possibile che vi sia un’evoluzionedell’umanità nella percezione di sé come popolo globale.Non così lontane le tesi di J. HABERMAS che immagina comepossibile una comunità internazionale decentralizzata,ovvero transnazionale, agglomerata attorno ad attoriglobali competenti per singole esigenze, tesi non lontanada quella sostenuta in questo scritto. Le posizioni indiscorso sono efficacemente ricapitolate da A. VON BOGDANDYne Il costituzionalismo nel diritto internazionale: commento su una propostadalla Germania, pubblicato in traduzione in Popoli e civiltà. Per unastoria e filosofia del diritto internazionale, a cura di G. Gozzi e G.Bongiovanni, Bologna, 2006, pp.183-215
11
diritti fondamentali21. Tutti e tre gli approccisono validi giacché osservano da differentiangolazioni lo stesso fenomeno: unainsufficiente democraticità; tutti sonocomplementari nell’offrire delle soluzioni.Quel che li accomuna è la prospettiva dialetticache si muove tra democraticità e tecnocraticitàpiù o meno elitaria che caratterizzal’organizzazione internazionale ben diversadalla tensione tra forme di governo democratichepiuttosto che autoritarie esistente a livellostatuale.
3. La domanda di democraticità si èprogressivamente accresciuta sino a culminare -soprattutto per le organizzazioni che svolgonoruoli di politica economica (IFI, Unioneeuropea)22- in conseguenza della crisifinanziaria, che ha messo in luce un fenomenogià noto: la capacità di erosione dellasovranità statale in settori chiave del rapportostato- cittadini quali i sistemi di welfare o imercati del lavoro, nei quali la necessità discelte percepite come democratiche -ovvero
21 Ben sistematizzate e ricapitolate da J. E. ALVAREZ inInternational Organizations as Law-makers, Oxford, 2005, pp.630-633.22 Come specificato anche da J.S. BARKIN, l’assenza dirappresentatività dei cittadini nei processi decisionalidelle OI è percepito come un reale problema in alcuneistituzioni internazionali economiche come il WTO, il FMI ela Banca mondiale, l’Autore aggiunge che “Oddly enough, it seemsto be less of a problem with international security institutions such as theSecurity Council, perhaps because of a stronger assumptions that issues as warand peace will be discussed among states more than among populations”.Così in International Organizations. Theories andInstitutions, London NewYork, 2006, p.141.
12
legittime, ma anche controllabili e censurabili-è cruciale23.Questa domanda di democraticità è in realtà piùrisalente, ed è diventata plasticamente visibilea partire dal XXI secolo con la creazione delWorld social forum nato nel 2001 a Porto Alegre;essa succede ai movimenti no global che hannodominato la scena negli anni Novanta.Progressivamente le occasioni di dialogo si sonomoltiplicate e sono oggi divenute un fenomenonormale, il riferimento è tanto agli incontriinternazionali a latere di importanti assiseinternazionali - come i civil society policy forums cheaccompagnano dal 2008 gli annual e spring meetingdel FMI e della Banca mondiale o il Civil 20 chedal 2010 è il momento di incontro tra G20 esocietà civile – quanto alla crescitaesponenziale del numero di organizzazioni nongovernative (ONG) che partecipano a meccanismidi interazione più risalenti, come le proceduredi consultazione con il Consiglio economico esociale delle Nazioni Unite previsto dall’art.71della Carta ONU24. Alcune organizzazioni23 Si vedano il dibattito in Europa sulla gestione dellacrisi finanziaria ed i contributi di dottrina sullacompressione dei diritti fondamentali e sociali in alcunistati beneficiari di programmi d’aiuto, in particolare laGrecia, si veda anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 13marzo 2014 relativa all'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE,Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto diprogrammi (2013/2277(INI)).24 Il meccanismo di consultazione è regolato dallarisoluzione 1996/31 ECOSOC. Il Consiglio economico esociale è l’unico organo delle Nazioni Unite per il quale èprevista una procedura formale di interazione con lasocietà civile, se nel 1946 le ONG che partecipavano aquesto meccanismo erano 41, nel 1992 erano diventate più di700 e nel 2011 più di 3400 (fonte: Working with the ECOSOC. An
13
internazionali hanno colto meglio di altre lepossibilità offerte dalla disponibilità allacollaborazione delle ONG, giungendo a delegaread esse compiti di attuazione sul campo delleproprie scelte, ad esempio in settori importantiquali la cooperazione allo sviluppo.25
Per rispondere a tali esigenze di interazionesono state introdotte in molte OI guidelinesspecifiche che regolamentano il dialogo con lasocietà civile26. Nei momenti aggregativi summenzionati appareevidente una domanda di partecipazione dellasocietà civile ai meccanismi di governosovranazionali e transnazionali, come pure unavolontà di contribuire all’elaborazione “dalbasso” di formule di partecipazione27 offrendovisioni e modelli alternativi di sviluppo. Ovviamente, il rapporto tra organizzazioniinternazionali e società civile non esaurisce ilrapporto tra OI e amministrati, ne si può inalcun modo ritenere la società civilelegittimata a fungere da portavoce o interpretedi un demos globale, la cui stessa esistenza èquanto mai controversa in dottrina28.NGO guide to Consultative Status, United Nations, New York, 2011)25 M. P. KARNS, K.A. MINGST, International Organizations.. op. cit, p.219e ss. Tanto l’Unione europea che la Banca mondiale operanoin stretto contatto con la società civile in questo campo.26 Si vedano, ad esempio, le Guidelines adottate dal WTO,WT/L/162 il 23 luglio 1996. Nel Fondo monetario, una Guidefor Staff Relations with Civil Society Organizations fu distribuita allostaff dal Direttore generale nel 2003, reperibile on-lineall’indirizzohttp://www.imf.org/external/np/cso/eng/2003/101003.htm27 Una posizione condivisa da M. ENGLER, How to Rule the World. TheComing Battle Over the Global Economy, New York, 2008, p.221 e ss.28 Interessante, a questo proposito, la teorizzazione di una“demoicracy” operata da K. NIKOLAIDIS con riferimentosoprattutto al contesto dell’Unione, ovvero la coesistenza
14
A spiegare la difficoltà di arrivare ad unavisione univoca al riguardo intervengonocertamente una serie di difficoltà oggettive nelrapporto tra organizzazioni internazionali eamministrati, siano esse di ordine giuridico,come la dubbia soggettività di dirittointernazionale degli individui, o semplicementefattuale, come le distanze, le profondediversità culturali e linguistiche. Tuttavia,non si può negare una rapida evoluzione in attonel tessuto sociale che porta di anno in anno unnumero crescente di cittadini ad interessarsi aquanto avviene al di fuori e al di sopra dellapropria sfera nazionale, da veri “cittadini delmondo”. Internet ed i social network hanno dato perla prima volta voce e strumenti a questoembrionale demos globale, che discute, siconfronta, cerca risposte e propone soluzioni29.Questa è la ragione per la quale, in unaglobalizzazione per molti aspetti “liquida”,30 èimpossibile trarre conclusioni definitiveriguardo all’esistenza o meno di un popolo
di più demoi di riferimento, che possono essere descritticome network transnazionali in cui il dibattito democraticonon sia mediato dal livello statale o nazionale. Talericostruzione enfatizza la dimensione orizzontale tracittadini, organizzazioni e istituzioni provenienti dadifferenti contesti nazionali e accomunati da interessicondivisi. Si veda “The Idea of European Demoicracy” inPhilosophical Foundations of European Union Law, J. DICKSON PELEFTHERIADIS, eds, Oxford, 2012.29 Impossibile non citare il sito Avaaz(http://www.avaaz.org/) con decine di milioni di membri,che apre alla sottoscrizione petizioni di interessepubblico globale con un indubbio impatto politico suglistati che ne sono destinatari. Analoga funzione riveste lapiattaforma per le petizioni www.change.org. 30 .L’aggettivo è preso in prestito da Zygmunt Bauman, chelega la sua nota metafora della “modernità liquida” allaglobalizzazione insieme ad altre concause.
15
globale, che probabilmente non esiste ancora mache vive - come insieme di popoli nazionali –una crescente consapevolezza della propriadimensione globale31.Si può certamente condividere la posizione diimportanti studiosi che, con riferimento acontesti più limitati come l’Unione europea,ritengono che il consolidarsi della dimensionecollettiva di popolo sia un passaggioineludibile per l’evoluzione verso forme didemocrazia mature32, uno stadio che – conriguardo alla dimensione globale – può esseresolo intravisto all’orizzonte ma che rileva nelsuo farsi, come elemento essenziale delprocesso. E’ questo un punto su cui si tornerà.
4. Gli elementi proposti per la costruzione diun paradigma della democraticità delle OI sonotipici del modello democratico: legittimazione,responsabilità o accountability, inclusività. Essipossono tuttavia essere declinati in modooriginale procedendo non secondo una dialetticapresenza/assenza ma secondo un percorso diprogressivo rafforzamento. Indubbiamente, formeembrionali di legittimazione, di responsabilitàe di inclusione già esistono nelle OI, ma
31 Ricordiamo, a questo proposito, che nell’Outlook on theGlobal Agenda 2015 pubblicato on-line dal World EconomicForum, il 77% degli intervistati si espresso concordandosulla necessità di sviluppare nuove strutture di governoglobale (la fonte è un sondaggio effettuato sulla GlobalAgenda dell’anno precedente.32 Si vedano in proposito le riflessioni di B. DE GIOVANNI inSovranità: il labirinto europeo, in Lo Stato, n.1 (2013), pp.1-27 e iriferimenti ivi operati ad altri autori..
16
ciascuno di questi elementi strutturali dellademocraticità può essere gradualmenteirrobustito. Definisco questo approccio “sperimentazionedemocratica”33 poiché la necessità di inventareformule nuove che si adattino ad ambiti e asettori differenti impone che si procedaempiricamente per tentativi e approssimazioni.Battistrada e modello in questo processo è statoil processo di integrazione europea definito aborigine “sui generis” o “di nuovo genere” dalla Cortedi Giustizia europea34. Tale assoluta atipicitàne fa un modello solo in termini di processo,ovvero nella capacità di procedere perapprossimazioni successive a forme più mature didemocraticità, ma non in termini di esito,ovvero ciascuna organizzazione internazionale èprobabilmente destinata a sperimentare formule“di nuovo genere” di legittimazione democraticae non a ricalcare il modello europeo, che è ilprodotto di specifiche circostanze storiche,culturali, geografiche.
33 La formula echeggia la “experimentalist governance” impiegataper descrivere l’UE da J. Cohen & C. F. Sabel in “GlobalDemocracy?” in International Law and Politics, 37 (2005), p.779 e daC. F. Sabel & J. Zeitlin “Learning from Difference: the NewArchitecture of Experimentalist Governance in the EU”, vol.14, no.3,pp.271-327.34 Il riferimento è alla nota sentenza Van Gend en Loos, in cuila Corte per la prima volta definisce la Comunità come unordinamento “di nuovo genere (…) che riconosce comesoggetti non solo gli Stati, ma anche i loro cittadini”,sentenza del 5 febbraio 1963 causa 26/62. Tale formulazioneè ripresa anche da importanti sentenze successive come laCosta c. ENEL (causa 6/64) ma anche Simmenthal (causa106/77), Francovich (procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90) enei pareri 1/91 del 14 dicembre 1991 e 1/2009 dell’8 marzo2011.
17
I tre pilastri della democraticità -legittimazione, accountability ed inclusività –sono, a propria volta, scomponibili in piùprofili sostanziali.
a) La nozione di legittimazione La legittimazione di un’organizzazioneinternazionale può essere compiutamenteverificata solo attraverso una scomposizioneprismatica della nozione nelle sue più rilevantiaccezioni. Un’organizzazione internazionale è percepitacome legittima anzitutto in ossequio ad unprincipio procedurale. E’ legittima se è statacreata rispettando le regole all’internodell’ordinamento di riferimento, quellointernazionale; se vi è un trattato validamenteconcluso, a cui gli Stati hanno sceltovolontariamente di aderire; se la lex specialis cosìcreata vale a creare un sub-ordinamento cherispetta le norme che si è date: i suoi statuti,il suo diritto interno. Alla legittimazionediscendente dal rispetto della rule of law se nesovrappone un’altra, più sostanziale, per laquale è percepita come legittimaquell’organizzazione che persegue gli obiettiviad essa attribuiti e rispecchia i valori comuniin cui si riconoscono i suoi membri35. Terzo elemento della legittimità è larappresentatività: un’organizzazione èconsiderata legittima se i suoi organi sono35 M. BARNETT M. FINNEMORE, Rules for the World. InternationalOrganizations in global politics, p.166. Gli autori evidenziano comele organizzazioni internazionali siano burocrazie inespansione che legittimano tale fenomeno proprio sulla basedell’ampiezza dei valori e degli obiettivi che le fondano.
18
percepiti come rappresentativi, ovvero se i suoimembri se ne sentono rappresentati. Larappresentatività può essere diretta oindiretta: è diretta qualora tutti i suoi membripartecipino alle scelte, per esempio in qualitàdi componenti dell’organo deliberante, èindiretta qualora essa sia mediata, nel caso incui un organo ristretto, per esempio, riceva unmandato o scaturisca da un momento elettivo daparte di un organo direttamente rappresentativoo proprio dalla pluralità dei membri. Gli organidecisionali di un’organizzazione sono dunquelegittimati da un maggiore o minore grado dirappresentatività a seconda che essi riflettanodirettamente o indirettamente la baseassociativa. Naturalmente, talerappresentatività è mediata dai poteri di votoe, in caso di ponderazione di voto, è benpossibile che alcuni Stati, che pure sonorappresentati in quanto tali, non si sentanoadeguatamente rispecchiati nel numero di votiche esprimono36. La rappresentatività cui si èfatto riferimento fin qui è – beninteso – larappresentatività degli Stati membri: alcunepeculiarità meritano di essere evidenziate conriguardo alle OI per il fatto che non si sia quidi fronte a una comunità di individui, ma diStati.Vi è, anzitutto, l’impossibilità di applicareagli Stati il principio di uguaglianza,36 Si veda in proposito l’annoso dibattito su voice andrepresentation in seno alle organizzazioni di Bretton Woods,che ha condotto alle revisioni del 2008 e del 2010 dellequote assegnate agli stati membri e agli emendamenti degliArticles of Agreements del FMI deliberati nel 2010 e non ancoraentrati in vigore.
19
connaturato alla nozione di democrazia. GliStati sono tutti sovrani e dunque uguali nellaComunità internazionale, ma tale principio nonpuò che essere una fictio,37 gli Stati sono benlungi dall’essere uguali38. Per conseguenza, ègeneralmente accolto nelle organizzazioni ilprincipio per il quale gli Stati sonodiversamente rappresentati in quanto riflettonodifferenti realtà.Il principio di uguaglianza appare nell’evomoderno sin dai primi documenti costituzionalidel Settecento39 e trae origine, com’è noto,dalla pari dignità degli esseri umani in virtùdella quale tutti i cittadini sono ugualidavanti alla legge, tale principio porta aignorare e addirittura a tentare di porrerimedio alle differenze di fatto che mettonoalcuni in una situazione di vantaggio pernascita. Tale principio di uguaglianza, ove fosseapplicato su scala internazionale - così comenegli ordinamenti interni- agli individui, ci
37 Come scriveva R. MONACO nel 1961: “Tandis que lesprincipes de l’unanimité et de la majorité simple sontfondés, par rapport à la substance des relationsinternationales, sur des fictions, les principes de lamajorité qualifiée et de la pondération de votecorrespondent à la réalité de la vie des organisationsinternationales. Et quant a nous, nous préférons, même dansce domaine particulier, la réalité à la fiction”, “Lesystèmes de vote dans les organisations internationales”,in Mélanges en l’honneur de Gilbert Gidel, Paris 1961, p. 482. 38 Troppi elementi marcano delle differenze tra gli Stati:la dimensione, la popolazione, la taglia delle economie, maanche il controllo delle risorse naturali o ladisponibilità di armamenti.39 Si vedano la Dichiarazione di Indipendenza U.S.A. del1776 e gli artt. 1 e 6 della Dichiarazione dei dirittidell’uomo e del cittadino francese del 1789.
20
indurrebbe a privilegiare un criteriodemografico per differenziare la partecipazionedegli Stati nelle OI che, qualora fosse dirappresentanza proporzionale alla popolazione,azzererebbe la presenza di molti piccoli Stati evedrebbe crescere a dismisura quella di altri.L’uguale rappresentanza degli Stati e l’ugualerappresentanza dei rispettivi cittadini dunquesono in conflitto tra loro e trovano un punto dicompromesso, quanto mai discrezionale, in senoalle organizzazioni internazionali, che siesprime attraverso ponderazioni e maggioranzespeciali40.La rappresentatività si declinerebbe bendiversamente qualora considerassimo comesoggetti non gli Stati ma i loro cittadini nonsolo con riferimento al principio diuguaglianza. In tal caso infatti sarebbe
40 Su quest’argomento rimangono classici alcuni studi cherisalgono a diversi decenni fa: R. DRAGO, La ponderation dans lesorganisations internationales, in Annuaire français de droit international,1956, p. 529 ss.; J. KRANZ., Le vote ponderé dans les organisationsinternationales, in Revue générale de droit international public, n. 2,1981, p. 313 ss.; R. MONACO, Le systèmes de vote dans les organisationsinternationales, cit, , pp. 469 ss.; C.W. JENKS, Unanimity, the Veto,Weighted Voting, Special and Simple Majorities and Consensus as Modes ofDecision in International Organisations, in Cambridge Essays in InternationalLaw. Essays in Honour of Lord McNair, London 1965, p. 48 ss; S.ZAMORA, Voting in International Economic Organizations, in The AmericanJournal of International Law, vol. 74, n. 3 (luglio 1980), p. 566ss. La materia è stata più recentemente sistematizzata daE. LAGRANGE., La représentation institutionnelle dans l’ordreinternational, Den Haag 2002. Vedi da ultimo M. VELLANO,“Verso il superamento del principio della parità formale degli Stati nel governodell’economia mondiale” in Problemi e tendenze del diritto internazionaledell'economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone, a cura di A.LIGUSTRO G. SACERDOTI, Napoli 2011, p. 153.
21
opportuno prestare specifica attenzione allaforma di legittimazione principe: ilparlamentarismo. Tutti sappiamo quanta parteabbia avuto nel dibattito sul deficitdemocratico l’evoluzione in Europa del ruolo delParlamento europeo, ma anche quale valenzasimbolica rivesta, sin dal 1950, l’Assemblea delConsiglio d’Europa. Non c’è dubbio che in Europala democrazia rappresentativa sia la democraziaper eccellenza e il momento elettorale ne sia ilculmine. Sebbene questo modello sia statoassimilato anche da alcune altre aggregazioniregionali41, rimane tuttavia minoritario. E’legittimo dubitare che possa essere consideratol’ingrediente necessario per un’evoluzionedemocratica delle OI.Non è impossibile, infatti, sperimentare formecrescenti di legittimazione democratica fuoridai canoni classici della democraziarappresentativa, accogliendo –ad esempio - letesi di Amartya Sen per il quale ciò cheveramente conta è la costruzione di una sfera didibattito politico che consenta l’esercizio diuna ragione pubblica42 e, d’altronde, un modellocondiviso, per essere applicabile su scala piùampia di quella continentale (o per non esseretacciato di eurocentrismo) deve necessariamenteibridare culture, accogliere input diversi e41 Fuori dall’Europa si veda il Parlamento Pan-Africanodell’Unione africana, il Parlamento del Mercosur, ma ancheforme di parlamentarismo embrionale come la Commissioneconsultiva del Consiglio di Cooperazione degli Stati arabidel Golfo (GCC). Una campagna per istituire un’assembleaparlamentare delle nazioni Unite è in atto dal 2007, siveda http://en.unpacampaign.org/.42 A. SEN, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzionedell’occidente, Milano, 2005.
22
visioni altre e presentarsi come punto d’arrivodi un sincretismo dei valori democratici.Formule innovative sono già state sperimentatein tal senso e non esauriscono certamente ilventaglio (infinito) delle possibilitàcreative.43 La stessa possibilità – ampiamentesperimentata in sede europea44 - di condurreconsultazioni aperte on-line prodromicherispetto ad un’attività normativa, si prestaquale strumento di dialogo atto a far crescerequalitativamente e quantitativamente una societàcivile che interloquisce con le OI sia pure inspecifici ambiti settoriali, con l’effetto di43 Si veda il board multisettoriale che gestisce il GlobalFund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria, composto di nove seggiregionali, sei Paesi donatori, due ONGs, una fondazione,una società private, un rappresentante dei malati e quattroosservatori senza diritto di voto (tra cui WHO e Bancamondiale). Altri esempi di ibridazione creativa tra modellisono il Kimberly Process e l’Internet Governance Forum. Tra itentativi di mappare le formule di governance innovativavanno citati l’Encyclopedia of Transnational Governance Innovation e theGlobal Institutional Design Project. Si veda M. P. KARNS, K.A. MINGST,International Organizations cit. p.544 e ss. Un trend significativoin atto è quello che vede un ruolo crescente dellepartnership pubblico-privato. Si rinvia per approfondimential contributo di A. TANCREDI in questo stesso volume, pp….44 Il riferimento è alla prassi europea delle consultazionilanciate dalla Commissione europea attraverso i libribianchi e verdi che precedono la redazione della propostadi atto normativo e su cui tutti i gruppi interessati, ONGe lobby, hanno la possibilità di esprimere le proprievalutazioni. Il Trattato di Lisbona accoglie tale prassicome espressione di valori democratici, nell’art.11 TUE incui, nei primi due paragrafi si legge: “1. Le istituzionidanno ai cittadini e alle associazioni rappresentative,attraverso gli opportuni canali, la possibilità di farconoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni intutti i settori di azione dell'Unione. 2. Le istituzionimantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con leassociazioni rappresentative e la società civile”.
23
incentivare il consolidamento di sottoinsiemetematici nell’ambito di un demos globale,communities di cittadini specificamenteinteressati ad un tema piuttosto che ad un altro(l’ambiente, i diritti civili, la salute etc…).Un modello interessante è offerto dalla GlobalEnvironment Facility (GEF) che vede negli organidecisionali una rappresentanza bilanciata dicontribuenti e beneficiari, un meccanismo didoppia maggioranza e canali procedimentalizzatiper coinvolgere i soggetti interessati..)45.
b) La nozione di accountability Un secondo elemento di democraticità di unsistema interviene ex post, una volta compiute lescelte, e può essere inscritto nella nozione di“responsabilità”, sebbene il termineanglosassone “accountability” sia di maggior respiroe dunque più calzante. Un organo tanto tecnicoche politico e un’organizzazione nel suocomplesso sono ritenuti accountable quandorispondono delle proprie scelte, vale a dire sene assumono in toto la responsabilità46. Il
45 La Global environmental facility è considerata un laboratorio digovernance particolarmente interessante e avanzato. Si vedanoin proposito N. WOODS, D. LOMBARDI, Uneven Patterns of Governance:How Developing Countries Are Represented in the IMF, in Review ofInternational Political Economy, 13:3, agosto 2006, pp. 480-515,nonché le notizie e i documenti ufficiali riportati sulsito http://www.thegef.org46 Come scrive A. PETERS, “Constitutionalised internationalorganizations must be accountable. In a constitutionalistframework there is both legal accountability (mainlythrough judicial review) and political accountability(through the democratic process)...” in “TheConstitutionalisation of International Organisations” in
24
principio di accountability esige anzituttol’imputabilità: la conoscibilità del “chi facosa”. Una seconda dimensione attiene allanecessità che l’organizzazione e/o chi virivesta un ruolo debba dichiarare in che modoquesto viene eseguito, come viene impiegato ildenaro, in quale misura sono stati raggiunti gliobiettivi e quali aspettative sono statesoddisfatte. Infine, ciò comporta anche che chiabbia sbagliato possa essere sanzionato orimosso. Accountability è, in fondo, l’esattocontrario di quell’arbitrio che potrebbeastrattamente imputarsi anche a un soggettopienamente legittimato. Tale nozione presuppone:trasparenza; motivazione delle scelte; garanzie;assunzione di responsabilità; rendicontazionesulle attività svolte; revisione da parte diorgani (o organismi) terzi; possibilità diavanzare reclami e, laddove possibile. anchegiustiziabilità.Il più avanzato modello di amministrazionepubblica oggi sembra essere quello che presentai tratti distintivi dell’open government:trasparenza, apertura dei dati e delleinformazioni e loro condivisione attraverso letecnologie digitali. Ben si prestaall’applicazione in sede di organizzazioniinternazionali poiché contribuirebbe a colmarequella distanza fisica dal cittadino che nonconsente forme di controllo più dirette.Un’organizzazione internazionale è accountable semette i propri membri -gli Stati, ma anche i
Europe's Constitutional Mosaic a cura di N. WALKER, J. SHAW, S.TIERNEY, Oxford, 2011, p.264.
25
cittadini- in condizione di formulareosservazioni e critiche, se vi da seguito edispone di strutture e organi deputati almonitoraggio e alla valutazione. Sebbene vi siano stati molti passi avanti daquesto punto di vista, importanti progressipossono ancora essere fatti in due direzioni.Una prima direzione, attiene all’accountability deisingoli organi tanto tecnici che politici. Incaso di cattiva amministrazione o di fallimentodi un’azione intrapresa gli organi di carattereoperativo potrebbero essere rimossi/rinnovati?In che modo?47 Un secondo indirizzo di riforma potrebbecoinvolgere i livelli di governo sottostanti,rendendo le organizzazioni, seppure in misuraridotta, accountable nei confronti degli stessicittadini e particolarmente delle popolazionidirettamente interessate dagli interventi.
47 Non può ad esempio, non destare perplessità quanto silegge nell’IMF Country Report No. 13/156 (June 2013) Greece:Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement.E’ scritto infatti a chiare lettere come il Paese abbiapagato un prezzo sociale troppo elevato a causa delprocesso di consolidamento di bilancio richiestodall’intervento di sostegno finanziario: “Market confidencewas not restored, the banking system lost 30 percent of itsdeposits, and the economy encountered a much deeper- than-expected recession with exceptionally high unemployment.Public debt remained too high and eventually had to berestructured, with collateral damage for bank balancesheets that were also weakened by the recession.Competitiveness improved somewhat on the back of fallingwages, but structural reforms stalled and productivitygains proved elusive”. “[N]otable failures” sono quindiesplicitamente riconosciuti, ma senza che alcunaconseguenza ne derivi in termini di responsabilità degliorgani competenti.
26
Infine vi può e vi deve essere unaresponsabilità di tipo legale48.L’imperfetta rappresentatività che abbiamoassunto come inevitabile, può essere in partecompensata proprio sul fronte dell’accountabilityche può essere invece compiutamente realizzataal livello di governo sopranazionale ancheinventando e sperimentando nuove formulegiuridiche e istituzionali.49
Naturalmente non si può immaginare che icittadini in forma organizzata possano impedirel’attività di un’organizzazioni internazionale o“sfiduciarla” - vi osta l’assenza dilegittimazione della società civile arappresentare la totalità dei cittadini - ma laconoscenza delle circostanze e delle motivazionialla base delle scelte e delle procedure chehanno condotto ad una decisione deve essereconoscibile e può consentire loro di attivare irispettivi rappresentanti nazionali e/o dicomunicare direttamente con gli organi dicontrollo interni dell’organizzazione stessa perpresentare un reclamo sia esso di naturagiudiziaria o politica50. Vi sono dunque una pluralità di potenzialisoggetti passivi dell’accountability: gli Stati, gli48 Si rinvia in questo stesso volume al contributo di P.PUSTORINO, pp… 49 Cfr sul tema ILA Report on Accountability, Berlino Conference(2004), reperibile sul sito dell’International LawAssociation http://www.ila-hq.org/50 Si veda a titolo di esempio l’Inspection Panel della Bancamondiale, che può ricevere domande di apertura diun’inchiesta su richiesta dei Comitati esecutivi di BIRS oIDA, direttori esecutivi o anche di “un gruppo di persone”che si ritengano lese da un’azione o omissione della Banca,anche per il tramite di rappresentanti come le ONG.
27
stakeholders, i cittadini, come vi sono piùsoggetti attivi: i singoli organi delle OI e leorganizzazioni nel loro complesso. Strettamente connessa alle esigenze dirappresentatività, di accountability e diinclusione è la domanda di trasparenza. Sipotrebbe anche dire che un’organizzazioneinternazionale è democratica qualora le duecomponenti del binomio rappresentatività-accountability siano parimenti sviluppate e traloro coerenti e lo strumento necessario etrasversale per realizzare entrambe sia latrasparenza51. La trasparenza implica lapermeabilità, la conoscibilità, la possibilitàdi comunicare per manifestare esigenze orimostranze. Attiene alla struttura dei lavori,alla pubblicità e accessibilità dei documenti,all’accesso. Non stupisce dunque che questo temasia particolarmente evidenziato nei documentiche sono espressione del punto di vista dellasocietà civile.52
Indubbiamente, anche sotto questo profilo ilprogresso in molte organizzazioni è innegabile eil contributo offerto da internet è stato quantomai rilevante. Non è tuttavia sufficienterendere fruibili i documenti attraverso un sitoweb se non se ne forniscono le chiavi dilettura: l’indicazione di chi fa cosa, e con
51 Sul tema si veda D. I. SHAMAN The World Bank Unveiled. Inside therevolutionary struggle for transparency, Marion, Michigan., 2009.52 Si veda il par. 42 ss. del Rapporto redatto da D.LOMBARDI, Report on the Civil Society. Consultations with the InternationalMonetary Fund on Reform of IMF Governance (cosiddetto IV PillarReport), Washington, DC, 2009, reperibile sul sitohttp://www.oxonia.org.
28
quali obiettivi, quali sono gli interessisottesi ai singoli atti e le valutazionieffettuate, i risultati attesi.
c) La nozione di inclusivitàLa trasparenza e l’accessibilità acquistano unparticolare valore e significato qualoraconsentono di dialogare con la società civile edunque di integrare il dialogo con gli Statiinserendo elementi e canali di dialogo direttocon i cittadini e con quegli organismi che sifacciano portatori di interessi diffusi53.Vi è una stretta parentela tra le nozioni dilegittimazione democratica, di accountability equella di inclusività: tutte muovono dallatrasparenza ed implicano la comunicazione. Perinclusività si può intendere la capacità diquesta comunicazione -necessaria ai finidell’attivazione degli strumenti dellademocrazia partecipativa come dei meccanismi diresponsabilità- di raggiungere il più grannumero dei cittadini. Il coinvolgimento della società civile al di làdegli ostacoli evidenti che derivanodall’esistenza di gap culturali, linguistici,digitali per arrivare alle minoranze e allecategorie svantaggiate è l’ingrediente cheimpedisce che – in prospettiva – i processisopra descritti e di fatto già avviati rimanganoappannaggio di una élite essenzialmente di razzacaucasica, anglofona, con elevati titoli di
53 Una ricca panoramica delle interazioni tra società civilee organizzazioni internazionali è offerta in J. A. SCHOLTE (acura di) Building global democracy? Civil Society and Accountable globalgovernance, Cambridge University Press, 2011.
29
studio, connessa alla rete e capace disfruttarne le potenzialità54. Sono questi,infatti, i tratti caratterizzanti la gran partedella società civile attiva a livello globaleche oggi vediamo svolgere un ruolo preziosissimodi avanguardia che però non potràindefinitamente rimanere tale. Una nozione didemocraticità che ambisca a superare il datoformale per giungere ad essere sostanzialerichiede strumenti di inclusività ad hocfinalizzati alla comunicazione mirata e allapartecipazione più ampia possibile, sia purenell’ambito di target circoscritti. Valori qualiil pluralismo, l’accettazione e l’integrazionedelle diversità sono elementi fondanti di unanozione di democrazia compiuta. Inutile dire chetutto ciò presuppone il superamento del gap notocome digital divide, sia in termini culturali che – amaggior ragione – infrastrutturali55.
d) Dalla scomposizione alla ricomposizione
Alla scomposizione segue una ricomposizione casoper caso, secondo un approccio che potremmodefinire costruttivista, dato che la maggiore ominore democraticità è frutto della creazionenormativa ed è creata nella norma del trattato onella dichiarazione di intenti prima che nella
54 Id, Civil Society and IMF Accountability in Building Global Democracy?cit., p. 80 e ss.55 Si veda la mappa riportata da Business Insider il 14settembre 2014, che riporta la densità delle connessioni adinternet nel mondo, ove si evidenzia la rarefazione deicollegamenti in buona parte dell’Africa e dell’Asiacentrale http://www.businessinsider.com/this-world-map-shows-every-device-connected-to-the-internet-2014-9.
30
realtà. E prima ancora nella nozione didemocraticità che si assume a punto diriferimento.In questo modo, al negoziatore, a tutti ilivelli, è attribuito un ruolo di inventore, chenon va tuttavia assolutizzato perché è semprepossibile l’intervento correttivo. Anche inquesto senso, l’esperienza comunitaria hasegnato un cammino esemplare ponendosi qualerealtà in divenire, quale cantiere istituzionaleaperto che incoraggia le proposte di modificacostruttive, a differenza di altri sistemi eorganismi in cui il trattato istitutivo èrivestito di una sacralità che non è soltanto ilportato della difficoltà dei processi direvisione56. Esperimenti interessanti sono già visibili,contaminazioni a partire da modelli disuccesso57, ma vi sono anche profonde differenzeculturali che impediscono di trovare soluzioni eformule universalmente applicabili. Ciò che sipuò trovare è piuttosto il metodo e più ancora ivalori/obiettivo che si vogliono perseguire, connuances che riflettano le differenze culturali edi contesto e graduino in funzione dello stadioevolutivo in atto. Come già avvenuto con ilprocesso di integrazione europea, quindi, altre
56 Ad esempio, nel FMI la maggioranza dei voti richiesta peremendare gli Articles of agreement è l’85% dei voti, la stessanecessaria ai fini della revisione quinquennale dellequote, eppure quest’ultimo processo è politicamente ben piùfacile nonostante siano gli stessi attori e le stesseprocedure. 57 Si veda la dinamicità dei fenomeni associativi in sudAmerica e l’influenza esercitata dal modello europeo. Siveda in proposito P. PENNETTA Integrazione europea ed integrazionilatino-americane e caraibiche: modelli e rapporti. BARI, 2009.
31
organizzazioni internazionali possonosperimentare formule istituzionali che dianovita ad ordinamenti di nuovo genere: nuovo ediverso.Un senso di disagio potrebbe coglierci a causadella nostra esigenza cartesiana di classificareper comprendere, ma è opportuno chiarire chequel che si propone non è un mondo “à la carte”bensì un’evoluzione progressiva verso valoricondivisi, che vedrebbe variare le modalità e itempi, non gli obiettivi finali. Allo stessotempo, questo approccio è atto a ricomprenderein una cornice teleologica una serie di piccoleevoluzioni già in atto fornendone una chiave diinterpretazione. Il riferimento èall’intensificarsi di strumenti di reclamo58, diorgani di controllo59, di occasioni di dialogostrutturato con la società civile60 che sono oggiosservabili. 58 Si veda l’Inspection Panel della Banca mondiale, di cui allanota 46, creato nel 1993, o gli United Nations Ombudsman andMediation Services. L’ufficio dell’Ombudsman è istituito nel2002, a partire dal 2006 esso serve anche UNDP, UNFPA,UNOPS ed UNICEF, negli anni successivi estendeulteriormente il proprio mandato e si dota di strutturedecentrate; 59 Nella Banca mondiale, l’Independent Evaluation Group,precedentemente denominato Operations Evaluation Department, è ilsistema di controllo interno della Banca sull’attivitàsvolta, caratterizzato da forte autonomia. Dal 1993 rendein buona parte accessibile l’esito delle sue valutazioniattraverso la pubblicazione della Annual Review of EvaluationResults e delle sintesi dei suoi rapporti. Analogamente,seppure in ritardo rispetto alla Banca, con deliberazionedel Comitato esecutivo il Fondo ha creato, nel 2001, unIndependent Evaluation Office. Nell’ambito dell’ONU nel’ 1994l’Assemblea, con risoluzione 48/218B, istituisce l’Office ofInternal Oversight Services (OIOS), per assistere il SegretarioGenerale; nel 2008 viene istituito l’Independent Audit AdvisoryCommittee (IAAC) per supportare l’Assemblea generale nei propricompiti di vigilanza 60 Quali quelle menzionate nel par.3.
32
5. Una naturale obiezione merita una rispostafin d’ora: l’assenza in partenza di una visionecomplessiva può minare l’esito del processoevolutivo? L’esperienza della Comunità economicaeuropea divenuta Unione sembra poter offriredelle risposte: vi sono geni nel DNA dei sistemiatti a condizionarne l’evoluzione. Ritengo cheil gene della sovranazionalità sia statocruciale nel condizionare l’evoluzione europea eche – qualora faccia la sua comparsa in unsistema - possa dotarlo di una capacità dipropulsione sulla propria stessa evoluzione. Sipuò affermare che esso è presente (sia pure inminime dosi) laddove sia riconosciuto uno statusagli individui, un ruolo ai corpi intermedi cheli rappresentano o agli organi composti daindividui - sia pure limitato- nell’ambito diun sistema di governance. Anche un’organizzazione classicamenteintergovernativa può sperimentare forme limitatedi sovranazionalità tutte le volte in cuistabilisce un rapporto diretto con gliamministrati che sia mediante la previsione diorgani consultivi rappresentativi della societàcivile o di specifiche categorie61, diconsultazioni aperte e di momenti assembleari,di canali che consentano ai diretti interessati(come individui o in forma associata) di61 Anche in organizzazioni tipicamente intergovernativericorre la presenza di organi consultivi di rappresentanzaparlamentare, così come non è raro che vi siano organi diesperti o di rappresentanti degli ambienti economici. Siveda P. PENNETTA, op. cit. pp.222-230.
33
presentare reclami direttamenteall’organizzazione. Naturalmente, è benragionevole che, in organismi fondati sulla softlaw anche questi momenti siano frutto di soft law eprassi e non c’è da stupirsi se i giuristi nonvedono in questo una compiutezza di diritti. Nonsiamo certo nell’ambito della democraziarappresentativa né tantomeno diretta, ma si puòconvenire su forme larvali di democraziapartecipativa, che possono nel tempo maturarecome regredire.Proprio la capacità di un’organizzazioneinternazionale di legittimarsi direttamente apartire dai cittadini -eventualmente creandoforme di cittadinanza ad hoc62- offrirebbe larisposta all’ostacolo insormontabile dallaimperfetta democraticità dei suoi Stati membri onella incapacità di Stati pure democratici, difungere quali cinghie di trasmissione di istanzedemocratiche in contesti intergovernatividominati dalla ragion di stato e da un non benprecisato interesse nazionale appaltato aigoverni spesso senza controllo da parte deiparlamenti nazionali. La democrazia globale o è–in qualche misura - sovranazionale o non è.Ci si potrebbe chiedere a questo punto quantopossano progredire sulla strada dellademocratizzazione quelle OI che accolgono qualivalori fondanti sovranità nazionale, sovranauguaglianza, indipendenza e non interferenza63,
62 Come prospettato da A. VON BOGDANDY, The European Lesson forInternational Democracy: The Significance of Articles 9-12 EU Treaty forInternational Organizations, European Journal of International Law, cit.63 Si vedano a titolo di esempio i documenti fondatividell’Asia Pacific Economic Cooperation (APEC Summary
34
eppure a dispetto di tali assunti anche questehanno capacità evolutive. I fattori che possono determinare un’evoluzionenella strutturazione progressiva dellacooperazione internazionale possono essere tantoesogeni che endogeni, ed a loro volta anche iprocessi di democratizzazione possono essernecondizionati: crisi economiche, catastrofinaturali, minacce alla pace possono indeterminate circostante fungere da catalizzatoridi riforme64. Parimenti, movimenti di piazza erivendicazioni diffuse nell’opinione pubblicapossono determinare il clima in cui maturanoconsapevolezza e volontà politica delcambiamento. La democrazia post-nazionale e post-territorialeè indubbiamente ancora da costruire, macondividiamo l’assunto per il quale “global spacesare not inherently undemocratic”65, quel che si richiedeper colmare tale lacuna è l’assenza di
Statement 1989 sub 16); della South Asian Association forRegional Cooperation del 1985 (art.II SAARC Charter);dell’Indian Ocean Rim – Association for RegionalCooperation del 1997 (art.2 (i))64 Come scrive I. Golding: “The establishment of sharedsystems of rules to promote inclusive and sustainableglobalization is urgently needed. The question is whetherthis will be in time to proactively address systemic globalcrises or whether reform must emerge from the ashes of adevastating crisis as has been the historical norm”, DividedNations. Why Global Governance is Failing and What we Can Do about It,Oxford, 2013, p.178.65 Come scrive I. A. SCHOLTE, a seguire, “Many of theinitiatives mentioned (…) indicate that globalization anddemocratization can be complementary. The future requiresnot a reversal of globalization, but a post-sovereignpolitics. concerted search for new concepts and practicesthat can make democracy work in post-territorialist, post-sovereign politics.” in Globalization. A Critical Introduction,London, New York, 2000, p.282.
35
pregiudiziali fondate sull’esperienza dellostato sovrano territoriale. La democrazianazionale non è probabilmente destinata atramontare, ne tantomeno a “cedere il passo” intempi brevi a forme di democrazia relative a piùampi contesti territoriali. Piuttosto, menomatacom’è dai processi di globalizzazione in atto,richiede un necessario completamento a livellosovranazionale.
36