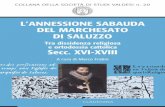oltre la politica. La crisi politico-istituzionale negli Stati Uniti tra Otto e Novecento
Migrazioni internazionali e crisi economica
Transcript of Migrazioni internazionali e crisi economica
1
3.5
Migrazioni internazionali e crisi economica
Luca Muscarà
Migrazioni, sviluppo economico e globalizzazione sono sempre più interconnessi. L’impatto della crisi economica sui flussi migrato-ri rivela alcuni elementi interessanti. A livello globale le migra-zioni continuano ad aumentare, in particolare quelle lungo l’asse Sud-Sud, tuttavia l’impatto sui flussi Sud-Nord è misto. Negli Stati Uniti crolla l’immigrazione dal Messico, ma aumenta quella dall’Asia. In Europa, dopo un temporaneo declino dei flussi Est- Ovest, aumentano le emigrazioni da alcuni dei paesi più colpiti dal-la crisi, come Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda, mentre diversi Stati irrigidiscono le proprie politiche di accoglienza. Nel comples-so, le migrazioni mostrano tuttavia una certa resilienza che, nel caso delle diaspore presenti in Italia, è sottolineata dall’aumento delle rimesse in patria dei cittadini cinesi e da quello delle quote pro capite di bengalesi, indiani e filippini, nonostante la crisi. I lavoratori migranti sono una risorsa per i paesi che li ospitano e politiche restrittive potrebbero avere conseguenze molto negative per l’economia degli Stati ricchi, invecchiati e sul lungo periodo poveri di giovani.
Se il prolungarsi della crisi economica sta accentuando un proces-so di riequilibrio dell’economia globale, dovuto al rallentamento o alla stagnazione della crescita economica nei paesi più ricchi e a tassi di crescita più elevati in un crescente numero di economie emergenti, il fenomeno risulta accentuato dalle recenti tendenze demografiche globali, delle quali le migrazioni internazionali sono una importante manifestazione1.
1 B. Ghosh, The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects: What Will Migration Look Like in 2045?, Palgrave MacMillan, Londra, 2013.
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 3 2
Così, mentre alla fine del 2012 il numero di disoccupati nel mondo ha raggiunto quasi i 200 milioni persone2, e al 30 aprile 2013 è stato stimato al 12% nei paesi dell’Eurozona, l’attenzione per l’impatto della crisi sulle migrazioni internazionali è aumentata.
Si presume, infatti, che eventuali riduzioni negli arrivi (o migra-zioni di ritorno, o verso destinazioni migliori, o un aumento delle emigrazioni di concittadini nazionali) siano altrettanti indicatori delle condizioni dei mercati del lavoro e dunque dell’economia di un dato paese.
L’aumento della disoccupazione si tradurrebbe in sostanza in ter-mini negativi sulle prospettive occupazionali dei migranti, favorendo ritorni in patria e ri-emigrazioni a volte verso mete inattese. Inoltre, il contesto di incertezza produce spesso un aumento dell’ansietà verso gli stranieri sul territorio nazionale, considerati in competizione con i nativi in un mercato del lavoro ridotto.
E ciò porta molti paesi a economia avanzata verso un irrigidimen-to delle politiche di accoglienza che a loro volta influiscono sui flussi.
Nondimeno, per l’Organizzazione Internazionale per le Migrazio-ni (Iom) il numero globale dei migranti è continuato ad aumentare anche negli anni recenti (vedi mappa 3.5.1)3.
Questa mappa ponderata del mondo mostra la dimensione rela-tiva di ciascun paese in base alla stima di popolazione emigrante (in uscita). Le stime sono arrotondate al centinaio di migliaia supeirore.
Esclusi rifugiati politici, naturalizzazioni, migrazioni irregolari e interne, negli ultimi dieci anni i migranti internazionali sono passati da 150 milioni (2000) a 214 milioni (2010). E se nell’ultima decade la quota percentuale dei nati all’estero è aumentata solo dal 2,9% al 3,1% della popolazione mondiale, la popolazione nata all’estero rappresen-ta comunque la quinta “nazione” al mondo per dimensione.
2 Ilo, Global Employment Trends 2013, Ginevra, 2013.3 International Organization for Migration, World Migration Report, 2011. M
appa
3.5
.1 -
L’or
igin
e de
lle m
igra
zion
i int
erna
zion
ali
Il nu
mer
o de
lle c
asel
le p
uò n
on e
sser
e il
tota
le d
ella
pop
olaz
ione
mig
rant
e a
caus
a de
ll’ar
roto
tnda
men
to.
Font
e: P
ew R
esea
rch
Cen
ter’s
For
um o
n Re
ligio
n an
d Pu
blic
Life
. Glo
bal R
elig
ion
and
Mig
ratio
n D
atab
ase
2010
.
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 5 4
Certo, la percentuale di migranti varia notevolmente da un pae-se all’altro (vedi figura 3.5.1), ma proprio perché le migrazioni inter-nazionali sono aumentate anche durante la crisi, con un incremento della pressione esercitata localmente su infrastrutture e identità na-zionali, non è difficile comprendere come in numerosi casi, gli atteg-giamenti nazionalistici e xenofobi siano in crescita, con il risultato di politiche più restrittive verso i lavoratori stranieri, come sta avvenen-do in Svizzera e in numerosi paesi dell’Unione Europea.
In tempi incerti, infatti, le migrazioni mettono alla prova capacità e volontà dei paesi destinatari di accogliere nuovi arrivi, ponendo a rischio pure precedenti politiche e consensi ottenuti sull’immigrazio-ne. Così il dibattito sul fenomeno risulta inevitabilmente politicizzato.
Per evitare percezioni distorte e reazioni irrazionali, va ricordato che le migrazioni non sono una patologia sociale temporanea di un mondo la cui norma è una metafisica sedentaria, ma sono uno dei flussi espressione della globalizzazione, come lo è il commercio este-ro, e continuano ininterrottamente ad aumentare dal 1960.
Anche la consapevolezza delle interrelazioni tra sviluppo econo-
mico, globalizzazione e migrazioni è aumentata negli ultimi tempi4.
Se le politiche di accoglienza di uno Stato restano una parte impor-tante dell’equazione, la presenza di stranieri ha un ruolo largamente positivo per l’economia.
Ciò è vero non solo nei paesi più sviluppati ad elevata immigra-zione, come Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Anche in tutti i paesi sviluppati, la cui popolazione sia fortemente invecchiata e il numero di giovani si sia ridotto, come Germania e Italia, essa è indispensabile e lo sarà anche più nei prossimi venti anni5.
Il ruolo positivo per l’economia non riguarda solo la domanda globale di manodopera straniera qualificata, che è richiesta da tutti, i cosiddetti lavoratori high skilled, portatori di competenze per le quali esiste una scarsità locale.
In molti paesi sviluppati, vi è ampia domanda di lavoratori low skilled, sia per periodi prolungati, sia stagionalmente, in tutte quelle occupazioni, come in agricoltura e nell’edilizia, considerate di scarsa attrattività per le popolazioni locali. Infine, sono alcuni Paesi in Via di Sviluppo ad avere le percentuali più elevate di stranieri in assoluto6.
Così, le migrazioni oggi non sono più riducibili al semplice discor-so di luoghi sviluppati e con una popolazione più anziana che attrag-gono persone da aree economicamente più deboli e con una popola-zione più giovane.
Esse risultano più ampiamente distribuite rispetto a dieci anni fa: i principali paesi di destinazione ricevono meno migranti che nel 2000, ma le diaspore sono presenti in un maggior numero di paesi. E i mo-vimenti da e per i continenti in via di sviluppo come Asia e Africa sono divenuti più importanti.
La crisi ha portato una grande varietà di conseguenze sulle mi-
4 O. Söderström, F. Klauser, E. Piguet e L. Crot, “Dynamics of globalization: mobility, space and regulation”, Geographia Helvetica, 67, 1-2, 2012, pp. 43-54.5 Cfr. L. Muscarà, “Geodemografia e sicurezza”, in G. Cucchi, G. Dottori, Nomos&Khaos, Rapporto Nomisma 2010-2011 sulle prospettive economico-strategiche, Roma, Nomisma, 2011, pp. 101-24.6 I paesi con le più elevate percentuali di migranti rispetto alla popolazione nativa sono Qatar (87%), Emirati Arabi Uniti (70%), Giordania (46%), Singapore (41%) e Arabia Saudita (28%).
Figura 3.5.1 - Destinazioni delle migrazioni internazionali
Fonte: Elaborazione dell’autore su dati World Bank Development Prospects Group’s Bilateral Migration Matrix (2010).
27%
2001
2000
1999
Oceania 3%
Africa 9%
Americhe 27%
Asia 28%
Europa 33%
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 7 6
grazioni internazionali. Molti flussi verso i paesi più sviluppati sono rallentati durante e subito dopo il picco della crisi e molti dei tradi-zionali paesi di destinazione hanno ristretto le quote di ingresso, sia per anticipare una domanda ridotta di lavoratori che per proteggere i mercati del lavoro domestici.
Così, nonostante le difficoltà di reperire dati confrontabili, che non sempre riflettono la situazione effettiva di un Paese, e che non sono aggiornati alla stessa velocità di quelli economici7, le migrazioni inter-nazionali sembrano mostrare una notevole resilienza alla crisi, spie-gabile in parte con il fatto che spesso lo Stato di origine presenta con-dizioni economiche peggiori di quello di destinazione, in parte con i notevoli costi e difficoltà del viaggio, in parte con la forte motivazione che sostiene chi parte8.
FLUSSI E DESTINAZIONI
Tra le principali conseguenze della crisi economica sui flussi mi-gratori a livello globale, si rileva un consistente aumento dei cosiddet-ti flussi Sud-Sud, tendenza che dovrebbe divenire anche più rilevante nel tempo (Ghosh 2011, 2013).
Per la Iom, le economie emergenti dell’Asia diverranno una mèta sempre più importante delle migrazioni per lavoro9.
I paesi produttori di petrolio, tradizionale mèta dei flussi da Filip-pine, Indonesia, India, Pakistan e Bangladesh sono quelli che meno hanno sofferto della crisi, nonostante abbiano risentito del calo nella domanda di petrolio del 2009 e delle oscillazioni nel prezzo del bari-le10.
7 Tenuto conto non solo dei flussi irregolari, ma soprattutto del fatto che non sempre i migranti che ripartono per altra destinazione lo comunicano ufficialmente, con il risultato di continuare a essere conteggiati nelle statistiche.8 Anche il fatto che le diaspore oggi siano più digitali, usino skype e i social network, contribuisce a renderle più autonome e meglio informate.9 Iom, World Migration Report 2010, Ginevra, 2011, p. 11.10 Ciò si spiega anche con il fatto che, nonostante i Paesi del Golfo offrano stipendi più bassi ai lavoratori migranti, in genere forniscono ai migranti anche l’alloggio e maggiore sicurezza in termini di garanzie di continuità dell’occupazione nel tempo.
Se si considerano sia le migrazioni dall’Asia verso i paesi del Golfo sia quelle interne alla Cina, tali movimenti rappresentano ormai qua-si un terzo delle migrazioni complessive.
Per quanto riguarda poi le altre macroregioni che attraevano i flus-si migratori più consistenti, Nord America ed Europa (vedi figura 3.5.2), la situazione è di un complessivo rallentamento. Durante la recessione gli Stati Uniti hanno visto una “quasi pausa” nei flussi pro-venienti dal Messico, mentre la situazione in Europa Occidentale per i flussi da Africa, Europa Orientale e Russia risulta più mista.
Gli Stati Uniti e i Paesi ad alta immigrazione
Anche se la popolazione straniera totale è continuata a crescere durante la recessione (vedi figura 3.5.3), il dato più eclatante è quello del rovesciamento del modello storico iniziato negli anni Settanta: le migrazioni dal Messico verso gli Stati Uniti sono scese a zero, sia per l’aumento nelle migrazioni di ritorno verso il Messico, sia per il crollo
Figura 3.5.2 - Destinazione delle migrazioni internazionali per origine
Fonte: Elaborazione dell’autore su dati World Bank Development Prospects Group’s Bilateral Migration Matrix (2010).
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Altro SudOceaniaEuropaAsiaAmericheAfrica
Altro NordAltro SudOceaniaEuropaAsiaAmericheAfrica
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 9 8
dei flussi dal Messico verso gli States11.
Il fenomeno ha avuto inizio già nel 2006 con il tracollo del mercato immobiliare americano e dell’occupazione nell’edilizia e ha toccato anche le migrazioni illegali, che si sono ridotte moltissimo. Il censi-mento messicano dei tre anni or sono ha mostrato 1,4 milioni di ritor-ni (soprattutto adulti) nel periodo 2005-2010, concentrati negli ultimi anni. Un raddoppio rispetto agli anni 1995-2000.
Se la popolazione messicana in America è aumentata per quat-tro decenni sino al 2007, gli effetti combinati della crisi economica, dell’aumento dei controlli e delle difficoltà ai confini e dei cambia-menti demografici (declino della fertilità e riduzione della quota di popolazione in età lavorativa), oltre al miglioramento delle oppor-tunità educative ed economiche in Messico12 ne hanno arrestato la crescita. Nondimeno, i 12 milioni di messicani, pari a circa il 30% del totale13, rappresentano il raggruppamento più consistente di stranieri
11 J. Passel , D. Cohn , A. Gonzales-Barrera, “Net Migration from Mexico Falls to Zero-and Perhaps Less”, Pew Hispanic Center, 2012. 12 Dopo la recessione del periodo 2007-2009, in Messico la ripresa si è avviata già dal 2010.13 Stimati intorno ai 40 milioni nel 2011.
presenti negli Stati Uniti.
Diversa invece la tendenza per le migrazioni dall’Asia: tra 2000 e 2011 la popolazione asiatica è passata da 8,2 a 11,6 milioni. Di quest’ul-tima, il 34% proviene dal Sud-Est asiatico, il 32% dell’Asia Orientale, il 26% dall’Asia Centro-meridionale e l’8% dall’Asia Occidentale. In particolare, al 2011 lo Us Census Bureau stimava oltre 2,2 milioni di immigrati provenienti dalla Cina, 1,8 milioni sia dall’India sia dalle Filippine, 1,2 milioni dal Vietnam e un milione dalla Corea del Sud14.
Nel complesso, la più recente tendenza alla diminuzione della di-soccupazione, ora al 7,5%, e la prevista ripresa nel comparto dell’e-dilizia dovrebbero consentire di superare il rallentamento dei flussi migratori in entrata negli Stati Uniti che ha caratterizzato gli anni peggiori della crisi, ma ci vorrà tempo prima che l’occupazione nell’e-dilizia o nei servizi finanziari possa ritornare ai livelli pre-crisi15.
Infine, nelle altre mete tradizionali dei flussi migratori (Canada, Australia e Nuova Zelanda), l’impatto della crisi è stato misto.
Quello peggiore è stato sull’economia della Nuova Zelanda, tut-tavia il mercato del lavoro per i nati all’estero non ne ha risentito in modo sproporzionato, né è aumentata la retorica anti-immigrazioni.
Canada e Australia hanno avuto performance migliori. Il primo ha mantenuto un forte programma di accoglienza ai flussi migratori an-che durante la crisi, il secondo ha fatto lo stesso sino alle elezioni fe-derali del 2010, quando le quote di ingressi programmati sono state ridotte (Nieuwenhuysen et al. 2012).
L’Europa
Anche nell’Unione Europea la crescita dei cittadini stranieri è con-tinuata nonostante la crisi economica (vedi tabella 3.5.1 e figura 3.5.4). Secondo Eurostat, sono 33,3 milioni gli stranieri residenti nell’Ue27,
14 T. Gryn, C. Gambino, The Foreign Born from Asia: 2011, Us Census, ACSBR/11-06, 2012.15 D. G. Papademetrious, A. Terrazas, “The United States”, in J. Nieuwenhuysen, H. Duncan, S. Neerup (a cura di), International Migration in Uncertain Times, 2012, pp. 7-34.
Figura 3.5.3 - Usa: popolazione nata all’estero in milioni e come percentuale della popolazione totale
Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Us Census Bureau, 1850-2000 Decennial Cen-sus; 2010 American Community Survey.
2,24,1
5,66,7
9,210,3
13,5 13,9 14,2
11,610,3 9,7 9,6 14,1
19,8
31,1
40,0
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
9.7
13.214.4 13.3 12.9
14.813.6 14.7
13.211.6
8.86.9 5.4
4.76.2
7.9
11.1
Popolazione nata all’estero(milioni)
Percentuale della popolazione totale
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 11 10
pari al 6,6% della popolazione totale (2011).
Oltre il 75% risiede in uno dei cinque stati più popolati: Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Francia. La maggioranza, 20,5 milioni, è costituita da cittadini extra-Ue, mentre 12,8 milioni sono cittadini Ue (vedi tabella 3.5.2)16.
Con oltre 2,3 milioni ciascuna, le diaspore romena e turca sono le più numerose nell’Unione. Il terzo gruppo è rappresentato da 1,9 milioni di marocchini, seguiti da 1,6 milioni di polacchi.
Italia, Regno Unito e Germania sono importanti sia come paesi di destinazione che come origine dei flussi (vedi figura 3.5.5.). Ciò si spiega sia con le elevate popolazioni totali sia con l’accresciuta mobi-lità all’interno dei confini dell’Ue.
Nel complesso, se il periodo seguito agli allargamenti dell’Unione Europea del 2004 e del 2007 ha visto un notevole incremento nelle migrazioni dai paesi dell’Europa Orientale verso quelli dell’Europa Occidentale, la crisi economica ha portato a un temporaneo declino nelle migrazioni per lavoro da Est verso Ovest.
16 Dato che la cittadinanza può cambiare nel tempo va considerato pure il numero dei nati all’estero residenti nell’Ue. Eurostat calcola quasi 49 milioni, pari al 9,7% della popolazione totale per il 2011. Di questi 32,4 milioni sono nati in uno stato extra-Ue, e 16,5 milioni in un altro stato membro.
Tabella 3.5.1 - La presenza dei cittadini stranieri nei primi dieci stati dell’Ue27 tra 2003 e 2012
Fonte: Eurostat.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Germania 7.347.951 7.341.820 7.287.980 7.289.149 7.255.949 7.255.395 7.185.921 7.130.919 7.198.946 7.409.754
Spagna 2.189.213 2.771.962 3.371.394 4.002.509 4.606.474 5.262.095 5.650.968 5.663.525 5.654.630 5.562.067
Italia 1.549.373 1.990.159 2.402.157 2.670.514 2.938.922 3.432.651 3.891.295 4.235.059 4.570.317 4.825.573
Regno Unito 2.760.031 2.941.400 3.066.055 3.425.000 3.659.900 4.020.800 4.184.106 4.362.174 4.486.644 4.802.331
Francia 3.263.186 NA 3.623.063 3.510.000 3.650.100 3.674.000 3.783.308 3.769.016 3.824.828 3.858.295
Belgio 850.077 860.287 870.862 900.473 932.161 971.448 1.009.055 1.052.844 1.162.608 1.224.904
Grecia NA 891.197 NA 884.000 887.600 906.400 929.530 954.784 956.007 975.374
Austria 746.753 754.216 774.401 796.666 804.779 835.182 864.397 876.355 907.407 947.717
Paesi Bassi 699.954 702.185 699.351 691.357 681.932 688.375 637.136 652.188 673.235 697.741
Svezia 474.099 476.076 481.141 479.899 491.996 524.488 547.664 590.475 622.275 646.095
Fonte: Eurostat.
Tabella 3.5.2 - Popolazione totale, popolazione straniera, extraeuropea e Ue negli stati Ue-15 al 2011 (in migliaia)
Popolaz. totale
Stranieri % del totale
ExtraUE
% del totale
Cittadini UE
% del totale
EU-27 502.510 33.306 6,6 20.501 4,1 12.805 2,5
EU-15 399.422 31.600 7,9 19.275 4,8 12.325 3,1
Germania 81.752 7.199 8,8 4.571 5,6 2.628 3,2
Spagna 46.153 5.655 12,3 3.326 7,2 2.329 5,0
Francia 65.048 3.825 5,9 2.485 3,8 1.340 2,1
Regno Unito 62.499 4.487 7,2 2.426 3,9 2.061 3,3
Italia 60.626 4.570 7,5 2.235 5,3% 1.335 2,2
Grecia 11.310 956 8,5 803 7,1 153 1,4
Austria 8.396 907 10,8 555 6,6 352 4,2
Belgio 11.001 1.163 10,6 414 3,8 749 6,8
Svezia 9.416 622 6,6 352 3,7 270 2,9
Portogallo 10.637 448 4,2 345 3,2 103 1,0
Paesi Bassi 16.656 673 4,0 338 2,0 335 4,2
Danimarca 5.561 346 6,2 221 4,0 125 2,2
Finlandia 5.375 167 3,1 106 2,0 61 1,1
Irlanda 4.481 362 8,1 70 1,6 292 6,5
Lussemburgo 512 221 43,2 30 5,9 191 37,3
Figura 3.5.4 - Presenza straniera nei principali stati europei
Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Eurostat.
BelgioFranciaRegno UnitoItaliaSpagnaGermania
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
200920082007200620042003 2005 2010 20122011
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 13 12
A questa fase è seguito poi un incremento delle migrazioni da al-cuni dei Paesi colpiti dalla crisi verso quelli più prosperi, fenomeno che pare rispondere alle mutate condizioni economiche. Nel periodo successivo all’allargamento dell’Ue sono emersi due corridoi per la mobilità europea: uno relativo ai flussi da Polonia e repubbliche bal-tiche verso Regno Unito e Irlanda, e uno relativo ai flussi da Romania e Bulgaria verso Spagna e Italia17.
Tuttavia le migrazioni intra-comunitarie per lavoro sono state lar-gamente influenzate dalle restrizioni decretate nei confronti dei nuo-vi Stati Membri: quelle imposte per sette anni ai lavoratori romeni e bulgari nel 2007 in nove Stati Membri, cesseranno dal 2014. Le restri-zioni per i paesi Ue8 (i nuovi Stati entrati nel 2004, salvo Cipro e Mal-ta) sono già state rimosse nel maggio 2011, così il numero di cittadini Ue8 in Germania è aumentato del 46% tra aprile 2011 e 2012.
Se la capacità di attrarre cittadini stranieri fosse un indicatore di-retto della crisi economica, in Italia, Regno Unito, Belgio, Grecia, Au-stria, Svezia, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Slovenia e Slovac-chia, la crisi non dovrebbe esserci stata, dato che la presenza straniera
17 Eu, Dg Employment, Mobility in Europe 2011, Brussels: DG Employment, 2011.
è continuata ad aumentare, pur con un rallentamento degli arrivi do-vuto a politiche più restrittive (vedi box 3.5.1).
* Sia pure con valori molto diversi negli stati membri: Spagna al 27%, Italia al 12%, Germania al 5%.
Così, nonostante esista una relazione tra l’andamento del mercato del lavoro e la presenza di cittadini stranieri, nel complesso l’Ue resta una destinazione globale ambita.
Box 3.5.1 - Attitudini e Politiche Europee verso l’immigrazione
La normativa relativa all’ingresso di stranieri è divenuta assai più restrittiva nella maggior parte degli Stati Membri, oltre che in Svizzera. L’aumento della disoccu-pazione, che nell’Eurozona era in media del 12,1% al 30 aprile 2013 ha contribuito in molti casi ad alimentare tensioni nel mercato del lavoro tra nativi e nuovi arriva-ti*. La questione resta molto calda politicamente e periodicamente viene cavalcata a fini elettorali, a prescindere dal fatto che la presenza di stranieri serve a colmare scarsità di manodopera in diversi comparti dell’economia, e che in l’invecchiamen-to demografico in molti stati europei, dalla Germania, all’Italia alla Grecia, è un problema strutturale.Nonostante le differenze, in alcuni casi notevoli, sia sul piano demografico sia su quello economico, Danimarca, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Croa-zia sono accomunati dal fatto di considerare l’immigrazione eccessiva. Nell’ultimo decennio l’aumento degli stranieri è stato particolarmente marcato in Spagna, Re-gno Unito e Italia. A parte il Lussemburgo (43,2%), in Spagna i cittadini stranieri rappresentano oltre 12% della popolazione, in Austria e Belgio oltre il 10%, in Ger-mania l’8,8, in Grecia l’8,5%, in Irlanda l’8%, in Italia il 7,5%, nel Regno Unito il 7,2%, in Svezia e Danimarca oltre il 6%, in Francia il 5,9%. In valori assoluti i cinque stati più popolati dell’Ue sono anche quelli che detengono le maggiori quote di stranieri: in Germania 7,4 milioni, in Spagna 5,5 milioni, nel Regno Unito e in Italia 4,8 milioni ciascuna, in Francia 3,8 milioni.Non tutti gli Stati Membri vedono i migranti allo stesso modo: in Svezia, Austria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria e Russia l’immigrazione è considerata infatti troppo bassa. Oltre che in questi paesi, la domanda di lavoratori stranieri è avvertita anche in Finlandia, Polonia, Bielorussia e Ucraina, al punto da aver spinto i rispettivi governi ad avviare politiche per aumentare l’immigrazione. Politiche a favore dei ricongiungimenti familiari sono state adottate in Polonia, Ungheria, Serbia, Bie-lorussia, Lettonia e Lituania, mentre Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Norvegia, Francia, Paesi Bassi e Spagna vorrebbero ridurli.Caso a parte è poi quello dell’immigrazione di lavoratori capaci o high-skilled: si tratta di migranti che hanno compiuto studi terziari, parlano le lingue, sono por-tatori di capacità professionali specifiche: tutti gli Stati Membri ne vorrebbero un maggior numero, con le sole eccezioni di Regno Unito (sempre sull’onda delle re-centi politiche di riduzione dell’immigrazione) e Serbia.
Figura 3.5.5 - Flussi in entrata nei principali paesi destinazione dell’Ue27
Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Eurostat.
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
2011201020092008
Francia
Italia
Spagna
GermaniaRegno Unito
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 15 14
nuito nello stesso periodo.
Sia i greci, sia i cittadini Ue che erano in Grecia, hanno generato
Un recente rapporto prova ad articolare i principali cambiamenti nella mobilità all’interno dell’Unione Europea18.
Pur con storie molto diverse quanto a migrazioni, vi sono alcune somiglianze tra Regno Unito e Germania da un lato, e Austria e Irlan-da dall’altro, quanto a presenza di cittadini Ue12.
Austria e Irlanda hanno valori assoluti bassi, ma quote più elevate sul totale delle loro popolazioni; viceversa, Regno Unito e Germa-nia hanno le quote più elevate in assoluto, che però rappresentano percentuali basse delle popolazioni totali. Il Regno Unito ha visto un significativo declino nei flussi Ue12 nel 2008-200919.
Tuttavia, tra 2007 e 2011 i cittadini Ue12 presenti nell’Ue15 sono passati da 2,8 a 4,2 milioni20. Lo stesso vale per i migranti provenienti da Paesi terzi: salvo una pausa nel 2010, sono ripresi a crescere dal 2011.
In Germania, sono aumentati i lavoratori provenienti dai paesi col-piti dalla crisi e dall’Europa Orientale (vedi figura 3.5.6).
Tra 2010 e 2011, l’immigrazione dalla Spagna è aumentata del 52% e quella dalla Grecia è aumentata del 90% (quasi 50mila persone). An-che le quote di romeni e bulgari sono in aumento, anticipando forse la fine degli accordi transitori prevista per il 2014, e poiché la Germania non richiede più un permesso di lavoro per gli stagionali provenienti da questi paesi.
In generale, i flussi in uscita dai Paesi più colpiti dalla crisi sono in crescita (vedi figura 3.5.7). Secondo Benton e Petrovic, i cittadini provenienti da Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo sono aumentati tra il 2008 e il 2011.
Per contro, il numero di nuovi arrivi da Romania e Polonia è dimi-
18 M. Benton, M. Petrovic, How Free is Free Movement. Dynamics and Drivers of Mobility within the European Union, Brussels: Migration Policy Institute Europe, 2013, p. 1.19 W. Somerville, M. Sumption, Immigration in the UK: the Recession and Beyond, Londra: Equality and Human Rights Commission.20 Valore riferito alla popolazione in età lavorativa proveniente da stati dell’Ue12 presente nei Paesi Ue15.
Figura 3.5.6 - Immigrazione in Germania da Stati sorgente significativi 1996-2011
Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Statistisches Bundesamt, Bevoelkerung und Erwerbstaetigkeit: Vorlaufige Wanderungsergebnisse 2011.
0
50.000
25.000
100.000
150.000
200.000Bulgaria
Romania
Ungheria
Polonia
Spagna
Grecia
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1998
1997
1996
175.000
125.000
75.000
1999
2000
2001
Figura 3.5.7 - Emigrazione di cittadini Ue dai paesi più colpiti dalla crisi, 2005-10
Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Eurostat, “Emigrazione per sesso, gruppo di età e cittadinanza”.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
201020092008200720062005
Portogallo
Italia
Spagna
Grecia
Irlanda
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 17 16
flussi in uscita soprattutto verso Germania, Australia e Turchia: da 22 a quasi 69mila tra 2008 e 2010, (+ 207%).
Nel 2012 sono aumentati pure i flussi dall’Irlanda verso altri paesi anglofoni come Gran Bretagna, Canada, Australia, Stati Uniti e Nuo-va Zelanda.
L’emigrazione dalla Spagna è passata da 70mila a quasi 120mila (+70%). Le destinazioni preferite sono Gran Bretagna, Francia e Ger-mania, tuttavia le statistiche del governo spagnolo indicano che l’Ue è mèta solo del 47% dell’emigrazione che ha origine dalla Spagna21. Mentre il Portogallo ha visto un aumento delle emigrazioni verso Francia e Brasile.
La crisi nella penisola iberica ha dato origine pure a flussi verso l’Africa, sia pure più modesti. Laureati portoghesi disoccupati sono partiti per i paesi lusofoni dell’Africa come Mozambico e Angola, con economie in crescita e domanda di lavoratori giovani e capaci22.
Già nel 2010, sono stati rilasciati 24mila visti per l’Angola, rispetto ai soli 156 del 2006. Rovesciando la tradizionale direzione tra Maroc-co e Spagna, il numero di spagnoli ufficialmente residenti in Marocco è quadruplicato tra il 2003 e il 201123.
Nonostante il Pil del Marocco sia un sesto di quello del paese ibe-rico, la forte disoccupazione in patria, il costo della vita molto più basso oltre Gibilterra, un tasso di cambio favorevole, la possibilità di entrare per tre mesi senza visto24 e la facilità di collegamenti tra Alge-ciras e Ceuta, sembrano contribuire a rendere il Marocco una land of opportunity per diversi spagnoli.
Va considerato poi il ruolo delle politiche favorevoli al rientro in patria degli emigrati.
Già nel 2007 il governo polacco ha introdotto un pacchetto di mi-
21 Il 10% di questa si è diretto nel Regno Unito, l’8% in Francia e solo il 6% in Germania.22 L. Ash, “Portugal’s jobless graduates flee to Africa and Brazil”, BBC News, 2011.23 Si stimano poi alcune decine di migliaia di spagnoli non registrati in Marocco.24 Il visto può essere rinnovato semplicemente mettendo piede nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla.
sure per il ritorno degli emigrati, in risposta alla crescente carenza di manodopera del mercato del lavoro. Nel 2012, i Campionati europei di calcio hanno prodotto un boom nell’edilizia e nell’ospitalità, favo-rendo il ritorno di un numero crescente di emigrati polacchi.
Anche il governo dell’Ecuador ha annunciato un piano per facili-tare il rientro in patria dei propri emigrati in Spagna con varie inizia-tive, tra le quali un’offerta di 20mila posti di lavoro. Secondo i servizi immigrazione, già 40mila ecuadoregni sono rientrati in patria con il piano e il governo prevede il rientro di altre 50mila emigrati. Gli ecua-doregni sono il secondo gruppo di stranieri in Spagna.
L’Italia
Nonostante la tendenza a trattare i paesi dell’Europa del Sud come un’area omogenea, la situazione dell’Italia rivela peculiarità proprie. Secondo l’Istat, al 1° gennaio 2012 gli stranieri presenti sul territorio nazionale erano stimati in circa 5 milioni25, dei quali 3,6 milioni gli extra-comunitari regolari.
Nondimeno, nel 2011 sono stati rilasciati 361.690 nuovi permessi di soggiorno, quasi il 40% in meno rispetto al 2010. Il saldo migratorio resta positivo: tra 2011 e 2012 il numero di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti è aumentato di circa 102mila unità, ben-ché tra 2005 e 2010 esso fosse in media di 330mila unità (con picchi di mezzo milione per anno nel 2007 e nel 2008).
In quattro anni, il numero di arrivi si è ridotto di oltre tre quarti ed è aumentata notevolmente la quantità di partenze. Gli stranieri cancellati per spostamento di residenza all’estero sono più che rad-doppiati tra 2007 e 2011 (passando da 14 a 32mila)26.
È interessante poi notare come nel 2011 oltre 11mila siano partiti dal Nord-Est (tra questi quasi 5mila dal Veneto e oltre 3.300 dall’Emilia-
25 Secondo i primi dati del censimento, come sempre accade, al 9 ottobre 2011 vi sarebbe uno scarto di quasi un milione di stranieri in meno rispetto a quelli risultanti dalle iscrizioni all’Anagrafe. Il numero degli stranieri in Italia al 31 dicembre 2011 sarebbe dunque di circa 4 milioni. Vedi: Istat, “Il censimento della popolazione straniera”, Roma, 2012.26 Il valore effettivo potrebbe essere notevolmente sottostimato dato che chi ritorna in patria o parte per un altro paese non ha alcun vantaggio a comunicare la propria partenza.
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 19 18
Romagna); altrettanti dal Nord-Ovest (7.600 dalla Lombardia); 6.700 hanno lasciato le regioni del Centro Italia e infine 3.300 il Sud e le Isole.
Nel Nord-Est, le autorizzazioni concesse tra il 2010 e il 2011 si sono dimezzate (da 170 a 83mila). I nuovi permessi rilasciati per motivi di lavoro sono crollati del 65%. Per la Fondazione Ismu, in Lombardia dieci immigrati su cento avrebbero dichiarato l’intenzione di trasfe-rirsi dall’Italia entro dodici mesi nel 2012.
Per la Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito (Rirva) del ministero dell’Interno vi è un aumento delle domande per l’ammis-sione al programma di rimpatrio volontario assistito.
Inoltre, l’Istat segnala in leggero aumento le migrazioni degli ita-liani verso l’estero, ma il saldo migratorio resta negativo27. Tra quan-ti sono partiti nel 2011 per Germania, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, la maggior parte è sopra i 24 anni di età. Aumenta il numero di laureati italiani che si trasferiscono in Germania.
LE DIASPORE AL LAVORO
L’analisi dei dati 2005-2012 relativi alle rimesse verso l’estero della Banca d’Italia28 da parte delle principali diaspore, mostra che nono-stante tutte abbiano risentito della crisi dal 2009, nella maggioranza dei casi, esse evidenziano importi complessivi per il 2012 superiori a quelli del periodo 2005-2008 (vedi tabella 3.5.3 e figura 3.5.8).
Le rimesse della diaspora cinese in Italia crescono ancora nel 2009 e, salvo un calo nel 2010, riprendono a crescere nei due anni succes-sivi, superando i 2,5 miliardi di euro inviati in patria (e oltre 13 mi-liardi inviati dal 2005). Nel 2012 quella cinese è l’unica diaspora le cui rimesse risultino ancora in crescita sull’anno precedente, con un importo quasi triplo rispetto al 2005.
27 Istat, “Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente”, Anno 2011, Statistiche Report, 28 dicembre 2012, Roma.28 Banca d’Italia, “Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia”, 4 aprile 2013, Roma.
Tabe
lla 3
.5.3
- R
imes
se d
all’I
talia
ver
so l’
este
ro (i
n do
llari
)
Font
e: B
anca
d’It
alia
201
3. S
egna
ti gl
i ann
i in
calo
risp
etto
all’a
nno
prec
eden
te.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cin
a94
7.54
070
0.51
01.
687.
560
1.50
4.23
01.
970.
780
1.74
0.72
02.
537.
080
2.67
4.45
7
Filip
pine
245.
440
519.
910
727.
930
922.
560
800.
750
743.
460
601.
590
366.
808
Bulg
aria
40.7
1047
.590
39.9
1012
9.66
043
.930
44.6
5042
.600
37.7
16
Rom
ania
652.
530
792.
530
789.
610
768.
490
823.
820
868.
610
894.
970
810.
948
Col
ombi
a14
7.37
094
.610
92.7
2010
2.25
010
1.20
098
.040
96.2
4083
.020
Mar
occo
244.
040
294.
800
339.
420
333.
030
279.
070
283.
540
299.
900
242.
509
Bang
lade
sh8.
610
108.
100
143.
080
180.
440
227.
970
221.
050
290.
490
228.
178
Sene
gal
157.
370
207.
860
252.
310
262.
780
235.
180
238.
910
245.
440
216.
264
Indi
a63
.050
101.
670
103.
080
140.
080
133.
340
133.
240
205.
650
198.
060
Bras
ile10
1.00
015
1.01
015
2.76
016
0.51
017
6.24
014
3.00
018
2.87
013
6.17
9
Peru
63.8
2011
2.64
012
7.91
015
9.01
019
2.23
019
1.39
019
4.02
018
7.65
4
Ecua
dor
94.0
9013
2.30
012
5.74
013
5.28
014
9.07
015
0.24
015
5.50
013
7.38
5
Ucr
aina
70.1
5090
.090
102.
050
110.
140
123.
120
148.
660
166.
390
138.
729
Alb
ania
119.
110
138.
570
143.
680
143.
220
133.
650
137.
370
131.
100
115.
716
Mol
dova
46
.080
53.9
5054
.570
53.5
8053
.240
78.1
5091
.680
75.0
26
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 21 20
Pur restando la quarta comunità di stranieri in Italia, il numero di cittadini cinesi è stimato in 277mila persone al 31 dicembre 2011, meno di un terzo rispetto alla diaspora romena, la più numerosa in Italia, che alla stessa data superava il milione di presenze.
Ma mentre dal 2005 le rimesse cinesi sono triplicate, quelle della diaspora romena, pur crescendo nel triennio 2009-2011, nel 2012 sono calate a un livello pre-2009. Eppure dal 2005 la presenza romena in Italia è più che triplicata, mentre quella cinese è solo raddoppiata o poco più.
Più rivelatore ancora è il confronto tra importi medi pro capite: se nel 2005 ogni cittadino cinese invia in patria in media circa 7.400 euro, che divengono oltre 9.100 euro nel 2011, per quanto riguarda i cittadini romeni, nel 2005 ciascuno invia in media meno di 2.200 euro, che nel 2011 scendono a 851 euro pro capite29.
29 È verosimile che, tenuto conto dei costi elevati delle transazioni, delle normative differenti per gli extracomunitari e delle rispettive distanze geografiche, la quota di rimesse in nero, che la diaspora cinese, e in generale quelle asiatiche, inviano attraverso cittadini che rientrino anche temporaneamente in patria, sia notevolmente inferiore a quella della diaspora romena, dato che Trieste e Timisoara distano tra loro poco più di 8 ore di automobile, tutte percorribili all’interno dell’Ue. Nondimeno anche prima della crisi, l’importo pro capite inviato in patria da ogni
Anche più spettacolare è la performance dei cittadini bengalesi. An-corché ben inferiore come importi totali (e presenza in Italia), la co-munità bengalese mostra una resilienza alla crisi superiore a quella cinese: se 41mila bengalesi in Italia nel 2005 riuscivano a inviare a casa in media poco più di 200 euro a persona, 106mila bengalesi nel 2011 hanno spedito oltre 2.700 euro a testa.
Le rimesse della diaspora filippina hanno subito un calo già dal 2008 e nel 2012 sono metà del 2007 in valori assoluti; il numero di cit-tadini filippini in Italia è comunque aumentato di oltre 60mila unità tra 2005 e 2011 e l’importo medio pro capite risulta pure aumentato dai 2.700 euro ai 3.900 euro inviati in patria.
Anche le rimesse della diaspora indiana, dopo un calo tra 2009 e 2010, nel 2012 sono più che triplicate come valori assoluti rispetto al 2005, a fronte di una presenza più che raddoppiata. L’importo pro capite è passato da 1.000 a 1.400 euro inviati tra 2005 e 2011.
Naturalmente, andrebbe considerato pure quanti stranieri risul-tino occupati e in quali settori. La comunità filippina, occupata nei servizi domestici in Italia, potrebbe aver resistito meglio di altre dia-spore impiegate in settori più colpiti dalla crisi come l’edilizia.
Tuttavia anche qui vi sono esempi di resilienza. Le rimesse della diaspora senegalese si sono ridotte in valori assoluti e nel 2012 sono scese a livelli pre-2007 (la presenza senegalese è aumentata di 30mila unità negli otto anni considerati), ma tra 2005 e 2011 l’importo medio inviato in Senegal è leggermente aumentato: da 2.755 a 2.811 euro a testa.
Tra i cittadini non-Ue, la comunità del Marocco, seconda per nu-mero di presenze in Italia, ha più risentito della crisi: le rimesse calano nel 2008-2009, riprendono nei due anni seguenti, e nel 2012 scendono sotto ai livelli 2005, pur con 186mila cittadini in più, mentre l’importo medio pro capite scende da 760 a 592 euro a testa inviati in patria.
Ciò potrebbe spiegarsi sia con il maggiore stress dei settori di oc-cupazione di questa diaspora, sia con il fatto che, essendo più antica,
cinese in Italia era più del triplo rispetto a quello del singolo cittadino romeno.
Figura 3.5.8 - Rimesse in patria da parte di cittadini stranieri presenti in Italia 2005-2012
Fonte: Elaborazione dell’autore su dati BankItalia 2013.
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
20122011201020092008200720062005
Senegal
MaroccoBangladesh
FilippineRomaniaCina
Nomos & Khaos Migrazioni internazionali e crisi economica 23 22
terze generazioni.
Negli Stati Uniti, di tutti gli europei giunti tra il 1880 e il 1920, i peggiori risultati li hanno fatti registrare i migranti di origine inglese (non gallesi, scozzesi o irlandesi), gli unici che, oltre a parlare già la lingua, non si sono dovuti insediare in enclave etniche o nei ghetti urbani, incontrando meno difficoltà a trovare lavoro e ad assimilarsi.
Le minori difficoltà incontrate di fronte ai tipici ostacoli del lavo-ratore migrante sono dunque responsabili di risultati economici più scarsi sul lungo periodo33. Eppure, secondo Rodriguez-Pasé, le orde di giovani migranti poveri e privi di educazione arrivati negli Stati Uniti alla ricerca di una vita migliore, nonostante le difficoltà di assi-milazione, sono proprio quelle che alla distanza hanno dato i risultati migliori.
Curiosamente, questo è esattamente il tipo di immigrazione che nessuno vuole e contro la quale molti governi europei stanno erigen-do ulteriori barriere. Se la resilienza dei migranti alla crisi non va so-pravvalutata, le politiche di chiusura verso gli stranieri rischiano di rivelarsi costose sul medio-lungo periodo, soprattutto per quei Paesi come l’Italia che sperimentano una riduzione della popolazione in età lavorativa.
33 A. Rodriguez-Pasé, V. Berlepsch, “European Migration and Long-Term Economic Development”, Association of American Geographers (Aag) Annual Meeting, 2013.
i legami con la madre patria potrebbero risultare indeboliti in tempo di crisi.
RESILIENZA ALLA CRISI
Tenuto conto pure del contributo in imprenditorialità di molti mi-granti, la presenza di stranieri è un fattore positivo per l’economia e il suo dinamismo30, oltre che sul piano della crescita culturale e su quel-lo dell’innovazione tecnologica. E l’analisi dei dati sulle rimesse verso l’estero mostra come, nonostante la crisi sia risentita, siano le motiva-zioni a fare la differenza, spesso tanto più forti, quanto maggiori sono le difficoltà che il migrante si trova ad affrontare.
Per questo, ad eccezione di romeni e marocchini, le altre diaspore considerate sono riuscite ad aumentare le quote pro capite delle pro-prie rimesse. Questo dimostra non solo la resilienza della maggior parte dei migranti di fronte alla crisi economica, ma pure il fatto che tale motivazione incide positivamente sulla qualità del lavoro.
Ad esempio, le associazioni di piccoli e medi imprenditori britan-nici, per opporsi alle rigide restrizioni di recente introdotte da quel governo alle migrazioni internazionali, non solo hanno esplicitamen-te sottolineato la domanda degli stranieri per colmare la scarsità di manodopera in molti settori, ma ne hanno affermato la migliore affi-dabilità ed etica professionale rispetto a molti lavoratori nativi31.
Anche tali elementi concorrono al contributo positivo della pre-senza di lavoratori stranieri per l’economia di un paese. Inoltre, non è possibile valutare quest’ultimo32, senza adottare una prospettiva di lungo periodo.
Lo studio delle relazioni tra sviluppo economico e migrazioni ri-chiederebbe infatti di analizzare i risultati economici delle seconde e
30 B. Ghosh, The Global Economic Crisis and Migration. Where do we go from here?, Ginevra: International Organization for Migration, 2011.31 U. C. Davis, UK: Migrants, Migration News, aprile 2013, vol. 20 n.2.32 H. De Haas, “Migration and development: a theoretical perspective”, International Migration Review, 2010, vol. 44 (1).