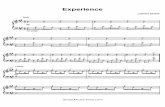"Explaining Europe to Americans and America to Europeans": Mario Einaudi e gli studi politici...
Transcript of "Explaining Europe to Americans and America to Europeans": Mario Einaudi e gli studi politici...
409
A R G O M E N T I
«Explaining Europe to Americans and America to Europeans»Mario Einaudi e gli studi politici internazionali nel secondo dopoguerra
Andrea Mariuzzo
Nell’ultimo quindicennio hanno conosciuto un grande sviluppo gli studi sul ruolo che le grandi fondazioni culturali americane (soprattutto le fondazioni Carnegie, Rockefeller e, dopo la Seconda guerra mondiale, Ford) hanno svolto nello sviluppo internazionale delle scienze, e in particolare degli studi sociali nel XX secolo. Su-perando la tradizionale interpretazione, eccessivamente appiattita sull’uso politico della cultura accademica, che vedeva in questi istituti il «braccio» privato di una rete di attività finalizzate al consolidamento dell’egemonia americana sul mondo dell’alta cultura1, gli sforzi di alcuni gruppi di studiosi2 hanno contribuito a gettare le basi per una dimensione analitica più complessa e suggestiva. L’attenzione si è spostata sulle dinamiche socio-istituzionali del mondo intellettuale e accademico, e in questo qua-dro le relazioni e gli interscambi tra studiosi si sono potuti definire nella loro natura di transfer culturali tra diverse esperienze e realtà sociali, al di fuori dell’esclusiva logica degli interessi politici della public diplomacy di Washington.
Fino a tempi recenti la concentrazione sulle fonti di natura istituzionale ha con-dotto a privilegiare una attenta ricostruzione delle pratiche di fund raising e di ge-
1 Un classico riferimento per questa interpretazione è E.H. Berman, The Influence of Carnegie, Ford, and Rockefeller Foundations on American Foreign Policy. The Ideology of Philanthropy, Albany, State University of New York Press, 1983, ma un lavoro più recente su questa linea è I. Parmar, Foundation of the Ameri-can Century. The Ford, Carnegie, and Rockefeller Foundations in the Rise of American Power, New York, Columbia University Press, 2011.2 Mi riferisco soprattutto a volumi come: G. Gemelli (ed.), The Ford Foundation and Europe (1950s-1970s). Cross-Fertilization of Learning in Social Science and Management, Brussels, Pie, 1998; G. Gemelli, J.F. Picard, W.H. Schneider (eds.), Managing Medical Research in Europe. The Role of the Rockefeller Founda-tion (1920s-1950s), Bologna, Clueb, 1999; G. Gemelli, R. Macleod (eds.), American Foundations in Europe. Grant-Giving Policies, Cultural Diplomacy and Trans-Atlantic Relations, 1920-1980, Brussels, P. Lang, 2003; L. Tournès (sous la direction de), L’argent de l’influence. Les fondations américaines et leurs réseaux euro-péens, Paris, Autrement, 2010.
Contemporanea / a. XVI, n. 3, luglio-settembre 2013
410
stione delle risorse economiche e umane nei progetti. È rimasto troppo spesso sullo sfondo un elemento centrale per offrire quella «storia sociale delle scienze sociali» che una delle studiose più attive nel campo, Giuliana Gemelli, ha giustamente individuato come obiettivo primario di questo campo di studi3: la relazione tra la mobilità interna-zionale di individui e progetti e lo sviluppo di contenuti, metodi e approcci nelle varie discipline. Il recente studio di Ludovic Tournès, Sciences de l’homme et politique4, si è proposto di riportare al centro dell’attenzione questa dimensione almeno per il caso francese. Lungi dal semplificare il quadro nella descrizione di una mera «americaniz-zazione» delle scienze sociali europee, l’autore evidenzia come gli scambi culturali abbiano piuttosto consentito una vera e propria «negoziazione» dell’approccio scien-tifico allo studio della società: da un lato, i modelli di organizzazione della ricerca e i nuovi metodi di lavoro proposti dagli Usa si confrontarono e si ibridarono con sistemi accademici già consolidati; dall’altro, il trasferimento di competenze non fu a senso unico perché, nonostante l’ormai acquisita centralità americana nel mondo della pro-duzione e della circolazione della conoscenza, gli intellettuali europei furono in grado di offrire un vivace contributo di cui si tenne conto oltreoceano. Il risultato, quindi, non è stato la diffusione senza ostacoli del modo americano di concepire le scienze sociali, intriso di pragmatismo e di ricerca di applicazioni empiriche, che nel corso del Novecento le fondazioni intellettuali statunitensi avevano fatto proprio e proposto al mondo come possibile strumento di soluzione ai problemi e alle tensioni della vita collettiva. Si può parlare, caso mai, della formazione di una comunità scientifica più chiaramente «denazionalizzata»5 rispetto agli anni precedenti al 1945, ma nella quale gli «Atlantic crossings»6 continuavano a proporsi in entrambe le direzioni.
Per comprendere meglio questo processo nello sviluppo delle discipline, si è rive-lato fruttuoso il tentativo d’insistere sulla ricostruzione dell’evoluzione culturale e di-sciplinare di singole figure e di piccoli gruppi di lavoro, trovando nelle loro specificità la chiave per comprenderne concretamente ritmi e direttrici di sviluppo. In questo senso, la biografia o la «stretta» prosopografia diventano la chiave per entrare in un insieme di contesti di scambio intellettuale e per valutarli in termini meno generici e più chiaramente legati al loro reale funzionamento. Il presente saggio intende offrire un contributo a questo filone di studi, prendendo in considerazione una biografia intellettuale assai significativa per questo insieme di processi, quella di Mario Ei-
3 Cfr. Le élites della competenza. Scienziati sociali, istituzioni e cultura della democrazia industriale in Francia (1880-1945), Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 11 ss.4 Sciences de l’homme et politique. Les fondations philanthropiques américaines en France au XXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2011.5 Per una definizione del concetto, cfr. i contributi in E. Crawford et al. (eds.), Denationalizing Science. The Contexts of International Scientific Practice, Dordrecht, Kluwer, 1993.6 L’espressione è mutuata da D.T. Rodgers, Atlantic Crossings. Social Politics in a Progressive Age, Cam-bridge (MA), Harvard University Press, 2000.
411
naudi7. Le ragioni per la scelta di questo caso di studio non risiedono solo nel carat-tere internazionale della sua carriera scientifica, che pure giocò un ruolo rilevante nella sua influenza sulla vita degli studi; con Einaudi, infatti, si potranno ridiscutere le linee evolutive di un settore degli studi sociali, quello della scienza politica, in cui tradizionalmente l’influenza mondiale delle metodologie e degli approcci americani è apparsa più profonda e di maggior successo.
Un mediatore culturale tra Europa e Stati Uniti
Figlio primogenito di Luigi, laureatosi in giurisprudenza a Torino nel 1927 con Gioele Solari, discutendo una tesi su Edmund Burke, Mario Einaudi si era orientato precocemente verso la carriera accademica. Nel 1933, però, aveva dovuto abbando-nare l’idea di trovare sistemazione in Italia a causa del suo rifiuto di richiedere la tessera del Pnf. Le relazioni maturate durante il suo periodo di ricerca negli Usa tra il 1927 e il 1929 – quando fu tra i primi italiani a ottenere una fellowship del Laura Spelman Rockefeller Memorial per studiare i poteri della Corte suprema – e il ruolo di adviser europeo che il padre svolgeva da anni per la Rockefeller Foundation8 – or-ganizzazione che più di ogni altra si spese negli anni Trenta per dare rifugio agli intellettuali esuli dall’Europa dei totalitarismi9 – gli furono di aiuto per trovare una collocazione prima come instructor a Harvard, poi come professore a Fordham e infine, dal 1945, a Cornell.
Il consolidamento della posizione accademica di Einaudi negli Usa, con la pro-mozione nel giro di pochi anni da assistant a full professor presso l’ateneo di Ithaca, avvenne non casualmente nel periodo della Seconda guerra mondiale, quando lo stu-dioso, ottenuta nel 1941 la cittadinanza statunitense, collaborò con le autorità militari della sua nuova patria come esperto di questioni linguistiche, istituzionali e culturali italiane. Tra l’inizio del 1943 e la fine del conflitto, Einaudi fu istruttore dei futuri
7 La scarsa conoscenza della figura di Mario Einaudi presso il pubblico italiano si deve soprattutto al fatto che i suoi lavori più maturi dell’analisi della politica europea siano stati pubblicati esclusivamente in lingua inglese e siano circolati prevalentemente negli Stati Uniti. La mancanza dei suoi principali scritti politici in italiano è stata recentemente colmata dall’antologia, da me curata e introdotta, Mario Einaudi. Scritti sulla politica europea (1944-1958), Firenze, Olschki, 2013. Tra i riferimenti generali sul suo pensiero e sulla sua attività di studioso, si ricordano soprattutto i due volumi celebrativi che le istituzioni a cui è stato più legato gli hanno dedicato: P.J. Katzenstein, T. Lowi, S. Tarrow (eds.), Comparative Theory and Political Experience: Mario Einaudi and the Liberal Tradition, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1990, e M. Vaudagna (a cura di), Mario Einaudi (1904-1994) intellettuale storico ed organizzatore culturale tra America ed Europa, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1995.8 Per ulteriori informazioni cfr. G. Gemelli, Un imprenditore scientifico e le sue reti di relazioni internazio-nali. Luigi Einaudi, la Fondazione Rockefeller e la professionalizzazione della ricerca economica in Italia, «Le Carte e la Storia», 1995, 1.9 Sui progetti di accoglienza di docenti in un corso di studi dottorali in scienze sociali messi a punto con finanziamento Rockefeller cfr. K.D. Krohn, Intellectuals in exile. Refugee scholars and the New School for Social Research, Amherst, The University of Massachusetts Press, 1993.
412
funzionari di occupazione della penisola nell’ambito dell’Army Specialized Training Program10, e realizzò alcuni contributi per l’Economic and Financial Group del pro-getto War and Peace Studies, forse il principale programma di sviluppo conoscitivo della situazione internazionale volto alla soddisfazione delle necessità operative del dipartimento di Stato, coordinato dal Council on Foreign Relations11. Tra il maggio e l’ottobre di quell’anno, infatti, il docente venne messo in contatto dai vertici della Rockefeller, principale finanziatrice del Council, col prestigioso gruppo di studi in-ternazionali newyorkese che raccoglieva intellettuali, amministratori, politici e di-plomatici; partecipò ad alcuni incontri sull’Italia e redasse una relazione sui grandi problemi sul tappeto per la ricostruzione dell’Italia dopo il fascismo12.
Nel corso di questa esperienza di collaborazione con gli uffici governativi, Einaudi modificò sensibilmente i suoi interessi di ricerca. Se infatti, fino a tutti gli anni Trenta, le sue pubblicazioni scientifiche avevano avuto una chiara matrice storica e si erano concentrate sul pensiero politico e giuridico settecentesco, proprio gli studi compiuti per l’elaborazione delle informazioni relative all’Italia in guerra concentrarono la sua attività sul funzionamento dei sistemi politici contemporanei in modo sostan-zialmente definitivo. In particolare, la frequentazione via via più assidua del Council on Foreign Relations rese possibile a Einaudi un confronto diretto con le origini e il consolidamento degli area studies, il prodotto intellettuale più maturo della guerra mondiale negli studi politici internazionali13.
Dall’inizio degli anni Quaranta lo sviluppo di tecniche e approcci multidisciplinari per la comparazione di realtà locali e nazionali differenti, con il sostanziale superamento della classica «divisione del lavoro» nelle scienze sociali attraverso il ripensamento
10 Per ulteriori informazioni cfr. L.E. Keefer, Scholars in Foxholes: The Story of the Army Specialized Trai-ning Program in World War II, Jefferson (NC), McFarland & Co., 1988.11 Per alcuni riferimenti generali, cfr. M. Wala, The Council on Foreign Relations and American Foreign Policy in the Early Cold War, Providence-Oxford, Berghahn Books, 1994, e P. Grose, Continuing the Inquiry. The Council on Foreign Relations from 1921 to 1996, New York, Council on Foreign Relations, 1996.12 Il 25 maggio 1943 Mario Einaudi partecipò al quarantaquattresimo incontro dell’Economic and Finan-cial Group della squadra di lavoro per i War and Peace Studies, dedicato al caso italiano. In tale sede gli venne commissionata la stesura di un dettagliato memorandum sull’Italia. Una prima redazione del lavoro venne consegnata col titolo Postwar Italy: Economic and Political Problems, significativamente il 10 luglio 1943, giorno dello sbarco alleato in Sicilia. Il verbale dell’incontro di maggio e il testo della relazione sono conservati presso la Seeley G. Mudd Library di Princeton, Council on Foreign Relations Records, «Studies of the American Interests in the War and the Peace», Printed Studies, b. 1, contrassegnati rispettivamente dai numeri di serie E-A44 ed E-C11. Nel 1944 i materiali, prima riservati, poterono essere ripresi per la stesura di alcuni articoli di riflessione critica sugli sviluppi politici nell’Italia libera nei mesi successivi all’occupa-zione americana, anche attraverso l’integrazione di alcune informazioni filtrate successivamente dall’Eu-ropa, specialmente The Economic Reconstruction of Italy, «Foreign Affairs», 1944, 2, e Political Issues and Alignments in Italy Today, «The Review of Politics», 1944, 4.13 Per una presentazione generale dei problemi relativi a natura e sviluppi degli studi d’area cfr. soprattutto l’ottimo D.L. Szanton, Introduction. The Origin, Nature, and Challenges of Area Studies in The United States, in Id. (ed.), The Politics of Knowledge. Area Studies and the Disciplines, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 2004.
413
delle soluzioni interpretative generaliste sulla base dei problemi di comprensione delle concrete realtà sociali ed etnografiche, trovò una fondamentale spinta istituzionale e finanziaria nelle esigenze di immediata applicazione delle conoscenze teoriche ai reali problemi incontrati dalle autorità militari e civili americane sui fronti della guerra e dell’occupazione militare. Così gli ambienti d’incontro e di cooperazione più stretta tra esponenti del mondo degli studi e funzionari, tra cui quel Council che rappresentava fin dalla sua fondazione il miglior prototipo di questo genere di contaminazioni di in-teressi, divennero l’ambiente d’incubazione di un nuovo atteggiamento conoscitivo verso il mondo extra-americano destinato a consolidarsi negli anni successivi. Il man-tenimento del ruolo di potenza globale degli Usa nel dopoguerra e il quasi immediato riacutizzarsi delle tensioni della Guerra fredda, che richiesero di nuovo un impegno di-retto del governo di Washington al di fuori dei propri confini, garantirono anche dopo il 1945 la possibilità di ulteriore spazio nel dibattito intellettuale e il sostegno sul piano politico e istituzionale per questo tipo di studi. Questo finì per imporre una graduale riforma di alcuni settori dell’organizzazione della vita degli studi all’interno delle sedi universitarie, con la fioritura, accanto ai dipartimenti suddivisi secondo la distinzione delle discipline tradizionali, di istituti che riunivano esperti dalle provenienze più varie ed esperti di singole aree geografiche. Si trattava di strutture meno convenzionali ma sicuramente adatte ad affrontare i problemi e i progetti di ricerca più facilmente finan-ziabili secondo le richieste avanzate dalle istituzioni pubbliche.
In questo contesto Einaudi trovò una propria precisa collocazione scientifica per gli anni della maturità. L’alto profilo che lo studioso raggiunse in questo campo di applicazione del sapere sociale venne dimostrato al meglio dall’attività di organiz-zazione culturale che lo vide protagonista negli anni a cavallo del 1960. Non solo fu importatore del modello del supporto privato alla ricerca sociale, con la creazione, nel 1964, della Fondazione Luigi Einaudi di Torino in memoria del padre da poco scomparso. Fu anche mediatore, insieme all’ex compagno di studi torinese Alessan-dro Passerin d’Entrèves (allora docente a Oxford), del finanziamento che negli anni 1957-1967 la fondazione Rockefeller accordò all’Istituto di scienze politiche di Torino per l’avvio di una serie di studi comparativi tra le varie realtà socio-politiche europee. Nel 1961, inoltre, Einaudi fu anche fondatore e primo direttore del Center for Inter-national Studies di Cornell, istituto di riferimento dell’ateneo per lo studio multidisci-plinare di tutte le realtà sociali extra-americane. Per il suo avvio ottenne dalla Ford Foundation uno dei più rilevanti finanziamenti per la promozione di programmi di studio integrati di natura politica, sociologica ed economica per le aree del sud-est asiatico e dell’Africa della decolonizzazione14.
14 Su questi spunti, ancora in parte da chiarire nei loro specifici aspetti documentari cfr. per ora i riferi-menti in M.T. Silvestrini, La Fondazione Einaudi. Storia di una istituzione culturale, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 2002, pp. 72-80.
414
Meno chiaramente individuabile si è rivelata, finora, la contiguità delle princi-pali pubblicazioni scientifiche einaudiane agli studi d’area sul piano dei metodi. Il fatto che gli area studies si siano sviluppati, e siano oggi essenzialmente identificabili, come percorsi conoscitivi multidisciplinari ai problemi di aree geografiche e comu-nità nazionali diverse dai paesi di cultura occidentale rappresenta una differenzia-zione importante con le proposte di ricerca portate avanti dallo studioso di origine to-rinese, profondamente radicate per temi e problemi alla realtà socio-politica europea e volte a una comparazione euro-statunitense tutta interna alla realtà occidentale. È però vero che nel secondo dopoguerra Mario Einaudi trovò la sua dimensione nel dibattito culturale applicando alla realtà europea uno degli aspetti cruciali degli studi di area che aveva imparato a conoscere attraverso la sua assidua partecipazione a uno dei centri più attivi nella promozione di programmi di lavoro di conoscenza e informazione disciplinare sulle diverse realtà internazionali: il confronto profondo e argomentato tra contesti politici e istituzionali tra loro distanti che rendeva la compa-razione qualcosa di più della semplice giustapposizione descrittiva di realtà nazionali differenti. Egli intese insomma il ruolo di «mediatore culturale», che si trovò a svol-gere dopo il 1945 insieme a tanti émigré scholars riparati negli Usa dalla persecuzione totalitaria nel ventennio precedente, nell’ottica della ricerca di un quadro espositivo d’insieme delle diverse realtà dell’Europa continentale che consentisse al pubblico colto statunitense la comprensione dei caratteri peculiari di un’area strategica nello scenario politico globale, senza indebite assimilazioni con il più familiare contesto statunitense.
Einaudi iniziò ad affrontare in prima persona le questioni interpretative legate alla comparazione internazionale quando venne coinvolto, insieme a diversi altri studiosi di origine non americana emigrati negli Usa durante la guerra, nella preparazione di uno dei primi manuali universitari di politica comparata per gli studenti americani, il collettaneo Foreign Governments diretto dallo studioso di origine tedesca Fritz Mor-stein-Marx15. Nel corso della stesura della parte assegnatagli, in cui cercò di trattare i casi italiano e francese in un’unica sezione del volume, individuando attraverso la comparazione dei modelli costituzionali e dei provvedimenti di natura economica un’«area» europeo-continentale omogenea, Einaudi si pose problemi metodologici ed espositivi che solo negli anni Sessanta sarebbero stati considerati con altrettanta attenzione16. Successivamente, dal 1948 e fino alla metà degli anni Cinquanta, Ei-
15 Foreign Governments. The Dynamics of Politics Abroad, New York, Prentice-Hall, 1949.16 La complessa esposizione unitaria proposta da Einaudi, in effetti, sarebbe stata poi scartata dagli editori per le ristampe successive alla prima edizione, perché ritenuta inadeguata a un testo scolastico. Tuttavia, essa pose problemi interpretativi che un quindicennio dopo Gabriel A. Almond (allievo di Einaudi a un seminario presso la New School for Social Research di New York nel 1947-1948) e G. Bingham Powell jr. avrebbero affrontato per la loro rifondazione su basi meno descrittive e formalistiche degli studi politici comparati: Comparative Politics. A Developmental Approach, Boston, Little Brown, 1966. Per ulteriori rag-
415
naudi impostò su questi criteri la sua più matura esperienza di ricerca, la raccolta e l’elaborazione di informazioni e riflessioni di prima mano sulle realtà politiche postbelliche italiana e francese presentate nei volumi della French-Italian Inquiry. Fi-nanziata dalla Rockefeller Foundation al preciso scopo d’incrementare le conoscenze di prima mano su due nazioni europee la cui situazione socio-politica contempora-nea era relativamente poco conosciuta negli Usa anche agli addetti ai lavori, ma che con lo sviluppo del Piano Marshall avrebbero visto aumentare la loro importanza nella politica internazionale, l’Inquiry vedeva i suoi punti di forza proprio nell’uso di documentazione originale e nella collaborazione di giovani intellettuali, studiosi e pubblicisti italiani e francesi. L’attività dell’Inquiry si concretizzò nella pubblicazione dei volumi collettanei Communism in Western Europe (in cui oltre a Einaudi scris-sero Aldo Garosci e Jean-Marie Domenach), Christian Democracy in Italy and France (dove un saggio del curatore fu accompagnato da un lavoro di François Goguel sul Mouvement Républicain Populaire francese) e Nationalizations in France and Italy (per il quale Einaudi coinvolse Ernesto Rossi e l’economista Maurice Byé), oltre alla monografia interamente redatta da Goguel su France Under the Fourth Republic.
Gli studi che hanno preso in considerazione l’Inquiry hanno sottolineato soprat-tutto il suo tentativo di riproporre su basi in parte rinnovate l’atteggiamento «newde-alista» nel confronto socio-economico con il comunismo, in anni in cui nel dibattito americano stava maturando sempre più chiaramente un atteggiamento di natura strategico-militare nell’interpretazione delle tensioni della Guerra fredda17. Più dif-ficile si è invece rivelata un’esatta collocazione metodologica dell’opera coordinata da Einaudi nel dibattito scientifico, anche di fronte all’atteggiamento del suo ideatore e curatore, sempre restio a individuare e applicare rigidamente criteri analitici vin-colanti e precostituiti agli oggetti del suo studio18, soprattutto a causa della sua fred-dezza nei confronti delle pretese di neutralità e di oggettività scientifica avanzate dai più convinti cultori di quel behavioral approach che negli Usa degli anni Cinquanta godeva di grande considerazione19.
La possibilità di studiare la selezione dei «ferri del mestiere» per l’Inquiry è stata fa-cilitata dal ritrovamento, tra le carte personali di Einaudi, del paper inedito sulla natura dei sistemi di partito europei del dopoguerra, che egli presentò nel pieno della messa a
guagli, cfr. G. Loewenberg, The Influence of European Émigré Scholars on Comparative Politics. 1925-1965, «American Political Science Review», 2006, 4.17 Per questo mi permetto di rinviare, oltreché ai testi raccolti nei già citati volumi commemorativi pub-blicati da Cornell e dalla Fondazione Einaudi, al mio La riflessione sul comunismo nella French-Italian Inquiry di Mario Einaudi (1948-1955), «Storia e problemi contemporanei», 57, 2011.18 Cfr. P.P. Portinaro, Mario Einaudi e la scienza politica, in M. Vaudagna (a cura di) Mario Einaudi, cit., p. 105.19 Si vedano, ad esempio, brevi discorsi di ricordo da alcuni colleghi di Cornell alla funzione commemora-tiva per Mario Einaudi organizzata dalla sua università il 18 novembre 1994, poco dopo la sua morte, e rac-colti dall’Institute for European Studies. Si vedano in particolare le parole di Theodore Lowi, alle pp. 9-11.
416
punto dell’Inquiry, il 12 settembre 1953, al meeting annuale di Washington dell’Ameri-can Political Science Association (Apsa), nell’ambito del panel di teoria e metodologie degli studi politici su The Comparative Analysis of Political Parties organizzato dallo studioso di Stanford Alfred De Grazia20. Tale presentazione può essere considerata la migliore esplicitazione delle prospettive teoriche prese in considerazione da Mario Ei-naudi nella sua attività di ricerca. Con lo studio della sua redazione si può valutare quanto la frequentazione einaudiana del mondo degli area studies, contesto operativo caratterizzato da un approccio eclettico agli spunti metodologici elaborati dalle sin-gole discipline e dalla capacità di guardare alle proposte teoriche e interpretative ge-nerali degli studi politici e sociali come all’arsenale concettuale da cui selezionare gli strumenti più idonei per risolvere specifici problemi comparativi, abbia influito sull’a-nalytical framework della sua impresa scientifica più importante. Attraverso una sele-zione dei migliori riferimenti analitici e teorici generali maturati in un dibattito scienti-fico che ormai tendeva a varcare le frontiere nazionali Einaudi costruì infatti l’insieme delle griglie teoriche e delle definizioni più adeguate alla specifica analisi di quell’area geografica europeo-occidentale che costituiva l’oggetto fondamentale del suo interesse.
Il contesto: i dibattiti sulle nuove forme di associazione politica tra Europae Stati Uniti
Fin dal 1949, quando recandosi a Parigi per un’estate di lavoro sviluppò i suoi primi contatti con gli ambienti politologici francesi per il coinvolgimento di firme qualificate ai volumi della sua Inquiry, Mario Einaudi iniziò a seguire con interesse quel dibattito sulle dinamiche della vita politica che in Francia manteneva un ele-vato profilo scientifico-accademico grazie alla presenza nei ruoli universitari di so-ciologia e giurisprudenza di un buon numero di cultori di studi politici, raccolti fin dal 1945 nelle attività di organizzazione e finanziamento della Fondation Nationale des Sciences Politiques (Fnsp). Proprio in tale ambiente Einaudi avrebbe contattato e selezionato – attraverso i consigli di François Goguel – i collaboratori francesi per il suo lavoro21. Docente all’Institut d’Études Politiques (Iep) e fra i più autorevoli esperti francesi di dinamiche elettorali appartenenti alla generazione nata a inizio secolo, Goguel aveva accettato fin dai primissimi passi dell’Inquiry di aiutare Einaudi a muo-versi nello scenario francese.
Dalle loro corrispondenze si può avere idea delle curiosità e delle aspettative con
20 Il testo è conservato nel fascicolo contrassegnato dallo stesso titolo presso l’Archivio della Fondazione Luigi Einaudi, Torino [d’ora in poi: Tfe], Carte Mario Einaudi [d’ora in poi: Cme], sez. 1.i, fasc. «Social Realities» and the Study of Political Parties. Ulteriori informazioni sulla definizione del soggetto del paper, che già dalla proposta giunta a Einaudi nel febbraio 1953 doveva riguardare il mutamento della composi-zione sociale dei partiti, sono in Tfe, Cme, sez. 2-3, fasc. De Grazia Alfred. Colgo l’occasione per ringraziare l’ambasciatore Luigi R. Einaudi per avermi autorizzato a prendere visione delle carte personali del padre.21 Su di lui P. Benoist, François Goguel, haut fonctionnaire et politiste, Paris, Les Cahiers du Cevipof, 2009.
417
cui lo studioso di Cornell si avvicinò all’attività di un uomo destinato a diventare, per lui come per diverse generazioni di ricercatori, un termine di confronto ineludibile per la definizione di un approccio operativo allo studio delle dinamiche dei sistemi politici europeo-continentali: il poco più che trentenne professore di diritto costitu-zionale Maurice Duverger. Quando nel gennaio 1952 ricevette da Ithaca la richiesta di un parere per incaricare Duverger di scrivere un contributo sul sistema costitu-zionale francese della IV Repubblica da comparare con quello relativo alla nuova costituzione italiana già preparato da Giorgio Balladore Pallieri, Goguel rispose con parole che, se lette nella prospettiva di una valutazione di natura eminentemente pro-fessionale formulata da un collega più esperto e quotato, tratteggiavano in estrema sintesi sia l’interesse che suscitavano in Francia i lavori di Duverger sulla vita dei partiti, sia i dubbi metodologici e di orientamento sulle sue conclusioni, che Einaudi avrebbe finito per condividere:
Duverger a beaucoup de talent, mais deux défauts. Le premier est de travailler parfois trop vitement et trop superficiellement. [...] D’autant plus que, second défaut, il a un esprit extraor-dinairement systématique, qui le conduit parfois, pour l’amour de la symétrie intellectuelle, à fausser un peu la réalité qu’il décrit [...]22.
Ben presto Einaudi dovette comprendere che l’indicazione offertagli da Goguel non rappresentava soltanto il giudizio personale di uno studioso affermato su un più giovane collega emergente, di cui non si approvavano del tutto metodi di lavoro e conclusioni, in particolare quando iniziò a confrontarsi con l’impatto generato dalla pubblicazione, nel 1951, del lavoro destinato a diventare in breve tempo il maggior contributo teorico d’insieme dello studioso di Angoulême: Les partis politiques23. Nei primi mesi del 1952, in particolare, il professore di Cornell seguì la preparazione del paper di verifica che il venticinquenne Steven Muller, allora dottorando in Go-vernment e destinato a diventare suo collega non molti anni dopo, dedicò alle in-tuizioni di Duverger sul rapporto tra partiti e sistemi elettorali24. Fu così che ebbe
22 Tfe, Cme, sez. 2-3, fasc. Goguel François, F. Goguel a M. Einaudi, 31 gennaio 1952. A seguito dei suggeri-menti di Goguel, Einaudi contattò in prima battuta per la realizzazione del saggio Georges Vedel, docente di diritto pubblico all’Iep e considerato più affidabile nella qualità del lavoro. Solo nel luglio del 1953 Duverger avrebbe ricevuto la proposta, a seguito della rinuncia di Vedel. Anche Duverger, però, nel corso dell’estate avrebbe declinato l’invito, impedendo di fatto l’uscita di un volume della French-Italian Inquiry dedicato alla comparazione costituzionale. Cfr. i carteggi tra Einaudi e i due corrispondenti conservati nei rispettivi fascicoli in Tfe, Cme, sez. 2-3.23 M. Duverger, Les partis politiques, Paris, A. Colin, 1951. La traduzione italiana sarebbe stata pubblicata solo nel 1961 (I partiti politici, Milano, Edizioni di Comunità), sulla base della nuova edizione francese del 1958 che presentava alcuni aggiornamenti e modifiche rispetto a quella originaria. Di seguito, laddove non diversamente specificato, le indicazioni bibliografiche dei luoghi presi in considerazione riprendono quelli dell’edizione italiana del 1961, in seguito alla verifica dell’assenza di modifiche sostanziali tra le due versioni.24 Una copia dello scritto, intitolato Electoral Systems and Political Parties. An Essay on the Ideas of Maurice
418
modo di entrare in contatto con le principali prese di posizione immediatamente suscitate dalle proposte interpretative dello studioso di Angoulême, e poté dunque realizzare che un giudizio simile a quello di Goguel si leggeva in filigrana in tutti i numerosi interventi che in Francia, fin dai primi mesi dopo la pubblicazione di Les partis politiques, avevano messo in discussione l’impianto complessivo del contributo duvergeriano, riconoscendogli il valore dell’intuizione del ruolo cruciale dei partiti organizzati nel funzionamento delle istituzioni democratiche contemporanee, ma rimproverandogli l’eccessiva rigidità nelle tipizzazioni partitiche, la fretta di genera-lizzare le relazioni tra le diverse forze politiche nelle diverse arene di confronto, e un eccessivo determinismo nell’individuare i fattori dello sviluppo dei diversi modelli partitici individuati.
In generale, dal percorso di letture che il giovane Muller aveva concordato con Einaudi, si ricostruiva il dibattito politologico dell’area parigina in questi termini. Duverger aveva enunciato l’intuizione della relazione tra forme di elezione, tipologie di sistema partitico e organizzazione interna delle formazioni politiche principali già in un breve articolo su «La Vie Intellectuelle» del 194625. In quella circostanza, Duverger non si era limitato a individuare la tendenza significativa dei diversi si-stemi elettorali a influire sul numero di partiti nell’arena, ma anche quella a influire sull’organizzazione interna, con la rappresentanza proporzionale a scrutinio di lista solitamente accompagnata allo sviluppo di partiti fortemente organizzati a direzione gerarchica. La sua idea di base ebbe buon seguito nella Fnsp, fino a ispirare un vo-lume collettaneo dedicato alla questione uscito nel 195026. La pubblicazione di una monografia che cercava di presentare in questi termini tutte le principali dinamiche socio-politiche dei regimi democratici prestò però il fianco a critiche e puntualizza-zioni. Già nella prima grande occasione di confronto di Les partis politiques con il mondo degli studi, il lungo saggio di presentazione che Georges Vedel preparò per la «Revue Française de Science Politique», il recensore mise in evidenza come Duver-ger, nella sua attenzione ai «partiti-macchina», finisse troppo spesso per considerare questa dimensione d’indagine tutta interna allo sviluppo strutturale dei partiti come autosufficiente. Questo orientamento produceva carenze anche sul piano della con-cezione politica. Esso, infatti, portava a considerare come inevitabile, perché deter-minato essenzialmente da una loro «superiorità» nell’efficienza con cui istituivano relazioni col corpo sociale e con le istituzioni, il successo dei grandi partiti di massa
Duverger Concerning the Relationship between Them e concluso il 18 marzo 1952, è in Tfe, Cme, sez. 2-3, fasc. Muller Steven.25 M. Duverger, Les partis politiques et la démocratie, «La Vie Intellectuelle», 1946, 10. 26 Id., L’influence des systèmes electoraux sur la vie politique, Paris, A. Colin, 1950. Per una più recente ri-presa delle principali osservazioni sulla «legge di Duverger» e sulla sua importanza nella storia degli studi politici del XX secolo, cfr. W.H. Ricker, The Two-Party System and Duverger’s Law. A Essay on the History of Political Science, «American Political Science Review», 1982, 4.
419
organizzativamente strutturati che appariva evidente nell’Europa tra guerra e im-mediato dopoguerra. Di conseguenza, era anche inevitabile il carattere «oligarchico» della moderna democrazia di massa; l’unica soluzione era una regolamentazione della vita interna dei partiti, che di fatto sarebbe stata però demandata a essi stessi. Ancora di più, un atteggiamento del genere nascondeva possibili rischi sul piano teorico, perché portava a considerare in modo esclusivo per la determinazione della tipologia organizzativa fattori (il sistema elettorale e gli equilibri costituzionali) che invece esclusivi non erano27.
Era in effetti questo, almeno a grandi linee, lo stato dell’arte da cui stava prendendo le mosse il lavoro di revisione della proposta duvergeriana più approfondito di questa primissima stagione del dibattito: Partis politiques et réalités sociales, chiuso in tipo-grafia a fine 1952, scritto proprio da uno dei più stretti collaboratori dello studioso francese nella sua ricerca, Georges Lavau, e introdotto dallo stesso Duverger, che presentò il libro come un positivo contributo a chiarire in modo più dettagliato molti aspetti di un quadro complessivo che Les partis politiques aveva appena iniziato a mettere a punto28. In realtà, il lavoro di Lavau muoveva nella direzione opposta sul piano metodologico: esso infatti accoglieva molte delle osservazioni più puntuali e specifiche di Duverger su come i rapporti tra le forze politiche, i sistemi elettorali e le istituzioni influissero sulla forma-partito e sul funzionamento concreto del potere, inserendoli però in un piano analitico complessivo decisamente diverso, in cui entra-vano in gioco in modo assai più diretto le specificità sociali nazionali e comunitarie, in una lettura in cui diversi comportamenti politici erano ricollegati anche a cause storiche e culturali profonde. Muovendosi, assai più chiaramente di Duverger, nel solco della grande tradizione di studi di sociologia del comportamento elettorale e di etnografia politica che, con Siegfried e Goguel, aveva caratterizzato gli studi politolo-gici di scuola francese nei due decenni precedenti, Lavau destrutturava e contestava nella sostanza uno degli assunti duvergeriani nel contempo più affascinanti e proble-matici, ovvero la possibilità – quantomeno teorica – di replicare in diversi paesi un certo tipo di relazioni politiche, di forma-partito o di rendimento istituzionale attra-verso un processo di trasferimento mirato di «ingegneria» istituzionale ed elettorale.
Mentre si confrontava con i contributi attraverso i quali, in uno scambio vivace e a tratti anche aspro, i problemi sollevati da Duverger portavano i colleghi fran-cesi a dare sempre maggiore caratterizzazione ai tratti specifici dei sistemi politici
27 Cfr. G. Vedel, Les partis politiques ou l’école de la démocratie, «Revue Française de Science Politique», 1951, 4.28 G. Lavau, Partis politiques et réalités sociales. Contribution à une étude réaliste des partis politiques, Paris, A. Colin, 1953. Nato nel 1918, Lavau era più giovane di Duverger di un anno e, al momento della realizza-zione del libro, il suo primo lavoro di ampio respiro e destinato a buona diffusione, era da poco divenuto professore di diritto a Grenoble. Per ulteriori informazioni su di lui e sulla sua carriera, cfr. Idéologies, partis politiques et groupes sociaux. Études réunies par Yves Meny pour Georges Lavau, Paris, Puf, 1989.
420
occidentali contemporanei, Einaudi era sicuramente consapevole che alcune delle conclusioni proposte all’attenzione dei ricercatori dallo studioso di Angoulême si pre-stavano ad essere accolte con interesse quasi «in tempo reale» anche da numerosi altri lettori qualificati negli Stati Uniti.
Le reti di collaborazione con l’area parigina costituitesi attorno al docente di Cor-nell per la preparazione dell’Inquiry non rappresentavano un fenomeno isolato, ma si inserivano in un contesto di sempre più fitti contatti, incontri e occasioni di confronto tra le realtà americana e francese di studi politici. Probabilmente queste due realtà erano allora le più avanzate al mondo per il livello di rigore nel dibattito e di struttura-zione istituzionale, e sul piano degli strumenti di comunicazione scientifica, generati dallo sforzo di promozione di convegni e pubblicazioni internazionali portato avanti fin dai suoi primi anni di vita dall’Unesco e dalla partecipazione delle associazioni professionali di entrambi i paesi alla creazione, nel 1949, di una nuova società inter-nazionale per lo studio della scienza politica29. Inoltre, nel caso specifico della tratta-zione delle peculiarità del funzionamento della democrazia dei partiti, alcuni spunti sviluppati da Duverger nel 1951, pur essendo trattati in contesti molto diversi tra loro e attingendo a informazioni di natura eterogenea, conducevano a conclusioni simili a quelle elaborate autonomamente e presentate un decennio prima da una delle pie-tre miliari dello studio del sistema partitico americano, Party Government di Elmer E. Schattschneider. Il volume, pubblicato nel 1942, aveva ispirato potentemente il prosieguo della trattazione del problema dei partiti politici negli Usa. Nel dicembre del 1946, infatti, l’Apsa avrebbe incaricato un comitato di studio sui partiti politici, presieduto da Schattschneider in persona30, di riprendere il tema individuando un possibile percorso Toward a More Responsible Party System: così venne poi intito-lato il fascicolo monografico supplementare dell’«American Political Science Review» pubblicato con i risultati dello studio nel settembre 1950 e destinato ad alimentare un intenso dibattito negli anni successivi31. Anche i lettori più superficiali potevano ritro-
29 Il progressivo approfondimento dei rapporti franco-americani è documentato soprattutto da pubblica-zioni come il volume promosso dall’Unesco Contemporary Political Science. A Survey of Methods, Research and Teaching, Paris, Unesco, 1950 comprendente gli atti di un incontro internazionale tenuto a Parigi sullo stato della scienza politica nel mondo, e il volume collettaneo dei «Cahiers de la Fnsp» su Les «sciences de la politique» aux Etats-Unis, Paris, A. Colin, 1951.30 Gli altri membri del comitato erano Thomas S. Barclay, di Stanford; Clarence A. Berdahl, della Uni-versity of Illinois; Hugh A. Bone, della University of Washington; Franklin L. Burdette, della University of Maryland; Paul T. David, della Brookings Institution di Washington; Merle Fainsod, di Harvard; Bertram M. Gross, del Council of Economic Advisers; E. Allen Helms, della Ohio State University; John W. Lederle, della University of Michigan; Fritz Morstein Marx, della American University di Washington; Louise Ove-racker, del Wellesley College; Kirk H. Porter, della State University of Iowa; J.B. Shannon, della University of Kentucky; E.M. Kirkpatrick e Howard Penniman, del dipartimento di Stato.31 La risposta in questo senso destinata alla maggiore circolazione fu N.E. Long, Party Government and the United States, «The Journal of Politics», 1951, 2. I principali interventi suscitati dalla proposta del comitato del 1950 sono stati raccolti nell’antologia curata da H.A. Turner, Politics in the United States. Readings in Political Parties and Pressure Groups, New York, McGraw-Hill, 1955.
421
vare in Les partis politiques elementi che lo studioso statunitense aveva già applicato al caso americano, come il ruolo fondamentale del sistema elettorale maggioritario e della sua applicazione a tutti i livelli per spiegare il presentarsi e il mantenersi nel tempo del two-party system in tutte le competizioni locali, regionali e federali, e la sua capacità d’influenzare in modo quasi irreversibile le relazioni dei gruppi d’interesse e di pressione con i soggetti in competizione elettorale32. Queste contiguità avevano però cause più profonde, legate all’impianto dei due lavori. In entrambi i casi, infatti, il problema della presunta deriva «oligarchica» della forma-partito, sollevato a inizio secolo da Ostrogorski e Michels, era trattato come un dato ineliminabile della politica di massa contemporanea, e finanche come una opportunità di consolidamento delle forme democratiche33. Schattschneider, in particolare, notava a più riprese che i limiti spesso lamentati nella vita politica americana, specialmente la distanza tra l’effettiva elaborazione programmatica dei vertici dei partiti e la volontà espressa dagli elettori, fossero determinati non dalla burocratizzazione verticistica che avrebbe dovuto ac-compagnare il consolidamento istituzionale sul piano nazionale dei grandi partiti, ma dall’eccessivo potere mantenuto dai potentati locali, veri intermediari nella con-trattazione con gli interessi costituiti e veto players nella scelta delle candidature alle cariche e degli orientamenti istituzionali34.
Di fronte all’efficacia con cui Roosevelt aveva iniziato a far sentire il peso del pro-prio ampio consenso personale nell’imposizione di un programma esecutivo per quanto possibile univoco e coerente, Schattschneider proponeva una soluzione di lungo periodo alla volatilità del sistema politico americano che, in una certa misura, percorreva una strada che non sarebbe stata estranea alle più generali conclusioni di Duverger sullo sviluppo dei partiti di massa: la formazione nei due partiti principali di una dirigenza nazionale permanente e istituzionalizzata, direttamente legittimata dall’elezione da parte di tutti gli iscritti e dotata di un ampio potere di orientamento programmatico e di appropriati strumenti di controllo sulle candidature, accompa-gnata da modifiche quantomeno nella prassi costituzionale, che rendessero maggior-mente coordinata la vita del potere esecutivo e quella del legislativo. Ciò avrebbe consentito di trasformare i partiti americani in efficaci strumenti di governo, capaci
32 E.E. Schattschneider, Party Government, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1942, pp. 64 ss. Per una precoce e sintetica presentazione del problema cfr. ancora S. Muller, Electoral Systems and Political Parties, cit., pp. 14-16.33 Per ulteriori osservazioni sul ruolo dei riferimenti d’inizio secolo nell’indagine sulle nuove forme-partito degli anni Quaranta-Cinquanta, rinvio anche a A. Pizzorno, Elementi di uno schema teorico con riferimento ai partiti politici in Italia, in G. Sivini (a cura di), Partiti e partecipazione politica in Italia. Studi e ricerche di sociologia politica, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 21-29, e P. Pombeni, L’apoteosi e la crisi della forma partito nell’Europa del secondo dopoguerra, ora in Id., La ragione e la passione. Le forme della politica nell’Europa contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 471-541.34 E.E. Schattschneider, Party Government, cit., pp. 99 ss.
422
di portare avanti una politica chiaramente individuabile dopo aver conquistato attra-verso il successo elettorale gli strumenti per applicarla35.
Il consolidamento delle macchine partitiche poteva insomma diventare un tema privilegiato nella ricerca di garanzie alla partecipazione democratica dei cittadini all’orientamento della vita politica, perché sembrava implicare maggiore resistenza ai gruppi di pressione, più efficace capacità di coinvolgimento del corpo elettorale nel suo insieme, e soprattutto maggiore responsabilizzazione dei vertici partitici rispetto alle proposte politiche e ai programmi presentati.
Partiti politici e realtà sociali: la relazione all’Apsa del 1953
Stando a quando detto finora, Einaudi arrivava alla stesura del suo paper del set-tembre 1953 in una posizione particolare. Genero di Robert Michels e profondo co-noscitore della teoria delle élites36 che, soprattutto nella sua versione applicata al-l’«oligarchia» partitica, rappresentava la base metodologica di gran parte dei dibattiti in campo, egli era un attento osservatore del dibattito francese, che nel sostanziale si-lenzio della scienza politica italiana degli anni Cinquanta gli offriva un buon punto di partenza per analizzare la società e la politica europea. In particolare, tra la fine degli anni Quaranta e il 1953 il dibattito suscitato dalla potente – ma unilaterale – proposta interpretativa di Les partis politiques stava individuando la strada per portare avanti percorsi di comparazione complessi e ad ampio spettro tra le diverse realtà socio-po-litiche nazionali, che ben si confacevano alla proposta di comparazione che Einaudi stava maturando nella sua Inquiry. Partecipe del dibattito che fioriva attorno a lui negli Usa, Einaudi era poi conscio del fatto che, al di là delle intenzioni dell’autore, l’opera di Duverger poteva finire per presentarsi come un ulteriore supporto a un’a-nalisi dei partiti politici in cui un latente orientamento di natura evolutiva sostituiva le necessarie cautele nell’accostamento tra realtà socio-politiche differenti. L’autore francese era partito da un tentativo d’individuare le ragioni di fondo che spiegavano le profonde differenze in soggetti e sistemi politici nei diversi casi esaminati, ma molte delle sue conclusioni sembravano convergere verso l’idea di spiegazioni «universali». Così, agli occhi di Einaudi, Les partis poliques rischiava di essere accolto negli Stati Uniti senza il necessario schermo critico che soprattutto Lavau aveva esplicitato nel suo lavoro di critica, andando ad alimentare un dibattito interno al mondo americano
35 Ibidem, pp. 129 ss., 164 ss., 170 ss., 206 ss.36 Tra il 1936 e il 1939, Mario Einaudi preparò e tenne diversi corsi e lezioni singole sul pensiero di Mosca e Pareto, sia a Harvard che a Fordham, arrivando anche a presentare la possibilità di gestire un ciclo di lezioni in materia come un importante asset per il suo curriculum (sul punto cfr. P.P. Portinaro, Mario Einaudi e la scienza politica, cit., pp. 106-107). Il carteggio tenuto con Gaetano Mosca (conservato in Tfe, Cme, sez. 2-3, fasc. Mosca Gaetano) mostra inoltre che tra il 1935 e il 1938 Mario Einaudi avrebbe man-tenuto i contatti tra Mosca e il mondo editoriale anglosassone per la pubblicazione in lingua inglese del suo Elementi di scienza politica (uscito come The Ruling Class, New York-London, McGraw Hill, 1939).
423
in cui egli in gran parte non si riconosceva. Gli studi statunitensi, infatti, guardavano ormai con una certa insistenza a una riforma dei propri partiti in un senso che poteva apparire facilmente sovrapponibile all’indagine della «fisiologia» delle nuove forze politiche impegnate nell’arena europea, e si avallava con eccessiva facilità l’idea che i partiti maggiori americani rappresentassero, per funzionamento e struttura, quasi un relitto dei meccanismi di rappresentanza individuale propri dei regimi liberali a suffragio ristretto, e che fossero perciò destinati a vivere una profonda revisione negli anni a venire37.
Nell’organizzazione della sua presentazione sul tema dei partiti politici contem-poranei si possono trovare tutti questi motivi. In primo luogo, fin nel titolo del suo intervento, «Social Realities» and the Study of Political Parties, l’autore riprendeva direttamente il Partis politiques et réalités sociales di Lavau, testo da lui immediata-mente citato e utilizzato nel tentativo di rimettere mano alla serie di definizioni du-vergeriane dei «partiti di massa», in modo da trovare una spiegazione d’insieme a tutti quegli elementi specifici (ampia diffusione del consenso elettorale, organizzazione dell’appartenenza, radicamento organizzativo sul territorio, controllo dei gruppi par-lamentari) che li caratterizzavano.
One can get a step closer to a useful definition of mass parties by pointing out that often we think of mass parties as being those whose membership and popular support are to a large extent drawn from those social groups which until the beginning of the twentieth century, or until the advent of the universal suffrage, were either cut off from political life or regulated to insignificant participation, mass parties would then be those supported by the proletarian masses. This would tend to eliminate from among mass parties the British Conservative Party, for in spite of its working class support the party derives most of its strength from the middle classes and certain rural elements. [...] Under this definition the communist and some [socialist and] Christian democratic parties would qualify [...].
Another useful concept in the definition of mass parties is undoubtedly that of the mili-tary discipline imposed upon party members [...] [and] the party’s elected representatives [...]. This is undoubtedly one of the important developments which have altered the nature of par-liamentary government by transferring parliamentary and constitutional responsibilities to extra-parliamentary and extra-constitutional bodies. The phenomenon is associated with the rise of socialist and communist and in some countries of Christian democratic parties38.
Come sarebbe emerso in modo ancora più diretto nel prosieguo del testo, con-naturato ai partiti d’integrazione di massa era lo strutturarsi di un’organizzazione
37 Anche Duverger stesso aveva sostenuto opinioni simili, prendendo in considerazione il caso americano con scarse informazioni specifiche di prima mano, in I partiti politici, cit., pp. 52 ss. Sugli sviluppi di questa idea nel dibattito europeo, cfr. anche gli interventi raccolti in M. Vaudagna (a cura di), Il partito politico americano e l’Europa, Milano, Feltrinelli, 1991.38 «Social Realities» and the Study of Political Parties, cit., pp. 4-7 [corsivo nell’originale].
424
decisamente verticistica, guidata da una élite dotata di forte legittimazione ideologica e maturata da uno sviluppo della partecipazione democratica basato più sul conflitto che sul consenso.
Su questa base, prima di tutto, Einaudi fondava l’insieme degli elementi costituivi della sua azione di ricerca focalizzata sui tratti comuni che caratterizzavano le società dell’Europa continentale, specialmente quella italiana, francese e, in parte, tedesca39. Nell’ottica di una comparazione con la democrazia americana, queste ultime appa-rivano caratterizzate da un grado minore d’integrazione tra le classi sociali, da un rapporto della comunità politica con il credo religioso dominante caratterizzato da più decise tensioni, da una maggiore frammentazione degli orientamenti ideali e da una minore mobilità verticale. In questo contesto, le forze politiche che il suffragio universale e l’emergere della democrazia di massa avevano individuato come le più rappresentative del corpo sociale si erano sviluppate per lo più al di fuori della legit-timità istituzionale e, una volta entrate nella vita delle istituzioni come partiti maggio-ritari, non potevano che vedere in quelle stesse istituzioni pubbliche uno strumento per la propria autoaffermazione.
Sicuramente, il confronto profondo con le «realtà sociali» e con le radici storiche dei comportamenti politici era cruciale per offrire al dibattito politico e politologico una proposta interpretativa dei problemi sociali dell’Europa occidentale (il cui sin-tomo più evidente era, almeno nei paesi presi in considerazione dalla French-Italian Inquiry, il successo dei locali partiti comunisti). Una proposta che aggiornava e ren-deva più complessi i tradizionali spunti dell’agenda liberal per la politica europea degli Stati Uniti nella Guerra fredda, per cui il comunismo era il sintomo della povertà diffusa e delle difficoltà produttive dei paesi europei in maggiore difficoltà nell’im-mediato dopoguerra. L’arretratezza francese, e soprattutto italiana, rispetto alle de-mocrazie anglosassoni, era infatti politica e sociale oltre che economica e produttiva. La chiave del successo elettorale e della presenza sociale di Pci e Pcf, unici partiti comunisti veramente capaci di giocare il ruolo di forze d’integrazione di massa nel mondo democratico occidentale, stava nel loro ruolo di opposizione organizzata a un tradizionale establishment politico e sociale che la vischiosità delle linee di sviluppo culturale e l’arretratezza di rapporti economici tra le classi produttive ancora carat-terizzati da divisioni rigide rendevano (almeno in apparenza) impossibile scalzare attraverso le normali pratiche della democrazia liberale.
Ma attraverso questo sviluppo argomentativo la presentazione einaudiana del 1953 interveniva, in modo meno diretto e più sottile, sulle valutazioni allora circo-
39 All’inizio del 1949, su suggerimento di Carl J. Friedrich, Einaudi avrebbe parlato di un possibile al-largamento di alcuni aspetti dell’Inquiry alla situazione socio-politica della Germania occidentale con Joseph Willits, responsabile della sezione di Social sciences della Rockefeller Foundation, ma il piano sarebbe abortito rapidamente. Cfr. Tfe, Cme, sez. 2-3, fasc. Willits Joseph H., M. Einaudi a J.H. Willits, 5 gennaio 1949.
425
lanti dello stato di salute del sistema americano dei partiti. Continuando la sua descri-zione della vita dei partiti di massa europei, Einaudi fissò infatti il suo sguardo sulla sostanziale mancanza di correlazione tra il consolidamento della struttura partitica (e della conseguente capacità dei partiti di tenere sotto controllo le istituzioni rap-presentative) e il rendimento qualitativo dei governi e delle loro politiche. La lettura di Duverger non aveva smosso Einaudi dal condividere nei suoi termini generali la posizione di Michels sulla valutazione sostanzialmente negativa del carattere oligar-chico dei moderni partiti d’integrazione di massa e degli strumenti organizzativi e ideologici che mantenevano saldo il consenso dei loro aderenti40. Così, secondo la sua ricostruzione, i maggiori partiti dell’Europa continentale avevano sviluppato una capacità di frenare quella mobilità di consensi propria dei floating voters, gli elettori «che guardavano ai partiti politici con l’atteggiamento freddo dell’analisi empirica piuttosto che nel clima appassionato del conflitto ideologico», e che in Usa e Gran Bretagna apparivano ormai cruciali per fare in modo che «un governo incompetente sopravvivesse» o meno41. L’efficienza dei partiti d’integrazione di massa nel conso-lidare il proprio consenso, sembrava implicare l’autore a conclusione del suo paper, non portava necessariamente all’efficienza dei governi, la quale invece rispondeva a correlazioni tra istituzioni politiche e contesto sociale decisamente più specifiche.
Questi accenni di natura indiretta avrebbero trovato un’eco più chiara nel mo-mento in cui l’autore si sarebbe cimentato con una ricostruzione storica delle tra-sformazioni politiche e sociali seguite alla «Roosevelt revolution» degli anni Trenta, intervenendo in maniera diretta nel 1959 in un dibattito sui partiti americani che peraltro, negli anni immediatamente precedenti, era andato gradualmente perdendo d’intensità a seguito della ritrovata alternanza al governo federale con l’elezione del repubblicano Einsenhower:
In Europe, the entry upon the political stage of roughly similar groups of factory workers and of urban dwellers, which occurred in the course of the last seventy five years in answer to new political and voting rights, has led to sharper political tensions and difficulties, to a deep-ening of party conflicts, to increased claims by the parties on government, to growing organiza-tional rigidities within the parties, to attempts to impose party discipline and programs on the elective party representatives. It cannot be doubted that the democratization and universaliza-tion of political life in Europe has tended to place in the hands of parties weapons which have shifted the balance of political power and the nature of constitutionalism [...].
The opposite is true in the United States. [...] Parties are not in America the instruments of government they have tended to become in Europe. Parties are useful for local purposes, they are essential for the screening and nurturing of leaders, they are all important as the vehicles through which the process of selection of the natural leaders and of the legislators is
40 «Social Realities» and the Study of Political Parties, cit., pp. 12-13.41 Ibidem, pp. 8-9.
426
accomplished every two or four years. But America has acquired a sufficiently realistic and common-sense view of what are the tasks of government not to nourish any illusions as to the aptitude of parties to engage directly in governing activities. Parties are indispensable elements in the democratic process, but they have, as such, no decisive role to play when it comes to governing42.
Mario Einaudi e la comparazione internazionale dei sistemi politici
Come si è visto, tirando le somme della sua analisi, Mario Einaudi ammoniva gli osservatori statunitensi a guardare alle dinamiche politiche dell’Europa occiden-tale evitando tanto assimilazioni inopportune tra le realtà sociali sulle due sponde dell’Atlantico, quanto riprese acritiche del tradizionale «eccezionalismo» americano, e mostrava così la capacità di porre i problemi considerati in una prospettiva genuinamente «transatlantica». Commentando il contributo di Einaudi allo studio dell’Europa nei Festschriften che Cornell gli dedicò nel 1990, uno dei massimi inter-preti della sociologia politica americana degli ultimi decenni sottolineò l’importanza di questo atteggiamento con parole inequivocabili:
Without fanfare, Einaudi had accomplished in 1945 what it would take political science three more decades to recognize – the inclusion of the United States in comparative politics.43
Su queste basi lo studioso di origine italiana strutturò le sue riflessioni pubblicate negli anni Cinquanta nella French-Italian Inquiry, offrendo presentazioni specifiche e puntuali del funzionamento dei sistemi istituzionali, delle pratiche di governo e delle nuove forze dell’arena politica.
L’approccio di cui Einaudi diede pratica dimostrazione nelle sue pubblicazioni si sarebbe rivelato valido anche ben al di là dei limiti cronologici e concettuali degli studi politici della Guerra fredda, impegnati nella delineazione di precise distinzioni tra «mondo libero» e sfide «totalitarie». Il suo insegnamento avrebbe rappresentato un esempio esplicitamente ricordato nei lavori di tanti studiosi della società europea nei due decenni successivi a quei primi anni Cinquanta che vedevano Einaudi attivo nella sua Inquiry. Dagli studi sulla rappresentanza partitica nelle campagne arretrate del Mezzogiorno di Sidney Tarrow, al confronto tra comportamenti e convinzioni di governanti e governati di vari paesi europei proposto dal Gabriel Almond di The Civic Culture, alle considerazioni sull’«ethos» politico diffuso portate avanti da Robert Putnam, negli anni Sessanta-Ottanta, le ricerche sociali americane che individua-
42 M. Einaudi, The Roosevelt Revolution, New York, Harcourt, Brace & Co., 1959, pp. 322-324.43 S. Tarrow, Introduction, in P.J. Katzenstein, T. Lowi, S. Tarrow (eds.), Comparative Theory and Political Experience, cit., p. 8.
427
vano l’Europa mediterranea come specifico luogo di tensione tra sviluppo e sotto-sviluppo avrebbero trovato nel lavoro einaudiano il modello per studi attenti allo sviluppo storico, al contesto operativo e alle implicazioni culturali44. Il pragmatico studio di area einaudiano, in questo senso, mostrò la sua utilità e la sua versatilità in modo più duraturo delle ambizioni universalistiche delle generalizzazioni astratte nell’analisi del comportamento politico.
Tracciare un quadro documentato della fortuna che più specificamente incontrò l’esposizione delle prospettive di metodo sottese ai lavori dell’Inquiry che Einaudi pre-sentò in modo esplicito nel paper all’Apsa del 1953, invece, è naturalmente assai più difficile. La relazione, infatti, non venne mai pubblicata, essenzialmente per il rifiuto dell’autore di occuparsi in modo impegnativo di enunciazioni teoriche generali, e per la sua preferenza a dare alle sue ricerche l’aspetto descrittivo di casi concreti. Di con-seguenza, mancano riprese o rielaborazioni immediate in altre ricerche a cui rifarsi con certezza. Comunque, le riflessioni d’insieme su partiti e sistemi politici europei maturate da Mario Einaudi negli anni Cinquanta ebbero senz’altro un riverbero più o meno diretto, anche se difficilmente individuabile a prima vista, sui percorsi di «dena-zionalizzazione» di spunti di ricerca e di strutture concettuali delle scienze politiche e sociali degli anni Cinquanta, grazie alla collaborazione einaudiana con un esponente di spicco della riflessione politica comparata negli Usa: Sigmund Neumann.
Nel 1954, proprio mentre vedeva la luce in Gran Bretagna e iniziava a circolare anche negli Usa una traduzione inglese di Les partis politiques di Duverger45, negli Stati Uniti trovava pieno consolidamento un importante cantiere internazionale per lo studio comparato dei partiti e dei sistemi politici, destinato a risultati durevoli. In quell’anno, infatti, vide la luce il Committee on Comparative Politics presso il Social Science Research Council (Ssrc), il principale istituto per la promozione e il finanzia-mento degli studi sociali negli Stati Uniti46. Il primo risultato degli sforzi organizzativi e dell’impegno finanziario del comitato fu, nel biennio successivo, il coronamento del lavoro collettivo sullo studio comparato dei partiti politici animato e diretto da Neu-mann. Quest’ultimo, studioso dei fenomeni politici fuoriuscito dall’Europa totalitaria come Einaudi, e allora docente alla Wesleyan University, già dal 1947 aveva tentato di raccogliere nell’ambito delle tavole rotonde promosse dall’Apsa nei suoi meeting annuali alcuni degli studiosi di formazione europea attivi negli Stati Uniti per la pro-duzione di un volume collettaneo che descrivesse, secondo criteri di analisi comuni, i soggetti politici caratteristici dei principali paesi occidentali47. Il nome di Mario Ei-
44 Per alcuni riferimenti generali cfr. A. Mastropaolo, From the Other Shore. American Political Science and the Italian Case, «Modern Italy», 2009, 3.45 Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State, London, Meuthen-New York, J. Wiley, tradotto da Barbara e Robert North.46 Per ulteriori ragguagli cfr. G. Loewenberg, The Influence of European Émigré Scholars, cit., pp. 600-602.47 Tfe, CmeE, sez. 2-3, fasc. Neumann Sigmund, S. Neumann a M. Einaudi, 7 novembre 1947.
428
naudi era stato compreso tra i contributori fin dalla prima ora per un lavoro che riprendesse e migliorasse la descrizione della forma-partito dell’Europa occidentale presentata nella relazione all’Apsa, da raccogliere insieme a quelli di Waldemar Gu-rian e di Felix Oppenheim, oltre al possibile contributo di Gabriel Almond, di Robert William Seton-Watson per l’Europa centro-orientale e di Robert Scalapino, per un possibile ampliamento dell’indagine all’Estremo oriente48. Nonostante le buone pre-messe, i ritardi nelle consegne, le difficoltà di coordinamento e la scarsa convinzione della casa editrice Alfred A. Knopf nelle potenzialità del prodotto finito avrebbero portato il progetto diretto da Neumann ad arenarsi tra 1951 e 1952. La ripresa del progetto nel 1954, che grazie al supporto del Ssrc si sarebbe concretizzata nel 1956 nel celebre volume Modern Political Parties49, non avrebbe visto la partecipazione diretta di Mario Einaudi poiché, rispetto agli anni 1948-1950, aveva già avuto ampia-mente modo di esprimere le sue considerazioni nei suoi saggi per i volumi dell’In-quiry. La sua defezione, del resto, si sarebbe rivelata particolarmente evidente nel piano dell’opera, per la rilevante assenza di un intervento specificamente dedicato al sistema dei partiti italiano. Tuttavia, almeno in una certa misura furono proprio le preoccupazioni che Einaudi aveva mutuato dai commenti francesi introducendo Duverger ai massimi livelli del dibattito politologico americano a dare nuova linfa al progetto, e finanche a garantirgli una prospettiva di analisi solida e rinnovata rispetto al tentativo di pochi anni prima, fino alla realizzazione di un modello interpretativo destinato ad avere, negli Stati Uniti, un impatto importante nella vita degli studi. Nella rassegna che Neumann, il grande animatore del programma di studi collettivo, aveva pubblicato nel luglio del 1954 su «World Politics»50 per riprendere definitivamente il filo interrotto qualche tempo prima con l’offerta di nuovi stimoli originati dalla letteratura scientifica internazionale sui partiti, le battute conclusive erano espressa-mente dedicate al confronto tra Duverger e Lavau, in vista di una rivisitazione delle categorie analitiche introdotte dal primo, poi coronata nel saggio conclusivo di Mo-dern Political Parties, quel Toward a Comparative Study of Political Parties destinato a diventare un pezzo da antologia della scienza politica del Novecento. Attraverso questo percorso, la caratterizzazione «di massa» dei grandi partiti contemporanei era integrata in quella, assai prossima al quadro tracciato da Einaudi nel paper del 1953 e dei saggi della French-Italian Inquiry dedicati ai partiti politici, di «parties of social integration», più adeguata a raccogliere le diverse esperienze di aggregazione politica secondo una precisa funzione e ad articolare meglio uno spunto definitorio generale allo sviluppo storico di diverse realtà sociali e istituzionali nazionali.
48 Tfe, CmeE, sez. 2-3, fasc., S. Neumann a M. Einaudi, 30 settembre 1948.49 S. Neumann (ed.), Modern Political Parties. Approaches to Comparative Politics, Chicago, University of Chicago Press, 1956.50 S. Neumann, Toward a Theory of Political Parties, «World Politics», 1954, 4.