La parte della filologia nella cultura e nell'università italiana dal secondo dopoguerra ad oggi
Transcript of La parte della filologia nella cultura e nell'università italiana dal secondo dopoguerra ad oggi
FASTI RECENTI E INCERTI ORIZZONTI.LA PARTE DELLA FILOLOGIA
NELLA CULTURA E NELL’UNIVERSITà ITALIANA DAL SECONDO DOPOGUERRA
A OGGI*
Francesco Bausi
Q uasi sessant’anni fa, il 20 novembre 1952, moriva a Napoli Benedetto Croce. Appena tre giorni prima, il trentasettenne Lanfranco Caretti aveva letto all’Università di Pavia la prolusione, dal titolo Filologia e
critica, al suo corso di Letteratura italiana.1 Richiamandosi a Pasquali e a Barbi, Caretti sottolineava l’importanza della variantistica, giacché il recu-pero dei materiali d’autore è « realmente utile alla comprensione più piena dell’opera d’arte », e dunque all’origine dell’interesse per le correzioni sta « una ragione essenzialmente critica, la quale punta, al di là del problema filologico, ad una particolare lettura del testo ». Affermando che lo studio delle varianti fornisce al critico « le pezze d’appoggio per la sua personale esegesi interpretativa », consentendogli di passare « dal momento della rico-struzione testuale a quello del giudizio di poesia vero e proprio », Caretti rivela il suo legame col crocianesimo, facendo almeno idealmente della fi-lologia solo il punto di partenza (il momento “pedagogico” e preparatorio, vale a dire) e della critica il punto d’arrivo del lavoro sui testi ; ma è l’insi-stenza sulla variantistica, e non sulla filologia tout court, a scavare il fossato con l’estetica crociana. Croce, infatti, non combatteva la filologia ricostrut-tiva, e anzi ne riconosceva l’utilità, purché essa non si mettesse in testa di sottrarsi al suo ruolo subalterno, e si limitasse a predisporre nel modo migliore i testi, per poi lasciare campo libero all’interprete ; i suoi bersagli erano piuttosto l’erudizione (ove aspirasse a divenire storiografia e critica : si pensi al duro attacco sferrato a Curtius nel 1950)2 e appunto la variantisti-ca, ossia quella filologia che, parimenti, voleva farsi critica.
* Una redazione parzialmente diversa di questo testo, più breve e priva delle note, è uscita anti-cipatamente, per gentile concessione del comitato organizzatore del convegno, sulla rivista « Ecdo-tica », viii (2011), pp. 175-192. Ringrazio Claudio Giunta e Michelangelo Zaccarello per alcuni utili suggerimenti.
1 Ora si legge in Lanfranco Caretti, Antichi e moderni. Studi di letteratura italiana, Torino, Ei-naudi, 1976, pp. 471-488, donde si cita.
2 Benedetto Croce, Dei filologi che hanno idee, « Quaderni della Critica », vi (1950), ? ?, pp. 118-121.
francesco bausi28Erudizione e variantistica sono incompatibili con l’estetica crociana,
giacché pensano di poter capire la poesia lavorando su ciò che poesia non è, e che con la poesia, secondo Croce, non ha niente a che fare. L’erudizio-ne crede di poter “spiegare” la poesia evocandone le fonti e i precedenti o, peggio, i referenti reali (storici e biografici), tutti materiali “allotri”, « cose inopportune ed estranee »,3 non pertinenti all’interpretazione e alla « carat-terizzazione » del testo letterario. L’esame delle varianti, analogamente, pretende di arrivare a comprendere la poesia tramite gli « scartafacci », ridu-cendola quindi a un processo, a un qualcosa che si fa e si conquista lavoran-do sulla materia verbale, e avvalorando dunque una concezione “dinamica” dell’opera d’arte. L’erudizione è ricondotta da Croce al positivismo e alla tradizione umanistico-retorica, la variantistica (con la connessa critica ge-netica) al “decadentismo”, cioè alle poetiche simbolistiche : correnti cultu-rali e filosofiche, tutte queste, da lui, com’è ben noto, fieramente avversate. La filologia ricostruttiva, che per comodità si suole definire lachmanniana, era viceversa ben compatibile con la critica crociana, essendo da un lato portatrice di una concezione statica del testo, dall’altra propugnando la se-parazione tra recensio e interpretatio.4
La polemica di Croce,5 per questo, prese di mira Michele Barbi (che ne La nuova filologia, del 1938, aveva dedicato ampio spazio allo studio genetico dei testi, da Dante a Manzoni), Giuseppe De Robertis (e la sua allieva Adelia Noferi), nonché, sia pure indirettamente, Gianfranco Contini, che fin dagli anni ’30 aveva pubblicato fondamentali contributi sulla critica delle varianti, pur evitando di contrapporsi frontalmente a Croce, e anzi affermando di non voler fuoriuscire dal “sistema” crociano e sostenendo la piena compa-tibilità di filologia delle correzioni e critica estetica : una convinzione, que-sta, ribadita anche nella sua replica del 1948 (La critica degli scartafacci) alla nota di Nullo Minissi apparsa nel gennaio di quello stesso anno su « Belfa-gor », replica in cui Contini distingueva fra l’autentica posizione di Croce e
3 Id., La poesia di Dante, settima edizione riveduta, Bari, Laterza, 1952 (19201), p. 20.4 Roberto Antonelli, Interpretazione e critica del testo, in *Letteratura italiana. iv, L’interpretazio-
ne, Torino, Einaudi, 1985, pp. (141-243), 223. Anche Gianfranco Contini, del resto, praticò la critica delle varianti soprattutto in gioventù (pur non scendendo mai, come vedremo tra un momento, in aperta polemica col Croce), per poi abbandonarla quando si “convertì” allo strutturalismo e alla linguistica, parallelamente elaborando una nozione di « critica verbale » che ritorna di fatto al crocianesimo, nel proclamare il primato di una “lettura” e di una “auscultazione” del testo basata sulla centralità e sulla soggettività del lettore (con dissimulate implicazioni attualizzanti, autobio-grafiche ed “esistenzialistiche”) : cfr. Roberto Antonelli, « Esercizî di lettura » di Gianfranco Contini, in *Letteratura italiana. Le opere. iv/2, Il Novecento. La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996, pp. (339-406), 395.
5 Cfr. Benedetto Croce, Intorno alla cosiddetta “critica stilistica”, « Quaderni della Critica », ii (1946), ? ?, pp. 52-59 ; Id., Illusioni sulla genesi delle opere d’arte documentabile dagli scartafacci degli scrit-tori, « Quaderni della Critica », III (1947), ? ?, pp. 93-94.
fasti recenti e incerti orizzonti 29quella, a suo parere più dogmatica, dei suoi seguaci.6 D’altronde, anche in quell’immediato dopoguerra, Contini non volle conferire apertamente alle sue scelte una valenza che andasse al di là del piano strettamente metodo-logico e pragmatico. Balza agli occhi, sotto questo aspetto, la sua distanza da Caretti, che nella parte finale della prolusione pavese insiste invece a lungo sulle ragioni profonde di quella che egli definisce « la spinta, oggi così vivace, verso la filologia », riconducendola a un prepotente « bisogno di au-torieducazione intellettuale e morale » ; e il pensiero va a Carlo Dionisotti, che con argomentazioni e parole simili aveva giustificato nella Postilla a una « lettera scarlatta » (1946) l’opzione sua e di molti suoi coetanei per la filologia e l’erudizione, riportandola alla fortissima esigenza di una « disciplina rigo-rosa » che fosse non solo argine alle discussioni estetiche e filosofiche, ma anche recupero di una nuova severità di vita e di lavoro dopo le ubriacature retoriche del ventennio fascista, e insieme riconquista di una dimensione comune e solidale di ricerca sui fatti concreti, dopo la liberazione dalla ti-rannide del gusto individuale e immediato.7 Non per nulla, la dionisottiana Postilla e il più tardo saggio continiano su L’influenza culturale di Benedetto Croce (scritto nel ’51, vivente ancora il filosofo, ma significativamente pub-blicato solo quindici anni dopo) si chiudono allo stesso modo : il primo, invocando « un programma semplice di buon lavoro [...] che non richiede preventive discussioni metodologiche » (giacché « dal lavoro stesso nascerà volta a volta o si confermerà la metodologia conveniente ») ; il secondo, con l’analoga esortazione « non metafisicizziamo oltre, e invitiamo piuttosto al lavoro ».8
Certamente, per gli intellettuali di quella generazione, era non meno ar-duo che impellente fare i conti con Croce, che per tutti era stato, oltre che figura simbolo dell’antifascismo (benché non militante) e maestro “mora-le” di libertà, profeta di una vulgata estetica ormai divenuta seconda natura. Così, Dionisotti – appellandosi al Croce erudito, da lui privilegiato rispetto
6 Nullo Minissi, Le correzioni e la critica, « Belfagor », iii (1948), ? ?, pp. 94-97 ; Gianfranco Con-tini, La critica degli scartafacci, « La Rassegna d’Italia », iii (1948), ? ?, pp. 1048-1056, poi in Id., La critica degli scartafacci e altre pagine sparse. Con un ricordo di Aurelio Roncaglia, Pisa, Scuola Normale Supe-riore, 1992, pp. 1-32. Si veda a questo proposito D’Arco Silvio Avalle, L’analisi letteraria in Italia, Milano-Napoli, Ricciardi, 1970, pp. 9-47 ; Cesare Segre, Contini, Croce e la critica degli scartafacci, in *Riuscire postcrociani senza essere anticrociani. Gianfranco Contini e gli studi letterari del secondo Nove-cento. Atti del Convegno di studio, Napoli, 2-4 dicembre 2002, a cura di Angelo A. Pupino, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2004, pp. 297-304, il quale osserva fra l’altro come Contini non abbia voluto includere nelle sue successive raccolte di saggi questo pur importante articolo, che fu ristampato solo dopo la sua morte (ivi, p. 303).
7 Carlo Dionisotti, Postilla a una « lettera scarlatta » (1946), ora in Id., Geografia e storia della lette-ratura italiana, Torino, Einaudi, 1984, pp. (17-23), 23.
8 Gianfranco Contini, L’influenza culturale di Benedetto Croce, « L’Approdo Letterario », n.s., xii (1966), 36, pp. 3-32 ; poi in volume col titolo La parte di Benedetto Croce nella cultura italiana, Torino, Einaudi, 1989 (19721), p. 57.
francesco bausi30al Croce critico e filosofo9 – vagheggiò per l’erudizione ciò che Contini aveva proposto per la variantistica, ossia una conciliazione col metodo cro-ciano e addirittura una sua diretta filiazione da esso ;10 ed entrambi vollero ri-badire la propria estraneità all’anticrocianesimo più acceso e rumoroso che cominciava a prender piede nel secondo dopoguerra. Nondimeno, la strada era ormai segnata, e proprio ad opera di quei « giovani più naturalmente dotati » che, come scriveva ancora Dionisotti nella Postilla, già prima della guerra erano tornati, sulle orme di Pasquali e di Barbi, agli studi filologici.11 Lo stesso Dionisotti faceva i nomi di Contini e di Giuseppe Billanovich ; tuttavia, sia pure emarginata dal trionfo del crocianesimo, la filologia si era guadagnata anche in quegli anni oscuri uno spazio non esiguo, prosperando soprattutto in alcuni luoghi franchi (Firenze, la Crusca, la Scuola Normale, la Biblioteca Vaticana, la Torino del « Giornale Storico ») e giungendo a ri-sultati di assoluto rilievo : oltre che ai due fondamentali volumi di Giorgio Pasquali (Storia della tradizione e critica del testo, 1934) e di Michele Barbi (La nuova filologia e l’edizione dei nostri scrittori da Dante a Manzoni, 1938), si pensi al Furioso (1928) e ai frammenti ariosteschi (1937) di Santorre Debenedetti, alle edizioni continiane delle Rime di Dante (1939) e di Bonvesin de la Riva (1941), ai carmi di Cristoforo Landino criticamente pubblicati da Alessandro Perosa (1939), alle grandi imprese compiute in quei veri e propri laboratori filologici che furono allora e in séguito le edizioni nazionali di Dante e di Petrarca. D’altronde, per quanto oggi possa suonare strano, era possibile negli anni ’30 in Italia essere o credere di essere al tempo stesso filologi (nella pratica del mestiere) e crociani (nel gusto estetico e nella concezione della letteratura) : esemplare al riguardo è il caso di Contini, e ancor più quello di Vittorio Rossi, che mentre lavorava all’edizione delle Familiares – una delle pietre miliari della nuova filologia italiana – andava rielaborando per la Vallardi il suo Quattrocento (primamente uscito nel 1898 in tutt’altra temperie culturale) onde adeguarlo ai dettami dell’estetica crociana e alla distinzione fra poesia e non-poesia, da lui peraltro accolta e applicata in sede critica e storiografica fin dal 1914.12 Quanto a Giorgio Pasquali, Montale
9 C. Dionisotti, Postilla a una « lettera scarlatta », cit., p. 23 : « ai giovani d’oggi si richiede d’inten-dere i Discorsi di varia filosofia, ma anche e più gli Scrittori del pieno e del tardo Rinascimento : quel che il Croce ne dice e i testi di cui parla ; tutti e altri ancora ; come da lui sono stati letti e in altro modo anche e con risultati forse in parte diversi ».
10 « Dionisotti proponeva a Croce un ideale di crocianesimo selettivamente orientato, ma è chiaro che egli stesso doveva riconoscere che in quel suo programma non poteva essere tutto il crociane-simo, ed era difficile che Croce lo potesse accettare senza riserve » : Vincenzo Fera, Tra la Scuola storica e la lezione di Croce : Dionisotti e la letteratura umanistica, in *Carlo Dionisotti. Geografia e storia di uno studioso, a cura di Edoardo Fumagalli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2001, pp. (26-46), 44.
11 C. Dionisotti, Postilla a una « lettera scarlatta », cit., p. 22.12 Cfr. Mario Martelli, Il « Quattrocento » di Vittorio Rossi tra Scuola storica e idealismo crociano,
in Vittorio Rossi, Il Quattrocento, aggiornamento a cura di Rossella Bessi, introduzione di Mario
fasti recenti e incerti orizzonti 31ebbe a citarlo fra quei « filologi illustri » che, pur « sempre in polemica col Croce », erano al tempo stesso « incapaci di fare a meno di lui ».13
Non ex nihilo, dunque, rinasceva la filologia dopo il secondo conflitto ; nuova era però la diffusa consapevolezza della necessità – invocata da Barbi e da Contini fin dagli anni ’30 – di riannodare con forza il rapporto spez-zato dal Croce tra filologia e critica, servendosi a questo fine, soprattutto, del decisivo apporto della linguistica e della stilistica (già esposte nei più aggiornati, come Contini e Devoto, alle suggestioni dello strutturalismo e di Spitzer), ma senza escludere in altri (quali, soprattutto, Dionisotti, Cam-pana, De Luca e Billanovich) il recupero dell’erudizione sette-ottocentesca, umanistica e positivistica, e senza trascurare importanti precedenti autoc-toni come quelli di Cesare De Lollis, Domenico Petrini e Alfredo Schiaffini. Da questo crogiuolo nascerà la migliore critica letteraria italiana del secon-do ’900, e questi – filologia, linguistica, erudizione – saranno presto ricono-sciuti come i fondamenti di qualunque rigoroso studio della letteratura ; ma la chiave di volta, l’innesco metodologico di tale “rivoluzione copernicana” furono rappresentati allora, per le ragioni già dette, dalla variantistica e dalla critica genetica, che non a caso conobbero nella seconda metà degli anni ’40 una stagione particolarmente felice, come attestano il contributo di Giuseppe De Robertis sull’autografo di A Silvia (1946), i saggi continiani su Proust, su Leopardi e su Mallarmé (i primi due del ’47, il terzo del ’48) e, sempre nel ’48, lo studio di Caretti sulle rime del Tasso e quello di Raffaele Spongano sui Ricordi di Guicciardini (destinato, tre anni dopo, a sfociare nell’edizione critica).
Ma l’affermazione della filologia in Italia non avvenne senza difficoltà, neppure dopo la scomparsa del Croce. Le istanze “filologiche”, infatti, si scontravano con la perdurante inclinazione italica alla critica “contenutisti-ca”, la quale, oltre che da un crocianesimo ancora ben vivo (benché non più incontrastato dominatore della scena culturale), traeva ora alimento anche dallo storicismo marxista, che attraverso Gramsci risaliva a De Sanctis, e che non vedeva di buon occhio linguistica, stilistica spitzeriana e filologia. Si rammenti la polemica condotta da Giuseppe Petronio nel 1958 contro Contini a proposito del saggio di quest’ultimo Dante come personaggio-poeta della « Commedia » ; 14 quel Contini che del resto già nel saggio su Croce del
Martelli, Padova, Piccin Nuova Libraria, 1992, pp. xiii-xxxv (l’edizione riveduta apparve nel 1933). Le Familiares uscirono in quattro volumi (il quarto però – morto Vittorio Rossi nel 1938 – a cura di Umberto Bosco) fra 1933 e 1942, a Firenze, presso Sansoni, nell’àmbito dell’Edizione Nazionale delle Opere di Francesco Petrarca.
13 Eugenio Montale, L’estetica e la critica (1962), in Id., Sulla poesia, a cura di Giorgio Zampa, Milano, Mondadori, 1976, pp. (128-143), 129.
14 Giuseppe Petronio, Ernst Robert Curtius o la critica del luogo comune, « Società », xiv (1958), ? ?, pp. (781-799), 796-798, con la relativa replica : Gianfranco Contini, A proposito di critica stilistica, « Società », xiv (1958), ? ?, pp. 1126-1129 (datata « Firenze, ottobre 1958 »), ora inclusa in Id., La critica
francesco bausi321951 aveva lamentato come dal marxismo « non fosse affatto venuto lo spe-rato appoggio a un nuovo positivismo ».15 Lo stesso Caretti, nel ’52, aveva ritenuto opportuno chiudere la sua prolusione pavese – che pure trovava nella poetica crociana il suo bersaglio primario – con una presa di distanze dal riduzionismo ideologico della coeva critica marxista, affermando che lo studio delle varianti permette anche di « impostare dialetticamente e non in forma meccanicistica le relazioni tra società e opera letteraria [...] senza ingabbiarci ad occhi chiusi in un tipo preformato d’inchiesta, ad esiti facil-mente prevedibili ».16
Un anno prima, nel ’51, auspice Raffaele Mattioli (uomo di formazione li-berale e crociana, ma anche amico personale di Palmiro Togliatti), l’editore Ricciardi aveva inaugurato la collana « La letteratura italiana. Storia e testi », la cui impostazione era decisamente tradizionale : edizioni non critiche e spesso antologiche, annotazioni essenziali e non erudite, assenza pressoché totale di corredi filologici. Non siamo lontani dai crociani « Scrittori d’Ita-lia » : e se da questi ci si differenziava per la presenza delle note di commento (tuttavia ridotte all’essenziale e in genere puramente esplicative), altri ele-menti – la dichiarata preferenza per i “classici” e la chiusura ai “minori”, e dunque il rifiuto dell’erudizione a favore di un approccio implicitamente attualizzante (« riunirsi a loro [scil. i nostri poeti e prosatori del passato] in assidua comunione, per ritrovarsi e vivere in quella tradizione umanistica che è la nostra tradizione di libertà », si legge nella plaquette di presentazio-ne) – denotavano il « suggello crociano »17 di un’operazione che non per nulla contava fra i suoi direttori Mattioli e Pancrazi, e fra i suoi previsti collabo-ratori Flora, Fubini, Getto e Momigliano. Il volume d’apertura, d’altron-de, fu un’antologia di scritti del Croce (Filosofia, poesia, storia) curata dal filosofo stesso. Nel medesimo anno 1951, tuttavia, Contini redigeva – come detto, senza pubblicarlo – il suo citato saggio sull’influenza culturale di Be-nedetto Croce, in cui, fra acrobazie concettuali e cautele dialettiche, e pur continuando a teorizzare un improbabile salvataggio di capra e cavoli, si affermava che la cultura viene solo « dall’amore “decadente” alle lettere [...] e dalla pratica della filologia e della linguistica come “scienze” », che « la cri-
degli scartafacci e altre pagine sparse, cit., pp. 33-41. Il saggio continiano Dante come personaggio-poeta della « Commedia » (preso di mira da Petronio soprattutto per le celebri pagine sul quinto canto dell’Inferno) era uscito su « L’Approdo Letterario », n.s., IV (1958), 1, pp. 19-46 ; fu poi ristampato in Id., Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino, Einaudi, 1970, pp. 33-62, e in Id., Varianti e altra linguisti-ca. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, Einaudi, 1970, pp. 335-361.
15 G. Contini, La parte di Benedetto Croce nella cultura italiana, cit., p. 53.16 L. Caretti, Filologia e critica, in Id., Antichi e moderni, cit., p. 487.17 Così Carlo Dionisotti, Storia e testi (1996), in Id., Ricordi della scuola italiana, Roma, Edizioni
di Storia e letteratura, 1998, pp. (503-509), 505, dove anche si osserva che « già era stato crociano l’av-vio, l’intento dichiarato nella premessa di “raccogliere in un corpus organico i risultati particolari, gli sparsi acquisti di un cinquantennio di lavoro” ».
fasti recenti e incerti orizzonti 33tica stilistica è oggi la sola viva » e che il postcrocianesimo dovrebbe mettere all’ordine del giorno degli studi letterari « un uso concreto della filologia e della stilistica perfettamente funzionale ».18
Insomma, un metodo e un programma ben poco crociani, che non po-tevano contentarsi dei soli classici Ricciardi, ai quali infatti nel 1957, scom-parso il filosofo ormai da cinque anni, il medesimo editore affiancava, a mo’ di integrazione “tecnica”, la collana « Documenti di filologia ».19 Nella breve premessa, dal titolo Propositi della presente raccolta, che apre ciascun volume – il primo furono le rime cavalcantiane curate da Guido Favati – si sottolinea il legame di complementarità con la collana maggiore, dalla qua-le proviene uno dei due direttori, il linguista e filologo Schiaffini (peraltro avvicinatosi per tempo al Croce) ; ma è l’altro, ossia Contini, il vero moto-re ed artefice dell’operazione, che ospita in prevalenza edizioni critiche di testi curati in modo « metodologicamente esemplare ». Si tratta di volumi rigorosi, privi di commento ma dotati di apparato e di solide introduzioni filologiche ; nondimeno, almeno nei voti, la filologia dei « Documenti » in-tendeva adeguarsi – come leggiamo nella premessa, vergata da Contini – ai « caratteri distintivi della cultura moderna », cui « compete essere insieme sperimentale e non agnostica », ossia, in pratica, « differenziarsi dalla media positivistica per la proprietà di ridare luce ed eloquenza, significato e inter-pretabilità, ai fatti inerti e opachi », e insieme « opporsi alla media idealistica col superare le tenzoni dialettiche che si svolgono entro i presunti confini puri della mente, al di fuori di qualsiasi verifica, resistenza e radicale no-vità del fatto ». In queste parole si respira ancora aria di “compromesso” con l’ingombrante eredità crociana ; ma nonostante questo, e, nonostante la proclamata connessione con la storiografia (la collana accoglierà infatti, benché in numero esiguo, anche saggi monografici di storia letteraria), i « Documenti » segnano una tappa fondamentale verso la definitiva eman-cipazione culturale e metodologica della filologia, che nella visione conti-niana è ancora, insieme, filologia romanza e filologia italiana, senza barrie-re cronologiche (dal Medioevo al xix secolo) né linguistiche (giacché, per quanto riguarda la letteratura delle origini, la collana fa posto a testi non solo italiani, ma anche provenzali, francesi, castigliani e mediolatini).
E davvero sono anni decisivi, questi, per l’ingresso a pieno titolo della filologia tra le forze più vitali della cultura e dell’università italiana. Mentre vengono bandite le prime cattedre di filologia italiana e di filologia medie-vale e umanistica (sollecitate nel 1949 da Pasquali con un articolo che si
18 G. Contini, La parte di Benedetto Croce nella cultura italiana, cit., p. 55.19 Si veda Guglielmo Gorni, Esame di coscienza di un filologo alla luce delle rime di Leon Battista
Alberti, « Albertiana », viii (2005), pp. (181-197), 181-185 (è il testo, abbreviato, della prolusione con cui Gorni inaugurò il 27 febbraio 2003 il suo insegnamento di Filologia italiana presso la Facoltà di Scienze umanistiche dell’Università di Roma « La Sapienza »).
francesco bausi34meritò la replica polemica del Croce),20 e i gloriosi « Studi di Filologia Italia-na » riprendono regolarmente le pubblicazioni a partire dal 1950 dopo una pausa di sei anni (nel 1958 ne assumeranno la direzione Bruno Migliorini e Gianfranco Contini, e quest’ultimo ne sarà poi direttore unico dal 1965 al 1970), Gianfranco Folena diviene nel 1959 direttore degli « Scrittori d’Italia », che immediatamente segnano un rapido incremento del proprio rigore fi-lologico, come accade anche ad altre collane similari, quali i classici Utet e soprattutto i classici Ricciardi, che nel 1960 vedono l’apparizione dei monu-mentali Poeti del Duecento, curati da Contini e, sotto la sua guida, da un ma-nipolo di giovani studiosi cui saranno affidate nei decenni successivi le sorti magnifiche della filologia italiana. Nel 1958, Dionisotti, Billanovich, Campa-na e Sambin fondano « Italia Medievale e Umanistica » (e l’anno successivo Billanovich, insieme a Rino Avesani e a Giovanni Pozzi, dà vita presso lo stesso editore alla collana « Medioevo e Umanesimo »), onde assicurare ade-guato spazio a quei versanti che Contini e la sua scuola lasciavano in ombra (denunciando in questo un persistente legame con l’eredità crociana e, in termini più generali, una forte pregiudiziale anticlassicistica) e che fin dal 1942 don Giuseppe De Luca, affiancato dai medesimi Dionisotti, Billanovich e Campana, oltre che da Schiaffini, aveva posto al centro dell’ambizioso progetto delle Edizioni di Storia e Letteratura : il Medioevo e l’Umanesimo latino, e la grande erudizione sette-ottocentesca, sia laica che ecclesiastica.21 Viene così sancita definitivamente, non senza ripercussioni anche sul piano metodologico, la separazione della filologia medievale e umanistica dalla filologia romanza e italiana, cui farà seguito negli anni a venire un’ulteriore progressiva frammentazione interna – favorita anche da ragioni di politica accademica – che è una tra le cause non secondarie del declino del ruolo culturale e sociale delle scienze filologiche nel nostro paese.
In effetti, a partire dalla fine degli anni ’40 si sono confrontate in Italia due filologie, quella più “tecnica”, caratterizzata dall’adozione di metodo-logie altamente formalizzate, e quella più “storicistica” e “letteraria”, mag-giormente legata alla nostra tradizione storiografica, critica ed erudita : una distinzione, questa, che presenta anche importanti riflessi “pratici”, nella misura in cui la prima delle due filologie professa generalmente il lach-manniano recensere sine interpretatione, ostentando fiducia nel “metodo” e nelle sue più asettiche applicazioni, laddove la seconda tende a privilegiare
20 Giorgio Pasquali, Cattedre di filologia italiana, romanza, medioevale, « Lo Spettatore Italiano », ii (1949), ? ?, pp. 132-135, poi, in Id., Scritti sull’università e sulla scuola, con due appendici di Piero Ca-lamandrei, introduzione di Marino Raicich, Firenze, Sansoni, 1978, pp. 337-343 ; Benedetto Croce, Sdegni filologici fuori luogo, « Lo Spettatore Italiano », ii (1949), ? ?, pp. 178-179.
21 Non è irrilevante, anche alla luce di quanto detto in precedenza, il fatto che il primo numero di « Italia Medioevale e Umanistica », come di lì a poco quello di « Studi e Problemi di Critica Testuale », si apra in medias res, senza alcuna premessa di carattere teorico e metodologico.
fasti recenti e incerti orizzonti 35lo iudicium rispetto alle procedure meccaniche di natura stemmatica, e a non recidere i ponti con l’esegesi e la storia letteraria. Emblematico, sotto questo aspetto, può considerarsi il convegno bolognese Studi e problemi di critica testuale, celebrato dal 7 al 9 aprile 1960 dagli stati generali della filo-logia e della linguistica italiana dell’epoca :22 accanto ai riconosciuti maestri (Spongano, Devoto, Migliorini, Schiaffini, Maggini, Terracini, Sàntoli) tro-viamo infatti, e sono la maggioranza, i più prestigiosi studiosi della genera-zione di mezzo (Contini, Dionisotti, Branca, Corti, Roncaglia, Billanovich, Caretti, Ageno, Nencioni, Marti) ed esponenti già affermati delle giovani leve (Folena, Castellani, Domenico De Robertis, Segre, Raimondi). Dalle pagine degli atti emerge il profilo di una filologia dinamica e aggiornata ma al tempo stesso, nella maggior parte dei relatori, solidamente ancorata alla nostra migliore tradizione culturale ; non a caso Spongano, nella sua premessa al volume, volle ricollegare direttamente il convegno a quello, analogo, progettato cento anni prima dalla Commissione per i testi di lin-gua (della quale egli stesso era presidente dal 1953) nella « stagione dei pri-mi filologi e linguisti dell’età moderna e della nuova Italia », citando fra gli altri D’Ancona e Comparetti, Ascoli e Mussafia, Carducci e Teza, Barto-li e Monaci, D’Ovidio e Rajna, dai quali, attraverso Parodi e Barbi, face-va discendere la presente fioritura filologica italiana.23 Non erano, queste, semplici parole d’occasione, se si pensa che tre anni prima, inaugurando i « Documenti », Contini aveva voluto sottolineare l’estraneità di quel nuovo progetto editoriale rispetto alla vecchia idea « angustamente umanistica » di filologia, escludendo con risolutezza dalla nuova collana « la mera curiosità erudita », con un chiaro riferimento dunque, non solo, e genericamente, alla tradizione sette-ottocentesca, ma in particolare alla Commissione bo-lognese e alle sue due benemerite collane, la « Collezione di opere inedite e rare » e la « Scelta di curiosità letterarie ».
Nella medesima sede proemiale, Spongano precisava l’idea di filologia cui il convegno si era ispirato :alieni come siamo dal considerare la filologia come strumentale alla critica, perché di procedimenti, giudizi e intuizioni e persino di sensibilità critica essa si avvale fin nel suo stesso farsi, e non ne può prescindere, non possiamo fare a meno di additare, proprio nella conferma che questa convinzione riceve dalla presente raccolta di studi, uno dei risultati più importanti, anche se dei meno proclamati, di questo convegno. E indiche-remo anche l’altro, altrettanto sottinteso ma altrettanto operante, checché ne sembri da qualche dichiarazione dall’apparenza contraria : della filologia che non è ausilio ma procedimento storico e, in ciò, scienza morale, non scienza naturale. Che se a tale fu
22 Cfr. R. Antonelli, Interpretazione e critica del testo, cit., p. 234.23 Raffaele Spongano, Premessa, in *Studi e problemi di critica testuale. Convegno di studi di fi-
lologia italiana nel centenario della Commissione per i Testi di Lingua (7-9 aprile 1960), Bologna, Commissione per i Testi di Lingua, 1961, pp. (v-vii), v.
francesco bausi36ridotta talvolta, ciò avvenne solo in tempi in cui, per errore o per fuorviata illusione gnoseologica, a tale si tentò di ridurre anche tutte le altre scienze dello spirito.24
Spongano prendeva dunque le distanze sì da Croce e da ogni considera-zione ancillare della filologia, ma anche e forse ancor più dalle sempre più vivaci tendenze formalistiche, delle quali proprio in apertura del convegno si era fatto portavoce Giacomo Devoto, che aveva concluso la sua relazione affermando : « contro la “storia spirituale” del critico e del linguista puro, contro la “storia intellettuale” dello storico della cultura, la storia del fi-lologo in quanto critica del testo è una “storia naturale” ».25 Polemizzando implicitamente con Devoto – studioso precocemente influenzato dalla lin-guistica strutturale, e non a caso molto apprezzato da Contini26 – Sponga-no ribadiva la sua idea “umanistica” di filologia, e dunque anche il forte legame di questa con la critica ; non stupisce pertanto che egli difendesse l’inserimento negli atti, all’ultimo posto, di un saggio non filologico, quello di Giovanni Getto dal titolo Echi di un romanzo barocco nei « Promessi sposi » : « non vi si è incluso a caso – scriveva – e non rappresenta un divertissement, se è vero che non è ‘testo’ la sola “lezione” di un testo ma anche la chiave e i cambiamenti di chiave in cui fu concepito e a cui quella lezione consuona ».27 D’altronde, accanto a quella di Getto, anche altre relazioni – come quelle di Nardi, Firpo e Bonora – presentavano un carattere storico-critico e non strettamente filologico o linguistico.
Sulle posizioni di Spongano si assestava anche Aurelio Roncaglia (il qua-le premetteva come il titolo della sua relazione, Valore e giuoco dell’inter-pretazione nella critica testuale, gli fosse stato suggerito, se non imposto, da Spongano stesso) : a suo parere, infatti, nella critica testuale quasi nessuna operazione è possibile prescindendo dall’interpretazione, compreso « lo stesso procedimento stemmatico », perché il riconoscimento degli errori « presuppone un atto interpretativo », che deve essere attento non solo alla lingua, al senso del passo e del contesto, alla punteggiatura, ma anche allo stile e al contesto « extraletterario », cioè quello « di natura storica e prati-ca ».28 Ancor più recisamente, Antonino Pagliaro sosteneva che il problema testuale della Commedia « si configura come un aspetto dell’esegesi, e non è suscettibile di soluzione se non nell’ambito di questa », auspicando una recensio il più possibile ampia « non ai fini non perseguibili di presunte stem-
24 Ivi, pp. vi-vii (corsivi dell’autore).25 Giacomo Devoto, Il testo come fine e il testo come mezzo, in *Studi e problemi di critica testuale,
cit., pp. (3-15), 15.26 Gianfranco Contini, La stilistica di Giacomo Devoto (1950), poi in Id., Varianti e altra linguistica,
cit., pp. 673-686.27 R. Spongano, Premessa, cit., p. vi.28 Aurelio Roncaglia, Valore e giuoco dell’interpretazione nella critica testuale, in *Studi e problemi
di critica testuale, cit., pp. (45-62), 50-51 e 54.
fasti recenti e incerti orizzonti 37matiche, ma perché si pongano le basi sicure di quella interpretatio, di cui il testo critico sarà l’atteso risultato », e arrivando ad affermare che « la scel-ta della lezione testuale è, in sostanza, un aspetto dell’attività esegetica ».29 Come si vede, l’impostazione “umanistica” del convegno comportava fra l’altro, nell’impianto generale e in numerosi interventi, un approccio libero e critico nei confronti del lachmannismo e dei suoi aspetti più “meccanici” ; non per nulla, alcuni relatori indagavano problemi filologici che, in quanto irriducibili al metodo ricostruttivo, ne rivelano l’insufficienza in determina-te situazioni.
In particolare, Vittore Branca (riprendendo e sviluppando alcune consi-derazioni esposte due anni prima nella prefazione al suo volume Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio),30 dichiarava che la tradizione del Decameron « non si ramifica secondo le consuete, canoniche linee di uno schematico albero genealogico, ma piuttosto con la irregolarità avventurosa, con la prepotente indisciplinatezza di una massa di virgulti su un tallo incolto », cosicché « per la ricostruzione della tradizione caratterizzata, per la “recen-sio”, è fattore indispensabile e ineludibile la conoscenza approfondita di quella che ho proposto di chiamare tradizione caratterizzante », che studia « le vie e i modi, il come e il perché della diffusione di un’opera ».31 D’altro canto, Vittorio Sàntoli e Domenico de Robertis dimostravano l’impossibi-lità e l’inutilità dell’applicazione del metodo di Lachmann rispettivamente ai testi popolari (nei quali « la tradizione [...] coincide con i testi stessi ») e ai cantari (la cui tradizione, fortemente “attiva”, presenta un « carattere tipi-camente redazionale, rielaborativo anziché riproduttivo », e nella quale di conseguenza « ogni testo ha il suo valore » e la « lectio singularis [...] non è mai secondaria ») ;32 ed Ezio Raimondi indagava su un caso concreto l’importan-za in filologia dello studio delle stampe e del loro intrecciarsi, concludendo col riaffermare « il principio di una filologia integrale : dove la parola non può essere disgiunta dal senso della storia, dall’idea dell’uomo e del suo mondo concreto, della sua ricchezza di strutture e di forme ».33
Non era dunque una filologia di retroguardia quella di Spongano e del convegno bolognese, che dieci anni dopo avrebbe dato il titolo all’omonima rivista (diretta dal medesimo Spongano fino al 1995), ispirata parimenti « a un’idea modernamente complessa di filologia, non ristretta al puro aspetto ecdotico, ma inclusiva di tutto ciò che concerne l’esegesi dei testi letterari
29 Antonino Pagliaro, Il testo della « Divina Commedia » e l’esegesi, in ivi, pp. (307-333), 307 e 310.30 Vittore Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio. Un primo elenco dei codici e tre studi,
Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1958, pp. (ix-xxxiii), xv-xxxiii.31 Id., Copisti per passione, tradizione caratterizzante, tradizione di memoria, in *Studi e problemi di
critica testuale, cit., (pp. 69-83), 73 e 77.32 Vittorio Sàntoli, La critica dei testi popolari, e Domenico De Robertis, Problemi di metodo
nell’edizione dei cantari, in ivi, rispettivamente pp. 111-118 e pp. 119-138.33 Ezio Raimondi, Note sulla tradizione a stampa di testi secenteschi, in ivi, pp. (159-71), 171.
francesco bausi38e la loro collocazione nel loro contesto storico e in un più vasto reticolato intertestuale ».34 Una simile visione della filologia si riflette con chiarezza in alcuni dati che balzano agli occhi scorrendo le pagine degli Atti : esiguo, ad esempio, è il numero delle relazioni di teoria e metodologia ecdotica ; la lin-guistica è ben rappresentata e il suo rapporto con la filologia ripetutamente sottolineato, ma essa è ancora intesa per lo più nel senso tradizionale di storia della lingua ; la critica stilistica trova ampio spazio (soprattutto negli interventi di Benvenuto Terracini e Dante Isella), e tuttavia sempre in un quadro generale di forte impronta storicistica. Solo pochi tra i partecipanti – segnatamente Devoto e Contini – si muovono in un’orbita diversa ; ma il vento stava rapidamente cambiando, e proprio quella sarebbe divenuta di lì a poco la linea vincente, almeno nella filologia italiana e nella romanistica. La rapida diffusione dello strutturalismo, infatti, determinò lo spostamento del metodo filologico verso una dimensione marcatamente “scientifica”, producendo un incremento del tecnicismo a tutti i livelli, con una forte tendenza alla formalizzazione e all’uso di procedimenti e linguaggi desunti dalle scienze esatte e dalla linguistica strutturale. Basti ricordare qui la fon-dazione nel 1966 della rivista « Strumenti Critici », ad opera di Avalle, Corti, Isella e Segre ; l’uscita di saggi quali La critica testuale come studio di strutture di Contini (1967) e I segni e la critica di Segre (1969) ; l’apparizione nel 1972 dei Principi di critica testuale dello stesso Avalle.
Lo strutturalismo ha permesso alla filologia di presentarsi e affermarsi come scienza, contribuendo in maniera decisiva al superamento dell’ipo-teca estetica, psicologistica e “contenutistica” che continuava a gravare sui nostri studi letterari, e mettendo al centro il testo nella sua materialità e nelle sue leggi autonome e interne : donde, ad esempio, il nuovo impulso fornito alle ricerche metriche e retoriche (per lo più neglette dopo Carducci e la Scuola storica), e la definitiva formalizzazione “scientifica” della filo-logia e in particolare dell’ecdotica, svincolata così da quel ruolo subalter-no e strumentale ancora attribuitole negli anni ’50 da molti dei suoi stessi cultori. Ha inizio allora il periodo aureo della nostra filologia, che, dietro le orme dei grandi maestri nel pieno della loro attività, raggiunge vertici assoluti di consapevolezza teorica e perfezione tecnica ; ma ha inizio nello stesso momento, a ben vedere, anche il suo declino, o meglio il declino della sua funzione storico-culturale e formativa. Il fenomeno è riconduci-bile a un complesso di cause, tra loro correlate, che provo qui a elencare sommariamente :
1) distacco della filologia dalla storia, generato dal presupposto della “au-tosufficienza” del testo, che conterrebbe in sé tutti gli elementi necessari alla
34 Così nella presentazione della rivista che si legge sul sito internet dell’attuale editore, Fabrizio Serra (www.libraweb.net).
fasti recenti e incerti orizzonti 39sua comprensione. Il rifiuto delle componenti allotrie ed estranee (ideolo-giche, psicologiche, politiche, filosofiche, autobiografiche) si traduce in un paradossale ritorno a Croce e alla sua distinzione di poesia e non-poesia.
2) preminenza assegnata all’ecdotica, cioè alle tecniche editoriali e all’edi-zione critica, e sostanziale identificazione di tali operazioni con la filologia pura e semplice.
3) divorzio tra ecdotica e interpretazione, che si traduce nell’idea (ma me-glio sarebbe definirla pericolosa illusione pseudo-scientifica) secondo cui l’edizione critica non debba prevedere né commento (storico ed esplicativo) né – ove il testo non sia in italiano – traduzione, e che riproduce, nelle sedi e talora anche nelle persone, la vecchia separazione crociana di filologia e critica (a parti capovolte, almeno in teoria, cioè questa volta col riconosci-mento di un maggior prestigio “scientifico” al momento filologico).35
4) identificazione, soprattutto in Italia, del metodo filologico “scientifico” col solo metodo ricostruttivo e stemmatico, non sempre e non da tutti oppor-tunamente “rivisto” alla luce dei correttivi bédieriani, del richiamo di Pasquali e Billanovich alla storia della tradizione, dell’attenzione al manoscritto inteso come vivo documento storico, anziché come mero tramite di lezioni.
5) proliferazione di edizioni critiche di autori minori, che offrono in ge-nere un ottimo campo d’azione al filologo ricostruttivo, laddove in molti casi i “maggiori” non altrettanto bene si prestano – per il gran numero di testimoni delle loro opere e per la maggior complessità della storia della tradizione – al metodo stemmatico.
6) tecnicizzazione sempre più spinta dell’ecdotica, nel metodo, nei modi di presentazione e di realizzazione tipografica, nel linguaggio (che giunge talora ai limiti del gergo ermetico-criptico, anche per il prestigio del model-lo continiano).
7) marcato e talora esasperato conservatorismo paleografico, generato dalla convinzione che anche minime particolarità grafiche costituiscano un elemento culturalmente rilevante e necessario alla piena comprensione di un’opera.
8) larga diffusione di astratte discussioni metodologiche, ossia di una fi-lologia “a tavolino” intesa come « ludo di astratta logica formale »36 e talora lontana dai problemi pratici del concreto lavoro “sul campo”.37
35 Già Michele Barbi, La nuova filologia e l’edizione dei nostri scrittori da Dante a Manzoni, Firenze, Sansoni, 1973 (19381), p. xxv, ebbe a reagire, in nome di uno « storicismo totalitario », contro quei “maestri” « che volevano l’edizione critica senza la critica ». Da ultimo cfr. a questo proposito le efficaci considerazioni e i persuasivi esempi di Giorgio Inglese, Ecdotica e commento ai testi letterari, « La Cultura », xlix (2011), ? ?, pp. 277-283.
36 Mario Martelli, Lucia Cesarini Martinelli e gli studi di filologia umanistica, in *Lucia Cesarini Martinelli. Umanesimo e filologia, a cura di Sebastiano Gentile, Roma, Edizioni di Storia e Lettera-tura, i.c.s.
37 Come scrive Luciano Formisano, Gaston Paris e i “Nouveaux philologues”, « Ecdotica », ii (2005),
francesco bausi409) ampia fortuna di una prevalente concezione formalistica della lettera-
tura, che privilegia il dato tecnico (linguistico, metrico, retorico) nell’inter-pretazione dei testi, considerando la ricerca sul linguaggio, sullo stile e sulla forma il necessario – e talora sufficiente – contrassegno della grande arte, e per questo concedendo la maggiore attenzione a testi e ad autori connotati o connotabili in senso “espressionistico” (donde anche l’idea antistorica se-condo cui « la frequentazione con il formalismo medievale prepari a capire il formalismo moderno »).38
E così, mentre nell’accademia, nell’editoria e nelle riviste specializzate, nel numero dei suoi praticanti e nella considerazione ufficiale la filologia toccava l’apice delle sue fortune, riprendevano vigore mai sopiti umori antifilologici, nei quali le tendenze “contenutistiche” (di matrice crociana, estetica, psicologistica) radicate nella nostra cultura si saldavano con più avanzate istanze ideologiche e filosofiche di varia natura, fra marxismo, psi-canalisi e irrazionalismo post-moderno (nelle sue diverse manifestazioni, dal “pensiero debole” al decostruzionismo). Nel 1975, Franca Ageno apriva il suo fortunato manuale L’edizione critica dei testi volgari evocando i due topici pregiudizi secondo i quali le edizioni critiche sono edizioni illeggibili (per-ché adottano grafie del tipo et, tucto, havere) e le fatiche filologiche devono ritenersi puramente servili rispetto all’interpretazione critica ;39 pregiudizi ancor oggi ampiamente condivisi, benché di rado, in Italia, pubblicamente espressi. Della filologia, infatti, si parla generalmente con ammirazione e deferenza ; ma, come scrisse Gugliemo Gorni, si tratta spesso del riguardo dovuto a « una vecchia signora rispettabile », dalla quale, una volta che le si è reso il debito omaggio, è meglio stare alla larga « e lasciare l’uggioso contenzioso che si trascina dietro a chi è nato con questa vocazione o ca-priccio ».40 Lo stesso Gorni, appena trentenne, recensendo a caldo nel 1976 il libro della Ageno osservava con coraggio che di questo disagio « gran parte della colpa spetta ai cattivi filologi », cioè ai « tecnici più chiusi e arroganti,
pp. (5-22), 5, il raffinato riflettere della filologia sui propri metodi e sul suo statuto epistemologico « può anche essere visto come il sintomo di una crisi, la misura del solco che si è venuto a creare tra uno specialismo sempre più avvertito e sicuro di sé e la reale capacità di incidere sul “sistema” della cultura ».
38 Paolo Cherchi, Filologie del Duemila (2001), in Id., Le nozze di Filologia e Fortuna, Roma, Bagat-to, 2006, pp. (17-41), 36.
39 Franca Brambilla Ageno, L’edizione critica dei testi volgari, Padova, Antenore, 1975, p. 3.40 Guglielmo Gorni, Filologia materiale, filologia congetturale, filologia senza aggettivi, « Modern
Language Notes », cxix (2004), ? ?, pp. (108-119), 110. Lo stesso studioso (La filologia di Franca Ageno. Dal manuale di critica testuale all’edizione del « Convivio », « Schede Umanistiche », n.s., i (1997), 1, pp. [7-31], 9-10) ricorda che la Ageno « non tollerava dubbi e obiezioni », essendole estranea « una concezio-ne problematica della disciplina » ; ma – continua – questa sorta di « clausura filologica » non poteva bastare ai giovani di allora : « Tutto intorno la vita, i metodi nuovi, gli strumenti critici : e invece in quel volume di Antenore, come in un austero convento, vigeva la regola ferrea di Franca Ageno ».
fasti recenti e incerti orizzonti 41restii al commercio delle idee e diffidenti o indifferenti alle ragioni della storia, quelli che hanno perso, come si dice, il contatto con la realtà ».41
Monumentalizzazione e autoreferenzialità : questi sono i due rischi cui la filologia è andata incontro in Italia nell’ultimo mezzo secolo. La monu-mentalizzazione scaturisce dal rispetto e dal prestigio riconosciuti sì alla filologia, ma al di là di ogni verifica reale delle sue operazioni e dei suoi prodotti, verifica che è di fatto impossibile ai più, anche se specialisti di letteratura ; rispetto e prestigio che nascono a loro volta dal carattere so-vente “intimidatorio” della filologia, per le raffinate competenze e la mole di lavoro che essa richiede, per il linguaggio tecnico, per il largo ricorso a strumenti difficili da maneggiare per chi non sia del mestiere (stemmi, descrizioni di manoscritti, apparati, tavole), per l’uso di metodi e schemi di tipo matematico, per la stessa natura dei testi su cui di preferenza il filo-logo esercita la propria arte. L’autoreferenzialità viene di conseguenza : le edizioni critiche, spesso costose, ingombranti, scomode, sono da tutti am-mirate ma da pochi usate, e molti preferiscono leggere e citare i testi dalle più maneggevoli e meno pretenziose edizioni commerciali, anche perché è diffusa – purtroppo non sempre infondatamente – la convinzione che poi, alla fine, l’edizione critica muti il testo solo in rari e non decisivi luoghi, e dunque serva esclusivamente ai filologi, non ai critici, agli storici delle idee e tanto meno agli studenti o ai lettori comuni.
Inoltre, la filologia – così come è stata intesa, praticata e presentata a par-tire dagli anni ’60 – “musealizza” la letteratura, col pericolo concreto, talora, di inibirne la libera fruizione. Non si può studiare seriamente un testo – si pensa e si dice – se non disponiamo della sua edizione critica ; ma non si può fare un’edizione critica se non collazionando tutti i testimoni e disponendo-li con cura nel letto di Procuste lachmanniano (cosicché uno studioso può essere costretto a lavorare per decenni su un’opera, e talora muore o getta la spugna prima di arrivare a pubblicarla) ; non si incoraggia l’allestimen-to di edizioni “di servizio” (commentate ed economiche), perché ritenute scientificamente deboli e scarsamente utili a fini concorsuali ; non ci si può lasciar andare ad alcuna affermazione, anche di modesta portata, se non corredandola di robuste note a piè di pagina che esibiscano le opportune pezze d’appoggio filologiche e ricostruiscano a colpi di bibliografia la storia delle questione, elencando scrupolosamente tutti coloro che se ne sono occupati (e guai a saltarne uno). E dunque : parcellizzazione esasperata del sapere ; eccessiva concentrazione sugli autori minori, che lasciano più spa-zio alla microfilologia e all’erudizione spicciola (mentre le grandi opere esi-
41 Id., recensione a F. Brambilla Ageno, L’edizione critica dei testi volgari, cit., « Studi Medievali », xvii (1976), ? ?, pp. (717-723), 718. Importanti, e di segno analogo, anche le considerazioni privatamen-te espresse riguardo a questo manuale da Carlo Dionisotti : si veda qui più avanti, nota 49.
francesco bausi42gono più tempo, obbligano a defatiganti letture bibliografiche, espongono maggiormente ad errori riconoscibili) ; ricerca accanita del testo inedito o del manoscritto sconosciuto, che induce molti giovani studiosi a raschiare i fondi bibliotecari in cerca di facili prede. Un poeta latino dimenticato, qual-che sonetto adespoto, un manipolo di varianti più o meno persuasivamente attribuibili all’autore, un nuovo testimone : qualcosa si trova sempre, e con una attrezzatura filologica di base (ormai abbastanza facile da procurarsi) si può accumulare il gruzzoletto di pubblicazioni necessario per tentare la carriera accademica.
Stando così le cose – e credo difficile contestare che stiano così –, non stu-piscono le odierne difficoltà delle filologie, che, per i caratteri assunti negli ultimi decenni, maggiormente risentono anche di altri fenomeni comuni a tutti i paesi occidentali : il complessivo declino delle discipline umanistiche e della “civiltà del libro”, il trionfo dell’informatica, la generale crisi eco-nomica e finanziaria. Molti oggi attribuiscono le difficoltà della filologia – come, a dire il vero, ogni altra sventura – ai famigerati “tagli” : ma della crisi delle edizioni nazionali, di alcune collane di classici e in genere dell’editoria scientifica proprio la nostra idea e la nostra pratica della filologia sono tra le cause principali, giacché l’edizione critica a norma lachmanniana impone in molti casi tempi e costi ormai insostenibili, a fronte di una ricaduta (non solo commerciale, ma anche culturale) per lo più modesta. In questo con-testo trova spiegazione la nascita, negli ultimi vent’anni, di tendenze filolo-giche più o meno rivoluzionarie e/o riformatrici, soprattutto all’estero, in paesi nei quali da un lato è minore il prestigio accademico della filologia, e dall’altro non vige, tra i filologi, il primato del metodo stemmatico.
Certo, è stato sin troppo facile per gli esponenti più illustri della nostra scaltrita filologia controbattere gli assalti tutt’altro che irresistibili di Ber-nard Cerquiglini (il cui Éloge de la variante risale al 1989) della New Philolo-gy e delle Textual Cultures, col loro appello spesso ingenuo all’autenticità materiale, evenemenziale ed antropologica del documento, nonché alla di-mensione “soggettiva” del lavoro filologico, di contro allo scientismo, alle alchimie ricostruttive e alla testo-latria della filologia tradizionale. Nondi-meno, come ha osservato Paolo Cherchi,42 la New Philology è un campanello d’allarme che non deve essere sottovalutato, poiché essa « potrebbe essere sintomatica di un qualcosa che non funziona, di un certo fastidio o disagio o stanchezza che si avverte anche in Europa » e in Italia, dove all’interno della stessa comunità filologica si moltiplicano, da qualche anno, i segnali di malessere. Una volta messi da parte i suoi aspetti più folkloristici e ideo-logici (l’edizione critica come atto borghese, autoritario e maschilista, o le facili suggestioni “derridaiche”, come le chiamava sarcasticamente Giovan-
42 P. Cherchi, Filologie del Duemila, cit., p. 24.
fasti recenti e incerti orizzonti 43ni Orlandi),43 e superato l’eccessivo entusiasmo riposto nelle possibilità e nei vantaggi offerti dalle “edizioni elettroniche”,44 bisogna riconoscere che la New Philology si è fatta portatrice di istanze non trascurabili, in particolare per quanto riguarda la critica a una filologia ingessata nella sua totalizzante pretesa di scientificità. A poco vale, come spesso si fa, ricordare che l’edizio-ne critica è solo un’ipotesi di lavoro e non pretende di stabilire il testo ma solo un testo dell’opera : di fatto, la fissità del libro stampato, il prestigio del filologo, l’aura algida e asettica dell’edizione critica di tipo neo-lachmannia-no, nonché la pratica di travasare il testo critico (senza nota introduttiva e senza apparati, e dunque senza giustificazione e senza possibilità di verifica) nelle edizioni commerciali, fanno diventare quello il vero e unico testo di quell’opera. Inoltre, la New Philology si richiama da un lato alle procedure dell’editoria informatica, dall’altro alla filologia dei testi a stampa (o Textual Bibliography), due settori che hanno contribuito efficacemente a mettere in discussione la monoliticità di alcune nozioni basilari della disciplina filolo-gica, da quella di autore (di autore unico, cioè, e di ultima volontà dell’au-tore) a quella stessa di testo. Innegabile è poi la filiazione della New Philology dal pensiero post-moderno, il quale – annullando le distanze fra presente e passato, sostituendo la superficie alla profondità, la sincronia alla diacronia, l’appropriazione onnivora alla distanza rispettosa, l’attualizzazione alla sto-ricizzazione, lo spazio al tempo, il frammento decostruito alla totalità or-ganica, la pluralità di significati (o opera aperta) all’univocità dell’interpre-tazione – crea un ambiente culturale poco adatto alla filologia tradizionale, sia in senso stretto (ecdotica) che in senso lato (studio storico e “oggettivo” del passato), e più consono, invece, a una filologia che prenda atto, cercan-do di riprodurla con gli strumenti informatici, della perenne mobilità dei testi e della costitutiva provvisorietà di ogni loro restituzione.
Nel recinto ben protetto della filologia italiana scarsa, in definitiva, è stata l’eco della New Philology, e modeste le sue ripercussioni nella concreta pras-si ecdotica (una delle più significative è la bistrattata edizione Savoca del Canzoniere petrarchesco, apparsa nel 2008).45 Ma simili polemiche possono
43 Giovanni Orlandi, Perché non possiamo non dirci lachmanniani (1995), in Id., Scritti di filologia me-diolatina, raccolti da Paolo Chiesa et alii, Firenze, sismel-Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. (95-130), 122.
44 Si veda ad es. Lorenzo Perilli, Filologia classica in prospettiva : machina, ratio et res ipsa, in *I nuovi orizzonti della filologia. Ecdotica, critica testuale, editoria scientifica e mezzi informatici elettronici. Convegno internazionale, Roma, 27-29 maggio 1998, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1999, pp. (133-156), 135 : « il nuovo concetto di edizione, ormai non più critica, prevede la sostanziale rinuncia alla tradizionale costituzione di un testo ottenuta mediante selezione, in vista di una opposta, to-talizzante disponibilità dei materiali in formato elettronico – facsimile di manoscritti, trascrizioni, collazioni, studi critici, etc. –, per consentire al lettore, al fruitore, di “costruirsi”, qualora lo deside-ri, un proprio testo, di ripetere le collazioni, di realizzarle secondo criteri diversi, in sostanza di (ri)organizzare i materiali nei modi più liberi ».
45 Francesco Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, edizione critica di Giuseppe Savoca, Firen-ze, Olschki, 2008.
francesco bausi44valere, se non altro, a mettere in crisi l’immagine snobistica e francamen-te indisponente del filologo come depositario di una scienza esoterica ed elitaria, nonché della filologia come ascesi e arduo itinerario della mente verso il vero, come sacerdozio che ha i suoi esercizi (non spirituali, ma di lettura) e il suo breviario (non di liturgia né di estetica, ma di ecdotica), che esige ed esibisce, anche nella scrittura e nella vita dei suoi cultori, austerità, moderazione, distacco e obiettività. Proprio questa trasformazione della filologia in una scienza autonoma e autosufficiente, rotta l’osmosi con la critica, la condanna alla marginalità : è senz’altro vero, in linea di princi-pio, che « senza acribia filologica ogni critica è destinata ad essere mediocre e inaffidabile »46 e che la filologia « è il discrimine certo tra l’officina dello scienziato e il magazzino delle ciance »,47 ma neppure si può negare che esi-stano anche ciance filologiche e che la filologia senza la critica (cioè senza la storiografia e l’interpretazione) rischi a sua volta di diventare puramente autoreferenziale, smarrendo ogni contatto con la storia e con la “vita” vera dei testi e della cultura, e incorrendo dunque, sia pure per ragioni opposte, nello stesso vizio che essa rimproverava un tempo alla critica speculativa e impressionistica. Né pare revocabile in dubbio che occorra deporre il feticismo del “testo”, considerato alla stregua di un’entità significante au-tonoma, a favore di una filologia che « non consideri il suo oggetto come enucleabile a prescindere dalla totalità culturale », e guardi pertanto al testo anche come elemento di una rete di rapporti (linguistici, letterari, culturali, sociali), anzi come esso stesso “rapporto”.48 Già nel 1963, in tempi dunque non sospetti, Dionisotti metteva in guardia dall’errore di parlare di testi « senza badare agli uomini » ;49 ammonimento tanto più valido oggi, dopo che strutturalismo e semiologia hanno diffuso la persuasione che tutto – non solo la letteratura – sia riducibile a parola, e che il mondo (in una sorta di nominalismo assoluto dai chiari contorni nichilistici) debba essere letto
46 Margherita Spampinato Beretta, intervento alla Tavola rotonda finale su Filologia romanza e comparatistica, in *Le letterature romanze del Medioevo : testi, storia, intersezioni. Atti del v Convegno nazionale, Roma, 23-25 ottobre 1997, a cura di Antonio Pioletti, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2000, pp. (317-323), 322.
47 G. Gorni, recensione a F. Brambilla Ageno, L’edizione critica dei testi volgari, cit., p. 718.48 Nicolò Pasero, Intervento alla Tavola rotonda finale su Filologia romanza e comparatistica, in *Le
letterature romanze del Medioevo, cit., pp. (337-340), 340.49 Carlo Dionisotti, Il filologo e l’erudito, in *Don Giuseppe De Luca. Ricordi e testimonianze, a cura
di Mario Picchi, Brescia, Morcelliana, 1963, pp. (143-167), 155. Si veda anche p. 158 : « anche la filologia, anche l’erudizione, quando non si risolvano in letteratura e storia, possono essere scappatoie. Sono state e sono assai spesso tali ». Non stupiscono, pertanto, le dure parole pronunciate dodici anni dopo dal medesimo Dionisotti a proposito del manuale di Franca Ageno (qui sopra citato alla nota 39) in una lettera privata parzialmente pubblicata da Mirella Ferrari, Dionisotti e « Italia Medioeva-le e Umanistica », « Aevum », lxxxiii (2009), ? ?, pp. (953-959), 956, dove il libro è ritenuto esemplare di una « filologia così soddisfatta di sé, […] così incurante della tradizione, dei produttori e degli uten-ti, degli aspetti sociali e giuridici di ogni produzione letteraria » (al riguardo, in questi stessi Atti, il contributo di Leonardo Quaquarelli, che ringrazio per avermi segnalato la lettera dionisottiana).
fasti recenti e incerti orizzonti 45alla stregua di un mero labirinto di segni il cui significato coincide in ultima analisi col significante. Avvicinare i giovani ai testi è importante ed è certo uno dei nostri principali compiti, ma il filologo dovrebbe evitare di presen-tarsi come il geografo del Piccolo principe, facendosi portatore della nefasta idea secondo cui – per dirla con Hans Blumenberg50 – la parola scritta può sostituire l’esperienza, e i libri, essendo gli unici depositari del “senso”, con-tengono tutto ciò che è necessario sapere.
La filologia, beninteso, ha continuato, e tuttora continua (anche se con sempre maggior fatica), ad andare avanti per la sua strada gloriosa e ormai consolidata, né è pensabile di poterne fare a meno, soprattutto se ci si occu-pa della letteratura medievale e umanistico-rinascimentale ; ma è indubbio che altre, e non da ora, siano le vie più battute della cultura contempo-ranea, dentro e ancor più fuori dalle università. Per ovviare a questa sua progressiva marginalizzazione, alcuni hanno pensato negli ultimi tempi di attribuirle compiti e poteri extra-letterari, parlando della filologia come palestra del libero pensiero e della democrazia,51 o come educazione alla lettura critica delle informazioni, utile per addestrarsi a smontare e capire i messaggi spesso ingannevoli dai quali siamo senza sosta assediati.52 Ma sem-brano, questi, obiettivi ad un tempo troppo ambiziosi e troppo riduttivi : da una parte, infatti, la filologia, come diceva Lorenzo Valla, è metodologia neutra, « ars in medio posita », e non può di per sé considerarsi sinonimo di libertà e di verità (così come, allo stesso modo, l’antifilologia di oscuranti-smo e di menzogna) ; dall’altra, pare eccessivo scomodare l’ecdotica per de-codificare un telegiornale o il discorso di un uomo politico (come quando si affermava che bisogna studiare il latino perché “insegna a ragionare”). Si potrebbe anche, e forse meglio, invocare l’utilità della filologia come anti-doto al dilagare inarrestabile della chiacchiera televisiva, telematica e poli-tica, un po’ come fu nell’immediato secondo dopoguerra (in reazione alla verbosità della critica idealistica ed estetica, nonché alla retorica fascista) e come fu per certi giovani studiosi negli anni ’70 (quando, secondo le pa-role di Gorni, la filologia sembrava recare con sé « una rivincita del sapere scientifico [...] sulle troppe promesse mancate di tante cosiddette scienze umane ») ; motivazione certo rispettabile, ma comunque sempre limitata alla sfera dell’autodifesa individuale.
Credo invece che l’utilità della filologia possa e debba oggi essere ribadita
50 Hans Blumenberg La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, Bologna, Il Mulino, 19892, p. 35.
51 Luciano Canfora, Filologia e libertà. La più eversiva delle discipline, l’indipendenza di pensiero e il diritto alla verità, Milano, Mondadori, 2008.
52 Paolo Maninchedda, Filologie e democrazia, in *Testi e tradizioni. Le prospettive delle filologie. Atti del seminario di Alghero, 7 giugno 2003, a cura di Paolo Maninchedda, Cagliari, Centro di studi filologici sardi, 2003, pp. 7-17 ; Id., Perché lo stato dovrebbe pagare gli stipendi ai professori universitari di filologia ?, « Belfagor », lxvi (2011), ? ?, pp. 222-230.
francesco bausi46sul terreno specificamente letterario, da un lato riallacciando il suo nesso con la critica, dall’altro aprendosi a una concezione più larga e meno rigida dell’attività filologica, per uscire da quello che Francesco Bruni – studioso non certo sospettabile di essere un pericoloso paladino dell’antifilologia – ha definito « massimalismo filologico », denunciando la « paralisi incorag-giata da una filologia male intesa, funzionale al gioco dei finanziamenti e agli interessi di corporazioni e microcorporazioni accademiche autore-ferenziali », e affermando che « la realizzazione di edizioni critiche fondate sull’intera tradizione manoscritta o a stampa non dovrebbe fornire un alibi per l’indisponibilità di edizioni che rimettano in circolazione opere spesso importantissime e tuttavia sequestrate da programmi troppo ambiziosi per essere portati a termine ».53
A questo scopo, sono nate in anni recenti, soprattutto all’estero, collane di testi che pubblicano edizioni “di servizio” (o “provvisorie” che dir si vo-glia) condotte senza pretese di esaustività ecdotica, con apparati essenziali o assenti, ma dotate in compenso di traduzioni e note di commento. Il fe-nomeno più interessante è quello della serie « I Tatti Renaissance Library », edita dalla Harvard University Press sotto la direzione di James Hankins, che in dieci anni ha pubblicato oltre cinquanta volumi, vendendone in tutto il mondo più di 70.000 copie e cedendo i diritti delle sole traduzioni inglesi persino in Cina, Giappone e Corea del Sud. È comprensibile che di fronte a questa e a simili operazioni editoriali gli arcigni custodi nostrani della pura scienza filologica abbiano arricciato il naso : ma gli inconvenienti (del resto superabili ove si ricorra a curatori esperti) sono ampiamente compensati dall’enorme beneficio che deriva dalla vasta e rapida messa in circolo non di questo o quel singolo testo splendidamente edito a norma di metodo dopo anni di lavoro solitario, ma di un’intera e spesso negletta civiltà letteraria, quella latina dell’Umanesimo e del Rinascimento. Una buona soluzione – anche dal punto di vista economico – potrebbe essere quella di diversificare le edizioni, riservando al formato elettronico l’edizione critica tradizionale (destinata a pochi specialisti) e stampando su carta l’edizione commentata e tradotta, rivolta a un pubblico più largo.54 Pare evidente, comunque, che dovere della filologia oggi sia rinunciare alla centralità dell’edizione critica tradizionale, puntando decisamente su altre e tuttavia non meno scientifi-che operazioni, quali l’edizione di servizio (che non significa “mal fatta”), il commento e la traduzione ; e accentuando dunque quel ruolo di “media-
53 Francesco Bruni, Edizioni di testi e storiografia. A proposito di due riedizioni parziali dell’« Italia illustrata » di Biondo Flavio e della « Descrittione di tutta Italia » di Leandro Alberti, « Giornale Storico della Letteratura Italiana », cxxiv (2008), ? ?, pp. (399-422), 399-400.
54 Alessandro Zironi, ? ?, in *Storicità del testo, storicità dell’edizione. Atti del Convegno, Trento, 15-17 dicembre 2008, a cura di Fulvio Ferrari e Massimiliano Bampi, Trento, Università degli Studi di Trento, 2009, pp. (43-58), 48.
fasti recenti e incerti orizzonti 47zione” e di “divulgazione” (il momento “politico” dell’edizione, come lo ha definito Cherchi)55 che in questa fase storica è vitale per la stessa sopravvi-venza accademica e sociale della letteratura.
Un altro aspetto decisivo sul quale intervenire, si diceva, è il raccordo con la critica, cioè la pratica e l’insegnamento di una filologia intesa non tanto come tecnica editoriale, quanto come abito mentale e intellettuale necessa-rio a chiunque si occupi, in qualunque modo, di testi : un tirocinio perenne che abitui a osservare e a verificare prima di immaginare, di ragionare e di costruire,56 a preferire i fatti alle ipotesi, a concedere la debita importanza ai dettagli, a non perdere mai di vista la dimensione materiale (linguistica, retorica, metrica) del testo, a capire che è più utile « dominare la lingua che imbottirsi la testa di discorsi generali e di slogan, [...] di professioni di fede civile o politica » ;57 a maturare in buona sostanza il carducciano « odio catilinario alle chiacchiere moralistiche e per mostra di estetica o saccen-teria ».58 Da ciò trarrebbero beneficio sia i filologi, persuadendosi che si fa filologia anche leggendo e interpretando un testo con proba attenzione alla sua storicità concreta e ai suoi aspetti formali ; sia i critici, soprattutto qua-lora estendessero questo habitus latamente ma autenticamente filologico ai territori della letteratura contemporanea, i cui studiosi sono talora sordi se non programmaticamente ostili alla filologia. A porre rimedio a questa situazione (per cui, di fatto, oggi filologo è soprattutto chi studia e insegna la letteratura del Due, Tre e Quattrocento) non è servita, alcuni anni fa, la riunione dei vecchi microsettori delle filologie italiana, dantesca, medievale e umanistica sotto la dubbia etichetta di « Filologia della letteratura italia-na » ; né presumibilmente le cose miglioreranno ora, con l’annessione della filologia italiana alla linguistica, cioè a una disciplina che, fatte salve alcune pur prestigiose eccezioni, non ha ormai più né la letteratura né tanto meno la filologia al centro dei suoi interessi.
In ultima analisi, entrambi questi momenti – quello editoriale e quello critico – dovrebbero tendere al medesimo obiettivo : far uscire la filologia dal suo ghetto dorato, e reimmetterla nel circolo vivo della cultura e della scuola, rinunciando ad ogni pretesa di separatezza e di autonomia per recu-perare, come nell’epoca anteriore allo specialismo accademico, la sua piena ed effettiva annessione a quella che chiamiamo “italianistica”. Se oggi, in-fatti, quello che soprattutto importa è appassionare i giovani alle lettere, al
55 Paolo Cherchi, Filologia d’autore, « Critica del Testo », 8 (2006), ? ?, pp. (861-888), 865.56 Così scriveva Joseph Bédier, Avant-propos a Id., Études critiques, Paris, Armand Colin, 1903, pp.
(vii-xi), ix-x. 57 G. Gorni, Esame di coscienza di un filologo, cit., p. 196.58 Così scriveva Carducci nella lettera del 20 agosto 1886 al suo allievo Luigi Brilli, a proposito
delle note di commento che quest’ultimo stava compilando per la seconda edizione dell’antologia scolastica Letture italiane, da lui curata insieme al maestro (Giosue Carducci, Lettere, Edizione Nazionale delle Opere, Bologna, Zanichelli, 1953, v. xvi, p. 51).
francesco bausi48fine di contrastare la crescente perifericità culturale della letteratura, biso-gna riconoscere che la vecchia filologia non sembra lo strumento migliore per farlo, giacché il necessario rigore storico non può esimere dall’obbligo di presentare i testi come cose vive, anziché come “monumenti” o reperti degni soltanto di restauro e di scavo archeologico. A questo scopo, sarebbe opportuno adoperarsi per far percepire non solo la “distanza” del testo, ma anche la sua “presenza” e la sua “continuità” nel tempo e nello spazio, facendosi carico della « contraddizione costitutiva » e del « problematismo esistenziale » che Contini individuava nella filologia come in ogni altra di-sciplina storica (e che sono intrinseci anche alle rivendicazioni della New Philology), per cui da un lato essa è ricostruzione di un “passato” e sanci-sce, anzi introduce una distanza fra l’osservatore e l’oggetto (il testo), ma per altro verso ripropone nel nostro hic et nunc la “presenza” dell’oggetto stesso.59 Parole che oggi potremmo tradurre in un’esortazione a non mitiz-zare la “scientificità” della filologia e a lasciare aperto uno spazio anche al rapporto “diretto” e “personale” con i testi, senza imporci ed imporre in ogni circostanza un’oppressiva ipertrofia della “mediazione” storicizzante : « certo, nessuno può leggere Dante senza adeguata preparazione e cultura, senza la necessaria mediazione filologica, ma la mediazione deve condurre al ritrovarsi con Dante da solo a solo, ossia a mettere in immediata relazio-ne con la sua poesia ».60 Ma qui è bene fermarsi, prima che a qualcuno possa venire il sospetto che, forse, don Benedetto non aveva tutti i torti.
Università della Calabria
Il saggio ripercorre la storia della filologia in Italia dagli anni ’40 a oggi, indagando le cause della sua ascesa e del suo declino : le prime, riconducibili al tramonto del crocianesimo e all’affermazione delle metodologie formalistiche ; le seconde, individuate nell’eccesso di tecnicismo e nelle pretese di autosufficiente scientificità. La rinuncia alla centralità dell’ecdotica e la piena confluenza della filologia nella storiografia letteraria potrebbero forse aprire una via d’uscita alla presente crisi della disciplina.
The essay traces the history of philology in Italy from the ’40s to the present, investigating the causes of its rise and its decline : the first, due to the decline of Crocianism and to the assertion of formalist methodologies, and the latter, identified in the excess of technicality and self-sufficient scientific pretences. The waiver to the centrality of textual criticism and full confluence of philolo-gy in literary historiography could perhaps open a way out of the current crisis of this discipline.
59 Gianfranco Contini, Filologia (1977), da ultimo in Id., Frammenti di filologia romanza. Scritti di ecdotica e linguistica (1932-1989), a cura di Giancarlo Breschi, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Franceschini, 2007, v. i, pp. (3-58), 5.
60 B. Croce, La poesia di Dante, cit., p. 20. Parole dalle quali nessuno – se non si appaga di avvici-narsi ai testi letterari con lo sguardo dell’entomologo o con il metodo dell’archeologo – credo possa ragionevolmente dissentire, e non solo relativamente a Dante.




































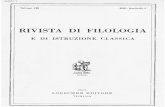

![Il dopoguerra e le origini del fascismo a Forlì e a Cesena (1919-1926) [in P. Dogliani (ed.), Romagna tra fascismo e antifascismo, 2006]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63191026d4191f2f93076d60/il-dopoguerra-e-le-origini-del-fascismo-a-forli-e-a-cesena-1919-1926-in-p-dogliani.jpg)



