Filologia e storia dell'arte. Il ruolo di Vincenzio Borghini nella genesi della Torrentiniana, in...
Transcript of Filologia e storia dell'arte. Il ruolo di Vincenzio Borghini nella genesi della Torrentiniana, in...
Atti delle giornate di studioPisa, Scuola Normale Superiore30 settembre - 1 ottobre 2004
Si ringraziano i partecipanti al convegno e quanti, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, hanno contribuito alla sua organizzazione e alla realizzazione del volume degli atti, in particolare Salvatore Settis e Adriano Prosperi, i quali fin da principio hanno voluto dare il loro sostegno a questa iniziativa.
Eliana Carrara e Silvia Ginzburg
Indice
Rosella Lauber«Et maxime in li occhî». Per la descrizione delle opere d’arte in Marcantonio Michiel 1
Sonia Maffei«Scultor di sensi e non miniator di vocaboli». Alcune considerazioni sul rapporto tra Giovio e Plinio il Vecchio 37
Franco MinonzioIl Museo di Giovio e la galleria degli uomini illustri 77
Silvia GinzburgFilologia e storia dell’arte. Il ruolo di Vincenzio Borghini nella genesi della Torrentiniana 147
Ginette VagenheimLa collaboration de Benedetto Egio aux Antichità romane de Pirro Ligorio: à propos des inscriptions grecques 205
Silvia Tomasi VelliPirro Ligorio, tra ricostruzione antiquaria e invenzione: i circhi e le naumachie di Roma 225
Carmelo OcchipintiL’iconografia del Buon Pastore secondo Pirro Ligorio: primi studî sulle catacombe romane 247
Antonietta PorroPier Vettori, oltre la filologia: il «Viaggio di Annibale per la Toscana» 279
Anna SiekieraLe chiose dantesche di Piero Vettori 303
Eliana CarraraIl ciclo pittorico vasariano nel Salone dei Cinquecento e il carteggio Mei-Borghini 317
Valentina ConticelliAcqua e Fuoco: fonti iconografiche e testuali per due pareti dello Studiolo di Francesco I 397
Riccardo DrusiAncora su Borghini e i testi volgari antichi 421
Maria Fubini LeuzziErudizione, ideologia e politica nel Trattato della Chiesa e Vescovi fiorentini di Vincenzio Borghini 455
Ingo HerklotzDie Hagioglypta des Jean L’Heureux. Ein vergessener Beitrag zur Historisierung der Kunstbetrachtung um 1600 471
Indice dei nomi 505
Illustrazioni 523
1. È lo stesso Vasari a fornire un’indicazione sull’origine del pro-getto delle Vite in una pagina celebre della sua autobiografia dove descrive una delle riunioni avvenute a Roma in Palazzo Farnese nel-la cerchia del cardinal Alessandro. Il dialogo tra l’autore e Paolo Giovio che vi è riportato getta piena luce – almeno in apparenza – sul contesto, le domande, gli interlocutori che diedero vita all’opera che avrebbe sancito un nuovo inizio per la storia dell’arte. Secondo il consolidato parere degli studi furono soprattutto la Roma farne-siana e l’esempio di Giovio a sollecitare Vasari all’impresa; ma pro-prio quel resoconto famoso mi pare indicare che le cose non stanno soltanto così.
Ascoltando il progetto gioviano
d’aggiugnere al Museo ed al suo libro degli Elogi un Trattato, nel quale si ragionasse degli uomini illustri nell’arte del disegno, stati da Cimabue insino a’ tempi nostri
Vasari criticò la genericità o, come lui stesso dice, la grossolanità di quel resoconto.
Ma è ben vero che, bastandogli fare gran fascio, [Giovio] non la guardava così in sottile; e spesso favellando di detti artefici, o scambiava i nomi, i cognomi, le patrie, l’opere, o non dicea le cose come stavano appunto, ma così alla grossa.
Per questo i presenti nella stanza – Francesco Maria Molza, An-nibal Caro, Claudio Tolomei, Romolo Amaseo, Gandolfo Porri-no – suggerirono al cardinal Farnese di affidare a Vasari il compito di scrivere
una ordinata notizia di tutti i detti artefici, e dell’opere loro secondo l’ordine de’ tempi
Filologia e storia dell’arte. Il ruolo di Vincenzio Borghini nella genesi della Torrentiniana
148 Silvia Ginzburg
laddove lo storico comasco, per sua stessa ammissione, ne avrebbe fatto
il più più un trattatetto simile a quello di Plinio1.
Al modello pliniano, per tanti versi e tanto profondamente caro al Giovio, rimanda la prosa densissima dei suoi elogia di Leonardo, Raffaello e Michelangelo redatti a metà degli anni Venti2. Come nei passi sui pittori antichi della Naturalis Historia, l’attenzione si foca-lizza sulle caratteristiche di stile proprie di ciascun artista, descrit-te tramite equivalenti linguistici di dati formali, e sulle coordinate geografiche, con un adeguamento della mappa di Plinio delle scuole pittoriche antiche al contesto dell’Italia moderna che trascura volu-tamente indicazioni cronologiche utili a costruire una tessitura fitta di dati sulla vita e sulle opere degli artisti. Nella coda dell’elogio gio-viano di Raffaello ai nomi di alcuni dei pittori di maggior spicco di primo Cinquecento vengono affiancati attributi di provenienza («il vercellese Sodoma», «il mantovano Costa», ecc.), e succinte indica-zioni dei caratteri dominanti dello stile di ciascuno: viene da credere che, se Giovio l’avesse scritto, il «trattatetto simile a quello di Plinio» avrebbe seguito uno schema simile.
Gli studi hanno più volte indagato la derivazione dall’esempio gio-viano di alcune componenti essenziali dell’impianto delle Vite: l’im-postazione dei medaglioni biografici, l’uso di un lessico atto a descri-vere gli stili, il ruolo affidato ai ritratti3. Minor attenzione viceversa si è dedicata alle critiche mosse da Vasari al Giovio, che pure emergono tanto esplicitamente dal dialogo citato. Dal punto di vista del meto-do, infatti, Vasari giudica l’approccio di Giovio impreciso, pieno di lacune; ed è innanzi tutto per correggere questi difetti che egli fonda
1 G. Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di R. Bettarini, commento secolare a cura di P. Barocchi, Firenze, Sansoni (poi Firenze S.P.E.S.) 1966-1987, VI, p. 389.
2 B. Agosti, Qualche nota su Paolo Giovio (“gonzaghissimo”) e le arti figurative, in «Prospettiva», 97, 2000, pp. 51-62: nota 12 p. 59.
3 T.C. Price Zimmermann, Paolo Giovio. The Historian and the Crisis of Sixteenth-century Italy, Princeton 1995; P. Giovio, Scritti d’arte. Lessico ed ecfrasi, a cura di S. Maffei, Pisa, Scuola Normale Superiore 1999 (Strumenti e testi, 5); Agosti, Qualche nota cit.; Ead., Intorno alla vita gioviana di Raffaello, in «Prospettiva», 110-111, 2003, pp. 58-69.
149 Filologia e storia dell’arte
una storiografia artistica in cui, per la prima volta con nuovo rigore e nuova consapevolezza, si mirano a tenere in debito conto anche i dati («i nomi, i cognomi, le patrie, l’opere») e le date, la sequenza cronologica («secondo l’ordine de’ tempi»).
Con un paradosso che merita di essere meglio compreso, il dialogo tra Giovio e Vasari mette in scena un’inversione di ruoli tra lo storico e l’artista: è il secondo a introdurre la rete a maglie fitte della crono-logia e delle notizie minute contro la genericità del primo, dando così vita alla storia dell’arte. Più che l’emulazione nei confronti di Giovio, che solitamente vi viene letta, quella pagina indica dunque la pole-mica nei confronti del suo metodo (ed è per questo che, nella più tarda reazione contro il fiorentinocentrismo e il manierismo di Vasari che prenderà forma nel passaggio tra Cinque e Seicento sarà di nuovo il modello Plinio-Giovio proprio nella sua valenza antivasariana a venire recuperato e adattato al presente4).
C’è allora da chiedersi cosa significhi una simile polemica e un simi-le scambio di compiti tra Giovio e Vasari, e come accada che l’artista si faccia qui portatore di un modello storiografico che oggi ci appare tanto più moderno di quello proposto dallo scrittore di storia.
Per la letteratura artistica si trattava di un’innovazione radicale: anche i fatti relativi alle opere d’arte e ai loro artefici venivano a strutturarsi in una historia, una narrazione ampia e ricca di dettagli raccolti con diligenza, e in questo distinta dal modello dei commen-tarii, più succinti e più poveri di notizie. La fondamentale distinzione si trova formulata a proposito della storiografia in un passo di una lettera scritta da Leonardo Bruni a Giovanni Torelli nei primi anni Venti del XV secolo:
Commentaria tamen ab historia multa differunt. Illa enim amplior ac diligentior est: haec contractiora et minus esplicata5.
Non è fuori luogo in questo contesto evocare il nome dello storico quattrocentesco: in un passo della dedica della Torrentiniana a Giulio III il ruolo del Bruni storiografo aretino della Firenze degli antenati
4 Cfr. l’introduzione di chi scrive a G.C. Gigli, La pittura trionfante, a cura di B. Agosti, S. Ginzburg, Porretta Terme (Bo), I Quaderni del Battello Ebbro 1996, pp. 11-17.
5 La lettera è citata e commentata da G. Ianziti, I Commentarii: appunti per la storia di un genere storiografico quattrocentesco, in «Archivio storico italiano», CL, 1992, pp. 1029-1063, in part. 1035 sgg.
150 Silvia Ginzburg
di Cosimo viene citato come precedente del ruolo di Vasari, di nuovo un aretino, storico delle arti fiorentine per Cosimo stesso:
Et se già alli Illu.mi Avoli suoi furono in grado le onorate fatiche della historia fiorentina del mio compatriota m. Lionardo Bruni, per le buone lettere sue et per la sua fedele servitù, non isdegni hora le vite di tanti suoi nobilissimi spirti fiorentini scritte da me, né vi cerchi altro giudizio né altra lingua che la natura mi habbia data6.
Come è noto, il testo della dedicatoria a Giulio III figura solo in pochissimi esemplari del volume, in posizione molto avanzata, dietro il frontespizio de La Terza ed ultima parte delle Vite7: esso venne infatti sostituito dalla lettera a Cosimo de’ Medici, come suggerito già nel 1547 dal Giovio, il quale il 29 gennaio 1548 passava a Vasari una bozza del testo che verrà poi pubblicato in apertura8. Veniva così scartata
6 G. Vasari, Le vite de più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri descritte in lingua Toscana, da Giorgio Vasari Pittore Aretino – Con una sua utile & necessaria introduzzione a le arti loro. In Firenze Lorenzo Torrentino MDC (esemplare della Biblioteca Apostolica Vaticana, Riserva IV.5).
7 R. Bettarini, Premessa, in Vasari, Le Vite cit., I, p. xx e nota 18 al testo, pp. 235-236, che rileva come questa posizione della dedica al papa indichi una destina-zione limitata dei pochi esemplari in cui essa figura e un inserimento avvenuto in una fase molto tarda della stampa. Vd. pure A. Rossi, Nota testologica, in Vasari, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’tempi nostri nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi, A. Rossi, Torino, Einaudi 1986, p. xlii.
8 Scrive Giovio: «A me par’, che per mille vive ragioni la dedichiate al Signor Duca Cosimo con fargli un stringato et semplice proemio, verbi gratia fratello di questo che vi mando per modello» (K. Frey, Der Literarische Nachlass Giorgio Vasaris, München, Müller 1923, I, p. 215). La convinzione di Giovio che il volume andasse dedicato a Cosimo de’ Medici, pienamente in linea con i suoi intenti di dedicargli l’opera propria (cfr. T.C. Price Zimmermann, Paolo Giovio cit., pp. 225-226), si trova già espressa nel 1547, nella lettera famosa dell’8 luglio con il passo sulla «leccata di ambra» (Pauli Iovi opera, II, Epistularum, pars altera, a cura di G.G. Ferrero, Roma, Società Storica Comense e Istituto Poligrafico dello Stato 1958, II, p. 91). Per le dedi-che a Cosimo I cfr. M. Plaisance, Les dédicaces à Côme Ier: 1546-1550, in L’écrivain face à son public en France et en Italie à la Renaissance. Colloque international (Tours, décembre 1986), éd. par J.-C. Margolin, A.C. Fiorato, Paris, Editions Vrin 1989, pp. 173-187, ora in Id., L’accademia e il suo principe. Cultura e politica a Firenze al tempo di Cosimo I e di Francesco de’ Medici, Mentana, Vecchiarelli 2004, pp. 235-255.
151 Filologia e storia dell’arte
la proposta di dedicare l’opera al nuovo papa che era stata sostenuta da Vincenzio Borghini in una lettera a Vasari del 27 febbraio 15509. Caduta quella citazione nella dedica a Giulio III, di Leonardo Bruni in tutta la Torrentiniana non è rimasta altra traccia esplicita se non le menzioni della sua tomba in Santa Croce nelle biografie di Antonio Rossellino e del Verrocchio. Tuttavia il modello di questa figura di primo piano della storiografia fiorentina ha giocato un ruolo impor-tante nella costruzione dell’impresa vasariana, come in parte già rico-nosciuto dagli studi10. Basterebbe il paragone con il Bruni a fare della lettera al papa messa in ombra nella fase finale di stampa delle Vite un documento da non trascurare nel tentativo di ricostruire l’universo di idee e nessi da cui nacque quell’impresa. Alla luce di quel paragone il quesito che sta dietro il citato dialogo in Palazzo Farnese emerge con maggiore evidenza: da dove poté venire a Vasari l’idea di adottare, nella narrazione delle vicende artistiche, la maggiore ampiezza e dili-genza dell’historia?
Prima di affrontare questo quesito, è necessario tornare a consi-derare il momento in cui poté avvenire quel colloquio, vero o prete-stuoso che sia, tra Giovio e Vasari.
2. Spesso datato al 1546 in ragione della posizione dell’aneddoto nell’autobiografia vasariana tra il soggiorno napoletano del 1544-’45 e l’esecuzione degli affreschi della Cancelleria del 1546, il dialogo in Palazzo Farnese va collocato più plausibilmente, come è stato propo-sto, entro il 154311, quando il Molza citato tra gli astanti si trasferì
9 «Ma per esser questa cosa del Papa [la dedica a Giulio III], cosa nuova, et questa altra [la dedica a Cosimo], per tanti libri dedicatili, quasi horamai stucca, quelle cose che vengono prime et fresche ànno un certo che di buono, che poi quando si è fatto il callo non si stiman tanto; voi m’intendete meglio ch’io non dico» (Il carteggio di Vincenzio Borghini, I. 1541-1552, a cura di D. Francalanci, F. Pellegrini, E. Carrara, Firenze, S.P.E.S. 2001, p. 303).
10 La Rubin rilevava come «Vasari’s description of Giotto’s precocious gifts, such as his quickness (‘prontezza’), seems to parallel Leonardo Bruni’s account of the young Dante in his Lives of Dante and Petrarch» (P. Lee Rubin, Giorgio Vasari. Art and History, New Haven, Yale University Press 1995, p. 303). Vd. anche R.J. Williams, Vincenzo Borghini and Vasari’s Lives, Ph.D. Thesis, Princeton University, Ann Arbour 1988, p. 19 e passim.
11 Così già G. Scoti Bertinelli, Giorgio Vasari scrittore, Pisa, Nistri 1905; cfr. anche T.S.R. Boase, Giorgio Vasari. The Man and the Book, Princeton, Princeton University Press 1979, p. 44; Ch. Davis in Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti
152 Silvia Ginzburg
a Modena, dove morì nel febbraio 154412, e Vasari lasciò Roma per Lucca e poi Firenze. La presa di posizione di metodo che vi è regi-strata deve infatti risalire all’origine del progetto delle Vite – essendo impensabile che un’idea così sostanziale sia emersa nelle ultime fasi della redazione dell’opera – ovvero ai primi anni Quaranta, dal mo-mento che, come lo stesso Vasari ricorda in due occasioni nel 1550, l’impresa era stata avviata un decennio prima13.
È questo un momento per più versi cruciale per la formazione di Vasari: secondo la sua stessa testimonianza, è tra il 1542 e il 1543, nel corso di un nuovo soggiorno romano, che egli frequenta Michelan-gelo, il quale lo incoraggia a sviluppare le sue conoscenze di architet-tura14. Si è discusso se questi scambi non siano piuttosto da collocare più tardi, verso la fine del decennio15, e in effetti appare probabile che colloqui decisivi con Michelangelo in materia d’architettura Vasari li abbia avuti in entrambi i momenti: sia alla fine degli anni Qua-ranta, all’altezza dei suoi impegni per il del Monte, sia al principio16,
nelle carte di Giorgio Vasari. Lo storiografo dell’arte nella Toscana dei Medici, catalogo della mostra (Arezzo, Casa Vasari, 26 settembre-29. novembre 1981), Firenze, Edam 1981, pp. 213-215; M. Winner, Il giudizio di Vasari sulle prime tre stanze di Raffaello in Vaticano, in Raffaello in Vaticano, catalogo della mostra (Città del Vaticano, Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 16 ottobre 1984-16 gennaio 1985), Milano, Electa 1984, pp. 179-193; Rossi, Nota testologica cit., p. xxix; Rubin, Giorgio Vasari. Art and History cit., pp. 11-12; 106-107, 115.
12 Cfr. R. Sodano, Nota biografica, in F.M. Molza, Elegiae et alia, a cura di M. Scorsone, R. Sodano, Torino, Edizioni RES 1999, pp. 130-132.
13 Vd. il passo delle conclusioni della Torrentiniana: « nel cercare minutamente dieci anni tutta la Italia per i costumi, sepolcri et opere di quegli artefici de’ quali ho descritto le Vite» e la lettera a Cosimo I dell’8 marzo 1550: «vi porgho non le fatiche et lo stento di duo mesi, ma quelle di dieci anni» (Frey, Der Literarische Nachlass cit., I, p. 270).
14 Vasari, Le Vite cit., VI, p. 383.15 Cfr. M. Hirst, Michelangelo and his first biographers, in «Proceedings of
the British Academy. Lectures and Memoirs», XCIV, 1996, pp. 63-84, trad. ital. Michelangelo e i suoi primi biografi, in Id., Tre saggi su Michelangelo, Firenze, Mandragora 2004, p. 32.
16 Così tra gli altri J. Wilde, Michelangelo: 6 lectures, ed. by M. Hirst, J. Shearman, Oxford, Clarendon Press 1978, p. 5 : «During this Roman visit of 1542-43 he [Vasari] was introduced to Michelangelo».
153 Filologia e storia dell’arte
quando proprio Alessandro Farnese accoglie l’ultimo tentativo di realizzazione dei progetti dell’Accademia della Virtù, la cui attività, sviluppatasi attorno a Ippolito de’ Medici fin dai primi anni Trenta e poi presumibilmente attorno alla figura di Giovanni Gaddi in seguito alla precoce morte di Ippolito nel 1535, svolgeva un ruolo di rilievo negli ambienti dei fuoriusciti fiorentini a Roma17.
La storia dettagliata dell’Accademia della Virtù è ancora da fare, restando per lo più oscura la sua fase più lunga e significativa, che sap-piamo svolgersi dal principio degli anni Trenta e a cui lo stesso Vasari deve aver partecipato da giovane quando nel 1532 si trova a Roma al servizio di Ippolito de’ Medici18. Su un impegno politico di Ippolito si concentravano allora le aspettative di molti, artisti e letterati, te-
17 Sull’Accademia della Virtù cfr. P.N. Pagliara, Vitruvio da testo a canone, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, a cura di S. Settis, III. Dalla tradizione all’ar-cheologia, Torino, Einaudi 1986, pp. 5-85; M. Daly Davis, Zum Codex Coburgensis: frühe Archäologie und Humanismus im Kreis des Marcello Cervini, in Antikenzeichnung und Antikenstudium in Renaissance und Frühbarock. Akten des internationalen Symposions (Coburg, 8-10 settembre 1986), hrsg.v. R. Harprath, Mainz am Rhein, Von Zabern 1989, pp. 185-199; Archäologie der Antike: aus den Beständen der Herzog August Bibliothek 1500-1700, catalogo della mostra (Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek 16 luglio-2 ottobre 1994), a cura di M. Daly Davis, Wiesbaden, Harrassowitz in Komm 1994; H. Günther, Gli studi antiquari per l’“Accademia della Virtù”, in Jacopo Barozzi da Vignola, a cura di R.J. Tuttle et al., Milano, Electa 2002, pp. 126-128; E. Ferretti, Tra Bindo Altoviti e Cosimo I, Averardo Serristori, amba-sciatore mediceo a Roma, in Ritratto di un banchiere del Rinascimento. Bindo Altoviti tra Raffaello e Cellini, catalogo della mostra (Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, 8 ottobre 2003-12 gennaio 2004; Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 1 marzo-15 giugno 2004), a cura di A. Chong, D. Pegazzano, D. Zikos, Milano, Electa 2004, pp. 456-461. Sulla cerchia di Ippolito cfr. M. D’Ercole, Il cardinale Ippolito de’ Medici. Contributo storico della prima metà del secolo XVI, Terlizzi, Tipografia Giannone 1907; su Giovanni Gaddi, oltre alle menzioni vasariane, J. Gaddi, Trattato istorico della famiglia de’ Gaddi, In Padova, per Paolo Frambotto 1642; A. Cecchi, Profili di amici e committenti, in Andrea del Sarto 1486-1530. Dipinti e disegni a Firenze, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 8 novembre 1986-1 marzo 1987), Milano, D’Angeli-Haeusler 1987, pp. 42-57, soprattutto pp. 48-50). Ringrazio Dario D’Agata di avere ragionato con me sulla figura di Giovanni Gaddi.
18 Cfr. la lettera di quell’anno in cui Vasari menziona come suoi protettori due figure di spicco di quella cerchia, Giovio e Tolomei (Frey, Der Literarische Nachlass cit., I, p. 2); vd. pure M. Hirst, Sebastiano del Piombo, Oxford, Clarendon Press 1981, p. 115.
154 Silvia Ginzburg
stimoniate tra l’altro dall’edizione degli scritti di Machiavelli curata da Giovanni Gaddi al principio degli anni Trenta, con la quale, come è stato supposto, si esprimevano le speranze che in quell’ambiente soprattutto il Molza sembra aver concepito di un Ippolito novello Principe che avrebbe potuto risollevare le sorti dell’Italia19. Sul fronte parallelo delle arti figurative, un ruolo di mecenate che avrebbe potu-to riunire presso di sé le eredità migliori della generazione precedente (i seguaci di Michelangelo ma anche gli allievi di Raffaello) gli affida lo stesso Vasari, come emerge dalle biografie da lui scritte dei molti che Ippolito protesse, come Sebastiano del Piombo e il Cellini, ma anche di coloro che non vollero o non fecero in tempo, come Perino e Giovanni da Udine, che contano qui a rappresentanza della bottega raffaellesca e che, afferma il Vasari, negli anni dopo il Sacco avrebbe-ro potuto trovare in Ippolito un sicuro protettore20.
È solo diversi anni dopo la morte di Ippolito de’ Medici, e dopo una fase discendente registrata dalle lettere di Annibal Caro del 1538 («Il regno della virtù è sbandato», «Il Regno della Virtù è in decli-nazione»21), che si data il documento più esplicito che ci sia perve-nuto sugli intenti di quell’accademia: la lettera di Claudio Tolomei a Agostino Landi, del 1542, nella quale esponendo il grandioso e mul-tiforme progetto di catalogazione dei resti dell’architettura, scultura, decorazione, numismatica antica, il Tolomei – probabilmente anche perché in quel momento muore Giovanni Gaddi, che aveva di fatto sostituito Ippolito de’ Medici nel ruolo di protettore di quella cer-chia – auspica di trovare un «nuovo Alessandro Magno» disposto a patrocinare quegli ambiziosi disegni il quale è, ad evidenza, il cardi-nale Alessandro Farnese22.
19 R. Sodano, Nota biografica, in F. M. Molza, Elegiae cit., p. 123.20 Così nella biografia di Perino: «e quantunque egli nella vita del cardinale
Ippolito de’ Medici avesse avuto lettere di servirlo, e si fusse disposto a farlo, la morte di quel signore fu cagione che così presto egli non si rimpaniassi»; e in quella di Giovanni da Udine: «se bene arebbe potuto vivere [a Roma] d’ufficii e d’entrate e servire il cardinale Ippolito de’ Medici et il nuovo pontefice Paulo Terzo, si risolvé a rimpatriarsi e tornare a Udine» (Vasari, Le vite cit., V, p. 147 e p. 454).
21 Sono lettere del Caro a Bernardino Maffei e a Giovan Francesco Leoni del 10 aprile 1538 (A. Caro, Lettere familiari, ed. critica a cura di A. Greco, Firenze 1957-1961, I, p. 83).
22 La lettera è indirizzata al conte Agostino de Landi (cfr. Scritti d’arte del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, Milano-Napoli, Ricciardi 1971-1977, III, pp.
155 Filologia e storia dell’arte
Anche quei primi colloqui tra Michelangelo e Vasari su argomenti d’architettura, posti da quest’ultimo all’incirca alla data della lettera del Tolomei, saranno da intendersi come emanazioni delle idee che circolavano nell’Accademia della Virtù, sulla quale la figura di Mi-chelangelo, di cui Condivi ricorda gli stretti rapporti col Tolomei, dovette ovviamente esercitare un’enorme influenza23. Il dialogo tra Vasari e Giovio sul progetto delle Vite si colloca nello stesso momen-to e di fatto nello stesso ambiente: quasi tutti i presenti citati in Palaz-zo Farnese in quell’occasione erano stati frequentatori dell’Accade-mia della Virtù e di quella che sembra averne costituito un antefatto, l’Accademia dei Vignaiuoli24. È noto infatti che numerosi protagoni-
3037-3046), protetto del Bembo, destinatario di una lettera del Doni sul museo gioviano e ritratto da Tiziano in un dipinto perduto ricordato in una lettera del-l’Aretino del 15 novembre 1539 (P. Aretino, Lettere, a cura di P. Procaccioli, Roma, Salerno Editrice 1998, II, pp. 153-154). La recente decadenza del Dizionario Biografico degli Italiani si misura anche sulla voce Landi, Agostino, che non allude neppure a questi episodi cruciali della storia della cultura italiana del Cinquecento, neanche alla lettera del Tolomei (la voce è di C. Bevilacqua, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXIII, Roma 2004, pp. 368-369).
23 A evocare Michelangelo è anche l’improvviso innalzarsi della sensibilità sti-listica e l’intelligenza tecnica e formale del passo della lettera del Tolomei in cui viene specificato il modo in cui si dovrà trattare la descrizione delle maniere della scultura antica prevista dopo la descrizione iconografica nel progetto dell’opera di catalogazione dei pili: «[…] si farà un’opera de’ pili, ritraendo in un libbro tutti i pili che sono in Roma o intorno a Roma, o interi o spezzati che siano; e appresso di ciascun pilo vi si faranno finalmente due isposizioni: l’una per via d’istoria dichia-rando che favola o istoria vi sia scolpita, e a che proposito, e quel che significhi la tal figura, o la tale […] L’altra sarà per via di scoltura, mostrando che maniera di scoltura sia quella, in che parte sia buona, dove maravigliosa, dove manchi; s’ella è di mezzo rilievo, se di basso, se spiccato; s’ella è maniera pastosa, s’ella è secca, di che secolo paia: e insomma si sporrà tutto quello, che per l’arte de lo scultore si puo avertire» (Scritti d’arte del Cinquecento cit., pp. 3042-3043).
24 Sull’Accademia dei Vignaiuoli e i suoi partecipanti nella Roma degli anni Trenta cfr. la bibliografia citata in A. Corsaro, Giovanni Della Casa comico. Intorno al testo e all’interpretazione dei ‘capitoli’, in Per Giovanni Della Casa. Ricerche e con-tributi. Atti del convegno (Gargnano del Garda, 3-5 maggio 1996), a cura di G. Barbarisi, C. Berra, Bologna 1997 (Quaderni di Acme, 27), pp. 123-178: nota 4, p. 124; su Uberto Strozzi cfr. G. Rebecchini, Private collectors in Mantua 1500-1630, Roma, Edizioni di storia e letteratura 2002, pp. 139-141: 144.
156 Silvia Ginzburg
sti dell’Accademia dei Vignaiuoli registrati intorno a Uberto Strozzi all’inizio del quarto decennio si ritrovarono poco dopo nella cerchia di Ippolito de’ Medici in cui prese vita l’Accademia della Virtù: An-nibal Caro, Claudio Tolomei, Francesco Maria Molza, il Della Casa, Gandolfo Porrino, Francesco Berni e i berneschi Matteo Franzese, Giovan Francesco Bini, Giovanni Mauro. E come accadde in parte agli artisti già legati a Ippolito, all’apertura degli anni Quaranta molti dei personaggi citati confluirono nelle stanze di Palazzo Farnese: ma le idee di cui furono portatori e di cui il cardinal Alessandro si fece patrono erano nate prima e altrove. Così come i progetti enunciati dal Tolomei cercano nel 1542 nel cardinal Farnese un nuovo protet-tore, ma sono emersi precedentemente in un altro ambiente (e mi-grano già sotto nuovo nome nell’Accademia degli Sdegnati), le Vite vasariane trovano nello stesso momento e nella stessa cerchia una prima presentazione pubblica, ma sono il frutto di altri contesti.
3. La Roma che ha contato per la genesi della Torrentiniana, più che quella di Alessandro Farnese, è dunque quella di Ippolito de’ Me-dici, che Vasari ricorderà sempre come una figura chiave della propria formazione25; e in quell’ambiente un ruolo importante deve avere avuto colui al quale era affidata l’educazione del giovane Ippolito e di conseguenza anche del giovane Vasari, Pierio Valeriano. Benché Vasari stesso ricordi di aver frequentato il Valeriano negli anni in cui questi era precettore a Firenze di Ippolito e Alessandro de’ Medi-ci26, gli studi hanno segnalato la difficoltà di misurare effettivamente la consistenza di questo discepolato27: forse perché si è cercato quasi
25 Nella ‘vita’ di Raffaello, a proposito del ritratto di Ippolito bambino nell’Inco-ronazione di Carlo Magno egli scrive: «alle benignissime ossa del quale [Ippolito] i’ mi conosco molto obbligato, poiché il principio mio, quale egli si fusse, ebbe origine da lui» (Vasari, Le Vite cit., IV, p. 197).
26 È quanto emerge dal racconto autobiografico introdotto nella ‘vita’ dell’ami-co Francesco Salviati sugli studi poco più che infantili (è il 1523) con i giovani Ippolito e Alessandro de’ Medici sotto la guida del Valeriano: «Il Vasari intanto, non lasciando gli studi delle lettere, d’ordine del cardinale [Silvio Passerini cardina-le di Cortona al quale Giorgio era stato raccomandato] si tratteneva ogni giorno due ore con Ipolito et Alessandro de’ Medici sotto il Pierio, lor maestro e valentuomo» (Vasari, Le Vite cit., V, p. 512).
27 Cfr. Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti cit., p. 183.
157 Filologia e storia dell’arte
esclusivamente nella direzione dell’opera per cui il Valeriano è più noto, ovvero gli Hyeroglyphica, le cui dediche certo disegnano il mon-do frequentato da Vasari tra Firenze e Roma, destinate come sono a tanti protagonisti dell’Accademia della Virtù e dell’ambiente romano di Michelangelo (Lattanzio Tolomei, Giovanni Grimani, Bernardino Maffei, Achille Maffei, Achille Bocchi, Romolo Amaseo28), ma il cui testo non sembra potersi identificare come una fonte per le Vite.
Vasari però potrebbe aver guardato con maggior attenzione a un’al-tra meno nota opera del Valeriano, il De Litteratorum infelicitate, av-viata subito dopo la drammatica frattura del 1527, nella quale si de-scrivono le morti infauste dei letterati delle generazioni precedenti, ovvero della cultura spazzata via dal Sacco, qui evocata con aspro rimpianto29. La redazione del testo interrotta alla fine degli anni Ven-ti venne poi ripresa durante il soggiorno del Valeriano a Roma, presso Ippolito dal 1533, presso Alessandro Farnese nel 1536-3730, prima del trasferimento a Belluno dove verrà nominato sacerdote dall’amico strettissimo Gasparo Contarini; era dunque sul tavolo di lavoro del Valeriano quando Vasari frequentava questi ambienti.
Dal De Litteratorum infelicitate Vasari poteva mutuare la soluzione che Valeriano (con un’idea che si direbbe derivare da un modello antico, e che comunque ha anche moltissimo a che fare con la Com-media dantesca) aveva adottato per poter dedicare medaglioni biogra-fici non soltanto alle figure maggiori della letteratura del tempo, ma anche alle figure di secondo piano, ai carneadi. Presentarne le morti era la scappatoia per narrarne le vite, sfuggendo così alla gabbia en-comiastica del genere biografico che include solo i maggiori. Raccon-
28 G.P. Valeriano, Hieroglyphica sive de sacris Aegyptiorum literis commentarii, Basel 1556 [rist. Hildesheim, Olms 2002].
29 Cfr. J. Haig-Gasser, Pierio Valeriano on the ill fortune of learned men: a Renaissance humanist and his world, PhD thesis University of Michigan, Ann Arbour 1999; K. Gowens, Remembering the Renaissance: humanist narratives of the Sack of Rome, Leiden, Brill 1998; Id., Life-writing and the theme of cultural decline in Valeriano’s De Litteratorum Infelicitate, in «Sixteenth Century Journal», XXVII, 1996, pp. 87-96.
30 J. Haig-Gasser, The dates of Pierio Valeriano’s De litteratorum infelicitate, in Roma nella svolta tra Quattro e Cinquecento. Atti del convegno internazionale di studi (Roma, Università La Sapienza, Dipartimento di Italianistica, 28-31 ottobre 1996), a cura di S. Colonna, Roma, De Luca 2004, pp. 223-232.
158 Silvia Ginzburg
tando le vite dei morti si possono celebrare anche i minori, e salvarli così dall’oblio a cui altrimenti sarebbero condannati31. Ma se in Va-leriano c’è ancora bisogno dell’artificio della narrazione delle morti infauste, in Vasari ormai le biografie si giustificano di per se stesse. Lavorare sul registro dei morti permette l’inclusione nei medaglioni biografici di stature diverse: i grandissimi, i grandi, ma anche i medi, e persino i piccoli. È infatti l’essere morti – non l’essere sommi – la condizione per essere inclusi nella storia32; e soltanto di quell’unico che è senz’ombra di dubbio il più grande di tutti si potrà parlare anche da vivo.
Valeriano offre dunque a Vasari una risposta alla domanda su come dare un posto, nel racconto per biografie, a figure di secondo piano. Ma da dove veniva quella domanda? Da dove veniva quell’urgenza storiografica e critica a non limitarsi più soltanto alle persone prime? Per rispondere a questo interrogativo la Roma farnesiana non basta: bisogna rivolgersi altrove.
4. Le critiche mosse da Vasari al Giovio non sono in realtà un caso isolato. Esse trovano uno strettissimo parallelo nella polemica con-dotta a Firenze contro lo storico comasco scoppiata soprattutto dopo la sua morte, ma con argomenti in parte emersi già prima, in piena consonanza con le posizioni vasariane registrate dal dialogo in Pa-lazzo Farnese. Nell’anonima Regola da tenersi nel leggere le Historiae si accusa Giovio perché
non distingue bene li tempi e dice molte bugie, massime delle cose fuor d’Italia et in quelle d’Italia33
31 Gowens, Life-writing cit., p. 189.32 Per il foglio databile al 1546 con la lista di date di morte di artisti, che conta
tra i rarissimi materiali di lavoro per la Torrentiniana pervenutici, cfr. J. Kliemann, Giorgio Vasari. Kunstgeschichtliche Perspektiven, in Kunst und Kunsttheorie 1400-1900, Hrsg. P. Ganz et al., Wiesbaden, Harrassowitz in Komm 1991 (Wolfenbütteler Forschungen XLVIII), pp. 29-74, soprattutto pp. 65-72 e tav. 2; cfr. anche Rubin, Giorgio Vasari. Art and History cit., p. 180.
33 Regola da tenersi nel leggere le Historiae, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magl. VIII, 1398, cit. in M. Lupo Gentile, Studi sulla storiografia fiorentina alla corte di Cosimo I de’ Medici, estratto da «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», XIX, 1905, p. 52, nota 2.
159 Filologia e storia dell’arte
ed è soprattutto Benedetto Varchi, mosso insieme da ragioni di or-dine di metodo e di ordine politico, a far propria questa posizione indicando i pericoli di una storiografia poco obiettiva, non solo nella lista degli errori del Giovio redatta dopo la morte di quest’ultimo, ma anche nella Istoria fiorentina, alla fine degli anni Quaranta34. La pole-mica era di primissima attualità a Firenze in quel momento, dato che proprio Varchi, e non Giovio, il quale pure molto vi ambiva, aveva ottenuto nel 1547 da Cosimo I l’incarico di redigere la storia di Firen-ze. Tanto più significativa appare quindi la dichiarazione di metodo posta proprio a introduzione di quell’opera, nella quale ai difetti del modello gioviano Varchi contrappone una storia fondata sull’attento uso di fonti documentarie:
non ritrovandosi nella segreteria alcuni libri pubblici […] fui costretto non pure a leggere, ma notare e intavolare per l’ordine dell’alfabeto e poco meno che trascrivere
documenti diversi, dai libri dei Dieci alle lettere e registri degli am-basciatori, fino a
volgere e rivolgere non pochi parte zibaldoni, che cosi gli chiamano, e parte scartabegli e scartafacci di diverse persone, le quali in varî tempi le cose che nella città o si facevano o si dicevano, di giorno in giorno più tosto con molta diligenza e curiosità (del che non poco si debbe loro obbligo avere) che con alcuno ordine o studio andavano in sù detti stracciafogli notando35.
Il nuovo rigore filologico proposto dal Varchi deriva dal magistero altissimo di Pier Vettori, di cui Varchi era stato allievo, e del suo maggiore seguace, Vincenzio Borghini. C’è infatti presumibilmente il Borghini dietro l’ampliamento inconsueto del canone delle fonti da parte del Varchi, che nel dichiarare di aver usato «libri […] e scritture
34 Ibidem, p. 96; Williams, Vincenzo Borghini cit., p. 43; Per altri attacchi di matri-ce anche politica al Giovio cfr. S. Lo Re, «Chi potrebbe mai, a questi tempi, badare a lettere?» Benedetto Varchi, Piero Vettori e la crisi fiorentina del 1537, in «Studi storici», XLIII, 2002, 2, pp. 367-409: 374; M. Pozzi, La Storia fiorentina di Benedetto Varchi, in Storiografia repubblicana fiorentina (1494-1570), a cura di J.-J. Marchand, J.-C. Zancarini, Firenze, Cesati 2003 (Quaderni della Rassegna, 23), pp. 117-140.
35 Storia fiorentina di Benedetto Varchi, Firenze 1838-1841, I, p. 44 (cfr. Lupo Gentile, Studi sulla storiografia cit., p. 91).
160 Silvia Ginzburg
così publiche come private» evoca il metodo poi rivendicato da Bor-ghini negli studi sulla lingua:
non una cosa sola, ma più son quelle che bisognano, e che non le regole sole, come certi han creduto, né la lezion sola di certi scrittori basta, ma che ci è anche luogo la loggia e il tetto dei Pisani e mercato nuovo, né solo il Petrarca, Dante e Boccaccio […] ma le scritture private dei nostri cittadini, come lettere, giornali, ricordanze, infin ai conti del dare e dell’avere scritti in quella età36
o quando affermerà di essere andato
investigando et cercando più libri antichi che far potessi, et d’ogni sorte, come dire di conti, di cose familiari, di ricordi, lettere che furono scritti intorno dal ’300 al ’40037.
Sono, è vero, appunti successivi o di incerta datazione; ma va sotto-lineato che il modello per questo uso delle fonti era il comune mae-stro di Borghini e Varchi, Pier Vettori, che dal 1538 è lettore di greco e latino nello studio fiorentino e avvia la pubblicazione di importanti autori commentati proprio secondo questi criteri.
È dunque in piena sintonia con le istanze filologiche rivendicate dal Varchi su probabile esempio del Borghini e del Vettori, che Va-sari sceglie di praticare una storia dell’arte che utilizzi non la rete a maglie larghe, l’approccio soggettivo di Giovio che tante falle stava rivelando sul fronte della storiografia, ma la rete fitta dei dati e delle date, secondo un metodo di controllo delle fonti che infatti si trova esplicitamente dichiarato nella chiusa della Torrentiniana:
E mi sono ingegnato per questo effetto con ogni diligenzia possibile verificare le cose dubbiose, con più riscontri, e registrare a ciascuno artefice nella sua vita quelle cose che elli hanno fatte. Pigliando nientedimeno i ricordi e gli scritti da persone degne di fede, e col parere e consiglio sempre degli artefici più antichi che hanno avuto notizia delle opere e quasi le hanno vedute fare38.
36 V. Borghini, Scritti inediti o rari sulla lingua, a cura di J.R. Woodhouse, Bologna, Commissione per i testi di lingua 1971, p. 103 (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. II X 110, c. 130r).
37 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. II X 97, c. 3r.38 Vasari, Le Vite cit., VI, p. 411.
161 Filologia e storia dell’arte
Grazie alla testimonianza di una lettera di Borghini a Vasari del gennaio 1550 noi sappiamo per certo che queste conclusioni sono state scritte su suggerimento di Borghini39, al quale pure deve spettare il paragone che compare poco oltre nel testo vasariano tra l’artista conoscitore che distingue gli stili e il cancelliere che riconosce le grafie40 e al quale pure si deve, come già ricordato, l’idea, e evidente-mente il contenuto, della dedicatoria a Giulio III. Di Borghini parla in particolare proprio quel parallelo così fecondo con Leonardo Bru-ni, del quale egli conosceva bene le opere e il ruolo nella storia della storiografia fiorentina per le proprie ricerche sull’origine di Firenze, pubblicate postume nel 1584, elaborate compiutamente in occasione della polemica con Girolamo Mei negli anni Sessanta41, ma per molta parte, come vedremo, frutto di studi e riflessioni compiuti negli anni Quaranta.
Il contributo di Borghini, che una folta documentazione registra come essenziale per la costruzione della seconda edizione delle Vite,
39 Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., pp. 299-300, lettera a Vasari del 24 gennaio 1549 (anno fiorentino): «Pur se volessi dir quattro parole in vostra scusa, lo potete far brevemente et i capi che havete a toccare gli sapete meglio di me, che sono que-sti o simili. Primo, che voi havete fatto questa opera per utile comune et honor de l’arte et artefici, et che vi siete ingegnato d’usare ogni diligenzia in ricercare queste cose; et se pure e’ fussi chi pensassi che molte cose o non fussino così (et questo sarà il 2°) o non fussino dette tutte, ma lasciatene indietro assai (et questo sarà il 3°), che voi rispondete che sapete molto bene che i giuditii son varii, ma che voi [avete?] seguito sempre il più certo et veduto etc. et domandato etc.».
40 «Ho pur sempre voluto riscontrar l’opere con la veduta; la quale per la lunga pratica (e sia detto ciò senza invidia) così riconosce le varie maniere degli artefici, come un pratico cancelliere i diversi e variati scritti de’ suoi equali» (Vasari, Le Vite cit., VI, p. 411). L’ipotesi che vi fosse Borghini dietro questo paragone era stata già formulata da Scoti Bertinelli (Scoti Bertinelli, Giorgio Vasari scrittore cit, p. 60).
41 Nei Discorsi pubblicati postumi (Discorsi di Monsignore Don Vincenzo Borghini al Serenissimo Francesco Medici, recati a’ luce da’ deputati per suo testamento; con la tavola delle cose più notabili, In Fiorenza, Stamperia Giusti 1584) Borghini loda le ricerche sull’origine di Firenze di Salutati, Bruni, Poliziano. Sulla polemica col Mei cfr. Williams, Vincenzo Borghini cit., pp. 273-277; E. Carrara, Gli studi antiquari del Borghini: ipotesi per nuove ricerche, in «Schede Umanistiche», n.s., 2001, 2, pp. 57-75; Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione nella Firenze di Cosimo I, catalogo della mostra (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 21 marzo-20 aprile 2002), Firenze, Olschki 2002, n. 2.2, pp. 16-20.
162 Silvia Ginzburg
nella prima sembrerebbe dunque limitarsi alle ultimissime battute: le conclusioni, la dedicatoria, gli indici, la correzione finale. Del resto le prime tracce documentate dei suoi rapporti con Vasari sono molto tarde, risalendo al 154942. Allo stato dei fatti noti Borghini sarebbe dunque entrato nella costruzione dell’edificio delle Vite soltanto alla fine – con idee però che, ed è un dato cruciale che non è possibile trascurare oltre, investono il cuore del metodo con cui molti anni prima quell’edificio era stato concepito.
L’ipotesi che vorrei sottoporre qui alla discussione è che dietro la posizione di Vasari nel dialogo in Palazzo Farnese si debba già leggere l’effetto dell’amicizia con colui che viene riconosciuto come il suo principale interlocutore a partire dalla metà del secolo, Vincenzio Borghini: che dietro la Torrentiniana vi siano cioè, fin dal principio, gli scambi tra Borghini e Vasari43.
5. Se la prima traccia documentata di un diretto rapporto tra i due è appunto la lettera del settembre 1549, è stato più volte rilevato come essa indichi una amicizia già consolidata, dal momento che Borghini vi figura come sensale di nozze di Vasari e che già sembra essere inter-venuto sulla biografia di Mino da Fiesole, che per errore porta via con sé: «Io vi mando quella parte di Mino, che per inadvertenza l’havevo portato meco: voi l’assetterete à vostro modo»44. Come già suppo-sto, i rapporti poterono avviarsi diversi anni prima, nel 1541, quando Borghini, professo benedettino nel ’38 alla Badia di Firenze, e che ha plausibilmente già instaurato il rapporto decisivo con Pier Vettori di
42 Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., pp. 289-291.43 Patricia Rubin individua in Borghini la fonte della scelta di Vasari in favore di
un metodo storiografico più dettagliato, cogliendone le implicazioni antigioviane («Borghini suggested a method of ‘minute and detailed treatment,’ which was directly opposed to Giovio’s broad method implicitly criticized by Vasari in his 1568 account of the writing of the first edition» (Rubin, Giorgio Vasari. Art and History cit., p. 195), e segnala l’ampia gamma di fonti consultate da Borghini (p. 196, nota 128), ma non si addentra a indagare le implicazioni di un simile nesso né le conse-guenze che comporta sulla ricostruzione della preistoria della prima edizione delle Vite. Un ruolo di rilievo del Borghini nella Torrentiniana è invece riconosciuto da R. Stapleford, Vasari and Botticelli, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XXXIX, 1995, pp. 397-408, per il quale cfr. oltre.
44 Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., p. 291.
163 Filologia e storia dell’arte
cui si hanno testimonianze certe dal principio degli anni Quaranta45, si trasferisce ad Arezzo, nel monastero di Santa Fiora e Lucilla46.
Del resto la nomina a sacerdote nel marzo del 1541 gli era stata conferita da Bernadetto Minerbetti, membro dell’Accademia degli Umidi come il fratello di Borghini, Agnolo, nonché vescovo di Arez-zo dal 1538 e molto legato al Vasari47; e sospetto che possa essere proprio Borghini, ad Arezzo dal giugno del ’41, la persona a cui si
45 Per i rapporti accertati vd. E. Carrara, Il discepolato di Vincenzio Borghini presso Pier Vettori, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. IV, IV, 1999, pp. 159-177; Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., p. 7. Un’anticipazione dell’in-contro con Vettori alla fine degli anni Trenta, che spiegherebbe il profilo degli studi borghiniani già a quella data, potrebbe appoggiarsi sui rapporti, stretti fin da allora, tra Vettori e Francesco Verino, di cui Borghini segue le lezioni alla Badia fiorentina a metà del decennio (S. Lo Re, Tra filologia e politica: un medaglione di Piero Vettori (1532-1543), in «Rinascimento», XLV, 2005, pp. 247-285: 249).
46 Per i dati biografici cfr. I Ricordi di Don Vincenzio Borghini. Prima edizione com-pleta condotta sull’originale con avvertenza di A. Lorenzoni, Firenze, Seeber 1909; G. Folena, Borghini, Vincenzio, in Dizionario Biografico degli Italiani, XII, Roma 1970, pp. 680-689; Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., cat. n. 1.2, pp. 5-8. Senza che ne siano tratte conseguenze, l’idea di un avvio precoce delle relazioni tra Borghini e Vasari è stata formulata già da A. Legrenzi, Vincenzio Borghini. Studio critico, Udine, Tipografia D. Del Bianco 1910, pp. 93 sgg.; R. Scorza, Vincenzio Borghini (1515-1580) as Iconographical Adviser, PhD Thesis London 1987, p. 143, propone che i due si siano incontrati a Arezzo nel 1541, e così J. Kliemann, in Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti cit., p. 153. L. Satkowsky, Giorgio Vasari Architect and Courtier, Princeton, Princeton University Press 1993, p. 88 propende per un incontro ad Arezzo già alla fine degli anni Trenta: in effetti Borghini vi fu nel 1537 per la festa di Santa Fiora, e se l’amicizia con Vasari fosse iniziata allora potrebbe aver giocato un ruolo nei giri per Bologna a vedere le pitture che Vasari dice aver fatto al tempo della commissione per San Michele in Bosco, nel 1539, che sanno già di progetto delle Vite, come ipotizzato da M. Hirst, Michelangelo and his first biographers, in «Proceedings of the British Academy. Lectures and Memoirs», XCIV, 1996, pp. 63-84, trad. it. Michelangelo e i suoi primi biografi, in Id., Tre saggi su Michelangelo cit., p. 39, nota 14.
47 Sul Minerbetti molto vicino anche al Varchi, a cui dedicava la traduzione del-l’Eneide stampata da Giunti nel 1556 e che gli scrisse due sonetti, e al Lasca, che nel 1550 gli dedicò la sua commedia La gelosia, cfr. G. Ticciani, Notizie letterarie, ed isto-riche intorno agli uomini illustri dell’Accademia fiorentina. Parte prima, Firenze MDCC, ad vocem; Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti cit., passim. e cfr. infra, nota 143.
164 Silvia Ginzburg
riferisce Vasari in una lettera scritta da Bologna a Pietro Aretino il 16 ottobre dello stesso anno:
Ho lasciato qui in Bologna un Fiorentino Aretino, che vuol meglio alle virtù aretine, che non volete voi alla verità, ed è tutto mio, e desidera conoscervi presenzialmente. Quelle carezze che li farete, le farete a me, perché l’amo come me stesso.48
Ma più che queste tracce biografiche, sono soprattutto le idee che costituiscono l’ossatura delle Vite, impalcate appunto all’inizio degli anni Quaranta, a indicare l’opportunità di riconoscervi sin dal prin-cipio il ruolo decisivo avuto da Borghini e dalla cultura filologica del suo maestro Pier Vettori.
Non sarà necessario spiegare qui quanto conti per Vasari l’idea di una Firenze forza trainante della Toscana (e poi dell’Italia tutta), in rapporto privilegiato con Roma – un rapporto che nelle Vite è stilisti-co, innanzi tutto, e poi critico, storiografico, politico, biografico, oltre che naturalmente autobiografico. Il nesso Firenze-Roma è l’arteria principale lungo cui si sviluppa la Torrentiniana, e per questo dalla fine del Cinquecento diventerà uno dei grandi obiettivi della batta-glia antivasariana. Il grande sforzo delle letterature artistiche locali per tutto il Seicento e oltre sarà proprio quello di spezzare quest’asse privilegiato, imposto con immensa fortuna da Vasari. Naturalmente è il percorso stilistico della generazione del manierismo tosco-romano che egli intende innanzi tutto celebrare; ma è estremamente signi-ficativo che proprio l’idea di una Firenze in specialissimo rapporto con Roma trovi un parallelo nelle ricerche di Borghini compiute nel corso degli anni Quaranta per il trattato sulle famiglie romane e do-minate dall’intento di dimostrare la discendenza diretta dei fiorentini moderni dai romani antichi49.
Sono idee e studi che nella Firenze di quegli anni hanno un espli-cito contenuto polemico: contro i membri dell’Accademia fiorentina
48 Frey, Der Literarische Nachlass cit., I, p. 110.49 M. Barbi, Degli studi di Vincenzio Borghini sopra la storia e la lingua di Firenze, in
«Il Propugnatore», XI, 1889, pp. 5-71: 9, ristampato in Vincenzio Borghini dall’eru-dizione alla filologia. Una raccolta di testi, Pescara, Scaffale di Lettere 1998, a cura di G. Belloni, pp. 191-259: 195; Williams, Vincenzo Borghini cit., p. 52.; Carrara, Gli studi antiquari del Borghini cit.; Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., cat. n. 2.3, pp. 20-25.
165 Filologia e storia dell’arte
che negli stessi anni Quaranta pubblicano i testi in cui si arroccano su posizioni ipermunicipali sostenendo il primato della legge noaica, contro gli Aramei Gelli, Giambullari, Bartoli, Lenzoni, che sull’ori-gine di Firenze credono alle «baie» di Annio da Viterbo, come le chiamerà Borghini, questi afferma l’antico nesso con Roma, già so-stenuto da Leonardo Bruni50 e da Poliziano, riferimento fondamenta-le del Vettori e significativamente celebrato da Borghini nel dialogo giovanile sulle famiglie romane51. Sono i temi e i metodi che Bor-ghini affinerà più tardi, negli anni Sessanta, ai quali farà riferimento la scena della fondazione di Firenze nella decorazione vasariana di Palazzo Vecchio e che saranno al centro della polemica con Girolamo Mei52; ma conta qui ricordare che in parte erano emersi già vent’anni prima. Come egli stesso ricorda, in quelle imprese degli anni Sessan-
50 Per le implicazioni politiche di questo rapporto cfr. N. Rubinstein, The Beginning of Political Thought in Florence. A Study in Medieval Historiography, in «The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», V, 1942, pp. 179-207.
51 Carrara, Gli studi antiquari del Borghini cit., p. 68; Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., cat. n. 2.3 Per il rapporto di Vettori col modello di Poliziano cfr. V. Branca, Poliziano e l’umanesimo della parola, Torino, Einaudi 1983; A. Grafton, Joseph Scaliger. A Study in the History of Classical Scholarship, I. Textual Criticism and Exegesis, Oxford, Clarendon Press 1983; L. Cesarini Martinelli, Pier Vettori e gli umanisti tedeschi, in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del ’500, II. Musica e spettacolo. Scienze dell’uomo e della natura. Atti del convegno internazionale di studi (Firenze, 9-14 giugno 1980), Firenze 1983, II, pp. 707-726; F. Lo Monaco, Ovidio, Poliziano, Pier Vettori. Sull’attribuzione delle postille dell’incunabolo München, Bayerische Staatsbibliothek, 2° L. imp. c.n. mss. 35, in Agnolo Poliziano. Poeta scrittore filologo. Atti del convegno internazionale di studi (Montepulciano, 3-6 novembre 1994), a cura di V. Fera, D. Martelli, Firenze, Le Lettere 1998, pp. 403-423.
52 Come ha rilevato Nicolai Rubinstein «the picture of the foundation of the Roman colony of Florence by the triumvis could be read as a pictorial representa-tion of a historical theory which originated in Poliziano’s interpretation of a passage in the Libri Coloniarum» (N. Rubinstein, Vasari’s Painting on the Foundation of Florence in the Palazzo Vecchio, in Essays presented to Rudolph Wittkower on his sixty-fifth Birthday. I. Essays in the History of Architecture, a cura di A. Fraser, H. Hibbard, M. Lewine, London, Phaidon Press 1967, I, p. 73); e cfr. anche A. D’Alessandro, Vincenzio Borghini e gli Aramei, in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del ’500, I. Strumenti e veicoli della cultura, relazioni politiche ed economiche. Atti del convegno internazionale di studi (Firenze, 9-14 giugno 1980), Firenze, Olschki 1983, I, pp. 133-156: 139.
166 Silvia Ginzburg
ta Borghini sta riprendendo e sviluppando idee a cui si era dedicato già molto tempo prima, quando erano usciti i testi degli Aramei – il trattato Dell’origine di Firenze di Gelli, stampato nel 1544; Il Gello del Giambullari, nel 154653.
È un’anticipazione di cui sarà opportuno tenere conto anche nella ricostruzione della preistoria delle Vite, sulla quale il contesto della Firenze degli anni Quaranta ha pesato ben più di quanto si sia finora voluto riconoscere.
6. Negli anni Trenta e Quaranta, come poi di fatto per tutta la vita, Borghini lavora nei più diversi campi ad un unico grande obiettivo: ricostruire su basi filologiche la centralità di Firenze fin dal Trecento. È una Firenze che è il cuore della Toscana ma non la esclude, e anzi la comprende, in un’accezione che ricorda da vicino la visione della lingua del Bembo54 – un modello per Borghini decisivo, e che per suo tramite costituisce, come vedremo, uno dei riferimenti principali dell’opera di Vasari fin dalla sua prima concezione.
Avvalendosi del rigoroso metodo filologico della scuola del Vettori, il progetto fiorentinocentrico di Borghini si dirama in tutte le direzio-ni: così lo vediamo occuparsi della storia antica di Firenze, della storia della storiografia fiorentina, della storia della lingua fiorentina, della storia ecclesiastica fiorentina, della storia della nobiltà fiorentina – è un elenco impressionante per un uomo solo, sebbene si tratti di uno dei maggiori storici linguisti e filologi del secolo XVI. È un elenco nel quale non stonerebbe l’inclusione della storia dell’arte: fiorentina anch’essa, in principio, e poi toscana, e più tardi infine italiana; è di
53 «Il Gello scrisse già un trattatello dell’origine di Firenze, il quale vidi io allora e me ne risi» scrive Borghini in una lettera a Baccio Valori del 19 gennaio 1578 (Prose fiorentine raccolte dallo Smarrito Accademico della Crusca, Venezia 1751-1754, vol. IV, parte IV, p. 50), e cfr. i riferimenti a studi giovanili nel testamento: «haven-do io fin da giovane havuto speciale inclinatione di scrivere (se mai havessi potuto) qualche cosa della città nostra» (Testamento di Vincenzio Borghini, Firenze 22 giu-gno 1574, cit. in G. Gaye, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI, Firenze, Giuseppe Molini 1839, I, n. CLXXXIV, pp. 386-387).
54 Cfr. C. Dionisotti, Pietro Bembo e la nuova letteratura, in Rinascimento europeo e rinascimento veneziano, a cura di V. Branca, Firenze, Sansoni 1967, pp. 47-59, ora in C. Dionisotti, Scritti sul Bembo, a cura di C. Vela, Torino, Einaudi 2002, pp. 79-91.
167 Filologia e storia dell’arte
Borghini infatti, come è noto, la lettera del 1564 che spinge Vasari ad occuparsi, nell’edizione giuntina, di una storia dell’arte dell’Italia intera – sollecitato, credo, dalla pubblicazione avvenuta appunto in quell’anno a Venezia degli ultimi libri della Storia d’Italia del Guic-ciardini (i primi sedici erano usciti nel 1561 da Torrentino)55. E sarà anche per questo che, come ebbe a notare Cochrane, «l’unico vero storico d’Italia dopo il Guicciardini fu Giorgio Vasari.»
Il ruolo esercitato da Vincenzio Borghini nella storia delle Vite, che per la preparazione della Giuntina è attestato da tanti documenti, per la genesi della Torrentiniana è nascosto, ma non meno decisivo: confrontando i temi e gli obiettivi degli studi borghiniani tra quarto e quinto decennio con i temi e gli obiettivi che muovono fin dall’ori-gine l’impresa di Vasari il rapporto emerge con stringente, innegabile evidenza; ed è proprio alla luce di questo confronto che diventa pos-sibile vedere dove affondino alcune delle radici dell’opera vasariana. È una strada che gli studi hanno imboccato qualche rara volta, senza però percorrerla mai: e se non potevano fruttare le intuizioni di Le-grenzi o le fantasiose ipotesi di Scoti Bertinelli, altro esito avrebbe-ro potuto avere le ricerche di Williams, il quale pur avendo trovato tanti scritti borghiniani che suggeriscono l’opportunità di anticipare questo rapporto resta persuaso che di nessun ruolo di Borghini nelle Vite si debba parlare prima della Giuntina56. Soprattutto, altro seguito avrebbe meritato la segnalazione, poi dimenticata, che Paola Baroc-chi affidava al commento agli Scritti d’arte del Cinquecento là dove, nel pubblicare passi del fino ad allora inedito trattatello sull’imitazione redatto da Borghini a San Benedetto in Polirone al principio degli anni Quaranta, indicava come la riflessione sulle lingue da questi compiuta allora avesse potuto avere un peso sul nascere delle succes-sive idee vasariane:
55 («Voi vorrei vedessi haver di Genova, Venetia, Napoli, Milano et in somma di queste città principali per numero di cose cosi di pittura come di scultura et architettura, che sia possibile et ornarne l’opera vostra; et anchora siate a tempo a scrivere: che vedrete, che importera assai. Et di nuovo vi ricordo che mettiate a ordine le cose de vivj, massime de principali, accio questa opera sia finita et perfetta da ogni parte, et che sia una HISTORIA universale di tutte le pitture et sculture di Italia etc., che questo è il fine dello scriver vostro» (Lettera di Borghini a Vasari, 11. 8. 1564, Frey, Der Literarische Nachlass cit., II, p. 98).
56 Williams, Vincenzio Borghini cit., p. 189.
168 Silvia Ginzburg
le parole degli antichi e dei moderni si collocano per lui [Borghini] in una prospettiva storica, che mira, non senza riflessi sul Vasari, alla riabilitazione del Trecento57.
Sono intuizioni da fare proprie. Alla base del progetto delle Vite c’è infatti, applicata ai dominii di pittura scultura e architettura, la stessa idea alla quale lavora Borghini sul fronte della storia della lingua o della storia locale: presentare con dovizia di documentazione la cen-tralità di Firenze cuore della Toscana e modello per l’Italia – perché nella giovanissima storia dell’arte, come nella più adulta storia della lingua che le fa da battistrada, la Toscana del Trecento è l’esempio e il principio della rinascita. L’obiettivo, per Borghini (come per Va-sari) è raccontare il primato linguistico (stilistico) della Toscana nel Trecento, la capacità della lingua (e degli stili pittorici, scultorei, ar-chitettonici) della Toscana fin dal Trecento di sondare ed esprimere le proprie potenzialità in direzioni vive e importanti ancora nel pieno del Cinquecento. Anche l’idea dell’andamento è la medesima: per Borghini la natura delle lingue è «mutarsi, crescersi, abbellirsi e peg-giorare ancora, perdere e pigliare voci di nuovo e simili accidenti»58; non diversamente per Vasari il destino degli stili nella pittura, scul-tura, architettura.
Come è noto, il tema dello sviluppo progressivo delle arti occupa un ruolo strategico nel sistema delle Vite: asse portante, sul piano narrativo e critico, dell’opera vasariana, viene enunciato nel den-sissimo proemio alla seconda parte del volume, in un passaggio di importanza decisiva per l’intero impianto storiografico e critico del-l’opera, la cui origine è stata individuata da Ernst Gombrich nel Bruto di Cicerone59.
Diversi appunti sparsi di Borghini prendono spunto da quello stesso passo di Cicerone per ragionare sul progresso delle lingue, delle let-tere, della storiografia, delle arti: ma mentre in Vasari la fonte non viene dichiarata, in Borghini si trova più volte citata espressamente. Lo schema ciceroniano è dichiaratamente alla base di una riflessione sullo sviluppo delle lingue che, come scrive Borghini in una nota di incerta datazione, relativa appunto al Bruto,
57 Scritti d’arte del Cinquecento cit., p. 1525.58 Barbi, Degli studi di Vincenzio Borghini cit., p. 252.59 E.H. Gombrich, Vasari’s Lives and Cicero’s Brutus, in «Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes», XXIII, 3-4, 1960, pp. 309-311.
169 Filologia e storia dell’arte
come molte altre cose, hanno il lor principio rozzo e imperfetto, il quale col tempo e coll’industria degli uomini si va ripulendo e riducendo a perfezione.
Da ciò deriva
che quelli scrittori che secondo l’uso e le voci dell’età loro, hanno scritto sensatamente e giudiziosamente, non debbono esser da chi sia abbattuto in miglior età biasimati se egli hanno usato le voci e la lingua con che si parlava in quel tempo60.
È qui evocato il principio fondamentale della relatività del giudizio, dell’opportunità di giudicare secondo contesto, ovvero di considerare il passato non simpliciter ma secundum quid61 – un vero e proprio car-dine della struttura delle Vite, che Vasari nel proemio suddetto indica come il giudicare
avendo rispetto al tempo, al luogo, al caso, alla persona et al numero62
e Borghini, in un passo del 1564 definisce
haver rispetto alle circustantie de’ tempi dell’arte63.
È quest’ultima una definizione che compare nel manoscritto della cosiddetta Selva di notizie, la cui redazione, pur sentendovisi molto forti i rapporti con idee più antiche, è fissata appunto alla metà degli anni Sessanta64. Ma l’idea di applicare il principio ciceroniano alla
60 V. Borghini, Scritti inediti o rari sulla lingua cit., p. 219 (dal codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ms. II X 117, pp. 142-143).
61 Un cenno a questo tema in M. Pozzi, E. Mattioda, Giorgio Vasari storico e criti-co, Firenze, Olschki 2006 (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum» serie 1, 330), p. 59, uno degli ultimissimi contributi sulle Vite, dal quale, a dispetto dell’abbondanza delle citazioni vasariane, la storia dell’arte appare molto spesso distante, quando non esclusa del tutto.
62 Vasari, Le Vite cit., III, p. 14.63 V. Borghini, Selva di notizie, Firenze, Kunsthistorisches Institutes in Florenz,
ms. K 783 (16), p. 15.64 P. Barocchi, Una Selva di notizie di Vincenzio Borghini, in Un augurio a Raffaele
Mattioli, Firenze, Sansoni 1970, pp. 87-172; sul testo vd. ora Vincenzio Borghini.
170 Silvia Ginzburg
ricostruzione del passato poteva contare su un esempio particolar-mente presente e caro al Borghini degli anni Quaranta.
7. Acquisire il criterio della relatività del giudizio significa anche es-sere consapevoli del fatto che conoscere le prime tappe dello sviluppo non deve voler dire prenderle a modello. Nel corso della medesima riflessione sul progresso delle lingue Borghini afferma, a proposito di quegli scrittori degli inizi:
Ben è vero che in quella parte non sono da esser imitati, e sciocco ben sarà colui che, ritrovato il pane e tanti dolci frutti della terra, vorrà garosamente attenersi alle ghiande degli antichi.
L’argomento non era futile: anche nell’ambito delle arti figurati-ve c’era chi percepiva il rischio che una storia dell’arte del passato finisse per proporre come modelli da imitare quei rozzi principii. Questa fu appunto una delle primissime critiche alla Torrentiniana, registrata nella cerchia dei correttori delle Vite legati all’Accademia fiorentina già prima della stampa del volume. Nella Difesa della lin-gua fiorentina et di Dante, pubblicata nel 1556, ma scritta alla fine degli anni Quaranta, Carlo Lenzoni, sostenitore delle tesi aramai-che e membro di quel gruppo dei correttori della Torrentiniana del-l’ultim’ora, con Gelli, Giambullari e Bartoli, aveva fatto dire a un personaggio forestiero in cui è stata letta la voce dell’ortodossia di Bembo:
Or non mi terreste voi per huomo di poco giudizio, se volendo esser dipintore, imitassi più tosto Giotto che Rafael da Urbino? Tutto che Giotto sia così stranamente lodato dal vostro Giorgio Vasari65.
Filologia e invenzione cit., cat. n. 4.8b, pp. 151-155; Williams, Vincenzo Borghini cit, p. 180; E. Carrara, Vasari e Borghini sul ritratto: gli appunti pliniani della “Selva di notizie”, (ms. K783.16 del Kunsthistorisches Institut di Firenze), in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», xliv, 2000, pp. 243-291.
65 C. Lenzoni, In difesa della lingua fiorentina et di Dante. Con le regole da far bella et numerosa la prosa, Firenze, Torrentino 1556, p. 10 e Williams, Vincenzo Borghini cit., p. 180. Per ‘forestiero’ inteso come non toscano e segnatamente Bembo cfr. anche le affermazioni fatte fare a Borghini dal Varchi ne L’Hercolano, in Opere di Benedetto Varchi, Milano, Bettoni 1834, I, p. 31.
171 Filologia e storia dell’arte
È un argomento a cui Borghini darà risposta più tardi in una pagina nella quale, in esplicito sostegno al modello storiografico vasariano, applica alle arti figurative le considerazioni tratte da Cicerone – an-che qui espressamente richiamato – sul progressivo miglioramento delle arti, che spingono a lodare Giotto non per imitarlo, ma per apprezzare il percorso compiuto:
ma questo è il punto: che inanzi che venga uno che sia perfetto, va molto tempo, et molti imperfetti come antecursori vanno inanzi, et par che la perfettione non venga in un tratto. Et chi tiene che Aristotile delle cose scritte inanzi a lui si servisse assai, non tiene una cosa fuor di ragione: così si è veduto che la pittura a poco a poco andò guadagnando, et non fu Giotto etc. a un tratto perfetto, ma aggiugnendo Masaccio a quel buono che trovò in Giotto un altro poco, et Fra Filippo a Masaccio et Filippino al padre Fra Filippo, potette poi Michelagnolo et l’Urbino a tutti questi aqquisti aggiugnere un maggiore et ridurlo a perfettione. Et con gran giuditio messer Giorgio scrisse et notò le virtù delli antichi pittori, né dispregiò di considerare, né dispregiò anchora di riguardar spesso le opere loro, non per imitarle che meglio fanno molti de’ suoi garzoni etc., ma perché quelle parti buone che coloro trovarono gli danno piacer, et maraviglia, et insegnamento anchora di aggiugnere al trovato, et al primo principio accrescer perfettione, etc. Così penso io che di quelli oratori, dirò così, abbozzati cavasse di molti bei frutti Cicerone […] Non per questo che io voglio dire che il Maestro Aldobrandino per dar un esempio, sia bello o vago scrittore ma dico che scrisse con la lingua dell’età sua, et che le voci da lui usate son pure et nette […] Ma in tutto et generalmente, non lo proporrei già per imitatione de’ giovani che imparino a scrivere etc. 66
Qui certo Borghini può essere inteso semplicemente come un intel-ligente lettore di Vasari: intelligentissimo, a dire il vero, dal momento che nel difendere la Torrentiniana è in grado di citare esplicitamente Cicerone, la fonte che Vasari tace e che ha dovuto attendere Gom-brich per essere individuata come il modello dello schema di svilup-po che domina le Vite. Ma mi chiedo se un semplice lettore della
66 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. II X 116, cc. 10v.-11v., cit. in Williams, Vincenzo Borghini cit., Appendix 10A, pp. 289-291; per un altro esempio cfr. il passo ivi citato pp. 274-275, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Chigi L V 178, pp. 65-68).
172 Silvia Ginzburg
Torrentiniana, per quanto accorto, avrebbe potuto illustrare con tale acutezza e autonomi argomenti quell’idea di progresso e le implicazio-ni dell’importanza della conoscenza del passato per il miglioramento progressivo delle arti se non le avesse verificate nel proprio dominio; in questo caso, il vasto campo della lingua e delle lettere, nel quale la matrice ciceroniana aveva trovato una precedente applicazione per opera di Pietro Bembo.
Come segnala Borghini, la strada era stata aperta appunto dal Bem-bo, che aveva incluso nella sua trattazione esempi dei periodi più antichi e più bassi dello sviluppo delle lingue: non per recuperarli all’uso, ma per mostrare il cammino fatto,
veggendosi la natural semplicità di essa lingua pura e schietta e quanto, a presso alla sua nascita, ella sia di mano in mano con l’età venuta crescendo in bellezza e leggiadria, la qual cosa oltre che arreca piacere a chi legge, fa ancora utile a chi è capace del miglioramento e gli è come una via e regola di conoscere e trovare sempre il migliore67
È questo il Bembo delle Prose della volgar lingua, che sarà opportuno considerare, molto più di quanto sia stato fatto finora, come uno dei pianeti attorno a cui deve aver gravitato fin dal principio l’impre-sa delle Vite68. Il modello di Bembo dovette lasciare una profonda impressione nel giovane Borghini, che immaginiamo attento lettore delle Prose – la cui seconda edizione era apparsa nel 153869 – forse
67 Borghini, Scritti inediti o rari sulla lingua cit., p. 12 (è un testo intitolato dallo stesso Borghini Bozzaccia d’una lettera inanzi al Novellino, le cui idee corrispondono a quelle esposte nella prefazione al Novellino pubblicata nel 1572; Woodhouse lo riporta alle pp. 11-14); vd. pure Scritti d’arte del Cinquecento cit., II, pp. 1539-1540, nota 4.
68 Per le considerazioni sul ruolo di Bembo ci si è avvalsi qui soprattutto degli studi di Dionisotti, ora in C. Dionisotti, Scritti sul Bembo cit.
69 Se la seconda edizione delle Prose contò per la preistoria della prima edizione delle Vite, la terza doveva uscire in un clima molto simile a quello in cui si avviò la stampa del libro di Vasari: il primo progetto del 1548 per la nuova ristampa era del Gualteruzzi, e prevedeva una lettera di premessa del poeta bernesco Giovan Francesco Lottini, scolaro del Vettori e ricordato dal Vasari nel passo sugli amici di Michelangelo (F. Niccolai, Pier Vettori (1499-1585), Firenze, Seeber 1912, p. 112; Vasari, Le Vite cit., VI, p. 109); poi, con una virata piuttosto simile a quella del volume vasariano, l’editore diventa Torrentino, e l’autore della lettera dedicatoria
173 Filologia e storia dell’arte
anche sulla scia dei rapporti di profonda stima che già da tempo le-gavano Bembo e Vettori70. A rafforzare l’importanza di quell’esempio fu però probabilmente una sollecitazione più diretta, occorsa qualche anno dopo, di cui testimonia lo stesso Borghini:
L’anno ’42, se io non m’inganno, passando Monsignor Bembo di Firenze, alloggiò con noi, dove da noi gli fur fatte quelle carezze e dimostrazioni d’amore che la virtù e grandezza sua meritava, e lui usò quella dimestichezza e familiarità che la virtù e umanità sua soleva.
Con la acutissima intelligenza e la straordinaria capacità di restitu-zione del vero che gli erano proprie, Borghini descrive l’incontro di Bembo con i giovani benedettini; ne deriva una diretta testimonian-za sull’operazione compiuta dall’autore delle Prose della volgar lingua: non messa a norma o astratta sistematizzazione, come poi è stata so-prattutto intesa nella sua secolare fortuna, ma al contrario vivissima intuizione di una realtà esistente, che trova conferma quasi insperata in un’esperienza quotidiana, felice riprova di una ricostruzione a ta-volino71.
a Cosimo diventa Varchi, che intanto ha avuto l’incarico della Storia fiorentina (A. Sorella, Benedetto Varchi e l’edizione torrentiniana delle Prose, in Prose della volgar lingua di Pietro Bembo. Atti del convegno (Gargnano del Garda, 4-7 ottobre 2000), a cura di S. Morgana, M. Piotti, M. Prada, Milano 2000 (Quaderni di Acme, 46), pp. 493-508; A. Sorella, Borghini, Bembo e Varchi, in Fra lo “spedale” e il principe. Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione nella Firenze di Cosimo I. Atti del convegno (Firenze, 21-22 marzo 2002), a cura di G. Bertoli, R. Drusi, Padova, Il Poligrafo 2005, pp. 149-157).
70 Nel luglio 1535 Benedetto Lampridio scrive al Vettori «A questi giorni passati parlai con monsignor Bembo qual desidera farvi piacere, et fu longo rasonar de voi et vostri studi et fatiche in adiutar gli testi di Cicerone» (A. Santosuosso, Pier Vettori e Benedetto Lampridio, in «La Bibliofilia», LXXX, 1978, p. 165); nel novembre 1535 Bembo scrive da Padova al Varchi a Firenze dicendosi lieto del «testimonio, che mi dite, che egli [Vettori] fa di me nelle annotazioni Ciceroniane sue», ma già nei mesi precedenti più volte invia i suoi saluti al Vettori (P. Bembo, Lettere, a cura di E. Travi, Bologna, Arti Grafiche Tamari 1992, III, n. 1730, p. 629 e n. 1701, p. 602).
71 Per questa lettura dell’opera del Bembo cfr. C. Dionisotti, Introduzione a P. Bembo, Prose e rime, Torino, UTET 1960, ristampato in Dionisotti, Scritti sul Bembo cit., p. 57.
174 Silvia Ginzburg
Come un antropologo dell’inizio del Novecento Pietro Bembo, pio-niere di una disciplina nascente, si sorprende sul campo e si rallegra della giustezza delle proprie intuizioni sulla lingua:
essendogli intorno certi dei nostri giovani, gli domandava di molte cose, tentando di fargli parlare per ogni via, e non crederesti come notava ogni minima cosa, facea replicare e spesso dichiarare qualche voce con un piacere incredibile, e si volgeva a quei suoi ridendo e, come s’egli avessi ritrovato un tesoro, ricordava loro quel che sopra quella materia gli avea scritto, e gli pareva un miracolo vederlo senza arte espresso naturalmente in quei giovani72.
Quel passaggio da Firenze, avvenuto a ridosso della nomina di Bem-bo a protettore della congregazione benedettino-cassinese in seguito alla morte del Contarini nel 1542, dovette lasciare una traccia pro-fondissima sul benedettino Borghini, che subito mostra di rievocare il nesso Bembo-Cicerone nel trattatello sull’imitazione scritto a San Benedetto in Polirone73, dove si era trasferito nell’agosto dello stesso anno e dove trovava il giovane protetto del Bembo, Lorenzo Masso-lo74.
Per il Borghini dei primi anni Quaranta l’effetto dell’incontro con Bembo si misura dunque su Cicerone, al quale lo spingeva l’edizione curata da Vettori negli anni Trenta, che egli acquista a Venezia nel 1544 (ma Borghini spesso comprava i libri dopo averli letti75): Vet-tori pubblica e commenta Cicerone, Bembo indica che uso farne; e
72 Uno di quei ragazzi stupito chiede a Borghini se quello sia davvero il tanto celebrato Bembo, e avutane risposta affermativa aggiunge: «Oh […] e che vuol dire che e’ fa tanta maraviglia di queste cose minime che e’ par che e’ non udisse mai più nulla?» e Borghini gli risponde che quella meraviglia non indicava ignoranza, «ma era diletto e sodisfazione dell’animo suo in riconoscere quelle cose di che lui era buon maestro, e più presto si dovea e potea chiamar satisfazione e letizia che maraviglia» (Borghini, Scritti inediti o rari sulla lingua cit., pp. 292-293, dal ms. della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze II X 116, c. 86v).
73 Scritti d’arte del Cinquecento cit., pp. 1537-1550.74 Su Massolo in rapporto al Borghini cfr. Il carteggio di Vincenzio Borghini cit.,
passim.75 Legrenzi, Vincenzio Borghini cit., p. 281; Vincenzio Borghini. Filologia e invenzio-
ne cit, p. 8. Su Vettori negli anni Trenta cfr. Lo Re, Tra filologia e politica cit.
175 Filologia e storia dell’arte
Borghini applica quel modello alla riflessione sull’andamento della lingua e delle lettere a Firenze, sollecitando Vasari a fare lo stesso per le arti.
Sono percorsi che non sorprenderanno chi consideri che l’acquisi-zione dell’opportunità di giudicare secundum quid, condizione essen-ziale per la storia dell’arte di cui Vasari si fa portatore con una con-sapevolezza del tutto nuova, era strumento primo, e già consolidato, di quella filologia: e non stupisce neppure, allora, che l’immagine più efficace di questo principio della relatività del giudizio applicato alle arti figurative sia Borghini a lasciarla, in una pagina del manoscritto della Selva di Notizie. Siamo ormai già nel 1564, a ridosso della Giun-tina: ma di nuovo mi chiedo se un semplice lettore della Torrentinia-na avrebbe mai saputo rappresentare tanto vividamente quell’idea astratta, come fa Borghini con il bellissimo inserto di genere ‘basso’, ritagliato dal repertorio dei gesti quotidiani, con cui si chiude il passo che segue:
Et hacci di quelli che parlando di Giotto non pensono che quello si vegha sia suo, tanto hanno nella mente et imagination loro presuposto una cosa da ogni parte perfetta; et pur chi scrisse non s’ingannò di quel ch’era, ma bene di quello che poteva essere, sì che disputando di questa cosa bisogna haver rispetto alle circustantie de’ tempi de l’arte etc., che parlando di Giotto lo terrò miracoloso et excellentissimo ne’ sua tempi perché si trovò a risuscitare un’arte che era morta con pochissimi aiuti, tanto che fu miracolo tutto quello che fece; ma per questo che si debba antiporre la sua pittur’a a quelle d’Andrea del Sarto, et di Raffaello da Urbino, o di Michelagniolo sarebbe una heresia, et nondimeno le lodi date a Giotto son ben date quanto le date a questi altri, non prese semplicemente, ma con una consideratione: che colui hebbe a.ffarsi il fondamento et l’edifitio da sé, quest’altri trovorno il pan cotto, la tavola apparechiata, i macheroni caldi76.
76 Borghini, Selva di notizie cit., p. 15. Per il parallelo in Vasari cfr. il proemio alla seconda parte delle Vite: «Laonde que’ maestri che furono in questo tempo, e da me son stati messi nella prima parte, meriteranno quella lode e d’esser tenuti in quel conto, che meritano le cose fatte da loro, pur che si consideri, come anche quelle delli architetti e de’ pittori di que’ tempi, [che] non ebbono innanzi aiuto et aveva-no a trovare la via da per loro; et il principio, ancora che piccolo, è degno sempre di lode non piccola» (Vasari, Le Vite cit., III, p. 11). La stessa idea è in un’altra pagina di Borghini sugli andamenti della storiografia fiorentina, pubblicata poi nelle Istorie pistolesi, ed. a cura di A.M. Biscioni, Milano 1845, p. xxvii: «Le lettere
176 Silvia Ginzburg
8. I nessi qui delineati indicano l’opportunità di antedatare l’avvio di quello scambio tanto fertile tra Vasari e Borghini di cui più tardi il secondo fornirà un’immagine efficacissima:
L’historia della nave la scrive il Guicciardino, che ne potrete pigliar uno da Giunti e darli un’occhiata. Ma come ho detto, bisogna che la mastichiamo insieme, et voi servirete per i denti di sopra, et io per que’ di sotto: pure io andrò in parte pensando77.
Già la Torrentiniana va intesa come il frutto di questo comune ma-sticare letture, pensieri e opere viste: e l’esempio più simile che viene in mente è quello della lettera a Leone X di Raffaello e Baldassar Castiglione, che dietro la firma solitaria dell’artista cela gli scambi fittissimi con l’umanista amico – un manoscritto della quale, già nella raccolta di Angelo Colocci, parrebbe essere stato posseduto da Pier Vettori, e forse per questa via noto a Vasari che, come è stato rilevato
umane in Italia perirono insieme con gli altri ornamenti nella barbara inondazione: Dante e ’l Petrarca risuscitarono la Poesia, ed in un tratto (cosa maravigliosa a dire) la rialzarono al sommo grado antico. La Storia non ebbe sì mirabile avventura, ma secondo natura prima per certe semplici ricordanze rozze e volgari cominciò un poco a palpitare, poi per Giovanni e Matteo Villani quasi respirò e rinvenne; tanto che M. Lionardo, e M. Poggio e ’l Machiavello, e ’l Guicciardino, per non uscire da’ nostri Fiorentini, l’hanno nella sua prima robustezza e beltà condotta. E quantunque all’artificio di quest’ultime storie non si possano quelle prime memorie, o Cronache agguagliare, non pertanto non si deono elle disprezzare, o schifare, anzi amare e conservare, sì perché elle furono della rinascente storia principi, che tutti sono piccoli, ma per lo merito e per l’antichità reverendi; sì perché elle ritengono e ci rappresentano la nostra Fiorentina favella semplice, pura, e candida» (cfr. anche Williams, Vincenzo Borghini cit., p. 93). Similmente, nel proemio della seconda parte delle Vite, dopo aver affermato che il confronto tra Giotto e contemporanei e quelli che sono venuti dopo è insostenibile, Vasari scrive: «Ma chi considererà la qualità di que’ tempi, la carestia de gli artefici, la difficultà de’ buoni aiuti, le terrà non belle, come ho detto io, ma miracolose, et arà piacere infinito di vedere i primi principii e quelle scintilla di buono che nelle pitture et sculture cominciavono a risuscitare» (Vasari, Le Vite cit., III, p. 14).
77 È la lettera di Borghini a Vasari dell’11 agosto 1566 su una scena degli affre-schi della Sala dei Cinquecento (Frey, Der Literarische Nachlass cit., II, p. 269; Williams, Vincenzo Borghini cit., p. 146).
177 Filologia e storia dell’arte
a più riprese, mostra di conoscerne alcuni argomenti essenziali come la riflessione sull’Arco di Costantino78.
Si tocca qui la questione dell’autografia dell’opera vasariana, che di recente è stata radicalmente messa in discussione in favore di una partecipazione sostanziale dei correttori del gruppo degli Ara-mei (Giambullari e Bartoli in particolare) alla concezione, prima che alla redazione, della Torrentiniana79. È sintomatico che nel formulare quelle proposte non si sia tenuto conto quanto ci si sarebbe aspettato della storia del problema, che pure è ricca e notoriamente complessa. La discussione sui molteplici autori delle Vite conta infatti una lunga tradizione: a più riprese, nei secoli, ai più stretti interlocutori di Vasari (Miniato Pitti, Gianmatteo Faetani, Silvano Razzi, lo stesso Vincen-zio Borghini) è stato attribuito un ruolo di rilievo nella redazione del testo – della Giuntina soprattutto, ma anche della Torrentiniana80
78 F. P. Di Teodoro, Raffaello, Baldassar Castiglione e la Lettera a Leone X, “…con lo aiuto tuo mi sforcerò vendicare dalla morte quel poco che resta…”, Bologna, Nuova Alfa 1994, pp. 99-109; I. Rowlands, Raphael, Angelo Colocci and the genesis of the architectural orders, in Sixteenth Century Italian Art, ed. by M.W. Cole, Oxford, Blackwell 2006, pp. 511-536.
79 Ch. Hope, Can you trust Vasari?, in «The New York Review of Book», 5 october 1995, pp. 10-13; seguito da Th. Frangenberg, Bartoli, Giambullari and the prefaces to Vasari’s Lives (1550), in «The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», LXV, 2002, pp. 244-258. L’ipotesi, sostenuta con l’intento esplicito di contrastare il primato di Vasari nella storia dell’arte, muove dalla convinzione che le biografie e i proemi siano stati concepiti, oltre che redatti, da figure diverse e, ciò che più conta, in tempi diversi. Ne deriva l’incredibile conseguenza secondo cui «one of the most influential historiographic innovations of the Lives – the subdivision of art history after the rebirth of art into three periods with their respective manners – was a late addition of this text» (Frangenberg, Bartoli cit., p. 255). Vasari viene ridotto così a un pettegolo raccoglitore di aneddoti (le biografie), ignaro delle implicazioni teoriche del sistema (i proemi) – come se le biografie non fossero intrise delle idee esposte nei proemi.
80 La fortuna della partecipazione di Borghini all’impresa vasariana conta diverse voci a partire dal XVII secolo, da Lorenzo Pignoria a Giovanni Cinelli (cfr. Scoti Bertinelli, Giorgio Vasari scrittore cit., pp. 76-77) e più tardi diversi altri tra i quali G. Negri, Istoria degli scrittori fiorentini, Ferrara 1722, p. 526; G. Mazzucchelli, Gli scrittori d’Italia, 2, 3, 1762; J. François, Bibliothèque générale des écrivains de l’Ordre de Saint-Benoît, Bouillon 1777-1778, répr. anast. Louvain 1961, I, p. 137; F.
178 Silvia Ginzburg
– alla quale, per esempio, è stato supposto che alludano i versi di Benvenuto Cellini scritti in odio alla coppia di ferro Borghini-Vasari: «Giorgio Aretin e quel Frate priore / sono uno stesso, se ben paion due»81. È una tradizione di cui, in assenza di manoscritti su cui lavo-rare, è impossibile misurare l’effettiva portata; e ben si capisce che la grande scuola filologica degli studi vasariani di inizio Novecento di Kallab e di Schlosser abbia criticato aspramente gli improbabili tentativi di Scoti Bertinelli di individuare mani diverse nel testo a stampa. Aveva tuttavia probabilmente ragione Charles Davis quan-do, nel commentare quei due modelli di metodo così diversi, uno tanto restio a cercare tracce di collaborazione, l’altro tanto pronto ad inventarsele, sosteneva che «forse resta ancora da scrivere una più complessa storia delle Vite»82. Non si tratta però di sottrarre a Vasari il suo ruolo decisivo, né di intendere l’opera sua come mera piaggeria nei confronti di Cosimo83, ma di tentare di ricostruire le tracce del dialogo tra l’artista e i suoi interlocutori che rese possibile questo esito straordinario: il che nel caso qui in esame significa chiedersi se sia mai possibile che, con quella testa e quei pensieri nella testa già negli anni Quaranta, Borghini possa considerarsi un semplice comprimario, un fornitore di notizie, o fosse pure di risposte alle gigantesche domande di Vasari – o se non si debba credere che quelle domande vennero a Vasari anche proprio dai colloqui con lui. A questo proposito mi pare meriti di essere ripresa in seria considerazione l’ipotesi già formulata di assegnare al Borghini, alla sua mente se non alla sua mano, il ma-noscritto XVII, 17 del fondo Magliabechi della Biblioteca Nazionale
Inghirami, Storia della Toscana, XII, Firenze 1843, p. 1543, fino al commento alle Vite di Marchese, Pini, Milanesi (1846-1855), che riunisce Borghini agli altri possibili coautori e correttori: «Abbiansi pure Don Miniato Pitti, Don Gian Matteo Faetani, Don Vincenzo Borghini, Don Silvano Razzi la nostra gratitudine per avere aiutato di consigli il Vasari e correttone il manoscritto; ma non si dia all’ultimo di questi monaci la lode di tutta l’opera, ché ciò nol comporta la verità e la giustizia.» (cit. in Vasari, Le Vite cit., Commento, I, p. 107). Sulla partecipazione di Borghini cfr. anche i passi del Bottari (ibidem, p. 7):
81 Secondo Legrenzi, Vincenzio Borghini cit., pp. 99-100, il Cellini, «per quanto di lingua pronta», non avrebbe potuto scrivere quei versi con tanto anticipo sull’uscita del volume giuntino «se non si fosse generalmente creduto che il Borghini avesse aiutato il Vasari anche nella prima edizione dell’opera».
82 Ch. Davis, in Giorgio Vasari. Principi, letterati ed artisti cit., p. 226-227.83 Hope, Can you trust cit.
179 Filologia e storia dell’arte
di Firenze, noto alla letteratura artistica come Anonimo Magliabe-chiano o più precisamente Anonimo Gaddiano dalla provenienza del manoscritto da casa Gaddi, che nell’inventario del 1755 del Fondo Magliabechiano è identificato come «Fonti di Monsignore Vincenzio Borghini. Selva di notizie delle vite de’ pittori»84.
Quello che soprattutto ha contato per Vasari è infatti il Borghini filologo, l’allievo del Vettori negli anni Quaranta, l’autore del trat-tato sulle famiglie romane redatto nella seconda metà del decennio, nel quale il modello di Bembo è fortissimo, fin dall’impostazione nar-rativa85. Al centro del dialogo Borghini pone il fratello Agnolo, in quegli anni figura di riferimento dei rapporti tra Firenze e Padova86 e, evidentemente, membro della cerchia fiorentina dei partigiani di Bembo. Agnolo Borghini figura infatti nella prima stagione dell’ac-cademia degli Umidi e viene definito dal Varchi «non pure amico, ma antichissimo e cordialissimo amico» nel discorso pronunciato nel 1554 in occasione della sua nomina a console dell’accademia fioren-tina e rettore dello Studio, il cui incipit è tutto sull’idea della natura che non fa salti nella sequenza principio-accrescimento-colmo-dicre-scimento-fine87.
84 L’identificazione di Borghini con l’Anonimo Magliabechiano è stata sostenuta da R. Stapleford, Vasari and Botticelli, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz», XXXIX, 1995, pp. 397-408 (sul quale cfr. F. Caglioti, D. Gasparotto, Lorenzo Ghiberti, il ‘Sigillo di Nerone’ e le origini della placchetta ‘anti-quaria’, in «Prospettiva», 85, 1997, pp. 2-38: nota 9, p. 3) e rifiutata da Scapecchi soprattutto perché nel redattore del manoscritto non si può identificare la mano del Borghini (P. Scapecchi, Una carta dell’esemplare riminese delle Vite del Vasari con correzioni di Giambullari. Nuove indicazioni e proposte per la Torrentiniana, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XLII, 1998, pp. 101-113, seguito da Carrara, in Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., cat. n. 4.8a, p. 151). L’argomento tuttavia non sembra decisivo, giacché il codice può ben essere stata redatto da un copista, mentre le coincidenze di interessi, di visione, di frequentazioni (Pontormo, Vasari) sono pienamente compatibili con l’attribuzione a Borghini del testo.
85 Carrara, Gli studi antiquari del Borghini cit.; Vincenzio Borghini, Filologia e inven-zione cit., cat. n. 2.3 pp. 20-25.
86 Su Agnolo cfr. Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., pp. 249-252.87 B. Varchi, Parole fatte pubblicamente nell’Accademia fiorentina nel rendere il
consolato in nome di mess. Guido Guidi a mess. Agnolo Borghini, la prima Domenica d’Aprile 1554, in Id., Lezioni sul Dante e prose varie di Benedetto Varchi la maggior
180 Silvia Ginzburg
Più che per le sue posizioni sulla lingua, nel trattato di Borghini sulle famiglie romane Pietro Bembo figura in quanto autorità della cultura filologica, garante primo della trasmissione del metodo di Po-liziano al presente – ovvero al Vettori e al suo allievo, che documenta così la propria piena adesione a queste date alla grande tradizione della filologia tra Quattro e Cinquecento lungo la linea Poliziano-Bembo-Vettori88.
L’innesto nella letteratura artistica di una concezione storiografica moderna, cioè fondata su un metodo filologico, di verifica dei dati, sa-rebbe dovuta dunque all’incontro tra un artista e un filologo. La storia dell’arte in senso proprio sarebbe sorta in risposta alle domande, alle richieste, alle esigenze della filologia. O meglio ancora: sarebbe sorta dalle risposte della filologia alle lacune metodologiche di un certo modo di fare storia – quello di Giovio.
9. Dietro la Torrentiniana non c’è solo Giovio, dunque (l’amore per Giovio, il conflitto con Giovio), ma anche Borghini e il suo maestro, Pier Vettori, «la figura più alta della cultura filologica italiana del Cinquecento», secondo la definizione di Momigliano89. Un riesame della figura del Vettori, che come segnalano gli studi più avvertiti at-tende ancora la piena restituzione che merita90, sarà cruciale per una riconsiderazione della preistoria delle Vite.
parte inedite tratte ora in luce dagli originali della Biblioteca Rinucciana per cura e opera di Giuseppe Aiazzi e Lelio Arbib, II, Firenze, Società Editrice delle Storie del Nardi e del Varchi 1841, pp. 65-69. Sugli scambi tra Borghini e Varchi attorno a Bembo cfr. A. Sorella, Borghini, Bembo e Varchi, cit., pp. 149-157.
88 V. Branca, Poliziano cit., p. 328; A. Grafton, Joseph Scaliger cit.p. 45; L. Cesarini Martinelli, Pier Vettori e gli umanisti tedeschi cit., pp. 708-710; F. Lo Monaco, Ovidio, Poliziano, Pier Vettori cit.; C. Vecce, Bembo e Poliziano, in Agnolo Poliziano. Poeta scrittore filologo cit., pp. 477-503; Dionisotti, Scritti sul Bembo cit., passim.
89 A. Momigliano, L’eredità della filologia antica e il metodo storico [1958], in Id., Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma 1960 [ristampato in Id., Sui fondamenti della storia antica, Torino 1984, p. 78]. Sul ruolo del Vettori per la rina-scita della filologia italiana a metà del Cinquecento cfr. anche C. Dionisotti, La letteratura italiana nell’età del Concilio di Trento [1965], in Id., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi 1967, p. 250 e i testi citati alla nota successiva.
90 L. Cesarini Martinelli, Contributo all’epistolario di Pier Vettori (Lettere a don Vincenzio Borghini, 1546-1565), in «Rinascimento», n.s., XIX, 1979, pp. 189-227; V.
181 Filologia e storia dell’arte
A indicarlo è innanzi tutto il rapporto tra Vasari e Vettori che poté passare naturalmente attraverso il Borghini, ma che c’è ragione di credere dovette essere anche più diretto e di non poco conto, dal momento che nel 1550 Vettori intercede presso Cosimo in favore dell’artista e al Vasari medesimo scrive
Et io non mancai d’aiutar la cosa, quanto potetti, come farò sempre in ogni vostro affare: Perché così sono tenuto per l’amore, che m’havete sempre mostro91.
Ma sono ancora una volta le affinità delle idee a sostanziare que-sto nesso. Fin dagli anni Quaranta Vettori pubblica gli autori classici della raccolta medicea con un progetto che a prima vista celebra la munificenza di Cosimo, ma il cui intento di fondo è onorare l’età di Lorenzo e perciò soprattutto di Poliziano, giacché per lui e per i mi-gliori tra i suoi allievi, Borghini in testa, la filologia non è semplice-mente un metodo: è un ponte che permette di raggiungere il modello dell’era laurenziana, con l’intento di affermare, prima e più che la continuità dei Medici, come si tende a credere noi oggi, la continuità della cultura filologica fiorentina, obiettivo che doveva star loro mol-to più a cuore allora92.
Il ruolo chiave del Vettori si misura anche semplicemente tenendo conto che egli è uno dei referenti primi della rete di rapporti che si intrecciano fra il quarto e il quinto decennio tra Firenze e Roma. Sono note, ma tutte da intendere nelle loro implicazioni e reciproci scambi, le fitte relazioni che tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta
Vianello, Fuoriuscitismo politico fiorentino e produzione letteraria nel Cinquecento, in T. Agostini Nordio, V. Vianello, Contributi rinascimentali. Venezia e Firenze (Materiali e ricerche 1. Collana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia), Abano Terme (PD) 1982, pp. 133-163; L. Cesarini Martinelli, Pier Vettori e gli uma-nisti tedeschi cit.; A. Porro, Pier Vettori editore di testi greci: la Poetica di Aristotele, in «Italia medievale e umanistica», XXVI, 1983, pp. 307-358; E. Carrara, Il discepolato cit., pp. 159-177; S. Lo Re, Tra filologia e politica cit.
91 Lettera del Vettori al Vasari del 17 maggio 1550 (cfr. Frey, Der Literarische Nachlass cit., I, p. 284).
92 Per la collaborazione di Borghini alla concezione del frontespizio per le edi-zioni dei testi della Biblioteca Laurenziana curate dal Vettori cfr. E. Carrara, Introduzione alle lettere in lingua latina, in Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., pp. 86-87; Vincenzio Borghini. Dall’erudizione alla filologia cit., cat. n. 4.1b, pp. 66-68.
182 Silvia Ginzburg
egli intrattenne da Firenze e durante i soggiorni a Roma con la cer-chia dei fuoriusciti fiorentini e degli eruditi e dei letterati legati poi all’ambiente farnesiano, ma prima all’Accademia della Virtù e prima ancora dei Vignaiuoli93: Niccolò Ardinghelli, Rodolfo Pio da Carpi, il cardinal Ridolfi, il Della Casa, Marcello Cervini, Bernardino Maf-fei, Giovanni Gaddi, Francesco Maria Molza, Annibal Caro94. Sono rapporti attestati da contatti diretti o registrati dalla corrispondenza che il Vettori intrattiene con Donato Giannotti, che nei primi anni Quaranta gli scrive da Roma quasi tutti i giorni e che è il principale tramite con gli ambienti romani più vicini al Buonarroti, accanto a Luigi Del Riccio e a Michelangelo stesso95.
93 Sono ambienti a cui sono legati anche gli allievi del Vettori, come Fabio Segni (cfr. infra, nota 103) o come il Varchi, di cui si è ipotizzata una partecipazione alle riunioni dell’Accademia della Virtù durante il soggiorno a Roma nel 1537 (R.S. Samuels, B. Varchi, the Accademia degli Infiammati and the origins of the italian academic mouvement, in «Renaissance Quarterly», XXIX, 1976, 4, pp. 599-633), o come lo stesso Borghini, che plausibilmente frequentò questa cerchia quando fu a Roma alla fine del 1539 (Folena, Borghini, Vincenzio cit.), ovvero subito prima che il Giannotti, Giovanni Gaddi e Ludovico Fabri da Fano a Roma lavorassero alla revisione delle Posteriores castigationes delle Familiari di Cicerone, edite dal Vettori nel 1540.
94 Su questi scambi cfr. Lettere di Piero Vettori per la prima volta pubblicate da G. Ghinassi, Bologna 1870; D. Giannotti, Lettere a Pietro Vettori, pubblicate sopra gli originali del Britsh Museum da R. Ridolfi e C. Roth con un saggio illustrativo a cura di R. Ridolfi, Firenze, Vallecchi 1932; Niccolai, Pier Vettori cit.; Lo Re, Tra filologia e politica cit.; Petri Victorii Epistolarum libri X, scelta e commento a cura di G. Pompella, Napoli 1991. Sui rapporti con Cervini, dedicatario dell’edizione vettoriana di Clemente Alessandrino del 1550 cfr. Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., p. 15 e R. Mouren, La lecture assidue des classiques: Marcello Cervini et Piero Vettori, in Humanisme et Eglise entre France et Italie, du début du XVe siècle au milieu du XVIe siècle. Colloque international (Roma, 3-6 febbraio 2000), Roma 2004 (Collection de l’Ecole française de Roma, 330), pp. 433-463; per gli scambi con Della Casa vd. Ticciani, Notizie letterarie cit.; C. Scarpati, Con Giovanni della Casa dal De Officiis al Galateo, in «Italia medievale e umanistica», XXIV, 1981, pp. 317-349: 322; S. Carrai, Per la cronologia di alcune lettere del Della Casa al Vettori, in «Rinascimento», XXV, 1985, pp. 293-296; Corsaro, Giovanni Della Casa comico cit.; C. Scarpati, Osservazioni intorno al frammento sulle lingue, ivi, pp. 241-251.
95 D. Giannotti, Lettere a Piero Vettori cit.; per i rapporti con Michelangelo cfr. la nota lettera a Borghini del 4 gennaio 1557 (stile fiorentino): «Questi gentil huomini Todeschi havevon gran voglia di veder solo Michel Agnolo Buon. et io
183 Filologia e storia dell’arte
C’era del resto anche il Vettori tra i giovani che negli anni Venti si raccolsero attorno a Michelangelo a studiare Vitruvio, in uno degli episodi più noti della fortuna vitruviana di primo Cinquecento96. Esso si può collocare, come è stato supposto, verso la metà del decennio: e se fosse avvenuto, come è probabile, tra il 1524, data del ritorno a Firenze di Ippolito e Alessandro de’ Medici con il Valeriano precetto-re, e il 1527, anno della loro cacciata, si collocherebbe come diretto e importante anticipo degli obiettivi dell’Accademia della Virtù, che qualche anno dopo a Roma troverà proprio in Ippolito il maggior protettore97. Inoltre, e ciò che più conta, a quelle date verrebbe a trovarsi in stretta contiguità con quell’occasione formidabile di studi e riflessioni sull’architettura che dovette essere il cantiere michelan-giolesco della Sacrestia nuova e della Libreria di San Lorenzo98: il che potrebbe contribuire a spiegare perché a una traduzione vitruviana si applichi di lì a poco, nel 1532, come attesta la celebre lettera scritta a Michelangelo99, un uomo come Giovanni Norchiati, che era fin
gli feci introdurre, il quale gl’accolse amorevolmente et sodisfece loro di ciò che e’ seppono adimandare, qui tamen solet quos spernere! et di più m’ha per loro mandato a ringratiare et offerirsi in ciò che e’ può per me et per gl’amici mia. Ma lasciamo andare questa scioccheria». (L. Cesarini Martinelli, Contributo all’epistolario di Pier Vettori cit., p. 214; Ead., Pier Vettori e gli umanisti tedeschi cit.). Vd. anche E. Steinmann, Michelangelo e Luigi del Riccio (con documenti inediti), estratto da «Rivista storica degli archivi toscani», III, 1931, 4.
96 «Pietro Vettori, homo dottissimo ne fece testimonianza com’egli nel MCXX… [sic] in compagnia sua [di Michelangelo], d’Antonio degli Alberti et d’Averardo Serristori gentilhuomini giudiziosissimi et di Giovan Francesco da San Gallo et Lorenzo Cresci, artefici eccellentissimi viddero et esaminarono gran parte degli scritti di Vitruvio; avvenga che per diversi accidenti lasciassero poi tale studio imperfetto» (I tre primi libri di Gherardo Spini sopra l’Instituzioni de’ greci et latini architettori intorno agl’ornamenti che convengono a tutte le fabbriche che l’Architettura compone, in Il dise-gno interrotto. Trattati medicei d’architettura I. Testi e documenti, a cura di F. Borsi, C. Acidini, Firenze, Gonnelli 1980, p. 51).
97 Così anche Ferretti, Tra Bindo Altoviti cit., soprattutto p. 457.98 Sull’episodio vd. almeno Pagliara, Vitruvio da testo a canone cit., p. 6; sul can-
tiere laurenziano C. Elam, Michelangelo and the Clementine Architectural Style, in The Pontificate of Clement VII. History, politics and culture, ed. by K. Gowens, S.E. Peiss, Aldershot, Ashgate 2005, pp. 199-225: 203.
99 «Da poi che vi partisti di qua io ho lavorato forte in sul Vitruvio e sono già nel
184 Silvia Ginzburg
dall’inizio degli anni Venti maestro della scuola dei chierici di San Lorenzo e che ritroviamo poi fondatore dell’accademia degli Umidi assieme ad altri partecipanti a quel gruppo di studio su Vitruvio atte-stato dal Vettori100.
10. A riflettere sulla datazione all’inizio degli anni Quaranta del-l’avvio primo delle Vite emergono più stretti quei nessi con Firenze in gran parte ovvi, ma che una lettura forse troppo filofarnesiana ha finora teso a lasciare nell’ombra, a partire dai rapporti con le idee e i progetti dei primi Umidi, così fortemente legati al modello di Bem-bo, importato allora a Firenze dal Varchi, e non ancora fatto oggetto dell’offensiva degli Aramei. In fondo vale per la storia della prima edizione delle Vite quello che dopo le ricerche di Plaisance è chiaro per la preistoria dell’accademia fiorentina; per il caso, per tanti versi intrecciato alle radici della Torrentiniana, dell’accademia degli Umi-di: la necessità di non trascurare quel primo capitolo così fortemente legato a Bembo, in cui il dialogo tra Firenze e Roma è continuo, e
settimo libro, che sei ne sono tradotti interi, e tuttavia lavoro […] ma harei bisogno di havervi a presso, si anchora coll’ochio vedere certe cose delle antiche, e se Dio mi dà gratia che io mi conduca a primavera, spero di venirvi a visitare a ogni modo, acciò che io vegga coll’ochio qualche cosa» (Lettera di Giovanni Norchiati da Firenze a Michelangelo a Roma del 7 dicembre 1532, in Il carteggio di Michelangelo ed. postuma di G. Poggi, a cura di P. Barocchi, Firenze, Sansoni 1965-1973, III, pp. 441-442).
100 Sul Norchiati cfr. Michelangelo e l’arte classica, catalogo della mostra (Firenze Casa Buonarroti, 15 aprile-15 ottobre 1987), a cura di G. Agosti, V. Farinella Firenze, Cantini 1987, n. 35 p. 83 e da ultimo C. Elam, Tuscan dispositions: Michelangelo’s florentine architectural vocabulary and its reception, in «Renaissance Studies», XIX; 2005, 1, pp. 46-82: 62 con bibliografia precedente. Sul suo progetto di raccogliere le voci degli artigiani fiorentini cfr. G. Gargiolli, Il parlare degli artigiani di Firenze: dialoghi ed altri scritti, Firenze 1876, rist. anast. Bologna, Forni 1978, pp. 111-112. Il progetto del Norchiati mostra una consonanza estremamente significativa con alcuni appunti di Borghini su termini legati alle professioni artigianali (legnaiuolo, fabbro, pizzicagnolo, calzolaio ecc.) che pur non trovandosi in Boccaccio meritano di essere inclusi nella lingua (cfr. Borghini, Scritti inediti o rari sulla lingua cit., pp. 111-113, dal ms. II X 110, pp. 66-69 e 102 della Biblioteca Nazionale di Firenze). Il trattato sui dittonghi del Norchiati era del resto tra le sue carte (Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., p. 310). Per il Norchiati tra gli Umidi (con Antonio degli Alberti e più tardi il Vettori) cfr. G. Ticciani, Notizie letterarie cit.
185 Filologia e storia dell’arte
che è stato messo in ombra dalla successiva e più ufficiale vicenda filomedicea. Eloquente in questo senso il caso della pubblicazione della raccolta di versi berneschi curata nel 1548 dal Lasca, membro tra i primi degli Umidi, poeta seguace del Berni e molto legato al Varchi, nonché in rapporto stretto con Bernadetto Minerbetti101. Gli autori dei versi sono per lo più membri dell’accademia fiorentina che sono stati anche parte a Roma dell’accademia dei Vignaiuoli e del-la Virtù: il Berni stesso, il Della Casa, il Varchi, il Mauro, il Bini, il Firenzuola102; ma è un rapporto che naturalmente vale anche alla rovescia: sono più d’uno i membri delle contigue accademie romane dei Vignaiuoli o della Virtù che ritroviamo tra i partecipanti dell’ac-cademia fiorentina – Giovanni Gaddi, Niccolò Ardinghelli, Agnolo Firenzuola o, particolarmente legati al Vasari, Baccio Rontini e Fabio Segni103.
101 Il primo libro delle opere Burlesche di Mes. Francesco Berni, di Mes. Giovanni della Casa, del Varchi, del Mauro, di Mes. Bino, del Molza, e del Firenzuola: ricorretto, e con diligenza ristampato in Firenze appresso Bern.o Giunta 1548. Cfr. M. Plaisance, Culture et politique à Florence de 1542 à 1551: Lasca et les Humidi aux prises avec l’Académie Florentine, in Les écrivains et le pouvoir en Italie à l’époque de la Renaissance (deuxième série), éd. par A. Rochon, Paris 1974, pp. 149-242, ora in Id., L’accademia e il suo principe cit., pp. 123-234.
102 Nel 1552 i versi vengono ristampati con dedica a Curzio Frangipani, genti-luomo romano citato nella Giuntina perché, essendo stato incaricato dal cardinal Farnese di compensare Aristotele da Sangallo per la prospettiva eseguita nel palaz-zo della Cancelleria su imitazione di quella commissionata all’artista da Ruberto Strozzi, fece venire Perino e Vasari a stimarla (Vasari, Le Vite cit., V, p. 401).
103 Il medico Baccio Rontini, già nei primi anni Trenta plausibilmente nella cer-chia di Ippolito, era in stretto rapporto con Vasari, il quale nel 1537, descrivendo la tavola del Corpus Domini a cui sta lavorando, gli domanda, se viene ad Arezzo, di portargli «quel libro dell’ossa et notomia, che l’altr’anno vi donai: perché me ne serviro un poco, non havendo qui io comodita di haver de morti come costi in Firenze» (Frey, Der Literarische Nachlass cit., I, n. XXVI, pp. 79-80). A Roma è il medico di Michelangelo: lo cura quando ha la febbre e quando cade dal ponteggio, e per questo viene lodato da Niccolò Martelli: «Voi lascerete il Papa, e Roma, e ognuno, per tornare di qua a’ tanti Amici vostri […] Ma perché e’ non pare, che un Fisico sia eccellente, se non ha medicato qualche tempo in una Roma, voi vi sete voluto cavare questa fantasia […] e se voi non aveste mai fatta più bella opera, che avere di già per due volte guarito il divino Michelagnolo, l’una oppressato da parocismi imensi della febbre e l’altra d’una rovinosa caduta di palco in palco, tanto
186 Silvia Ginzburg
Sono ambienti e persone in rapporto con Michelangelo tra Firenze e Roma, e spesso coinvolti a vario titolo nei lavori in San Lorenzo: a metà degli anni Trenta nelle lettere di Francesco Berni a Giovan Fran-cesco Bini, altro membro della Accademia dei Vignaiuoli, viene citato continuamente il referente primo di Michelangelo in quel cantiere, il Figiovanni «vostro e mio»104; nel 1550 Antonio Petrei, anch’egli
che prostrato, e quasi vicino alla morte, lo riduceste nell’unico tesoro della sanità, non ve ne debba avere obbligo tutto il mondo» (Ticciati, Notizie letterarie cit., pp. 30-31). Membro dell’accademia fiorentina, il Rontini a Roma doveva far parte dell’ambien-te dell’Accademia della Virtù e già dei Vignaiuoli se ben si intendono i versi a lui dedicati del capitolo che Matteo Franzesi scrisse a Fabio Segni: «Che voi vi state e satollo, e digiuno, / Col Rontin, col Ginoro, ed Antonietto, / Né vi stancate a intrat-tenere ognuno. / Che se sete col Fisico perfetto, / Discorrete i Segreti di Natura, / Con quel suo divinissimo intelletto; / Et anche insieme dell’Architettura / Ragionate, e di linee, e prospettive, / E di fare al Vin Greco una congiura ec.» (Ticciati, Notizie let-terarie cit., p. 30). Quando morì Fabio Segni gli dedicò un epitaffio. Anche quest’ul-timo ebbe rapporti stretti col Vasari: figlio di Antonio Segni che Vasari ricorda come «amicissimo» di Leonardo, scrisse gli epigrammi di Masaccio e di Correggio pubblicati nelle Vite (Vasari, Le Vite cit., III, p.134; IV, p. 55), e secondo la testimonianza dello stesso Vasari donò a Giovanni Gaddi un disegno di Leonardo con Nettuno assieme a versi che aveva ricevuto dal padre (ivi, IV, p. 23), il quale gli aveva lasciato anche la Calunnia di Apelle di Botticelli (ivi, III, p. 520). Allievo a Firenze di Pier Vettori (W. Rüdiger, Petrus Victorius aus Florenz: Studien zu eine Lebensbilde, Halle a. S., Niemeyer 1896; Niccolai, Pier Vettori cit., p. 128), a cui fa leggere i propri versi, a Roma il Segni è membro dell’accademia della Virtù, come attestano il Caro e i versi di Matteo Fran-zese, e in patria lavora a uno dei progetti che emersero in quella cerchia, un trattato sulle medaglie a cui nello stesso tempo a Roma si applica anche Bernardino Maffei (cfr. la lettera di Donato Giannotti a Pier Vettori del 7 maggio 1541: «Et la presente è per dirvi come m. Bernardino Maffei ha inteso che Fabio Segni scrive anchora egli sopra le medaglie et harebbe desiderio d’intendere qualche cosa della sua intentione, cioè se scrive sopra tutte o sopra una parte, et che modo di procedere egli tiene», Giannotti, Lettere a Pietro Vettori cit., p. 95). Nella sua lettera a Agostino de’ Landi il Tolomei parla del progetto di un libro sulle medaglie; il Maffei ci lavorava già dal 1540: è del 26 ottobre di quell’anno una lettera di Giannotti a Vettori in cui si dice che monsignor Ardinghelli ha giudicato il lavoro del Maffei bellissimo (ibidem, p. 82).
104 F. Berni, Poesie e prose, criticamente curate da E. Chiorboli con introduzione, nota, lessico e indici, Genève-Firenze, Olschki 1934, p. 349.
187 Filologia e storia dell’arte
autore di sonetti burleschi che lo collocano tra i seguaci del Berni, e all’apertura del decennio precedente a Roma come maestro di casa di Lorenzo Ridolfi, legato da stretti rapporti allo stampatore Francesco Priscianese e a Donato Giannotti, il quale lo pone assieme a se mede-simo a Luigi del Riccio e a Michelangelo nel dialogo su Dante105, è a Firenze, dove aveva sostituito il Norchiati come maestro dei chierici di San Lorenzo e segue la vicenda dell’ideazione di Michelangelo della scala di accesso alla libreria106. Per ragioni a tutt’oggi non del tutto chiarite, Antonio Petrei possedeva una strepitosa biblioteca, circa cin-quecentocinquanta codici di cui molti antichi e di qualità straordi-naria, e alcuni preziosissimi, come il celeberrimo Orazio del Petrarca donatogli da Lorenzo Ridolfi, che sono stati solo in minima parte iden-tificati tra i manoscritti della Laurenziana o altrove107. In questa stu-pefacente raccolta figurava anche uno dei due manoscritti pervenutici del cosiddetto Libro di Antonio Billi, una delle riconosciute fonti del Vasari108. Sono tutti dati noti: ma è sintomatico di una separazione che domina gli studi che, dopo i contributi pionieristici del Ridolfi, il Petrei protagonista del dialogo di Giannotti in rapporto con Michelangelo e il Petrei possessore del manoscritto del Libro di Antonio Billi non si incontrino – soprattutto non facciano il corto circuito che ci si aspetta.
Non sono i soli casi, né i più gravi, della scissione che si è imposta troppo spesso sugli studi e come un crepaccio impedisce di percorre-re continuativamente il territorio, che viceversa fu evidentemente
105 Dialogi di Donato Giannotti, de’ giorni che Dante consumò nel cercare l’Inferno e ’l Purgatorio, edizione critica a cura di D. Redig De Campos, Firenze, Sansoni 1939.
106 Nel 1550 Giannotti in una lettera a Lorenzo Ridolfi scrive: «Dite al Petreio che io sono addosso a Michelagniolo, e che io spero fargli fare un disegno per quella scala di S. Lorenzo: se lo potrò avere glielo manderò, acciò se ne faccia onore con sua excellenzia» (G. Milanesi, Alcune lettere di Donato Giannotti nuovamente trovate nell’Archivio Centrale dello Stato, in «Giornale storico degli archivi toscani», 1863, 2, pp. 155-175 e 3, pp. 220-252: lettera XXXIX).
107 Cfr. le notizie sul Petrei in Memorie istoriche dell’ambrosiana R. Basilica di S. Lorenzo di Firenze opera postuma del canonico Pier Nolasco Cianfogni umiliata dal-l’editore Canonico Domenico Moreni, Firenze presso Domenico Ciardetti, 1804, pp. 241-242; e nella Continuazione edita nel 1816, I, p. 66; R. Ridolfi, Antonio Petrei letterato e bibliofilo del Cinquecento, in «La Bibliofilia», XLIV, 1947, pp. 53-70.
108 Il Libro di Antonio Billi, a cura di F. Benedettucci, Anzio, De Rubeis 1991.
188 Silvia Ginzburg
compattissimo, e più che mai tra Firenze e Roma, tra gli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento, delle vicende che toccano la storia della lingua, della letteratura, della storiografia e della filologia da un lato, la storia dell’arte e della storiografia artistica dall’altro. A pagare il prezzo più alto, in questo caso, è proprio la ricostruzione del rapporto, che viceversa fu decisivo, tra la storia dell’arte e la filologia.
La strada che sembra più proficuo intraprendere per ricucire questi nessi è quella, su cui in altra occasione bisognerà tornare, della fortu-na di Bembo tra quarto e quinto decennio109, alla quale ad esempio mi pare si leghi un episodio tanto significativo per la storia dell’afferma-zione del volgare nel cuore del Cinquecento come la pubblicazione nel 1540 della grammatica del Priscianese, di cui è stata ragionevol-mente supposta una partecipazione all’Accademia della Virtù110. È un testo che appare come una pronta risposta alla riedizione delle Prose del 1538, ma ancor più alla presenza a Roma dal 1539 di Bembo, che era amico di Niccolò Ridolfi, presso il quale il Priscianese è a Roma appunto nel 1540. Un passo di una lettera di Giannotti a Vettori testimonia eloquentemente dell’influenza di Bembo su questa stessa cerchia a questa stessa data: una delle ragioni per cui inizialmente non voleva stampare Il libro della Repubblica de’ Vinitiani (pubblicato a Roma nel 1540 ma pronto già dal 1526) era che, scrive Giannotti, «non me pareva honorevole che la prima cosa che io dessi fuori fusse in lingua toscana»; a fargli cambiare idea su questo punto è l’esser stato convinto «dall’esemplo et persuasion di Mons. Bembo»111.
L’esempio di Bembo, l’influenza delle sue idee e della sua figura do-minano profondamente molte delle imprese qui ricordate: il Bembo filologo, il Bembo delle Prose, ma anche il Bembo degli anni ultimi, in rapporto con la cerchia degli ‘spirituali’ e con il Contarini, di cui
109 Per ricostruire appieno le relazioni di Bembo con la storia dell’arte, che restano ancora incredibilmente trascurate, si può partire dalla lunga nota di G. Agosti, Su Mantegna. I. La storia dell’arte libera la testa, Milano Feltrinelli 2005, pp. 181-183, nota 21.
110 Sul Priscianese e i suoi De primi principii della lingua romana, Vinegia per Bartolomeo Zanetti 1540, cfr. D. Redig De Campos, Francesco Priscianese stampa-tore e umanista fiorentino del secolo XVI, in «La Bibliofilia», XL, 1938, pp. 161-183; per i suoi rapporti con Venezia alla stessa altezza, nel 1540, vd. G. Padoan, A casa di Tiziano, una sera d’agosto, in Tiziano e Venezia. Convegno internazionale di studi (Venezia, 27 settembre-1 ottobre 1976), Vicenza, Pozza 1980, pp. 356-367.
111 Giannotti, Lettere a Pietro Vettori cit., p. 68.
189 Filologia e storia dell’arte
nel 1542 verrà nominato successore alla testa della congregazione be-nedettino-cassinese112.
11. Roma e Firenze: ed era noto. Ma all’origine della Torrentiniana c’è anche, più inaspettatamente, Mantova – o per essere più precisi San Benedetto in Polirone, dove Borghini si reca già nell’aprile 1542 al Capitolo generale dell’ordine e dove risiede stabilmente dall’agosto del ’42 al luglio del ’43, seguendo di poco il breve passaggio mantova-no del Vasari, del novembre del ’41. L’importante abbazia benedetti-na è proprio in quegli anni oggetto della grande campagna di rinno-vamento affidata a Giulio Romano dall’abate Gregorio Cortese113: un rinnovamento nel rispetto della tradizione, frutto di un rapporto con il passato che è nel contempo filologico rispetto e scatenata innova-zione. I benedettini, avendo chiesto espressamente licenza a Paolo III di non distruggere la chiesa gotica, commissionano infatti l’impresa a un artista la cui maniera veniva indicata proprio in quel preciso momento come «anticamente moderna, e modernamente antica», nella celebre definizione usata dall’Aretino nella lettera a Giulio stes-so del 1542, ripresa dal Doni a proposito degli abiti delle figure della Sala dei Cento Giorni affrescata da Vasari nel ’47 e dal Vasari stesso riportata programmaticamente nella biografia del Pippi114. Non fosse che per questa enunciazione di uno dei principii che stanno alla base
112 P. Simoncelli, Pietro Bembo e l’evangelismo italiano, in «Critica storica», XV, 1978, 1, pp. 1-63.
113 Sulle committenze del Cortese cfr. almeno E. Menegazzo, Marginalia su Raffaello, il Correggio e la congregazione benedettino-cassinese, in «Italia medievale e umanistica», III, 1960, pp. 329-340; G. Fragnito, Il cardinale Gregorio Cortese (1483?-1548) nella crisi religiosa del Cinquecento, in «Benedictina», XXX, 1983, pp. 127-171, 417-459 e XXXI, 1984, pp. 79-134, 146-147; Dal Correggio a Giulio Romano: la committenza di Gregorio Cortese, catalogo della mostra (San Benedetto Po, Abbazia di Polirone, 11 giugno-30 ottobre 1989, a cura di P. Piva, E. Del Canto, Mantova, Casa del Mantegna 1989; G. Romano, Correggio in Mantua and San Benedetto Po, in Dosso’s Fate: Painting and Court Culture in Renaissance Italy, ed. by L. Ciammitti, S.F. Ostrow, S. Settis, Los Angeles, Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities 1998 (Issues and Debates, 5), pp. 15-40; vd. anche M. Zaggia, Tra Mantova e la Sicilia nel Cinquecento. II La congregazione bene-dettina cassinese nel Cinquecento, Firenze, Olschki 2003 (Biblioteca Mantovana), pp. 484-494.
114 Cfr. Agosti, Qualche nota su Paolo Giovio cit., p. 60, nota 17.
190 Silvia Ginzburg
del sistema storiografico e critico delle Vite, quella biografia occupa un posto di particolare importanza nell’economia del volume torren-tiniano115, attestato anche dall’affermazione stupefacente, e del tutto trascurata dagli studi, destinata significativamente a sparire nell’edi-zione del ’68, che Vasari riserva a Giulio:
E ben posso io sicuramente dire che in questo volume non sia egli secondo a nessuno116
È un elogio che appare sconcertante per come in quel contesto im-plica una messa in ombra del primato michelangiolesco, e che per questo mi sembra da intendersi come un indizio molto forte del fatto che la biografia di Giulio Romano deve essere stata concepita, se non scritta per intero, molto presto, proprio all’indomani di quella gita mantovana del Vasari (come indica tutto l’incipit, entusiasta, poi ca-duto nella Giuntina), quando Borghini stava a San Benedetto in Po-lirone, dove le riflessioni sull’anticamente moderno e modernamente antico dovevano essere all’ordine del giorno – e quando, come sem-bra doversi evincere, il ruolo primario di Michelangelo nell’architet-tura complessiva del progetto del volume non doveva essere ancora dominante. In seguito il primato del Buonarroti incarna ormai a tal punto l’essenza costitutiva dell’intera opera vasariana che si fatica a riconoscere tracce di altri, più antichi impianti, come appunto mi sembra da intendersi quel giudizio su Giulio, che segnala nella genesi della Torrentiniana la presenza di una stagione polironese, risalente all’inizio degli anni Quaranta, dalla quale dovette trarre nuova forza quell’idea di combinazione dell’antico e del moderno che, prendendo spunto proprio dall’esempio di Giulio Romano, era divenuto uno dei temi cari alla cultura che chiamiamo manierista e che appare indubi-tabilmente come una delle idee fondanti del pensiero di Vasari.
Come è stato rilevato dalle ricerche sull’architettura del Cinque-cento e sul caso delle committenze di Giulio Romano, la convinzione che sia possibile e necessario preservare le testimonianze del passato senza rinunciare all’obiettivo primario dell’innovare era particolar-mente diffusa negli ambienti benedettini, dominati dalla «volontà di dar segno di rinnovamento nella conservazione». Come è stato osserva-to, oltre che a Giulio Romano,
115 Cfr. G. Agosti, Qualcosa su e di e intorno a Giulio Romano, in Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro, in «Prospettiva», 91-92, 1998, I, pp. 171-185: 181.
116 Vasari, Le Vite cit., V, p. 55.
191 Filologia e storia dell’arte
il gusto della mescolanza sembra essere appartenuto – per ragioni program-matiche, prima che artistiche – anche ai benedettini. Come giustificare al-trimenti l’ardito accostamento di forme goticizzanti, arcaiche e all’antica, imposto all’architettura117?
Non sembra improprio supporre che l’esempio di questa miscela tra devoto, filologico rispetto e radicale innovazione, di questo amore per la mescolanza dei generi e per l’ampliamento della gamma dei riferimenti stilistici del passato, che accomuna la ricerca di Giulio Romano architetto e i desideri dei suoi committenti118, abbia contato molto per Borghini, che di simili aperture darà prove numerosissime nei suoi studi, e parallelamente per la definizione di uno dei presup-posti delle Vite vasariane: l’intento di tenere insieme nel presente tanti passati linguisticamente – stilisticamente – diversi, dai più noti ed amati ai più ostici e difficili da digerire, il linguaggio colto e il linguaggio basso, il classico e il gotico. Del resto, dell’incontro, che a San Benedetto in Polirone senz’altro vi fu, e dovette essere folgoran-te, tra Borghini e Giulio Romano, e di quello più noto e certo non meno cruciale fra Giulio e Vasari a Mantova119, parlano vari indizi:
117 Le citazioni sono da M. Tafuri, Osservazioni sulla chiesa di San Benedetto in Polirone, in «Quaderni di Palazzo Te», V, 1986, p. 22. Vd. anche M. A. Winckelmes, Form and Reform: Illuminated Cassinese reform-style Churches in Renaissance Italy, in «Annali di architettura», VIII, 1996, pp. 61-84, secondo cui «the method by which Cassinese monks devised their style of church architecture and decoration demon-strated an unusual level of historical self-consciousness» (p. 61).
118 Si pensi ai casi simili di chiese gotiche da rinnovare senza distruggere che vengono sottoposti a Giulio Romano da membri della stessa cerchia del Cortese: il duomo di Verona dal Giberti (sul quale cfr. A. Prosperi, Tra evangelismo e controri-forma. G.M. Giberti (1495-1543), Roma, Edizioni di storia e letteratura 1969, e ora G. Conforti, Gian Matteo Giberti, Giulio Romano e il Duomo di Verona: arte, evan-gelismo e riforma nel Cinquecento, in «Studi storici Luigi Simeoni», LII, 2002, pp. 85-100) o San Petronio a Bologna dal cardinal Morone, che da giovane era stato allievo di Bartolomeo Marliani, il quale lo ricorda con somma lode nella prefazione all’edizione del 1538 dell’Antiquae Romae topographia, libri septem già pubblicata a Roma presso il Blado nel 1534, espressione tra le più precoci degli intenti che ani-mavano la cerchia dell’Accademia della Virtù.
119 A. Conti, Osservazioni e appunti sulla ‘vita’ di Leonardo di Giorgio Vasari, in Kunst des Cinquecento in der Toskana, München, Bruckmann 1992, pp. 26-36: 32, ipotizzava che Vasari potesse essere stato a San Benedetto in Polirone già nel 1541.
192 Silvia Ginzburg
per esempio il fatto che ancora molti anni dopo, nel 1565, quando vengono chiamati a restaurare la Badia di Arezzo, Borghini e Vasari riutilizzino la serliana adottata dal Pippi proprio in San Benedetto Po – una citazione emblematica per il rapporto tra modello antico e restauratio moderna in architettura120.
È dunque forse necessario ipotizzare che, nella storia delle Vite, l’obiettivo di presentarsi come lo strumento principale della fortuna di Michelangelo sia subentrato in corso d’opera – in seguito all’attac-co dell’Aretino al Giudizio e al soggiorno romano di Tiziano. Dobbia-mo immaginare il mondo nel 1541-’42, alla vigilia dello scoppio della fortuna post-Giudizio di Michelangelo, prima cioè che si imponga in funzione antiveneziana l’identità critica del Michelangelo del Giu-dizio campione del disegno contro il colore, ma prima anche che si affermi definitivamente la fisionomia di Michelangelo eroe della scul-tura contro la pittura, e che il dibattito sul paragone divenga uno stru-mento di affermazione di Firenze contro Padova e contro Venezia. Di questo momento più antico testimoniano con particolare eloquenza quelle voci di fortuna veneziana di Michelangelo nei primi anni Qua-ranta, tra cui spiccano per l’insistenza sul primato del Buonarroti in tutte e tre le arti e per l’elogio di lui moderno che supera gli antichi, in piena sintonia con il Doni, i casi meno famosi della dedica del Tra-mezino a Michelangelo della Roma Trionfante del Biondo121 e quello, di qualche anno precedente, della menzione michelangiolesca nel-la Lettera in difesa della lingua volgare di Alessandro Citolini122. Sono voci che si collocano al di qua della spaccatura della metà degli anni Quaranta, che si compirà dopo le accuse dell’Aretino al Giudizio e che sposterà le opinioni del Dolce: e se il caso del Tramezino, editore veneziano che, a una data che è già un apice della fortuna di Tiziano, celebra il Michelangelo pittore per il suo primato nel disegno e nel colore, può essere implicitamente spiegato attraverso i rapporti suoi con Donato Giannotti e della cerchia michelangiolesca romana con
120 Satkowsy, Giorgio Vasari Architect and Courtier cit., p. 90.121 La testimonianza, importantissima e ingiustamente trascurata, è nella Roma
trionfante di Biondo da Forli, tradotta pur hor per Lucio Fauno di Latino in nuoua lingua volgare, Venetia per Michele Tramezino 1544.
122 Lettera di M. Alessandro Citolini in difesa della lingua volgare, scritta al Magnifico M. Cosmo Pallavicino, Venetia per Francesco Marcolino 1540, nella quale è il cele-bre e bell’auspicio «io voglio starmi ne la Toscana, non come in una prigione, ma come in una bella, e’ spatiosa piazza dove tutti i nobili spiriti d’Italia si riducono».
193 Filologia e storia dell’arte
Venezia, Priscianese in testa123, il libro del Citolini, in cui si elogia il Buonarroti per scalpello e pennello come prova della grandezza dei moderni124 si lega più espressamente alla difesa del volgare di Bembo, ricordato assieme al Molza, secondo il modello diffuso dalla «dottissi-ma Accademia de gl’Infiammati in Padova».
Il celebre spostamento di posizioni dell’Aretino, che ancora nel ’40 è destinatario della dedica del Marcolino della Lettera del Citolini (ed è questo l’Aretino che Vasari trova a Venezia di lì a poco), metterà in ombra dopo la metà del decennio questo primo elogio ‘italiano’, ‘moderno’ e ‘volgare’ di Michelangelo, per farlo diventare soprattutto ‘fiorentino’. Ma di quella diversa, più antica fortuna, legata al picco di diffusione del modello di Bembo che si registra tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta, bisogna tenere conto nello studio della genesi delle Vite vasariane. Nella Torrentiniana si conserva infatti il fossile di que-ste idee originarie: farne cominciare la storia nelle stanze del cardinal Farnese nel 1546-1547 non solo non basta a spiegare l’origine di un libro concepito dieci anni prima della sua pubblicazione, ma peggio è deviante, perché sposa una sola delle anime contenute in quell’opera. L’altra, rimasta nascosta, è quella della fortuna non solo fiorentina, e non solo del disegno, di Michelangelo, che verrà spazzata via dall’arrivo di Tiziano a Roma, con le conseguenti prese di posizione dell’Aretino e il mutamento di gerarchie che ciò impone. Lo schiacciamento di Mi-chelangelo su posizioni di primato del toscano è successivo al 1545: ed è un passaggio di cui le Vite sono naturalmente l’espressione più mani-festa. Ma per spiegare come nacque quel progetto non basta quello che divenne; bisogna anche cercare di misurare – per sottrazione, magari – quello che doveva esserci in principio e poi non si volle più: un’idea del volgare ispirata profondamente al Bembo, nata dai dialoghi tra l’acca-demia senese degli Intronati, l’accademia padovana degli Infiammati, l’accademia fiorentina degli Umidi, e presto sopraffatta a Firenze dal-l’imporsi dei nuovi obiettivi filomedicei e antibembeschi degli Aramei.
123 Nel 1540 Tramezino è in rapporto con Giannotti e Vettori (Giannotti, Lettere a Pietro Vettori cit., p. 92, lettera del 26 febbraio 1540).
124 «Ma vedete per vostra fe; s’egli è da dire, che una cosa sia più nobile che un’altra, per esser più antica; che, se questo fusse, seguirebbe, che certe figure total-mente prive d’ogn’arte, d’ogni giudizio, & d’ogni proporzione; che tutto ’l di quà, e là si veggono e’ scolpite, e’ dipinte; per esser state già gran tempo fatte; fusser da preporre a’ i miracoli; ch’oggi dì escono da lo scalpello, e’ da ’l pennello del gran Michiel’Agnolo» (Lettera di M. Alessandro Citolini cit.).
194 Silvia Ginzburg
Se si considera che l’elogio sperticato di Vasari a Giulio rimasto nel-le pagine della Torrentiniana potrebbe risalire appunto all’apertura degli anni Quaranta, e che proprio allora il Serlio nelle sue Regole generali di architettura, date alle stampe con il dichiarato compito di celebrare l’architetto di Palazzo Te, non può esimersi, nella dedica a Alfonso d’Avalos, dal ribadire il primato indiscusso (e indiscutibile in area filoimperiale) di Tiziano «esempio, padre, et padrone de la pittura a tempi nostri», si comprende meglio quale dovesse essere a quelle date il significato e l’audacia di quella lode a Giulio Romano: affidare a lui il compito di contrastare per quanto possibile il primato tizianesco (o perlomeno di dialogare con esso).
Fu un onere che gli venne presto sottratto: con la presentazione del Giudizio, con tutto quello che comportò, il testimone doveva passare al solo Michelangelo. Molto presto, dunque, l’asse portante della Tor-rentiniana dovette mutare radicalmente d’angolazione, e solo qualche traccia di una trama precedente resta a dirci dell’esistenza di un bre-vissimo momento, tra il ’41 e il ’42 evidentemente, in cui si era potuto immaginare di contrapporre a Tiziano non Michelangelo, come sarà di lì a breve, ma Giulio Romano.
Erano allora, del resto, mondi molto più comunicanti di quanto spesso oggi a molti non paiano: nello stesso brevissimo passaggio a Mantova, Vasari fa in tempo a vedere i lacerti del cartone della Battaglia di Cascina «i quali con riverenza grande son tenuti» in casa di Uberto Strozzi125, che è appunto uno dei ponti tra Michelangelo e Giulio, tra Mantova e Roma, trattandosi plausibilmente del «magnificum dominum Rober-tum Strozzam, patricium Mantuae» che nel 1543 il Pippi nomina a Mantova suo procuratore per eventuali cause da trattare a Roma126, ove accoglieva l’accademia dei Vignaiuoli, frequentata da alcuni degli uo-mini che assistettero al dialogo in Palazzo Farnese da cui siamo partiti: il Molza, il Tolomei, il Caro, Gandolfo Porrino, Monsignor Della Casa, Francesco Berni, Giovanni Mauro.
125 Vasari, Le Vite cit., VI, p. 25, sul cartone «in molti pezzi diviso, talché in molti luoghi se n’è sparto, come ne fanno fede alcuni pezzi che si veggono ancora in Mantova in casa di M[esser] Uberto Strozzi gentiluomo mantovano, i quali con rive-renza grande son tenuti. E certo che a vedere e’ sono più tosto cosa divina che umana».
126 Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie, a cura di D. Ferrari, Roma 1992 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, 14), II, p. 1012; Rebecchini, Private collectors cit.
195 Filologia e storia dell’arte
12. Il soggiorno di Borghini a San Benedetto Po e più in generale la sua partecipazione all’ordine benedettino, che è l’aspetto della sua multiforme attività fino ad oggi meno indagato dagli studi127, è anche per altre ragioni un elemento da non trascurare nell’indagine sugli inizi delle Vite.
Nel 1542 Giulio Romano riceve dal priore dell’abbazia di San Be-nedetto Po (facente le veci di Gregorio Cortese, allora assente) un aumento del compenso previsto per i suoi incarichi perché quello già pattuito per lui,
homo expertissimo et probantissimo in architectura, pictura et designamenti per tali consimili effecti […] ali prefati reverendi patri domino abbate, priore et superiori he parso esser non bastante alla sufficientia de li meriti suoi128.
Come ho potuto appurare, il priore «don Zoan Benedetto da Man-tova» va identificato con Giovanni Benedetto Volpi, del quale sono attestati gli stretti rapporti con Borghini e con Vasari. Ricordato con grande affetto da Borghini in una lettera del 1546, fu abate di Santa Fiora e Lucilla ad Arezzo dal 1545 al 1548 e per il refettorio dell’ab-bazia commissionò a Vasari (che di lui scrive: «dilettandosi infinita-mente delle cose di pittura ed essendo molto mio amico») la tavola gigantesca con Le nozze di Ester e Assuero eseguita nel 1549129. Come
127 Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione cit., p. xix.128 Il documento del 31 maggio 1542 è in P. Piva, G. Pavesi, Giulio Romano e la
chiesa abbaziale di Polirone: documenti e proposte filologiche, in Studi su Giulio Romano. Omaggio all’artista nel 450° della venuta a Mantova (1524-1974), San Benedetto Po, Accademia Polironiana 1975 (Biblioteca Polironiana di fonti e studi, 2), pp. 53-97: 89; Id., L’arte a Polirone: regesto cronologico-documentario (con documenti inediti), in I secoli di Polirone. Committenza e produzione artistica di un monastero benedettino, catalogo della mostra (San Benedetto Po, Museo Civico Polironiano, 12 aprile-30 giugno 1981), a cura di P. Piva, San Benedetto Po 1981, p. 39.
129 Matricola monachorum congregationis casinensis ordinis S. Benedicti compilata dal P. D. Arcangelo Bossi da Modena (†1811) ed edita a cura di L. Novelli, G. Spinelli, I, 1409-1699, Cesena 1983 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica a cura del Centro Storico Benedettino Italiano, 3), p. 136; la menzione del Borghini è nella lettera a Teofilo Benintendi del 13 gennaio 1546 («Ioannem Benedictum praesulem tuum, optimum atque humanissimum patrem, et quem ego ob egregias animi virtutes et admiror et amo», Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., p.
196 Silvia Ginzburg
si evince dalla lettera di Borghini a Vasari del 10 settembre 1549, in questo immenso dipinto il pittore incluse i ritratti del Borghini e dello stesso Volpi130, con il quale aveva concordato il soggetto da trattare131.
218); per il rapporto con Vasari cfr. Vasari, Le Vite cit., VI, p. 392. Sul dipinto oggi nel Museo statale d’arte medievale e moderna di Arezzo cfr. Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti cit., cat. n. 21, pp. 338-339 con bibliografia; A. Baroni, in Dal Rosso a Santi di Tito. La maniera moderna nell’Aretino. Guida alle opere, a cura di S. Casciu, Venezia 1994, n. 39, pp. 65-67. All’identificazione del Volpi a Mantova e al passo del Calzolai a lui relativo, da me segnalati nel contributo al convegno che qui si presenta, è giunta per vie che mi dice indipendenti E. Carrara, «Qui non si è mangiato altro che pane et messer Giorgio». Un probabile ritratto giovanile di Vincenzio Borghini di mano del Vasari, in «Iconographica», V, 2006, pp. 106-117, che registra la presenza del ritratto di Borghini nelle Nozze di Ester e Assuero cui allude in modo trasparente il Borghini medesimo nella lettera a Vasari del 10 set-tembre 1549 (il nesso non viene individuato nelle note alla lettera in Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., p. 291, dove pure non è sciolto il riferimento al «padre don Benedetto»).
130 Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., p. 291 e ora Carrara, «Qui non si è man-giato cit. La visita ad Arezzo del cardinale Georges d’Armagnac, di cui riferisce il Borghini nella lettera citata, è un ulteriore indizio dei rapporti di Borghini con gli ambienti già dell’Accademia della Virtù: presso l’Armagnac si trovava infatti fin dal 1539 il Philander, di cui è nota la partecipazione a quella cerchia, nell’ambito della quale nel 1541 terminava le sue annotazioni su Vitruvio, date alle stampe nel 1544 (Philandri Castilionii Galli civis Ro. in decem libros M. Vitruvii Pollionis de Architectura Annotationes, Romae 1544) e di cui una lettera di Giannotti attesta nel 1540 il legame con il Vettori (lettera al Vettori del 4 dicembre 1540, in Giannotti, Lettere a Pietro Vettori cit.: «Io ho letto le due prefattioni, holle fatte leggere a Filandro, persona molto dotta, et amico vostro; et è quel gentil’huo-mo, che sta col cardinale Armagnac»). Sul Philander cfr. M. Daly Davis, Notes to Guillaume Philander’s Annotationes to Vitruvius, in Gedenkschrift für Richard Harprath, Hrsg. W. Liebenwein, München, Deutscher Kunstverlag 1998, pp. 93-103; Les Annotations de Guillaume Philandrier sur le De Architectura de Vitruve : livres I à IV, introd., trad. et comm. par F. Lemerle, Fac-similé de l’éd. de 1552, Paris, Picard 2000.
131 Nella sistemazione originaria un Cristo dipinto sul muro, oggi distrutto, recava una corona di fiori sul capo di Ester. Secondo la spiegazione fornita dallo stesso Vasari nel 1568 il Cristo sul muro «vi fu posto per accennare il concetto spirituale della istoria: per la quale si denotava che, ripudiata l’antica Sinagoga,
197 Filologia e storia dell’arte
Il Volpi si trova citato con grande ammirazione da Pietro Calzolai, benedettino fiorentino trasferitosi a Padova, nella sua Historia mona-stica, che mette in scena un dialogo tra monaci benedettini e gen-tiluomini fiorentini e padovani nel monastero di Santa Giustina132. Questo ambiente di benedettini tra Firenze e Padova presentato dal Calzolai è per più ragioni familiare al Borghini133: uno dei protago-nisti del dialogo messo in scena nell’Historia monastica, Teofilo Be-nintendi, per il quale il Calzolai ha molti elogi, era forse parente del
Cristo sposava la nuova chiesa dei suoi fedeli cristiani» (Vasari, Le Vite cit., VI, p. 393). Meriterebbe forse di verificare con ricerche più approfondite di quelle com-piute qui se questo soggetto apparentemente ortodosso non potesse camuffare un altro significato: se cioè con quell’audace soluzione spaziale non si volesse alludere al matrimonio tra Cristo e l’anima peccatrice, «fondamento della dottrina della giustificazione gratuita per i meriti di Cristo» e tema centrale del Beneficio di Cristo, un testo concepito, scritto e diffuso nei centri benedettini frequentati dal Volpi alle stesse date (cfr. da ultimo A. Prosperi, L’eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta, Milano, Feltrinelli 2000, passim e soprattutto pp. 51-55, da cui è tratta anche la citazione, p. 51).
132 Historia monastica di D. Pietro Calzolai da Buggiano di Toscana, monaco della Badia di Firenze, della congregatione di Monte Cassino, distinta in cinque giornate…, Firenze, appresso Lorenzo Torrentino, MDLXI. Il testo è accompagnato da versi di Prospero Martinengo, del quale si ricordano gli elogi tributatigli dal Vettori (ibidem, p. 147), e di Benedetto Varchi e Laura Battiferri degli Ammannati con riferimenti a Silvano Razzi.
133 Così in una lettera del 1566 a Antonio Benivieni a Padova: «Mi farete grazia risalutare a nome mio que’ miei onorati fratelli e padri di S. Justina, e conosco che sono poco cortese a non intrattenere talvolta certa sorta d’amici; ma scusimi lo star sempre affogato in occupazioni fastidiosissime» (Vincenzio Borghini dall’erudizione alla filologia. Una raccolta di testi cit., pp. 153-154). Il destinatario, allievo di Pier Vettori, aveva studiato con Vincenzio e Agnolo Borghini: a lui è indirizzata nel 1567 ancora a Padova, dove era in rapporto con Speroni, Pinelli e Giannotti, la lettera in cui Borghini dichiara di non far parte dell’accademia (sulla quale cfr. R. Scorza, Borghini and the Florentine Academies, in Italian Academies of the six-teenth century, ed. by D.S. Chamber, F. Quiviger, London 1995 [Warburg Institute Colloquia, I], pp. 137-152: 137); più tardi Antonio Benivieni si trova indicato nel testamento di Borghini tra coloro che dovranno occuparsi dei suoi manoscritti (Testamento di Vincenzio Borghini, Firenze 22 giugno 1574, cit. in G. Gaye, Carteggio inedito cit.).
198 Silvia Ginzburg
Borghini134, che lo menziona nel 1540 quale suddiacono della Badia fiorentina135 e gli scrive a più riprese136; ma anche gli altri dialoganti avevano rapporti con lui. Essi sono Ignazio Minerbetti (probabilmen-te parente di Bernadetto vescovo d’Arezzo e qui già ricordato, per il quale altrove il Calzolai ha parole di somma lode137), menzionato da Borghini come «mio amicissimo» in una lettera a Vasari del 1551138; Crisostomo Nicolini, professo nella Badia fiorentina alla fine degli anni Trenta, come Borghini139, e i gentiluomini fiorentini Lorenzo Ri-dolfi, Filippo Salviati, Lorenzo Strozzi, riunitisi per ammirare uno dei chiostri «nuovamente stato adornato di belle, e vaghe pitture»140.
Calzolai «essendo vissuto gran te[m]po con esso lui [Giovan Bene-detto Volpi]»141, ne elogia la profonda cultura:
questo D. Giovanbenedetto, è non solamente d’ingegno vivo, e molto eloquente, & assai esercitato nelle sacre lettere; ma cosi perito anchora nelle
134 La sorella del padre di Vincenzio, Domenico Borghini, aveva sposato in seconde nozze Lorenzo di Niccolò Benintendi (cfr. Andrea del Sarto 1486-1530 cit., p. 128, nota 7). Su Teofilo Benintendi cfr. Historia monastica cit., giornata quarta, pp. 149-150.
135 I Ricordi di Don Vincenzio Borghini cit.136 Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., pp. 127-131, 214-218; Vincenzio Borghini.
Filologia e invenzione cit. p. 37. Teofilo Benintendi è probabilmente da identificarsi anche con il «don Teofilo» citato nel Discorso fatto in Padova per il quale cfr. infra, nota 143. Vd. anche Matricola monachorum congregationis casinensis cit., p. 233.
137 Cfr, nota 143.138 «Et potrà essere che fra pochi dì vi scriva di nuovo per don Ignatio Minerbetti,
mio amicissimo, che viene alla volta di costì et ve lo manderò perché gli mostriate qual cosa, et per lui vi scriverrò» (Il carteggio di Vincenzio Borghini cit., p. 332). Vd. anche Matricola monachorum congregationis casinensis cit., p. 233.
139 Professo nella Badia di Firenze nel 1538, tradusse in volgare Giovanni Crisostomo (cfr. B. Collett, Italian Benedectine Scholars and the Reformation: the Congregation of Santa Giustina, Oxford, Clarendon Press 1985, p. 253 e nota 17). È plausibilmente citato nel Discorso fatto in Padova citato oltre. Vd. anche Matricola monachorum congregationis casinensis cit., pp. 233.
140 Historia monastica cit., p. 6. Sul chiostro di Santa Giustina cfr. M. P. Billanovich, Una miniera di epigrafi e di antichità. Il Chiostro Maggiore di Santa Giustina a Padova, in «Italia medievale e umanistica», XII, 1969, pp. 197-294.
141 Historia monastica cit., giornata seconda, p. 256.
199 Filologia e storia dell’arte
scienze humane, che ha dichiarato in Tolomeo molti passi difficili, e poco intesi insino a’ hoggi da altri, o’ piu tosto da niuno. Lascio stare l’humanità, e gratia, con la quale sa guadagnarsi quasi chiunque gli favella, & il giuditio che ha delle cose antiche, cosi nelle sculture, come nelle pitture, e medaglie. Quanto poi sia magnifico nelle sue cose, ne possono far’ampia fede due tempii, ch’egli (gran parte d’essi) ha piu tosto fatti di nuovo, che restaurati; l’uno è San Benedetto fuori di Mantova, l’altro San Benedetto di Ferrara; per tacere molti altri edificii, da lui in alcuni de’ luoghi, dov’è stato à governo, ridotti non meno utili, e commodi, che belli, e magnifici142
e lo definisce
Gianbenedetto Volpi mantovano n[os]t[r]o Abbate, e grande Istoriografo
in un Discorso fatto in Padova nel 1584 de’ successi, della grandezza e degli huomini illustri di Firenze rimasto dimenticato dagli studi143.
142 Ibidem, giornata seconda, p. 255. Secondo la testimonianza del Calzolai, se Gregorio Cortese non fosse morto, avrebbe fatto venire il Volpi da Arezzo a Roma «co[n] promessa, che dal detto Paolo Terzo, l’havrebbe fatto porre al governo di S. Spirito di Roma, il che si puo credere, che sarebbe stato senza dubbio, essendo di quello Spedale esso Gregorio Cardinal protettore».
143 Discorso fatto in Padova nel 1584 de’ successi, della grandezza e degli huomini illustri di Firenze M.S. di don Pietro Calzolari da’ Buggiano diocesi di Fior[enz]a Monaco di Monte Casino dimorante in Padova (ma nel testo ci si riferisce a Vettori come di anni 81 (c. 34v.), il che porterebbe al 1580). Il manoscritto, non registrato dalla voce del Dizionario Biografico degli Italiani dedicata al Calzolai, oggi in Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Chigi G IV 115, proviene dalla raccolta di Costantino Gaetani (cfr. J. Ruysschaert, Costantino Gaetano O.S.B. chasseur de manuscrits. Coytribution à l’histoire de trois bibliothèques romaines du XVIIe siècle. L’Aniciana, l’Alessandrina et la Chigi, in Mélanges Eugène Tisserant, vol. VII, Bibliothèque Vaticane, 2ème partie, Città del Vaticano 1964 [Studi e Testi, 237], pp. 261-326) ove è indicato come Discorso di successi grandi e huomini illustri della città di Firenze; come altri manoscritti passati al Gaetani, e visti i sicuri nessi tra il Calzolai e il Borghini, era probabilmente già in possesso di quest’ultimo. La sezione dedicata agli «Huomini Ill[ustr]i in Pittura scultura et Archit[ettur]a», si apre con Cimabue seguito da Giotto, Filippo Lippi, Brunelleschi, Donatello, Ghiberti, Michelangelo, Antonio da Sangallo, Bronzino e infine l’Ammannati, naturalmente celebrato nel-l’ambiente padovano frequentato dal Calzolai, con il quale si chiude la trattazione:
200 Silvia Ginzburg
Saranno nate anche dai dialoghi tra Borghini, Vasari, il Volpi e Giulio Romano, alcune delle idee cardine delle Vite: con il Cortese e l’universo benedettino sullo sfondo. San Benedetto in Polirone non è infatti un luogo qualunque in cui trovarsi tra il 1542 e il 1543. Per chi abbia in mente la storia dei tentativi di conciliazione che in quello stesso momento investivano fino a scuoterla alle fondamenta la congregazione benedettino-cassinese, saranno facilmente visibili le coincidenze di date, luoghi, persone che portano la preistoria delle Vite a intrecciarsi con quella complessa vicenda144.
Dei molti contesti trascurati che è opportuno considerare attorno a Vasari questo è senza dubbio il più dimenticato, e uno dei più densi di implicazioni. Nessuno mi pare abbia mai osservato quanti benedettini olivetani camaldolesi si affollano intorno al cantiere delle Vite, nella prima e nella seconda edizione: l’olivetano Miniato Pitti, l’olivetano Gian Matteo Faetani, il camaldolese Silvano Razzi; per non dire del benedettino Borghini. Sono questi i ‘veri’ correttori di Vasari (Giam-bullari, Gelli, Bartoli e Lenzoni sembrando piuttosto i correttori d’ac-cademia, l’intervento ultimo, istituzionale), al punto da esserne stati, come abbiamo visto, spesso considerati anticamente i coautori (e ven-gono in mente i diversi casi di molti autori nascosti dietro i testi usciti dai centri benedettini in questi stessi anni). Ma per misurare il peso che la cultura, i progetti, le attese dei benedettini e degli ‘spirituali’ poterono avere sulla storia delle Vite molto c’è ancora da fare. Atten-dono ancora di essere indagati a fondo anche aspetti già segnalati dagli
«Bart[olo]meo Ammannati fiorisce hoggi in scultura delle cui opere se ne vede qui in Padova, come quel bello Gigante in casa del Dottore Mantova» (c. 56v). Questa sezione sugli artisti consiste per la quasi totalità in una collazione di Landino e di Vasari, citati a margine e nel testo dopo la menzione del Ghiberti: «E p[er]che hà tanto seguito grande in q[ue]sta professione di valenti huomini le vite, et opere de quali insieme a’ quella di Lorenzo di cui si ragiona s’alcuni fossero desiderosi leggerle le vedranno a’ pieno scritte co[n] ogni diligenza da Landino, e Giorgino Aretino, autori.» (c. 55r-v). Nella sezione sugli «Huomini Ill[ustr]i in Musica» si trova un interessantissimo ritratto di Bernadetto Minerbetti, il vescovo di Arezzo in stretti rapporti con Vasari e con Borghini, che evidentemente il Calzolai conosceva bene: «è insonare di liuto tanto ecc[ellen]te ch’ardisco dire no[n] habbia in tutta Italia pari: ne pare solo il suoni ma che ogni corda parli in voce humana; et il med[esi]mo fà d’altri strumenti: oltre à che è perfettissimo musico singulare aritmetico; buono pittore, e finalmente scrive benissimo d’ogni sorte di Lettere» (cc. 52v-53r).
144 Per questi nessi il riferimento è a Prosperi, L’eresia cit.
201 Filologia e storia dell’arte
studi, quali gli scambi del Vettori con l’ambiente degli ‘spirituali’ tra Firenze, Roma e il nord Europa, o i fittissimi, ben noti ma ancora non chiariti rapporti che l’ambiente romano vicino a Michelangelo intrat-tenne con le figure di maggior riferimento per la diffusione di quelle idee, dal Contarini al Pole. Alla ‘schola’ del Pole aderivano del resto alcuni di coloro ai quali spettò di portare avanti ancora fino alla metà del secolo echi dei progetti dell’Accademia della Virtù. Sembra questo il caso della descrizione delle statue antiche presenti nelle raccolte ro-mane redatta da Ulisse Aldrovandi145. Arrestato a Bologna per eresia nel 1549, l’Aldrovandi fu poi liberato grazie all’intervento del legato, il cardinal Del Monte146: ed è a Roma nei mesi che precedono l’elezione di Giulio III che l’Aldrovandi scrive la sua opera, nella quale la dedica e il testo riservano un posto di rilievo al cardinal Pio da Carpi, uno dei punti di riferimento di quelle ultime voci dell’Accademia della Vir-tù147. Anche la descrizione Delle statue antiche può intendersi come un frutto tardivo di quelle idee: oltre che per il rapporto privilegiato con il cardinal Pio da Carpi, per lo spirito che anima il testo e per gli scambi che l’autore ebbe a Bologna con Bocchi e Manzuoli, a Roma con il Cervini, presentatogli dal Del Monte. Della partecipazione di Rodolfo Pio da Carpi alla cerchia del Pole parlano i ritratti della sua collezione, raffiguranti Bembo, Contarini, Cortese, il Pole medesimo148 e la lirica di Marcantonio Flaminio sul suo ninfeo; quanto all’Aldrovandi, di cui si conoscono i rapporti con editori eterodossi, negli atti del processo al cardinal Morone è definito: «Ulixes de Bononia scholaris, alumnus Poli, haereticus»149.
145 Sul testo dell’Aldrovandi, pubblicato a Venezia nel 1556 con Le antichità di Roma di Lucio Mauro, cfr. E. Carrara, La nascita della descrizione antiquaria, in Dell’antiquaria e dei suoi metodi. Atti delle giornate di studio, a cura di E. Vaiani, Pisa, Scuola Normale Superiore 2001 («Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. IV, Quaderno 6, 1998), pp. 31-50.
146 A. Biondi, Ulisse Aldrovandi e l’eresia a Bologna, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», XVII, 1991, pp. 77-89: 79.
147 Daly Davis, Zum Codex Coburgensis cit., p. 189; Ferretti, Tra Bindo Altoviti e Cosimo I cit., p. 458.
148 G. Mancini, Una collezione romana del 1564: i dipinti del cardinale Rodolfo Pio da Carpi, in «Paragone», LIV, 2003, 51, pp. 37-59.
149 M. Firpo, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone, Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1981, I. Il Compendium, p. 204.
202 Silvia Ginzburg
Ancora da chiarire resta la partecipazione dello stesso Borghini alle idee di riforma che attraversano il suo ordine negli anni Quaranta, attestata da alcuni episodi particolarmente significativi150, ai quali si dovrà aggiungere il caso, qui già ricordato, della proposta di Borghini di dedicare il volume a Giulio III. È possibile che dietro quella dedica vi fossero le medesime attese che portarono il movimento riformato-re e tanta parte della congregazione benedettino-cassinese nel 1550 a vedere nel Del Monte il sostituto del Pole151? Quante di queste aspettative e conflitti cela allora la Torrentiniana, venuta alla luce in un contesto tanto diverso da quello in cui fu concepita, scritta, corretta152?
Sono questioni a cui al momento non so dare risposta; ma a chi cerchi la strada per lavorare su questi snodi potranno essere d’aiuto ancora una volta le parole di Dionisotti, il quale indicava
il nesso, che è difficile per noi oggi intendere, ma che pur è indubitabile e stretto in quegli anni, fra l’evangelismo e riformismo italiano da un lato, e la
150 Per i libri di Erasmo e Melantone portati da Borghini a Arezzo nel 1541 cfr. E. Carrara, «Et portai nel fanghotto gl’infrascritti libri…». Libri e letture di Vincenzio Borghini, in «Vivens homo», VII, 1996, pp. 153-179; per i rapporti con il Contarini vd. Folena, Borghini, Vincenzio cit.; vd. anche M. Leuzzi Fubini, Vincenzio Borghini spedalingo degli Innocenti. La nomina, il governo, la bancarotta, in Fra lo “spedale” cit., pp. 37-64, in part. 50.
151 Prosperi, L’eresia cit., pp. 171-190.152 Sui segni della frattura proprio alla metà del secolo cfr. G. Fragnito, Ercole
Gonzaga, Reginald Pole e il monastero di San Benedetto in Polirone. Nuovi documenti su Luciano degli Ottoni e Benedetto Fontanini (1549-1551), in «Benedictina», XXXIV, 1987, pp. 253-271 e il quadro proposto da Prosperi, L’eresia cit. È ancora del Calzolai una testimonianza del clima di severa autocensura che la congregazione benedettino-cassinese si imponeva alla fine degli anni Cinquanta, alla vigilia delle grandi persecuzioni. Dopo aver elogiato le grandi personalità di monaci studiosi che restano ignoti nei conventi e farebbero invece onore all’ordine, Calzolai scrive (ed è un inserto di una certa audacia in un libro pubblicato nel 1561): «E se i padri che governano la religione non fussero così rigidi in non lasciare stampare le opere, che compongono i nostri monaci, vedreste alla giornata uscire di belle, e giuditiose compositioni, degne di uscire in luce, e non istare più nelle tenebre sepolte, Ma tutto fanno i nostri Padri à buon fine, considerando i tempi pericolosi, e pieni di sospetto; ne i quali siamo» (Historia monastica cit., giornata IV, pp. 2-3).
203 Filologia e storia dell’arte
153 Dionisotti, La letteratura italiana nell’età del Concilio di Trento cit., p. 233.
nuova lingua letteraria e volgare dall’altro. I devoti del Contarini e del Polo furono quasi tutti anche devoti del Bembo153.
Silvia Ginzburg






































































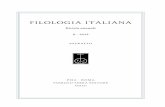




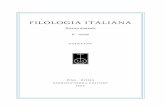




![Filologia dei testi a stampa, Cagliari, CUEC, 2008 [pdf integrale del volume]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324f849c9c7f5721c01d64a/filologia-dei-testi-a-stampa-cagliari-cuec-2008-pdf-integrale-del-volume.jpg)




