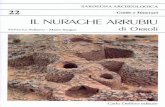Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
-
Upload
accademiadipalermo -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace
e i rapporti con il ponente ligure
Luigi Agus
1. Genesi della Scuola di Stampace
A Cagliari, durante il primo quarto del XVI secolo, si sviluppò quellache è comunemente nota come “Scuola di Stampace”. Tale idea prendespunto soprattutto dall’iscrizione del retablo di Villamar, nella quale il pittorePietro Cavaro si firma, il 25 maggio 1518, con l’appellativo di “pictorum mi-nimus stampacis” (il più piccolo dei pittori di Stampace).
Stampace è uno dei quattro quartieri storici della città di Cagliari. Edifi-cato in epoca pisana alle pendici del Castrum (Castello), fu conquistato dagliaragonesi, a seguito d’una furiosa battaglia capitanata da Raimondo Peraltae Francesco Carróz, nel gennaio del 1326. Nel Cinquecento, come docu-menta l’Arquer, il quartiere era cinto da mura, con la piazza principale situataal posto dell’attuale piazza Yenne, dalla quale si dipartivano le due arterieprincipali, una verso il colle di Castello (via S. Margherita) e un’altra versol’attuale chiesa di S. Michele (via Azuni), su quest’ultima si affacciava lapiazzetta della chiesa parrocchiale di Sant’Anna.
Oltre l’iscrizione di Villamar di Pietro Cavaro, in effetti, molte sono leevidenze documentali che testimoniano come in quel quartiere vivessero pit-tori, scultori e altri artigiani. I pittori tuttavia paiono prevalere in quell’in-tricata rete di rapporti che si sviluppa durante tutto il Cinquecento. Lafamiglia dei Cavaro è certamente predominante, anche se molti altri pintors,loro coevi, sono documentati, non solo a Stampace.
Si tratta in realtà di un fenomeno che, pur studiato dall’Aru, dal Delogue dalla Serra più recentemente, pone tuttora interrogativi soprattutto sullaformazione di quella che potrebbe definirsi una koinè artistica, tuttavia nonsupportata – almeno i documenti tacciono su quell’aspetto – da una corte dicommittenti colti e illustri, tali da giustificare un tale alto livello qualitativo.
Carlo Aru aveva notato come il mondo di questi pittori, ma soprattuttole figure di Pietro e Michele Cavaro, ruotasse attorno al monastero di SanFrancesco, appena fuori le mura di quel quartiere1. In realtà i pittori che làoperarono ricevevano commesse non solo da Cagliari (cattedrale, mona-steri, ecc.), ma anche dal circondario. Mancherebbero dunque precisi ri-scontri, al di là di qualche commessa o della semplice vicinanza delmonastero al quartiere, che porti a credere che quel convento avesse svolto
Luglio / dicembre 2013 315
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 315
un qualche ruolo d’attrazione per gli artisti.I fattori che portarono alla formazione di una comunità di pittori stabili-
tisi in quella porzione di città furono forse altri. Primariamente la maggiorutilità d’essere vicino all’area portuale dalla quale provenivano le materieprime, in secondo luogo perché più comodo sarebbe stato dimorare in unquartiere pianeggiante (anche per questioni logistiche) e in ultima analisiperché gli altri quartieri della città già avevano assunto una determinata vo-cazione: Castello era sede della burocrazia e della nobiltà, la Marina (o LaPola) dei commerci e Villanova degli agricoltori.
Fatte tali premesse occorre comprendere, tuttavia, se la graduale manife-stazione di fatti artistici, soprattutto in campo pittorico, di rilevante entitàche testimoniano percorsi di formazione – per molti artefici e non solo per iCavaro – di livello internazionale, siano stati endogeni, oppure, come pro-spettato nella costante letteratura artistica, importati a seguito della conqui-sta aragonese, quale “arte ufficiale” dei dominatori atta a penetrare nelprofondo intimo della cultura isolana, come ebbe già modo di evidenziare ilPost nel 1958, il quale sottolineò come “the painting of this island duringthe early sixteenth century, as largely still faithful to the modes of the Quat-trocento, as not yet really transmuted by the tendencies of the Reinassance,and as maintaining a considerable dependence upon the school of Catalonia,takes its place properly within the stage in the evolution of Spanish art”2.
Né l’una, né l’altra visione a mio avviso paiono sufficienti, da sole, a giu-stificare un fenomeno come quello della così detta “Scuola di Stampace”,capace di soddisfare non solamente una committenza provinciale, privaquindi di quei mezzi di conoscenza propri dell’umanesimo rinascimentale,ma anche una committenza ricca e molto colta quale era l’élite sarda di queltempo. Ne è un esempio proprio il già citato retablo di Villamar, commis-sionato da don Salvatore Aymerich per la sua villa di Mara Arbarei al com-pimento della maggiore età, proprio in coincidenza col viaggio versoSaragozza, perché il nuovo re, Carlo I, gli riconoscesse i suoi possedimenti,conquistati, più che con la spada, con il danaro3. Nonostante infatti gli in-trighi che coinvolsero don Salvatore, questi era un uomo che, da ricco mer-cante, aveva girato l’Europa e certamente possedeva non solo le ricchezze,ma pure i mezzi culturali per comprendere il valore intrinseco e oggettivoche un’opera d’arte possedeva, ma soprattutto il prestigio personale che neavrebbe potuto trarre. Non è un caso, infatti, che proprio a pochi chilo-metri da Villamar, più precisamente a Tuili, Salvatore e Iolanda di SantaCruz appartenenti alla più antica nobiltà castigliana, circa vent’anni prima,avessero commissionato il retablo per la parrocchiale di S. Pietro del lorovillaggio (fig. 14). Don Salvatore aveva ben compreso la lezione sull’op-portunità che un’opera d’arte prestigiosa avrebbe potuto dare, soprattuttoagli occhi della più antica nobiltà ispanica, a un uomo come lui che inveceapparteneva ad un ceto emergente e che, guarda caso, aveva avuto proprio
Luigi Agus
316 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 316
come tutore lo stesso Salvatore di Santa Cruz nel 15014.Accanto naturalmente a personaggi come Salvatore Aymerich, abbiamo
pure altri committenti come le confraternite, le curie vescovili o i monasteri.Va detto tuttavia che proprio all’interno di quegli enti era penetrato, in ma-niera sempre crescente, il ceto mercantile e della nuova nobiltà a cui appar-teneva lo stesso Aymerich. La ragione dunque per la committenza di grandipale d’altare per le chiese e cappelle cittadine o dei villaggi, pare sia semprela medesima: il riconoscimento di un prestigio sociale che andava conqui-stato passo per passo, anche attraverso la cultura.
Un tale quadro della società sarda, soprattutto del ceto medio alto, si andòdelineando già nel secolo XV quando, tuttavia, non pare si siano sviluppatebotteghe autoctone atte alla realizzazione di retabli come invece avvennenel Cinquecento. È proprio durante il Quattrocento che nell’isola venne in-trodotto il retablo pittorico, non solo nel meridione come sostenne la Serra5,ma indiscriminatamente nell’isola, non quale prodotto atto a soppiantaredefinitivamente l’arte italiana, piuttosto per affiancarvisi, in un ambienteche di per sé non esprimeva una marcata tendenza del gusto. Se è pur vero,infatti, che inviarono nell’isola le loro opere artisti come Pere Serra, JuanMates, Jaime Huguet, Bernat Martorell, Miquel Nadal, Rafael Thomas e JuanFiguera, tutti attivi nei territori peninsulari della Corona d’Aragona6, è al-trettanto vero che si continuò a importare opere pure dal versante italiano,come quelle di Alvaro Pirez, Giovanni da Gaeta, Giovanni Canavesio, Fio-renzo di Lorenzo o perfino dalla bottega di Donatello7.
2. Il “Maestro di Olzai”
L’individuazione della personalità artistica del “Maestro di Olzai” si devea Raffaello Delogu, il quale – per primo – raccolse un corpus di appena dueopere8, ma comunque significative, a cui aggiunse la tavola della Vergine conBambino della Galleria Parmeggiani, che il Post riteneva prova “that theOlzai master was at least partially educated in a region even farther inlandthan the east coast, Aragon, or that, dwelling there, he was influenced bythe Aragonese school”9. Ipotesi poi accantonata in quanto “sumamente pro-blématica y con ella resultaría aún más dificil de explicar la presencia de labanderola con armas de Castilla y León”10, come sottolineò Pérez Sánchez,che invece la assegnò al Maestro di Alfajarín, poi identificato con TomásGiner, visto che la composizione è replica della tavola custodita presso lacollezione Matías Muntadas (oggi al Museo di Barcellona), senza escludere,tuttavia, una provenienza castigliana come farebbero pensare le insegne realipresenti nella pala11. L’analisi di Delogu ruotava attorno all’ancona – già se-gnalata dalla Goddard King12 – conservata a Olzai presso la chiesa di SantaBarbara (fig. 21). Si tratta di un retablo dai toni e dalla qualità assai popola-resca e ingenua chiuso in alto da un timpano a capanna con tre partimenti
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 317
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 317
verticali divisi al centro in due e sui lati in tre casas. All’ancona di Olzai Delogu associò due parti di uno smembrato retablo
proveniente dalla chiesa di S. Maria di Sibiola a Serdiana, confluiti poi allaPinacoteca di Cagliari (fig. 22)13. Ad “analogo ambito e al medesimo livelloculturale” la Serra associò pure una Dormitio Virginis, unico elemento super-stite di un retablo a Selargius, e il retablo Manca di Villahermosa14, recente-mente acquisito dalla Pinacoteca di Cagliari, anche se queste ultime due nonsono comunque riferibili all’anonimo autore della pala di Olzai, quanto piut-tosto ad altro artefice del medesimo ambito culturale.
Il retablo di Olzai – secondo Delogu – sarebbe stato commissionato inoccasione della peste del 1477, anche se la notizia da lui riportata dei sedi-cimila morti a Sassari15 non è relativa a quella epidemia, ma ad un’altra del152916. Una conferma comunque indiretta di tale datazione compresa tra lafine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del Quattrocento sarebberoi rimandi “a modelli valenzani del sesto e del settimo decennio”, come “ilSan Michele che pesa le anime, il Martirio di San Sebastiano e la Madonnadel Latte per i quali si possono trovare precisi riscontri: il San Michele si col-lega, ad esempio, ad analoghe raffigurazioni molto probabilmente derivateda un perduto originale di Jacomart e, tra l’altre, al San Michele dell’anconadella Parrocchiale di Nules (Valencia), eseguito circa il settimo decennio delsecolo da un divulgatore delle maniere del maestro; il Martirio di San Seba-stiano trova riscontro nella composizione con l’analoga scena di un retablodella Collezione Mateu di Barcellona, egualmente dovuto a seguace di Jaco-mart; la Virgen de la leche, così simmetrica e bilanciata nelle sue parti e colcaratteristico dossale estofado, può poi riattaccarsi ad altri esemplari, sempredi seguaci di Jacomart, come, ad esempio, alla Sant’Anna con la Vergine eil Bambino della Collezione Bosch di Barcellona”17. Una via quindi che dauna parte prende spunti nell’area valenzana, secondo Delugu, dall’altra inquella “italianeggiante”18 con precisi spunti fiamminghi19, i cui prototipierano noti forse “unicamente nella versione diffusa da disegni e stampe”20.
Spunti e novità che portarono Delogu ad associare il piccolo corpus aquello di Lorenzo Cavaro, portando in tal modo a individuare le origini dellascuola sarda di Stampace proprio nel Maestro di Olzai, più che per la coin-cidenza di diversi elementi iconografici – desunti per altro anche dal reper-torio del Maestro di Castelsardo – per tutto ciò che concerne il linguaggioespressivo: “plastico e rude il Maestro di Castelsardo quanto è piatto e calli-grafico, almeno in questa sua prima e fino ad oggi unica fase nota, Lorenzo;umano e drammatico il primo quanto ingenuo, devoto e pio il secondo”21.Constatazioni che portarono a ritenere come l’anonimo Maestro di Olzai po-tesse essere identificato – pur dubitativamente – in Antonio Cavaro, forsepadre di Lorenzo, documentato nel 1455 e che da questi discendesse e si svi-luppò successivamente la scuola stampacina22. Tesi – pur non verificabili –ritenute dalla Serra almeno plausibili, anche se non andava trascurata l’ipo-
Luigi Agus
318 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 318
tesi di assegnare pure le ancone di Olzai e Serdiana a Lorenzo Cavaro e allasua bottega23.
Si tratta di ipotesi comunque suggestive e che certamente tengono contodell’aspetto popolaresco e ingenuo che contraddistingue sia l’anonimo diOlzai, sia Lorenzo Cavaro, ma che non prendono in considerazione come ta-luni stilemi da loro usati derivino in maniera chiara e netta da idee e inven-zioni presenti nei retabli di Tuili (fig. 14), del Presepio (fig. 20), dellaPorziuncola (figg. 12, 13), di Castelsardo (figg. 2, 4, 5) e Tallà (fig. 16). IlSan Pietro preso leggermente di scorcio con la chiave sulla spalla destra e illibro nella sinistra presente nel retablo di Olzai (fig. 21), che troviamo anchenel retablo di Santo Stefano di Pablo Vergós (1480-95) presso la chiesa dela Doma (La Garriga)24, deriva chiaramente da quello di Tuili (fig. 14), a suavolta replicato in quello del Presepio (fig. 20) e in quello di Gonnostramatza(fig. 23), firmato da Lorenzo Cavaro e datato 1501. La perete a mattoni pre-sente dietro i Santi Matteo e Antonio Abate del retablo del Giudizio Univer-sale (fig. 22) e il pavimento ad azulejos a scacchi derivano dagli esempi diCastelsardo (predella), del retablo minore di Saccargia (fig. 6), da quellodella Porziuncola e da quello integro di Tallà in Corsica; così come derivanochiaramente da quello di Saccargia le figure oranti incappucciate poste sottola Vergine del Latte di Olzai, mentre derivano dalla Madonna oggi a Birmin-gham (fig. 11) i due angioletti musicanti posti ai lati sempre della Vergine diOlzai. Per finire la figura dell’Imago Pietatis di Olzai con quel sepolcro lilla inprospettiva e l’angelo che regge il Cristo, deriva in prima battuta dagli esempidi Figuera del retablo di San Bernardino – datato 1455 – e della predella di SanLucifero, di poco posteriore, mutuata ed evoluta secondo la lezione del retablodella Porziuncola, ma soprattutto di quello del Presepio (fig. 20). Spunti dun-que eterogenei, ma largamente presenti ed elaborati in loco che portano aritenere come la figura del Maestro di Olzai non possa essere vissuta prece-dentemente a Lorenzo Cavaro, quindi nemmeno all’anonimo Maestro di Ca-stelsardo, ma anzi debba ritenersi un artista di secondo piano che – comealtri faranno nel corso del Cinquecento – imitava per le parrocchie del con-tado con uno stile ingenuo e pio i grandi esempi dei maestri stampacini, oche là vi dimoravano temporaneamente, come potrebbe essere il caso del“Maestro di Castelsardo”.
3. Il “Maestro di Castelsardo” tra Liguria, Corsica e Sardegna
Una prima tendenza all’unitarietà del gusto si ebbe solo allo scorcio delXV secolo, quando operò l’anonimo Maestro di Castelsardo. Fu attorno aquesta figura infatti che andrebbero individuati gli albori della scuola stam-pacina, piuttosto che – come già sottolineato – nel popolaresco Maestro d’Ol-zai, che in parte da lui dipende. Tornerebbe a tutto vantaggio di quest’ultimatesi il nome che si leggerebbe nello scudo dell’arcangelo Michele di Castel-
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 319
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 319
sardo: Gioacchino Cavaro (fig. 4)25. Il fatto che un tale nome non compaianei documenti d’archivio, infatti, non è di per sé discriminante nell’accettareuna tale lettura26, così come non pare ammissibile l’idea che l’epigrafe sia to-talmente priva di significato27. Al di là comunque di tali questioni, resta ilfatto che proprio taluni stilemi presenti in alcuni retabli assegnati a quell’ar-tista, siano pedissequamente ripresi anche da artisti di minor peso e lavaturacome il “Maestro del Presepio”, Lorenzo Cavaro o il “Maestro di Olzai”, segnoche andava formandosi una tendenza del gusto figurativo abbastanza uni-forme, almeno a Cagliari.
La situazione sarda, tuttavia, nella quale si va formando la scuola di Stam-pace a sud e quella sassarese a nord28, risulta eterogenea anche quando appareuna figura predominante qual è l’autore del retablo di Castelsardo (figg. 2, 4)o quello di Tuili (fig. 14)29. Accanto a quell’autore, infatti, altri continuaronoa mantenere il proprio stile peculiare, nonostante la tendenza generale versol’unitarietà del gusto.
Per certi versi la situazione cagliaritana di fine Quattrocento sembra es-sere inversa rispetto a quella barcellonese. Se a Barcellona infatti, fino alterzo quarto del XV secolo, permase una certa tendenza del gusto abbastanzaomogenea – che prevedeva accanto ai particolarismi fiamminghi qualcheapertura verso le novità del rinascimento italiano, e per la quale ebbero unaposizione di rilievo Lluís Dalmau, Jaime Huguet e atri artefici, quasi tuttipassati prima per la Valenza – dall’ultimo quarto del secolo in poi ci fu unatendenza all’eterogeneità, ammettendo la convivenza di artefici distinti pergusto e formazione, come i Vergós, Aine Bru, Pedro Fernández o il Maestrode la Seu d’Urgell-Canapost30. Nell’isola – e a Cagliari in particolare –, alcontrario, si andava delineando una tendenza che, partendo da una situa-zione complessivamente frammentaria e priva di figure di riferimento,avrebbe portato ad un ambiente sostanzialmente omogeneo sul piano delgusto, nel quale, per l’appunto, la Scuola di Stampace ebbe un ruolo chiave.
Il percorso, quindi, per giungere a Pietro Cavaro parte, più che dal Mae-stro d’Olzai, certamente dal Maestro di Castelsardo, passando per quello diSanluri31. Accanto a questi vanno inseriti altri artefici che costituirono ilprincipio della fortuna di quella scuola come Lorenzo Cavaro o il Maestrodel Presepio, ovvero altri ancora come il Maestro della pala d’Oliena o quellodi Milis che, pur distaccandosi dalla tendenza dominante, parteciperannopropendendo ancora di più verso un italianismo sempre più marcato.
Un esempio concreto dell’introduzione di un nuovo linguaggio di tipo ri-nascimentale italiano è rappresentato dalla costruzione geometrica di asso-luta e limpida perfezione della Trinità di Castelsardo (fig. 5). Partefondamentale e centrale della composizione è il Cristo Crocifisso che risultainscritto in un quadrato avente per lato l’altezza della figura, al centro delquale si trova il pube. Per ottenere il punto dell’ombelico occorre invecetracciare la semi-diagonale, disegnare una curva avente il suo fulcro nell’an-
Luigi Agus
320 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 320
golo sinistro alto del quadrato e il suo raggio uguale alla metà del suo lato; ot-tenuto tale punto sulla semi-diagonale, puntando il compasso al centro dellato basso del quadrato lo si proietta nell’asse centrale dello stesso. In tal modosi ottiene un punto che divide l’asse centrale in due parti differenti, perfetta-mente proporzionali fra loro, la cui dimensione è determinata dal numero ir-razionale 1,618, meglio noto come numero aureo, divina proporzione o .
Da questo punto, per determinare la curva che compiono le braccia, sidisegna un cerchio il cui raggio – appunto – è il . Nel caso della Trinità diCastelsardo – come si vede – la geometria compositiva è la medesima delnoto disegno di Leonardo dell’uomo vitruviano, che ritroviamo anche inAntonello da Messina32, anche se il nostro artista si spinge ancora più in làcostruendo anche il resto tenendo la stessa base. La colomba dello SpiritoSanto infatti è perfettamente inclusa tra il cerchio e la parte alta del qua-drato, avendo perfino le ali spiegate perfettamente coincidenti con la me-desima circonferenza. Un sistema geometrico – che è possibile proseguireper ottenere ogni minimo dettaglio – che testimonia oltre ogni ragionevoledubbio le sue avanzate conoscenze umanistiche sviluppate certamente acontatto con i più elevati ambienti culturali italiani come quello urbinate,riminese o veneto.
Proprio all’ambiente veneto, già fortemente influenzato da Antonello,rinvia l’Imago Pietatis della predella del retablo della Porziuncola. La straordi-naria immagine è studiata per sottolineare l’intimità tra il volto del Cristodefunto e quello dell’angelo piangente che lo regge seduto sul sepolcro se-condo uno schema, che pur nettamente lineare, tende a divenire pittorico,attraverso l’adozione di uno schema aperto, nel quale le due figure dialoganotra loro, divenendo interdipendenti33. Una citazione diretta della scenogra-fica e pietosa immagine belliniana di Brera così attentamente studiata daBelting34, rielaborata poi anche in area piemontese da Macrino d’Alba nel1499 per un polittico destinato alla chiesa abbaziale di Lucedio35. Il prototipodi questo tipo di raffigurazione è infatti l’Imago Pietatis di Santa Croce in Ge-rusalemme a Roma, ritenuta acheropita, ma in realtà del XIII secolo, che ri-prende quella sindonica. Durante il Quattrocento tale immagine vieneripresa sia in maniera identica, sia con talune modifiche come quella intro-dotta da Donatello nel rilievo della basilica del Santo di Padova, dove si-stema ai lati della figura due angioletti piangenti che reggono una cortinadietro la figura di Cristo. Il tema dei due angioletti viene successivamenterielaborato da Giovanni Bellini nella tavola del Museo Correr dove però an-ziché tendere una cortina reggono lo stesso Salvatore, il quale viene assu-mendo – in tal modo – un peso gravitazionale preciso. Tuttavia la svolta sicompie con la trattazione dello stesso tema iconografico da parte di Anto-nello da Messina nelle versioni del Museo Correr di Venezia e del Prado diMadrid dove la corporeità del Salvatore è resa ormai in maniera esplicitacon l’abbandono della ripresa frontale e l’adozione di una visione di scorcio
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 321
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 321
attraverso la quale si pone ancor più in evidenza il peso del corpo morto,retto da uno o più angeli piangenti che sollecitano – come nel caso della pre-fica della Deposizione di Donatello di Padova – la pietà del fedele che guardala composizione e si trova, così, a partecipare al dramma rappresentato. Laraffigurazione cagliaritana deriva con tutta evidenza da quest’ultima edestrema evoluzione passando attraverso alcune elaborazioni belliniane comeil disegno custodito oggi alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Anche se– in Sardegna – l’Imago Pietatis era stata già elaborata con l’aggiunta di unangelo che sembra reggere il Cristo nella predella del retablo di San Bernardino(Cagliari, Pinacoteca), opera di Juan Figuera e Rafael Tomás, e nella predelladi San Lucifero (Cagliari, Pinacoteca), assegnata allo stesso Figuera, mai siera vista una tale intensa interpretazione di stampo marcatamente antonel-lesco dove viene abbandonata completamente la rigidità gotica frontale –citazione esplicita dell’immagine acheropita romana – per rielaborare il Cri-sto di scorcio squisitamente rinascimentale. Una novità che non passò certoinosservata, se nel 1515 Giovanni Muru decise di riprendere con esattezzala posizione del Salvatore defunto, pur eliminando l’angelo, fulcro dell’in-tenso pathos dell’opera cagliaritana, nella predella del retablo di Ardara.
L’influsso dell’autore delle ancone di Tuili, di Castelsardo e della Por-ziuncola ebbe un riverbero in molti degli autori locali dell’epoca, dando intal modo origine a una vera e propria uniformità del gusto in senso marcata-mente classicista. Dimostrazione di ciò è l’invenzione del San Pietro di Tuiliripreso di scorcio con una grande chiave sulla spalla destra (fig. 14), un librosulla sinistra e con sullo sfondo una balaustra a losanghe ripresa da quelladello studiolo di Federico da Montefeltro di Urbino – disegnato da Botticellie Baccio Pontelli36 – che viene puntualmente ripreso nel retablo del Presepio(fig. 20) e in quello di Gonnostramatza di Lorenzo Cavaro, datato 1501 (fig.23). Un’influenza che non si fermò solo ai minori, ma che coinvolse ancheartisti di sicuro talento come il Maestro di Sanluri e Pietro Cavaro. Perquest’ultimo basta un confronto tra l’Arcangelo Michele di Tuili, quello diVillamar e quello del Trittico della Consolazione per rendersi conto dell’im-portanza che ebbe la scuola del Maestro di Castelsardo nell’isola.
Se non vi possono essere dunque dubbi sulla straordinaria importanza diquesto artista nel panorama sardo e non solo, permangono circa il suo per-corso formativo, che alcuni hanno individuato accanto a Huguet, ai Vergósin Catalogna o addirittura a Torner nelle Baleari37, mentre io ho proposto diindividuarlo accanto a Pedro Berruguete con un passaggio alla corte urbinatenegli anni Settanta38. Un passaggio quest’ultimo che sembrerebbe testimo-niato dalle riprese pierfrancescane – come le candelabre di Castelsardo (fig.2) –, dalla soluzione dei paesaggi che sembrano citazioni chiare e inequivo-cabili di Giovanni Santi, dalla straordinaria pacatezza che elabora nella co-struzione volumetrica delle figure – come l’Arcangelo di Castelsardo (fig. 4),che sembra replicare la Giuditta e Oloferne di Donatello – alle quali riesce a
Luigi Agus
322 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 322
imprimere quella “serenità della vita” e “quella liberatrice bellezza che gu-stiamo con un benessere generale ed un accrescimento della nostra forza vi-tale”39 e infine per la tecnica di stendere progressivi veli di grigio, riscontratanel retablo di Tuili, derivata da Botticelli40.
Nonostante tutto sembrerebbe portare a ipotizzare una sua formazione inun ambiente ricompreso tra Marche e Veneto, si potrebbe formulare un’altraipotesi che concilierebbe anche le citazioni fiamminghe e catalane fin troppoevidenti, ma che non paiono sufficienti, da sole, a convalidare definitiva-mente l’ipotesi che il Maestro di Castelsardo possa essere uscito dalla bottegadi Huguet, avendo una prossimità con Pau Vergós.
Un ambiente dove nel Quattrocento giungevano istanze venete (e quindianche emiliane e marchigiane) sia filtrate attraverso la Lombardia, sia dirette– com’è il caso del pittore pugliese Tuccio d’Andria che riprende chiaramenteCrivelli – era quello del ponente ligure, da Genova a Savona, dove operòper qualche tempo Vincenzo Foppa, accanto ad autori come Ludovico Breae successivamente ad altri come Donato de’ Bardi41 e dove non mancavanomarcati accenti fiamminghi e suggestioni lombarde fin nell’estrema LiguriaOccidentale grazie all’apporto di Francesco Grasso da Verzate o da Pavia42.Già prima infatti – proprio in quell’area – sono documentati pittori comeAgostino da Messina, attivo a Genova tra il 1400 e il 1401, il sardo PietroPericone, attivo a Savona nel 1433, il napoletano Tommaso Bugo, documen-tato a Genova nel 1444 e il fiammingo Alessandro di Bruges, che attesta“quasi un diritto di primogenitura della Liguria nel rapporto che si svilupperànei decenni successivi tra l’Italia e le Fiandre con episodi di grande rile-vanza”43. Non è un caso infatti che ben due dipinti furono commissionati avan Eyck da cittadini genovesi tra il 1430 e il 1441. Tra le due opere l’altarolocon la Madonna in trono tra i Santi Michele e Caterina, eseguito nel 1437 perMichele Giustiniani (oggi a Dresda, Gemäldegalerie), rimase documentata-mente a Genova fino almeno alla fine del secolo, servendo da modello – tral’altro – ad Antonio da Fabriano (ora identificato in Antonello da Fabriano),per il San Girolamo nello studio della Walters Art Gallery di Baltimora, datato145144, quando il pittore marchigiano risulta attivo a Genova45. La Liguriaera infatti una regione di confine dove giungevano pure istanze provenzali,toscane e catalane riprese – fra l’altro – anche da Giovanni Canavesio, ilquale risulta impegnato a inviare una pala d’altare a Oristano nel 147246.
Una conferma in tal senso giunge dal confronto tra la Crocifissione di Tallà(fig. 16) o quella di Castelsardo del nostro con quella di Brea provenientedalla cappella fondata nel 1481 da Biagio de’ Gradi in San Bartolomeo degliArmeni a Multedo, attualmente al Museo di Palazzo Bianco a Genova, col-locabile cronologicamente allo scorcio del nono decennio del secolo47 equella di Gandolfino da Roreto della cattedrale di Alessandria, forse ele-mento superstite di un perduto polittico, collocabile al primo decennio delCinquecento48; oppure dall’ancor più convincente confronto tra la Madonna
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 323
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 323
di Castelsardo (fig. 2) e quella commissionata dal cardinale della Rovere aVincenzo Foppa tra il 1485 e il 1490 per l’antico altare maggiore della cat-tedrale savonese dedicato a Santa Maria di Priamàr, oggi presso l’Oratoriodi Santa Maria di Castello della stessa città (fig. 3)49. Nella pala sarda tuttopare replicare puntualmente la grammatica compositiva ideata dall’artistalombardo a cominciare dalla forma del trono, i tre angioletti musicanti sopralo scranno – dei quali sono ripresi con dovizia di dettagli perfino gli strumentimusicali: buccine ai lati e cornamusa al centro –, quelli laterali – dove ugual-mente sono ripresi gli stessi strumenti musicali nella medesima posizione:viola da braccio a sinistra e liuto a destra50 – e il Bambino Gesù col cardellinonella mano sinistra.
Proprio la dovizia di dettagli nella rappresentazione degli strumenti mu-sicali, tipica del nostro, le prospettive dei troni sempre caratterizzati da pa-raste laterali e i loro dettagli architettonici – a volte classici, come nel casodi Castelsardo (fig. 2) o Tallà, a volte gotici come nel caso della Madonnadel Latte di Barcellona (fig. 15) o in quella di Birmingham (fig. 11) – le par-ticolari fisionomie dei volti, la costruzione volumetrica dei corpi, in particolarmodo quelli di Cristo in croce, rinviano direttamente agli esempi di un Gio-vanni Mazone – in particolare la cosiddetta Madonna dei Greci di Santa Mariadelle Vigne a Genova databile attorno al 1477 o il polittico della Madonna eSanti oggi al John and Johanna Bass Museum of Art di Miami Beach, asse-gnato a un suo seguace e proveniente dal convento francescano di Corbarain Corsica51 –, di un Nicolò Corso – in particolare la Madonna con Bambinoe angeli, già in Collezione Lanz ad Amsterdam52 –, di un “Maestro di San Lo-renzo” o di un Lorenzo Fasolo con vicinanze tanto stringenti e convincentida far propendere addirittura per un apprendistato del nostro presso qualchebottega ligure nel settimo e ottavo decennio del secolo53. Non è un caso – epotrebbe essere proprio questa la conferma definitiva – che la pala custoditapresso di depositi del Museo di Torino, assegnata da Brunelli al Maestro diCastelsardo54, vada invece ricondotta a mio avviso proprio a Nicolò Corsoper assonanze stringenti con la già citata Madonna già ad Amsterdam o conla Visione di San Domenico del convento di Santa Maria di Castello di Ge-nova; o ancora che un’iconografia inconsueta – documentata da GiovanniSpano nel 1861 al centro del retablo della Porziuncola – di “una Madonnacon un santo che le offre un piatto di rose”55, la ritroviamo puntualmente inun’altra tavola datata 1495 oggi presso il Musée du Palais Carnolès a Men-tone, proveniente dalla Collezione Manzi di Parigi56, assegnabile allo strettoambito del nostro, se non direttamente a lui, anche se per le sue dimensionipotrebbe non essere quella cagliaritana documentata dallo Spano (fig. 13).
Un’ulteriore conferma in tal senso possono essere i due retabli realizzatiper Tallà (fig. 16) in Corsica commissionati dal potente conte Rinuccio dellaRocca. Genova infatti dal 1453 passò al Banco di San Giorgio importantipiazzeforti corse come Bonifacio, Calvi e Bastia, mantenendo tuttavia il con-
Luigi Agus
324 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 324
trollo dell’isola, dalla quale giunse nel capoluogo ligure il pittore Nicolò diLombarduccio – meglio noto come Nicolò Corso57 – che sembra avere stra-ordinari punti di contatto col nostro, come già detto, soprattutto confron-tando gli incarnati, i drappeggi e la postura dei quattro santi dell’AccademiaLinguistica di Genova con la Madonna di Birmingham; i Santi Francescanidella predella della Porziuncola, quelli dell’unico retablo rimasto intero aTallà o il così detto Santo Diacono della Pinacoteca di Sassari – provenientedal monastero cittadino di San Pietro in Silki – con il San Vincenzo di Corso(Roma, Palazzo Venezia), proveniente dall’omonimo polittico della chiesadei Domenicani di Taggia, datato 150158.
Tali assonanze stringenti tra il Maestro di Castelsardo col ponente liguree i suoi protagonisti principali, nonché con altri attivi in Corsica nello stessotorno di tempo – che comunque dovette necessariamente conoscere – por-tano anche ad una nuova possibile interpretazione dell’epigrafe di Castel-sardo, laddove quel “IAXI” possa essere letto non già come Gioacchino59,ma come Giacomo. Se così fosse – ma siamo nel mero campo delle ipotesi –potremmo supporre che il nostro possa essere identificato in quel Giacomoda Milano, del quale abbiamo notizie tra il 1490 e il 1491 proprio in Corsica.In particolare due documenti genovesi attestano che Giacomo ricevette unpagamento di 16 lire il 9 aprile 1490 per opere realizzate nella residenza delgovernatore e nel portico di “Terranova” a Bastia e un altro di 6 lire e 3 soldiil 29 novembre 1491 per aver decorato due sale della stessa residenza del Go-vernatore60. Purtroppo di questi dipinti non avanza nulla, mancherebbequindi un termine di confronto certo, anche se attraverso la ricerca d’archi-vio in Liguria, Sardegna e Corsica si potrebbero reperire ulteriori notizie diquel misterioso Giacomo, magari portando a collegarlo con certezza adun’opera esistente.
Le strette assonanze con la pittura del Ponente ligure – non solo di ca-rattere iconografico e formale, ma anche a livello di struttura del polittico,come dimostra quella del Retablo Minore di Saccargia (fig. 6), che trova precisiriscontri in opere di Lodovico Brea del medesimo periodo, come il politticodella chiesa di Saint-Benoit di Bonson, quello della chiesa di San Domenicodi Taggia o quello della chiesa di Sainte-Marie-Madeleine di Coursegoules(fig. 7)61 – potrebbe portare a ritenere che i suoi lavori corsi siano stretta-mente connessi con la circolazione culturale e artistica del Mediterraneo Oc-cidenatale che “seguiva un percorso del tutto autonomo […] toccando i passie le coste, attraverso vie transalpine (Piemonte) o marittime (Liguria, Sicilia,Sardegna, Corsica, in rapporti con il Sud della penisola iberica)”62. Tale con-statazione farebbe propendere per un preventivo passaggio corso – quindi trail 1490 e il 1491 circa –, a cui seguì l’arrivo in Sardegna dell’anonimo mae-stro, dove soggiornò, quasi certamente, a Sassari e poi a Cagliari (o vice-versa), ospite forse di qualche bottega locale che lo coadiuvò completando
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 325
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 325
le sue opere o mettendo in opera le sue idee63. Tesi che non troverebbe tut-tavia un suo possibile appoggio nella prima ipotesi di lettura dell’epigrafepresente nello scomparto della Vergine di uno dei retabli di Tallà, del qualeavanza oggi solo la Crocifissione (fig. 16), che si era ipotizzato poter leggerecome 1492, data nella quale Rinuccio della Rocca – committente del retablo– fondò il convento corso situato a nord di Bonifacio64. Una lettura che, piùrecentemente, è stata confutata da Mereu, il quale invece ipotizza che al-meno una delle due opere – cioè la stessa Crocifissione, unico dei due rite-nuto autografo del maestro – sia stata commissionata dallo stesso Della Roccaattorno al 1504, quando giunse in Sardegna per rimanervi esiliato fino al1507, dopo un breve rientro in Corsica65. Oscillazioni temporali che – in as-senza di riscontri documentali ulteriori – non aiutano certo a costruire unacronologia definitiva, tanto più se si considera che l’unico documento chemenziona un’opera del Maestro, quella di Tuili (fig. 14), costituisce sempli-cemente un ante quaem per la sua realizzazione che potrebbe oscillare tra il1489 (data di ultimazione della parrocchiale)66 e il 4 giugno 1500, quando ilretablo viene regolarmente pagato a Cagliari, davanti al notaio Carnicer,non già al pittore direttamente – probabilmente fuori città – ma al mercanteNicolò Gessa, direttamente dai committenti: i coniugi Giovanni e Iolandadi Santa Cruz67.
Se per i retabli di Tallà e Tuili resta comunque una forbice cronologicaabbastanza ampia pur restringibile (tra il 1492 e il 1507 il primo e tra il 1489e il 1500 il secondo), altrettanto non può dirsi per quello di Castelsardo, at-torno a cui fu costruito il corpus dell’artista. L’individuazione, infatti, dellafamiglia di riferimento dello stemma sullo scudo dell’Arcangelo Michele (fig.4), i Guzmán68, permette ora di individuarne, attraverso la ricerca storica, ilcommittente e un ante quaem abbastanza sicuro per la realizzazione dell’an-cona. L’unico membro della nobile famiglia castigliana presente in zona inquel periodo fu Diego de Guzmán, che ricopriva l’importante incarico di al-cayde della città di Castel Aragonese, pur vivendo a Sassari. Questi nel no-vembre del 1492, assieme a Bernat Sart e Joan Maldonado, essendosi rifiutatodi consegnare le chiavi dei castelli di Castel Aragonese e Sassari fu incarce-rato per ordine del viceré che gliele aveva richieste69. Abbiamo in tal modoun termine ultimo preciso per la realizzazione dell’opera, il novembre 1492,che si concilia perfettamente con la presunta data leggibile lungo il bordodello stesso scudo (1490)70, e un committente: l’alcayde di Castel Aragonesein lotta con il potere centralistico monarchico71. Fatti che portano a ricon-siderare anche la questione della provenienza dell’opera stessa, ritenutadall’Aru l’antica ancona della chiesa del vicino convento francescano diSanta Maria delle Grazie72 e da me la pala che invece ornava l’antica catte-drale di Ampurias, come voleva anche una più antica tradizione73. Il retablo,a ben vedere, potrebbe essere stato commissionato dall’alcayde cittadino pro-prio per la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, che Alessandro VI
Luigi Agus
326 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 326
aveva intenzione di elevare a nuova cattedrale diocesana, proposito poi at-tuato – su indicazione del pontefice precedente – da Giulio II nel 1506, nel-l’ambito più vasto della riorganizzazione delle diocesi sarde74. La pala fusmembrata entro il 9 aprile 1739, quando risulta eretto l’attuale altare mar-moreo, al centro del quale fu collocata la sola tavola centrale75. La datazionedel retablo castellanese compresa tra 1491 e il novembre 1492 pone defini-tivamente un termine fisso all’interno del corpus dell’anonimo artista, chein quegli stessi anni, evidentemente, risiedeva a Sassari, magari ospite dellabottega di Barceló, il quale – molto probabilmente – fu l’esecutore materialedi alcune parti sia del retablo di Castelsardo, sia del cosiddetto Santo Dia-cono di Sassari (fig. 8), mentre ad altro allievo di bottega si deve l’esecuzione– nel medesimo torno di tempo – del retablo minore di Saccargia (fig. 6), ilcui aspetto formale pare derivare direttamente da Castelsardo, prima che unaltro anonimo artefice, nel 1496, eseguisse la pala maggiore per la stessa aba-zia medievale di Codrongianos76.
Se quindi il passaggio a Sassari del nostro, magari proveniente dalla Cor-sica o direttamente dalla Liguria, va fissato tra il 1491 e il 1492, successivo,per ragioni logiche, fu quello cagliaritano, che andrebbe compreso tra la finedel 1492 – quando il suo principale committente Diego de Guzmán fu arre-stato – e la prima metà del 1500, momento nel quale risulta già altrove, postoche il 4 giugno di quello stesso anno il retablo di Tuili risulta pagato a NicolòGessa e non direttamente al pittore, evidentemente assente. Nella capitalesarda il nostro trovò ospitalità, molto probabilmente, in qualche bottegastampacina, verosimilmente in quella del cosiddetto Maestro del Presepio, icui aspetti formali risultano prossimi, se non sovrapponibili, a quelli di PauVergós. Attorno a questi, se non nella medesima bottega, dovette operareanche Lorenzo Cavaro, che nel 1501 eseguì il retablo di Gonnostramatza(fig. 23) dove si replicano le formule del retablo Carnicer (fig. 20), derivatea loro volta da quello di Tuili (fig. 14)77. Vi è dunque un filo logico conse-guenziale che lega strettamente – e nel giro di pochi anni – il retablo di Tuili,quello della Porziuncola, quello da cui proviene la Madonna di Birminghame le opere di poco più tarde, ma di altra mano, come quelle del Maestro delPresepio o di Lorenzo Cavaro. In tal senso la formula ipotizzata da Ainaudde Lasarte – cioè la consecutio Huguet, Vergós, Maestro di Castelsardo, Mae-stro del Presepio, Maestro di Sanluri – verrebbe stravolta, posto che l’inno-vatore principale in senso italiano sarebbe un anonimo ligure che avrebbesoggiornato pochi anni prima a Sassari e poi a Cagliari, appoggiandosi a bot-teghe locali che, evidentemente, colorivano e completavano opere che luiabbozzava o solo disegnava. Solo in tal modo è possibile spiegare – pur nel-l’unità formale e compositiva – le differenze cromatiche che sussistono trale opere presenti nel settentrione dell’isola e quelle meridionali: le prima le-gate strettamente alle gamme di Barceló, le altre a quelle dei Vergós-Maestrodel Presepio, basta per ciò confrontare il retablo di Castelsardo (figg. 2, 4) e
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 327
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 327
quello di Tuili (fig. 14), rispettivamente con quello della Visitazione di Bar-celó (fig. 1) e quello del Presepio (fig. 20).
Se dunque è possibile chiarire il passaggio del Nostro con relativa appros-simazione prima a Sassari, ospite forse della bottega di Barceló, tra il 1491 eil 1492 e quello successivo a Cagliari collocabile tra la fine del 1492 e gliinizi del 1500, più complessa resta la questione dell’eventuale passaggio nellevante iberico, dove di suo resterebbe la Madonna in Trono (fig. 15) e la Cro-cifissione, già presso la Collezione Muntadas, forse facenti parte di un unicosmembrato retablo (la prima oggi presso il Museu d’Art de Catalunya, la se-conda in collezione privata), e i tre scomparti del Retablo di San Vincenzodi Sarriá (fig. 25), attribuiti al Maestro di Castelsardo da Ainaud de Lasartenel 1959, che certificherebbero un probabile apprendistato presso la bottegadi Huguet, accanto a uno dei Vergós, prima del suo viaggio in Sardegna78.Se per lo scomposto retablo già presso la Collezione Muntadas è possibile ac-cettare una provenienza dalla bottega del Nostro, per gli scomparti di Sarriál’attribuzione non appare altrettanto convincente, posto che le tre casas,come ebbe modo di rilevare Post, si accostano maggiormente all’opera cheJoan Gascó realizzò per il San Pere de Vilamajor (1513-16) o al retablo diSan Pietro Martire (Barcellona, Museu d’Art de Catalunya, 1516 circa), bot-tega dalla quale, molto più probabilmente, uscirono anche i tre scomparti diSarriá all’inizio del XVI secolo79. Basta un confronto tra il Martirio di SanVincenzo (fig. 25) e l’Incontro con la Veronica di Vilamajor per rendersi contoche alcuni personaggi – come il carnefice di Cristo e quello di Vincenzo –sono talmente prossimi da non lasciare adito a dubbio che si tratti, quantomeno, del medesimo atelier, già influenzato da certi dinamismi classicistitardo quattrocenteschi che giunsero nella Penisola Iberica attraverso i pittoridel cardinal Borja, primo fra tutti Paolo di San Leocadio80. Per quanto ri-guarda, invece, lo smembrato retablo proveniente dalla Collezione Muntadas(fig. 15), occorre sottolineare come si può essere tutt’altro che certi della suaprovenienza da qualche chiesa o palazzo spagnoli, mentre potrebbe proveniredalla Sardegna ed essere giunto a Barcellona magari attraverso il mercatoantiquario nel XIX secolo, come già ipotizzò il Post81. Ipotesi, quest’ultima,a mio avviso molto più probabile, vista l’estrema vicinanza del viso della Ver-gine con quello del San Michele di Castelsardo e il Bambino ripreso pun-tualmente – e col medesimo accento anamorfico che ne accentua i volumisferiformi – nello scomparto centrale del retablo di Fonni (fig. 17), opera delmedesimo pittore, uscito certamente dalla sua bottega sassarese di inizio Cin-quecento, che operò al retablo maggiore di Ardara negli scomparti superiorie nello stendardo processionale (fig. 19), a cui si deve anche una Crocifis-sione, già documentata attraverso foto d’archivio nell’isola82, da me ora rin-tracciata presso la Galería Bernat di Barcellona (fig. 18). In tal modo sipotrebbero ricomprendere nella sua attività sassarese del primo periodo(1491-92), ospite o socio di Barceló, il retablo di Castelsardo, il santo Dia-
Luigi Agus
328 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 328
cono della pinacoteca di Sassari e il retablo minore di Saccargia, tutti realiz-zati tra il 1491 e il 1492; mentre andrebbero ricompresi nella sua attività ca-gliaritana, ospite o socio del cosiddetto Maestro del Presepio – artistafortemente influenzato dai Vergós – il retablo della Porziuncola, la Madonnadi Birmingham e, quale suo esito finale, il retablo di Tuili, completato dallabottega, realizzati tra il 1493 e il 1499. Successivi sarebbero invece i duescomparti della collezione Muntadas, realizzati verosimilmente durante unsuo presunto rientro a Sassari a partire dal 1500, quando iniziò ad essere coa-diuvato dall’anonimo artefice che realizzò gran parte della pala d’Ardaraprima del 1515.
Questione a parte rappresentano, invece, i due retabli di Tallà in Corsicaper i quali, come detto, era stata avanzata l’ipotesi potessero essere stati di-pinti attorno al 1492, quando Rinuccio della Rocca fondò il convento fran-cescano di Santa Lucia a nord di Bonifacio da dove provengono le due pale83.Ipotesi che ritengo molto complessa da argomentare, posto che la commit-tenza dei due retabli da parte di Della Rocca non necessariamente coincisecon la fondazione del convento, che ancora nel 1492 non era stato realizzato.Più verosimile appare l’ipotesi che le due pale siano state commissionate suc-cessivamente, ossia dopo che chiesa e convento furono ultimati. In tal sensotroverebbe ulteriore riscontro l’ipotesi di Simone Mereu secondo la quale laCrocifissione (fig. 16) – unico scomparto ritenuto autografo – fu realizzataattorno al 150484, quando il suo committente si spostò da Genova in Sarde-gna – quasi certamente Sassari – dove, pur non essendosi guadagnato la col-laborazione dell’esiliato Gian Paolo di Leca, raggiunse nuovamente laCorsica con diciotto membri del suo clan tra parenti e clienti, per riprenderela lotta contro Niccolò Doria. Battaglia nella quale ebbe la meglio Doria,che fece assassinare uno dei sui figli e Giudice Della Rocca, principale alleatodi Rinuccio. Vista la situazione Rinuccio riparò nuovamente in Sardegna,dove restò in esilio fino al 1507 con gli altri figli Bernardino e Giudicello,quando decise – approfittando delle discordie interne che dilaniavano la Re-pubblica di Genova agli inizi del Cinquecento – di capeggiare una terza ri-volta85. Fu molto probabilmente quando Rinuccio soggiornò in Sardegna nel1504 o tra il 1505 e il 1507, che commissionò alla bottega del nostro le duepale. Se così fosse cadrebbe del tutto l’idea di un possibile spostamento nellaPenisola Iberica dopo il soggiorno cagliaritano (1492-1499), mentre pren-derebbe corpo un suo rientro a Sassari attorno agli inizi del 1500, quandocioè risulta già assente da Cagliari – come si è argomentato prima – e quando,forse, la situazione nel capoluogo del Capo di Sopra si era tornata a norma-lizzare, dopo il rientro da Granada del viceré Dusai, che intraprese una seriedi importanti riforme su indicazione di Ferdinando il Cattolico coinvolgendoanche i municipi86.
Un percorso così segnato, che vede la prevalente presenza del nostro aSassari presso la bottega di Barceló con un soggiorno cagliaritano compreso
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 329
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 329
tra il 1492 e il 1499-1500, pur non portandoci direttamente a un nome, cer-tamente ne fa escludere qualcuno fino ad oggi avanzato in sede storico-cri-tica. Dal novero dei possibili candidati andrebbe primariamente esclusoFrancisco de Fortineros, autore di un perduto retablo per la basilica di SanSaturnino a Cagliari nel 148787, posto che a quella data, molto probabil-mente, era ancora a Savona, dato che il polittico di Santa Maria di Priamar– da cui deriva la Madonna di Castelsardo – fu commissionato al Foppa trail 1485 e il 1489, quando risulta aver ripreso i contatti con Genova, che loterminò il 5 agosto 1490 nella parte centrale, mentre si deve a Brea il com-pletamento del resto appena cinque giorni dopo88. Per le medesime ragioniandrebbe escluso pure Marchus Loret, che compare unicamente in un attodel 12 gennaio 148289. Altro nome da escludere dall’elenco sarebbe quellodi Michele Spanya, non solo perché risulta essere una proposta complessi-vamente debole dato che si basa solo sulla “frequente presenza nei retabli,non solo sardi, del Maestro di Castelsardo dell’immagine di San Michele”90,ma anche per il fatto che il documento citato dal Pillittu riporta una semplicecompravendita tra due pittori, Joannes Dunyat e lo stesso Spanya, di unacasa nel Castello di Cagliari nel 149791, fatto che non ci dice nulla di precisosu nessuno dei due, che avrebbero potuto essere anche semplici imbianchinio pittori tutt’altro che dotati. Potrebbero invece tornare utili i nomi del sas-sarese Nicolau De Liper, padre di Francesco apprendista a Barcellona di Ni-colau de Credensa, che risulta già defunto nel 151892 o del già citatoGiacomo il milanese, che potrebbe aver preso anche parte col Foppa (avendola medesima origine lombarda) alla realizzazione di parti minori o della co-loritura di parte del polittico per il cardinale Della Rovere tra il 1485 e il1490 a Savona. Quest’ultimo risulta attestato in Corsica, infatti, poco primadel completamento del polittico savonese, tra il 1490 e il 1491 al serviziodel Governatore93. Si tratta ovviamente di nomi e nulla più al momento,che certamente non vanno considerati risolutivi, vista anche la complessitàdel problema “Maestro di Castelsardo”, il quale presenta anche forti legamicon la pittura castigliana, in particolare Pedro Berruguete: basta un confrontotra la Predica di San Sant’Antonio da Padova del retablo della Porziuncola(fig. 12) e il Miracolo della Nuvola del Prado. Fatti che potrebbero trovare laloro spiegazione più plausibile nella stessa natura geografica dell’isola “nien-t’affatto periferica, ‘diversa’ rispetto alla produzione figurativa moderna inau-gurata dall’avanguardia fiorentina, ma non per questo inferiore”94. Ed è daascrivere proprio alla circolazione culturale del Mediterraneo Occidentale –dalla Valenza a Genova, da Pisa a Palermo, passando per Napoli – la forma-zione del nostro, una circolazione che ebbe il suo esordio con il valenzanoGherardo Starnina all’inizio del Quattrocento e la commissione da parte diBonifacio Ferrer del retablo per la Certosa di Portacoeli dopo il 1396, doveseppe fondere i modi valenzani con la nuova cultura fiorentina alla AgnoloGaddi, ben visibile del resto nella tavola del Giudizio Universale oggi all’Alte
Luigi Agus
330 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 330
Pinakothek di Monaco, i cui riverberi espressivi sono ancora riscontrabiliallo scorcio del secolo in Sardegna nel popolaresco Maestro di Olzai. Unacircolazione a cui la Sardegna prese parte attiva – e non solo passiva – du-rante tutto il secolo, come documenta lo scomparto della Madonna con Bam-bino data al portoghese attivo a Pisa Alvaro Pirez della Pinacoteca di Cagliari,proveniente dal convento di San Domenico, o la Madonna della Misericordiadi Giovanni da Gaeta proveniente da Ardara, oggi al Wawel di Cracovia95.
4. Il “Maestro del Presepio”
Aderente pedissequamente al modello rappresentato dal retablo di Tuili(fig. 5) è il cosiddetto Maestro del Presepio96, anonimo autore della pala d’al-tare proveniente dalla cappella posta sotto il patrocinio della famiglia Car-nicer in S. Francesco di Stampace a Cagliari, ora custodita presso la localepinacoteca (fig. 20). L’ancona, secondo uno schema già ampiamente diffusonel meridione isolano, è a doppio trittico con predella, priva di polvaroli,che probabilmente andarono perduti durante i vari trasporti che subì. Deri-vano da Tuili (fig. 14) i paesaggi, così verdi e variegati, dominati da dirupirocciosi aggettanti e castelli fatati; gli sfondi a mattoni neri dai contorni bian-chi, ripresi a loro volta da Pedro Berruguete; le balaustre losangate; i pavi-menti ad azulejos, come pure i volumi resi per campiture di grigio stese, comeun sottile velo, sul colore sottostante97, nonché i colori vivaci e sgargianti,cifra tipica di entrambe le pale, così diversi e distanti dalla sobrietà cromaticadi Castelsardo (fig. 2). Talune differenze tra le due opere tuttavia fanno pro-pendere sì per una diversa mano, ma anche per la provenienza delle due paledalla medesima bottega. È il caso della Crocifissione che, nel caso di Tuilirisulta aderente al modello italiano proporzionato secondo il numero aureo,mentre nel caso della pala Carnicer guarda certamente al tardo gotico dellevante spagnolo, in particolare a Joan Reixac (retablo di Sant’Úrsula oggi alMuseu d’Art de Catalunya) secondo un modello già presente nell’isola nelretablo della Visitazione di Juan Berceló (fig. 1), che l’anonimo artista riprendepedissequamente. Non è un caso, infatti, che proprio l’atto con il quale i co-niugi Santa Cruz nel 1500 costituirono un censo per il pagamento del retablodi Tuili, sia stato sottoscritto davanti al notaio Giovanni Carnicer, alla cuifamiglia spettava, come detto, il patronato della cappella di provenienza delretablo del Presepio98.
5. Lorenzo Cavaro
Se per le opere del così detto Maestro del Presepio sfugge un’esatta col-locazione cronologica, come pure è impossibile, allo stato attuale, fornirneuna identità precisa, discorso differente è invece quello per Lorenzo Cavaro,documentato a Cagliari dal 1500 al 1528 e per il quale abbiamo pure un’opera
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 331
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 331
firmata.La prima attestazione documentale di Lorenzo Cavaro è del 28 gennaio
1500, quando Francesco Pipinelli, luogotenente e Procuratore Reale, con-cede in enfiteusi al “venerabili magistro Laurenzio Cavaro pictori abitatori villeStampacis, apendiciorum Castri Calaris”, per un censo annuo di un soldo e perl’entrata d’un ducato d’oro, corrispondente a due lire e 16 soldi, un pezzo diterra sito nei pressi del cimitero giudaico, situato nel medesimo quartiere99.
L’anno successivo Lorenzo firma la modesta ancona di Gonnostramatza(fig. 23). Il retablo, proveniente dalla parrocchiale del villaggio abbandonatodi Serzele100, è a doppio trittico, compreso di polvaroli e predella, al centrodella quale, similmente a Tuili, è collocato il tabernacolo. Pur nella popola-resca e quasi folkloristica composizione, dovuta forse alla modesta commessapiù che all’incapacità dell’autore, si avverte anche in questo caso il palese echiaro riferimento sia al retablo di Tuili (fig. 14) che a quello del Presepio(fig. 20), tanto da fornire un sicuro ante quaem per ques’ultimo al 15 settem-bre del 1501, data che compare nell’ancona di Lorenzo. Se infatti il retablodi Tuili è certamente esistente il 4 giugno 1500, quando il suo autore è pro-babilmente fuori città, la sua esecuzione deve essere anticipata almeno a cin-que se non dieci anni prima. Vengono riprese dal retablo Carnicer, inparticolare, le balaustre losangate, che derivano come abbiamo visto da Tuili,così come l’iconografia del San Pietro con la chiave appoggiata sulla spalladestra. Curiosa infine la Crocifissione, derivata forse da un’incisione del“Maestro E.S.”, dove compare un vescovo, inedita interpretazione forse delsommo sacerdote sempre presente in altre composizioni, posto sulla destraintento ad evangelizzare, o redarguire, i soldati che hanno crocifisso Gesù.
A Lorenzo vengono attribuiti altri due piccoli retabli, quello di Giorginodatato 1508, ora diviso tra la collezione Ballero di Torino e la Pinacoteca diCagliari, e quello di Sinnai (fig. 24), custodito presso la chiesa di S. Vittoria.Come non notare, anche in questi due ultimi casi, i forti richiami soprattuttoa Tuili (fig. 14), come le pareti di fondo, a Sinnai, disegnate con mattonineri contornati di bianco, oppure i paesaggi che, in entrambi i casi, paionocostruiti su dune artificiali tenute alla base da pietrame, simili a quello chesta alle spalle del S. Giacomo di Tuili o al S. Michele Arcangelo di Castel-sardo (fig. 4), tanto che non è possibile pensare a Lorenzo Cavaro senza con-siderare non solamente queste ultime opere, ma anche il retablo Carnicer(fig. 20). Nel caso di Sinnai, poi, vi sono da notare taluni dettagli, come lecornici contornate da pseudo motivi vegetali realizzati in pastiglia a punti,come si vedono a Castelsardo o nel retablo della Porziuncola.
È stato riferito a Lorenzo pure un piccolo scomparto con un S. Gerolamopenitente, custodito presso la Chiesa della Purissima di Cagliari. In effettil’opera, pur presentando talune peculiarità tipiche del modesto pittore stam-pacino, sembra distante temporalmente e stilisticamente dalle altre sueopere, come il retablo di Giorgino o quello di Gonnostramatza. La presenza
Luigi Agus
332 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 332
del crocifisso di Nicodemo e altri caratteri rinviano piuttosto ad una perso-nalità, popolaresca e ingenua, attiva nel secondo quarto del Cinquecento.Del resto i caratteri apparentemente arcaicizzanti non devono trarre in in-ganno, visto che, proprio nella stessa chiesa cagliaritana, è presente pure unpiccolo altarolo dedicato a S. Antioco, donato dal sacerdote Antioco Casulanel 1593 che, a dispetto della data posta accanto alla rappresentazione del-l’offerente, possiede quegli aspetti formali tipici delle ancone del tardo Quat-trocento. Certo la data (1593) riportata a margine della tavola centrale stridefortemente con lo stile di tutta l’opera – fatta eccezione forse per la partecentrale della predellina – che parrebbe essere, come si è detto, tardo Quat-trocentesca. A tal proposito si potrebbe ipotizzare pure che Antioco Casulanon donò l’opera, ma piuttosto provvide a farla restaurare o ridipingere, comesovente accadeva. Questo dato porterebbe a ricondurre l’opera tra quellesarde databili tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo.
Un’altra attestazione di Lorenzo Cavaro è del 20 luglio 1518, quando èindicato tra i confinanti d’un terreno concesso a Giovanni Porcell da PaoloComelles, procuratore reale. In quest’ultimo documento, a differenza del-l’iscrizione di Gonnostramatza e del documento del 1500, Lorenzo è citatocome “magistri Laurenty Cavaro alias Pintor pictoris”, dal ché si deduce chePintor possa essere interpretato sia come secondo cognome, magari quellodella madre, sia come appellativo dato alla famiglia Cavaro101. La questionenon è di facile soluzione, come potrebbe apparire, anche perché come aliaspintor compaiono pure Pietro Cavaro e il figlio Michele, così come altri mem-bri della stessa famiglia. D’altra parte però non è da escludere che fosse unsecondo cognome, infatti Pietro Cavaro è citato pure come “Petri Pintor pic-toris”, il che significherebbe che quel Pintor, più che un appellativo dato peril mestiere praticato, potesse stare ad indicare un secondo cognome. Un ul-timo documento attesta l’esistenza di Lorenzo ancora il 24 settembre 1528102.
Se dubbi sussistono sui cognomi o lo pseudonimo dei Cavaro, altrettantidubbi possono avanzarsi sul fatto che Lorenzo fosse il padre di Pietro. Sullaquestione, a partire dall’Aru, si pensò che Lorenzo potesse essere identificatocome il figlio di Antonio, documentato dal 1455 e deceduto nel 1482, epadre di Pietro Cavaro103. Tuttavia la questione parrebbe lontana da una so-luzione soddisfacente, infatti l’età presunta di Pietro, nonché la sua firma sulretablo di Villamar dove si firma “il più piccolo dei pittori di Stampace”, porte-rebbe a credere che si tratti del minore d’una serie di fratelli, tra cui potrebbetranquillamente figurare Lorenzo, il quale ancora vive nel 1528, data dopola quale non ne abbiamo altre notizie104.
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 333
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 333
Luigi Agus
334 Par l anno XXVIII - n° 24c
1. Joan Barcelo, Retablo della Visitazione,Cagliari, Pinacoteca (1488-1500 ca.)
2. Maestro di Castelsardo, Madonna introno e angeli musicanti, Castelsardo,Concattedrale di Sant’Antonio Abate(1491-92).
3. Vincenzo Foppa, Madonna in trono, an-geli musicanti e donatore, Savona, Ora-torio di S. Maria di Castello (1485-90)
4. Maestro di Castelsardo, San MicheleArcangelo, Castelsardo, Museo Diocesano(1491-92)
1
2
3
4
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 334
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 335
5. Maestro di Castelsardo, Trinità,schema geometrico della composi-zione, Castelsardo, Museo Dioce-sano (1491-92)
6. Maestro di Castelsardo e bottega,Retablo della Vergine, Codrongia-nos, Pinacoteca (1491-92)
7. Lodovico Brea, Polittico di S. Gio-vanni Battista, Coursegoules, ÉgliseSainte-Marie-Madeleine (1470-90)
8. Maestro di Castelsardo e bottega,Santo martire, Sassari, Pinacoteca(1491-92)
5
7
8
6
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 335
Luigi Agus
336 Par l anno XXVIII - n° 24c
9. Maestro di Castelsardo, San Ottone martire, Cagliari, Pina-coteca (1492-95 ca.)
10. Nicolò Corso, S. Vincenzo martire, Roma, Palazzo Venezia(1501)
11. Maestro di Castelsardo, Madonna in trono e donatori, Bir-mingham, Museum of Art (1492-95)
12. Maestro di Castelsardo, Predica di Sant’Antonio da Padova,Cagliari, Pinacoteca (1495 ca.)
13. Maestro di Castelsardo, Madonna in trono con San Francescoche offre un piatto di rose, Mentone, Musée du Palais Carnolès(1495)
14. Maestro di Castelsardo e bottega, Retablo di San Pietro,Tuili, Parrocchiale (1495-99)
910
11
12
13
14
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 336
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 337
15. Maestro di Castelsardo e Maestro di Ardara, Madonna del Latte,Barcellona, Museu d’Art de Catalunya (1500-1504 ca.)
16. Maestro di Castelsardo, Crocifissione, Tallà,Chiesa di Santa Lucia (1504-07)
17. Maestro di Ardara, Madonna del Latte, Fonni,Basilica dei Martiri (1505-10)
15
16
17
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 337
Luigi Agus
338 Par l anno XXVIII - n° 24c
18. Maestro di Ardara, Crocifissione, Barcel-lona, Galería Bernat (1505-10 ca.)
19. Maestro di Ardara, Madonna della pera,Ardara, Basilica di S. Maria del Regno(1510-15)
20. Maestro del Presepio, Retablo del Prese-pio, Cagliari, Pinacoteca (1500 ca.)
18
19
20
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 338
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 339
21. Lorenzo Cavaro e bottega, Retablo della Madonna delLatte, Olzai, S. Barbara (1492-99)
22. Lorenzo Cavaro e bottega, Retablo del Giudizio Universale,Cagliari, Pinacoteca (1492-99)
23. Lorenzo Cavaro, Retablo della Vergine, Gonnostramatza,Parrocchiale (1501)
21 22
23
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 339
Luigi Agus
340 Par l anno XXVIII - n° 24c
24. Lorenzo Cavaro, Retablo della Vergine, Sinnai, Santa Vit-toria (1508)
25. Joan Gascó e aiuti, Martirio di San Lorenzo, Barcellona,Museu d’Art de Catalunya (1510-15)
26. Rafaél Vergós, Crocifissione, Amsterdam, Rijksmuseum(1495-1500)
24
25
26
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 340
Note1 C. Aru, La pittura sarda nel Rinascimento, I, Leorigini: Lorenzo Cavaro, in «Archivio StoricoSardo», XV (1924), estr., pp. 3-5, tesi ripresaanche da R. Sfogliano, Il Retablo di Castelsardo,in «Archivio Storico Sardo», VII (1981), p. 285.2 C. R. Post, A history of spanish painting, vol. XII,part II, Cambridge (Ms) 1958, p. 460. Tale ideaderiva, in larga misura, dalla lettura del VanMarle, il quale sosteneva come “the history ofSardinia is in itself sufficient to explain why, ar-tistically speaking, this island became a Spanishcolony; in fact it would have been very strange ifit had been otherwise” [R. Van Marle, The deve-lopment of the Italian Schools of Painiting, vol. XV,The Hague, 1934, p. 452].3 F. Manconi, Il governo del regno di Sardegna altempo dell’imperatore Carlo V, Sassari 2002, p. 8;A. Pasolini, El caballero de la Orden de SantiagoSalvatore Aymerich y Pietro Cavaro: encargos, re-tratos y fondos de oro en la pintura sarda del Cin-quecento, in «Quintana», 8 (2009), p. 177.4 Archivio di Stato di Cagliari (=ASC), ArchivioAymerich, b. 1, 63.5 R. Serra, Retabli pittorici in Sardegna nel Quattro-cento e nel Cinquecento, Roma 1980, pp. 5-6.6 A. Sari, L’arte figurativa in Sardegna nei primi se-coli della conquista catalana, in Studi in onore di Er-cole Contu, Sassari 2003, pp. 301-302, a cui sirinvia per la bibliografia precedente.7 L. Agus, Il secolo dei retablos. L’arte figurativadella Sardegna del Quattrocento, in «Dedalo», 2(2005), pp. 6-23.8 Delogu, Il «Maestro di Olzai» e le origini dellaScuola di Stampace, in «Studi Sardi», VI (1942-44), pp. 5-21.9 R. Post, A history of spanish painting, cit., p. 469.10 A. Pérez Sánchez, Dipinti della Civica Galleria“Anna e Luigi Parmeggiani”, 1. I dipinti spagnoli,Reggio Emilia 1988, p. 28.11 Ibidem12 G. Goddard King, Sardinian Painting. I. ThePainters of the Gold Backgrounds, Filadelfia 1923,pp. 92 ss.; G. Goddard King, Pittura sarda delQuattro-Cinquecento, a cura di R. Coroneo,Nuoro 2000, pp. 105-109.13 R. Delogu, Il «Maestro di Olzai», cit., pp. 10-15.14 R. Serra, Pittura e scultura dall’età romanica allafine del ‘500, Storia dell’Arte in Sardegna, Nuoro1990, p. 172.15 R. Delogu, Il «Maestro di Olzai», cit., p. 8.
16 G. F. Fara, Opera, E. Cadoni (ed.), vol. III, Sas-sari 1992, pp. 282-284; L. Agus, Rinascimento inSardegna. Saggi di storia, arte e letteratura, Cagliari2009, p. 8.17 R. Delogu, Il «Maestro di Olzai», cit., p. 8.18 C. Maltese, R. Serra, Episodi di una civiltà anti-classica, in Sardegna, Venezia 1969, p. 272.19 R. Serra, Retabli pittorici, cit., p. 44.20 R. Serra, Pittura e scultura, cit., p. 172.21R. Delogu, Il «Maestro di Olzai», cit., p. 18.22 Ivi, p. 21.23 R. Serra, Pittura e scultura, cit., p. 173.24 Il collegamento tra il Maestro di Castelsardo,ma soprattutto il Maestro del Presepio, con PabloVergós e i suoi fratelli risulta talmente stringenteche lo stesso Post [A history of spanish painting, vol.VII, part II, Cambridge (Ms) 1938, p. 442], diedeinizialmente al maestro catalano la tavola con laPredica di Sant’Antonio, proveniente dal Retablodella Porziuncola, oggi alla Pinacoteca di Cagliari.Errore che poi corresse nel volume successivo, ri-solvendo il problema attributivo attraverso unsuggerimento di Carlo Aru [Id., vol. VIII, part II,Cambridge (Ms) 1941, p. 490]. Un legame, quellocon la bottega dei Vergós, il cui tramite fu proba-bilmente l’anonima figura del Maestro del Prese-pio a Cagliari la cui opera, da un punto di vistacromatico, compositivo e formale, risulta dipen-dere dal Retablo di Granollers, mutuato dallagrande Crocifissione di Amsterdam che avevo giàipotizzato potesse essere assegnata all’anonimosardo [L. Agus, Una Crocifissione del “Maestro delPresepio” al Rijksmuseum di Amsterdam, in “BTA-Bollettino Telematico dell’Arte”, 311 (2002)] cheinvece va certamente restituita a Rafaél Vergósper strette e inequivocabili tangenze con quelladi Granollers, data dal Post allo stesso autore [Ahistory of spanish painting, vol. VII, part II, cit., pp.431-434].25 L. Agus, Gioacchino Cavaro. Il Maestro di Ca-stelsardo, Cagliari 2000, pp. 43-44.26 M. G. Scano Naitza, Giovanni Spano, la sua“collezione” e i problemi attuali della storia della pit-tura sarda, in P. Pulina e S. Tola (ed.), Il tesoro delcanonico, Sassari 2005, p. 185.27 F. Poli, La prospettiva nelle opere del Maestro diCastelsardo (e altre considerazioni), in «ArchivioStorico Sardo», 41 (2001), pp. 400-401, nota36. A tal proposito possono citarsi le epigrafidelle aureole del retablo di Tuili, tutte realizzatead embutido come quella di Castelsardo, che ri-portano il nome del santo raffigurato con carat-teri decorativi simili a quelli usati nella tavola
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 341
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 341
castellanese.28 L. Agus, Le botteghe pittoriche della prima metàdel Cinquecento nel “Capo di Sopra”, in «Crona-che di Archeologia», 7 (2008), pp. 115-139.29 I due retabli, distanti temporalmente almenotre-cinque anni, andrebbero distinti per mano efattura. Infatti, pur dovendo riconoscere un’ideacompositiva e formale del tutto simile, furonomolto probabilmente completati da autori diffe-renti all’interno di botteghe diverse, una sassaresee l’altra cagliaritana. A tali ambiti, come avevagià sottolineato la Goddard King, non dovetteessere estraneo Juan Barceló [G. Goddard King,Pittura sarda, cit., p. 104], almeno per quanto ri-guarda il retablo di Castelsardo, forse inventatodal Nostro mentre era ospite di quella bottega aSassari o il Maestro del Presepio, strettamente le-gato ai Vergós (in particolare Pablo), che moltoprobabilmente completò quello di Tuili. Come sivedrà, infatti, in tutti e due i casi (Castelsardo eTuili) appaiono nelle tavole alcune indicazionisotto lo strato pittorico scritte dal capo bottega,che avrebbero dovuto servire evidentemente aterzi per colorire, disegnare o completare l’opera,fatto che porta a distinguere nettamente l’aspettoprogettuale da quello esecutivo [L. Agus, Gioac-chino Cavaro, cit., p. 38; G. Carcangiu, O. Cocco,L. Donati, et al., Non-Destructive Investigations onFour Paintings by the Master of Castelsardo. A Col-laboration Between ENEA and University of Ca-gliari, in «EAI-Speciale», II (2012), pp. 150-151].Si tratta di questioni che pongono il nostro ormaifuori dall’alveo della pittura medievale o tardo-medievale, per proiettarlo verso quella pretta-mente rinascimentale e pre-manierista, dove ildisegno era divenuto uno “strumento di baseormai affrancatosi dai modelli, e con una diffu-sione autonoma” all’interno delle botteghe, comechiarì anche Cennino Cennini nel suo trattato[A. Griseri, Il disegno, in F. Zeri (ed.), Storia del-l’Arte Italiana, parte III, Vol. II, tomo I, Torino1980, pp. 204-205]. Nel nostro caso tale distin-zione diviene ancora più netta e marcata se si raf-fronta l’aspetto formale e compositivo dei dipintidelle casas ideati dal nostro, con il progetto com-plessivo dell’ancona, ancora di marca tardo go-tica (come lo saranno quelle successive di PietroCavaro), dove “insieme alla gran quantità di fi-gure e di scene, permane il goticismo in tutto iltritume d’ornati, delle foglie stellate, de’ trafori,di fondi di stucco o campes embotits con graffiti agrandi foglie seghettate; ancora l’effetto decora-tivo sovrasta a quello dell’immagine sacra, a cui
gli ori abbaglianti, le stole gemmate, i broccati lacircondano, danno veste e fulgore di idolo”,come sottolineò Adolfo Venturi a proposito del-l’influsso della pittura iberica in Sardegna [A.Venturi, Storia dell’Arte Italiana, vol. VII, parteIV, Milano 1915, p. 112].30 J. Molina i Fugueras, Rutas artísticas y culturavisual en Cataluña (1470-1520), in El arte en laCorte de los Reyes Católicos, rutas artísticas a prin-cipios de la Edad Moderna, Madrid 2005, pp. 115-144.31 Sulla figura dell’anonimo “Maestro di Sanluri”,delineata dall’Aru con significative aggiuntedella Serra, vi è da sottolineare l’importante re-cente ritrovamento di quattro scomparti di pre-della a San Gavino Monreale, chedefinitivamente accostano la sua produzione aquella di Giovanni Muru, attivo nello stesso pe-riodo di tempo (fine sec. XV, inizi sec. XVI) nelnord dell’isola, quando firma e data la predelladel Retablo Maggiore di Ardara nel 1515 [L.Siddi, La predella di San Gavino Monreale. Risco-perta e restauro, Cagliari 2011, pp. 28-36].32 La relazione diretta tra il Maestro di Castel-sardo e Antonello da Messina fu evidenziata giàdall’Aru [C. Aru, Il Maestro di Castelsardo, in«Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia del-l’Università di Cagliari», 1/2, 1926-27, p. 40.] edal Van Marle [The development, XV, cit., p. 464],per poi essere ripresa dalla Sfogliano [Il retablo diCastelsardo, cit., pp. 290-291], la quale eviden-ziava come “l’introduzione in molte opere pitto-riche spagnole di elementi architettonici classiciche appaiono di origine centro italiana, poste-riormente ai viaggi in Italia di Jacomart, di PedroBerruguete, di quel «Maestro Alfonso» docu-mentato alla corte ferrarese, [siano] elementi chetuttavia restano posticci rispetto alla struttura deldipinto” e come “la limitata conoscenza che ilMaestro di Castel Sardo dimostra della contem-poranea pittura italiana […] può più ragionevol-mente spiegarsi sulla base di tendenze e stimoligià presenti e attivi nell’arte catalana” [Ibidem].Ragionamento che tuttavia non è più proponi-bile quando si dimostra, come nel nostro caso,che anche l’impianto compositivo – e non solotaluni dettagli architettonici, desunti dal reper-torio antonellesco già patrimonio del levante ibe-rico – risente in maniera sostanziale dellespeculazioni umanistiche delle corti italiane, inparticolare quella urbinate degli anni Settantapoi diffuse attraverso Mantova alla Lombardia ealla Liguria nei decenni successivi.
Luigi Agus
342 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 342
33 Sui concetti contrapposti di “lineare-pittorico”,“forma chiusa-forma aperta”, si veda H. Wölfflin,Concetti fondamentali della storia dell’arte, Milano2012, pp. 35-98, 155-190.34 H. Belting, Giovanni Bellini. La Pietà, Modena1996.35 E. Villata, Per Macrino d’Alba, in G. Romano(ed.), Primitivi piemontesi nei musei di Torino, To-rino 1996, p. 222.36 L. Agus, Gioacchino Cavaro, cit., p. 23.37 La vicinanza o addirittura una derivazione dallabottega di Huguet è stata ipotizzata, pur in ma-niera non del tutto convincente, da Ainaud deLasarte, che tuttavia sottolineava come la piùnetta tendenza al realismo riscontrabile nel-l’opera del Maestro di Castelsardo sia dovuta“alla presenza a Barcellona tra il 1486 e il 1490del grande pittore di Cordoba Bartolomé Ber-mejo che aveva lavorato prima a Valencia e aDaroca”. Un’idea che, secondo lo studioso spa-gnolo, sarebbe suffragata dal fatto che il Post“abbia attribuito alcune delle pitture cagliaritanea Pau Vergós, senza dubbio il continuatore più fe-dele e allo stesso tempo originale di Huguet” [J.Ainaud de Lasarte, La pittura sardo-catalana, inCultura quattro-cinquecentesca in Sardegna. Retablirestaurati e documenti, Cagliari 1985, pp. 28, 29].La vicinanza invece con i Vergós, forse più con-vincente, ma non relazionata col nostro, bensì alMaestro del Presepio, fu ipotizzata da Post [A hi-story of spanish painting, vol. VII, part II, Cam-bridge (Ms) 1938, p. 442], che in altra sedepropose invece una vicinanza col maiorchinoTorner [A history of spanish painting, vol. VIII, partII, Cambridge (Ms) 1941, pp. 482-497]. Tale ul-tima ipotesi più recentemente è stata ripropostaa proposito dell’autografia di alcune tavole del re-tablo maggiore di Ardara [F. Cardini (ed.), L’Ita-lia medievale, Milano 2004, p. 323]. Un’altraproposta, non del tutto da scartare, fu quella diAdolfo Venturi, che invece assegnò le tavole diCastelsardo, Tuili, Sanluri e della Porziuncola aun artista uscito dalla bottega di Joan Barceló, dacui poi derivò la produzione di Giovanni Muru,il quale si sarebbe attardato sulle formule compo-sitive e i modelli formali propri del nostro [A.Venturi, Storia dell’Arte Italiana, vol. VII, parteIV, cit., p. 116].38 L. Agus, Gioacchino Cavaro, cit., pp. 26-28.39 H. Wölfflin, Rinascimento e Barocco. Ricercheintorno all’essenza dello stile barocco in Italia, Fi-renze 1988, p. 135.40 L. Siddi, La pittura del Cinquecento, in F. Man-
coni (ed.), La società sarda in età spagnola, vol. I,Cagliari 1992, p. 90.41 G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria.Il Quattrocento, Genova 1991, pp. 287-335; M.Caldera, La pittura in Liguria nel XV secolo, Mi-lano 2005, pp. 15-22.42 V. Natale, Non solo Canavesio. Pittura lungo leAlpi Marittime alla fine del Quattrocento, in Primi-tivi piemontesi nei musei di Torino, cit., p. 44.43 G. Algeri, Testimonianze e presenze fiamminghenella pittura del Quattrocento, in P. Boccardo, C.Di Fabio (ed.), Pittura fiamminga in Liguria. SecoliXIV-XVII, Genova 1997, p. 39. 44 Ivi, pp. 39-40.45 G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria,cit., p. 490.46 G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria,cit., p. 499. Il 28 gennaio 1472 al pittore d’originepinerolese, documentato ad Albenga come “pre-sbiter”, venne ordinato un polittico di San Gio-vanni Battista dal rappresentante di GiovanniPirele di Oristano che doveva misurare circa cm.375x300, che gli sarebbe stato pagato 360 lire,moneta di Albenga e che il pittore si impegnavaa consegnare entro la metà di luglio dello stessoanno. Lo stesso giorno il carpentiere D. Gastaldipromise al pittore di fornire entro 20 giorni il sup-porto ligneo del polittico. L’opera era verosimil-mente destinata alla cattedrale di Oristano.47 G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria,cit., pp. 410-411; L. Nieddu, Il Maestro di Castel-sardo: contatti con la cultura figurativa del ponenteligure, in «BTA – Bollettino Telematico del-l’Arte», 306 (3 settembre 2002). Ancora con-fronti convincenti tra il Nostro e Brea possonoessere quelli tra la Madonna in trono del Poldi Pez-zoli di Milano, proveniente dalla collezione Bel-lesi (inv. 5239) e quella di Castelsardo, doveritroviamo le medesime candelabre sui bordi deltrono e il tema dei tre angeli musicanti appolla-iati sul trono, derivati dall’idea di VincenzoFoppa per la chiesa di Santa Maria di Priamar aSavona, presenti anche in quella di Birmingham,i cui angeli reggi corona derivano da quella asse-gnata sempre a Brea della collezione Costa di Ge-nova (Fototeca Zeri, scheda 22540).48 S. Baiocco, Repertorio delle opere di Gandolfinoda Roreto, in G. Romano (ed.), Gandolfino da Ro-reto e il rinascimento nel Piemonte meridionale, To-rino 1998, p. 269.49 G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria,cit., pp. 361-363; M. Caldera, La pittura, cit., p.23.
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 343
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 343
50 Recentemente uno studio approfondito sul-l’iconografia degli strumenti musicali in diversescuture e retabli sardi di Giovanni Battista Fa-edda – che in questa sede doverosamente ringra-zio – mi ha permesso di mettere a confronto idettagli della pala savonese con quella di Castel-sardo fornendo ulteriori indizi della dipendenzadella seconda dalla prima in maniera presso chediretta. G. B. Faedda, Aspetti di iconografia musi-cale nelle fonti della Sardegna Settentrionale, Uni-versità degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere eFilosofia, Corso di Laurea in Lettere Moderne,tesi di laurea, relatore prof. Giampaolo Mele, cor-relatore prof. Aldo Sari, A. A. 2009-2010, inpart. pp. 40-52.51 G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria,cit., pp. 287-291, 300.52 Ivi, pp. 397-398.53 Ulteriore esempio è la derivazione diretta dellaTrinità di Castelsardo da quella del polittico datoad un seguace di Manfredino Bosilio, oggi a Bal-timora presso la Walters Art Gallery, dove con-vergono elementi piemontesi – non a caso inpassato fu assegnato alla cerchia del Canavesio –e lombardi, sviluppati in area ligure. Con loscomparto di Castelsardo risulta identica la fisio-nomia del Cristo proporzionato secondo il me-todo aureo, Dio padre che regge la croce con losguardo fisso verso lo spettatore col mantelloaperto sul davanti, la colomba sul capo di Cristoe la mandorla con cherubini che attornia la scena[G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria,cit., pp. 324-325]. Si tratta di un’iconografia giàvista in area piemontese, dato che compareanche nel Breviario di San Michele della Chiusadella Biblioteca Nazionale di Torino (ms D.VI11, c. 182v) realizzato tra il 1470 e il 1480 da unanonimo miniatore piemontese [G. Romano, DaGiacomo Pitterio ad Antoine de Lonhy, in Primitivipiemontesi nei musei di Torino, cit., p. 195].54 E. Brunelli, Note Sarde. II – Una tavola sardanella Pinacoteca di Torino, in «Bollettino d’Arte»,XXVII (1933), pp. 112-113.55 G. Spano, Guida della città e dintorni di Cagliari,Cagliari 1861, p. 184.56 G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria,cit., pp. 424, 480, nota 47. La tavola misura cm105x65, mentre gli scomparti laterali del retablodella Porziuncola rispettivamente cm 95x140 e95x180.57 La vita e le opere di Nicolò di Lombarduccio,detto Nicolò Corso, fu celebrata fin dal XVII se-colo attraverso il Soprani (1674), che elogiò la
sua cospicua produzione del Monastero di SanGerolamo a Quarto. Le fonti sette-ottocentescheaggiunsero poco, mentre rilevanti sono gli studidel XIX e XX secolo, che meglio hanno delineatola sua figura in costante bilico tra le istanze fiam-minghe presenti a Genova e quelle, di poco suc-cessive, di matrice lombarda. Nacqueprobabilmente nel 1446 a Pieve di Vico e fu at-tivo fin dal 1469, quando risulta già socio di Gio-vanni dell’Acqua. Nel 1478 opera a Pietrasantae poi a Genova in cattedrale, stringendo rapportisempre più stretti con la comunità lombarda. Fusuccessivamente ad Alessandria accanto a Pietro“de Abiate”, milanese, e al pittore Galeotto Neb-bia da Castellaccio. La sua piena maturità arti-stica, tuttavia, la denuncia attraverso lacomplessa e straordinaria decorazione del mona-stero di Santa Maria delle Grazie a Portovenereeseguita tra il 1485 e il 1490. Nel 1491-92 fuchiamato a stimare la tavola eseguita da Gio-vanni Mazone per il cardinale Della Rovere a Sa-vona, anni in cui risulta pure vicemagister diFrancesco da Pavia. Gli stretti rapporti con Ma-zone influenzarono la sua opera per la cappella diSan Gerolamo a Quarto, terminati entro il 1503,anni in cui dipinse il polittico di Taggia e variealtre opere. Morì nel 1513. L. Martini, NicolòCorso, un pittore per gli Olivetani, in G. RotondiTerminiello (ed.), Nicolò Corso. Un pittore per gliOlivetani. Arte in Liguria alla fine del Quattrocento,Genova 1986, pp. 17-24; G. Algeri, A. De Flo-riani, La pittura in Liguria, cit., p. 519.58 M. Cataldi Gallo, Nicolò Corso, Polittico di SanVincenzo Ferrer, in G. Rotondi Terminiello (ed.),Nicolò Corso, cit., pp. 115-116.59 L. Agus, Gioacchino Cavaro, cit., p. 43.60 G. Algeri, A. De Floriani, La pittura in Liguria,cit., p. 509.61 B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance.Central Italian and North Italian Schools, London1968, pp. 62-65.62 P. Santucci, La pittura del Quattrocento. Storiadell’Arte in Italia, Torino 2000, p. 241.63 La realizzazione delle sue opere a più mani sem-bra dimostrata definitivamente dall’utilizzo nonsolo di cartoni da spolvero presenti in bottega,come nel caso di Tuili, dove sotto il S. MicheleArcangelo è leggibile chiaramente la scritta“MQL I”, contrazione di Miquel 1, ossia il primocartone relativo all’iconografia dell’arcangelo [L.Agus, Gioacchino Cavaro, cit., p. 38], ma anchedall’indicazione dei colori, com’è il caso della ta-vola del San Mattia della predella di Castelsardo,
Luigi Agus
344 Par l anno XXVIII - n° 24c
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 344
dove è stata rinvenuta la scritta in lingua cata-lana “vermell”, indicante il colore da utilizzareper quella porzione di dipinto [G. Carcangiu, O.Cocco, L. Donati, et al., Non-Destructive Investi-gations, cit., pp. 150-151]; scritte che non neces-sariamente andrebbero considerate autografe, mache potrebbero anche essere state apposte da ungarzone di bottega addetto alla preparazione deisupporti.64 R. Serra, Pittura e scultura, cit., p. 114.65 S. Mereu, Osservazioni sull’opera del Maestro diCastelsardo, in «Studi Sardi», XXXII (1999), p.375.66 La correzione della data – erroneamente ripor-tata dalla Serra scambiando le ultime due cifredell’anno rispetto a quella pubblicata dal Delogu[R. Delogu, Studi e memorie sulla architettura goticain Sardegna, in «Studi Sardi», IX (1949), p. 570]– è stata proposta e dimostrata recentementedalla Scano [M. G. Scano Naitza, GiovanniSpano, cit., p. 186]. Da ultimo Pillittu [A. Pillittu,La pittura in Sardegna e in Spagna nel ‘500 e il Cro-cifisso di Nicodemo, s.l. 2012, pp. 30-31] ha pro-posto una possibile derivazione in controparte delgruppo di donne ai piedi della croce da una inci-sione assegnata all’ambito di Dürer databile tra il1495 e il 1500, fatto che restringerebbe la forbicecronologica di esecuzione del polittico di Tuili,che in tutti i casi nel giugno del 1500 risulta ter-minato. In questa sede, oltre a rilevare l’inconsi-stenza di molte asserzioni di quella pubblicazioneautoprodotta e priva di ogni valore scientifico estorico-artistico (basta pensare alle affermazionisul Ferra o sul cosiddetto Maestro di Ozieri chelo stesso autore identificherebbe in Pietro Raxisil vecchio, del quale ben si conoscono le opereandaluse, che non cita, e che non era più pre-sente nell’isola dopo il 1570, quando risulta giàrientrato a Piego di Córdoba per installare il re-tablo maggiore commissionatogli nel 1565 [L.Agus, I rapporti storico-artistici nel bacino del Me-diterraneo Occidentale nel XVI secolo. Il caso deiRaxis-Sardo, pittori, scultori e architetti tra Cagliari,Roma e Granada, in «Mneme-Ammentos», IV(2012), pp. 83-89]), si vuole sottolineare come ilconfronto non sia del tutto pertinente, ma troppogenerico, posto che si tratta di immagini ripetutee diffuse fin del Trecento in ambito umbro (Mae-stro del Dittico Poldi Pezzoli, Crocifissione, Vene-zia, Fondazione Giorgio Cini) e poi europeo. Intutti i casi la forbice cronologica resterebbe co-munque ampia (1495-1500), tanto da non for-nire un punto certo e definitivo, ma solo il fatto
che il retablo di Tuili sia stato eseguito successi-vamente rispetto a quello di Castelsardo.67 C. Aru, La pittura sarda del Rinascimento. II. Idocumenti d’archivio, in «Archivio StoricoSardo», XVI (1926), p. 212.68 L. Agus, Tra scandali e umanesimo. L’inedita sto-ria di un protagonista del Rinascimento a Sassari,mons. Salvatore Alepus, in «Almanacco Gallu-rese», 14 (2006), p. 298.69 F. Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo.Secoli XVI-XVII, Nuoro 2010, pp. 60-61.70 L. Agus, Gioacchino Cavaro, cit., pp. 21, 43.71 F. Manconi, La Sardegna, cit., pp. 60-61.72 C. Aru, Il Maestro di Castelsardo, cit, p. 33, nota1; R. Sfogliano, Il retablo di Castelsardo, cit., p.285; R. Serra, Retabli pittorici, cit., p. 54; R. Serra,Pittura e scultura, cit., p. 114.73 L. Agus, Gioacchino Cavaro, cit., p. 113.74 Il progetto di riforma delle diocesi sarde ebbeil suo esordio già durante il pontificato di Euge-nio IV, vista la disastrosa situazione economicanella quale versavano. La popolazione infatti ri-sultava di gran lunga ridotta rispetto ai secoli pre-cedenti, ma soprattutto molti centri sede didiocesi (come Sorres, Ampurias, Castra, ecc.) ri-sultavano ormai abbandonati e i vescovi risiede-vano in luoghi più sicuri e fortificati come Sassario Castel Aragonese [R. Turtas, Storia della Chiesain Sardegna dalle origini al Duemila, Roma 1999,pp. 315-317]. Emblematico fu il caso di Ampu-rias, il cui centro già nel 1580-90 è descrittocome “antiqua civitas a Phocensibus, ut creditur,condita, iacet in planitie iuxta piscosum flumenadeo excisa ut in ea nihil memorabile cernaturnisi templum prisca structura insigne, divo Pietrodicatum et episcopali dignitate decoratum” [I. F.Farae, Opera, 1. In Sardiniae Chorographiam, cit.,pp. 174-176]. Fu tuttavia per l’energico inter-vento di Ferdinando il Cattolico, a partire dal1493, che si diede impulso definitivo al riordinodi una situazione che, di fatto, era divenuta talegià nella prima metà del secolo [R. Turtas, Storiadella Chiesa, cit., pp. 327-329].75 L. Agus, Gioacchino Cavaro, cit., p. 113. 76 L. Agus, Retabli scomparsi. II L’epigrafe di Sac-cargia, in «Almanacco Gallurese», 11 (2003), pp.134-137.77 R. Van Marle, The development of the ItalianSchools of Painting, XV, cit., p. 464.78 J. Ainaud de Lasarte, Les relacions economiquesde Barcelóna amb Sardenya i la seva projecció artí-stica, VI Congreso de Historia de la Corona deAragón, Madrid 1959, p. 642.
Il Maestro di Castelsardo, la genesi della Scuola di Stampace e i rapporti con il ponente ligure
Luglio / dicembre 2013 345
Impaginato FEBBRAIO 24_Layout 1 18/02/14 10:01 Pagina 345