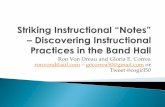Cuando la Universidad de Santiago de Compostela buscó su gloria en ultramar
Dall'Oltregiogo alla Gloria. Militari di Novi Ligure e Serravalle Scrivia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Dall'Oltregiogo alla Gloria. Militari di Novi Ligure e Serravalle Scrivia
25
L’allontanarsi nel tempo delle guerre acui l’Italia partecipò ne ha ridotto i contorniad eventi di grandi masse, leader politici divertice e relazioni internazionali. Ma essefurono combattute da uomini, soprattutto diestrazione popolare, che vi manifestarono illoro carattere: vogliamo qui, in modo sinte-tico e senz’altro lacunoso, ricordare alcunidi essi, nati nelle nostre terre e citati in variepubblicazioni anche a livello nazionale.Sono stati, il più delle volte, dimenticati esolo alcune lapidi e poche ricerche li ripor-tano alla nostra memoria.
Risorgimento
Iniziamo la nostra ricerca citando Giu-seppe Passalacqua, marchese di Villalver-nia, nato a Tortona il 9 dicembre 1794.
Nel 1848, quando venne dichiarata laPrima Guerra d’Indipendenza aveva rag-
giunto il grado di Maggiore Generale. Dopol’occupazione della Lombardia rappresentòCarlo Alberto nel governo provvisorio di Mi-lano, quindi passò a comandare la BrigataCasale, che combatté a Santa Lucia pressoVerona.
Alla ripresa delle ostilità con l’Austria, nelmarzo del 1849, faceva parte della IV Divi-sione comandata dal Duca di Genova, cheera sul confine del Ticino.
Dopo alcuni scontri a Mortara ed a Vige-vano, il 21 marzo era alla Bicocca alle portedi Novara. Il successivo 23 marzo avvenneun nuovo scontro ed egli assunse personal-mente il comando del 3° Reggimento Fan-teria per arrestare l’avanzata austriaca. Ilfuoco nemico era molto intenso: colpitomortalmente, cadde sul campo di battaglia.
Il re Carlo Alberto lo insignì della Meda-glia d’Oro al Valor Militare: si trattò, quindi,della prima medaglia d’oro concessa nelleguerre del Risorgimento e la motivazione fu:
DALLʼOLTREGIOGO ALLA GLORIAPierfranco MalfettaniSergio Pedemonte
Krionero (Valona), estate 1943. In piedi, al centro, il sottotenente Renato Gatti. Seduto, terzo da sinistra, un altro illustre novese: Gino Corte
26
Per essersi distinto nel fatto d’armi di No-vara. 23 marzo 1849.
Essa fu poi donata all’Istituto d’Istruzione,Antichità e Storia, quindi al Comune di Tor-tona, che la conserva ancora oggi.
Le spoglie del Generale Passalacqua fu-rono sepolte nella cappelletta del Castellodi Villalvernia che, dopo anni di abbandono,nel 1989 è stata restaurata a cura del Co-mitato Permanente Superstiti 38° Regg.toFanteria della Divisione Ravenna.
Così quell’antica cappelletta è diventatail Sacrario dei caduti e dei dispersi dellostesso reggimento in Russia nel corso dellaSeconda Guerra Mondiale, ma anche sa-crario dedicato ai Caduti della Provincia diAlessandria decorati al V.M.; Tortona ha ri-cordato il Gen. Passalacqua intitolandoglila grande caserma di Corso Alessandria,mentre un’altra caserma con il suo nomeera in Novara. Nel 1893, in sua memoria,presso l’ingresso, fu murata una epigrafecon busto, pregevole opera dello scultoreGoria.
Tale busto è ora misteriosamente scom-parso, vittima, purtroppo, dell’incuria, maanche dell’ingratitudine dei tortonesi.
Prima guerra mondiale
Nel documentato volume dello StatoMaggiore del Regio Esercito La conquistadel Monte Nero troviamo descritta l’epicaimpresa della conquista del Monte Nero,sopra Caporetto, effettuata dagli alpini nellanotte tra il 15 e il 16 giugno 1915. La 35a
compagnia (battaglione Susa), al comandodel capitano Vittorio Varese, superate le dif-ficoltà opposte dal ripido pendio gelato, ir-ruppe di sorpresa dalle nostre posizioni delVrata nel trincerone avversario di quota2.138 e, dopo un furioso combattimento,costrinse i difensori (circa 200, con 12 uffi-ciali) ad arrendersi. Con pari slancio, nono-stante il violento fuoco di reazione delnemico, continuò l’avanzata e riuscì, dopoaspra lotta, ad espugnare la quota 2.133.
Contemporaneamente gli uomini dell’84a
compagnia (battaglione Exilles), al co-
mando del capitano Vincenzo Albarello –preceduto dagli esploratori con alla testa ilvaloroso sottotenente Alberto Picco, chemorì nell’impresa –, con le scarpe fasciatee ognuno sulle spalle un sacchetto di terra,mossero dal Kozliak verso la vetta delMonte Nero (m 2.245). Appena giunti incima del Monte Nero gli alpini si lanciaronoall’assalto travolgendo i difensori e dopoun’aspra lotta corpo a corpo conquistaronola posizione sulla vetta. Tra le Medaglie diBronzo concesse ai superstiti per questaazione c’è il tenente degli alpini Alberto So-linas di Tortona1.
Il sottotenente Luigi Lodi, nato a Novi Li-gure nel 1893, cadde sul Carso il 29 ottobre1915. In un volumetto del 1920 (L’IstitutoSuperiore di Studi Commerciali ai suoi al-lievi morti per la Patria) si legge:
Dai suoi avi, fra cui il garibaldino Bacchi e l’Albertini,morto nelle prigioni dello Spielberg, egli aveva im-parato ad amare la Patria, e perciò si arruolò volon-tario, appena dichiarata la guerra. Dopo averseguito a Modena il corso accelerato per gli ufficiali,partì nel settembre per la fronte come era suo ar-dente desiderio. Di là scriveva al fratello capitano:“[…] Mi sono recato oggi dietro ordine del Comandodi reggimento a riconoscere le trincee dove dovròrecarmi domani mattina all’alba per prendere il co-mando del mio plotone. La posizione è assai battutadal fuoco nemico. Io nutro però grande fiducia nellenostre armi e spero di poter anch’io fare qualchecosa di buono per l’onore del mio reggimento e perla grandezza della mia Patria […]”. Il giorno dopo,ricevuto l’ordine di occupare col suo plotone unatrincea antistante, alla quota 70 delle Cave di Seltz,si spingeva all’assalto […].
Ebbe la Medaglia d’Argento: Ferito ad unpiede continuava a guidare, con ammire-vole slancio, il plotone all’assalto di una trin-cea nemica finché cadde eroicamente pernuova e mortale ferita.
Un altro caduto famoso è Luigi Bailo diSerravalle Scrivia: fu comandante del primoreparto “Sezione Autonoma Ca.300” costi-tuito il 19 agosto del ’15; l’unità aveva treaerei in carico, tra cui il Ca.478 che suscitòcuriosità e meraviglia al punto che varie
personalità, tra cui il Comandante Supremo,generale Cadorna, si recarono apposita-mente al campo della Comina per vederlo.
27
bardamento di Milano3 da parte degli au-striaci avvenuto il 14 febbraio 1916. Decol-larono da Aviano e dalla Comina(Pordenone) dieci bombardieri, tre rientra-rono subito per danni al motore, uno fu co-stretto a scendere in territorio nemico: ilCa.478, di cui Bailo era il comandante, fuintercettato dai micidiali Fokker E (Eindec-ker, ossia monoplani) dotati del nuovo, e se-greto, dispositivo di tiro attraverso l’elica.
A Luigi Bailo fu concessa la Medagliad’Argento: In una lotta aerea colpito mortal-mente a bordo del velivolo da mitragliatriceavversaria, con sublime atto di camerati-smo faceva scudo del proprio corpo all’altropilota, anch’esso ferito, il quale poteva cosìricondurre in salvo l’apparecchio. Lubiana,18 febbraio 1916.
Fu citato da Luigi Barzini sul «Corrieredella Sera» del 23 febbraio seguente e daGabriele D’Annunzio nel suo Notturno,come da Ojetti in D’Annunzio. Amico-mae-stro-soldato (Firenze, Sansoni, 1954).
L’aviatore serravallese Luigi Bailo
Il 18 febbraio 1916, nei cieli sloveni, a 50chilometri da Lubiana, si consumava la tra-gedia aerea che ebbe tra le sue vittime ilnostro serravallese, capitano d’artiglieria,assegnato all’arma aeronautica allora na-scente2. All’altezza di Aidussina (o Arduis-sino), due aerei austriaci attaccarrono lasquadriglia italiana e Luigi Bailo fu dap-prima ferito e poi colpito al cuore. Il capi-tano Oreste Salomone riuscì a riportarel’aereo in Italia, a Gomars, presso Palma-nova, e fu il primo aviatore italiano insignitodi Medaglia d’Oro. L’aereo su cui volavanoera un Caproni trimotore e la missione erastata progettata per una ritorsione al bom-
Riccardo Bajardi, caduto eroicamente a Cima Sief il20 settembre 1917
28
Il capitano Riccardo Silvestro Bajardi diNovi Ligure, a cui è dedicata una via, morìil 20 settembre 1917 al Monte Sief (Col diLana) e gli venne concessa la Medagliad’Oro. Ne parla Robert Striffler nel suoGuerra di mine nelle Dolomiti. Monte Sief1916-1917. Ecco la motivazione della Me-daglia d’Oro: Diede costante esempio dicalma e ordinamento ai suoi soldati. Co-mandante di una compagnia la condussevalorosamente all’attacco di forti posizioninemiche. Ferito, continuò ad avanzare inci-tando i suoi all’ultimo sforzo. Colpito una se-conda volta e mortalmente, si trascinò sullacima conquistata e gettò al nemico l’ultimasfida ed ai suoi l’ultimo appello: Abbiamovinto, avanti ragazzi!
La brigata Reggio (45° e 46° reggimentofanteria) fu citata nel Bollettino di Guerra n°850 del 21 settembre 1917 per l’azione acui partecipò il Bajardi: gli austriaci stavanopreparando sotto le nostre posizioni unagalleria da mina e il II battaglione del 45°reggimento, al fine di scongiurarne il peri-colo, raggiunse con rapido sbalzo l’im-bocco. Gli arditi assalitori ebbero difficoltàa sistemarsi a difesa della posizione con-quistata e furono attaccati dall’artiglieria av-versaria nonché da un violentocontrattacco. Si ritirarono solo dopo averperduto 16 ufficiali e 300 uomini di truppa.
Nel libro di Luciano Viazzi e Arturo An-dreoletti, Con gli alpini sulla Marmolada(pp. 262-263) leggiamo l’importante reso-conto sull’opera del tenente Flavio Rosso diNovi Ligure:
[…] Nel frattempo i minatori italiani che prosegui-vano le perforazioni nel braccio sinistro della galleriaaccertarono che la contro-mina austriaca stava av-vicinandosi rapidamente alla Forcella a Vu (sullaMarmolada, N.d.R.). Se quest’ultima galleria nonaveva potuto impedire l’occupazione da parte degliitaliani, ora poteva far saltare in aria il presidio chela occupava.Il 26 settembre 1917, alle ore 4,30, il tenente FlavioRosso, che sostituiva nel comando di reparto un uf-ficiale rimasto ferito, con una rapida azione riuscivaa prender possesso di un’altra galleria (ovest) au-striaca, dopo aver messo in fuga gli occupanti.Erano trascorse poche ore da questa brillante
azione quando, verso le nove, lo scoppio della po-derosa mina nemica sconvolgeva rovinosamente laForcella a Vu, danneggiando gravemente la galleriada poco occupata dai nostri. Nell’enorme massa dimacerie, trascinata da grande altezza nell’immanevoragine sul Pian d’Ombretta, furono sepolti unaquindicina di uomini del 51° fanteria con il loro co-mandante: tenente Flavio Rosso da Novi Ligure, allacui memoria venne poi decretata una Medaglia d’Ar-gento. Il tenente Gunther Langes, che si trovavanella galleria accanto alla Forcella a Vu, così de-scrive quel cataclisma:“Una grande detonazione fece tremare tutta la no-stra fortezza. Subito dopo l’osservatore delle batterieal Sasso delle Dodici ci domandò telefonicamentese fossimo ancora in vita, poiché sopra di noi si eraaperto come un vulcano, dal quale uscivano nubi difumo e blocchi di ghiaccio, mentre la neve d’intornosi colorava di nero e di giallo per un lungo tratto”.La posizione austriaca sovrastante la Forcella a Vuera completamente devastata dal tiro delle artiglierieitaliane, che avevano smantellato anche la ripidagalleria di ghiaccio che conduceva alla postazioned’artiglieria. Per impedire altre infiltrazioni, gli au-
Flavio Rosso, caduto in combattimento il 26 settem-bre 1917. Il tenente rimase vittima del crollo di unagalleria sul Pian d’Ombrella (poi “Galleria Rosso”),
provocato da una mina austriaca
striaci munirono di cavalli di frisia tutti gli accessidelle loro gallerie, intasandone le estremità rivolteverso la Forcella a Vu con sacchetti di sabbia.Questo combattimento nelle viscere del ghiacciaiopose termine alla lunga lotta per il possesso dellaForcella a Vu, ed entusiasmò le truppe del Seràuta,incitandole a proseguire nell’azione intrapresa. Il ge-nerale F. Porta, comandante della 18a divisione, rife-riva il fatto in questi termini:“Stamane, alle ore 9, la galleria A sbucava nel fondodi Forcella a Vu, rendendo così sicure e permanentile comunicazioni. In onore del prode ufficiale cadutovittima della mina austriaca, ho disposto che la gal-leria in parola, da ora in avanti, venga chiamata Gal-leria Rosso”.
29
e sventolavano bandiere bianche. Franchinivide a lato della linea ferroviaria i due uo-mini mentre la mitragliatrice dal Coni Zugnasparava ancora colpi intermittenti. Accom-pagnato da un soldato egli usci dalla trin-cea e, attraverso i reticolati, andò incontroagli avversari.
Ed ecco, alla lettera, la testimonianza delcapitano tortonese sul seguito dell’episodio:
I due militari che sventolavano le bandiere biancheerano un capitano di Stato Maggiore, elegantementevestito, e un caporal maggiore. Il primo agitava unabandiera bianca regolamentare e il secondo la pro-pria camicia legata ad un palo. Il capitano austriacoevidentemente commosso (si chiamava CamilloRuggera ed era di Trento), mi disse, in tono conci-tato, che i miei avevano sparato sui parlamentari eferito il portabandiera. Aggiunse che aveva ordinedi far recapitare, al più presto possibile, i documentiche aveva in consegna. Gli risposi che avrei fatto cu-rare subito il ferito, ma che non aveva alcun diritto difare appello alle norme internazionali dati i prece-denti noti abusi. A mia richiesta, mi esibì la letteracredenziale di presentazione nonché il documentoda consegnare al nostro Comando Supremo (questofoglio era redatto in italiano e in tedesco). Il porta-bandiera ferito era un caporal maggiore.Bendato il capitano lo feci accompagnare nelle no-stre trincee, a braccetto di due sottotenenti del36.mo Fanteria, scesi dal Coni Zugna mentre io esa-minavo i documenti. Appena il parlamentare fugiunto nei nostri ricoveri, e precisamente al co-mando di una compagnia mitraglieri, ne detti comu-nicazione per telefono al comando della miaDivisione. In attesa, vista la sua eccitazione e com-prendendo il suo stato d’animo, gli feci portare unatazza di caffè che però gentilmente rifiutò dicendo:“Prima debbo fare il mio dovere”. Poco dopo giunseuna motocarrozzetta, guidata da un tenente e feciaccompagnare il capitano al comando del mio bat-taglione, in attesa che giungesse il generale di Divi-sione. Qui Ruggera chiese una limonata che gli fecisubito portare. Si tolse il cappotto, senza dubbio permostrare le numerose sue medaglie. Poco dopogiunse il generale Battiston, e debbo rilevare un par-ticolare curioso; i due ufficiali si trovavano, in quelmomento di fronte e rappresentavano i due esercitibelligeranti, erano entrambi trentini. Appena entrò ilgenerale Battiston, il capitano Ruggera scattò inpiedi e disse: “Signor generale, ho l’onore di presen-tarmi a lei per ordine dei signor generale vonBulow(?), designato membro per un probabile armi-stizio, per consegnare questo documento al Co-mando Supremo italiano”. Battiston, senzastringergli la mano, gli chiese: “Ha i documenti in re-
La Città del Ghiaccio, sulla Marmolada, tenuta dagli austriaci
Da un articolo di Antonino Ronco su«La Casana» traiamo l’episodio che segue:«[…] Il primo contatto tra italiani e austriaci,per le trattative che portarono il 4 novembre1918 all’armistizio di Villa Giusti, ebbe luogoa Serravalle d’Adige, il 29 ottobre 1918 e nefu protagonista il capitano Giuseppe Fran-chini […]», nato a Tortona nel 1882 e dece-duto a Genova nel 1959.
Egli apparteneva alla Brigata Pistoia, 35°reggimento di fanteria, che attendeva inquella mattina il segnale di assalto alle lineeaustriache quando i soldati udirono unosquillo di tromba e videro due figure sen-z’armi che uscirono dalle trincee avversarie
30
gola?” Poi si fece consegnare tutte le carte e, trova-tele in regola, lo fece accompagnare al comandodella 26.ma Divisione.
Fin qui il resoconto del capitano Fran-chini. Intanto il graduato austriaco era statomedicato di una leggera ferita. Dopo le curedisse agli italiani che avrebbe desideratorestare nostro prigioniero. Era italiano anchelui e aveva un fratello prigioniero di guerraa Genova nel forte Castellaccio. Questi gliaveva scritto che si trovava bene. Il deside-rio dei caporal maggiore non poté però es-sere accolto: egli non era infatti prigionierodi guerra e, pertanto, il 30 ottobre ripassavale linee insieme al capitano Ruggera per ri-ferire della missione compiuta.
La sera di quello stesso giorno si presen-tarono davanti alle trincee italiane i noveparlamentari austriaci che dovevano poi fir-mare l’armistizio di Villa Giusti.
Questo racconto, redatto in base alla do-cumentazione fornita dal Prof. Aldo Fran-chini, figlio del protagonista, ad AntoninoRonco, fu pubblicato dal «Secolo XIX» diGenova il 3 novembre 1968, per la ricor-renza dei Cinquantenario della Vittoria e,successivamente, ripreso integralmente dalBollettino del Museo del Risorgimento «Ca-stello del Buon Consiglio» di Trento.
Guerra dʼEtiopia
Per la guerra d’Etiopia facciamo riferi-mento al libro di Nicola Labanca, Posti alsole. Diari e memorie di vita e di lavoro dallecolonie d’Africa (p. 92). Non sono le gestadi un nostro compaesano, ma le vicende diun soldato, Sergio Botta, che si trovava aNovi Ligure nel 1935 nell’imminenza dellapartenza per l’Africa il quale descrive lostato d’animo dei novesi allora.
Manca mezz’ora dalla sveglia ed un sottufficiale incamerata ci scuote dai pagliericci e scandisce adalta voce i nomi di una decina di soldati coi qualisono tra i prescelti. Vestirsi in tutta fretta, fare su tuttoil corredo, colazione anticipata e subito partenza,senza conoscere la destinazione. Forse, si com-menta fra noi, siamo per qualche urgenza nei din-torni ..., e così non si saluta gli amici rimasti, sicuridi rivederci presto. Ci portiamo alla stazione ferro-viaria e qui, dal sergente che ci accompagna si ap-prende di una chiamata con fonogramma di tuttaurgenza, si deve rientrare in sede a Novi. Col primotreno per Novara, Mortara, Alessandria si scende aNovi Ligure che sono circa le 11. Il precipitoso rien-tro al Reggimento fa subito pensare che gatta cicova e infatti, appena al nostro arrivo, quel dubbiocovato in silenzio diventa realtà e apprendiamodell’avvenuto arruolamento per l’Africa Orientaledetto allora per esigenza A.O. Nello stesso giornoversiamo le armi e subito si deve partire per Roma.Radunati nel cortile della Caserma con altri commi-litoni giunti dalle varie Compagnie dislocate, fervonoi preparativi per la partenza. Sono le 20,40 del 10Luglio e il Generale Comandante del Corpo d’Ar-mata di Alessandria, il nostro Colonnello Mazzetti ele più autorevoli autorità politiche e civili dalla pro-
Il capitano Franchini accompagna il capitano au-striaco Camillo Ruggera al comando italiano (Archiviodi P. Malfettani). Franchini fu protagonista del primocontatto fra italiani e austriaci per le trattative che
portarono all’armistizio del 4 novembre 1918
vincia ci porgono il loro saluto augurale. Dopo i varidiscorsi di prammatica il Generale Comandante in-vita a sé a baciare il sottufficiale più anziano e, contale gesto dice di baciare tutti noi uno ad uno. Terminato questo commovente congedo, zaino inspalla, un saluto al Re, un saluto al Duce e con labanda in testa, in fila per tre marciamo verso la sta-zione; sono le ore 21,30. Due fitte ali di popolo schierate lungo la strada ci ac-colgono con clamorosi applausi e battimani. Tutta lacittadinanza è presente al nostro passaggio e tuttihanno un saluto, una parola o un gesto amichevoleper noi. Le ragazze gettano fiori; i giovani agitanocalorosamente le braccia, i più anziani e diversedonne in lacrime ci guardano pietosamente comeloro figli; pensando, forsanche, a qualche loro carogià partito in precedenza. Alla stazione tutta la piaz-zetta è pure gremita di folla e a stento troviamo unvarco per il passaggio. Arriva il treno […] un calo-roso abbraccio ai nostri amici rimasti e si cominciaa salire per occupare i nostri posti. Donne in divisafascista si danno da fare a distribuire sigarette, vino,e vari generi alimentari da farci comodo durante ilviaggio e, poco dopo, ecco il segnale di partenza.Dai finestrini, con le mani protese in commovente sa-luto, risponde una moltitudine svolazzando fazzolettie cappelli con tanto tripudio di entusiasmo da partedei rimasti e dai partenti. Con il cuore pieno di emo-zioni seguiamo quella folla delirante fintanto le tene-bre serali cancellano dallo sguardo quel tributo diaffetto che la cittadinanza ha offerto ai suoi genieri.Riconoscenti, serbando un perenne ricordo vi di-ciamo un grazie sincero, per tanto affetto spartana-mente dimostrato […] e mentre il convoglio siallontana da questo commovente scenario, i nostrianimi piombano nella più cupa tristezza e la mentecorre verso i nostri cari tanto lontani e inconsapevolidi quanto ci succede in questi istanti. Dai nostri postioccupati e così per tutto il convoglio si è spento tuttoquell’entusiasmo provocato da una baraonda collet-tiva ed è calato il sipario per portarci ognuno nellanostra solitudine a meditare a mente fredda la realtàdi questi avvenimenti che turbano ogni senso del-l’animo. Nessuno più parla, eccetto qualche bisbi-glio ed il fruscio che provoca un cerino peraccendere l’ennesima sigaretta da consumarsi pereffimero sollievo, mentre pure inoltra la notte a por-tarci uno stanco dormiveglia.
Seconda guerra mondiale. Guerra dʼAlbania, Grecia e Jugoslavia
Il capitano Aldo Zanotta, nato nel 1903 aNovi, frequentò il corso allievi ufficiali dicomplemento nel 1924, dopo essersi lau-
31
reato in Scienze Economiche a Torino. Fuassegnato al 5° alpini e congedato dopo tremesi. Fu richiamato nel 1939 e inviatopresso il IV settore di copertura della Guar-dia alla Frontiera. Trasferito a domanda nel9° alpini (divisione Julia) raggiungeva la suaunità il 14 dicembre 1940. La motivazionedella Medaglia d’Oro recita4: Comandantedi compagnia alpina, era primo al contras-salto in una forte posizione nemica. Duevolte ferito, tornava a riprendere il comandoe contrattaccava ancora l’avversario supe-riore in forze, riuscendo, con l’esempio econ prodigi di valore, a respingerlo e amantenere la contesa posizione fino a che,colpito a morte, donava la sua giovinezzaalla Patria sulle posizioni conquistate. Quota1.967 di Chiarista e Fratarit (Fronte greco),27 dicembre 1940.
Dal volume Fronte greco-albanese: c’eroanch’io, a cura di Giulio Bedeschi (pp. 92-
L’alpino Aldo Zanotta morì in battaglia, sul fronte greco, nel 1940
32
93), riportiamo la testimonianza del capi-tano Gerolamo Consigliere, II battaglionecomplementi poi 9° reggimento alpini, suAldo Zanotta di Novi Ligure:
Sciolgono tutti i Battaglioni “Valle”. Ritorniamo, per-ciò, a Dronero al nostro Centro di Mobilitazione, persmantellare il nostro Valle Maira. Si deve formare unbattaglione di volontari, del 2° Reggimento, su duecompagnie, per la Divisione Julia che è in Albania.La 1a Compagnia è comandata da me, la 2a dal te-nente Aldo Zanotta, di Novi Ligure (che nel dicembre1940, in un assalto disperato, sotto i reticolati greciverrà falciato, e poi insignito della Medaglia d’oro alV. M.).Il II Battaglione Complementi è comandato dal mag-giore Aquilino Guindani, ottima persona, uno spor-tivo, campione di scherma dell’esercito italiano. Tuttinoi ufficiali, che in precedenza facevamo parte della219a Compagnia, partiamo volontari. Della truppa,circa il 60%, che aveva fatto con me il fronte occi-dentale, vuole seguirmi; e completiamo la 1a Com-pagnia con gli elementi più giovani.Si parte in tradotta per Foggia, e da lì con gli Junkerstedeschi siamo sbarcati ai Pozzi di Devoli (Albania).In cinque giorni di marcia, con freddo pungente emolestati da forte vento, passando per Berat rag-giungiamo i rovesci di quota 457 (settore Vojussa).Purtroppo, i compiti più ingrati toccano sempre anoi, ultimi giunti, e il 28 dicembre 1940 la mia com-pagnia viene posta a quota 897. Trascrivo qui unriassunto del rapporto del combattimento che sisvolse il 30 dicembre 1940 a quota 897:“Verso le 7,30 del giorno 30 dicembre 1940, un for-tissimo tiro artiglierie avversarie, su tutto il fronte delsettore, faceva intuire un attacco a fondo. Il combat-timento andava man mano crescendo di intensità;ma si resisteva ostinatamente. Verso le 9,15 il ne-mico tentò i primi attacchi, e precisamente sul trattodi fronte tenuto dalla compagnia del capitano Con-sigliere. Questi portava immediatamente i propri di-pendenti al contrassalto, mantenendo salda laposizione. Verso le 11 il nemico, avuti sempre mag-giori rinforzi, tentava per altre tre volte di raggiungerele posizioni della Compagnia; ma questa non ce-deva un palmo di terreno e infliggeva all’avversariogravissime perdite. Cadute le posizioni sul fianco si-nistro della 1a Compagnia, questa era minacciata diaccerchiamento. Dietro ordine ricevuto, il capitanoConsigliere seppe sganciarsi e nel ripiegamento, or-dinato e per scaglioni, poté ancora, coi propri uo-mini, contenere la furia dell’avversario cheminacciava di travolgerlo. Il tiro delle artiglierie e deimortai aveva intanto già messe fuori uso parecchienostre armi automatiche; le munizioni e le bombe amano, specialmente, scarseggiavano”.Il sottotenente Bruno Negro, un valoroso, in questa
fase del combattimento, era caduto. Illeso era rima-sto il solo sottotenente Nervi (disperso poi in Russia).Il sottotenente Banderali, ferito, è stato accompa-gnato all’ospedaletto, e il valoroso, entusiasta sotto-tenente Giorgio Camino era ferito gravemente,intrasportabile da una raffica di mitragliatrice allegambe, a un braccio e nel corpo, ma continuavaa incitare gli alpini durante il furioso combattimento[…].
Al tenente Aldo Zanotta è intitolata la viaa ridosso del Viale della Rimembranza eun’aula dell’ex Liceo “Andrea Doria”.
Ernesto Trevisi, «magnifico esempio delle più elevatevirtù militari»
Un’altra Medaglia d’Oro novese è Erne-sto Trevisi la cui motivazione dice5: Giova-nissimo ufficiale pilota da caccia, in pochigiorni di guerra si distingueva per rare qua-lità di volatore e di soldato. Il 13 novembre,partito su allarme, mentre una pattuglia dibombardieri nemici attaccava il proprioCampo, riusciva a raggiungerne uno e ad
abbatterlo in fiamme. Il giorno successivo,levatosi in volo con altro gregario per inter-cettare un’azione di caccia avversari chetentavano di attaccare le nostre truppe im-pegnate in aspra battaglia, li attaccava de-cisamente riuscendo a stroncare le lorointenzioni. Ferito gravemente il gregariodalla reazione nemica e rimasto solo conti-nuava a lottare con sovrumano valore finoall’estremo sacrificio. Magnifico esempiodelle più elevate virtù militari. Cielo delFronte Korciano, 2-14 novembre 1940.
Dal volume di Rino Cossard, 1940-1943.I Diavoli Bianchi, Gli alpini sciatori nella Se-conda Guerra Mondiale. Storia del Batta-glione “Monte Cervino” (p. 135),trascriviamo le gesta di Giacomo Zino, diSerravalle Scrivia, nel settembre 1941:
[…] Ritirandosi da Arza, sotto la pressione conver-gente da tre lati, i reparti avevano perso ogni orga-nicità e al Colle gli sbandati passavano a gruppi ditre, quattro o anche otto o nove, ma non di più. Quila lotta riprese sostenuta dai bersaglieri, ma gli altrierano ormai in rotta e non si fermavano. Al passag-gio del torrente, qualcuno cercò di fermare i fuggitivi:dapprima alcuni sottufficiali del Monte Cervino e poii loro ufficiali, ma era fatica vana. Tra le curve del tor-rente gli sbandati si ammucchiavano in macchie gri-gie che s’ingrossavano per i nuovi arrivi e poiriprendevano restii e compatti la via verso il Colle.Percorrevano cinquanta o cento passi, quando uncolpo di mortaio esplodeva vicino alzando una pe-sante nuvola di fango, e allora si sparpagliavano an-cora come un gregge assalito dai lupi eriprendevano la corsa all’indietro sulle sponde deltorrente. Nel pomeriggio verso le due – raccontaTamburelli – i greci tentarono di sfondare dalla nostraparte. Vennero avanti con balzi veloci e si apposta-rono dietro alcuni muriccioli eretti sul Colle a circaduecento metri da noi. Ne arrivavano in continua-zione, ma quando tentavano di avanzare li ferma-vamo col nostro fuoco. Fu una strage che durò peralcune ore: solo due greci riuscirono a varcare ilColle. Più tardi fummo individuati e, durante la notte,tentarono di sorprenderci, ma l’alpino Giacomo Zinoli respinse a colpi di bombe a mano.Non c’era da farsi molte illusioni: sarebbero ritornati!Gli alpini si preparavano a vender cara la pelle,senza molte speranze di venirne fuori vivi. I greci risalirono per un canalone defilato e com -parvero improvvisamente alla loro altezza, ad uncentinaio di metri di distanza, preparandosi a circon-darli.
33
Un breve e concitato colloquio si svolse fra i tre uffi-ciali presenti sulla posizione.Cossard e Sgorbati chiesero a Crosa: “Cosa fac-ciamo? La responsabilità è tua!”Crosa rispose: “Abbiamo avuto ordine di restare qui,e qui resteremo”; poi, rivolgendosi agli alpini, disseancora “Ragazzi, tirate fuori le bombe a mano!”In quel mentre giunse alle loro spalle un portaordini,il quale – senza avvicinarsi troppo – urlò l’ordine delmagg. Zanelli: “Ritirarsi tutti, senza passare per ilcampo, che è già occupato dal nemico!”. Il portaor-dini, dopo essersi accertato che l’ordine era stato in-teso, si buttò nel canalone dal quale era venuto esparì in un attimo.Non se lo fecero dire due volte: tutti cominciarono aretrocedere lasciando in retroguardia Zino, Tambu-relli e Crosa. Gli alpini scivolarono velocissimi giù peril canalone come su di una taboga: uno andò a finirecon la gamba sinistra in una buca e i compagni so-pravvenuti gli compressero la neve intorno, tanto danon potersi più muovere. Il poveretto si mise ad ur-lare, chiedendo aiuto: Cossard con altri due alpiniriuscì a liberare il malcapitato dalla morsa che lostringeva. – Tamburelli ricorda ancora quei dramma-tici momenti – Prima di poterci infilare in uno dei tanticanaloni che ci avrebbero permesso di proseguireal coperto, dovemmo attraversare uno spiazzo moltobattuto dal fuoco nemico.Passammo intervallati, per ultimo si prese a correresul sentiero in leggera discesa, ma in quel mentreuna raffica di mitraglia ci sollevò la neve intorno.Sentii un urlo: Zino era rimasto ferito e invocavaaiuto. Tentai di risalire la china nevosa ma perdevotroppo tempo e consigliai Zino di buttarsi in bassocon la testa in avanti, cercando di aiutarsi con lemani per raggiungermi. Finalmente ci riuscì, mal-grado fosse stato colpito da due proiettili, uno soprae l’altro sotto il ginocchio destro. Lo trascinai nel ca-nalone, dove perdemmo l’equilibrio e precipitammoentrambi in mezzo alla neve per qualche centinaiodi metri, insieme ad una confusione di zaini e di armi.Anche Crosa, in quel momento, stava trascinandoun ferito lungo quel ripido canalone, segnato da unalunga scia rossastra.Si fermarono quasi in fondo, nel punto in cui c’eraun salto di roccia di alcuni metri e che i feriti non po-tevano affrontare.I greci, frattanto, avevano piazzato un fucile mitra-gliatore sul ciglio superiore del canalone ed avevanocominciato a sparare su di loro.“Signor tenente”, esclamò Tamburelli, “qui ci freganoanche noi!”Crosa cercò allora di convincere i due feriti ad arren-dersi ai greci: “State tranquilli non vi faranno nulla!”.
Un’altra testimonianza del volume a curadi Giulio Bedeschi, Fronte greco-albanese:
34
c’ero anch’io (pp. 192-193), è quella delsergente Luigi Tamburelli, 1a compagnia,battaglione sciatori Monte Cervino, sempresu Giacomo Zino, nel febbraio 1941:
[…] Era un continuo arrivare, e noi ad ammazzarli.Fu una strage che durò per alcune ore; un mio alpinonotò che solo due greci riuscirono a varcare il Colle;più tardi i greci si accorsero dove eravamo e in not-tata tentarono di farci visita ma le bombe dell’alpinoZino di Serravalle Scrivia ne ebbero ragione.Al mattino presto arrivò un alpino; mi portava l’ordinescritto di ripiegare sulle posizioni di partenza. Ci pre-parammo, partimmo, facemmo il percorso in alto,sulla neve, perché le nostre tute bianche ci nascon-devano meglio.Prima di poterci infilare in uno dei tanti canaloni checonoscevamo, e da lì proseguire al coperto, si do-veva attraversare un pendio innevato e molto sco-perto. A intervalli passammo. Zino penultimo, presea correre sul sentiero in piano; io, con gli sci, mi but-tai in leggera discesa; a un tratto una rabbiosa raf-fica di mitraglia mi sollevò la neve attorno. Un urlo:Zino, ferito, mi chiamava. Tentai di risalire ma mi ac-corsi che perdevo troppo tempo; consigliai alloraZino di buttarsi in basso con la testa in avanti, spin-gendosi con le mani. Finalmente ci riuscì; le pallot-tole grandinavano e la mia non veniva; mi caricaiZino sulle spalle perché era stato colpito da due pro-iettili, uno sopra e l’altro sotto il ginocchio destro; dicorsa mi diressi nel canalone dove persi l’equilibrio;precipitammo entrambi in mezzo alla neve, pensoper un qualche centinaio di metri. Lo persi di vista;vennero in nostro aiuto altri alpini e quelli della mili-zia; assieme ad altri feriti, Zino venne lasciato in unatenda molto più in basso in attesa dei portaferiti;questi, nel tentativo di recuperarli, vennero presi afucilate dai greci, con altre vittime. In serata i grecifecero una puntata in avanti e all’improvviso giun-sero a far visita alla tenda dei feriti; fecero loro capireche non potevano portarli via; potevano solo dare ilcolpo di grazia se lo volevano, quelli lo rifiutarono.Nel pomeriggio, aiutato dai miei alpini in quanto zop-picante pur la battuta di un ginocchio contro unmasso, raggiunsi la compagnia e informai Chiara deiferiti; Chiara, verso le tre del mattino, con alpini delsecondo plotone e con portaferiti riuscì a recuperarlidalla terra di nessuno (Giacomo Zino nel 2008 vi-veva ancora a Serravalle Scrivia).A completamento di quanto detto, aggiungo che inquel canalone era un precipitare di uomini, di zainie armi, trasportati a valle dalla neve fresca che, stac-catasi dall’alto, rovinava con forza su di noi. Ricordoche a metà di questo canalone vi era un salto di al-cuni metri; questo mi provocò varie contusioni, una,brutta, al ginocchio.
Ecco invece un estratto da Giulio Bede-schi, Fronte jugoslavo-balcanico: c’ero an-ch’io, del geniere di Novi Ligure Gino Corteche descrive le sue avventure in Albania(pp. 706-707) e riporta anche:
[…] Avevo con me lo zaino (l’8 settembre 1943) ab-bastanza gonfio con qualche scatoletta e mi inco-raggiava la presenza dei miei concittadini AldoBorghero e Massa. La mattina del 15 settembre inuna situazione caotica per un’accanita sparatoria tratedeschi e ribelli riuscii a fuggire insieme a moltissimialtri militari coi quali, ci avevano detto, saremmo do-vuti andare a finire nei campi di concentramentodell’Europa centrale. Per lo scoppio della polverieradi Draskovizza, avvenuto verso sera, perdette la vitail mio amico Massa […].
Oltre alla testimonianza di Corte, sullostesso libro troviamo le memorie e le cita-zioni di altri reduci su l’autiere GiuseppeGubin (pp. 209-210, 684-685) e del sottote-nente Renato Gatti (pp. 209, 210, 682, 686e 706), entrambi di Novi Ligure. Quest’ul-timo pubblicherà nel 1973 le sue espe-rienze in Le croci sul Golico (Roma, AngeloSignorelli editore).
Nel 1941 il tenente Luigi Lualdi di Gaviera nel deserto libico (ebbe la Medaglia diBronzo) ed è citato nel libro di memorie delsuo comandante Salvatore Castagna, La di-fesa di Giarabub:
[…] Sempre deciso a tenere a distanza il nemico,all’alba del 17 marzo mandai il tenente Lo Mazzi aEl Aamra, per ricollocarvi il posto di osservazione edi allarme. Con lui inviai il tenente del genio Lualdi,che doveva rimettere in efficienza la linea telefonica(…) Il gruppo alle dipendenze del tenente Lualdi, di-stante un centinaio di metri dal tenente Lo Mazzi,tentava di unirsi a questi, ma, bersagliato dalle mi-tragliatrici, non poteva muoversi. Rimase sul posto,difendendosi con l’arma individuale (…) Il gruppo alcomando del tenente Lualdi, che aveva inutilmentetentato di unirsi ai compagni, fu pure travolto e cat-turato […].
Seconda guerra mondiale. Guerra di Russia
Del capitano Aldo Massiglia, classe1910, 38° reggimento fanteria, divisione Ra-
venna, nato a Novi Ligure, riportiamo la mo-tivazione della Medaglia d’Argento: Coman-dante di compagnia sistemata a difesa,manifestandosi improvvisamente un at-tacco dell’avversario, prontamente reagivae riusciva ad arginare l’irruzione inchio-dando il nemico a pochi passi. Sotto violen-tissimo fuoco dei mortai che producevanoulteriori perdite, benché gravemente ferito,non desisteva dall’incitare alla lotta i dipen-denti con la voce e con l’esempio. Colpitouna seconda volta da scheggia di bomba,cadeva sul campo; ma la Sua eroica resi-stenza consentiva ai rincalzi di giungere ericacciare l’avversario. Krassno Orecowo(Russia), 11 dicembre 1942.
35
[…] Quella notte sul venerdì 11 dicembre 1942 nes-suno ha dormito a Krassno Orekovo […] Le senti-nelle che rientrano poco prima delle 5 del mattino,col pastrano ridotto ad uno scudo di ghiaccio, nonhanno nulla da riferire e questo preoccupa il capi-tano Aldo Massiglia, che sta bevendo un caffè bol-lente nel ricovero interrato situato alle spalle delvillaggio dove si trova il comando della sua compa-gnia, l’11a, III battaglione […] Quel silenzio significasoltanto che i russi stanno per attaccare […] Alle5,30 la fanteria russa esce dai boschi e attraversacorrendo il letto ghiacciato del fiume. Urlano “Hurrà,davai, davai”, 400 uomini si riversano sui capisaldidel battaglione. Ne sommergono due, ma poi le mi-tragliatrici li bloccano a 50 metri dal comando dellacompagnia. Soltanto allora il capitano Massigliatrova il tempo di chiamare al telefono da campo ilcomandante del battaglione. Al maggiore Mattielloche gli risponde dall’altro capo del filo grida: “Cisiamo è un attacco in piena regola” […] Dal 20 al 24agosto e l’11 e 12 settembre la divisione era stataattaccata due volte. In agosto i russi avevano occu-pato Krasno Orekovo buttandosi anche contro laquota 220 al centro dell’ansa, da cui dominava ilfronte, occupandola e riprendendola. Il tenente DeCarlini, con la sua 11a compagnia, e il tenente Per-petuo Robotti della 9a erano rimasti sull’altura permolte ore accerchiati. Li aveva liberati un contrat-tacco del capitano Massiglia e del tenente colonelloRenato Lupo […].
Al capitano Massiglia è stata dedicatauna via a Novi Ligure.
Ulteriore testimonianza della campagnadi Russia, riferita ai nostri soldati, la tro-viamo in Giulio Bedeschi, Fronte Russo,c’ero anch’io (vol. 2, pp. 739-743), dove ilfante Angelo Viganò di Novi Ligure, appar-tenente al CDXLI Battaglione TerritorialeMobile, descrive il suo arrivo in zona diguerra nel 1942 e l’inizio della ritirata il 15gennaio 1943.
Nel febbraio 2014 è uscito il libro diGiampaolo Pansa Bella ciao. Controstoriadella Resistenza. A pagina 137 c’è il ritrattodi un partigiano “bianco” novese:
[…] Uno di questi era Mario Bogliolo, un geometradi 28 anni, nato a Novi Ligure nel 1916 da una fami-glia di agricoltori. Richiamato alle armi nel 1939come goniometrista nell’artiglieria, era stato man-dato a combattere su tutti i fronti possibili: in Francia,in Jugoslavia, in Russia. Qui era rimasto dal febbraio
Copertina del volume che riporta le gesta del capitano Massiglia
Egli è citato in Piero Fortuna e RaffaelloUboldi, Il tragico Don (pp. 7, 8, 42):
36
1942 al marzo 1943 quando l’avevano promossosergente maggiore. L’ultimo fronte era stato quelloin Sicilia. All’armistizio aveva gettato la divisa del-l’esercito. Per riprendere strada di casa, convintoche non avrebbe più dovuto combattere. Invece in-contrò Mauri6 e lo seguì. Bogliolo era un bel giovane,alto, di struttura atletica, svelto di testa e di gambe,resistente alla fatica. Nelle Langhe scoprì di essereun partigiano nato, risoluto, tenace qualche volta ir-ruento, però capace di grande calma nei momentidi difficoltà. Quando l’aria si faceva spessa, e c’erail rischio di perdere la testa, lui cavava di tasca unamela e cominciava a rosicchiarla, adagio adagio.Gli uomini lo seguivano tranquilli perché sapevanoche Bogliolo non li avrebbe mai portati al disastro.Era anche il classico sergente: non amava le zaz-zere lunghe, barbe incolte, gli scherzi da caserma.E spesso svelava il lato rude del carattere, poco ac-comodante, severo con i partigiani che sgarravano.A differenza di Mauri, voleva restare distante dallapolitica. Diceva: “Combatto un partito, quello fasci-sta repubblicano. E non voglio essere invischiato inun’altra parrocchia” […].
Questa breve rassegna di citazioni dimo-stra, al di là di ogni considerazione retorica,la partecipazione dei giovani dell’Oltre-giogo alle guerre italiane. Mancano da que-sto studio i conflitti risorgimentali del secoloXIX comprese Dogali e Adua.
Gli studi di Egidio Mascherini e France-sco Melone, comparsi su «Novinostra», o diEnrico Mazzoni, su «In Novitate», in varianni (vedere bibliografia), ci permettonoinoltre di conoscere altre figure di novesiche si sono distinti in guerra o nella carrieramilitare.
1 SMRE (1921).2 ALLEGRI (1988).3 VIGNA (2001).4 FIGARA (1990), p. 251.5 MELONE (2001).
Il fante Angelo Viganò è citato in questo libro, inseritonella documentata serie curata da Giulio Bedeschi
Giampaolo Pansa, in Bella ciao, fa un bel ritratto delpartigiano Mario Bogliolo
6 Enrico Martini, nato a Mondovì nel 1911, ufficiale del 3°reggimento alpini.
Bibliografia ALLEGRI ROBERTO, Luigi Bailo, eroe dannunziano, «Novino-
stra», n. 4, 1988ANDREOLETTI A., VIAZZI L., Con gli alpini sulla Marmolada,
Milano, Mursia, 1977BEDESCHI GIULIO, Fronte greco-albanese: c’ero anch’io, Mi-
lano, Mursia, 1977BEDESCHI GIULIO (a cura di), Fronte russo: c’ero anch’io, vol.
II, Milano, Mursia, 1983-, Fronte jugoslavo-balcanico: c’ero anch’io, Milano, Mur-
sia, 1985BENSO ROBERTO, Alpin fa grado, Gruppo Alpini di Novi Li-
gure, Novi Ligure, 2011CASTAGNA SALVATORE, La difesa di Giarabub, Milano, Lon-
ganesi & C., 1967COSSARD RINO, 1940-1943. I Diavoli Bianchi, Gli alpini scia-
tori nella Seconda Guerra Mondiale. Storia del Batta-glione “Monte Cervino”, Milano, Mursia, 1984
FIGARA AROLDO, Elementi per una storia della Guardia allaFrontiera (GAF), Livorno, Tipografia Stella del Mare,1990
FORTUNA PIERO, UBOLDI RAFFAELE, Il tragico Don, Mondadori,Milano, 1980
GATTI RENATO, Le croci sul Golico, Roma, Angelo Signorellieditore, 1973
LABANCA NICOLA, Posti al sole-Diari e memorie di vita e dilavoro dalle colonie d’Africa, Rovereto, Museo StoricoItaliano della Guerra, 2001
L’Istituto Superiore di Studi Commerciali ai suoi allievi mortiper la Patria, Genova, Stab. Tip. G.B. Marsano, 1920
MASCHERINI EGIDIO, Silvestro Bajardi, Medaglia d’Oro al
37
Valor Militare nel cinquantesimo della sua morte, «No-vinostra», n. 3, 1967
MAZZONI ENRICO, Una Medaglia d’Oro. Antonio Ferrari, Ge-nerale dei Carabinieri, «In Novitate», n. 12, 1991
MELONE FRANCESCO, Un alpino del secolo scorso: il gene-rale Giacomo Rebora, «Novinostra», n. 3, 1988
-, Un casato novese: i Gazzana Priaroggia, «Novinostra»,n. 1, 1991
-, Ernesto Trevisi, Medaglia d’Oro novese, «Novinostra»,n. 2, 2001
-, Toponomastica cittadina. Via Aldo Massiglia, Medagliad’Argento al Valor Militare alla memoria, «Novinostra»,n. 3, 2002
-, Francesco Carenzi: un novese comandante generaledell’Arma dei Carabinieri, «Novinostra», n. 3, 2004
-, Un novese caduto nella battaglia di Lissa, «Novinostra»,n. 1, 2009
PANSA GIAMPAOLO, Bella ciao. Controstoria della Resistenza,Milano, Rizzoli, 2014
PEDEMONTE SERGIO, Han fatto la guerra, Busalla, BrunoGuzzo Editore, 2003
PEDEMONTE SERGIO, POGGIO PAOLO, Caduti e decorati di Co-muni dell’Oltregiogo: una ricerca, «In Novitate», n. 32,2001
-, I caduti militari di Novi L. e Tortona dal 1936 al 1947, «InNovitate», n. 33, 2002
RONCO ANTONINO, 1918: bandiera bianca austriaca tra i re-ticolati del Trentino, «La Casana», n. 3, 2008
STATO MAGGIORE DEL REGIO ESERCITO (SMRE)-Ufficio Storico,La conquista del Monte Nero, Roma, Stab. Poligraficoper l’Amministrazione della Guerra, 1921
STRIFFLER ROBERT, Guerra di mine nelle Dolomiti. Monte Sief1916-1917, Trento, Edizioni Panorama, 2000
VIAZZI LUCIANO, ANDREOLETTI ARTURO, Con gli alpini sullaMarmolada 1915-1917, Milano, Mursia, 1977
VIGNA ACHILLE, I Caproni nella Grande Guerra, «Storia Mi-litare», n. 91, aprile 2001