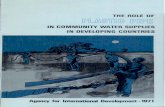A. Bettarini Bruni, P. Trovato, Dittico per A. Pucci. Filologia italiana, 6, 2009, 81-128 (it...
Transcript of A. Bettarini Bruni, P. Trovato, Dittico per A. Pucci. Filologia italiana, 6, 2009, 81-128 (it...
Direttori · EditorsSimone Albonico (Lausanne) · Stefano Carrai (Siena)
Vittorio Formentin (Udine) · Paolo Trovato (Ferrara)
*
Comitato di lettura · RefereesGino Belloni (Venezia) · Saverio Bellomo (Venezia)
Lucia Bertolini (Chieti-Pescara) · Guido Capovilla (Padova)Paolo Cherchi (Chicago) · Claudio Ciociola (Pisa, «Normale»)
Luciano Formisano (Bologna) · Giorgio Inglese (Roma, «La Sapienza»)Guido Lucchini (Pavia) · Livio Petrucci (Pisa)
Marco Praloran (Lausanne) · Brian Richardson (Leeds)Francisco Rico (Barcelona) · Claudio Vela (Cremona-Pavia)
Massimo Zaggia (Bergamo) · Tiziano Zanato (Venezia)
*
Redazione · Editorial AssistantFabio Romanini (Novedrate, e-Campus)
*
«Filologia italiana» is a Peer-Reviewed Journal
*
Per la migliore riuscita delle pubblicazioni si invitano gli autori ad attenersi, nelpredisporre i materiali da consegnare alla Redazione ed alla Casa editrice, alle norme
specificate nel volume Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali,Pisa-Roma, Serra, 20092 (ordini a: [email protected]).
Il capitolo Norme redazionali, estratto dalle Regole, cit., è consultabileOnline alla pagina «Pubblicare con noi» di www.libraweb.net.
DITTICO PER ANTONIO PUCCI
Anna Bettarini Bruni · Paolo Trovato
i.
DI ALCUNE EDIZIONI RECENTIDI ANTONIO PUCCI, DEL CODICE KIRKUP
E DELLA CLADISTICA APPLICATAALLA CRITICA TESTUALE
Paolo Trovato*Università di Ferrara
La filologia redazionale […] non è, per intenderci, lafilologia del codex optimus; e naturalmente non prescinde dall’esperienza e dagli strumenti della piùaffinata tecnica ricostruttiva. Solo che quell’espe-rienza va trasferita entro una nuova realtà […], questi strumenti hanno bisogno di essere riadattatiai nuovi oggetti e alle nuove esigenze.De Robertis 1961
1.er cominciare, due notizie: una buona e l’altra cattiva. La buona è che – grazie allaripresa di interesse per i cantari e il Pucci suscitata dal Convegno di Montreal del 1981
(Picone, Bendinelli Predelli 1984) e confermata dal Convegni gemelli di Montreal 2004(Bendinelli Predelli 2006) e Zurigo 2005 (Picone, Rubini 2007) – l’intero cantiere edito-riale pucciano, bloccato da decenni, si è rimesso in movimento. Renzo Rabboni ha pro-curato un’edizione critica dei Cantari di Apollonio di Tiro. Elisabetta Benucci ha edito ilcantare di Madonna Leonessa e il Bruto di Bertagna. Franco Zabagli ha riesumato il Gismi-rante. Alessandro Bencistà ha riproposto, pur se in edizione divulgativa, recuperandolida edizioni sette-, otto- e primo novecentesche, il sirventese sull’Alluvione dell’Arno nel1333 e altre «storie di un poeta campanaio» (le Proprietà di Mercato Vecchio, il serventese Perricordo delle belle donne, il Contrasto delle donne, la canzone della vecchiezza, le Noie ecc.).Ute Limacher-Riebold ha pubblicato il serventese Onnipotente re di somma gloria. AttilioMotta e William Robins hanno fornito non una, ma due edizioni della Reina d’oriente.1
La cattiva notizia è che, a quanto pare, nessuno degli editori si è preso la briga di sottoporre a uno dei nostri bravi paleografi né a uno degli ormai numerosissimi storicidella lingua italiana in attività, per un esame approfondito delle parti di loro compe-
* [email protected] Si rinvia rispettivamente a: Rabboni 1996, da integrare con l’articolo-recensione di Motta 1998; Be-
nucci 2002a; Benucci 2002b; Zabagli 2002; Bencistà 2006; Limacher-Riebold 2007; Motta, Robins 2007.
«filologia italiana» · 6 · 2009
P
82 paolo trovato
tenza, il ms. già appartenuto a Seymour Kirkup, ora N.A. 333 della Biblioteca Naziona-le di Firenze (= K), che è latore della maggior parte delle opere in versi del Pucci e perquesto è stato giudicato, non senza buone ragioni, da uno studioso di rango come Mor-purgo, «fondamentale per l’edizione delle rime pucciane».1 Nessuno, con l’eccezione diMotta, è riuscito a risalire – oltre che alle descrizioni del ms. fornite da Jackson 1910,Morpurgo 1912, McKenzie 1931 – alla notevole scheda contenuta nel catalogo della Mo-stra di codici romanzi fiorentina del 1957 (anonima, ma da attribuire alla cara memoria diIgnazio Baldelli, allora trentatreenne e però già molto scafato).2
2.
Ben inteso, come rivela la numerazione antica, il ms. Kirkup (cart., di cc. ii, 61, ii, scrit-to su 2 colonne da 2 copisti) è mutilo per almeno un terzo rispetto all’originaria consi-stenza. Mancano infatti le cc. 1-16 (dove, oltre alle 58 ottave mancanti della Reina d’orien-te, rimane spazio nelle cc. iniziali per un poema delle dimensioni del Gismirante). Di lìin avanti si rileva la seguente distribuzione del contenuto e delle mani:3
1 Morpurgo 1912, p. vi. Sullo scrupolosissimo Morpurgo, Stussi 1970 (1982), specialmente pp. 106-7 enota 47; Stussi 1973 (1999).
2 Le descrizioni più accurate sono quelle di Morpurgo 1912 (con un facsimile); Baldelli 1957 (pure conun facsimile); Rabboni 1996, pp. xii-xiii; e Motta (in Motta, Robins 2007, pp. xlii-xlvi, da integrare conlo spoglio linguistico di pp. cxv-cxlviii).
3 Per ragioni di tempo non ho avuto modo di esaminare direttamente K. Poco male perché in que-sto modo ho potuto avvalermi dell’aiuto di colleghe di me molto più competenti, Gabriella Pomaro eAnna Bettarini Bruni, che ringrazio di cuore. In particolare, la distinta a testo, che integra e corregge ledescrizioni di Jackson, Morpurgo e Motta, riproduce una scheda molto analitica fornitami con grandecortesia dalla Bettarini Bruni.
Cc. Contenuto Note (rubriche, ecc.)
1r (17r)-2r (18r) Reina d’oriente; mano ·copia da ii 9 5 a ii 39 4.
Rubrica Chomincia I chantarj della Reina do-riente di mano Á; sopra al limite del marginechomicia el chantare della reina duriente di unamano rozza e incerta (‰).
2v (18v)-8v (24v) Reina d’oriente; mano ‚da ii 39 5 fino alla fine.
Dopo ogni cantare (ii 3ra, iii 6ra, iv 8vb)Ame(n), di mano ‚.
9r (25r)-11r (27r) Bruto di Bretagna; mani‚, · e di nuovo ‚.
Rubrica Brutto di brettangnia di mano Á all’in-terno di cornice, sopra un’altra della stessamano, poi cassata, che ha l’unica differenzagrafica in bretangnia; a fianco bruto di breta-gnia di mano ‰. All’interno del testo la mano‚ scrive Bruto di Berttagna, ma la forma del nome con la doppia t è anche di questa ma-no e nettamente prevalente (nove casi + unprutto contro a un bruto).
La mano ‚ copia le ottave 1-8; subentra poia 9v la mano · che scrive fino a rigo 30 di 11ra(ottave 9-40); sèguita ‚ che completa la carta(ottave 41-44).
dittico per antonio pucci - i 83
Mancano quindi le cc. 34-48 (che avranno contenuto precisamente i 3 cantari finali del-l’Apollonio e le prime 45 ottave di Madonna Lionessa). Segue:
Cc. Contenuto Note (rubriche, ecc.)
11v (27v), 12r(32r)-13v (33v)
Apollonio di Tiro, cant. iott. 8, cant. ii ott. 25-50,cant. iii ott. 1-4; mano ‚.
Rubrica Chomincia p(r)imo chantare dapolloniomano Á, rubrica precedente di mano nonidentificata Apolonio dj tiro preceduta da segno di richiamo (croce), mano ‰ chantaredapollonio, c. 13va explicit di mano Á: finito Ilsechondo chantare dappollonio / di Tiro.
Cc. Contenuto Note (rubriche, ecc.)
14ra (49r) Madonna Lionessa(ott. 46-49); mano ‚.
Alla fine Ame(n) ame(n) ame(n), di mano ‚.
14rb (49r)-15vb (50v) Proprietà di MercatoVecchio; mano ‚.
Rubrica di mano ‚ Mercatto vechio; explicit: diq(u)esto anttonio pucj fu poetta | (cristo) viguardi senp(r)e i(n) vita chetta, segue Amen trevolte.
16 ra (51r)-18rb (53r) Noie; mano ‚. Rubrica di mano ‚ Noye. Explicit: Antonio pucjne fu dicitore | ghuardiuj senpre (cristo) saluatore
18vb (53v)-20ra (55r) Ballata della guerradi Pisa; mano ‚.
Didascalia di mano Á che ingloba quella di ‰(questa tra parentesi uncinate): Chanzone de[ripassata da Á su ‰] ‹lla guerra di pisa› | chon-fortando luccha, Ho luchesi pregiatti. SegueAme(n) due volte; segue di mano Á: finita unachanzone della guerra di pisanj e di lucha Amen.Quindi Amene ripetuto 6 volte di mano Á,metà colonna bianca.
20rb (55r)-25va (60v) Contrasto delle donne;mano ‚.
La carta 24r è scritta nella mezza colonna a,segue l’avvertenza di mano Á: volgi allaltrafaccia di sotto; la colonna b è bianca, 20ra bian-ca, una mano del secolo xv vi scrive in altodue terzine dantesche (Inf. xxiv 46-51); sullacolonna b continua il testo, segue ame(n) trevolte, mano ‚.
25va (60v)-42vb (77v) Cantari dela guerra diPisa; mano ‚.
Didascalia di mano ‚ distanziata dal testoche precede e seguita da spazio bianco Anto-nio puci p(er)la ghuera che | sichomincio tra pi-sani e fiore(ntini) | p(er) piettra buona la q(u)alep(er) | lipisani fumolto rea nel mo|do che udret-te a paso a paso | cio che aduene che notabile | fo-se dise chosi chome udre|tte nela partte di q(u)a.
84 paolo trovato
Cc. Contenuto Note (rubriche, ecc.)
Rubriche di mano Á: 25vb p(r)imo chantare djpisa, alla fine 28ra segue Ame(n) tre volte, ma-no ‚; 28rb sechondo chantare dj pisa, alla fine a30va due volte Ame(n) mano ‚; 30 vb terzochantare dj pisa, finisce a 32vb segue Ame(n)tre volte, mano ‚; 33ra q(u)arto chantare dj pisa, alla fine 34vb segue Ame(n) tre volte, ma-no ‚; 35ra q(u)into chantare dj pisa, segue a37vb Amen tre volte, mano ‚; 38ra Sesto chan-tare di pisa, segue 40va Ame(n) tre volte, ma-no ‚; 40vb Settemo chantare dj pisa, segue42vb Ame(n) due volte, mano ‚.
43r (78r)-46ra (82r) Serventese sulla pienadell’Arno; mano ‚.
Rubrica di mano ‚ diluvio che fu i(n) firenze adjiiij dj nouenbre MCCCXXj fatto p(er)antonio pu-ci: Nouelo s(er)mintese lagrimando (strapponella carta che impegna 2/3 della colonna bsul retto di 43 e della colonna a sul verso, al-la fine del testo Ame(n) due volte, mano ‚.
46ra (82r)-47ra (83r) Serventese delle belledonne di Firenze;mano ‚.
Didascalia di mano ‚ a 46r (82ra), seguita dauno spazio bianco: Anttonio puccj p(er) Ricor-do dele | bele done cherano i(n) firenze | nelmcccxxv nefe ilsegue|ntte s(er)minttese chescritto di q(u)a: Legiadro s(er)mintese pien da-more. Alla fine Ame(n) due volte, mano ‚.
47rb (83r)-48vb (84v) Serventese sullacarestia; mano ‚.
Didascalia di mano ‚: Charastia che fu i(n) fi-renç[e] mcccxlvi, I p(r)iegho giesu (cristo) oni-potentte. Segue il testo la firma antonio puci.
48vb (84v)-51va (87v) Serventese sulla peste;mano ‚.
Didascalia di mano ‚ a 48vb: sieghue dela mor-ttalitta che fu | i(n) firenze nel mcccxlviii | ep(er)o anttonio puci nefelseghue|ntte s(er)mint -tese e dise chosi. Metà colonna è lasciata inbianco, il testo inizia sul retto della carta suc-cessiva Ho giesu (cristo) che sopra la chrocie, al-la fine del testo antonio puccj.
51va (87v)-52vb (88v) Ballata per la cacciatadel Duca d’Atene;mano ‚.
Didascalia di mano ‚: Anttonio pucci p(er)ladetta chagione | q(uand)o fu chaci[a]tto ilduchane fe la se|guentte chanzone e dise cosi. Il testoinizia a 51vb: Viua laliberttade. Alla fine il ri-tornello è scritto dopo amen di mano ‚.
52vb (88v)-53vb (89v) Serventese per la perditadi Lucca; mano ‚.
Didascalia di mano ‚ in fondo alla colonna52vb: Come lucha si p(er)de ramaricha|ndosi fi-renze anttonio pucj di|se chosi. Il testo inizia a53ra: Nuouo lamento dj pietta rimatto, segueAnttonio puccj.
dittico per antonio pucci - i 85
Cc. Contenuto Note (rubriche, ecc.)
53vb (89v)-56rb (92r) Serventese sull’acquistodi Lucca; mano ‚.
Didascalia di mano ‚ a 53vb: Anttonioq(uand)o ifiorenttinj conp(er)a|ro lucha dames(er) mastino ne | fe ilseguente s(er)minttese |dise chosj. Segue il testo: honipottentte re di so-ma ghloria; explicit: al uostro onore | Antoniopuci ne fu dicitore.
56rb (92r)-57va (93v) Serventese al Comune;didascalia e il testo dimano ‚.
Didascalia di mano ‚ a 56rb: Volendo antoniopuci chonsiglare | ilchomune suo p(er) cierttechose | che apariano p(er) prestanze e seghe ep(er) aparechiamentto doste ne | fe il p(re)senttes(er)minttese che siguira | di q(u)a e dise chosimcccxli adj p(rim)odj nouenbre il testo iniziasul verso: De uero saluattor figliuol didio segueAnttonio pucj ilfe.
57vb (93v)-58vb (94v) Serventese sulla presadi Lucca, mano ‚.
Didascalia di mano ‚: mcccxlii adj ‹p(rimo)dj nouenbre› xxviij dj magio (interlineare)a|nttonio pucj chonsiderando che | mes(er) ma-lattesta chapittano di ghue|ra alucha pefioren-ttinj erasta|tto q(ua)rantta dj aostte enonaue|uafatto nula eragionandosi | di far pascie copisaeachuj pia|cea e achuj no(n) espicialmentte | pa-rendone male aluj ne fe | il p(r)esentte s(er)min-ttese edisechosi: Degloriosa vergine maria SegueAnttonio puci ilfe.
58vb (94v)-59vb (95v) Serventese sulla vittoriadi Piero Rosso a Padova; mano ‚.
Didascalia di mano ‚: Anttonio pucj auendosenttitto si|chome mes(er) piero roso ebe vi|tto-ria a padoua ne fe ilsegue|ntte s(er)minttese e di-se chosi Al nome sia deluer figluol didio segueAnttonio pucj ilfe. 59vb (95v)-61ra Canzone perFirenze; mano ‚. Didascalia di mano ‚: Volen-do anttonio pucj brieue | mentte rachonttare tut-ti glista|tti che firenze auea muttattj a | suo dj nefe laseguentte cha|nzone e dise chosi aggiuntauna didascalia di mano Á chanzone morale Fi-renze q(uand)o tueri fioritta.
Carte fortemente deteriorate e in granparte mancanti; la canzone finisce probabil-mente a c. 61r perché sul verso ci sono trac-ce di scritture diverse di mani non identi-ficate rispettivamente vicino al marginesuperiore e verso i tre quarti della carta (pa-role solo parzialmente ricostruibili).
86 paolo trovato
Ritorniamo sui dati fin qui agli atti, cercando di ‘lavorarli’ tenendo conto anche del-le indicazioni di Bettarini Bruni e Pomaro. Il codice è opera di due copisti, · e ‚ (manoprincipale, pur se «inelegante e rozza», della sezione pucciana di K).
L’omogeneità della filigrana, rilevata da Jackson 1910 e confermata da Morpurgo eMotta, suggerirebbe che i copisti disponessero di un vecchio stock di carta liocorno, simile a Briquet nº 9926, riscontrata a Firenze, Ravenna e Perugia tra il 1373 e il 1380 (vediperò il § 4), ovvero che da subito avessero stabilito di copiare per intero il perduto anti-grafo di K. «La rilegatura moderna nasconde la fascicolazione originaria», che – a giu-dizio di Motta – «può aver alternato fascicoli di 12 e 4 oppure di 10 e 6 carte»; tuttavia,in un quadro del genere, ci si aspetterebbe una fascicolazione almeno tendenzialmenteregolare, ossia (prevalentemente) in quaderni.
Se davvero, come pare a Motta, la mano · avesse scritto sul margine superiore di c.17r «Chomincia i chantari della reina d’Oriente», ciò implicherebbe (come avvertito daMorpurgo) che la prima ‘mutilazione’, cioè la caduta delle prime 16 carte, fosse avve-nuta poco dopo il lavoro di copia. Tuttavia, mentre Motta assegna anche le «annotazionisul margine superiore di c. 1r (17r)» alla mano ·, Morpurgo attribuisce la nota «in capoalla carta 17a, che oggi è la prima», a «due diverse mani del principio del secolo xv». Suuna linea vicinissima a quella di Morpurgo, Anna Bettarini Bruni riferisce a ‚ solo unaminima parte delle didascalie e assegna quelle in questione a due mani diverse e evi-dentemente più tarde, ma ancora quattrocentesche, Á e ‰.1
In conclusione, come si ricava dalla tavola appena presentata, · sarà anche più esper-to nella scrittura, ma ha una parte del tutto subordinata perché:
a) le rubriche non sono sue, nemmeno quella iniziale che ha fatto pensare ad altri auna sua gestione del manoscritto acefalo. A parte gli interventi posteriori di Á o le sporadiche intitolazioni dell’altra mano incertissima e acerba, è ‚ che gestisce il codicein ogni sua parte;
b) la stessa mise en page di · è meno organizzata: mentre la mano ‚ fa coincidere la fi-ne della colonna col completamento dell’ottava in numero sempre uguale (4ª colonna),· procede senza progetto.
3.
Come si è detto, la datazione di K (la parte pucciana di un ms. contenente anche il Filostrato di Boccaccio, donata a Firenze nel 1912 dal Wellesley College, che ha conser-vato invece la sezione boccacciana, di mano degli stessi copisti, ma su carta diversa) ri-sale alle valutazioni dei primi studiosi e la localizzazione è stata tentata fin qui opera peropera, con esiti tutt’altro che illuminanti. Così, Rabboni 1996, p. xlix in nota, rilancial’ipotesi, già di Morpurgo, di una provenienza «più meridionale» di Firenze, «forse alconfine con un’area tosco-orientale e umbro settentrionale» e anche Benucci 2002b osserva, nella Nota al testo del Bruto, che «linguisticamente il testo è toscano ma si indi-viduano alcune forme, per lo più riguardanti il trattamento della i protonica […] chepotrebbero ricondurre a un’area diversa […]: si potrebbe trattare di infiltrazioni della fascia sud orientale della Toscana fino all’Umbria» (p. 888). Limacher-Riebold 2007, pp.90-92, dedica, chissà perché, l’unico paragrafo linguistico del suo lavoro al frequentissi-
1 Ricavo le citazioni rispettivamente da Motta, Robins 2007, p. xlii, e da Morpurgo 1912, p. iii. Comeosserva, in una lettera datata 11 febbraio 2009, Bettarini Bruni: «La qual cosa, se viene a togliere responsa-bilità e interesse ad ·, ci dice che la perdita dei fascicoli iniziali è comunque antica anche se fuori bottega».
dittico per antonio pucci - i 87
mo, idiosincratico raddoppiamento della t, «che avviene in tutti i contesti» e, di conse-guenza, non permette di «poter azzardare una qualsiasi ipotesi sulla provenienza del co-pista». E il solo Motta 2007, pp. cxv-cxlviii, conclude il suo spoglio della lingua di K ri-levando che «la maggior parte dei tratti induce a «ipotizzare una provenienzasettentrionale, e forse padana del copista cui appartiene la mano ‚ [scil. la mano princi-pale di K], se non anche di un antigrafo del manoscritto».
Premesso che lo spoglio andrebbe condotto in modo sistematico su tutto il ms., cioètenendo conto anche del Filostrato, allo stato mi sembra preferibile la localizzazione me-no prudente e insomma magnanima del giovane Baldelli: «S. Morpurgo […] indica nel-la parte trascritta dalla prima mano [scil. ‚] forme meridionali (che saranno invece pro-babilmente emiliane: sienza, scipolto, conzeduta, gaiardo, gaioffo, ioti [scil. ‘ghiotti’?] … Eanche il testo della seconda mano offre le stesse forme)». Fino a prova contraria, la lo-calizzazione sembra confermata anche dai dati che seguono (prescindo dai fenomenipiù generici come i frequentissimi scempiamenti o i pronomi atoni me, te, se). All’isola-to scipolto, registrato da Baldelli, si possono aggiungere, nella Reina, almeno iii 1 5 po-scia ‘possa’; iii 2 6 comparisce ‘comparisse’ e, per contro, ii 43 5 aparisenza e ii 44 3 amba-sador. Nelle 4 ottave finali della mutila Lionessa, trovo il doppiamente notevole 49 8 fieci‘fece’ (con riscontri nella Reina d’oriente e in altri cantari). Nell’Apollonio, il già citatoRabboni 1996, p. xlix in nota, segnala (pur interpretandola sulla scia di Morpurgo) unaserie di tratti ridotta, ma eloquente (esiti come simel, stabelito; un caso di metafonesi da -icome barun(i); altre semplificazioni fonetiche di -sc- come usia, cognosi).1 Spigolando ne-gli apparati della purtroppo ricostruitissima edizione Limacher-Riebold di Onnipotentere, trovo, oltre ai banali chonciedi, vegiendosi, cieruglio e anche 125 uciedendo ecc., formeiperdittongate tipiche, anche se non esclusive, dell’emiliano illustre come 97 alieghra,106 alieghri, 164 fiecior (da confrontare col già ricordato fieci); la seconda plur. in -eti (174aveti); 204 usire ‘uscire’ e 319 piaza ‘piaccia’ (piaza è anche nella Reina, ii 42 8); 234 en si-mel modo; 262, un altro esempio di gaiardi (anche nella Reina e nel Bruto: Motta). E si no-tino, riguardo agli esiti di O e U protonica, 264 disinore e i più notevoli 318 rimanzi ‘ro-manzi’, 92 bigia ‘bugia’ e 267 figiano ‘fuggivano’.
A conferma della correttezza dell’osservazione di Baldelli per cui «anche il testo del-la seconda mano offre le stesse forme», segnalo infine qualche tratto notevole della ma-no · nel Bruto: oltre a 43 3 rinvigorisse (che anche l’editore ritiene più «probabilmentepres. ind.»), 7 7 gieristi ‘giresti’; 19 6 gionge(v)a; e ancora 44 6 gaiardo.2
1 Il tipo aggio (un meridionalismo letterario diffusissimo nella lirica toscana due-trecentesca) è invecepluriattestato anche nella tradizione tosco-fiorentina trecentesca non aulica, inclusa la prosa della TavolaRitonda, la poesia ‘borghese’ del Sacchetti e di Pieraccio Tedaldi e la produzione in ottave d’autore e non,dall’Amorosa visione al Ninfale fiesolano al Teseida al Fiorio e Biancifiore (attestazioni più recenti in Serianni2009, pp. 194, 297): si tratterà insomma di un cultismo del Pucci piuttosto che di un peruginismo del copista.
2 Altre forme notevoli, che confermano o non ostano all’ipotesi, mi sono segnalate in data 5 maggio2009 da Anna Bettarini Bruni. Nell’ordine. A) Canzone della guerra di Pisa (O lucchesi pregiati): ricordive; me-cidio|micidi; recevette, seguisce ‘seguisse’, mimoria, 3 3 fiecci (3ª pers.); 12 4, 13 4, 15 5, 18 8, 41 2-6 fieci, 15 5 ra-scigurata, 18 7 sienza, 31 8 si stesa, 35 7 mezidio ‘omicidio’. B) Cantari della guerra di Pisa (oltre all’anche quicomune fieci: iv 19 2, iv 25 8, ecc.), gaiardo, i 10 Pezole (Pecciole), i 25 3 remetter, i 36 4 asesa (‘ascesa’), i 36 8zinse (‘cinse’); ii 27 1 usirano; iv 10 6 pregione; iv 19 4 soglier (‘scioglier’); iv 32 8 signur; iv 44 8 chresesor; v48 2 niscita (‘necessità’); v 22 4, v 23 3 siguitar; vii 24 7 rason, vii 31 8 perosini. Ancora ghaiardo, lizenza. C)Noie: 17 umel, 53 gintil, 73 simelemente, 208 chionque. D) Dè gloriosa: 5 signur, 103 momoria. E) Mercato vecchio:90 ghaioffi. F) Onnipotente re: 262 gaiardi, 311 vira (‘verrà’). G) Reina: ii 41 3 scrimire, ii 42 8 piaza (: -acia), ii43 6 aparisenza, iii 2 6 comparisce (‘comparisse’), iv 31 4 barun’, iv 40 8 puciolente, iv 41 5 divocione.
88 paolo trovato
4.
Vengo alla datazione di K, pure ancorata alle proposte degli studiosi ottocenteschi e pri-mo novecenteschi (cioè D’Ancona e i suoi scolari – per es. Paoli –, Jackson e Morpur-go) e giudicata prossima alla morte del Pucci (1388).1 Tra gli studiosi posteriori basteràricordare De Robertis («Tra il 1370 e il 1390») e Rabboni («Sec. xiv, ultimo quarto»).2 Laforbice 1370-1390, autorevolmente ribadita da De Robertis nella premessa alla sua edi-zione dei cantari antichi e nel successivo intervento La tradizione dei cantari,3 si ritrovacon le stesse parole – «Il codice Kirkup (K) del secolo xiv (1370-1390)» – sia nella Nota altesto della Leonessa di Benucci, sia in quella del Bruto di Zabagli. Motta data sia K1 (cioèil codice Wellesley del Filostrato) sia K, ossia la sezione pucciana, «sec. xiv ex.». Di pa-rere diverso Branca 1958, p. 44, che data il solo Filostrato Wellesley al xv secolo.
L’amica Gabriella Pomaro, che ha esaminato a mia richiesta scritture e filigrane diK, propone anche per la raccolta pucciana, esemplata, come si è già detto, dagli stes-si copisti del Filostrato Kirkup, una datazione decisamente bassa. Innanzi tutto, nono-stante la perentoria identificazione della Jackson (Briquet nº 9926, anni 1373-1380), le fi-ligrane recano lo stesso disegno, ma sono diverse («Almeno due tipi di liocorno,nessuno nettamente identificabile nel Briquet né come disegno né come posizione trai filoni»). Il primo tipo, «rilevato alle cc. 18 e 82, è caratterizzato da disegno rozzo e im-preciso; la posizione fortemente verticale (con asse quasi parallelo ai filoni) e la carat-teristica del corno orizzontale lo avvicinano a Briquet 9939-9947 (pienamente quattro-centeschi)», ma è «più grande di questi, con il muso molto allungato». Il secondo tipo,«ben rilevabile a c. 91», è ancora «più grande e dal disegno più netto» e può essere «av-vicinabile (solo per rendere l’idea) a Briquet 9940 (1436)». Per quanto riguarda la data,Pomaro mi scrive in data 30 dicembre 2008: «la mercantesca [di ‚] è fortemente con-notata, molto tarda (sicuramente fine Quattrocento»; e ribadisce il 22 gennaio 2009:«La mano iniziale [·] è leggermente meno corsiva, usa la (et) tachigrafica e forse è diformazione leggermente più vecchia; il tutto è – a star proprio ben corazzati, calco-lando che le due mani cooperano – assegnabile alla seconda metà del Quattrocento,ma non ulteriormente retrodatabile» per l’insieme grafico (sotto il rispetto grafico, in-vece, riscontri pertinenti «attorno al 1480, nei Manoscritti datati d’Italia, iii, BibliotecaRiccardiana»).
Ma al di là della cronologia bassa e della confezione periferica, resta il fatto che il codice Kirkup conserva, a volte con diffuse didascalie in prosa, la parte più copiosa del-la produzione in versi del Pucci. Con ogni probabilità esso riproduce, anche se con gliscadimenti del caso, un perduto ‘libro’ del Pucci (o d’ambiente a lui vicinissimo), comeè stato sottolineato già da vari studiosi, che hanno parlato giustamente di una silloge«non lontana dall’autore», «written by someone having unusual opportunities to obtain
1 In particolare, Jackson 1910, p. 316 riporta le valutazioni di Paoli 1872 («Il detto codice [scil. Kirkup]è bambagino, apografo, del più sicuro e chiaro trecento, miscellaneo») e di D’Ancona 1878, p. 46, nota («Tut-te queste rime [scil. del Pucci] furono da me copiate di sur un codice sincrono appartenente già al Sig. Cav.Seymour Kirkup, adesso passato in Inghilterra»). Morpurgo 1912, p. v ribadisce, a proposito della mano‚, di cui riporta un facsimile: «È scrittura che senza esitazione si assegna alla seconda metà del trecento […].Concorrono assai bene tutti gli indizi esteriori a circoscrivere la età del codice fra il terz’ultimo e il penul-timo decennio del secolo xiv» (corsivi miei).
2 De Robertis 1961, p. 123 (= De Robertis 1978, p. 95).3 De Robertis 1970, p. 69 (= De Robertis 1978, p. 112); De Robertis 1990, p. 429.
dittico per antonio pucci - i 89
Pucci’s writings», «forse non indipendente dalla volontà dell’autore».1 Il rango del ma-noscritto, anche testualmente privilegiato, come cercheremo di provare, non sembrasufficientemente valorizzato nelle edizioni recenti.
5.
Poche osservazioni sull’edizione dei 5 cantari di Apollonio di Tiro, del resto piuttosto com-plessa (Rabboni classifica 17 mss. con forti caratteri rielaborativi e una copiosa tradizionea stampa; altri 2 mss., entrambi di tradizione settentrionale e conservati rispettivamentea Venezia e a Verona, sono stati segnalati dallo stesso curatore nell’Errata corrige del vo-lume e da lui studiati nel 2008). Come risulta dallo schema del § 2, in K mancano le otta-ve 9-50 del i cantare; le prime 24 del secondo; e i 3 cantari finali ad eccezione di iii 1-4. Sicapisce quindi che, nonostante la consapevolezza che K rechi «una versione ‘antica’, or-mai difforme da quella corrente a distanza di poche decine d’anni» (p. xlix), Rabboni nonabbia dedicato a un testimone così gravemente mutilato tutta l’attenzione del caso. Pro-verò quindi a saccheggiare il suo apparato, ricco anche se non esaustivo (il rilievo è di Mot-ta 1998, p. 560, nota), limitatamente alle zone del testo presenti in K (da lui siglato FK).
Sulla scia di un saggio meritamente celebre di De Robertis, Problemi di metodo nel-l’edizione dei cantari, Rabboni insiste a ragione sull’«attiva collaborazione dei copisti»,propria del genere, e sull’apparente assenza di «direttrici sicure» per la classificazione genealogica (pp. vii e viii). Sempre con le sue parole, «un’attività sistematica di varia-zione e reinvenzione» finì per «alterare in modo irreparabile la matrice pucciana: a cominciare certo dall’elemento più vistoso, la ‘firma’ apposta al termine di ogni canta-re» (p. viii). È il caso di ricordare che K è tra i pochissimi codici a conservare la ‘firma’di Pucci a ii 50 7-8:
Che per via le colse (che nel mare gli colse FM FR3, che per mare gli colse FR1, che stravaia li tolse VC)|Antonio in rima l volse FK (Antonio alvosto onore rimar volse FM, Antonio rimarevolse FR1, domenego rimar el volse FR3, antonio far la volse VC) K + FM FR1 FR3 VC vs Che lcolse intra via (che corse tra via FR2, chelebbe travia FLa, chegli colse per via FRm, cheglj colsetra via FLs Vbo)|Al vostro onor detta è la canzon mia BU + Alii
E va precisato subito che:1. la serie appena indicata dei mss. che, in aggiunta a K, conservano in tutto o in par-
te la firma, FM FR1 FR3 VC coincide in sostanza con una sottofamiglia di cui Rabboniha provato impeccabilmente la consistenza, cioè ·1;
2. il periferico K presenta errori separativi sicuri (per es. a ii 50 2, dove si ha diffrazio-ne in presenza e la lezione buona, di FR2 FLa FLs Vbo, è andava c(h)aendo: -endo, ma ilgrosso della tradizione, incluso K, banalizza poligeneticamente l’arcaismo nel sinoni-mo cerc(h)ando, mentre BU escogita, per salvare la rima, l’errore critico cherendo);
3. il solo Kirkupiano sembra conservare d’altra parte – a conferma del criterio pa-squaliano delle aree laterali – alcune lezioni originarie dove tutti gli altri testimoni (inseguito: ‰) innovano banalizzando. Citerò solo i casi che seguono:
ii 40 5-6 E non credo chasimel chonvenennte|Avese onor giamai alcun cristiano K vs Mai nonebbe onor similmente|Per tal condizion alcun cristiano Alii
L’arcaica e polisemica convenente è parola chiave del lessico cavalleresco pucciano.
1 Le citazioni rispettivamente da Morpurgo 1912, p. v; McKenzie 1931, p. cliii; Bettarini Bruni 1984,p. 143.
90 paolo trovato
ii 41 1 sosprasberghe K vs sopraveste AliiIl tecnicismo soprasberga (7 esempi in tutto nel tlio, distribuiti tra Siena e Firenze e tutti ante
1348; 5 esempi, tutti del Villani, per gli stessi secoli, nella liz) è difficilior rispetto a soprav(v)este (35esempi nel tlio, 41 nella liz).
ii 44 4 quinentro K vs quellegno FR2 FLa FRm FLs Vbo, in quello BU + AliiDue ess. pisani di quinentro e due boccacciani di quincentro nel tlio, tre dei quali si ritrovano
nella liz (e si noti, a riprova dell’impegno di Rabboni, che anche la serie FR2 FLa FRm FLs Vbocorrisponde in sostanza a una sottofamiglia individuata dall’editore, ‚1).
Si aggiunga almeno un altro caso nel quale sembra di poter far leva su «direttrici sicu-re», di natura logica. È noto che la tradizione canterina, proprio come le situation come-dies e altri tormentoni a puntate, ha istituzionalizzato a inizio di cantare l’impiego di ve-ri e propri riassunti delle puntate precedenti. Tale, a iii 2, la lezione di K, di FR2 La RmLs (ovvero ‚1, eccettuati FN1 e Vbo) e di una larga zona di ·1 (FR1 FR3 FN2 FN3):
I’ vi contai ne la sichonda partecome Apollonio […].con la sua donna insieme si diparte…[…].Or seguirò la legenda e le cartesì come el…
La mossa, cara al Pucci, si ritrova per es. nell’Apollonio, iv 2 («Di Tarsia vi contai nel terzocanto|come…») e nella Reina d’oriente, ii 2 («Io vi contai come lo ’mperatore…»). BUed altri (l’apparato di Rabboni è negativo) offrono invece una versione rabberciata delriassunto, promettendo di raccontare in futuro vicende già accadute appunto «ne la si-chonda parte»:
Io dirò al tutto in la seguente partecome Apollonio […].Or seguirò […].
Come Rabboni (e già De Robertis, da qualcuno invocato, a sproposito, come autorità-alibi per riproduzioni meccaniche o quasi),1 sono convinto che – pur con tutte le diffi-coltà del caso – un tentativo di stemma sia utile e anzi raccomandabile anche quando silavora sui cantari; e tuttavia credo, con Avalle, che un importante fattore di scelta trapiù stemmi concorrenti sia quello di limitare, nei limiti del consentito, le ipotesi di con-taminazione, che frustrano spesso il lavoro dei filologi alle prese con tradizioni com-plesse cone quella in discussione, ben descritta da Motta 1998, p. 559: «Ogni volta che siprocede all’individuazione di un rapporto tra mss., per un certo numero di lezioni (spes-so adiafore) che lo corroborano, ve ne sono almeno altrettante che non si lasciano razionalizzare, obbligando a ipotizzare plurimi processi di contaminazione o imbaraz-zanti poligenesi». Come è ovvio, nel caso dell’Apollonio le modifiche che possono di-scendere dalle osservazioni che precedono riguardano solo i piani più alti del comples-
1 Oltre alla citazione di De Robertis in esergo, si considerino almeno l’osservazione seguente: «Lastessa individuazione dell’oggetto, di una particolare tradizione o redazione, non potrà uscire che dallostudio dell’intera tradizione»; e la distinzione, avanzata sempre in De Robertis 1961, tra la tradizione,«piuttosto raccolta», del Cantare di Piramo e Tisbe A (stemma bipartito con individuazione di un archeti-po ecc.) e casi assai diversi, in cui una classificazione «è un modo di abbracciare il panorama della tradi-zione, ma non è traducibile in recensio».
dittico per antonio pucci - i 91
sivamente accettabile stemma di Rabboni (p. xciv) e in particolare la posizione di K(che, in quanto mutilo, avrebbe comunque solo una funzione di controllo). E possonotradursi in un grafo come il seguente, in cui il tipo testuale di K risulta indipendente dalla vulgata, entro la quale si svolge l’ampia attività contaminatoria di cui lo stesso Rabboni ha cercato di precisare i vettori. Se la mia proposta fosse fondata, il riassettodella genealogia – da verificare ora anche alla luce della recente edizione dei volgariz-zamenti in prosa dell’Apollonio –1 dovrebbe consentire di monitorare più efficacementeil comportamento del testimone base di Rabboni, BU, le cui uscite isolate sarebberosmentite già in caso di accordo ·1 + ‚1 (per non dire degli accordi K + ‰, K + ·1 o K + ‚1),semplicemente grazie a un disegno stemmatico che promette una buona operatività giànei piani bassi:
Mentre è piuttosto facile provare l’esistenza di ‰, la circostanza che K sia molto vicinoal libro pucciano rende difficile, almeno all’interno delle lezioni registrate in apparato,individuare errori significativi comuni ai 2 rami, ovvero l’archetipo. Non mi spingo achiedermi se sia possibile individuare, dentro lo spesso banalizzante ‰, tracce di una di-versa redazione d’autore, che sarebbe peraltro difficile distinguere dagli ammoderna-menti e dalle idiosincrasie del copista di ‰ (altro discorso varrà per la presenza di un’ot-tava copiata due volte in K con varianti sostanziali che passano in ‰: verosimilmente unassetto complesso nel perduto manoscritto originario, che poteva contenere almeno inquel luogo la doppia lezione).
6.
Ma la portata più ghiotta o almeno più curiosa del revival pucciano è certo il volume‘dialogico’ del 2007, che contiene, affrontate, un’edizione diciamo bédieriana della Rei-na d’oriente, condotta, fin dove possibile, su K, a cura di Motta, e un’edizione computer-assisted secondo i dettami della cladistica, a cura di Robins: salvo errore, il primo espe-
1 Sacchi 2009. Come dimostra impeccabilmente lo stesso S. (ivi, pp. 29-33), il Pucci versificò un affinedi B, edito alle pp. 179-248.
Archetipo (per ora non dimostrato)
‰
‚·1 (= FM FR1 FR3 VC ecc.)
K
BU
‚1 (= FR1 FLa FRm FLs Vbo ecc.)
92 paolo trovato
rimento del genere nell’ambito della filologia italiana. Dando bella prova di civiltà e sen-so pratico, i due studiosi che avevano iniziato a lavorare l’uno indipendentemente dal-l’altro, hanno infatti «deciso di unire le loro forze», dividendosi i compiti come indica-to a pp. vii-viii.
L’edizione Motta, di regola intelligentemente conservativa, è, nel suo genere, prege-vole. L’essenziale caratterizzazione della tradizione della Reina, definita (in termini ispi-rati al più volte citato saggio metodologico di De Robertis) «solo parzialmente rielabo-rativa» (p. xiii), sembra del tutto convincente. È tra l’altro notevole (e conferma lanatura tutt’altro che disastrata di K) che «la stragrande maggioranza di versi apparen-temente ipermetri» sia riconducibile «alla misura esatta tramite l’espunzione di vocalio sillabe finali di parola dopo liquida o nasale, com’è noto talora scritte ma non pro-nunciate» e «evidenziate in corsivo» dall’editore (p. cxcii).
Molto ragionevole anche il trattamento che si propone, ivi stesso, per le figure pro-sodiche («Abbiamo adottato la soluzione di considerare ‘normali’, e dunque implicite,sinalefe e sineresi» ecc.).
Condivisibile, infine, la scelta di ricorrere a M (cioè il ms. meno difforme da K) per leparti che mancano nel Kirkupiano.
Quanto all’ed. Robins, ha carattere programmatico – e presuppone una ben diversavalutazione delle varianti ovvero, con Cerquiglini, della variance del cantare pucciano –la dichiarazione di voler «ricercare una soluzione editoriale innovativa che sfugga al-l’alternativa fra manoscritto più antico e testo ricostruito su base stemmatica, nella con-vinzione che nessuna delle due scelte sia in grado da sola, di render conto, sul piano edi-toriale, dell’ambivalenza del testo e della stessa figura di Pucci» (pp. xiv-xv). La nuovasoluzione consiste in una classificazione genealogica condotta «non solo attraverso imetodi della filologia tradizionale, ma anche sperimentando, in sostituzione della no-zione di errore, quelli quantitativi “orientati” della cladistica», cioè uno dei frutti più re-centi delle tassonomie sviluppate, grazie alla diffusione dei pc e alle applicazioni dellabiologia evoluzionistica, lungo la linea Dom Quentin-Dearing-Froger: dei quali meto-di e applicazioni lo stesso Robins riassume a beneficio dei lettori italiani i presupposti ele caratteristiche fondamentali (pp. lxxvii sgg.).1
Un assioma dei seguaci del nuovo metodo e (già) di Quentin, concordi anche nel ne-gare legittimità alla nozione di errore, è che – a differenza che per i lachmanniani (an-tiscientifici) che cercherebbero subito di individuare, soggettivamente, gli errori signi-ficativi – tutte le varianti devono entrare, allo stesso titolo, nella classificazione e chesolo in un secondo momento, una volta costruita la catena che lega tra loro i mss., sideve orientare il grafo ricorrendo agli errori. La costruzione delllo stemma presuppo-ne infatti, da Dom Quentin in giù, almeno due tappe: a) enchaînement; b) orientation (peres., Froger 1968, pp. 78 sgg.; Bourgain, Vielliard 2002, pp. 52-53; Motta, Robins 2007, pp.lxxvii-lxxx ecc.).
È appena il caso di notare che, al di là dei miti di fondazione (sempre molto drastici)che Robins sembra condividere, in pratica le posizioni sono meno lontane di quantonon sembri, poiché:
1. anche i famigerati lachmanniani in una prima fase collazionano e basta, e poi – difronte a serie larghe di varianti che caratterizzano insiemi di mss. (famiglie potenziali)– decidono che cosa può o non può essere un errore;
1 Ma si vedano almeno – oltre alla notevole rassegna dello stesso Robins 2007 – le raccolte di van Ree-nen, van Mulken 1996; Macé e a. 2006, entrambe con ampia bibliografia pregressa.
dittico per antonio pucci - i 93
2. gli stemmatologi più avvertiti sembrano aver capito che per costruire stemmi nonillusori alcune decine di errori significativi servono più di migliaia di varianti geolingui-stiche o flessionali, massimamente poligenetiche (per es. Salemans 1999 sottolinea che«only very few variants can be building tools», propone condivisibili regole di selezionedegli errori significativi e parla esplicitamente, già nel titolo dei suoi lavori, di un ag-giornamento del metodo di Lachmann).
Ma torniamo all’ed. Robins.
7.
Lo studioso propone un tipo di analisi cladistica dura e pura, lontana dalle ‘concessio-ni’ di Salemans al neolachmannismo e fondata esclusivamente sulle varianti (anche secon giustificazioni non petitae a volte un po’ ingenue, come quelle degli ultimi due capoversi di pp. lxxix-lxxx). Assistito nella gestione di 1450 varianti (o luoghi di varia-zione? non sono sicuro di aver capito bene) degli 8 testimoni ‘completi’ della Reina dal software cladistico MacClade 4.06., capace di individuare il Most Parsimonious Tree(= mpt), cioè l’albero che «richiede il minor numero di […] tratti innovativi introdottiindipendentemente» (p. lxxxvii), Robins approda alla catena che segue:
Nel tentativo di orientare lo stemma, Robins individua 16 luoghi a suo dire significativi,che permettono di individuare «se non “errori”, almeno “lezioni scorrette”» (la piroet-ta concettuale si trova a p. cii). È degno di nota che Robins senta l’esigenza di esclude-re le varianti sostanziali che si trovano «nel verso finale di un cantare» (p. ciii) e consi-deri i congedi, fatalmente investiti dal rimaneggiamento attualizzante dei canterini (sipensi, per es., alla soppressione o alla sostituzione della ‘firma’ del Pucci), in qualche mi-sura meno affidabili degli altri luoghi testuali (pp. cvii-cix). Riporto lo stemma da luiproposto a p. cxii, certo, come lo studioso sottolinea, ‘provvisorio’, ma non diversa-mente da qualsiasi altra analoga induzione dei filologi:
US
V
F
BM
K
Z ·
‚Á
94 paolo trovato
L’edizione di Robins usa come testo-base V, «scelto perché quasi completo (il che garantisce una coerente tessitura linguistica) e perché il fiorentino del copista presentapoche forme e quasi nessuna grafia che sarebbero state insolite per Pucci» (pp. clxxxiii-clxxxiv).
Sulla base dei ricchi apparati di varianti procurati dallo stesso Robins e lavorando ov-viamente solo sui mss. non frammentari e sulle peraltro ampie sezioni di testo presen-ti in K (dove il testo inizia a ii 9 5 e mancano le ottave iii 9-10), un neolachmanniano co-me chi scrive inclinerebbe invece a uno stemma come quello tracciato qui sotto:
1 Ma si vedano, al riguardo, i numerosi indizi raccolti, in questo stesso volume, da Bettarini Bruni,che, pur confermando le linee essenziali del mio stemma, precisa significativamente anche l’articolazio-ne interna di ·.
stampe
Pucci
ˆ
· ‚ Á
SV FB MKU a
Archetipo
(da me non dimostrato)1
Ì
Ë
‰
· (= SUV) ‚
M K
B F z (= incunaboli a, b ecc.)
dittico per antonio pucci - i 95
Anche in questo caso, come in quello dell’Apollonio, lo stemma a cui sono approdatonon è in termini astrattamente morfologici lontanissimo da quello proposto dall’edito-re critico, ma opera in modo radicalmente diverso, in virtù del diverso ‘peso’ di K e Mquando (quasi sempre) è necessario applicare la legge della maggioranza (e si noti – unavolta avvertito che U corrisponde in Rabboni a BU, M = FM, B = FRm, V = Vbo – che lostemma della Reina non smentisce, ma ricalca, gli snodi essenziali di quello, più folto,dell’Apollonio; e non si differenzia troppo, a giudicare dal pur datato avvio di classifica-zione e dall’apparato offerti da McKenzie, nemmeno dalla genealogia, ancora più ricca,dei mss. superstiti delle Noie).1 Non occorre aggiungere che la vulgata Ë è l’unica zonadello stemma dove si percepisce una forte attività contaminatoria (una dimostrazioneanalitica nell’articolo di Bettarini Bruni che segue).
La differenza tra i due stemmi della Reina si spiega sostanzialmente con i metodi se-guiti; e le indicazioni più istruttive che mi sembra di aver ricavato dall’esperimento ri-guardano appunto un possibile punto debole della procedura seguita da Robins. Aquanto pare, quando i cladisti più rigorosi (o meno eclettici) passano alla fase 2 (orien-tare lo stemma), non sono portati a mettere in discussione le coppie tassonomiche sug-gerite dall’incatenamento computer assisted e tanto meno l’assunto per cui «tutte le ra-mificazioni di un albero sono bifide» (così Robins a p. lxxxviii). Nella fattispecie K e Mcontinuano a rimanere ‘legati’ a uno snodo comune anche dopo che la catena è stataorientata e tradotta in uno stemma. Ma mentre le asserite consanguineità di BF e diSUVz (con z, ovvero a e b, Robins indica i primi incunaboli) sono facilmente confer-mabili anche in termini neolachmanniani (grazie a serie ampie di errori congiuntivi), lefrequenti coincidenze tra K e M – la presunta famiglia Á segnalata dal software Mac-Clade nella fase di incatenamento (pp. xciv sgg.) – sono, a mio giudizio, tutti accordi inlezioni buone o almeno indifferenti (inclusi, naturalmente, i tre casi, ii 36 7, iii 19 3, iv16 3, che Robins considera invece orientativi e che discute alle pp. cv-cvi).
Se non rinunciamo a priori a ragionare sulla presenza e sull’assenza nel testo della‘firma’ di Antonio Pucci (una ‘regola’ supplementare di Robins, di cui è francamentedifficile comprendere la ratio),2 salta all’occhio che, alla fine dei cantari ii, iii e iv (nel
1 McKenzie 1931, pp. cxlix-clxii. Basandosi prevalentemente sulla quantità e sull’ordine delle terzi-ne presenti nei vari mss., McKenzie, pur senza tracciare uno stemma, individua due classi, la prima for-mata dal nostro K (siglato dall’editore A, per la sua importanza) e altri 4 mss., più conservativi (sottofa-miglia x), la seconda dal nostro U (per McKenzie, K) e da altri 16 mss. La consistenza della ii classe sembrasicura. Ma si avverta (apparato McKenzie alla mano) che: 1. il Kirkupiano è l’unico ms. a recare il disticofinale con la firma di Pucci («Antonio puci ne fu dicittore|ghuardivi senpre Christo salvatore»); 2. i 4 mss.di x presentano innovazioni smentite dall’accordo tra il Kirkup e la ii classe (è significativo che lo stessoMcKenzie 1931, p. 1, nota, avverta, all’inizio del suo apparato: «x means all the manuscripts of group i ex-cept A […]; y means all the mss. of group ii that contain the verses in question»); 3. il più conservativodei mss. della ii classe concorda spesso in lezione buona con la i. Infine: 4. la ii classe (nel complesso con-taminata) sembra derivare da un affine di D (banalizzazioni almeno in qualche caso congiuntive con que-sto o quel ms. x ai vv. 25, 70, 76, 82, 90, 92, 105, 128, 170, 174, 184, ecc.; omissioni di terzine condivise conmss. x ai vv. 187-195, 232-237, ecc.). Di nuovo, insomma, sembra che la traduzione grafica più appropria-ta sia uno stemma bipartito nel quale l’isolato K (ben inteso, anche per le Noie non infallibile) rappre-senta un ramo ancora molto vicino all’archetipo e tutti gli altri mss. documentano vari stati della vulga-ta quattrocentesca, variamente aggiornata dai copisti.
2 Peraltro, sembra che i matematici che assistono i critici testuali nell’applicazione delle procedurecladistiche suggeriscano con disinvoltura eccessiva la rimozione di varianti in qualche misura ‘scomode’rispetto alle attese. Con le parole di Salemans 2002: «Most of the times the development of chains by
96 paolo trovato
primo, K manca), la firma di Antonio è presente solo nel Kirkupiano, affiancato una vol-ta dal solo U e due dal solo M. Sappiamo che il Pucci tende a firmare la sua produzionee dunque, anche in questo caso, K conserverà meglio degli altri l’assetto tardotrecente-sco del testo. Anche in altri casi di ampia diffrazione, il Kirkupiano reca, da solo o contestimoni che cambiano di volta in volta, la lezione con ogni probabilità genuina:
*iii 17 6 ben per non diviso K + SB] ben per non divisi M, per mio aviso U, quel bel fiordaliso z,ben per noviso F
*iv 35 7 barbani (: Romani) K] balbani U, cani U, baroni sovrani S, burbani B, baroni M
La lezione per non diviso di K + SB è un tecnicismo giuridico caro a Pucci (Glossario Mot-ta, s.v. diviso). Barbani, del solo K, è già nel secondo ’300 toscano un termine démodé (neltlio, ess. solo in Bono Giamboni e Guido da Pisa; nessun esempio toscano nella liz).
Se continuassimo a lavorare su errori o innovazioni significativi (cioè non poligene-tici), come fa più sotto Bettarini Bruni, potremmo vedere che – a differenza di K – Mcondivide numerose deviazioni con la tradizione più recente. Come ho anticipato, leconseguenze di questa diversa classificazione non sono irrilevanti. Mentre nello stem-ma di Robins ci troviamo di fronte a una recensione aperta con soluzioni equiprobabi-li (·+ ‚= Á), nello stemma che chiameremo per comodità Bettarini Bruni-Trovato l’ac-cordo K + M o K + Ë basta a ricostruire con sicurezza la lezione dell’archetipo, ossiadella redazione più antica del cantare cui siamo in grado di risalire, consentendoci di va-lutare con maggior precisione anche gli apporti dei successivi rifacitori, ragionando vol-ta a volta dell’editio U, S, ecc. (e magari anche di procurare edizioni elettroniche di tut-ti i testimoni manoscritti e delle prime stampe).
Ben inteso, non presumo che le mie deduzioni abbiano validità generale, e mi auguroanzi che, a titolo sperimentale, operatori diversi tentino di editare un certo numero di te-sti tanto con criteri lachmanniani quanto secondo i dettami della stemmatologia (ricor-do ai filologi romanzi che un banco di prova privilegiato della cosiddetta new philology èla tradizione di Chrétien de Troyes). Sono tuttavia tentato di osservare che il trasferi-mento indifferenziato dalla biologia alla critica testuale di procedure e programmi in-formatici cladistici pone forse più problemi di quelli che vorrebbe risolvere. Pur convin-to che il ricorso al pc sia fondamentale per assistere il critico testuale, soprattutto quandosi analizzino tradizioni complesse, non mi pare che rinunciare sistematicamente a ser-virsi di indicazioni non opinabili in nome di una più serrata convergenza di metodi con icugini biologi sia vantaggioso per i nostri studi. A differenza dei biologi, che una voltatanto hanno di fronte a sé dati più ambigui, più difficili da interpretare dei nostri, mi pa-re che un uso prudente dei pochi errori logici presenti nella tradizione (di solito non piùdel 5% dell’estensione del testo) ovvero di indicazioni areali e di cronologia relativa in-controvertibili come quelle che ci vengono dalla storia linguistica, dalla codicologia ecc.,ci permetta di arrivare (con una strumentazione, se si vuole artigianale, ma più raffina-ta) a esiti stemmatici meglio fondati di quelli ottenibili ricavando, a partire da una bancadati ricchissima di varianti inutili (perché poligenetiche), il mitico (ma casuale) mpt. Al-tro discorso farei, ben inteso, per le procedure messe a punto da Salemans, che, pren-
these mathematicians is undocumented. That is a serious problem. For instance, mathematicians throwaway rather easily variants that cause ‘bias’ in a chain. I have never seen a (theoretical) justification aboutthis (de)selection of variants. If there is no justification of the removal of ‘difficult’ variants, this has tobe considered as uncontrollably subjective, and therefore unscientific activity!» (corsivi miei).
dittico per antonio pucci - i 97
dendo le distanze dai suoi compagni di strada,1 fonda la classificazione su una ridottissi-ma scelta di varianti che è ragionevole ritenere monogenetiche e propone di fatto, comeho già accennato, un neolachmannismo computer assisted di indubbio interesse.
8.Concludo questa occasionale scorribanda tra i testi del Pucci con alcune note, si dicapure linguistiche, su singole soluzioni testuali o esegetiche delle edizioni recenti.Serventese Onnipotente re, 25-28: «Noi siamo a gran periglio!|Se Lucca viene a signoria del Gi-glio,|di Pisa muoia innanzi ’l padre e ’l figlio,|che ciò sia». L’interpunzione non va. Si corregga:«Noi siamo a gran periglio|se Lucca viene a signoria del Giglio!|Di Pisa muoia innanzi ’l padree ’l figlio|che ciò sia».
Ai vv. 34 sgg.: occorre un punto alla fine del v. 34 e va eliminato il punto del v. 36.Al v. 185 l’ed. legge «col magio’ onor che si potes[s]e avere». Ora, magio (cioè maggio) non sarà
una riduzione da maggior, ma forma nominativale come nella fiorentina via Maggio: l’apostrofoè quindi fuori luogo.
Al v. 249, «Ma li cava[lier] de Fiorentin cedeano», l’integrazione cava[lier], impossibile per ragioni prosodiche, è comunque superflua, documentatissimo essendo in it. ant. l’uso di cavalli(in poesia anche cavai o, come nel caso in discussione, cava’) per ‘cavalieri’ (basti il riscontro delv. 243 «onde molti caval[l]i fino a l’os[s]a | fur fediti»).
Al v. 265, «Sì come dice chi ne salì il tenore», la nota spiega: salire ‘diffondersi’ (dunque: in-transitivo). Ma subito dopo: «come dice chi ne (o vi) trasmise il racconto» (dunque: transitivo).Entrambi i valori di salire non sembrano documentati. Inoltre, anche questo verso è ipermetro,mentre (come risulta anche dalle indicazioni prosodiche di Motta) il Pucci è un artigiano deco-roso. Ipotizzo quindi una sorta di dittografia prodottasi in K o a monte di K «…chi ne sal il te-nore», da ridurre a «…chi ne sa ’l tenore».Reina d’oriente. Il glossario, s.v. barbano (iv 35 7: «I’ son un de’ barbani | di Macometto, Idio degliRomani»), spiega ‘seguace’, ma, data l’indeterminatezza temporale e geografica in cui la vicen-da si svolge, non si capisce perché non si possa intendere, come di norma, ‘zio’ (un luogo paral-lelo dello stesso Pucci nel serventese Onnipotente re 288).
Sempre nel glossario, s.v. quale, la formula sanza quale di ii 21 4 («Perché tal novitade?|Tu mostri sanza quale tale apitito») è spiegata in modo poco persuasivo (‘Senza la quale [novità] nondimostri un tale desiderio’). Senza quale vale in realtà ‘senza ragioni, sine quare’ (riscontri nel teatro dell’Aretino: Filosofo ii 7 1, «non è senza quale lo sciorinamento che ha fatto d’ogni sua cosa»; altri ess. nella prima Cortigiana iv 6 1 e nella Talanta v 10 1).
Ma si tratta, come è ovvio, di poche minuzie all’interno di edizioni benemerite e utili,anche se in diverso modo, per una miglior conoscenza di una zona cruciale del nostroTrecento.
1 «From about the eighties of the 20th century, according to me, something went wrong… Moderntextual scientists, modern textual criticism, did not want to be accused of unscientific behavior anymore.They wanted to act like and to be respected as true scientists, like mathematicians. They met very friend-ly colleagues of mathematical departments of their universities (true scientists!) who were willing tobuild, inductively, chains out of almost every package of textual variants (‘facts’) delivered. Many mo-dern textual scientists were thrilled: in their view, chains produced by mathematicians had to be, almostby definition, objective. At last all subjective flaws of earlier text critical methods had been mastered! Theultimate goal had been achieved: textual criticism (and the building of text-genealogical trees) had become a part of true science! Most of the times the development of chains by these mathematicians isundocumented. That is a serious problem. For instance, mathematicians throw away rather easily variants that cause ‘bias’ in a chain. I have never seen a (theoretical) justification about this (de)selectionof variants. If there is no justification of the removal of ‘difficult’ variants, this has to be considered as uncontrollably subjective, and therefore unscientific activity» (Salemans 2002). Diversamente sfumate ecomunque molto interessanti anche le posizioni di Canettieri e a. 2008.
ii.
ESERCIZIO SUL TESTO DELLA «REINA D’ORIENTE»:È POSSIBILE UN’EDIZIONE NEOLACHMANNIANA?
Anna Bettarini Bruni*Firenze
1.
Che la coincidenza di studio su uno specifico argomento si traduca in lavori tra loro con-nessi non è fatto consueto e nel caso potrebbe apparire quale effetto della generosa ope-razione a quattro mani che ha riportato sugli scaffali il cantare del Pucci.1 La sollecita-zione di Paolo Trovato, già formalizzata nelle sue linee generali, mi ha colto con quellibro tra le mani e ha contribuito a orientare diversamente il mio lavoro, da una finalitàrecensoria a un’applicazione dimostrativa da affiancare all’intervento di carattere piùteorico. A fare da cerniera la questione di metodo posta in primo piano dalla soluzionesperimentale adottata dai due editori.
Trovato pone il focus della sua analisi nel Nuovi Acquisti 333, codice capitale per l’ope-ra di Pucci, rimarcando l’assenza anche nei lavori recenti di una descrizione del mano-scritto con supporto specialistico: tale rilievo, che punge anche chi come me veleggiada troppo tempo intorno all’autore, riflette nello specifico la considerazione di Dioni-sotti, in contesto relativo proprio alla letteratura canterina, la quale merita di essere al-logata qui a giusto memento:
La bibliografia dei nostri antichi testi è piena zeppa di valutazioni e datazioni di mss. fatte a lumedi naso, senza manco prendersi la briga di tentare una elementare analisi paleografica, da stu-diosi competentissimi in altre discipline, non in quella richiesta da tali valutazioni e datazioni.Pertanto, se accada, che purtroppo non è caso frequente, di avere su un ms. il verdetto paleo-grafico di un competente, bisogna farne tesoro, né è lecito sbarazzarsene senza fortissimi argo-menti che dimostrino quel verdetto paleograficamente errato.2
A compensare tale mancanza, nelle pagine che precedono si riferisce di un consulto –consulto piuttosto che expertise, perché il giudizio è dato sullo stesso n.a. 333 con ele-menti non organici e in assenza dell’altro codice Plimpton 101, allegato al precedente ocon esso composito (anche questo è aspetto da studiare), scritto comunque dalle stessedue mani. Il risultato priverebbe il manoscritto della palma di vetustà che lo ha sempreaccompagnato e che gli ha meritato un aprioristico rispetto di appartenenza allo scar-
* [email protected] Motta, Robins 2007. Per le altre opere del Pucci mi servo delle seguenti abbreviazioni: Apollonio =
Antonio Pucci, Cantari di Apollonio di Tiro (si cita dall’ed. Rabboni 1996); Bruto di Bertagna = Antonio Pucci, Bruto di Bertagna (si cita da Benucci 2002b); Cantari della guerra di Pisa = Antonio Pucci, Guerra tra’Fiorentini, e’ Pisani dal mccclxii al mccclxv (si cita da Ildefonso 1772-1775, iv, pp. 189-266; Centiloquio =Antonio Pucci, Centiloquio (si cita da Ildefonso 1772-1775, iii-iv); Contrasto delle donne (Il) = Antonio Pucci,Il contrasto delle donne (si cita da Pace 1944); Gismirante = Antonio Pucci, Gismirante (si cita da Zabagli2002); Libro = Antonio Pucci, Libro di varie storie (si cita da Vàrvaro 1957); Madonna Leonessa = AntonioPucci, Madonna Leonessa (si cita da Benucci 2002a). 2 Dionisotti 2003, p. 121.
dittico per antonio pucci - i i 99
so manipolo di codici latori di opere canterine nei termini del secolo xiv, questo al di làdei meriti verso l’autore in corpore.
Se un’analisi completa confermerà il verdetto, ad altra pregiudiziale varrà la penad’appellarsi: a quella pasqualiana dei recentiores non deteriores. Infatti, anche se aggrega-to alla più ampia congerie dei manoscritti del ’400 che trasmettono cantari,1 il cosid-detto Kirkupiano non perde nulla del suo valore per l’opera di Pucci, i requisiti verso laquale si comprendono bene se s’immagina di sottrarre quanto quel codice singolar-mente vi apporta: meno un cantare, drasticamente ridotta la produzione dei serventesie quindi quasi cancellata la testimonianza scandita degli eventi cittadini che costituiscel’ossatura dell’impegno civile. Allontanato nel concreto dall’area culturale dell’autore,o addirittura dal suo controllo diretto (piaceva in altri tempi anche a me evocare in pro-posito l’occhio del Pucci), il codice acquista punti d’intenzionalità conservativa del suomodello per le caratteristiche della confezione, anche trascurando qui, perché perten-gono al più preciso ritratto, alcuni tratti arcaizzanti di corredo. Si constata infatti che latrama delle lunghe rubriche, e in alternanza delle didascalie rimate, nonché della solafirma, va ben al di là, quantitativamente e qualitativamente, della tensione di qualsiasicopista e corrisponde in pieno all’impegno qualificante di un libro di prima mano. Chetale volontà sistematica possa risalire a quel Pucci, dichiarato, ma anche forzoso e infa-stidito, poeta d’occasione, il quale non ha posto rimedio a che la massa delle rime si di-sperdesse in mille rivoli, non apre alcuna contraddizione e corrisponde alle altre circo-stanze in cui lo stesso pone la marca dei diritti d’autore.2 Insomma, l’aura del manufattonon dovrebbe venire intaccata, anche se, in tempi desacralizzati, resta affidato allo scri-gno della memoria il bozzetto oleografico che si ricava dalla lettera di D’Ancona a Ve-selovskij, introduttiva a un pioneristico articolo:
Io vi vengo innanzi con un componimento poetico del trecento che certo non vi giungerà nuo-vo: poiché non credo vi debba esser uscito affatto di mente come, nell’autunno del 67, mentre aldi fuori tutto era tumulto d’armi, noi ci eravamo rinchiusi in una solitaria stanzetta a decifrarepazientemente quel codice antico delle rime di Antonio Pucci, che il buon vecchio cav. SeymourKirkup ci aveva concesso con generosa fiducia e con permissione di trascriverne ciò che più cipiacesse.3
I caratteri esterni del manoscritto qui sopra riferiti corrispondono alla qualifica di apo-grafo diretto assegnata nel vademecum col quale Morpurgo accompagnava il passaggiodel codice alla Biblioteca Nazionale di Firenze,4 qualifica che dal punto di vista testua-le non può essere acriticamente accolta ma pretende conferme dall’analisi, senza pre-giudicare l’inserimento nei ranghi del testimone blasonato.
Non si può dire che fin qui gli editori non abbiano corrisposto all’imparzialità ri-chiesta, anzi si è, al contrario, sfiorato il rischio di deprimere il valore della testimo-
1 Per il numero ridotto di codici del sec. xiv contenenti cantari e sull’incremento delle testimonianzenel secolo xv si vedano De Robertis 1961, p. 121; De Robertis 1990.
2 Per uscire dalla casistica del codice si ricordi l’acrostico costruito con l’iniziale dei canti xxiv-xliii delCentiloquio (Ildefonso 1772-1774, iii-iv): Antonio Pucci Fiorentin. Nell’antologia poetica di sua mano – il Riccardiano 1050 – nella tavola autografa che comprende anche la parte mancante del codice vengono se-gnati solo pochi nomi: in rubrica solo Dante e Petrarca, mentre una volta per ciascuno, a fianco a un lorotesto si scrive il nome di Guido a indicare Cavalcanti, Fazio (degli Uberti) e Antonio, per lo stesso Pucci.
3 D’Ancona 1869-1870, p. 397.4 Morpurgo 1912. M. espone le «ragioni più intrinseche» per le quali «il nostro esemplare non è
lontano dall’autore», quali le didascalie e le sottoscrizioni, rilevando che «questo codice sarà, dunque,fondamentale per l’edizione delle rime di Antonio Pucci».
100 anna bettarini bruni
nianza, che è la constatazione di Paolo Trovato, ad ampio giro sulle recenti edizionipucciane. Il critico apre all’ieri e recupera i risultati di Renzo Rabboni nell’edizione deiCantari di Apollonio di Tiro, per i quali K è testimone frammentario ma assai impor-tante, sia per la presenza di varianti rispetto a tutti gli altri manoscritti, sia per la regi-strazione di una fase di non pieno assestamento del testo. Il movimento entropico, nel-le poche decine di ottave trasmesse, disorienta l’editore, che rovescia il segno delvariantismo e lo giustifica come risultato di precocissima contaminazione, accanto-nando nei fatti il testimone inquinato. Dal troncone improduttivo del disegno stem-matico di Rabboni lo recupera Trovato, discutendo le lezioni relativamente ai lacertiin cui è presente anche K, per proporre un nuovo assetto dell’albero e riaprire su nuo-ve basi la fase della restitutio per l’intero testo. Ci si augura che sia lo stesso Rabbonia raccogliere gli stimoli, e non c’è forse da disperare s’egli è ritornato anche di recen-te su un aspetto minore della tradizione dell’Apollonio, dimostrando di non avere maiarchiviato l’antico argomento.1
2.
Col cantare della Reina comincio ad operare nella tavoletta del dittico che mi spetta coltramite appunto della nuova edizione. La quale, nei capitoli introduttivi, impatta subi-to le analisi di metodo con una progressione dalle problematiche relative al genere, chefanno capo, lungo il filo di lavori dello stesso autore, all’intervento di De Robertis, epo-nimo di tutta la questione, per affrontare quelle specifiche, non coincidenti, ma che tro-vano nelle prime la sponda giustificativa. Per il cantare del Pucci, presentato nella sua‘anomalia’ di testo autoriale, con una trasmissione scritta in apparenza controllabile, manello stesso tempo ad alto rischio di mutazioni rielaborative, si prospetta una soluzio-ne originale che non scarti le alternative «fra manoscritto più antico e testo ricostruitosu base stemmatica nella convinzione che nessuna delle due scelte sia in grado, da so-la, di render conto, sul piano editoriale, dell’ambivalenza del testo e della stessa figuradi Pucci». Mentre mi permetto di segnare con virtuale interrogativo l’associazione fi-nale,2 noto che le direzioni metodologiche così sinteticamente presentate trovano le lo-ro ragioni fuori campo, piuttosto nel pregresso dei due studiosi, in particolare per Mot-ta, che qui si fa carico di curare il singolo manoscritto K, nell’articolata recensione aiCantari di Apollonio, dove vaglia la periclitante costruzione dello stemma codicum e agita«il rischio di scivolare in una sorta di (vano) accanimento terapeutico (?) sulla tradizio-ne»;3 per Robins in un lungo articolo in cui dà un quadro storico delle modalità teori-che con cui vengono gestite le modificazioni in biologia e delle varianti in ecdotica, con-siderando possibile un ponte tra i metodi applicati.4 Lo spazio dedicato nel libro allemotivazioni dei procedimenti è impari: Motta dà per legittimata, quasi implicitamentesulle autorevoli tesi derobertisiane, la proposta dell’unico testimone in ragione della suaantichità, indugiando sulla descrizione linguistica per creare un retroterra ai criteri del-
1 Per l’edizione Rabboni 1996. Sul problema editoriale dei cantari è tornato lo stesso nella lunga recensione-articolo Rabboni 2003 e, con particolare riferimento alla tradizione veneta dell’Apollonio, inRabboni 2008.
2 È possibile qui solo richiamare come e quanto Pucci abbia perseguito coerentemente il suo progettodi cultura vulgata, lavorando in scrittura, prosastica e in prevalenza poetica, mentre niente sappiamo dieventuali pratiche di recitazione diretta. Inutile ricordare che l’appellativo dicitore ampiamente usato nelle clausole è sinonimo riconosciuto di ‘poeta’.
3 Motta 1998, p. 560. 4 Robins 2007.
dittico per antonio pucci - i i 101
la resa;1 Robins invece illustra con puntiglio didascalico le diverse fasi applicative, in con-tinuità con quel precedente lavoro.
Il punto d’incontro che motiva l’abbandono della strada maestra del metodo e che dàcorso all’esperimento è indicato nel fatto che «la tradizione della Reina d’Oriente resistefortemente al concetto filologico di ‘errore’, poiché non presenta casi chiari di errori se-parativi e congiuntivi»; si volge così in diagnosi irreversibile in base alla non evidenza(che però non sempre corrisponde con la non esistenza) di lezioni erronee, una sinto-matologia di per sé almeno controllabile, se è pur vero che la ‘resistenza’ all’errore è lareazione normale di ogni copista.
L’inapplicabilità affermata, non dimostrata, dei principi della logica lachmanniana in-duce dunque da un lato a editare il manoscritto più antico e di maggior autorevolezzasulla traccia di chi in territorio sfavorevole si era già avventurato,2 dall’altro costituiscela condizione per la pratica dell’analisi cladistica – integrata con la statistica e da una par-ziale «recensio qualitativa» – al fine di costituire il testo col fondamento di tutte le testi-monianze. A tutti e due i risultati singolarmente dovrebbe essere riconosciuta validitàdi rappresentazione autosufficiente, pur coi limiti dell’ipotesi di lavoro, in forza fidu-ciaria del relativo metodo adottato. Questo vale tanto più per l’operazione condotta sulla pluralità delle testimonianze, di un lavoro cioè orientato in positivo a un’alterna-tiva praticabile a tutto campo (l’edizione su un solo manoscritto assume fin nel princi-pio ad excludendum la sua parzialità), ma lo stesso operatore avverte che a ovviare allecaratteristiche della tradizione non è bastevole lo stesso procedimento che proprio adesse pareva poter meglio corrispondere. Da qui il ‘dialogo’ dei due testi a fronte, che dovrebbero dare un’immagine compiuta non tanto nello sviluppo piano della sinossi,ma nella visione binoculare, con l’intento di restituire ‘in rilievo’ le modifiche. Fermi alla metafora ottica ci si domanda se, per raggiungere l’effetto stereoscopico, non si richieda almeno il supporto di un commento puntuale che aiuti nella sovrapposizione,dal momento che senza la dovuta guida l’occhio è stimolato solo al confronto contrap-positivo.3
Tuttavia, il lettore non viene certo lasciato senza stimoli, se si considerano gli appa-rati in fascia a piè di pagina, l’uno a minima registrazione degli scarti per l’edizione a
1 Sulla rappresentazione del testo a manoscritto unico si avverte che «si è proceduto con criteri par-ticolarmente conservativi», sui quali si potrebbero avanzare riserve di funzionalità se come dichiarato «sitratta di un’edizione critica e non diplomatica o diplomatico-interpretativa». Tormentato risulta il testoa base M per il primo cantare, con tolleranza di evidenti erronee ripetizioni in clausola, per non dire dialtre precarie situazioni testuali che risulteranno qui dalle tavole. Per quanto riguarda K nella mano prin-cipale ‚, viene riprodotto sempre il raddoppiamento della dentale sorda, un fenomeno che si riconosceessere in molti casi solo grafico, e la selezione sarebbe necessaria per acquisire al fenomeno un signifi-cato linguistico che è quello che interessa ai fini editoriali. Segnalo due casi significativi che riguardanola mano · a proposito della grafia ngi/gi per la nasale palatale, casi nei quali l’editore non è intervenutocome ha fatto invece giustamente altrove (vi si fa riferimento nella descrizione linguistica a p. cxxiv): ii28 8 regiare varrà regnare, il lemma è registrato nel glossario «come possibile incrocio tra reggere e regna-re»; di «incrocio» si parla anche a proposito del lemma insagiata, ma in realtà il ms. ha insegiata evidente-mente per insegnata nella coppia di aggettivi che ricorre anche in Gismirante ii 13 1:«savia ed insegnata».Altre due voci di glossario non hanno ragione di essere: iii 38 4 inguenti ma nel ms. unguenti, così alun-gare relativamente a iv 19 1 alungatti mentre il ms. scrive dilungatti come anche gli altri mss.
2 De Robertis 1961, p. 118 parla di «esperienze di un lachmanniano in un territorio non lachmanniano».3 Insistono con esemplificazioni sulla dinamica testuale i titoli richiamati in Motta, Robins 2007, p.
xvi, come modelli teorici: Segre 1971, Bettarini 1978 e, particolarmente puntuale nel commento, Fonta-na 1992.
102 anna bettarini bruni
manoscritto unico, l’altro giustificativo del testo a base plurima, e in sezione separataquello «completo della tradizione testuale della Reina d’Oriente», encomiabile per lacompletezza anche delle singulares, le quali, si sa, per quanto spostino la lettera in orbi-te sempre più distanti, possono illustrare le cause di iniziale allontanamento. Su quei re-gesti ho acquisito una campionatura di lezioni che sono venute ad arricchire l’elenco diquelle selezionate a testo, legittimate dai rispettivi editori. In più casi non è stato diffi-coltoso constatare la flagranza dell’errore, e questo è stato di stimolo per estendere, nonsenza esito, l’osservazione ad altri luoghi critici, dove la tela grossa della testura avevaquasi assimilato il rammendo all’ordito, a provare la funzionalità dei ferri convenzio-nali, già accantonati. A questo punto la ricerca s’innestava su quella di Paolo Trovato econfermava coi dati aggiuntivi delle tavole lo stemma da lui proposto. Per quanto este-so a tutto il testo, il mio lavoro si presenta con le peculiarità d’indagine esplorativa cheprofitta dei materiali già sgrossati, in subordine all’opera altrui e di conseguenza nonpretende di surrogare la completezza della discussione critica. L’esercizio qui svoltosconta quindi i suoi limiti di fondo.
3.
La prima risultanza generale conferma quanto detto dagli editori, che la trasmissionedella Reina non è segnata da interventi rielaborativi estesi e che anche le alternative pun-tuali sono piuttosto controllate: il pulviscolo delle varianti è più denso nei piani bassi,anche se qualche circoscritta impennata rifacitoria non manca nemmeno nei testimonipiù piazzati. Del morbo endemico della contaminazione, riconosciuto come partico-larmente aggressivo nella tradizione dei cantari, si hanno alcuni segnali circostanziati,dei quali si dà parzialmente conto (e si legga questo come dichiarato difetto) dal mo-mento che non impediscono né alterano il disegno dell’albero. Non si insisterà nem-meno su alcune corrispondenze trasversali, passate ex silentio come non probatorie, inquanto mi sono astenuta, con l’eccezione di alcuni casi implicanti, dal discutere il feno-meno della poligenesi. Mi pare però di potere scagionare la princeps e la tradizione astampa da essa derivata (z), almeno dalla colpa originaria che Robins le contesta, cioèdi essere frutto di sistematico confronto e fusione.
Pur con qualche intrigo negli snodi più remoti che sono meno marcati, lo svolgi-mento delle operazioni di verifica dei rapporti tra i testimoni è risultato praticabilesenza particolari difficoltà, in base alle categorie tradizionali di errore e variante, essen-do richiesto semmai, ma non pare sottolineatura d’eccezione, un certo puntiglio in-diziario. È stato così possibile verificare sul campo l’adattabilità del metodo, pur contutte le accortezze che derivano dalle sedimentate revisioni teoriche e dalle concretecorrezioni applicative. Nella progressione scalare i raggruppamenti si rilevano in mo-do sempre più definito, con l’isolamento di K contrapposto a tutti gli altri manoscrit-ti nel disegno dello stemma bipartito.1 In sostanza, il procedimento ecdotico confer-
1 Del supporto teorico a questo mio percorso faccio emergere soltanto l’esortazione (che è anche unmonito) di Contini 1953, p. 313: «L’eterno circolo e paradosso della critica testuale è che errori predicaticerti servono a decidere l’erroneità di varianti per sé indifferenti: un giudizio non soggettivo si fonda sopra un’evidenza iniziale, che, fuor di casi particolarmente grossi, è o rischia di essere soggettiva. Persfuggire al corto circuito occorre non stancarsi di discernere l’errore sicuro e la variante adiafora, almenonei raggruppamenti alti dell’albero, poiché nei suoi piani bassi poco importa che la variante sia palese-mente cattiva o indifferente; tanto è già in minoranza, sprovvista di autorità. Quella tal cernita s’impo-ne tanto più energicamente se la tradizione abbia […] due rami».
dittico per antonio pucci - i i 103
ma quanto si poteva dedurre dalle caratteristiche esterne, cioè la posizione decisa-mente alta del Kirkupiano e la sua vicinanza al modello, come dimostrato dalla tipo-logia degli errori che corrispondono a infortunî nell’operazione di copia, sanabili an-che con l’ausilio degli altri testimoni: sulla base di questo risultato il manoscritto saràfondamentale per la costituzione del testo e la valutazione peserà anche per la sceltadelle varianti adiafore.
Fra le lezioni equipollenti si devono richiamare quelle che pertengono a elementi trala lingua e lo stile, insieme ad alcuni aspetti di sintassi che insistono sulla struttura del-l’ottava: queste lezioni si presentano con modalità unidirezionale – K vs gli altri mano-scritti – e con conferme di andamento rovesciato. Si potrebbe pensare che il bacino ditali varianti sia il punto più alto della convergenza dei manoscritti diversi dal Kirkupia-no nella tradizione di questo cantare, ma un sondaggio esteso alle altre opere di Pucci,comprese nel codice e che hanno tradizione plurima, ha mostrato analoghe alternan-ze, con K opposto alle altre testimonianze. La tipologia delle alternative (si veda in par-ticolare la Tavola 5b) rimanda non tanto alla procedura correttoria della trasmissione,ma piuttosto ad adattamenti dell’usus scribendi dell’autore, il quale, se in altra occasio-ne si è premurato di dichiarare di non lavorare di lima,1 ha offerto più di un motivo perindurre al sospetto di sue operazioni di ritorno proprio nei testi contenuti nel Kirku-piano.2 Ciò non può essere ignorato nel tracciare i piani più alti dello stemma. La di-mostrazione della convergenza di tutta la tradizione è affidata a prove che paiono de-boli per postulare un’entità intermedia, mentre resta la possibilità che il disegno sichiuda in un codice d’autore da cui dipenderebbe da un lato il solo K, dall’altra i restantimanoscritti, con gli snodi dimostrati qui di seguito, in subordine tutti a un antigrafo, de-positario di quel lavoro di revisione che rende sistematica, nei diversi testi del Kirkupia-no, la contrapposizione tra quel manoscritto e gli altri testimoni.
L’assenza di K per tutto il primo canto più un boccone del secondo rende più com-plicata l’opera dell’editore del cantare. La soluzione di Motta è stata quella di supplirecol manoscritto M, una volta provata la sua vicinanza al Kirkupiano nello schema di Ro-bins. L’assetto stemmatico che qui sosteniamo non consente operazioni semplificate: inassenza di K il testo dovrà essere ricostruito sulla restante tradizione che converge in ununico punto Ì. Per l’articolazione ancora a schema bifido dei manoscritti sotto quellosnodo, il criterio di maggioranza premierà M, che rappresenta uno dei rami, se in con-cordia con singoli testimoni o con uno degli altri raggruppamenti, e farà orientare inquello stesso senso la scelta nei casi di sicura equivalenza delle varianti, ma sarà al con-tempo possibile valutare le pecche di quel manoscritto e isolarne le individuali lezioniinnovative. In questa parte verrebbe posto a testo il ‘sistema’ in certo modo alternativoa K,3 altrimenti a distanza nell’apparato, sistema in cui, a quanto sopra si è detto, si con-fonde la mouvance della fortuna col processo di revisione autoriale.
4.Le tavole che seguono si riferiscono allo stemma di Paolo Trovato (sopra, § 7). Si ri-prendono le sigle adottate da Motta, Robins 2007: Bologna, Biblioteca Universitaria, 158(U); Firenze, Biblioteca Marucelliana, c 265 (M); Firenze, Biblioteca Moreniana, Bigaz-zi 213 (B); Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano viii 1272 (N); Firen-
1 Nella prosa introduttiva al Centiloquio.2 Parla esplicitamente di diverse redazioni d’autore per il Contrasto Pace 1944, e ne dà conferma De-
benedetti 1944, p. 95. 3 Nel senso della definizione teorica di Segre 1978.
104 anna bettarini bruni
ze, Biblioteca Nazionale Centrale, n.a. 333 (K); Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale,Panciatichiano 20 (P); Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2725 (F); Firenze, Biblioteca Ric-cardiana, 2971 (R); Paris, Institut de France, Manuscrits de Léonard de Vinci, Manuscriti (I); Roma, Università degli Studi «La Sapienza», Biblioteca Angelo Monteverdi, FondoMonaci, ms. non catalogato (S); Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Bor-giano latino 384 (V). Quando possibile, registro anche il comportamento dei manoscrittiframmentari I, N, P e R, che, com’è naturale, ricorrono sporadicamente nelle tavole.Adotto una rappresentazione interpretativa.
Per cominciare, verifichiamo la tenuta del gruppo · di Robins (SUV + z):
Tav. 1. Errori di · (= SUV + z).
SUV + z Alii
ii 25 4 di figliuol maschio (+ z) di figliuol maschio avere
L’ipometria conseguente non è compensata dai diversi esiti del secondo emistichio. Robinssegnala il luogo senza dichiarare l’errore («la lezione di BFKM è leggermente preferibile»).
iii 31 1 selva scura selva dura
L’associazione con l’aggettivo è prodotta dall’eco dantesca, come rileva Robins, ne derivaidentità di rima col v. 5 della medesima ottava, valle scura.
iii 31 8 scuro buratto VU, oscuro S chiuso buratto
È un caso di errore riflesso: vedi v. 1.
iv 42 7 ma chi ma chi qui
Errore per aplografia.
Fin qui l’elenco coincide con quello di Robins. Si possono aggiungere:
ii 13 3 perché (+ F) che (ché nell’edizione) perché
Viene avvertita la difficoltà della doppia congiunzione e si risolve, gordianamente, la caren-za sintattica compensata di seguito dal solo S; l’errore – poligenetico per F – varrà come con-ferma.
ii 28 5 armegiando (+ z) armegiâr
Verrebbe a mancare il verbo reggente; l’alternanza si spiega con la presenza di un gerundio nelverso successivo, il che potrebbe giustificare anche per poligenesi la presenza dell’errore in z.
iv 39 3 e tanto rio (+ z) ch’è tanto rio
La relativa risulta necessaria nell’organizzazione sintattica.
Non si può invece dichiarare errata l’alternativa i 45 8 e disse i’ VU + z, poi disse i’ S, che pre-tende per la misura dialefe prima del pronome i’ rispetto a ma pur disse io BF (K manca e Mlegge «ma pure io verò, per vostro amore», cioè omette il verbo; e anche qui si deve fare di-stinzione sillabica tra pure e io). Robins indica come «preferibile» la lezione di BF e in parte diM «per la congiunzione contrastiva».
Dagli apparati si possono estrarre un numero limitato di varianti a conferma del grup-po. Si anticipa, al solito, la lezione dei manoscritti in oggetto:
dittico per antonio pucci - i i 105
Tav. 1a. Varianti di ·.
SUV Alii
i 34 3 alzò i panni alzossi i panniii 10 7 dispogliate V spogliate US (-1) le spogliateiii 4 5 santo padre SV, padre santo U santo papaiii 6 4 il figliuolo mio figliuol mioiii 5 2 santo pastore UV divino p. S sommo pastore
Anche se santo si ritrova al verso successivo in Padre santo (di qui forse la scelta di S) non si puòdichiarare erronea la ripetizione in presenza del differente appellativo.
U e V presentano coincidenze che Robins specifica secondo alcuni parametri quali «varianti significative» (Motta, Robins 2007, pp. lxxxiii-lxxxiv):
Tav. 1b. Errori di UV.
UV Alii (incluso S)
i 30 inversione delle coppie di versi 5-6, 3-4iii 14 6 fattura fu di donna Berta ria piangendo fortemente tutavia
S ha la lezione individuale dal capo al piè (che ricorre al v. 5 dell’ottava successiva) a quella donnapia.
iv 28 8 signor della Spina (: reina) U, reina reina Galatea (: havea)della Spina (: con dottrina) V
La lezione obbliga all’adattamento della rima di v. 7, operazione con esiti diversi nei due mss.Da notare che V interviene in maniera identica a sostituire il nome in clausola, nell’unico al-tro caso in cui questo si presenta, a iii 11 2, con effetto sull’uscita -ina dei vv. 4 e 6, opportu-namente riparati ad indicare l’intenzionalità dell’alternativa.
La casistica è troppo esigua per dimostrare un rapporto privilegiato tra i due mano-scritti; sottolinea piuttosto lo smarcamento di S, che verrà confermato nel corso del-l’analisi. Di «promiscuità» di S parla Robins (Motta, Robins 2008, p. xcvii).
Pochi errori significativi, ricavati al solito dallo spoglio degli apparati, uniscono S e U:
Tav. 1c. Errori di SU.
SU Alii (incluso V)
i 22 7 onde partiva ciascuno lagrimando S, sicché si partirono l.onde ciaschuno parti l. U (+ ciaschedunopartiva l. z)ii 25 2 segreta stata (s. fu stata S) segretiera stataii 25 8 che ài lo senno (+1) ch’à’ ’l senno tuttoii 26 4 om. l’avverbio cilato K, cielata F, cielatamente VB,
segretamente ziii 7 7 i’ son contenta (-1) i’ son più che contenta
Con soluzioni indipendenti per risolvere l’ipometria.
106 anna bettarini bruni
SU Alii (incluso V)
iv 30 6 ora m’aita (+ z) non m’aita
La frase positiva non dà senso.
i 50 3-4 e die’ U, diede S / om. die(de) om. die(de) / die’
Anticipazione del verbo, che gli altri mss. hanno al verso successivo.
Si aggiungono altri casi che riguardano la misura dei versi:
i 42 6 certamente (-1) veracemente
iii 16 8 poi (-1) sì che
Con soluzioni diverse all’interno del verso le quali compensano la misura.
iv 23 8 che giunse dove in prigione era che giunse ov’era in prigione il maritoil marito (+1)iv 29 3 mandisi + z (-1) Mandivisiiv 37 4 non (io non U) mi impacerò (-1) non mi impacerò più.
U evita la dialefe col pronome io.
Raccolgo a conferma varianti caratteristiche di SU:
Tav. 1d. Varianti di SU.
SU Alii
i 13 7 son son già
i 15 7 donne (+ B + z) figlie
Ripetizione: la voce donne è presente al v. 5.
i 29 5 e veramente veracementeii 11 4 venir (+ z) premer
Ripetizione: il verbo è anche al v. 2.
ii 11 7 e iniz. om.ii 13 3 a (da) Dio sè stata istata sè di Dioii 23 4 molta gente (+ z) gran genteiii 4 3 costui questi
iii 13 6 è comandato (+ F) comandato
iii 17 4 ella rispuose ed ella disseiii 37 3 che ’l re (+ B) ched e’
Il re anche a v. 1.
iv 24 8 teneva à tenutiiv 25 6 temean U, temevano S temeroniv 26 5 messaggio messager
dittico per antonio pucci - i i 107
Per le quattro ottave in cui è presente, P affianca V; in alcuni casi le lezioni sono indivi-dualmente partecipate dagli altri mss. del gruppo, da S soprattutto, e da U. Nella tavo-la precedono le lezioni di PV:
Tav. 1e. Accordi PV.
PV Alii
i 1 1 O somma Maestà Superna maestài 1 5 similemente umilementei 2 5 ond’io (+ z + S onde) po chei 2 7 chio vi prometto (+ U) però ch’io credoi 3 3 e da levante infino a ponente (+ S) non fu mai da levante a ponentei 3 4 non fu ma’ donna (+ S) di tanto donna che fusse di sì grani 3 7 giovane e bella era (+ S) era giovane e bella
Il manoscritto P ha vari errori singolari: ricordo solo l’inversione tra i vv. 7-8 della pri-ma ottava. Non ci è dato rilevare dall’apparato errori o lezioni singolari di V non ripro-dotte da P, sì da escludere la dipendenza diretta di quest’ultimo, dipendenza che restaquindi possibile.
Il gruppo ‚ (Robins) è composto dalla coppia BF. Se ne ripropone la dimostrazione:
Tav. 2. Errori di ‚ (= BF).
BF Alii
ii 49 3 e se ’l nostro si spoglia co la sposa se ’l nostro re si spoglia co lla sposa
Robins si limita a definire «preferibile» la lezione dei mss. diversi da BF, ma il salto del sostantivo monosillabico si può legittimamente considerare erroneo.iii 15 7 e po’ le disse quella be ll’adochia e poi le disse quando ben l’adocchiaF, e po le disse quella dama bella B
Il forte rimaneggiamento di B mantiene l’erroneo dimostrativo, derivato forse dall’incom-prensione della grafia compendiata qu(ando).
iii 17 7-8 e chosi dice il re che sono assai| s’e’ chosì dicie i rre ch’a senno assai|contenti più ched e’ fussem giamai B, più i’ son contento più che fossi maicontento ch’i’ fussi mai F
L’errore al v. 7 consiste nel fraintendimento sono per senno.
iii 44 3 donna Bella Spina donna della Spina
La lezione di BF viene segnalata da Robins come lezione alternativa. In realtà lo scambio pre-posizione-aggettivo nasce da una accidentale sostituzione della lettera iniziale, come si rica-va dal corrispondente toponimo rocca della Spina.
iii 44 7 alla sua rocca andò dove dovea gire alla sua rocca donde dovea gire
Robins non parla di errore, ma la manipolazione, che crea tra l’altro ipermetria, risponde al-l’esigenza di appianare, non senza colpa, una sintassi contratta, si veda un caso simile a iv 16 3.
108 anna bettarini bruni
I due manoscritti coincidono in lezioni che Robins appella «varianti significative»:
BF Alii
i 23 4 gagliardi tutti quanti e pien di posse che dieci tanti non temien percosseiii 14.7 disse sorella (sirochia F) omo e disse (dicendo) come tu femina sono(huomo F) io non sono
Si dà anche un caso di condivisa deficienza nella misura, che potrebbe essere poligene-tica:
i 42 6 veramente BF + z (-1) veracemente Alii
I due mss. condividono poi altre lezioni, tra le quali due considerate da Robins alla paridei casi qui giudicati erronei, ma che vanno degradate a varianti (le indico con una R):
Tav. 2a. Varianti di ‚.
i 20 7 ora oma’i 29 6 fa bisogno (+ V) fa soggiorno
È formula sintagmatica.
i 40 2 ciento sessanta chom mille dugento B, sessanta sei con se’ milia davanti (davanticento sessanta due [il resto del v. bianco] F per ripet.) M, settanta (s. due V) con tremilia
secento UV + zi 40 6 (R) di sua venuta n’avrie pentimento di sua venuta avrebbe pentimento
La particella pronominale è nella maggioranza dei mss., incluso B, al verso precedente.
i 45 6 che mossa prima (+ V che mossa in prima) se prima mossaii 33 1 (R) Se voi farete (fate F) tanto che lui E se voi fate sì ched egliii 39 5 drappo a oro drappo d’oroii 42 7 se ne sapete ch’a lei si confaccia se ne sapette alcun ch’a lei si facia (afacia SM)
BF omettono l’indefinito per il quale gli altri testimoni trovano soluzioni differenti; insiemea z propongono anche un verbo alternativo a si faccia di K e V (afacia SM). E si deve sottoli-neare come l’uso di fare nel significato di ‘convenire’, ‘essere adatto’ sia attestato in it. ant.(per tutti i casi l’incipit di Chiaro Davanzati Lo nome a voi si face, ser Pacino). La lezione alter-nativa di BF è dunque sospetta di rifacimento banalizzante.
ii 46 8 son presto a far io son per fariii 43 4 che io mi parta ch’io mi diparta
Le conseguenze per la misura potrebbero essere ovviate con la lettura che ˇ io.
iii 44 5 pensava (+z) e pensòiii 50 3 sappiate pensate
I rumori di fondo già segnalati nel gruppo ‚ si avvertono anche in ·, dove è U ad averelezioni comuni con BF, alcune semplicemente formulari.
dittico per antonio pucci - i i 109
Tav. 2b. Accordi in errore o in innovazione ‚+ U.
BF + U Alii
i 23 7 batoli mantella M, mantello S, mantè z, panni V
Di particolare interesse la proposta di BF + U, batoli. Il vocabolo indica un mantello propriodei medici, descritto da Giovanni Villani, lib. 13, cap. 4 (Porta 1990-1991, iii, p. 302) e attestatoin Decameron viii 9, nella forma assimilata batalo (Branca 1996, p. 559) e nel Trecentonovelle,novv. 42 e 155 (Piccini 2004, pp. 161 e 427). Il lemma col suo carattere tecnico-localistico po-trebbe avere tutti i crismi della lectio difficilior; propongo tuttavia di valutare questa alternati-va di minoranza insieme ad altri casi per i quali si rinvia a quanto osservato alla Tavola 6a aproposito di iv 14 8.
i 36 1 santa corona (+ z) Santo padre MS padre santo Vi 37 4 visitare (+ z) invitarei 40 1 om. è (+ z) è
La frase può al limite reggere la sintassi nominale, ma il verso presenta un accento di 5ª.
i 40 5 sei cotanti (+ z) tre cotantii 50 4 morta cadde BF (+ z), cadde morta U in terra cadde VSiii 2 7 tremasse v’entrasse
La lezione di BFU non dà senso; si può trovare una spiegazione in qualche effetto di riverbe-ro della voce di chiusa del verso successivo, effetto non razionalizzabile anche perché con esi-to differente nei diversi testimoni (’ntronasse, versasse, rovinasse…).
Vanno aggiunti casi che vedono insieme i soli BU:
B + U Alii
i 7 7 dicendo pensandoi 9 5 gravandola (+ z) gravando
Con adattamenti diversi per la misura.
i 15 6 lor mani le manii 45 6 facessi con meco fussi con meco
5.
Dopo la conferma su dati in parte coincidenti delle famiglie · e ‚ individuate da Robins,le scelte di metodo comportano un differente percorso nella dimostrazione della con-vergenza dei due gruppi · e ‚ in alternativa a KM ed alla tradizione delle stampe z. Inrealtà i soggetti implicati vengono a coincidere in una serie di lezioni, delle quali soloalcune possono qualificarsi, per di più dubitosamente, come errori. Si dà valore alla na-tura delle varianti e alla loro consistenza quantitativa, restando comunque nell’ambitodel ‘revisionismo’ neolachmanniano. A conferma di quanto sopra notato, S manifestaancora qualche stravaganza.
110 anna bettarini bruni
Tav. 3. Errori comuni di ‰ (= ·+ ‚).
SUV + BF KMz
ii 19 8 e benedillo e poi (e poscia SV + F) e benediselo (benedisse M) e poi
L’alternanza di per sé non erronea ha riflesso sulla misura, di seguito sanata da VS + F con po-scia invece di poi: solo B e U porterebbero ancora lo stigma dell’originale carenza di gruppo.
iii 42 1 Poi ch’ebbe poi ch’ell’ebbe
In assenza della testimonianza di U, non è possibile escludere che la coincidenza possa deri-vare da poligenesi.
iv 33 6 uno in mano V (+ I), uno in un’anca di lor KM, un’anca avea in bocca z,braccio S, um n’avea in mani B uno avea nancha N
La posizione di U è smarcata rispetto al gruppo, forse per effetto di contaminazione: ad artelor l’anche.
Ci sono casi in cui non è facile stabilire il confine tra banalizzazione e errore (essendolezioni del quarto cantare manca la testimonianza di F):
SUV + BF KMz
iv 11 4 una malvagia e rea B, una malvagia piesima (pessima Mz) giudea (+ pessima ereina V giudea S) K
V adatta la rima per esigenza di lectio singularis.
iv 21 4 ciaschuno sgumbrasse SB, subito sghonbraser (isgombrassin) KMzogniuno si ritornase V
Il pronome potrebbe essere stato anticipato da v. 6; da quello stesso verso V recupera il verbo.
iv 26 2 mal far VUB campar KM +S, scampar z
Il verbo rende la disposizione negativa ampiamente dichiarata nell’ottava precedente e nonla nuova sfumatura intenzionale.
iv 26 8 che tu (che nne U) meni presa (+ R) che menate presa
Si noti in KMz il plurale maiestatis in bocca al re, come a iv 18 2, dove si ha analoga alternan-za delle attestazioni.
iv 41 4 ch’eran fugiti (fugite) prima ch’eran fugiti (fugite) prima paventando K, sospirando (+ R) …spaventando Mz + S
Come a iv 26 2, S non è allineato col gruppo di appartenenza. Proprio perché muoversi sospi-rando è topico (ricordo qui due esempi pucciani, col gerundio in clausola, Novello sermintese,2 e Cent. 6 286) la variante può essere guardata come scelta facilior.
Segue l’elenco delle lezioni caratteristiche di ‰:
dittico per antonio pucci - i i 111
Tav. 3a (varianti di ‰).
SUV + BF KMz
ii 29 7 parea veramente parea veracemente
L’impiego in ‰ di un avverbio con una sillaba in meno è compensabile con la lettura trisilla-bica del verbo.
i 40 5 sei cotanti (+ z) tre cotantiii 30 7 appresso fe’ tornar ed ella fe’ tornarii 34 3 quando la madre se lla reinaii 36 7 sicché tornasse bene accompagnato sicché paresse bene accompagnatoiii 2 5 e non fu mai ch’el (ch’e’ Mz) non fu maiiii 16 7 la qual era (è F) ita tutta notte la qual danzando era gitta (ita M) dintornoattorno VBF; li quali (che S) erano iti tutta KM, danzando andando dintorno znotte intorno SUiii 32 3 tormi la vita tormi l’anima (+ F)iii 33 1 Il cerbio giunse e inanzi a lui sogiorna Giugnendo il cerbio innanzi li sogiornaiii 37 3 ched e’ tornava V, che tornava (-1) chom’el tornava K, chome tornava MzF, chel re tornava SUBiii 37 7 quando fu giunto SVBF, come fu giunto U e come giunseiv 16 6 chi di prigione l’avea fatta (facta uscire chi l’avea fatta di pregione uscirel’aveva S)iv 20 7 ond’io sì ch’ioiv 33 1 nero come un calabrone (+ NI) tutto nero come carbone (+ U)iv 34 8 per paura per temenza
Altre varianti che saranno imputabili a ‰ si possono rilevare anche in assenza di K (cioènei cantari i e ii 1-10):
Tav. 3b. Varianti ‰ in assenza di K.
‰ Mz
i 7 4 papa santo padre (pare M) santo (+ U)i 13 3 al papa andava andava al papa (+ U)i 14 6 farò farà (+ R)
La variante di Mz implica l’uso del discorso indiretto.
i 19 1 d’Oriente de l’Orîenteii 3 8 infino che ’nfino (che ’nsino z)
Circola in ‰ la lezione alternativa battuto avea la sugna UF, avien batutto la sugna V, modo di di-re altrimenti non attestato che Robins spiega come ‘se l’erano sbrigata’, ma al quale darei ilsenso opposto: ‘avevano tergiversato’; gli altri manoscritti hanno la rima equivoca pugna ‘pu-gni’, e poi ‘battaglia’ in avìen vinto la pugna M, avevano vinto la pugna S, aveam facto la pugna B,facto havien la pugna z.
112 anna bettarini bruni
Si può segnare un punto di convergenza più alto (Ë) in presenza di errori comuni di ‰+z vs KM:
Tav. 4. Errori comuni di Ë.
SUV + BF + z KM
ii 27 6 ghuardando B, dicendo VSz, ridendo U gridando
La diffrazione è indicativa e nasce forse da un fraintendimento tipo quello di B sulla lezioneregistrata da KM. Il verbo gridare, che pure parrebbe eccedere il lieto annuncio (si veda in pro-posito U che evidentemente reinterpreta), rende l’idea dell’ampiezza della pubblicizzazionecome risulta dall’ottava seguente; del resto quello stesso verbo al gerundio e spesso in posi-zione iniziale nel verso ricorre in molti casi nella narrazione del Centiloquio.
iii 19 3 al re (il re B) parlando brieve parlando
La pletorica esplicitazione del destinatario viene a sostituire per guasto o incomprensione laformula di KM, formula usata da Pucci due volte nel Libro, alle pp. 99 e 257.
iv 16 3 andò il messaggio e ritornò onde il messaggio (onde il re M erroneo) ritornò
lezione rimaneggiata su un fraintendimento (come a iii 44 7, dove BF presentano lo stessoscambio donde / andò) o per semplificazione della sintassi narrativa.
iv 26 1 marina SUBz riva (: veni(v)a: apari(v)a) + V
V corregge per contaminazione o per (facile) congettura.
Aggiungo il caso seguente, significativo nonostante la mancata compattezza del gruppo:
ii 26 4 celatamente (segretamente z) un fanciul celato (cielata + F) un fanciul maschio fefe venire VBz; un fanciul maschio chella fe venire(a se fece S) venire US con l’omissionedell’avverbio
Analogo uso avverbiale dell’aggettivo in Noie 224 (e glossario dell’edizione McKenzie 1931).La considerazione d’usus porta la variante alternativa a celato al limite dell’errore.
I manoscritti di ‰ omettono inoltre il nome dell’autore nel verso di chiusura:
iii 50 8 al (a V) vostro onor finito è (à F) Antonio al vostro onor finito (compiuto M)à il cantar (canto terso B) terzo il terzoiv 44 8 questo cantare è detto VU, Antonio Pucci (Pocci M) il fececompiuto è questo cantare (+) S, qui èchompiuto i·libro B, questa istoria è finita ziv 18 2 i’ verò con teco Veremo con teco
Si noti ancora l’uso del plurale maiestatis come a iv 26 8, nella Tavola 3.
Confermano le seguenti varianti:
dittico per antonio pucci - i i 113
Tav. 4a. Varianti di Ë.
VUSBFz KM
ii 17 3 ricchezze che à richezze sue
ii 39 1 per tutto il contado V, per lo per suo contadocontado UBF, per lor contado z
iii 5 5 furon mossi fursi mosi (fursi vedi Centiloquio 16 37, 25 146)furonsi mossi M + S
iii 28 2 gioia e festa VU, festa SBFz festa e gioia, così sempre in numerosericorrenze nelle opere di Pucci
Si potrebbe anche pensare che l’ordine di VU derivi da un recupero in presenza dell’omis-sione rappresentata dagli altri mss. del gruppo.
iii 40 4 per trar d’errore per trarne d’er[r]o
iii 41 2 trovarsi VF, trovarselo SB, ritrovarsegli z trovarlosi
Si noti in trovarlosi l’ordine arcaico dei pronomi personali.
iii 43 7 ed è onde
Ed è è anche a v. 5: può tratttarsi di errore di ripetizione, ma l’alternanza si propone nel casoqui di seguito registrato:
iii 48 2 ed e’ ond’el
iii 49 6 truova V (-1), trovava BF, trovando Sz trova mai
iv 5 8 si vincesse VSB, si perdesse z s’arendesseiv 13 8 schavalcando V, ischavalcando SBz eschavalandoiv 15 6 questa paterina quela patterina
Questa è anche al v. 4.
iv 19 5 fu preso il re con tutta sua famiglia il re co la reina e lor famiglia (+ S lor figlia)iv 19 6 e tutte l’arme tolte lor da lato fur (furono M + S) presi e tolto lor l’arme da
latoiv 29 5 la terra tutta VB, e quella terra U, tutta sua terra (+ S)tutta la terra z
Il raggruppamento VUSBFz si conferma anche in presenza del solo M:
Tav. 4b. Errori di VUSBFz vs M.
VUSBFz M
i 36 8 castello della milizia (: letizia) castello delle melizie (: letizie) M, delle milizieV (: letizia)
L’oscillazione di V in rima imperfetta (milizie: letizia) è significativa e pare frutto di un recu-pero individuale; infatti l’alternanza di singolare e plurale non è indifferente se si tratta di un
114 anna bettarini bruni
nome proprio, come nel caso si ricava da Giovanni Villani, lib. 9, cap. 6: «Comperò il castellodelle Milizie di Roma, che fu il palazzo d’Attaviano imperadore e quello crescere e reedifica-re con grande spendio» (Porta 1990-1991, ii, pp. 20-21).
Segue l’elenco delle varianti di Ë vs M; nella serie non selettiva la sottolineatura di casiinteressanti è affidata al breve commento:
Tav. 4c. Varianti di VUSBFz vs M.
VUSBFz (+ PR) M
i 1 6 ti chieggio chiegiotii 2 6 priegovi che vi piaccia d’ascoltare per dio signori (pero signori S) vi piaccia
d’ascoltarei 2 8 più bella sì bellai 3 5 e ’l marito era vecchio e ’l suo marito (+ B) vecchioi 4 7 nel mondo del mondoi 4 8 gli avea gli volea (+ P)i 6 1 l’altissima reina questa gentile reginai 7 6 per ubidenza VSFz (per ubidir U) per riverentiai 7 8 quel ch’io vorò pur quel ch’ïo voròi 8 7 richieder la fate (fatela richiedere F, z cambia) però cetar la fate che
Motta integra ce[r]tar ‘accertare’, ma si tratta in realtà del verbo citare (la forma viene regi-strata, anche se con una sola occorrenza, in tlio: Banchi 1866, p. 23). Di per sé le due lezionisono equipollenti: si veda però all’ottava seguente il v. 2, ch’ella fosse richiesta.
i 9 8 sugel papal segnale papale
Vero è che segnali si trova al v. 5, ma la ripresa, tanto più con l’aggettivo individuante, pareammissibile.
i 10 2 quell’ambasciata questa inbasciatai 11 3 più ch’altr’uom sopra a ogni omoi 12 4 rispuose il savio messagiere (messaggio savio S) onde rispuose el mesageroi 13 3 al papa andava andava al papa (+ Uz)i 14 3-4 che comparisse (comparisca) fra che in persona, fra cinquanta giorni /cinquanta giorni / so’ (sotto VSF, a BRz) a pena della vita fusse a cortepena della vita fosse a corte
Al v. 3 il verbo potrebbe essere stato introdotto per un chiarimento al limite della banalizza-zione.
i 16 1 E (Poi R) ragunato chebbe (l’ebbe U) Raunato a suo modoi 16 3 dopo il bel proponimento dopo il suo proponimentoi 16 4 avie mandata gli avia datai 16 7 dicendo e disse (+ S)
A iii 14 7 si ha analoga alternanza nella stessa sede dell’ottava, ma vedi anche i 34 5, i 35 4.
dittico per antonio pucci - i i 115
VUSBFz (+ PR) M
i 16 8 E dopo lei un conte Dopo lei uno gran conte
i 18 3 Io (e io BFRz) vi vo dar BFU vo dar R, E ciò dare’vi darò S (V manca)
i 21 6 ad elmo (ederom F, almeno z) diecimilia armati diecimila cavaliericavalieri
Lo stilema ad elmo si ritrova nella testo cronachistico pubblicato come Gesta florentinorum (San-tini 1903, p. 144). Pucci ha l’analoga forma coll’elmo ad indicare il corredo di truppe armate inCent. 33 113; la lezione di M è meno tecnica, ma si veda quanto detto a iv 14 8 nella Tavola 6a.
i 23 6 menò con seco e’ menò seco
i 25 3 eran guidati (era gliadati F) eran guardati
i 25 6 perch’ella perché
i 25 7 a ogni carro (sopr’ogni c. U) in su ’n ogni carro (+ z)i 26 3 quanto VUz come BF l’ermellino più che l’ermellino (+ S)
i 26 5 sopra ciascuno aveva e sopra ognuno erai 26 7 perle e gemme BF, pietre e gemme Uz, gemme e perle (gioie e perle S)pietre pretiose V
i 27 3 valevan più valeva più
In M si avrà terza persona singolare con soggetto plurale o forma assimilata.
i 27 4 magno fornimento maggior fornimentoi 27 7 com’ella e comei 32 2 che d’esto (che nostro F) mondo di questo mondo (+ US)i 32 6 di cosa (cose S) ch’i’ mai non (nol U) di quello ch’io non comissi maipensai (non pensai mai Sz, non feci mai F)i 34 1 E poscia (e poi gli z) Apresso (+ U)i 34 5 e disse (poi disse S) dicendoi 35 2 donna santa santa donnai 35 4 disse: Per quello Idio dicendo: Aquello Idio
Da confrontare, sopra, con i 34 5. Nell’ottava in esame il verbo al gerundio è ripetuto dal v. 2e preceduto da altro gerundio, per cui il periodo pare reggersi tutto sul verbo a tempo finitodi v. 1. La costruzione trova un riscontro esemplare in Gismirante ii 27 e, in modo semplifica-to, a ii 57.
i 35 4 per quello a quelloi 35 7 voglia (grazia z) chesta (chiesta S, inquesta F)i 36 3 che ch’ioi 36 7 se n’andò con gran letizia n’andò piena di letiziei 38 7 e Roma vuol e ciò vuol fare
e Roma vuol riprende apertamente il v. 4 dell’ottava.
116 anna bettarini bruni
VUSBFz (+ PR) M
i 39 5 quando suona quando e’ suona
i 40 2 diffrazione [i dati alla Tavola 2a] sessantasei con semila
I numeri col sei sono topici anche per Pucci: si veda per semila in questo cantare a iv 33 7 eCent. 39 77, 40 8, 43 74, 46 51, 46 150.
i 40 7 ma priego e priego
i 41 8 tal briga questa guerra
Questa guerra è in verso ipermetro (← esta?).
i 43 5 volete (voleste B, voresti F) vorete
i 44 5 se le potete (poteste UB) s’i’ le potessi
i 44 6 sarò sare’ (saria U)
i 46 4 a seguitarmi di seghitarmi
La differenza è nella preposizione; la forma del verbo seghitare risulta nel tlio un’altra volta nelle Chiose del falso Boccaccio (Vernon 1846, p. 218).
i 48 5 allora tutti
i 49 7 offesa inpresa
i 50 4 in sulla testa | die’ tal che morta (in terra VS) in su la testa | le die’ un colpo
La lezione di M va confrontata con Gismirante i 42 2 «e diegli un colpo, che cade stordito».
ii 1 8 quella alta reina questa alta reina (+ F)
ii 3 5 e quando quando (+ S)
La misura si mantiene per una lettura dieretica süa.
ii 4 4 e d’ogni (d’ogni U, e ogni F) arnesi con tutti arnesi
ii 4 4 a caminare a [ca]valcare (cavalcare F)
ii 4 6 partianci partiàno
ii 4 8 siàn tutti tuti siàno (+ S)
ii 5 8 fia sia
ii 6 8 po’ ti potrai tornare e po’ ti puo’ tornare
ii 8 8 pietosi sì che ci perdoneranno piatosi sì ch’esi perdoneranno
ii 9 3 a lor volere (per loro v. U) al suo volere
In assenza di K si riscontrano lezioni insoddisfacienti sia in M che in Ë.
dittico per antonio pucci - i i 117
Tav. 5. Errori comuni a Ì (= Ë+ M).
i 27 1-2 le some|de’ muli con campanelle d’ariento SUVBFz, le some|e ’ muli con campanelle d’arientoM
Le lezioni d’impatto non paiono erronee, ma il rinvio a un passo di Giovanni Villani, lib. 11,cap. 1: «MD some a muli a campanelle» (Porta 1990-1991, ii, p. 522), nel quale l’associazione«some a muli» = ‘muli da soma’ si mostra quale tecnicismo, mette in crisi sia la coordinazio-ne di M che la resa facilitante degli altri mss. La validità dell’accostamento è confermata dalparticolare aggiunto degli accessori (le campanelle) delle cavalcature.
i 28 1 per lo suo tereno V, per lo lungho tenea F, per lo suo reame S, per lunghessa Bz, e coreva pel suoM, e per lo suo coreva U
I numerosi interventi singoli possono essere la reazione a una lezione insoddisfacente: e co-reva pel suo M, e per lo suo coreva U, detto di un fiumicello per cui altri cercano di chiarire: perlo suo tereno V, per lo lungho tenea F, per lo suo reame S, per lunghessa Bz). L’ipotesi più economi-ca rasenta la banalità: e coreva pel suo[l].
Si aggiungono alcuni casi in cui si presentano questioni di misura dei versi:
i 28 2 che usciva del paradiso luziano omnes
La presenza dell’aggettivo lutiano/luziano che ricorre a iii 39 7 e in Madonna Lionessa 47 7 e 487, sempre quadrisillabo, fa pensare che tutti i manoscritti eccedano nella forma usciva, da correggere uscìa.
i 42 7 ond’egli disse: «I’ son più che ’nprima preso» (+1) UVBz ond’egli disse: «I’ son più prima preso M
Il taglio di M più prima sacrifica la sintassi e il senso, mentre la soluzione di SF ond’e’, accettabile e quanto mai accessibile, è probabilmente poligenetica.
ii 8 2 de’ dua partiti l’uno ci convien pigliare (fare U) (+2) VUMF, de’ dua partiti l’un convien Bz,de’ dua partito l’uno è da pigliare S
La diffrazione reagisce variamente all’ipermetria.
ii 9 2 egli è meglio fare una morte che cento VUSMF, me’ fare Bz
iii 10 2 spregia (ispregia) lusuria e loda verginitade omnes
Levi 1914 proponeva la forma sincretica vergintade accolta da Robins, sul tipo dell’esistente cristentade, ma potrebbe forse leggersi in episinalefe con e iniziale del verso successivo.
Interessa vedere confermata la convergenza di Ë e M in presenza di K. Nella casistica sianticipano gli errori o le rielaborazioni che hanno a monte un fraintendimento:
Tav. 5a. Errori di Ì (= Ë+ M) vs K.
VUSBFz + M K
ii 43 5 però ch’egli à si bella appariscenza V, però che sola del’aparisenzaperò che s’ella (ched ella S) à bella a. BS,
118 anna bettarini bruni
VUSBFz + M K
però che s’ella è bella d’adornanza U,però ch’è si bella lappariscenza z,però s’el’ à bella appariscenza M
La lezione di K è qui data con divisione delle parole differente rispetto a quanto reso da Motta(però ch’e’ sol’à del’aparisenza). Il verso si riferisce al re d’Oriente nella rappresentazione entu-siastica del Papa; sola va letto in funzione avverbiale ed ha un riscontro in Madonna Leonessa,25 4 «Due once – dice – sia tagliata sola», la voce appariscenza come ‘aspetto esteriore con qualità positive’ risulta attestata dalle schedature del tlio quasi unicamente in testi di Pucci(sono sue sei delle otto occorrenze). La difficoltà degli altri mss. pare derivare proprio da que-sti due elementi, per cui si ricostruisce in vari modi; in comune l’introduzione dell’aggettivo,che dimostra come non venga compreso il significato, per di più con l’eccezione di V e forsez; si scambia anche il destinatario dell’apprezzamento, che è il promesso sposo e non la figliadell’imperatore.
iv 30 2 a quella donna che l’oste era bandita VB, a quela dove l’ost’era bandita (+ S)che quello re l’oste gli a bandita U,e quella donna l’oste ebbe bandita M
Ripartiamo dall’ultimo verso dell’ottava precedente: e di presente féli (K) bandir l’oste, recepitonella ripartenza E quando fu cotal novela nota cui segue il verso in analisi, nel quale i manoscritti,con l’eccezione di KS, omettono dove, in maggioranza, VBM sostituendolo col nome, per in-duzione forse della sillaba iniziale. Si può presupporre una difficoltà di lettura, ma radicatanell’incomprensione sostanziale della pratica del bando del conflitto, per lo più accompa-gnato da relativa informazione logistica (il dove quindi integra di necessità l’informazione):per citare solo Pucci Cent. 11 22: e poi bandiron l’oste a Montalcino; 28 209: bandir l’oste ad Arez-zo, e dièr le insegne, e ancora 41 245, 44 66. Dunque inutili le congetture integrative di Levi eRobins.
iv 38 6 col popol tuo posente V, col popol tuo presentecol popol tuo servente MUB,col popol tuo fervente z
Un’allusione intertestuale non compresa, perché estremamente sintetica, scatena la diffrazione posente / servente / fervente («Iddio, come veracemente | liberasti di man di Farao-ne | quel Moisé col popol tuo presente…»). Il riferimento del Pucci è alla Bibbia volgare, Eso-do, 18 1: «Ma l’altro dì sedé Moisé, acciò che giudicasse al popolo, il quale istava presente aMoisè dalla mattina insino al vespro».
Aggiungerei:
ii 10 8 e tutte quante sieno incatenate V, e incontenente a Roma le menate (+ z)imprigionate U, incharcierate F,e in prig[i]one a Roma le menate M,S cambia: in uno fuoco siano tute getate
Forse il vario montaggio della lezione in Ì deriva dall’incomprensione dell’avverbio, datato,ma ampiamente documentato nella poesia di Pucci.
Solo in apparenza adiafore le lezioni a:
dittico per antonio pucci - i i 119
VUSBFz + M K
iv 40 3 si fece il segno della santa croce V, si fieci in fronte il segno della croce (+ BR)e si fece il segno della croce U,si fece il santo segno della croce S,fecesi il segno della santa croce z,si fece il segno della croce (-) M
L’indicazione generica del segno, di K (+ BR), può certo considerarsi la resa più banale.
Si possono forse aggiungere anche:
ii 47 4 ambasciata MFU mandata (+ Sz), voce più rara
Ambasciata occorre nella stessa ottava al v. 2. La lezione di MFU occorre in prima istanza an-che in V, che poi cassa e corregge con la lezione di KSz.
iv 35 7 cani V, balbani U, baroni sovrani S, barbani (+ z)burbani B, baroni M
iv 37 6 molta gente fa star paurose VUM, molta gente ci stanno (stanno z) pauroseci fa star p. B
La lezione dei mss. diversi da Kz altera il senso, il soggetto non è più chiaro (forse partita div. 5?); evidentemente non si è capito il verbo e predicativo al plurale riferito al collettivo.
iv 39 4 promesso VSMBRz, promessa U permesso
Lo scambio ben documentato tra promesso e permesso attenua il peso dell’alternanza, pur si-gnificativa per il raggruppamento.
Si aggiungono alcuni casi che, pur riguardando la misura del verso, implicano questionidi scelte lessicali o di sintassi:
ii 48 2 benedizione benezione
iii 43 6 benedizion benizion
L’alternanza ha conseguenze per la misura nella lettura di maggioranza. La forma di K (gallicismo?) ha nel tlio poche attestazioni, tutte fiorentine trecentesche: altra ricorrenzapucciana nel testo K dei Cantari della guerra di Pisa vi 1 3.
ii 24 5 e non dubitate ché signor novello e non dubiate ché signor novello
ii 50 7 pognam che poco valesse (valessi S) pognam che poco valse i·lusingare (: -are)il lusingare (: -are) SUVF, e come al fine (+ Bz)per gratia di dio (: chonvertio) M
M modifica radicalmente il distico finale.
ii 33 4 Ch’i’ (che B, om. M) ve ne darò ch’io ve ne darò quanto vorete (+ S, quanti U)quantunque vo’ vorete
120 anna bettarini bruni
VUSBFz + M K
iii 28 2 gran festa e gioia (gioia e festa U) gran festa e gioia (gioia e festa V)mostrandosi guarito UM, mostrando guarito (+ V)gran festa mostrandosi g.(mostrando essere guarito z) SBFz
In UM il verso risulta ipermetro in quanto in Pucci non si dà mai gioia monosillabo; si spiegacosì in SBFz la riduzione della dittologia al solo festa. z agisce anche sul verbo con un inter-vento ponte tra le due varianti (mostrando esser g.). Per contro, in K il verbo mostrare è in dia-tesi intransitiva col valore di ‘parere, sembrare’ (come esplicita z); così anche in Libro, p. 4:«ma [la luna] mostra grande perché è presso di noi».
iii 41 1 E la moglie soferia gran pena VF (-1), E la mogliere soferia gran penasua isposa BM, donna sua S, sua moglie z.
La banalizzazione di VF (e verosimilmente di Ì) provoca ipometria e viene variamente inte-grata da MB, S, z.
iv 44 6 in vita etterna andarono con pacienza VS, in vita etterna andar con pazïenzaandono con pacienza U,andaron con pacienza (piacenza z) MBz
Pazienza è in poesia, almeno fino a tutto il Trecento, trattato come quadrisillabo.
Nei due luoghi seguenti si conferma l’isolamento di K in presenza di lezioni almeno piùbanali:
iii 25 5 e allo imperador si fu inviata VBF, ed a lo ’nperador fu apresentatasi fu aviata U, fu arrivata SMz
Apresentata ha il senso di ‘presentare (presentarsi) ufficialmente’.
iii 28 8 non le crede VM, nolla crede U, nula ’l credenollo crede F, non gli crede SBz.
I testimoni diversi da K attenuano la funzione negativa espressa dall’avverbio.
Si segnalano anche due casi di rima imperfetta nei quali i testimoni che fanno capo a Ìsono concordi, con l’eccezione di recupero (del resto facile) di z e, in un caso, di U:
ii 14 7 avea (aveia S) (: -ia) avia (+ Uz)
iii 39 2 dicea (: -ia) dicia corretto su diciea (+ z)
Agli errori si aggiungono varianti adiafore, delle quali alcune si presentano collo stessosegno per altri testi nel confronto tra K e altri manoscritti: in questa direzione solo un’indagine estesa alla tradizione di tutte le opere trasmesse dal Kirkupiano consentiràdi valutare quelle corrispondenze e forse anche di sapere se certi caratteri linguistici,svolti in modo univoco, possano indicare una stratificazione d’uso d’autore fissata nellatestimonianza di K.
dittico per antonio pucci - i i 121
Tav. 5b (varianti di Ì vs K).
VUSBFzM K
iii 17 2 sì allegra così lieta
Un riscontro analogo a ii 20 4 molta allegra VF (alegreza M) di contro a molta lieta di K, questavolta col sostegno di U e z. L’alternanza anche nel testo di K dei Cantari della guerra di Pisa ri-spetto all’edizione: iii 5 3 letto e gaio vs allegro e gaio.
iii 36 8 quand’ella com’ella
iv 41 1 Quando Come
Uguale alternanza tra K e l’altra tradizione si riscontra in Madonna Lionessa, 47 1; Cantari diApollonio, i 7 1, ii 31 1, Cantari della guerra di Pisa, iii 24 1.
iv 3 6 pro’ e saputo VSB, prode e saputo M, molto saputodocto e saputo z
Da notare come nella lezione di K in altri casi si contrapponga alla doppia aggettivazione ilsuperlativo analitico; si veda anche l’esempio qui di seguito: iv 22 5. Nella lezione di K dei Can-tari della guerra di Pisa, iii 2 8 molto fiero vs ardito e fiero; iv 9 6 molto dotti vs arditi e dotti; e an-cora a conferma della resistenza alla dittologia: Cantari della guerra di Pisa, iii 25 3 e presi furontutti lor più forti vs e presi furo i più gagliardi e forti; iv 5 6 molta travaglia vs briga e travaglia; Can-tari di Apollonio, ii 3 5 a gran marchese vs a conte e marchese.
iv 22 5 savio e accorto SVBz (M manca) savio, molt’acortto
Varianti adiafore ricorrenti per le voci del verbo fare, per lo più con sì di ripresa:
ii 20 8 fece VM, feceno S, facean U, fecion z fenne (+ F, tenne B)iii 8 7 ne fece SUVzM, ne fe BF sì ne fe’iv 7 6 feciono SVB, fecela z, fe M sì feroiv 20 2 fece SVBzM sì fe’iv 29 8 vi fe’ UVzM, fece S feli
Altre varianti:
i 34 5 rispondea (ella rispondea U) ella diceaii 42 7 niuno Sz, veruno V, ciaschuno M, om. BF alcuniii 8 8 ancor si noma, se ne noma z ancor si sona (+ U la novella sona)iii 14 7 dicendo SUVzM e dise (+ BF disse, in lezione fortemente
modificata)iii 15 1 disse ciò che dise come (+ z)iii 27 6 montarono SUV, montaron z, e montaroe montarono (+1) BFMiii 32 6 morte sostener, sostener morte z morte sofferir (+ U)iii 34 5 onde di cheiii 39 2 cacciò la gente la gente chacia
122 anna bettarini bruni
VUSBFz + M K
iii 40 7 parole nol conforta SBF, né parole né parole il confortan (il conforta Vz)non conforta Miii 45 7 dodici VFzM, sedeci S ben dieci (+ B)iii 46 8 fe ’l metter sì ’l mise (+ B misselo)iii 46 8 serrar VSzM serrò (+ BF)iv 10 4 adimanda Vz, domandar dovria B, dimandar si de’domandar dovia M, S cambiaiv 10 8 tornò la guardia e ffe’ po (e fece BS) la guardia torna e dise la risposta (+ z)la risposta SVBz, e lla ghuardia alla donna fe’la risposta Miv 12 7 riebbono (riebeno S) eboniv 12 8 gli altri gli altri suoi (+ B)iv 12 8 furon morti, fur morti B moriroiv 17 2 torna VSM vane (+ B + z)iv 14 8 per aschio a morte per lei a morte
Rispetto ad astio (42 ess., in prevalenza toscani, nel tlio), la forma popolare aschio ha solo treoccorrenze nella stessa banca dati, il che non esclude che potesse essere più comune nella lin-gua d’uso. Comunque, a stare ai dati, tale lezione si presenta come difficilior e tale caratteredovrebbe condizionare la scelta (al contrario per lei è facilmente ricavabile dai vv. 2 e 7). Ma ilcriterio non può essere assunto in maniera assoluta, non necessariamente cioè lemmi o sin-tagmi fortemente connotati garantiscono la lezione originale, soprattutto se, come nel casocol sostegno di altri luoghi, precisamente i 21 6 (Tav. 4c), i 23 7 (Tav. 2b) e forse anche ii 3 8(Tav. 3b), la discussione ecdotica nel suo complesso comporti la valorizzazione del testimo-ne che porta l’altra lezione.
iv 24 5 dieronli B, dierono z, dierole M, V diede lor (+ S)cambia debonoiv 26 1 furon giunti giunti furono (+ S)iv 28 3 debba gire V, andasse USM, andar debba z gise (+ B)iv 28 3 per udire SB, ad ubidire z, a udire M, a vedere (: -ire)V om.iv 32 7 di grandeza sua grandezaiv 33 3 un teribil roncione VUSM, abiante or[i]bile roncione (+ B)roncione N, gran roncione I, nobile roncione ziv 33 5 gioganti VSNIz, uomini BM leoni (+ U)iv 36 7 a suo cittade in sue contrade (+ S)
iv 36 8 in tuo contrade a la tua cittade (+ S)
iv 40 7 con suo chompagni VBz, con sua compàgnacon sua compagnia MS (R), con suo giente U
iv 41 1 fu dilungato, fu partito z fu dileghuato (+ B)
Lo stesso K ha errori individuali i quali si possono classificare secondo tipologie diffe-renti di difetti di copia:
dittico per antonio pucci - i i 123
Tav. 6. Errori di K vs Ì
K VUSBFzM
a) Interpretazione da cattiva lettura:
ii 29 5 e poi che sendo a modo mascolina e poi crescendo a foggia (in forma S) mascolinaii 37 7 figliore (sciolto da Motta figlio re) signore
Anche figliore può spiegarsi per refuso, da signore.
b) errato scioglimento di compendio:
ii 39 5 chopir (← choprì?) coperse (fe’ coprir U)ii 45 5 per metter promette
Per l’alternanza si veda lo scambio, a parti invertite, tra promesso e permesso a iv 39 4, nella Ta-vola 6.
c) omissione di una parola:
iii 18 8 non ci fia vergogna che non ci sarà vergogna V, che non ci siavergogna Fz, che non ci fia vergognaUBSM
Motta sopperisce alla mancanza della congiunzione leggendo fia bisillabo; si potrebbe pen-sare una lettura fi’ a vergogna, ma siamo fuori dell’uso pucciano. Più semplice pensare a unsalto da parte di K.
d) errore d’anticipo o di ripetizione:
iii 45 6 andò ver lui ben con più di diece (-1) andò ’nver lui con anche più di diece
Per la misura l’editore di K propone la lettura bisillabica del pronome, ma risulta evidente ilvizio di costruzione nell’anticipo dal verso successivo n’avia seco ben dieci. La formula degli al-tri mss., numero a parte, si ritrova nel Centiloquio («e fu pregion con anche più di sedici»).
iv 6 4 battaglia forte e dura battaglia aspra e dura
Lo stilema dei mss. diversi da K spesso ricorre nel Centiloquio; l’aggettivo forte di K può deri-vare dal verso precedente (forte resedio), tenendo conto in aggiunta che la sostituzione fa ag-gio sulla memoria della serie dura aspra forte di If. i).
e) sovrapposizione mentale:
iv 40 1 l’angiol di Piero (: croce: boce) l’angiol veloce
La lezione di K è variazione rispetto alla clausola del primo verso dell’ottava precedente: l’angelo richiamato può essere quello che libera san Pietro dalla prigione di Erode in ActusApostolorum, 12, 6-16, episodio citato di frequente nei testi volgari.
124 anna bettarini bruni
K VUSBFzM
f ) sostituzione di parola per attrazione:
ii 33 3 non v’è pensiere pensare d’avere danari nonn’è mestiere pensare d’aver danari VBM,nonne pensate avere danari S, nonn è mestierche per danari assai F, nonn è mestier d’avertanti danari U, non habbiate pensiere di da-nari z
Mentre la perifrasi degli altri manoscritti, più o meno semplificata, pare corretta, la lettura diK, in realtà di significato meno pertinente, propone una figura etimologica non rara e perquesto al limite sospetta di banale sovrapposizione di parole vicine per grafia.
A questa casistica si aggiungono i refusi segnalati in apparato da Motta (tra parentesi lalezione corretta): ii 12 6 da lloro (la lloro), ii 13 4 mandata (mandato), ii 25 3 cierto (in rima:-erta), iv 20 1 natta per [incate]natta.
Tra le carenze di K l’omissione delle due ottave iii 9-10, la cui presenza risulta indi-spensabile per un preciso richiamo al loro contenuto più avanti, all’ott. 15. Il salto coin-cide nel manoscritto col passaggio da una colonna all’altra, che può aver facilitato la di-strazione dal testo di copia, tanto più che l’ott. 9 ha lettere iniziali uguali a quelle dell’ott.8 (El padre / El papa). Proprio nell’avvio dell’ott. 8 troviamo il segno della distrazionedell’occhio già scorso in avanti: dopo la E viene scritto La, poi corretto cassando la a,per l’attrazione di ott. 11 che inizia La sera. È invece più difficile classificare come erro-nea la lezione di K a ii 41 4: e ma’ (non ina come legge Motta) ciascun fu ˇ ardito e saputo,di misura solo se si legge dialefe. Se si prende per buona la lezione VMB: e ˇ in ciascunofu ardito e saputo, con ciascuno riferito agli infiniti del verso precedente (aparò (imparò) discrimire (schermire) edi giostrare), la genesi dell’errore di K sarebbe ancora una volta unacattiva lettura, m per in da cui l’adattamento a ma, scontando l’altra differenza nel-l’apocope del pronome. Del resto nel gruppo alternativo a K la diffrazione focalizza unadifficoltà che si cerca di aggirare puntando sulle diverse preposizioni con esiti insoddi-sfacenti: e da ciascuno era pro e saputo U, e di ciascuno fu ardito e saputo F, e con ciascuno eraardito saputo z, mentre S adatta per dare un senso: più che niun altro fu a. e s. Alla luce diquesti dati resta il sospetto che il difetto possa trascendere le testimonianze, ad esem-pio con l’omissione di più, che in altro contesto è anche in S, davanti alla coppia degliaggettivi, costituendo così una prova d’archetipo. Mi fermo qui a segnalare la possibili-tà e a confermare l’insoddisfazione per tutte le lezioni attestate.
Robins considera dimostrata la presenza di un archetipo in base a una serie di ipo-metrie e ipermetrie, sul presupposto che tali scarti alla misura non potessero essere im-putati all’autore in virtù della «cura che Pucci ebbe nel copiare versi nelle due antolo-gie di sua mano», un rincalzo non solo estraneo ma anche aleatorio, perché intantoconfonde la passione con i risultati. Della lista dei loci proposti (Motta, Robins 2008, p.cx) i seguenti hanno trovato collocazione nelle tavole che precedono: Tav. 2a: ii 42 7;Tav. 3b: ii 3 8; Tav. 5a: i 42 7, ii 8 2, ii 9 2, iii 10 2; Tav. 6: ii 24 5, ii 33 4, iii 28 2, iii 41 1. Neresta escluso solo uno, ii 39 2, che viene considerato qui di seguito.
Si possono segnalare un paio di luoghi di verosimile convergenza di tutta la tradizione:
dittico per antonio pucci - i i 125
Tav. 7. Prove di archetipo.
ii 39 2 tutta la strada dove (ove z, onde U, donde V) dove’ passar[e] (carta rifilata in K) K + Ì
Lo scarto di una sillaba in più coinvolge tutti i testimoni in un errore di per sé di poca evi-denza e di eziologia elementare, ma per questo insidioso anche per un autore. Si tratta di unaaplografia che ha portato a rendere identica la prima sillaba tra avverbio e verbo, dove dove’,e proprio per la sua banalità non stupisce che la menda si sia potuta mantenere e trasmette-re in tutta la tradizione con qualche tentativo d’intervento (donde V, onde U, fino a quello ri-solutivo, ove, recuperato nella stampa).
iii 34 7 te deo lodamus e poi si fu aviato K, te deum laudalmus e fu aviato V, te deum laudamus eaviato S, te deus laldamus semper sia lodato M, te deum laudiamo che cci a dato U, te deum lauda-mus a dir chomincioe B, te deum laudamus e cie mi chanto F, te deum laudamus ha ringraziato z
In presenza della formula latina si apre un ventaglio di soluzioni che intervengono sul-la misura e che dimostrano la difficoltà forse originaria a bilanciare i due emistichi: il ta-glio secco di V te deum laudalmus e fu aviato e quello ancora più deciso di S te deum lau-damus e aviato, mentre altri modificano te deum laudiamo che cci a dato U, te deus laldamussemper sia lodato M, te deum laudamus a dir chomincioe B, te deum laudamus te cie mi cantoF, te deum laudamus ha ringraziato z. Per la precisione, l’eccedenza si appunta nella con-sonante finale del verbo latino e sulla possibilità del suo assorbimento in elisione con lacongiunzione che segue. Non ci stupirebbe in realtà che questa irregolarità prosodicarisalisse addirittura al Pucci, talmente insicuro nella gestione della gramatica che nei suoiautografi ad ogni citazione in latino appone in margine un circoletto di richiamo.
Ambedue i casi, ma in particolare il secondo, mostrano incertezze originarie, che piùche postulare un’entità intermedia, paiono da attribuire addirittura a un modello auto-riale (O), dal quale K dipenderebbe direttamente; sull’altro ramo i restanti manoscritti,secondo l’articolazione qui dimostrata. Non si renderebbe del tutto conto dei dati senon si considerasse quanto esposto alla Tavola 5b, cioè che alcune varianti nell’uso lin-guistico si ripropongono tra K e gli altri testimoni in modo uguale e sistematico anchein altri testi del Kirkupiano. Per questo si può pensare che la conseguente giustificazio-ne non riguardi solo la tradizione in studio e che sia invece praticabile l’ipotesi di un li-vello più alto nello stemma, qui al di sopra dello snodo Ì, per un antigrafo, riproducentealmeno il contenuto di O, al quale riferire quelle lezioni alternative. Non si tratta diun’antieconomica moltiplicazione degli enti, ma di un passaggio indispensabile a spiegare un assetto differente, con effetti limitati nella tradizione della Reina, per altreopere – penso ai Cantari della Guerra di Pisa – estesi e sostanziali, assetto al quale non sarebbe estraneo lo stesso autore.
126 anna bettarini bruni
Abbreviazioni bibliografiche
Baldelli 1957 = [Ignazio Baldelli, scheda sul Kirkupiano,] in Mostra di codici romanzi 1957, pp. 147-48.Banchi 1866 = Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena, a cura di Luciano Banchi,
Siena, Gati.Bencistà 2006 = Antonio Pucci, L’alluvione dell’Arno nel 1333 e altre storie popolari di un poeta campa-
naio, a cura di Alessandro Bencistà, Reggello (fi), FirenzeLibri s.r.l.Bendinelli Predelli 2006 = Firenze alla vigilia del Rinascimento: Antonio Pucci e i suoi contemporanei,
Atti del Convegno di Montreal (22-23 ottobre 2004), McGill University, a cura di Maria Bendi-nelli Predelli, Fiesole (fi), Cadmo.
Benucci 2002a = Antonio Pucci, Madonna Leonessa, [a cura di Elisabetta Benucci,] in Benucci e a.2002, pp. 85-105 [cappello, testo] e 886-87 [nota al testo].
Benucci 2002b = Antonio Pucci, Bruto di Bretagna, [a cura di Elisabetta Benucci,] in Benucci e a.2002, pp. 107-27 e 888.
Benucci e a. 2002 = Cantari novellistici dal Tre al Cinquecento, a cura di Elisabetta Benucci, RobertaManetti e Franco Zabagli, introduzione di Domenico De Robertis, Roma, Salerno Editrice.
Bettarini 1978 = Rosanna Bettarini, Sguardo alla fabulosa storia della Reina Rosana, in Testi e inter-pretazioni: studi del Seminario di filologia romanza dell’università di Firenze, Milano-Napoli, Ric-ciardi, pp. 65-146.
Bettarini Bruni 1984 = Anna Bettarini Bruni, Intorno ai cantari di Antonio Pucci, in Picone, Bendi-nelli Predelli 1984, pp. 143-60.
Bourgain, Vielliard 2002 = Pascale Bourgain, Françoise Vielliard, Conseils pour l’édition des textesmédiévaux. Fascicule iii. Textes littéraires, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques-École nationale des chartes.
Branca 1958 = Vittore Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio, Roma, Edizioni di Storiae Letteratura.
Branca 1976= Giovanni Boccaccio, Decameron, edizione critica secondo l’autografo hamiltonia-no a cura di Vittore Branca, Firenze, Accademia della Crusca.
Briquet = Charles Moïse Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leurapparition vers 1282 jusqu’en 1600, 4 voll., Genève, Julien, 1907 (rist. anast. Hildesheim-New York,Georg Olms).
Canettieri e a. 2008 = Paolo Canettieri, Vittorio Loreto, Marta Rovetta, Giovanna Santini, Philo-logy and Information Theory, «Cognitive Philology», 1 (http://padis2.uniroma1.it:81/ojs/in-dex.php/cogphil).
Contini 1953 = Gianfranco Contini, Per l’edizione critica di Jacopone, rli, 57, pp. 310-18.D’Ancona 1869-1870 = Alessandro D’Ancona, Una Poesia e una Prosa di Antonio Pucci, precedute da
una Lettera al prof. Alessandro Wesselofsky dell’Università di Mosca, «Il Propugnatore», 2 (1869), pp.397-438 e 3 (1870), pp. 35-53, poi in D’Ancona 1913, pp. 329-86.
D’Ancona 1878 = Alessandro D’Ancona, La poesia popolare italiana, Livorno, Vigo.D’Ancona 1913 = Alessandro D’Ancona, Saggi di letteratura popolare, Livorno, Giusti.Debenedetti 1944 = Santorre Debenedetti, rec. a Pace 1944, gsli, 122, pp. 93-96.De Robertis 1961 = Domenico De Robertis, Problemi di metodo nell’edizione dei cantari, in Studi e
problemi di critica testuale, Convegno di Filologia italiana nel Centenario della Commissionedei testi di lingua (7-9 aprile 1960), Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1961, pp. 119-38,poi in De Robertis 1978, pp. 91-109.
De Robertis 1970 = Domenico De Robertis, Cantari antichi, sfi, 28, pp. 67-175, poi parzialmentein De Robertis 1978, pp. 110-14.
De Robertis 1978 = Domenico De Robertis, Editi e rari. Studi sulla tradizione letteraria tra Tre e Cin-quecento, Milano, Feltrinelli.
De Robertis 1990 = Domenico De Robertis, La tradizione dei cantari, in Actes du xie Congrès inter-national de la Société Rencesvals (Barcelona, 22-27 août 1988) (= «Memorias de la Real Academiade Buenas Letras de Barcelona», 22), ii, pp. 425-31.
dittico per antonio pucci - i i 127
Dionisotti 1964 = Carlo Dionisotti, Appunti su antichi testi, imu, 7, pp. 77-131, poi in Dionisotti 2003,pp. 95-139.
Dionisotti 2003 = Carlo Dionisotti, Boiardo e altri studi cavallereschi, a cura di Giuseppe Anceschie Antonia Tissoni Benvenuti, Novara, Interlinea.
Fontana 1992 = Cantare di Madonna Elena, edizione critica a cura di Giovanni Fontana, Firenze,Accademia della Crusca.
Froger 1968 = Dom Jacques Froger, La Critique des Textes et son Automation, Paris, Dunod.Ildefonso 1772-1775 = Delle poesie di Antonio Pucci celebre versificatore fiorentino del mccc e prima, della
Cronica di Giovanni Villani ridotta in terza rima, pubblicata e d’osservazioni accresciuta da Fr. Ilde-fonso di San Luigi, 4 voll., Firenze, Cambiagi.
Jackson 1910 = Margaret Hastings Jackson, Antonio Pucci’s poems in the codice kirkupiano of Welles-ley College, r, 39, pp. 315-23 e 635.
Levi 1914 = Fiore di leggende. Cantari antichi, editi e ordinati da Ezio Levi, s. i. Cantari leggendari, Ba-ri, Laterza.
Limacher-Riebold 2007 = Ute Limacher-Riebold, Il serventese inedito «Onnipotente re di somma glo-ria» di Antonio Pucci, spct, 74, pp. 81-116.
Macé e a. 2006 = The evolution of texts: confronting stemmatological and genetical methods, Procee-dings of the International Workshop held in Louvain-La-Neuve on September 1-2, 2004, ed.by Caroline Macé, Philippe Baret, Andrea Bozzi, Laura Cignoni, Pisa-Roma, Istituti editorialie poligrafici internazionali (= «Linguistica computazionale», 24-25).
McKenzie 1931 = Antonio Pucci, Le noie, ed. by Kenneth McKenzie, Princeton-Paris, PrincetonUniversity Press-Les presses universitaires de France.
Morpurgo 1912 = Salomone Morpurgo, L’apografo delle rime di Antonio Pucci donato dal collegio diWellesley alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, «Bollettino delle pubblicazioni italiane ri-cevute per diritto di stampa [dalla Biblioteca nazionale di Firenze]», 133, pp. ii-vi.
Mostra di codici romanzi 1957 = Mostra di codici romanzi delle biblioteche fiorentine, Firenze, Sansoni.Motta 1998 = Attilio Motta, Per i cantari di Antonio Pucci. A margine di un’edizione dell’Apollonio di
Tiro, li, 50, pp. 554-65.Motta, Robins 2007 = Antonio Pucci, Cantari della Reina d’Oriente, edd. critiche a cura di Attilio
Motta e William Robins, Bologna, Commissione per i testi di lingua («Collezione di opere ine-dite o rare», 163).
Pace 1944 = Antonio Pucci, Il contrasto delle donne, A Critical Edn. with Introduction and notes byAntonio Pace, Menasha (wi), G. Banta Publishing Co.
Paoli 1872 = Cesare Paoli, Nuovi documenti intorno a Gualtieri di Brienne, «Archivio Storico Italia-no», s. iii, 16, pp. 52-62.
Piccini 2004 = Franco Sacchetti, Trecentonovelle, a cura di Davide Piccini, Torino, utet.Porta 1990-1991 = Giovanni Villani, Nuova Cronaca, a cura di Giuseppe Porta, Parma, Fondazione
Pietro Bembo/Guanda.Picone, Bendinelli Predelli 1984 = I Cantari. Struttura e tradizione, Atti del Convegno internazio-
nale di Montreal (19-20 marzo 1981), a cura di Michelangelo Picone e Maria Bendinelli Predelli,Firenze, Olschki.
Picone, Rubini 2007 = Il cantare italiano fra folklore e letteratura, Atti del Convegno internazionaledi Zurigo, Landesmuseum (23-25 giugno 2005), a cura di Michelangelo Picone e Luisa Rubini,Firenze, Olschki.
Rabboni 1996 = Antonio Pucci, Cantari di Apollonio di Tiro, edizione critica a cura di Renzo Rab-boni, Bologna, Commissione per i testi di lingua («Collezione di opere inedite o rare», 150).
Rabboni 2003 = Renzo Rabboni, Per l’edizione dei cantari, li, 55, pp. 540-68.Rabboni 2006 = Renzo Rabboni, Il Pucci di D’Ancona e Veselovskij, in Bendinelli Predelli 2006, pp.
271-315.Rabboni 2008 = Renzo Rabboni, Per l’«Apollonio di Tiro» veneto e per il «Florio e Biancifiore» (Ms.
Toledo, Bibl. Capitular, 10-8), lia, 9, pp. 223-49.Robins 2007 = William Robins, Editing and Evolution, «Literature Compass», 4, pp. 89-120.
128 anna bettarini bruni
Sacchi 2009 = Historia Apollonii Regis Tyri. Volgarizzamenti italiani, a cura di Luca Sacchi, Tavar-nuzze (fi), sismel-Edizioni del Galluzzo.
Salemans 1999 = Ben Salemans, The old text-genealogical method of Lachmann updated with the helpof cladistics and the computer, in I nuovi orizzonti della filologia. Ecdotica, critica testuale, editoriascientifica e mezzi informatici elettronici, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 115-25.
Salemans 2002 = Ben Salemans, The remarkable struggle of textual criticism to become truly scienti-fic… (http://www.knaw.nl/agenda/pdf/Abstract_ben_salemans.pdf ).
Santini 1903 = Pietro Santini, Questioni e ricerche di storiografia fiorentina, Firenze, Seeber, pp. 96-144.
Segre 1971 = La Chanson de Roland, edizione critica a cura di Cesare Segre, Milano-Napoli, Ric-ciardi.
Segre 1979 = Cesare Segre, Critica testuale, teoria degli insiemi e diasistema (Appendice: Il testo cometrascrizione), in Semiotica filologica. Testo e modelli culturali, Torino, Einaudi, pp. 53-70.
Serianni 2009 = Luca Serianni, La lingua poetica italiana. Grammatica e testi, Roma, Carocci.Stussi 1970 (1982) = Alfredo Stussi, Tormenti di un filologo, in Critica e storia letteraria. Studi offerti a
Mario Fubini, Padova, Liviana, 1970, ii, pp. 27-40, poi in A. S., Studi e documenti di storia dellalingua e dei dialetti italiani, Bologna, il Mulino, 1982, pp. 97-109.
Stussi 1973 (1999) = Alfredo Stussi, Salomone Morpurgo (biografia, con una bibliografia degli scritti), inTra filologia e storia. Studi e testimonianze, Firenze, Olschki, pp. 145-227.
van Reenen, van Mulken 1996 = Studies in Stemmatology, ed. by Pieter van Reenen, Margot vanMulken, Amsterdam-Philadelphia, Benjamins.
Vàrvaro 1957 = Antonio Pucci, Libro di varie storie, a cura di Alberto Vàrvaro, «Atti della Accade-mia di Scienze e Lettere e Arti di Palermo», s. iv, 16, parte ii, fasc. ii, 1957 [a.a. 1955-1956], pp.3-312.
Vernon 1846 = Chiose dette del falso Boccaccio (Inferno), a cura di lord William Varren Vernon, Fi-renze, Piatti.
Zabagli 2002 = Antonio Pucci, Gismirante, [a cura di Franco Zabagli,] in Benucci e a. 2002, pp. 129-64 e 888-89.
Fabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected], www.libraweb.net
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official subscription rates are availableat Publisher’s website www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento sul c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Eurocard, Mastercard, Visa).
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa, [email protected] di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma, [email protected]
*
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 18 del 26 novembre 2003Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento anche parziale oper estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi messo effettuati, compresi la copia fotostatica,il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc. senza la preventiva autorizzazione della
Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2010 by Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 1724-6113issn elettronico 1825-1021
SOMMARIO
Stefano Carrai, La filologia di Dante Isella 9
Antonio Ciaralli, Alle origini del documento mercantile. Postille intorno al «Rendi-conto navale» pisano 21
Vittorio Formentin, Noterelle sulla tenzone tridialettale del codice Colombino diNicolò de’ Rossi 51
Giorgio Inglese, Crocco in «Purgatorio» xxiv 30? 75
Anna Bettarini Bruni, Paolo Trovato, Dittico per Antonio Pucciii. Paolo Trovato, Di alcune edizioni recenti di Antonio Pucci, del codice Kirkup
e della cladistica applicata alla critica testuale 81ii. Anna Bettarini Bruni, Esercizio sul testo della «Reina d’Oriente»: è possibile
un’edizione neolachmanniana? 98
Denis Fachard, «A maggiore vostra cognizione, mi farò un poco da lato, e voi aretepazienza a leggerla». Appunti su inediti machiavelliani riguardanti l’attuazione del-l’Ordinanza 129
Patrizia Arquint, Di un repertorio di briglie cinquecentesco falsamente attribuito aCesare Fiaschi 147
Annalisa Cipollone, Una ghirlanda fiorentina. 1938. Autografi novecenteschi nellaNational Library of Scotland (con lettere inedite di Saba e Ungaretti) 171
Davide Checchi, L’architettura dei «Versi livornesi» di Giorgio Caproni 201
Indici, a cura di Fabio Romaninii. Indice dei nomi 213ii. Indice dei manoscritti e dei postillati 223iii. Indice dei nomi delle lettere machiavelliane 227
Sigle impiegate in questa rivista 229