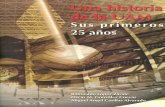Esercizi di esproprio e di riappropriazione. «A nome tuo» di Covacich
A. RUTA, S. TUZZATO, P. ZANOVELLO, (a cura di), Indagine archeologica nell’anfiteatro di Padova....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of A. RUTA, S. TUZZATO, P. ZANOVELLO, (a cura di), Indagine archeologica nell’anfiteatro di Padova....
Indagine archeologica nell’anfiteatro di Padova.Saggio 2007(a cura di Angela Ruta, Stefano Tuzzato, Paola Zanovello)
PREMESSA
L’anfiteatro è il monumento più “emergente” edevidente dell’antica Patavium. Non era mai stato og-getto di indagini stratigrafiche, tuttavia, fino alla finedel 2007, quando il Comune di Padova ha sostenutol’onere di un ampio saggio di scavo1. In prospettivadel suo recupero e della sua valorizzazione era indi-spensabile un’accurata indagine, che comportasse an-che una verifica diretta dei dati dagli scavi condottidall’arch. ing. Eugenio Maistri nel 1881, allora finaliz-zati alla sistemazione degli scoli delle acque piovaneper la salvaguardia della Cappella degli Scrovegni. Lapubblicazione degli scavi e delle ricerche condottenell’inverno 1906-1907, “quando si stava costruendola nuova via denominata Corso del Popolo”2 avevacostituito fino ad ora, assieme alle murature ancor og-gi visibili, tutto ciò che gli studiosi avevano avuto adisposizione per elaborare ipotesi ricostruttive e didatazione.
Un’essenziale ricerca d’archivio, preliminare al-l’indagine commissionata dal Comune, aveva portatoalla fortunata scoperta, presso l’Archivio di Stato,della documentazione dell’intervento del 18813, dicui erano finora edite soltanto alcune fotografie e lapianta. La scelta dell’area per la nuova indagine hapuntato, tra le poche zone possibili, proprio sulla ria-pertura della trincea est del Maistri. Tra i motivi dellascelta, non secondari, sono stati la sua posizione geo-metricamente significativa sull’asse minore dell’arena,la relativa velocità con cui si sarebbero potute ottene-re sezioni stratigrafiche ragguardevoli (anche in rela-zione alla profondità da raggiungere), vuotando unvecchio scavo poi riempito, e la possibilità di allargarel’esplorazione con uno scavo stratigrafico, orientatodalle prime evidenze emerse (fig. 1). Il ritrovamentodei documenti, assieme al saggio del 2007-08 (fig. 2),ha permesso di capire che alla base di tutte le ipotesiricostruttive vi era stato un singolare equivoco, indot-to proprio da quei primi scavi.L’equivoco in cui incorse il Maistri, traendo inconsa-pevolmente in inganno gli studiosi successivi, consi-
, , 20
PADOVA
Fig. 1 - Localizzazione del saggio di scavo 2007-2008, e principalielementi strutturali.Fig. 2 - Pianta diacronica del saggio, alla fine dello scavo.
Fig. 3 - Sezione longitudinale XCY, e dettaglio della sezione XC.Disegno acquerellato datato 9 aprile 1881 (Atti Comunali, b. 3075,dis. 1)
Fig. 4 - Sezione trasversale alla trincea, con ricostruzione ipoteticadella sezione del sotterraneo.
tre, il settore di acquedotto6 in grandi tubi di trachite,riportato alla luce e osservato per un tratto lungo 5,30m, si confermò interrotto dalle fondazioni dell’arena,quindi più antico, e lievemente inclinato verso est(figg. 2, 6).
È riemersa l’imponente sostruzione che reggeval’anfiteatro; tra i due muri anulari più interni, distantitra loro m 2,50 e qui indicati con A e B in fig.1 (corri-spondenti ai muri B e C del Brunelli Bonetti), era sta-to riportato uno spesso riempimento a matrice sab-biosa, come livellamento di base per il pavimento so-prastante del deambulatorio. La porzione inferioredel muro del podio (C in figg.1, 2), più interno di cir-ca 5 m, presentava un andamento rettilineo negli 8 mesposti, ma è da ritenere che su una fondazione costi-tuita di segmenti rettilinei poggiasse un alzato rego-larmente curvo. Nella mezzeria del saggio, e quindi alcentro dell’asse trasversale dell’arena, vi era un’aper-tura irregolare ma con tracce di bordi conformati, en-tro cui doveva trovar sede una soglia per l’accesso adun vano sotterraneo. Sono emersi anche il lacerto di
steva essenzialmente nel fatto che la quota pavimen-tale di un corridoio sotterraneo dell’arena, intercetta-to dalla trincea che nell’Ottocento ne aveva ricalcatol’ingombro (combaciante con l’asse minore che costi-tuiva una linea ideale per un sondaggio), fu scambiataper la sua pavimentazione interna4. Dagli acquerelliottocenteschi (fig. 3), come dai lavori successivi, sem-brava ricavarsi infatti una quota di arena più bassa dicirca 3,50 m rispetto al p.c. del 1881 (il piano attualeinterno dei giardini è nell’area del saggio circa 0,60 mpiù basso di allora), e quindi la naturale deduzione dipoter portare alla luce in futuro ampie parti ancorasepolte.
Angela Ruta Serafini, Stefano Tuzzato,Paola Zanovello
IL SAGGIO DI SCAVO
Con uno scavo di 22 m per 9 si riaprì così l’anticatrincea5, che ben presto apparve ricca di informazioniper certi versi sorprendenti; in questa sede, per i limi-ti di spazio, si daranno pochi cenni schematici. Va su-bito osservato, procedendo in ordine stratigrafico,come i livelli alluvionali precedenti l’arena superasse-ro incontrovertibilmente di almeno 1,5 m la quota delpiano di calpestio antico ipotizzato in passato. Inol-
22 , ,
(G), largo circa m 3,10 e lungo almeno 10,50 e in pro-secuzione oltre il limite ovest di scavo, ricostruito gra-zie ai tagli di spoglio che risparmiarono porzioni dipreparazioni pavimentali in cocciopesto, e all’im-pronta delle grandi lastre di contenimento delle pare-ti, dello stesso tipo di quelle del corridoio. Mancava-no del tutto dati sull’alzato e sulla copertura del sot-terraneo.
Il pavimento vero e proprio, di cui, forse, rimane-vano due lastre in trachite, si sarebbe trovato diversicm più in alto rispetto al cocciopesto10.
L’ambiente interrato si allargava su entrambi i lati,dopo 4,50 m, per un’ampiezza a sua volta di 4,50 m; laprofondità delle due rientranze (H1, H2) non è stataindagata. Un lungo monolite trachitico, un architrave,giaceva (e tuttora giace) quasi sul fondo del sotterra-neo (il suo crollo avvenne dopo lo spoglio del rivesti-mento pavimentale ipogeo), ma il Ghirardini avevadescritto “due grandi pezzi di trachite, che sembranoessere appartenuti a un architrave, lunghi ciascuno m4, larghi m 0,75, e della grossezza di m 0,55, trovati nelcentro a oriente l’uno, l’altro a occidente dell’asse mi-nore”11. Il secondo architrave è con tutta evidenzaquello oggi utilizzato nei pressi come panca, per i giar-dini dell’Arena. I due architravi, che potrebbero esse-re crollati nel sotterraneo senza ulteriori spostamentifino all’epoca moderna, confermerebbero la presenzadi veri e propri vani laterali e simmetrici, in corrispon-denza delle due rientranze del corridoio.
un muro disposto radialmente (J), conservato per m3,80, e un altro lacerto murario quadrangolare in po-sizione simmetrica, dall’incerta interpretazione.
Un corridoio con asse nord/sud (F), al quale senzadubbio corrisponde un tratto dei “viottoli” indivi-duati nel 18817, largo internamente m 0,80, si diparti-va dal centro dello spazio tra il muro del podio (C) eil muro anulare (B); piegava poi, con un angolo retto,verso il centro dell’anfiteatro, nell’asse del raggio cor-rispondente all’asse minore dell’arena, proseguendoper m 4,25 8. Le pareti del corridoio erano costituiteda lastre in marmo ammonitico9 (una di queste, con-servatasi parzialmente in situ, misurava m 1,50 x>1,05 x 0,10), incassate nel terreno e fermate alla baseda un cordolo di cocciopesto; un livello di malta eframmenti laterizi costituiva forse un piano di cantie-re piuttosto che il pavimento vero e proprio.Sull’innesto dei due tratti tra loro ortogonali insiste-vano alcuni dei grandi blocchi esposti dal 1881 finoad epoca recente (fig. 5). I livelli a malta e laterizi e letracce di malta sulla faccia di una lastra in posizionesub-primaria, pur orientando ad ipotizzare più fasicostruttive, potrebbero riferirsi in alternativa a pianidi cantiere e preparazioni; tutti declinavano verso ilcentro dell’edificio, così come un “muretto” in coc-ciopesto, le lastre e gli spolii, fino alla breccia parzial-mente sagomata sul muro del podio.
Oltrepassata quest’ultima, la rampa immetteva inun ambiente centrato nell’asse minore dell’anfiteatro
23:
di edifici della X Regio mostrano notevoli analogieper dimensioni, tecniche costruttive e decorazione ar-chitettonica: è in corso di studio il materiale recupe-rato nello scavo di Padova, che potrà aggiungerequalche dato sulla cronologia dell’anfiteatro patavi-no, che appare comunque allinearsi all’imponenteprocesso di monumentalizzazione che vede protago-niste le più importanti città del nord-est italico eistriano.
Paola Zanovello
Le soglie della tripla apertura (D)nel muro anulare mediano (A in fig.1) indicano che il pavimento dellecampate radiali adiacenti e dell’am-bulacro interno si trovava a m 13,90s.l.m.12. È del resto evidente che le so-glie sopravanzano nettamente le quo-te romane in quest’area di Padova; lamaggiore altezza si ritiene sia imputa-bile in parte alla scelta di un sito giàmorfologicamente elevato, e in partea una necessità “tecnica”: il bisognodi fondazioni imponenti e la grandequantità di materiale di risulta conse-guente.
In conclusione il saggio di scavo,senza quasi intaccare strati antichi,oltre a confermare l’anteriorità dellatubatura in trachite rispetto al grandeedificio, ha portato a reinterpretare ilcorridoio inclinato ad “L”, scopren-do che esso conduceva non alla caveama ad un sotterraneo presente sul-l’asse minore dell’arena, finora nonindividuato, offrendo alcuni elementiessenziali per una nuova ricostruzio-ne dell’area interna dell’anfiteatro pa-tavino.
Stefano Tuzzato, Stefania Bonato
Per la realizzazione del grande an-fiteatro, quindi, fu defunzionalizzatoun lungo tratto dell’acquedotto urba-no, che fu con ogni probabilità fattopassare nelle immediate adiacenze,forse utilizzando grandi fistule di piombo, di cui una,con marchio P(ublicum) M(unicipii) Pat(avii), ancorasi conserva presso il Museo degli Eremitani13. Il sag-gio di scavo documenta inoltre un altro importantedato: il condotto poggiava su un piano in leggera pen-denza verso est, confermando che si trattava di unsettore dell’acquedotto destinato all’approvvigiona-mento idrico di un quartiere periferico.
Il dato sicuramente più eclatante riguarda peròl’esistenza di strutture sotterranee all’arena, come di-venne tipico nei più importanti edifici anfiteatrali delmondo romano, soprattutto a partire dall’età flavia(Roma, Capua, Pozzuoli). Il nord Italia sembra pre-correre queste esperienze: è testimoniata la presenzadi vani ipogei già nella I metà del I sec. d.C. ad esem-pio a Libarna14 nella Regio IX – Liguria, ma soprattut-to nella X Regio – Venetia et Histria, dove accanto aPatavium si collocano, meglio documentati archeolo-gicamente, gli anfiteatri di Verona e Pola15. I tre gran-
, , 24
Fig. 5 - L’angolo del corridoio a “L” che conduceva al sotterraneodell’anfiteatro, coperto da materiali di crollo in parte spostati du-rante e dopo gli scavi del 1881. La lastra inclinata verso sinistra,parzialmente in situ, fa parte del rivestimento del corridoio.Fig. 6 - Il tratto della conduttura in trachite riemerso con il saggio,tra i muri B e C della fig. 1, visto da nord.
: 25
1 Direzione di Angela Ruta, Soprintendenza per i Beni Ar-cheologici del Veneto. Intervento finanziato dal Comune di Pa-dova, con un contributo della Regione Veneto. Hanno partecipa-to, con Tuzzato Studio di Archeologia, S. Bonato, M. Cagnoni, D.Rossetto e per lo studio dei reperti S. Mazzocchin, C. Destro, F.Rinaldi dell’Università di Padova, Dipartimento di Archeologia,oltre a M. Maffei per la ricerca d’archivio. Si ringraziano il Setto-re Edilizia Monumentale del Comune per l’attenta cura nella pro-grammazione del cantiere, il Museo agli Eremitani per l’ospi-talità, e l’arch. A. Verdi per aver fornito il rilievo del muro esisten-te dell’anfiteatro.
2 TOLOMEI 1881, GHIRARDINI 1881, BRUNELLI BONETTI 1916 (la cita-zione è tratta da quest’ultimo, a p. 352).
3 Si tratta di tre disegni acquerellati in scala (Atti Comunali, b.3075, una pianta e due sezioni), della perizia di stima del 4 set-tembre 1880, di una lettera del 3 aprile 1881 al Sindaco di Pado-va, e della “Relazione dei lavori eseguiti nell’Arena e proposte peraltri lavori da eseguirsi nel 1882”.
4 In realtà, il Tolomei fin dal 1881 ne aveva data la corretta in-terpretazione, che però fu trascurata o contraddetta in tutti glistudi successivi.
5 La trincea del 1881 era rimasta parzialmente aperta per di-versi decenni, degradandosi e costituendo un piccolo invaso su-perabile con un ponticello.
6 ZANOVELLO 1997, pp. 117-119. Il Ghirardini (GHIRARDINI 1881)riferisce di un tratto lungo 17 m.
7 Si cita al riguardo il brano del Brunelli Bonetti (BRUNELLI BO-NETTI 1916, p. 354): “Interessanti sono i due viottoli c e c’ postisull’asse minore, larghi m 0,80 e lunghi m 5.00, discendenti a pia-no inclinato verso il centro dell’Arena ed attraversanti il muro delpodio. Essi erano pavimentati e fiancheggiati con lastre di marmodi Verona, di cui si conservano soltanto piccole tracce, ora quasiscomparse sotto il rigoglio di erbe invadenti. Per questi viottoli iocredo si accedesse direttamente al piano interno dell’Arena, comeavveniva negli anfiteatri di Pompei e in quello di Nimes”. Prece-duto peraltro dalla descrizione del Ghirardini (GHIRARDINI 1881),che se ne discosta quando descrive i corridoi pavimentati di “cal-cestruzzo”, e che si trovò a sua volta costretto a spiegazioni com-plesse per giustificare, sia pure prudentemente, il basso livello deiviottoli rispetto al – da lui stesso – presunto piano dell’arena, epur riportando correttamente il diverso parere del Tolomei: “ed èmolto notevole che erano fiancheggiati e chiusi ai lati da una spe-cie di parapetto, formato di lastre di marmo rosso di Verona, al-cune delle quali stanno ancora al loro posto, altre cadute giù, tor-narono in luce lì presso. L’egregio sig. ing. Brunelli, facendomi os-servare i due sbocchi o viottoli in parola, notò giustamente che,arrestandosi essi a metà circa dello spazio che è tra i muri A e B,in quel punto doveva forse trovarsi una scaletta di legno, la qualepoggiata al muro B avrebbe condotto al piano dell’ambulacro po-sto tra B e C, che era più alto, come si disse prima, del livello ter-reno dell’edificio”. Ma ben più interessante era – di pochissimoprecedente – la descrizione del Tolomei: “Sono degne di nota letracce di due vie (C.C’) discendenti con forte declivio verso ilcentro che si ravvisano nell’una e nell’altra trincea dell’asse mino-re. Partono dal muro fondamentale della media cavea ed attraver-sano il podium con piano fortemente cementato, fiancheggiate dalastre di pietra veronese rinforzate esse pure da solidissimo ce-mento. Domandano la nostra attenzione perciò che accennereb-bero ad una discesa verso ad ipogei ed a sostruzioni nel centrodell’Arena che ci richiamano alla mente l’anfiteatro Flavio e quel-lo di Capua”. Questo sospetto non ebbe però alcun seguito, escomparve ben presto dagli studi successivi.
8 m 5,60 se si considera l’angolo esterno.9 Molto probabilmente veronese. Definizione del prof. G.P.
De Vecchi, che si ringrazia.10 Dalla relazione del Maistri: “…sotto a quei massi di mase-
gna /…/ si scavò ancora, e si rinvennero non uno, ma due pavi-
menti. L’uno compreso fra il primo ed il secondo muro nuova-mente scoperti, cioè nella zona larga m. 7 – e questo con vari qua-dri di cotto ancora solidamente fermati in malta al sottofondo; edil secondo al di qua dell’ultimo muro e questo più alto del primoe costituito da una scagliata senza malta, rassomigliante di moltoalle nostre croste di massicciate stradali”. Va tenuto presente cheil sotterraneo, prima degli spogli e dell’obliterazione, potrebbeessere stato adattato e utilizzato per un periodo anche lungo, co-me inducono a ritenere alcuni dati di scavo.
11 GHIRARDINI 1881, p. 15. Le misure sono: m 3,87x0,68x0,54.Lo stesso Maestri nella relazione parla “più verso il centro, di unenorme monolite pure di masegna lungo quasi quattro metri,squadrato e lavorato con varie intaccature per modo da farlo rite-nere un architrave”.
12 Sarebbe opportuno verificare la quota dei lastroni calcareivisibili all’esterno del muro C, verso corso Garibaldi e la Cassa diRisparmio, che sembrano essere i resti in situ della pavimentazio-ne di una campata radiale, e che forse sono quelli visti e descrittidal Brunelli Bonetti nel 1906-07.
13 ZANOVELLO 1997, p. 117. Il dato relativo alla defunzionalizza-zione del condotto era comunque deducibile dalla relazione e so-prattutto dalla sezione riportata dal Brunelli Bonetti (1881, tav.II).
14 TOSI 2003, pp. 481-482.15 TOSI 2003, pp. 535-537; 521-523.
BIBLIOGRAFIA
BRUNELLI BONETTI F. 1916, Studi intorno all’Anfiteatro romano di Pa-dova, “Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Pado-va”, XXXII, IV, pp. 352-362.
GHIRARDINI G. 1881, Gli scavi dell’Anfiteatro di Padova, Roma.TOLOMEI A. 1881, La Cappella degli Scrovegni e l’Arena di Padova.
Nuovi appunti e ricordi, Padova.TOSI G. 2003, Gli edifici per spettacoli nell’Italia romana. Catalogo,
Roma.ZANOVELLO P. 1997, Aqua atestina, aqua patavina. Sorgenti e acque-
dotti romani nel territorio dei Colli Euganei, Padova.