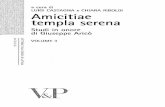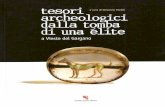S’io doglio no è Meraviglia. Indagine sulle varianti di un testo a tradizione plurima
-
Upload
unisalento -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of S’io doglio no è Meraviglia. Indagine sulle varianti di un testo a tradizione plurima
SCUOLA SUPERIORE ISUFI
S’io doglio no è Meraviglia Indagine sulle varianti di un testo a tradizione plurima
a cura di
Gabriele Rosato
Maggio 2012
S’io doglio no è Meraviglia
I
In copertina: Particolare delle tre fodere del mantello di Ruggero II
Schatzkammer del Kunsthistorisches Museum, Vienna
S’io doglio no è Meraviglia
II
Prefazione
Come reca il sottotitolo sul frontespizio, il presente elaborato risulta come un primo
tentativo di ricerca filologica volta a indagare le varianti linguistiche (in materia di
lessico, fonetica e morfologia) di un testo poetico a tradizione plurima. Il sonetto in
esame – S’io doglio no è Meraviglia – è unanimemente considerato fra i più mirabili
esempi di lirica tràditi dalla vasta produzione della Scuola Siciliana, e l’autore –
Giacomo da Lentini – ne fu l’indiscusso caposcuola.
Per il sottoscritto, la ricerca in questione è stata la prima esperienza di studio
filologico, ma sin dai primi incontri, il ciclo seminariale – tenuto dal Prof. Rosario
Coluccia (Accademico della Crusca) – si è rivelato una preziosa occasione di
accrescimento culturale. Gli ottimi spunti di riflessione, fra l’altro, hanno permesso
agli allievi di maturare una maggiore coscienza critica anche in altri ambiti
d’interesse, il che rientra pienamente nella vocazione interdisciplinare della nostra
Scuola.
L’elaborato è il frutto di un’indagine condotta essenzialmente su alcuni validi testi di
riferimento – elencati in bibliografia – reperiti sia nelle Biblioteche dell’Università
del Salento, sia consultando quella dell’Abbazia Madonna della Scala, in Noci (Bari).
Inoltre si è rivelato davvero prezioso il contributo della prof.ssa Elisabetta Romano
(docente presso l’IISS Gigante di Alberobello), che ha messo a mia disposizione degli
strumenti didattici utili alla ricerca filologica.
Di seguito è proposta una breve introduzione alla Scuola Siciliana, che costituì lo
sfondo storico-letterario entro il quale, Giacomo da Lentini, intessette la variopinta
tela di sonetti di sua produzione. Questi ci sono stati tramandati grazie ai polverosi
manoscritti superstiti, redatti nel corso dei secoli, che ancora oggi costituiscono
autentici reperti del passato e reliquie della storia dell’umanità.
Segue la versione integrale della poesia, così come trasmessaci dai manoscritti
Vaticano Latino 3793, V1 e Laurenziano, Lb; pur tuttavia, l’indagine è stata condotta
– in via del tutto sperimentale – sulle strofe III, IV e V.
Gabriele Rosato
S’io doglio no è Meraviglia
III
La Scuola Siciliana: tempi e luoghi
Le origini della poesia lirica
nel continente europeo
sono da collocare intorno
alla fine dell’XI secolo,
contestualmente al contri-
buto attivo del primo trova-
tore, Guglielmo IX d’Aquita-
nia (1071-1126). Si trattava
essenzialmente di una
poesia in lingua volgare che
i trovatori provenzali aveva-
no legato strettamente alla
vita e ai valori cortesi. Di
conseguenza l’occitano
diventava la lingua conven-
zionale della lirica, e il
modello trobadorico fu di
ispirazione anche in altri
territori. D’altronde, la
poesia lirica non poteva che
nascere dalla vivace esperienza dei rapporti sociali della corta feudale. E furono
queste le solide fondamenta sulle quali si edificò in Italia la lirica siciliana, promossa
dall’imperatore Federico II di Svevia (che come iniziatore, probabilmente fu pure
talvolta autore di alcune liriche) in un periodo che si colloca negli anni Venti del XIII
secolo. In realtà, secondo l’ipotesi di A. Roncaglia1 sarebbe rintracciabile addirittura
una data precisa – il 1233 – ma, con più probabilità, la fondazione andrebbe
anticipata di circa un decennio. La corte federiciana costituì evidentemente il punto
nevralgico della lirica d’arte che, per quanto itinerante, era per lo più stabilita in
Sicilia: territorio divenuto non più solo di importanza per l’attività politica, quanto
più un influente centro d’erudizione per l’impero intero.
1: A. RONCAGLIA, Per il 750° anniversario della Scuola poetica siciliana, «Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche, filologiche», s. VIII, XXXVIII 1983, pp. 321-333, rist. in La lirica, a cura di L. FORMISANO, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 412-429
Figura 1: Mappa della Poesia volgare nel XIII secolo in Italia
S’io doglio no è Meraviglia
IV
Tale fu l’influenza della poesia siciliana che i poeti successivi, sino addirittura agli
stilnovisti, furono chiamati siciliani anche se operavano in regioni del Centro o del
Nord Italia2. Oggi si parla di Scuola Siciliana solo per indicare il gruppo di poeti (in
numero di circa 25) attivi nel periodo fra il 1230 e il 1266, quando, con la battaglia di
Benevento (in cui venne sconfitto Manfredi, figlio e successore di Federico II), il
sogno ghibellino della dinastia sveva subì una crisi rapida e definitiva2. Queste
considerazioni portano a ritenere i siciliani come i primi poeti d’arte in Italia, al
punto da poter essere considerati come i fondatori della tradizione letteraria
italiana3. Il nutrito gruppo di poeti – in gran parte occupati come notai, diplomatici o
comunque funzionari alle dirette dipendenze dell’imperatore – vantava personalità
di rilievo per il tempo, quali lo stesso figlio di Federico, Enzo, oltre a vari esponenti di
corte quali Guido e Odo delle Colonne, Pier della Vigna e Giacomino Pugliese.
Cionondimeno resta indiscusso il ruolo del principale esponente di questo
movimento, Giacomo da Lentini. Conosciuto anche come Jacopo da Lentini, ma
soprattutto come il Notaro, in un documento messinese del 1240 si firma proprio
come «Jacobus de Lentino domini imperatoris notarius», in qualità di alto
funzionario del sovrano. Non a caso, anche Dante in seguito lo chiamerà per
antonomasia il "Notaro"4. Di sicuro fu quello che ebbe più larga fama, e la cui
produzione ci è giunta in maggior copia: gli sono infatti attribuiti 38 componimenti2
tra sonetti e canzoni. Egli fu anche, per quanto consta, l’ideatore del sonetto, forma
metrica fortunatissima nella poesia italiana. Fu però con la morte dello stesso
Federico II – avvenuta a Fiorentino di Puglia il 13 dicembre 1250 – che il movimento
poetico cominciò a subire un declino che si realizzò appieno a seguito di una serie di
episodi successivi. Pur tuttavia, contestualmente agli sviluppi dell’esperienza
siciliana è riscontrabile, perlomeno nelle linee fondamentali, lo spostamento della
lirica siciliana verso la Toscana e il Settentrione3, benché sia pure accertato il
transito attraverso il Mezzogiorno continentale5.
2: LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, Manuale di Letteratura, Vol. I - Medioevo e Rinascimento, G.B. Palumbo Ed, Palermo, 2006, p.61 3: R. COLUCCIA, Scuola poetica siciliana. Lingua, in Federico II. Enciclopedia fridericiana, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 2005 4: Dizionario Letterario delle opere e dei personaggi, Vol. VI, Milano, Bompiani Ed, 1972 5: R. COLUCCIA, I poeti della Scuola Siciliana, Vol. III – Poeti siculo-toscani, Mondadori, Milano 2008
Figura 2: Federico II di Svevia e la sua corte
S’io doglio no è Meraviglia
V
S’io doglio no è Meraviglia Giacomo da Lentini
S’io doglio no è meraviglia
e s’io sospiro e lamento:
amor lontano mi piglia
dogliosa pena ch’eo sento,
membrando c’eo sia diviso 5
di vedere lo bel viso
per cui peno e sto ’n tormento.
Allegranza lo vedere
mi donava proximano,
lo contrario deggio avere 10
ch’eo ne son fatto lontano:
s’eo veggendo avea allegranza,
or no la veggio ò pesanza
mi distringe e tene mano.
Lo meo core eo l’aio lassato 15
a la dolze donna mia:
dogliomi ch’eo so’ allungiato
da sì dolze compagnia;
co·madonna sta lo core,
che de lo meo petto è fore, 20
e dimora in sua bailia.
Dogliomi e adiro sovente
de lo core che dimora
con madonna mia avenente,
in sì gran bona-ventura: 25
odio e invidio tale affare,
che con lei non posso stare
né veder la sua figura.
Sovente mi doglio e adiro,
fuggir mi fanno allegrezze; 30
tuttavia raguardo e miro
le suoe adornate fattezze,
lo bel viso e l’ornamento
e lo dolze parlamento,
occhi, ahi, vaghi e bronde trezze. 35
Figura 3: Federico II di Hohenstaufen e il falcone raffigurati nel suo libro
De arte venandi cum avibus; miniatura del XIII secolo (Biblioteca Vaticana)
S’io doglio no è Meraviglia
VI
Note sulle varianti
v. 15 – Meo: Mio antiquato meo è da meus, acc. meo (m), come in Dio, antiq. Deo da Deus [Grammatica Storica della Lingua Italiana, F. Demattio]. In analogia a meo si ebbe in antico il romanesco teo, seo, tio, sio; l’umbro tio, sio (per es. in Jacopone da Todi) [Grammatica storica della Lingua Italiana e dei suoi dialetti, Morfologia, G. Rohlfs, § 427]. Core: variante poetica di cuore, attraverso il prov. Cors, il fr. Coeur, l’a. sp. Cuer (mod. corazón, port. coraçâo); ladin. Kor, koer: dal latino cor – genit. cordis e greco kêr, kèar, kardia; dalla radice indoeuropea skar, skard [Vocabolario etimologico della Lingua Italiana, O. Pianigiani]. I neutri della terza declinazione latina uscenti in consonante (come cor) dànno in Italiano forme con uscita vocalica: cuore. Queste forme possono riguardarsi come dolativi, ovvero come accusativi formati analogicamente [Grammatica storica della Lingua Italiana e dei suoi dialetti, Morfologia, G. Rohlfs, § 348].
Eo: dalle base latina ĕgō, la ĕ tonica in iato, anziché produrre il dittongo iè (dando luogo a ièo) si è progressivamente chiusa: ĕō > èo > éo > io [Nuovi lineamenti di grammatica storica della Lingua Italiana, Patota, p. 66]. L’aio: lagio – estesa risulta la
generalizzazione del verbo avere con gli intransitivi nel Meri-dione. Nel napole-tano per esempio si dice aggio venuto, ma ancor più rego-lare è tale uso in Calabria e Sicilia [Grammatica storica della Lingua Italiana e dei suoi dialetti, G. Rohlfs, § 729]. Lassato: da lasciato, rum. lasà; prov. laissar; fr. laisser; catal. deixar; ant. sp. lexar, leixar; port. leixar, deixar. Dal latino laxàre, allargare, sciogliere, allentare [Voca-bolario etimologico
della Lingua Italiana, O. Pianigiani].
v. 16 – Dolze: da dolce; così viene pronunciato nel veneto [Dizionario della Lingua Italiana, Tommaseo-Bellini].
Figura 4: La c. 140r del Laurenziano Rediano 9f (Biblioteca Mediceo
Laurenziana di Firenze); riporta due sonetti del notaro Giacomo da Lentini
S’io doglio no è Meraviglia
VII
v. 17 – Dogliomi: la vocale di derivazione i (e) talvolta si conserva
(come in abbia, sappia), ma più spesso produce l’ammollimento della l o della n, o il g aspro, come in doglio, dolgo (doleo) [Grammatica storica della Lingua Italiana, Fornaciari-Diez, p. 67]. So’: apocope per sono [cfr. nota in Canzoniere, F. Petrarca, Donzelli Editore, p. 82]. Allungiato: da allungiare, allontanare; verso da intendere come provo dolore perché mi sono allontanato [Biblioteca dei Classici italiani di G. Bonghi, da http://www.classicitaliani.it/ glossari/glossario_medioevo_01.htm].
v. 18 – Sì: così: caso di avverbio di comparazione; Sic: sì fattamente, talmente [Grammatica storica della Lingua Italiana, Fornaciari-Diez, p. 77].
v. 19 – Co•: da con, preposizione che in questo caso esprime compagnia. In varie parti del Mezzogiorno la
consonante finale è caduta [Grammatica storica della Lingua Italiana e dei suoi dialetti, G. Rohlfs, § 802].
v. 20 – Fore: da fora, fuori. Lo sviluppo da avverbio a preposizione inizia già nel latino, cfr. in San Gerolamo (IV secolo) foras portam. In Italia si sono conservate entrambe le forme latine, foris e foras [Grammatica storica della Lingua Italiana e dei suoi dialetti, G. Rohlfs, § 848].
v. 21 – Bailia: da balìa, potere (sinonimo di potenza, forza) [Biblioteca dei Classici italiani di G. Bonghi, da http://www.classicitaliani.it/glossari/ glossario_medioevo_01.htm]. In questo caso sarebbe evidentemente da intendere l’accezione del termine in balìa degli affetti: ad esempio Dant. Rim. 30. ediz. Crus. (Gh.), o ancora Del Signor che m’ha in balía (Amore), Bocc. Canz. 6. [Dizionario della Lingua Italiana, Tommaseo-Bellini].
v. 22 – Adiro: intr., mi rattristo (cfr. v. 29), in dittologia sinonimica con doglio [I poeti della Scuola Siciliana, Vol. I – Giacomo da Lentini, R. Antonelli, p. 309]. Di necessità, colui che si adira si cruccia pure, qui si scorge però la differenza fra adirarsi e crucciarsi: così si spiega il proverbio toscano Non t’adirare a tuo danno [Dizionario della Lingua Italiana, Tommaseo-Bellini].
v. 24 – Avenente: vocativo, solito gallicismo per ‘leggiadra, bella’ [I poeti della Scuola Siciliana, Vol. III – Poeti Siculo-Toscani, R. Coluccia, p. 58].