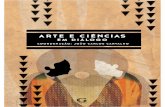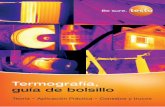I connettivi inferenziali nel testo: un confronto tra la prosa giornalistica e letteraria...
-
Upload
uniromatre -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of I connettivi inferenziali nel testo: un confronto tra la prosa giornalistica e letteraria...
ILARIA MINGIONI (Roma)
I connettivi inferenziali nel testo: un confronto tra la prosa
giornalistica e letteraria dell’ultimo cinquantennio.
0. Il connettivo inferenziale (C.I.) può essere considerato una
sotto-categoria del connettivo testuale (C.T.), che, sulla base
delle voci curate da Angela Ferrari nell’ENCIT e da Francesco
Sabatini nel DISC, qui definiamo come un elemento linguistico di
varia natura morfo-sintattica e semantica, che congiunge due unità
di testo indicando la relazione logica esistente tra esse; tra i
C.T. possono essere individuati quelli “conclusivi”, che cioè
indicano la relazione di conclusività tra unità connesse, dal
punto di vista dell’organizzazione degli atti di enunciazione e da
quello della distribuzione di contenuti semantici. Alla base della
relazione di conclusività sussistono alcuni aspetti che dipendono
dal significato descrittivo del connettivo e da quello pragmatico-
testuale: ad es., il termine infine contiene concettualmente il
tratto della temporalità, riconoscibile nell’etimologia e in virtù
della sua funzione avverbiale; a livello testuale esso trasferisce
tale semantica nella dispositio delle sequenze e, in relazione al co-
testo, può anche denotare valori istruzionali1 di altro tipo, tra1 Con tale dicitura si allude al concetto secondo cui i segni linguistici sonoistruzioni impartite al ricevente da chi produce un testo (orale o scritto)durante l’atto comunicativo, affinché vengano attuate le operazioni necessarieper la decodifica del testo ricevuto: Weinrich (1988: 139-141). Quando quindi sifa riferimento al “significato/valore istruzionale” (o procedurale) nell’analisidei singoli connettivi, si allude al loro risvolto pragmatico, nell’ottica dellalinguistica del testo. Ogni connettivo ha un suo significato intrinseco più omeno ricco: a seconda del grado di specificità che possiede il connettivo,dunque, l’istruzione sarà più o meno “pesante” semanticamente. Connettivi menoricchi sono connettivi maggiormente polifunzionali; viceversa connettivi più“pesanti” hanno una più precisa valenza, che li rende più facilmente
cui, come si vedrà, quello inferenziale. Il C.I. è un elemento il
cui significato istruzionale dà conto di un’inferenza2 esercitata
nella connessione delle unità di testo, definibile per la natura
esplicita o implicita delle premesse da cui scaturisce. Tra i
conclusivi, si possono distinguere C.I. di tipo deduttivo e di tipo
sintetico: i primi (quindi, dunque, in ultima analisi, in ultima istanza)3 si
basano sull’esplicitazione di un contenuto semantico cui si
collega una sequenza da esso direttamente dedotta; i secondi (in fin
dei conti, infine, in definitiva, in ultima analisi/istanza, in fondo)4 informano di un
ragionamento che sfrutta dati referenziali, premesse implicite che
si intendono come conosciute e condivise e connettono una sequenza
conclusiva alla precedente chiamando in causa il non detto. Mauri
e van der Auwera (2012), spiegando la dicotomia tra significato
concettuale (in base al quale sarebbero analizzabili connettivi
“vero-funzionali” come and, or) e significato procedurale (in base
al quale sarebbero analizzabili connettivi “non vero-funzionali”
come so, but, nevertheless), sostengono la necessità di partire da unaclassificabili e circoscrivibili. Sulle definizioni dei cosiddetti conceptualmeaning e procedural meaning, si veda Blakemore (1987, 1992 e 2002).2 L’inferenza, detta più genericamente ‘deduzione’, secondo la definizione delDISC, è un “ragionamento con cui si trae una conseguenza da una o più premesse”.Ne Il Conciso Treccani si legge: «nel linguaggio filosofico, ogni forma diragionamento con cui si dimostri il logico conseguire di una verità da un’altra;sinonimo quindi di illazione. Regole di inferenza (definizione di ambito matematico)in un sistema deduttivo, l’insieme delle regole secondo le quali le proposizionipossono essere dedotte dai postulati».3 La serie non si esaurisce con questi casi: ad es. anche la forma di conseguenzaè, sulla base del DISC, una locuzione congiuntiva testuale analoga a perciò,quindi, che conferisce valore deduttivo-conclusivo a una frase o sequenza didiscorso rispetto a quanto detto in precedenza. In questa sede si consideranoalcuni dei connettivi che possono rappresentare le funzioni analizzate, senzaper questo ritenere esaurito il paradigma delle forme.4 Dunque e quindi (non considerati sinonimi) sono i connettivi presi comeriferimento emblematico nell’espressione della deduzione; la formula in fin dei contiè intesa come espressione per antonomasia della sintesi conclusiva; a questeforme si possono aggiungere alcune varianti che si menzioneranno nel corso dellatrattazione.
concezione che consideri come semantica del connettivo «the
portion of meaning that is part of the linguistic form,
independent of its possible truth-functionality or logical
formalizability», mentre attribuisca alla pragmatica «the portion
of meaning that depends on speakers’ inferential processes» (Ivi:
349).
In base alle caratteristiche del testo, cioè al suo essere poco,
mediamente o molto vincolante ( Sabatini 1990), il ricorso a un
C.I. presenta delle differenze: confrontando esempi di prosa
giornalistica con altri di prosa letteraria, si può intuire come
il meccanismo deduttivo sia maggiormente riscontrabile nella prima
tipologia, soprattutto nel caso di articoli di taglio divulgativo,
nei quali si punta alla “persuasione” del ricevente; negli
articoli di attualità si può rilevare un’inferenza di tipo
sintetico, in quanto lo scritto documenta fatti di dominio
pubblico, dei quali chi legge ha cognizione. In un testo
letterario la creazione di uno sfondo narrativo e il ricorrere
alle capacità evocative di dati extralinguistici aprono la
possibilità allo sfruttamento di meccanismi inferenziali che
coinvolgono il non detto; la tendenza al meccanismo deduttivo,
invece, sarà forse minoritaria, in virtù del diverso fine,
estetico5.
Approfondiamo l’aspetto teorico della questione proponendo alcune
definizioni elaborate nell’ambito della lavorazione della tesi di
5 Preciso che la delimitazione del campo di una funzione testuale rispetto aun’altra (in sé giudicabile come una forzatura) risponde solo all’esigenza dicircoscrivere il discorso ed evitarne la dispersione: l’obiettivo è ladescrizione di un tipo particolare di connessione logica del testo e deglistrumenti linguistici (i connettivi) che concorrono alla sua fattibilità.
dottorato: Mingioni (2014) incentrata sui connettivi conclusivi6,
analizzati in prospettiva sincronica e diacronica, sulla base
della loro funzione nel testo7; anzitutto stabiliamo che l’area
concettuale della conclusività contiene diversi aspetti,
classificabili e sfruttabili in chiave euristica per
l’interpretazione del singolo connettivo; le sotto-categorie
individuate sono quelle della temporalità, della riformulazione,
della deduzione e della sintesi: nella fattispecie queste ultime
due indicano, rispettivamente, che la relazione di conclusività
impressa dai connettivi è di tipo logico-deduttivo, cioè in altre
parole il contenuto espresso nell’enunciato connesso è una
conseguenza logica derivata dai contenuti espliciti, oppure che la
relazione di conclusività che si attesta tra sequenze connesse è
basata su premesse implicite e dà conto del passaggio finale di un
meccanismo inferenziale operato a partire da e a proposito di
informazioni conosciute (e condivise) in via pregressa8.6 Quello della “conclusione”, o meglio della “conclusività” è un concetto cherimanda a due diverse chiavi di lettura, una di tipo logico dal punto di vistadel significato del testo (e allora si tratta di conclusione di un movimentoinferenziale) e una che riguarda la dispositio, cioè la distribuzione delle diversecomponenti del testo, sia a livello strettamente fisico (atti di enunciazione),sia a livello di contenuto (organizzazione dei contenuti semantici).7 L’approccio funzionale permette di analizzare connettivi diversi tra loro daun punto di vista semantico e, soprattutto, sintattico: i connettivi testualiconclusivi hanno ciascuno uno statuto sintattico, uno lessicale (di significatoconcettuale, descrittivo), uno testuale (di significato pragmatico, proceduraleo istruzionale); l’aspetto sintattico ha un peso nella considerazione dellacapacità del connettivo di dare istruzioni, quindi nel definire in prima battutala ricchezza semantica dello stesso: ad es. infine è morfo-sintatticamente unavverbio, per finire (usato come connettivo testuale conclusivo) una proposizionefinale e quindi ha uno statuto sintattico ben diverso. Sul concetto disignificato cfr. Diodato (2007).8 Per evitare fraintendimenti utilizzo il termine “sintetico” differenziandolonettamente da “riassuntivo”, che qui non viene usato come sinonimo. L’aggettivo“sintetico” è adottato nell’indagine solo in riferimento ad una sintesi delragionamento implicito, non quindi in relazione al contenuto espresso (per ilquale si parlerebbe appunto di “riassunto”, legato all’aspetto dellariformulazione che qui non viene trattato).
Il concetto di conclusività dunque si articola in accezioni
particolari, che prevalgono le une sulle altre anche in funzione
del tipo di testo considerato: nella fattispecie, un genere
testuale di tipo argomentativo, come quello della saggistica o di
certa prosa giornalistica, si trova a sfruttare con evidenza le
diverse sfumature che pertengono al concetto della conclusività, a
cominciare da quella della distribuzione dei contenuti, che va
cioè a segnalare la transizione dalla fase dello sviluppo dei
contenuti a quella della loro compiutezza, ma anche la
riformulazione e l’inferenzialità. Il genere narrativo sfrutta
senza dubbio l’organizzazione dei contenuti dal punto di vista
della dispositio, mentre i meccanismi inferenziali potrebbero
verosimilmente avere minore spazio (soprattutto quello deduttivo,
che si è detto essere proprio dei testi che puntano al
convincimento del lettore, o a far apprendere un determinato
messaggio).
1. È il caso di proporre degli esempi che attestino le diverse
tipologie di C.I., al fine di chiarirne le peculiarità accennate:
per basare le osservazioni su un campione di testi attendibile, si
fa affidamento al corpus on line de «La Repubblica», che mette a
disposizione articoli di diverso genere, scritti tra il 1985 e il
2000, prevedendo l’ampliamento del quadro attraverso il
reperimento di ulteriori fonti giornalistiche recenti; allo stesso
modo, per l’ambito letterario e in particolare il genere
narrativo, si considera principalmente il corpus disponibile su dvd
del Primo Tesoro della Lingua Letteraria Italiana del Novecento, a cura di De
Mauro (PTLLIN), arricchendolo con altre attestazioni. Si è deciso di
osservare principalmente questi due corpora9 per delimitare più
agevolmente cronologia e genere testuale di riferimento, pur
prevedendo che l’arco di tempo considerato non permetterà forse di
verificare delle concrete modificazioni nell’uso dei connettivi,
mentre sarà forse possibile argomentare su come questo sia
influenzato dal tipo di testo e di stile.
1.1. Consideriamo la voce infine, assumendola come punto di
riferimento per le osservazioni relative agli altri connettivi.
Lasciando da parte il suo statuto avverbiale, questa forma ha, in
ottica testuale, un valore conclusivo basato anzitutto
sull’aspetto della temporalità (evincibile dal significato
concettuale), che riguarda l’articolazione del testo, ma anche la
distribuzione logica dei contenuti; in questa seconda accezione,
infine può manifestare gli aspetti della deduzione e della sintesi e
comportarsi quindi come C.I..
L’infine descrivibile come connettivo conclusivo di deduzione
presenta un tipo di significato piuttosto sfumato, che si può
assimilare al valore di un dunque o un quindi, ma di fatto
riscontrato non frequentemente nello scritto italiano attuale. Si
rileva per lo più all’interno di interrogative, dove spesso occupa
la posizione di explicit (ad es. in una frase come ‘che facciamo
infine?’, dove coincide con quel valore che può appartenere a quindi e
dunque, come si vedrà oltre, quando occorrono per sollecitare una
conclusione deduttiva). Per le caratteristiche proprie del genere
testuale, interrogative simili si riscontrano di rado in testi
9 Preciso che le fonti considerate differiscono nettamente tra loro per quantoconcerne la quantità di testi inclusi e per questa ragione solo laddove siriveli effettivamente utile si citeranno alcuni dati numerici, necessari semmaiper stime indicative di alcune tendenze.
giornalistici o divulgativi, mentre saranno più probabili in testi
narrativi (all’interno delle parti mimetiche).
Nel PTLLIN si rintracciano i seguenti esempi:
1) Qualcuno pone erbe magiche durante la notte per convincere ivisitatori inopportuni che la biblioteca è protetta da presenzediaboliche. Cosa hai provato, infine? (Umberto Eco, Il nome della Rosa,1981)
2) Questo è sufficiente per commuovermi davanti alla loro stupiditàcieca e indifesa. Ma che cosa vogliono, infine? Bisogna guardarsidal semplificare banalmente. (Alberto Arbasino, L’anonimo lombardo,1960)
3) Quanto più bello era il suo viso stanco, dolorante e fiero,quando appoggiava le mani in grembo in via Porpora, fissava gliocchi sbiaditi in un punto e si perdeva in pensieri sconosciuti! Chiera, infine, la principessa Turen? Un ricco pagliaccio con ilfaccione carnoso ispessito da una cipria troppo bianca contro ipomelli rosa pesco. (Francesca Sanvitale, Madre e figlia, 1980)
In questi casi l’infine è assimilabile al dunque che riprende
contenuti espressi in precedenza, sollecitandone la conclusione e
conferendo a quanto seguirà un aspetto consequenziale e deduttivo
(su questo tipo di semantica conclusiva si tornerà al momento
dell’analisi di dunque e quindi), che presuppone un’inferenza basata
su premesse esplicite.
In ambito giornalistico, i casi di infine deduttivo (tale solo nella
funzione vista, come mezzo per sollecitare una deduzione) sono di
difficile individuazione, dal momento che l’uso di interrogative
come quelle citate entra ben di rado in un testo con tutt’altri
fini e caratteristiche (salvo i casi di discorso diretto
riportato, che può avere punti in comune con le parti mimetiche
del testo narrativo); per di più si può affermare che l’infine
presentato si trova a sostituire forme propriamente deduttive, in
virtù di un’affinità semantica con esse, data da fattori
etimologici (più con quindi che con dunque e ne vedremo il perché al
momento della loro analisi), accanto ai quali però si sono
sviluppate accezioni peculiari che ne hanno poi distinto gli usi.
Nel corpus considerato non pare manifestarsi (sebbene non si
possano scandagliare una per una le quasi 40.000 occorrenze
presenti lungo l’intero asse cronologico), ma, pur ammettendo la
possibilità che esso compaia, il fatto che non emerga è indicativo
di un diverso impiego del connettivo.
Si definisce connettivo conclusivo sintetico l’infine parafrasabile
con un ‘in fin dei conti’, che attesta una conclusione raggiunta
in base a passaggi logici basati su dati non espressi nel testo e
in virtù di un processo inferenziale portato a termine (ad es. in
un enunciato come ‘più di questo non potevamo fare. Infine abbiamo
fatto anche troppo’, infine “sintetizza” le inferenze esercitate su
informazioni implicite che giustificano il contenuto ‘abbiamo
fatto anche troppo’).
Luscher e Moeschler (1990) hanno lavorato sul francese enfin,
presentato nel dizionario come un indicatore di ‘conclusione di
una serie’, ‘sollievo’, ‘rassegnazione’: gli ultimi due
significati si distinguono sulla base di fattori non linguistici,
ma contestuali (co-testo, punteggiatura). Chiedendosi come possano
esistere tanti valori semantico-pragmatici diversi e se questi
possano essere valutati sullo stesso piano, gli studiosi
sostengono che esista per enfin un valore originario di base che è
quello che definiscono “spazio-temporale” (di conclusione), al
quale, per senso figurato e fattori contestuali vari, si
aggiungono le nozioni di “conclusione di un processo” e
“conclusione di un discorso”.
Mosegaard Hansen (2005a e 2005b) ha osservato alcuni connettivi
francesi fra cui enfin, a proposito del quale sostiene che «the
prototype senses are, respectively, the temporal sense […]; a non-
truth-conditional ‘synthesising’ sense, in which enfin marks (a part
of) an utterance that sums up the previous discourse, formulates
it more pithily, or draws a conclusion from it; and a ‘repair’
sense, in which it marks the discourse in its scope as
constituting a corrective reformulation of some aspect of the
previous discourse»: Mosegaard Hansen (2005b: 155).
Buchi e Städtler (2008), considerando enfin come “grammème”10,
affermano che esso può essere definito temporale (col significato
di ‘da ultimo’) o aspettuale (col significato di ‘finalmente’,
‘dopo molta attesa’); inteso come “pragmatème”11, parlano di un enfin
epistemico: «cet emploi de enfin pourrait être glosé par ‘en
dernière analyse’, ‘tout compte fait’, ‘tout bien considéré’
(marque que le locuteur arrive à une conclusion sur la base de
tous les éléments disponibles). […] Le français partage la valeur
épistémique avec l’italien, où elle est attestée de même depuis le
Moyen Âge, et de façon ponctuelle avec l’espagnol du 16e siècle:
it. infine [dp. 1268 (Trattati morali di Albertano da Brescia
volgarizzati: schifare de’ la guerra quantunque tu pòi […], per
molte ragione. La prima è […]. La seconda ragione […]. La sesta
ragione […]. Et all’ultimo ti dico; che infine tre ragion sono per10 Unità minima della gerarchia grammaticale che insieme a quella fonologica (conil fonema) e a quella lessicale (con il morfema) costituisce le tre gerarchieconsiderate dalla strutturalismo americano nell’analisi della lingua (cfr.Treccani on line); il grammema equivale al tagmema (la tagmemica è teorialinguistica elaborata negli anni 1950 da K.L. Pike che osserva la correlazionetra la funzione grammaticale propria di una data posizione nella frase e laclasse di forme tra loro mutuamente sostituibili che possono comparire in quellaposizione).11 In linea con le gerarchie evidenziate nella nota precedente, con il terminepragmatème si fa riferimento all’unità minima della pragmatica.
le quale battaglie non si potrebbero agevolmente pensare), OVI;
DELI² [(dp. 1543); GDLI (dp. 1543)]12.
Quello definito come “sintetico” è un infine che esprime l’idea
della ‘fine di un processo’: Luscher-Moeschler (1990: 91), secondo
una proprietà che discende dal significato originario (quello
morfo-sintattico e descrittivo, temporale)13, che estende la sua
portata ben oltre, dalla dimensione locale a quella globale. La
commutazione con ‘in fin dei conti’ esprime in maniera più
esplicita il senso proprio di questo connettivo e l’idea di ‘fine
di ragionamento’, una fine che temporalmente (stando cioè al
significato lessicale di base) arriva ‘da ultima’, dopo altra
considerazione.
12 Per completezza riporto anche le altre osservazioni di Buchi e Städtler(2008): «[…] On rejoint donc là le cas d’une pragmaticalisation parallèle dansdifférentes langues romanes» (Ivi: 160- 161). Gli altri 5 tipi di enfin sonoquello ricapitolativo: «enfin peut être rendue par “bref”, “en un mot” et marqueque le locuteur conclut, résume à la fin d’un développement», enumerativo: «enfinénumératif se rattache à enfin temporel [Mosegaard Hansen, (2005a: 48-49)]: lesémantisme passe de la sphère mondaine (‘dernier élément d’une série de procès’)à la sphère discursive (‘dernier élément d’une énumération’)», rettificativo:«fréquemment réalisée en français oral spontané contemporain peut être gloséepar “du moins” (indique une rectification, un amendement)?», performativo (chesi può rendere con “oublions cela!”, “tant pis!”: «indique que le locuteurrenonce à insister. […] Seul le portugais présente l’équivalent de cettevaleur»; può essere usato per esprimere una sorta di rimprovero: «un dernieremploi énonciatif de enfin peut être rendu par “voyons!” (marque une impatienceréprobatrice, un rappel à l’ordre)» (Ivi: 161- 164).13 L’enfin epistemico può essere considerato equivalente al nostro infine sintetico,in base alle parole di Buchi / Städtler (2008: 160-162): «Pour ce qui est del’origine de enfin épistémique, les résultats de notre étude tendent à départagerles deux hypothèses envisagées par M.-B. Mosegaard Hansen (2005a : 63), quihésite entre un rattachement à enfin temporel et enfin récapitulatif, en faveur deenfin temporel, et cela en dépit de la chronologie (enfin épistémique est attestéplus d’un demi-siècle après enfin récapitulatif, contingence que nous mettons surle compte d’une documentation insuffisante), car l’italien, qui partageclairement enfin épistémique avec le français, ne possède pas l’équivalent deenfin récapitulatif» (Ivi: 162).
Vediamo degli esempi, considerandone anche alcuni che presentano
la polirematica in fin dei conti14, tenendo presente che, nell’accezione
qui considerata, l’infine sintetico ne condensa il significato
pragmatico:
4) Ovviamente, per difendere l'Italia, basta parlar bene degli StatiUniti. Come copione sembra un po' scontato, ma al CT lo si puòconcedere. In fin dei conti questa partita è sempre un bel passoavanti. Gli Usa si sono dimostrati una squadra solida, tra l’altronon erano nemmeno parenti di quelli che domenica avevano presocinque gol dalla Cecoslovacchia. (Fabrizio Bocca, Mi basta laqualificazione, «La Repubblica», 1990)
5) La non discriminazione infatti, mentre esige la ricerca dellesoluzioni legali più corrette, non può trasformarsi in una pura esemplice equiparazione dei ruoli e dei riti, cancellando così anchela radicalità della scelta omosessuale. Tutto questo infine nonsignifica prevaricazione della maggioranza sulle minoranze. (MiriamMafai, Dateci tempo, «La Repubblica», 1994)
6) Non basta questa vittoria per essere sicuri che con Amoroso lastagione del Parma avrebbe avuto un altro colore, perché in fin deiconti il gol è stato sempre l'ultimo dei problemi per la squadra diMalesani. (Emilio Marrese, Amoroso rilancia il Parma. Bari ko, Cassano non basta,«La Repubblica», 2000)
7) Viveva come se nascere, morire e rinascere fosse un'abitudinequotidiana, incideva dischi nei quali fissare il suo lampeggianteviaggio, ma non perdendo mai di vista, come racconta a ognioccasione, che in fin dei conti l'unica vera possibile celebrazionedel suo credo era la performance, il concerto dal vivo, dove lamusica poteva fino in fondo esplodere nella sua massimaimprevedibilità, a contatto con la gente, con la bruciante urgenzadel tempo presente. (Gino Castaldo, Parola dopo parola il "voodoo child" che sibruciò volando, «La Repubblica», 2014)
Dal PTLLIN:
14 Trattandosi di una polirematica, è chiaro che la sua grammaticalizzazione è unfatto successivo alla diffusione dell’avverbio: senza entrare nel merito, possodire che l’indagine diacronica che ho condotto mi ha portato a concludere che lapotenzialità inferenziale fosse già in nuce nell’avverbio, nella vesteuniverbata (che è coesistita a lungo con quella staccata, usata per lo più comecomplemento di tempo) e che per tale ragione esso può da solo condensare ilsignificato esteso della polirematica.
8) Può darsi anche tu sia stanco di stare con noi. Non è di sicuroil genere di vita che pensavi di fare. In fin dei conti non seiabituato a stare con gente come noi. (Giuseppe Berto, Il cielo è rosso,1947)
9) Lei, ormai, è così lontana, da non veder più la moretta che hapreso il suo posto, e verso Antonio le pare di essere tornata allacondizione famigliare, ovvia ma protetta, dei suoi anni di moglie.Perché, infine, nessuno ha detto che il suo matrimonio sia sciolto,che il nuovo sia celebrato. (Anna Banti, Artemisia, 1948)
10) Mosse le spalle come se qualche cosa la infastidisse, poi in untono tra dispettoso e lamentevole mormorava: "Infine, che male hofatto?" Capii che stavo facendole domande sciocche, e che già ellaaveva preso il sopravvento. (Massimo Bontempelli, L’amante fedele, 1953)
11) Proprio per salvare l'amicizia tu devi, in piccolissima parte eper brevissimo tempo, tradirla. Infine, chi è uomo lo sa. Siamoforti contro le tentazioni forti. Contro le deboli, deboli. Non valela pena, ci diciamo, fare gli eroi delle occasioncelle perdute.(Mario Soldati, Lettere da Capri, 1954)
12) Wally cresceva, non le mancava nulla, si faceva bellina e assaigentile, un po' scontrosa, ma le piaceva studiare e riusciva acapire con molta disinvoltura cose che a Zita parevano assaidifficili. Zita lottava per lei, in fin dei conti. (GuglielmoPetroni, La morte del fiume, 1974)
13) Come se l'infelice non avesse dovuto soffrire per quelle coseproprio perché erano vere; il che infine voleva dire che tutti ibrutti e i poveri debbono accontentarsi di essere tali. (PaoloVolponi, La strada per Roma, 1991)
14) Mentre aspettano, le mie mani invecchiano. O forse,asciugandosi, si semplificano. In fin dei conti non sono ancorabrutte mani, anche se ridotte all'essenziale. (Maurizio Maggiani, Ilviaggiatore notturno, 2005)
Una variante formale che può avere alcuni punti in comune con
infine, ma su cui mi soffermo solo per un breve riferimento è alla
fine, che presenta delle caratteristiche formali (il suo frequente
ricorrere in sintagmi che funzionano come complementi di tempo o
luogo, come “alla fine del giorno”, “alla fine della strada”,
ecc.) che la rendono più atta a funzionare per il suo valore
frasale, di portata locale, ma può assumere il valore inferenziale
sintetico (mai deduttivo, almeno stando allo spoglio fatto) su
descritto.
Esempi tratti dal PTLLIN:
15) E mi sento sul volto un'espressione intontita simile alla sua,più che altro una specie di stupore plastico: credevo che di questafusione non m'importasse niente e invece, mettendola così, scoproche alla fine me ne importa. (Sandro Veronesi, Caos Calmo, 2006)
Cambiando genere, vediamo un esempio di prosa giornalistica:
16) Il primato arriva dopo la sesta vittoria per 1-0 e questo numeroracconta che i successi della Juve nascono nella fatica e forseproducono più di quello che sono. Ma gli altri combinano ancorameno, e alla fine va bene così. (Maurizio Crosetti, Ma Ancelotti avverte:A Parma sarà dura, «La Repubblica», 2000)
In 15) e 16) è piuttosto evidente come un’inferenza determini
conclusioni che non possono essere direttamente dedotte dal
contenuto espresso, ma necessitino di informazioni che, seppur non
esplicitate, siano già assodate.
Per completezza, è il caso di fare almeno un cenno ad una forma
molto in voga nel parlato: è la forma in finale15, il cui significato
nel ruolo di connettivo è analogo a quello che assumono spesso in
fondo o in sostanza (sul cui significato e valore d’uso si argomenterà
15 Per D’Achille e Giovanardi (2001: 136-137) si tratta di un «sintagmaavverbiale in forte espansione, al quale si riconnettono almeno due accezioni:‘infine’ e ‘in fin dei conti’, ‘tutto sommato’». Per ampliare il paradigma diforme faccio inoltre solo un minimo accenno a finalmente, risultato dall’aggettivo‘finale’, cui si aggiunge il suffisso avverbiale; in comune con infine esso ha labase nominale di partenza, ma sviluppa una soggettivizzazione che, nell’italianocontemporaneo, lo mantiene legato allo statuto di avverbio. Mosegaard Hansen(2005b) ha analizzato in francese la forma finalement, in parallelo con enfin, perla quale, afferma, ci sarebbe «a “chronological” use, and a “conclusive” use.[…] finalement is said to mark the last of a succession of facts, where the term‘facts’ covers both real-world events, and discourse ‘events’ such as thesuccession of evaluative statements» (Ivi: 158).
oltre). Propongo un esempio tratto da un forum in rete, in cui la
scrittura è di tipo colloquiale:
17) Un ristorante senza infamia e senza lode; servizio puntuale, lasera in cui siamo stati ci hanno offerto anche un gradito mezzoprosecco, per la cucina si può trovare di meglio ma in finale non simangia male male. (http://www.tripadvisor.it)
È di fatto estremamente raro nello scritto attuale, ma si può
presumere una possibile espansione.
1.2. In apertura, due locuzioni sono state annoverate in entrambe le
sotto-categorie dei C.I., in quanto si prestano, per la loro
semantica intrinseca, ad assolvere diverse funzionalità testuali:
in ultima analisi16 è espressione, piuttosto comune, derivata dal
linguaggio scientifico, passata con ogni probabilità all’italiano
dal francese, con attestazioni a partire dalla fine del secolo
XVIII17. Il significato concettuale si compone di quelli
dell’aggettivo ‘ultima’ e del termine ‘analisi’, che insieme
presuppongono l’idea della ‘fine di un processo (analitico)’.
Nell’uso comune pare essersi appannata la semantica originaria,
tanto che la locuzione si impiega anche in condizioni informali;
la variante in ultima istanza18, più recente, deriva invece dal
16 Definita nel DISC come locuzione congiuntiva testuale: ‘in definitiva’, ‘inconclusione’, ‘alla fin fine’; conferisce valore riassuntivo e conclusivo(talora per prospettare una concessione finale) a una frase o sequenza didiscorso rispetto a quanto detto in precedenza.17 A chiarire l’origine tecnica della locuzione è Ugo Foscolo nella lettera AMichele Araldi, 3 Settembre 1812. (BIBLITA): «E, se non peccherà nello stile, nelledigressioni e nelle lungaggini, vizi tutti delle nostre storie moderne, il suolibro non si rimarrà nelle biblioteche per essere scartabellato dagli eruditi edalla gente del mestiere, ma riescirà utile a tutte le persone educate egentili, presso le quali, in ultima analisi, (ved'ella s'io divento scienziato?)sta l'arbitrio della fama de' letterati».18 Leggiamo ne Il Conciso Treccani:« l’espressione in ultima istanza è usata in sensofigurato, riferita a deliberazioni prese da un organo qualsiasi circa unaquestione che già precedentemente era stata discussa rimanendo però insoluta o
linguaggio giuridico ed entra in quello comune mantenendo una
certa formalità espressiva e conservando un’origine manifesta del
senso originario (l’idea della ‘conclusione di un giudizio’). Nel
corpus giornalistico esaminato, in ultima istanza si attesta in tutto
con 143 occorrenze, metà delle quali presentano il significato
pieno, relativo all’istanza giudiziaria. Ben 496 sono invece le
occorrenze totali della variante con ‘analisi’, usata con completa
libertà espressiva.
Per le due locuzioni, a livello testuale si può affermare che esse
manifestino i tratti della deduzione e della sintesi e siano
pertanto considerabili come C.I., che lavorano per una conclusività
intesa in senso logico: in ultima analisi e in ultima istanza presentano una
semantica istruzionale (che deriva dall’unione delle componenti,
secondo un passaggio che da un linguaggio tecnico le ha portate ad
una lessicalizzazione nel linguaggio comune, in una fase
antecedente al periodo considerato in questa sede) considerabile
univoca e non fraintendibile.
Confrontiamo i seguenti casi:
18) Il problema dell'autonomia buona è lo sviluppo di poteri 'locali'capaci di riformare la scuola dal basso, secondo linee generali diinnovazione culturale e professionale di profilo culturale alto. Ilproblema dell'autonomia della scuola è in ultima analisi un problemadella democrazia e dei suoi strumenti. (Scipione Semerario, Scuola sottoesame, «La Rivista del Manifesto», 2000)
19) La prima "lei" è Nelli Scilabra, la studentessa universitaria difiero cipiglio promossa assessore da Crocetta. Risoluta nel ricordare,nella missiva firmata ieri, la lesione alla «credibilità» e«all'onorabilità», oltre che il danno d'immagine, subiti per colpa diquel portale miseramente inceppato davanti al prevedibile assalto di unafolla di aspiranti tirocinanti. Una sventagliata di critiche diretta, inultima analisi, alla società che gestisce il sito ma che si abbatte
decisa in modo contrario».
inevitabilmente sulla destinataria della lettera, cioè la responsabileburocratica dell'intero procedimento. (Redazione, «La Repubblica», 2014)
In 18) si ha un’unità testuale il cui contenuto semantico è in
rapporto di conclusività rispetto al precedente in virtù di
un’inferenza suggerita dall’in ultima analisi evidenziato: il connettivo
informa della necessità di operare una sintesi del messaggio
esposto nella porzione di testo antecedente con conoscenze
pregresse, che spieghino la coerenza dell’enunciato connesso (cosa
sia la democrazia e quali siano i suoi strumenti sono dati
referenziali necessari a comprendere il problema dell’autonomia
scolastica).
L’esempio 19) mostra la locuzione nella funzione di connettere due
enunciati, il secondo dei quali conclude il primo in virtù di
un’inferenza di tipo deduttivo, fondata su premesse esplicite; per
comprendere al meglio è possibile suggerire una prova di
commutazione: se il primo esempio può essere modificato con un in fin
dei conti, inferenziale-sintetico per antonomasia, lo stesso non può
valere per il secondo, dove un dunque o un quindi, inferenziali-
deduttivi, sono le uniche scelte ipotizzabili. Questo in quanto in
19) il contenuto del segmento connesso è diretta conseguenza del
contenuto cui si lega e dal quale scaturisce, mentre in 18) il
contenuto connesso è una sintesi conclusiva del contenuto cui si
lega, a condizione che vi siano informazioni già date per
scontate.
L’idea di successione temporale di fondo, che risulta chiara nella
percezione del significato globale da parte di chi interpreta il
testo o lo produce, a mezzo di inferenze, si connette con lo
svolgersi di un ragionamento o di un processo che presuppone una
durata e una fine degli stessi, al di là del significato lessicale
della locuzione che, da un punto di vista descrittivo, non ha
riferimenti con l’aspetto logico della temporalità, mentre può
assumerne per senso figurato.
Nel PTLLIN, la locuzione in ultima analisi ricorre in una sola opera,
per due volte:
20) Ma sì, ma sì, è un bravissimo ragazzo, ma in ultima analisi sadi poco, è e rimane un po' limitato e sarebbe difficile farlodiventare qualcuno. (Alberto Arbasino, L’anonimo lombardo, 1960)
21) Le mie conclusioni mi vengono rivoltate contro nel senso,preteso da lui, che sarebbero tendenziose, al fine di "tirar acquaal mio mulino," e in ultima analisi di mascherare, sempre a questosi arriva, la mia avarizia. (Ivi)
In ultima istanza è presente in 2 opere:
22) Ma per la missione che, come sapeva, comportava la frode, iltradimento e, in ultima istanza, forse anche la morte di un uomo, sirendeva conto che tutto cambiava. (Alberto Moravia, Il conformista,1951)19
23) Ma la realizzazione di un'offerta adeguata di prodottisiderurgici o la valorizzazione di ingenti risorse da poco investitein un contesto sociale come quello di Napoli dipende in ultimaistanza dalla capacità del potere politico di esprimere direttivefunzionali all'interesse di lungo periodo del paese. (Ermanno Rea,La dismissione, 2002)
Il funzionamento come connettivi conclusivo-deduttivi non è per la
verità troppo frequente: il significato istruzionale delle
locuzioni ha una potenzialità più vasta, che li connota
maggiormente per il tratto della sintesi. Il fatto che
stilisticamente in ultima analisi e ancor più in ultima istanza siano
19 Questo caso e il precedente 21), per la verità, parrebbero esempi disvuotamento dei connettivi per il proprio valore istruzionale: essi sembranoscandire una serie, alla stregua di un infine avverbio, il che presuppone unappiattimento del loro potenziale testual-pragmatico.
connotati da una certa “tecnicità” fa sì che la narrativa li
sfrutti meno, sentendoli probabilmente come tipici di un
linguaggio che usi toni neutrali e più formali.
Consideriamo il seguente stralcio giornalistico:
24) E per la prima volta, da quel gennaio del 1987 in cui MikhailGorbaciov riuscì a strappare a un plenum riluttante, che aveva giàdissotterrato l'ascia di guerra, la difficile decisione di condurrequesto forum, viene avanzata l'ipotesi di far slittare a settembrela conferenza del partito per permettere un'elezione dei delegatidavvero democratica, che rompa gli schemi politici fin qui adottatie, in ultima istanza, salvi una perestrojka ormai in serio pericolo.(Fiammetta Cucurnia, Anche la voce di Sacharov alla conferenza del PCUS, «LaRepubblica», 1988)
La locuzione, posizionata in inciso, da un lato svolge una
funzione di scansione degli atti di enunciazione («un'elezione dei
delegati davvero democratica, che rompa gli schemi politici fin
qui adottati e, in ultima istanza, salvi una perestrojka…»),
dall’altro, in virtù del suo significato istruzionale, stabilisce
la relazione conclusivo-inferenziale tra l’ultimo enunciato e il
senso veicolato della porzione di testo interamente considerata:
la presenza del connettivo rimanda all’esercizio di un’inferenza,
che giustifichi il fatto che si debbano rompere “gli schemi
politici adottati” e che “la perestrojka sia in serio pericolo”,
condizioni che s’intendono come assodate e già conosciute.
L’esempio che segue presenta delle differenze:
25) Ma se iniziamo a ragionare così, se una scelta per essere liberadeve essere compiuta in completa indipendenza da influenze esterne epressioni sociali, dovremmo ammettere allora che ciascuno di noi èinconsapevole e, in ultima istanza, incapace di scegliereliberamente (Francesca Gallerani, Cara Lorella Zanardo, il corpo (è) delle donne,«L'Huffington Post», 2014)
Il significato istruzionale impresso dalla locuzione nella
connessione tra contenuti esposti chiede un’inferenza nel
collegare l’essere ‘incapace di scegliere liberamente’ all’essere
‘inconsapevole’, in virtù di quanto appena esplicitato:
l’inferenza cioè si basa su quanto detto ed è fondata su un
meccanismo deduttivo. La differenza nell’impiego, fermo restando
il potenziale semantico-istruzionale del connettivo, dipende
essenzialmente dal co-testo; pertanto la decodifica non può
avvenire senza considerare tutto gli elementi in campo20.
Il grado di formalità evidente nella locuzione limita il suo
impiego nei testi di genere narrativo, fra i quali si rintraccia
molto raramente.
Vediamo quindi degli esempi con la variante:
26) Anche se i ricercatori ritengono siano necessari studi difollow-up per convalidare e perfezionare questo sistema diclassificazione del cancro, in ultima analisi esso può fornire labase biologica per una nuova era di trattamento personalizzato delcancro che sia i pazienti che i medici attendono con impazienza.(Luigi Mondo / Stefania Del Principe, Un grande studio genomico rivoluziona iltrattamento del cancro, «La Stampa», 2014)
1.3. Andiamo quindi a considerare un’altra forma classificabile, in
questa sede, come C.I.: in definitiva, un’espressione impiegata di
frequente nel linguaggio giuridico (da cui è passata nell’impiego
comune, in una fase anteriore a quella qui considerata), per il
quale significa “sentenza definitiva”, o “giudizio”. Cercando dati
recenti in Google mi sono imbattuta in un titolo di articolo di
cronaca che dà conto della locuzione intesa a mo’ di tecnicismo:
il titolo è “Pedofilo 85enne in carcere, condannato in definitiva a 6
anni” (http://www.abruzzo24ore.tv/news) e mostra l’uso specifico20 Un fatto che vale chiaramente per tutti i connettivi esaminati e non solo.
della locuzione, atta ad indicare appunto la “sentenza
definitiva”, con l’omissione del nome, per una formularizzazione
intervenuta nell’uso, si presume, abituale dell’espressione nel
linguaggio giruidico. Vediamo quindi il suo impiego come
connettivo:
27) Una punizione gioiello di Pirlo con il contributo sostanziale diFrey fa sognare a lungo la Reggina. Poi una spinta improvvida diBrevi su Franceschetti e il rigore che riapre la partita: tocca albrasiliano Adailton (5 gol nelle ultime 5 partite) evitare al Veronauna sconfitta con appendice di crisi. E il pareggio, in definitiva,ci può anche stare. (Adalberto Scemma, La Reggina viene ripresa da Adailton,«La Repubblica», 2000)
La comprensione del meccanismo inferenziale si attua per una
conoscenza pregressa di informazioni non espresse nel testo (che
giustificano l’esistenza di tale meccanismo), come nel caso visto
poco fa, a differenza del quale qui non c’è nemmeno un co-testo
precedente che in qualche modo dia minimo conto di tali
conoscenze.
Si evince una stretta vicinanza con infine, che dipende in effetti
da una comune base lessicale: “definitivo”, viene da “definire”,
cioè de + finire, “circoscrivere” (dal latino, per il significato di
finis “confine”), quindi in estensione, “delimitare”, “terminare”.
Rispetto alla temporalità insita nel vocabolo infine, la locuzione,
pur mantenendone traccia, si orienta verso l’“aspetto” di questa
temporalità, che trasmette una semantica più connotata, con
un’idea di determinatezza che travalica il dato strettamente
legato al tempo e passa su un piano più valutativo. La forma è
meno usata nello scritto narrativo e nel PTLLIN le occorrenze sono
scarse lungo tutto l’asse cronologico e senza significative
differenze numeriche; ne vediamo alcune:
28) […] perché i vecchi amici e tutti i conoscenti s'eran dimostratiimbarazzati perfino a salutarlo. I picchiatori, dopo quella lezionel'avevan lasciato in pace sapendo che, in definitiva, era unapersona mite che non avrebbe più osato esporsi. (Guglielmo Petroni,La morte del fiume, 1974)
29) Gianna piega il viso e dischiude le labbra. "Ti attacco lafebbre," mormora, baciandolo lentamente, deridendolo un po', poichévede che, in definitiva, non riesce a sottrarsi alle sue labbra.(Giorgio Montefoschi, La casa del padre, 1994)
1.4. Faccio riferimento alla forma in fondo, in quanto si tratta di un
caso particolare, considerabile per lo più una locuzione
avverbiale di frase, ma contraddistinto da un potenziale sintetico
che lo accomuna agli altri C.I., pur avendo una specificità
lessicale molto distinta; durante il lavoro per la tesi: Mingioni
(2014), si è notato come esso tenda da un lato a funzionare nella
dispositio della materia testuale, dall’altro, slegandosi dai
contenuti espressi, a indicare un’inferenza. Se si considera il
significato concettuale, in fondo è da leggersi come ‘nella
sostanza’, ‘nell’essenza’ e si qualifica perciò come non testuale.
Intuitivamente, però, leggendo alcuni esempi, si è portati a
prendere quell’in fondo come un in fin dei conti, cioè come mezzo per
esprimere inferenza: c’è in tal senso un limite sottile tra la
spinta esercitata da un significato pieno, lessicale, e un
significato testuale, funzionale al ragionamento sintetico.
Per agevolare l’interpretazione, può essere utile il riferimento
ai dizionari: leggiamo nel DISC, alla voce “fondo” (sostantivo
maschile), la formulazione in fondo, senza alcuna etichettatura e
con la resa ‘tutto sommato’, ‘in definitiva’. Più dettagliato Il
Conciso Treccani: «locuzione avverbiale in fondo, alla fine, in
conclusione, tutto sommato: in fondo, sei tu che ci rimetti; ripetuto: in
fondo in fondo, avevi ragione tu».
Da alcuni casi sembra possibile intravedere un’estensione verso un
uso testuale, in cui effettivamente emerge un valore sintetico:
30) [Le donne] oggi votano e hanno i diritti civili, ma icondizionamenti sono ancora infiniti; in fondo, altrove, si sonoorganizzate meglio, ad esempio nel mondo musulmano, dove con leconcubine più giovani è possibile dividere il lavoro casalingo.(Simonetta Fiori, Elogio dell'harem, «La Repubblica», 2000)
31) Senza centravanti e senza aver ribaltato la maggioranza in LegaA, tanto vale per il Cesena far pace con il futuro re primadell’incoronazione. In fondo, un attaccante può girarglielo propriola Lazio di Lotito (Pavoletti, prendendolo dal Sassuolo), primogrande elettore del ragioniere di Ponte Lambro. (Francesco S.Intorcia e Matteo Pinci, Retromarcia del Cesena la colpa è di Borriello, «LaRepubblica», 2014)
32) Ed ecco che dalle salumerie alle librerie, passando perristoranti e botteghe storiche le aperture diventano all'improvvisono stop (ferragosto escluso). Cercando di approfittare del boom dituristi che neanche il maltempo di luglio, almeno finora, è riuscitoa frenare. In fondo, le oltre 208mila persone oggi presenti in cittàqualcosa, in questo periodo, dovranno pur fare. (Enrico Miele, Eventi enegozi aperti fino a ferragosto per i duecentomila che restano a casa, «LaRepubblica», 2014)
In fondo qui par rendere l’istruzione di chi articola il testo, che
esprime la sintesi di un processo ragionativo, tanto che una
commutazione con infine/in fin dei conti funzionerebbe senza problemi.
Consideriamo esempi tratti dal PTLLIN: nell’opera di Ennio Flaiano
(Tempo di uccidere, 1947), si rintracciano 16 occorrenze della forma,
di cui 4 considerabili come casi di C.I; ne riporto 2:
33) Sparai. Ora non dovevo perdere la calma: in fondo, non l'avevouccisa, le avevo impedito di soffrire più a lungo.
34) Non mi ero fatto illusioni sulla loquacità di Johannes, ma avevosperato da lui almeno un segno di riconoscenza. In fondo, non eroaffatto obbligato a sovvenirlo e i motivi che mi spingevano in quelluogo non lo riguardavano affatto.
La commutazione con un in fin dei conti pare assolutamente plausibile.Le restanti occorrenze invece presentano un in fondo usato nel suosignificato proprio, come complemento di luogo, da solo o insintagmi, o come avverbio di frase, legato cioè al contenuto deltesto e non quindi atto ad esprimere un valore istruzionale.
Gli esempi più recenti presentano ancora questa ambivalenzafunzionale, per cui l’ultimo cinquantennio non ha portato aun’effettiva definizione dell’impiego testuale, che peròverosimilmente conoscerà ulteriori sviluppi; un esempio nellanarrativa più recente:
35) Ma, per come vedono le cose qui dentro, che le faccia non haimportanza finché non le fa alla perfezione. Anche Gemma, in fondo,sbaglia molto più di quanto riesca a essere perfetta. (SandroVeronesi, Caos calmo, 2006)
1.5. Le forme dunque e quindi sono propriamente delle congiunzioni,
genericamente considerate equivalenti nel significato e nell’uso21;
a livello testuale il valore congiunzionale collega a un
significato temporale di base l’aspetto dichiaratamente deduttivo:
nel testo “ho fame. Quindi/dunque mangio”, l’azione connessa dal
quindi/dunque è conseguenza della prima e la conclude in senso
logico, proprio in quanto da essa determinata; l’aspetto temporale
riguarda il momento di realizzazione dell’azione connessa, qui
coincidente alla precedente. Il discorso resta valido anche in un
caso come “ho fame, quindi/dunque mangerò”, dove il tempo della21 Le due congiunzioni derivano dal latino e sono attestate nell’italiano scrittodalle origini della nostra letteratura. Quindi proviene dalla locuzione parlata*(ĔC)CU(M) ĬNDE, propriamente ‘ecco di là’; dunque proviene dal latino tardo DŬNC,probabile incrocio di DUM ‘ancora’ con TUNC ‘allora’. Il quindi ha poi assunto unvalore temporale (“da allora”), più in linea con dunque.
seconda azione non è coincidente, ma spostato in avanti. I due
termini come connettivi di valore conclusivo-deduttivo danno conto
di una relazione di conclusività esistente tra il contenuto in cui
compare uno dei due connettivi e il cotesto precedente, che poggia
sul movimento inferenziale basato su premesse esplicite; quindi (e
non dunque) per il suo significato temporale derivato da quello
etimologico locativo, è in grado di mettere in relazione un
contenuto che non deriva come conseguenza dal precedente, sia in
contesto di frase che tra le frasi: se diciamo ‘passo in banca,
quindi alla posta’ oppure ‘ho fatto la spesa. Quindi ho messo a
posto la casa’ stiamo dicendo ‘prima vado in banca, poi alla
posta’; ‘prima ho fatto la spesa, dopo ho sistemato casa’, non di
certo ‘ho fatto la spesa, di conseguenza ho sistemato casa’. Come
C.T. può mostrare il valore appena descritto (che poggia su un
significato avverbiale legato al concetto di tempo, in questo caso
un tempo che presuppone uno spostamento da un dato momento a un
altro) e funzionare come elemento di dispositio. Va anche segnalato
che dunque (e non quindi) si può sostantivare; il fatto non
interessa la testualità, ma fa riflettere sul significato
conclusivo prototipico che viene in questo caso attribuito al
termine.
Nella fase odierna, per quel che concerne l’impiego delle due
forme come C.I., trovo si attesti un’equivalenza che si deve
probabilmente alla frequenza d’uso, la quale ha livellato le
differenze esistenti tra i due e conservato viva solo quella
particolare proprietà del quindi di mantenersi attivo come
connettivo conclusivo-temporale. Cito alcune delle osservazioni
proposte da Ferrari e Rossari (1994) nell’ambito di un’analisi
contrastiva tra i francese e l’italiano: «Dunque et quindi partagent
les propriétés basiques de donc, c'est-à-dire fonctionner comme des
connecteurs, signaler une implicitation, présenter cette
implicitation comme issue d'un raisonnement infèrentiel» (Ivi: 41).
[…] «Quindi est spécialisé pour des emplois où l'implication est
présentée comme nouvelle et, par voie de conséquence, le lien
"logique" est fortement valorisé. Dunque, en revanche, est plus
approprié pour des emplois où l'implicitation est présentée comme
saillante, ce qui met au second plan la connexion “logique”. C'est
comme si l'existence en italien de deux formes lexicales
différentes pour exprimer le même type de lien avait engendré, par
un principe de complémentarité, la lexicalisation d'effets
pragmatiques exclusifs susceptibles d'être déclenchés à partir de
la valeur de base préconisée.» (Ivi: 46-47).
Il discorso sulla “salienza” contraddistinta dalla “novità” del
contenuto connesso è alquanto sottile e difficilmente
riscontrabile nell’italiano attuale, dove in effetti le due forme
appaiono pienamente intercambiabili22; a tal proposito se
consideriamo il PTTLIN, abbiamo in tutto 2059 occorrenze per il
dunque e 2047 per il quindi. Se prendiamo a campione due opere
distanti cronologicamente e ne controlliamo i casi, vengono fuori
dei dati particolari: in Flaiano (Tempo di uccidere, 1947) su un
totale di 28 quindi, 9 non sono inferenziali, ma strumenti di
indicazione temporale. In Riccarelli (Il dolore perfetto, 2005) su 33
quindi, quelli non inferenziali sono ben 25. Questo ci dice che
anche attualmente la forma è molto usata per il suo senso
22 In effetti però, nell’ambito dell’indagine diacronica svolta per la tesi, sonoemersi significativi riscontri che confermano le teorie di Ferrari e Rossari(1994), per lo meno per quel che riguarda una fase della lingua meno recente.
cronologico prototipico e che numericamente ricorre meno nel ruolo
di inferenziale (il valore esclusivo del dunque). Propongo solo
alcuni esempi per entrambe le forme:
36) Scacciato da ogni altro oggetto, m'indussi a innamorarmi di me.Emulo, se i nomi son numi, di quell'altro Narciso ch'era peritomirandosi a una fontana. Non fu raro, quindi, che mia sorella misorprendesse nudo in piedi dinanzi a uno specchio e mi colpisse pergioco astioso coi pugni. (Gesualdo Bufalino, Le menzogne della notte,1988)
37) Io credo a Jean-Claude: credo alla storia che mi ha raccontatoproprio qui, seduto su questa panchina, soffrendo intensamente sottoi miei occhi; quindi credo che Thierry sia un traditore, perciò nongli rispondo. (Sandro Veronesi, Il caos calmo, 2006)
38) Credo si guardasse in ogni sconosciuto s'era o non era uno chepoteva fermarsi nel villaggio. Dipendeva dunque dal suo aspetto diessere trattato con cordialità o con distacco. (Elio Vittorini,Donne di Messina, 1949)
39) Lo sapevamo perché l'avevamo visto succedere, e spesso neavevamo anche approfittato. Dunque noi fingevamo di essere incontrasto - un contrasto, comunque, che doveva sempre darel'impressione di essere sanabile - e nel frattempo continuavamo avederci di nascosto, a Milano, a Londra. (Sandro Veronesi, Caos calmo,2006)
Nel corpus giornalistico i casi di quindi temporale sono decisamente
ridotti, in quanto il tipo di testo fa a meno di un incedere
narrativo e se scandisce temporalmente le sequenze, ricorrendo più
spesso ad altre forme (infine, ecc.)23. Fornisco un paio di esempi
recenti:
40) Ma le elezioni amministrative si possono svolgere solo fra il 15 aprilee il 15 giugno; quindi il 16 aprile è una scelta obbligata. (SilvioBuzzanca, Regionali, al voto il 16 aprile Il Polo: rischio astensionismo, «La Repubblica»,2000)
23 Si tratta ovviamente di una tendenza, non di un dato esclusivo: le occorrenzenel solo anno 1985 sono più di 6000m e pertanto l’osservazione è stata condottasenza entrare nel merito di ciascuna; il dunque ricorre quasi 5000 volte e seconsideriamo un buon numero di quindi temporale, direi che numericamente i dueconnettivi inferenziali sono ben bilanciati.
41) I cinque erano ricoverati per altre malattie, per loro sono statefatali le complicazioni create dal virus. La Lombardia, dunque, lancial'allarme. (Stefano Rossi, Influenza, prime vittime cinque anziani a Milano, «LaRepubblica», 2000)
Dunque sembrerebbe essere specializzato nel conferire un’istruzione
circa il carattere essenziale di quanto espresso nell’enunciato
conclusivo, mentre quindi nel qualificare l’aspetto logico
consecutivo; questa differenziazione poggia sulla considerazione
del diverso significato etimologico delle due forme, pertanto è
assolutamente fondata. Tuttavia si tratta di una sfumatura che
nell’impiego comune è veramente molto difficile da percepire.
Conclusioni.
Il contributo ha messo in evidenza le proprietà di alcuni
connettivi testuali, accomunati tra loro da un punto di vista
funzionale: forme diverse per statuto morfo-sintattico e
significato descrittivo hanno nel testo un valore istruzionale che
permette di metterle in correlazione tra loro; nella macro-
categoria dei connettivi conclusivi cui è stata dedicata la tesi
di dottorato (Mingioni 2014) sono stati individuati connettivi che
indicano la relazione di conclusività tra sequenze connesse,
stabilita per mezzo di inferenza e non per successione temporale
in senso stretto. L’assunto di partenza del lavoro è quello
secondo cui i significati lessicali influiscono su quelli
testuali, come traccia di istruzioni pre-inscritte.
Entrambi i processi inferenziali della deduzione e della sintesi
sono possibili perché permessi dal significato alla base del
connettivo: quello della deduzione, in particolare, poggia su un
concetto di “conseguenza”, che è proprio di forme la cui semantica
riguarda l’idea di uno spostamento inteso in senso figurato ‘da un
punto a un altro’, idea solo talvolta derivata da una prima
accezione legata alla temporalità (quindi e dunque, o il diverso
caso, solo accennato, di conseguenza). La sintesi è l’aspetto di tipo
inferenziale più interessante da un punto di vista della
pragmatica: è emerso che questo può essere rintracciato nei
connettivi il cui primo significato concettuale è quello temporale
(con un’eccezione rappresentata da in fondo, che si è visto essere
potenzialmente un connettivo sintetico, malgrado si attesti più
spesso come avverbio di frase; in questo caso si deve ammettere un
senso figurato): forme che manifestano oggi una conclusività
“sintetica”, come infine, alla fine (seppur con meno attestazioni), in
ultima analisi/istanza, in definitiva, hanno tutte, per valore etimologico,
aspettuale o figurato, un’idea di tempo alla base, che si
trasferisce dalla dimensione verbale a quella referenziale che
partecipa alla costruzione del significato del testo: in tal senso
parrebbe che si attui una dispositio non più della materia testuale,
ma dei processi ragionativi che coinvolgono il non detto.
Per quel che concerne il campo d’osservazione, a livello
diacronico non si hanno dati significativi e quanto alle
differenze legate al genere si può dire che l’impiego dei C.I. non
si differenzi nettamente in base al tipo di testo: il testo
narrativo fa uso di connettivi di scansione temporale (quindi
anche dei conclusivi) indubbiamente molto più del testo
giornalistico, che non condivide in toto le caratteristiche del
racconto; entrambi i generi, però, fanno uso di connettivi
inferenziali con due differenze: in primis, lo stile distingue un
impiego più e meno formale, ragion per cui in ultima analisi/istanza e in
definitiva, sono più appannaggio del testo giornalistico (a
prescindere da ulteriori specificazioni); secondariamente, il
testo giornalistico veicola un contenuto di interesse collettivo
divulgato perché sia conosciuto (maggior meccanismo deduttivo), o
perché, una volta conosciuto, sia approfondito (maggiore sintesi).
Il testo narrativo, creando un mondo parallelo, vi trasferisce in
sostanza gli stessi meccanismi, legati però al micro-cosmo della
vicenda. In più, in virtù dello stile e dell’incedere discorsivo
del racconto che prevede la dispositio dei contenuti in relazione
allo svolgimento della storia, un testo di narrativa prevede
maggiore variatio e minore formularità, cosa che motiva la scelta di
soluzioni scrittorie diverse e molteplici. Ancora, e senza entrare
troppo in questioni che riguardano le caratteristiche dei generi,
la maggior parte degli esempi visti presenta una narrazione in
prima persona, che presuppone quindi l’esposizione di pensieri e
ragionamenti, un punto in comune con l’esposizione del testo
giornalistico, che s’intende collegato a un soggetto collettivo.
Riferimenti bibliografici
Dizionari:
DELI1999 Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, a cura di Manlio Cortelazzo
e Paolo Zolli, Bologna, Zanichelli.
DISC2003 Il Sabatini-Coletti: dizionario della lingua italiana, a cura di Francesco
Sabatini e Vittorio Coletti, Milano, Rizzoli-Larousse.
ENCIT2010-11 Enciclopedia dell’Italiano Treccani, dir. Da Raffaele Simone, Roma,
Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
Treccani1998 Vocabolario Treccani: il Conciso, dir. da Raffaele Simone, Roma,
Istituto della Enciclopedia italiana, 1998.
Studi:
Buchi, Eva - Städtler, Thomas2008 La pragmaticalisation de l’adverbe enfin du point de vue des romanistes («Enfin,
de celui des francisants qui conçoivent leur recherche dans le cadre de la linguistiqueromane»), CMLF (Paris, 9-12 juillet 2008). Recueil des résumés,CD-ROM des actes, pp. 159-171.
D’Achille, Paolo – Giovanardi, Claudio2001 Dal Belli ar Cipolla. Conservazione e innovazione nel romanesco contemporaneo,
Roma, Carocci.
Diodato, Filomena2007 Il problema del significato. Tra linguistica e filosofia del linguaggio, Napoli,Liguori.
Ferrari, Angela1994 De donc à dunque et quindi: les connexions par raisonnement inférentiel,
«Cahiers de Linguistique Française» 15, pp. 7-49.
1995 Connessioni. Uno studio integrato della subordinazione avverbiale, Genève,Editions Slatkine.
Jaszczolt, Kasia – Allan, Keith
2012 The Cambridge Handbook of Pragmatics, Cambridge, Cambridge
University Press.
Luscher, Jean Marc – Moeschler, Jaques1990 Approches dérivationnelles et procédurales des opérateurs et connecteurs
temporels: les exemples de et et de enfin. «Cahiers de linguistiquefrançaise» 11, pp. 77-104.
Mauri, Caterina - van der Awera, Johan2012 Connectives, in Jaszczolt/Allan 2012, pp. 347-402.
Mingioni, Ilaria
2014 Aspetti formali e semantico-pragmatici dei connettivi di chiusura del discorso inprospettiva storica e sincronica, tesi di dottorato in co-tutela.Dottorato in ‘Italianistica’, Università degli studi Roma Tre,XXVI ciclo, e Dottorato in ‘Linguistica italiana’, UniversitätBasel. Rell. Paolo D’Achille e Angela Ferrari.
Mosegaard Hansen, Maj-Britt2005a A comparative study of the semantics and pragmatics of enfin and finalement, in
synchrony and diachrony, «French Language Studies» 15, pp. 153-171.2005b From prepositional phrase to hesitation marker he semantic and pragmatic
evolution of French enfin, «Journal of Historical Pragmatics», 6 (1),pp. 37-68.
Rossari, Corinne – Ferrari, Angela1994 De donc à dunque et quindi: les connexions par raisonnement inférentiel,
«Cahiers de Linguistique Française» 15, 7-49.
Sabatini, Francesco1990 Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei
testi, in Corso di studi superiori legislativi 1988-1989, a cura di M.D’Antonio, Padova, CEDAM, pp. 675-724.
Sitografia e corpora:
http://www.bibliotecaitaliana.it/
http://books.google.it
http://dev.sslmit.unibo.it/corpora/corpus=Repubblica
http://www.treccani.it/vocabolario/
PTLLIN
2007 Primo Tesoro della Lingua Letteraria Italiana del Novecento, a cura diTullio De Mauro, Torino, UTET-Fondazione Bellonci, (dvd).