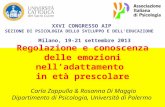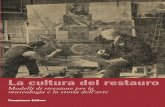Regolazione e conoscenza delle emozioni nell’adattamento in età prescolare
Lo spazio del testo. Paesaggio e conoscenza nella modernità letteraria, Bologna, Edizioni...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Lo spazio del testo. Paesaggio e conoscenza nella modernità letteraria, Bologna, Edizioni...
Vincenzo BagnoliLo spazio del testoPaesaggio e conoscenza nella modernità letteraria
in copertina: particolare daHieronymus Bosch, San Giovanni di Patmos (1504-1505).
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
© 2003, Edizioni PendragonVia Albiroli, 10 – 40126 Bolognawww.pendragon.itÈ vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.
progetto grafico: Giorgio Morara (Meta srl)
Lavoro pubblicato con il contributodell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.
INDICE
Premessa, Una retorica dello sguardo p. 7
CAPITOLO PRIMO
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio 131. Lo sguardo e lo spazio allargato 132. Il senso dello sguardo, il senso del paesaggio in letteratura 193. Gli orizzonti del luogo comune 254. Lo sguardo e lo stile: dall’“io” al “qui” 355. Il paesaggio e la sua mappa: il sorriso della musa 43
CAPITOLO SECONDO
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino 611. Rappresentare e riprodurre: la forma del mondo 612. La visione dall’alto: spazio, geografia e coordinate 733. Il personaggio e lo sfondo: i “lochi già descritti” 924. La “doppia maraviglia” del conoscere 102
CAPITOLO TERZO
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla Ginestra 1151. Lo sguardo e l’idillio (retorica) 1152. L’immaginazione dello sguardo (estetica) 1253. La strategia dello sguardo (poetica) 144
CAPITOLO QUARTO
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90 1611. Forme (città) 1612. Scritture (architetture) 1703. Poetiche (processo) 179
Indice dei nomi 191
5
PREMESSA
Una retorica dello sguardo
Come avvertono i geografi, dietro il termine paesaggio si na-sconde qualche insidia; i dizionari lo definiscono l’aspetto di unluogo quale appare quando lo si abbraccia con lo sguardo,quindi ciò che un osservatore può vedere dei territori circo-stanti in una veduta d’insieme, ma anche l’ambiente proprio diuna località. La stessa parola designa insomma l’oggetto e la suaimmagine. Per plagiare allora i titoli altrui, chiedersi quale sia il“segno del paesaggio” in letteratura non è cosa di poco mo-mento, ed occorre dare almeno avviso di alcuni altri equivoci incui si può incorrere.
In buona parte dei commenti la presenza dell’elemento pae-saggistico è apprezzata – in maniera riduttiva – alla stregua diun dato contenutistico o del tratto di un genere; stanti però i li-miti dei generi definibili su questa base (poesia descrittiva, nar-rativa odopoietica ecc.), altri più sottili interpreti richiamanoall’esigenza di superare il pregiudizio della referenzialità e re-stituire al paesaggio letterario, quale tecnica di visualizzazionemediante lo strumento della parola, la propria specifica “di-mensione semiotica”1, consistente nella definizione delle coor-dinate spaziali di un testo letterario, complementare quindi,come del resto già avvertiva la stessa intuizione bachtiniana, ri-spetto alla parallela e ben più studiata tramatura temporale.
Questo richiamo, al tempo stesso, mette in guardia dal li-mitarsi a considerare tale fatto strutturale mero dettaglio della“decorazione”, come se le forme rappresentate nel “campo lun-go” dello sguardo non fossero che un elemento pittorico colo-
1 A. Guyot, Le paysage au miroir des genres. Pour une confrontation poétiqueet stylistique des descriptions de nature, in «Compar(a)ison», 1998, 1, pp. 57-78.
7
ristico (il “colore eloquente” essendo altro2). Nel descrivere, in-fatti, il linguaggio non si comporta semplicemente ut pictura,acquisendo di questa l’intensità cromatica, ma mantiene unaspecifica tensione conoscitiva: nell’organizzare lo spazio secon-do le proprie peculiari cadenze prospettiche, sviluppa una di-stinta ottica o piuttosto, più precisamente, una retorica dellosguardo (non è forse un caso che con l’inizio della modernità,quando l’orizzonte del mondo si fa più vasto e articolato, ap-paiano trattati sull’arte del viaggiare, libri che insegnano un me-todo dello sguardo per correggere gli errori compiuti nel pas-sato). Nel romanzo il paesaggio si dimostra certo più aperta-mente lontano da una dimensione piattamente esornativa, tut-tavia paga lo scotto di essere ricondotto al realismo d’ambien-te; viceversa in poesia è forse più facile intuire un diverso ruo-lo del panorama, risultando scandaloso un siffatto “guardarsiattorno” quando i cliché imporrebbero il ripiegamento su di sédel soggetto lirico.
Un indizio di come la presenza del paesaggio possa rivelarsielemento strutturale può venire dalla subiectio sub oculis impli-cata dalla figura della phantasia in quanto mezzo di rappresenta-zione, nella retorica classica, fondato sul richiamare (simulando)le sensazioni fisiche: il termine stesso deriva del resto da phantá-zo, “faccio vedere”, “mostro”, quindi è chiaramente imparenta-to per radice con quel phaíno il cui valore passivo resta nel sen-so del participio phainómenos, “visibile ai sensi”. La figura ope-ra insomma con ciò che appare ai sensi (ciò che è soggetto all’e-sperienza estetica, si può dire anche): c’è più di una sfumatura didifferenza rispetto al “realismo”. Se dunque qualche vaga intui-zione si trova nelle estetiche sensistiche, il carattere del “paesag-gio in parole” come “strumento per vedere” fra trasparenza eostacolo, più che visione, è meglio delineato in una prospettivafenomenologica. Ma già lo stesso Aristotele, per parte propria,sgombrando il campo da possibili equivoci rimarcava la peculia-
2 Come avvertono E. Raimondi, Il colore eloquente. Letteratura e arte barocca,Il Mulino, Bologna 1995 e L. Ritter Santini, Le immagini incrociate, Il Muli-no, Bologna 1986 e Ritratti con le parole, Il Mulino, Bologna 1994.
Vincenzo Bagnoli
8
rità dell’occhio mentale della “fantasia” rispetto alla nuda ópsis,peculiarità consistente soprattutto nell’intensità critica (Poet.,14,1-2, 1453b): nella sua forza icastica esso infatti aggiunge al-l’enárgeia qualcosa che va oltre la pura visività. Non s’intendesemplicemente il mero “distacco” della posizione di sicurezza(quella, per intenderci, esemplificata nei notissimi esametri lucre-ziani sul naufragio visto da riva, approfonditamente discussi daBlumenberg), quanto piuttosto un carattere di “azione sospesa”che farebbe pensare a quella “contemplatività nell’azione” de-scritta da Kuki Shuzo come uno degli attributi dell’iki, ossia unosguardo più ampio e generale della sola posizione soggettiva.
L’ottica del paesaggio è dunque quella dell’“osservare” e nondell’“osservatore privilegiato”, quello sguardo profondo dell’ar-te proprio delle poetiche tra romanticismo e decadentismo cuiper esempio s’affidava ancora Pascoli, con la nota metafora deiraggi x. Per tornare alla bibliografia critica, si deve allora richia-mare la struttura d’orizzonte della scrittura, le cui caratteristicheper Collot consistono nella negazione della soggettività e nell’ar-ticolazione di uno sguardo e uno spazio interni alla parola. Laprospettiva fenomenologica s’integra a un agire comunicativoche respinge ogni istanza di autoaffermazione (analogamente al-l’etica della comunicazione di Karl Otto Apel, nemica dei soli-psismi), così che la profondità spaziale del testo letterario pareallora avvicinabile alla Lichtung (il luogo aperto) di Heidegger, ladimensione di un sentire non soggettivo dell’“essere qui” che sidelinea non nel senso dell’unità di un “noi”, ma della moltepli-cità dell’“altro”, attraverso la dinamica di vicinanza e lontanan-za (quello che era anche un convincimento leopardiano), del-l’apparire e del restare in ombra.
Secondo una diffusa idée reçu sarebbe la phoné in quanto pa-rola non spazializzata né formale, espressione della temporalitàdell’essere, a garantire con la propria mobilità l’inesauribilità deltesto; ma una siffatta ermeneutica sembra risentire di un equivo-co di fondo, ossia credere che la suggestione partecipativa del-l’aura sia immediatamente comunicativa (quando invece gli stes-si suono e voce nel testo sono inevitabilmente non soltanto pro-nuncia ma ascolto, memoria). L’inesauribilità dovrebbe piuttosto
Premessa
9
essere cercata a partire dalla natura multiprospettica del dato te-stuale, la mobilità essendo infatti propriamente legata alla perce-zione spaziale, alla lettura, come sottolinea Blanchot3: la paroladel testo letterario, questa è esperienza abbastanza comune, èsempre formalizzata, eppure – per rubare la battuta antitolemai-ca di Galilei – si muove. Quando poi Mallarmé definiva le imma-gini come il “sangue” della poesia, alludeva certo a una qualità vi-siva di questa, ma non solo: la percezione spaziale è infatti com-pletata dalla sensazione atmosferica dell’esserci, il clima, e al tem-po stesso dalla scansione dello spazio, la misura. La geografia, lamappa topografica e la coordinata si rivelano dunque riferimentiessenziali per capire l’immagine letteraria del paesaggio, che vie-ne a essere soprattutto la rappresentazione e la costruzione di unaforma: una produzione dell’attività umana, non la traccia dell’e-lemento naturale; non la presenza di un senso, ma la sua ricerca,l’azione dello sguardo.
Nel testo letterario il paesaggio può insomma configurarsicome imago mundi, forma del mondo e forma del testo: le sue li-nee servono allora a disegnare non i contorni dei realia ma i modidella conoscenza in quanto rappresentazione d’ambiente, come èben evidente nella nozione di cronotopo. Accanto allo sviluppodiacronico, il paesaggio è non semplice quinta o digressione, rap-presentando invece l’altra faccia del testo letterario, quella dellacostruzione spaziale; faccia in verità assai importante, perché fun-zionale alle relazioni di sistema, perciò intimamente connessatanto all’aspetto progettuale e architettonico del testo (sia intra-sia intertestuale) quanto alle dinamiche dell’ambiente culturale,in particolare alla dialogicità.
Il “paesaggio descritto” della letteratura è – bisogna ricor-darlo – un paesaggio scritto: il testo sembra snodare la comples-
3 M. Blanchot, L’espace littéraire, Gallimard, Paris 1955, trad. it. Lo spazio let-terario, Einaudi, Torino 19752, p. 165 nota. Si vedano inoltre D.R. Olson,The World on Paper. The Conceptual and Cognitive Implications of Writingand Reading, Cambridge University Press, Cambridge 1994, in part. il deci-mo capitolo; H.J. Graff, The Labyrinths of Literacy, The Falmer Press, Lon-don-New York 1987, p. 25 (nuova ed. ampliata: Pittsburgh University Press,Pittsburgh 1995).
Vincenzo Bagnoli
10
sità del mondo al lettore in forma di mappa, riconducendone laparte duramente materiale alla sfera dei significati umani, senzapretendere però di dissolverne la sostanza in un gioco retorico,ma al contrario realizzando nella propria topologia interna unmodello non tanto del mondo, quanto del nostro guardare ilmondo. Lo dimostra proprio una buona parte dei testi del mo-derno, preoccupati di tracciare una mappa testuale del mondonon più tassonomica (com’erano quelle medievali, che scandiva-no lo spazio su base categoriale in regni, temi ecc.), servendosidelle forme irregolari e frattali del labirinto, della waste land, del-la città. L’unica realtà che il testo convoca è l’occhio del lettore,al quale si rivolgono inventio e dispositio nell’approssimarne unacartografia dei movimenti, una topica dei loci e insieme un’archi-tettura dei significati, dei quali l’elocutio costituisce la coordinatatopografica e insieme il dato climatologico.
L’unica avvertenza di cui rendere conto al lettore riguarda il quar-to capitolo, che in minima parte fonde e rielabora due interventi ap-parsi su «il rosso e il nero» e «Versodove». Per una bibliografia sui variargomenti trattati si potrà invece fare comodamente riferimento alleindicazioni riportate in nota nei singoli capitoli. Questo lavoro nascenell’ambito della ricerca diretta da Niva Lorenzini presso l’Universitàdi Bologna sul tema del paesaggio. Un ringraziamento è quindi dovu-to, oltre che alla coordinatrice, a quanti hanno fatto parte del gruppodi lavoro e vi hanno contribuito in termini di competenze, metodi e ri-sultati. Devo altresì un ringraziamento particolare a Giorgio Bertone,la cui esperienza sul tema ha confortato il dattiloscritto e infine ai com-pagni di strada di «Versodove», che con amicizia, pazienza e intelli-genza hanno voluto continuare a discutere con me di molti temi delpresente volume per un intero decennio.
Premessa
11
CAPITOLO PRIMO
Sguardi, letture e carte.Scrivere il paesaggio
1. Lo sguardo e lo spazio allargato
Fra i moltissimi esempi disponibili (così numerosi da con-durre la riflessione sempre a un passo dall’ovvio), la più nota en-diadi che lega una scrittura a un paesaggio, ossia all’immagine diun luogo come spazio organizzato (orientato) e dotato di senso, èquella stabilita fra Baudelaire e Parigi, non solo per la vicendabiografica del poeta francese, ma anche per la monumentale in-terpretazione della sua opera progettata e solo in parte realizzatada Walter Benjamin, che per molti versi costituirebbe un puntodi partenza obbligato. Procedendo attraverso quelle pagine, ilfuoco della lente critica si sposta dal letterario all’artistico, di quiall’estetico, quindi a una riflessione sulla percezione che si allar-ga fino a confondersi con gli orizzonti della sociologia, come al-cuni hanno obiettato; ma è una sociologia della conoscenza e del-l’arte d’alto valore antropologico (cosa che agli studiosi di huma-nitates non dovrebbe mai dispiacere, a meno di rimuovere il te-sto, il discorso, il linguaggio dalla sfera delle attività umane)1.
1 Importante almeno il richiamo fatto da K. Mannheim alla problematicità delrapporto con la totalità anche in una “storia formale dello stile”, dal mo-mento che, tanto per i processi artistici quanto per le scienze umane (nelmomento dell’interpretazione), sono necessari ambiti di significato ampi:Das Problem der Wissenssoziologie, in Wissenssoziologie, Luchterhand, Ber-lin 1964, trad. it. Sociologia della conoscenza, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 5e ss.; il richiamo sembra proprio alla Theorie des Romans di Lukács, che delresto è esplicitamente discussa nel saggio. D’altro lato P. Burke, A Social Hi-story of Knowledge, Polity, London 1999, trad. it. Storia sociale della cono-scenza, Il Mulino, Bologna 2002, usa la cartografia come “scienza guida”.
13
Nel paesaggio gli oggetti del leggere e dello scri-vere si posano tra le rocce le erbe le lucertole,diventano prodotti e strumenti della continuitàminerale-vegetale-animale.
I. Calvino, Il castello dei destini incrociati
Volendo concentrare l’attenzione sul letterario, ma tenendo co-munque ferme le molte suggestioni, o se non altro i problemi aper-ti da questa lettura, ci si può soffermare almeno su una lirica diBaudelaire, posta in apertura dei Tableaux parisiens, vale a dire del-la sezione che più si concentra su una raffigurazione visiva dellacittà, intitolata Paysage (Les Fleurs du Mal, LXXXVI). Il paesaggioin questione è appunto quello della “Parigi capitale del XIX seco-lo”, ma di là dal riferimento contingente interessa come il poetatratteggi il modo in cui l’opera letteraria può guardare e riprodurreil paesaggio: “Je veux, pour composer chastement mes églogues, /Coucher auprès du ciel, comme les astrologues” (vv. 1-2).
Il primo elemento da considerare è questa particolare posi-zione assunta dal soggetto vicino al cielo, ossia alla sfera di un co-lore diffuso, della percezione epidermica del clima, nella posa dichi scruta le costellazioni come riflessi di spazi ancora di là dal-l’orizzonte2. È il suono però, portato “par le vent”, che guida lacostruzione di un’immagine “en rêvant”: dalla sonorità ritmicadipende, attraverso il procedimento dell’immaginare (che, allalettera, è produrre immagini), la scansione dello spazio visivo,sempre divisa tra i dettagli topografici del panorama e il golfo dei“grands ciels”. La dimensione temporale di questo modo di guar-dare, di sentire e di essere nel paesaggio non può quindi essere ri-solta che nella campitura ampia delle stagioni, dove accanto altrascorrere resta la durata. Il testo sembra dunque suggerireun’immagine del mondo a partire dall’atto di guardarlo, secondola tecnica della teichoskopia omerica (Iliade, III: un paesaggioumano). Al giungere dell’inverno il registro delle immagini cam-bia: chiuse le imposte, è sempre un rêver a essere praticato, ma lesue immagini, gli horizons bleuâtres e persino “tout ce que l’Idyl-le a de plus enfantin”, si disegnano su uno spazio vuoto, “dans lanuit”, così che l’immaginare generi “des […] pensers brûlantsune tiède atmosphère”.
2 La posizione elevata è uno dei marcatori dell’inizio di una pausa descrittivanel romanzo: Ph. Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif, Hachette,Paris 1981, pp. 185 e ss. e Id., Cos’è una descrizione, in Semiologia, lessico,leggibilità del testo narrativo, Pratiche, Parma-Lucca 1984, pp. 55-83.
Vincenzo Bagnoli
14
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
15
Si potrebbe citare in proposito la “felicità invernale di abitare”di Bachelard e, ancor più appropriatamente, la sua dialettica (con-dotta sulla complementarità) fra spazio aperto e chiuso; ma so-prattutto, per andare a un autore italiano, la capacità ricordata daSvevo “di ottenere col vivo ricordo in pieno inverno le rose delMaggio”, non come mera finzione letteraria, bensì come viva emo-zione di riavere “un passato che più non duole”3. Ciò che tuttaviapreme rilevare sotto il profilo tecnico è che il testo dichiara cosìnon di guardare il mondo, ma di ricostruirlo. Sembra in questomodo mettere in scena due distinte categorie di immagini nelle epi-fanie ritmiche dei versi, nella loro atmosfera sonora: quelle perce-pite dal vero e quelle interamente comprese nell’artificio letterario.Per gli occhi che guardano il testo, però, la distinzione esiste solonello spazio della finzione, poiché nessuna immagine è davveropresente: l’evidentia, la descrizione articolata di ciò che è davantiagli occhi, è nel testo sempre in absentia, è sempre realizzata comevisio (ossia il vedere come vista o veduta), un atto compiuto anchequando sia proposto come un compiersi. La letteratura, come ri-corda Genette parafrasando Leonardo, è cosa mentale4. La to-pothesia, la meticolosa immagine della disposizione dei luoghi, siavvicina pertanto alla phantasia, e questa a propria volta (in quan-to appunto costruzione di un ordine nello spazio mentale per im-magini) alla imaginatio vera. All’interno della phantasia l’allocuzio-ne al lettore (come individuo o collettività) contenuta nell’apostro-fe5 svolge una determinante funzione prospettica, poiché “imma-gina” (ossia raffigura) la presenza del lettore stesso e lo posizionadavanti al “quadro” della visio, estendendo l’ordine dell’immagi-nato oltre il limite della fictio, coinvolgendo e intersecando altrispazi nel suo ordine. Sotto l’insegna del rêver, insomma, da inten-dersi dunque nell’accezione proposta da Bachelard, si ha il feno-
3 I. Svevo, La coscienza di Zeno, Dall’Oglio, Milano 197620, pp. 443 e 445: ènel capitolo “Psico-analisi”.
4 G. Genette, Fiction et diction, Gallimard, Paris 1991, trad. it. Finzione e di-zione, Pratiche, Parma 1994, p. 13. Sul rapporto tra finzione e realtà si vedaanche G. Celati, Finzioni occidentali, Einaudi, Torino 1986, p. 5.
5 Cfr. H. Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, Max Huber Verlag,München 1967, trad. it. Elementi di retorica, Il Mulino, Bologna 1969, p. 244.
meno dello “sguardo che ritorna sullo sguardo”6 (su questa baseNovalis sosteneva nel frammento 118 che “L’occhio non vede altroche l’occhio”). Una assimilazione delle due categorie è suggerita daprecisi segnali testuali che avvertono come anche l’ipotiposi “inpresa diretta” avvenga a imposte chiuse, a “volets fermés”: la stes-sa dinamica verbale è infatti interamente compresa nella sfera del-l’intenzione (“Je veux”), del fine (“pour composer”, “pour bâtir”)e del futuro (“verrai”, “viendra”, “fermerai”, “rêverai” ecc.). Lasola eccezione è la constatazione “il est doux…”, riferita al guar-dare, che al centro del testo sviluppa il tema del “piacere dellosguardo”, e realizza così l’identificazione tra lo sguardo del lettore,sempre postumo, sempre costretto a rincorrere con la fantasia i se-gni del testo, e lo sguardo costruito, inscritto nel testo, sotto l’inse-gna comune di un avvicinamento al mondo. Si affianchino allora aiversi francesi queste parole di Calvino, uno fra gli scrittori italianipiù attenti non semplicemente e genericamente al paesaggio, ma alfatto che “il metodo da seguire nella descrizione diventa altrettan-to importante che il paesaggio descritto”:
… lo scrivere è un’operazione di movimento di per sé. Anchese adesso che sono seduto qui a scrivere sembro fermo, sonogli occhi a muoversi, gli occhi esteriori che corrono avanti e in-dietro seguendo la linea di lettere che corre da un margine al-l’altro del foglio, e gli occhi interiori che anche loro corronoavanti e indietro tra le cose sparpagliate nella memoria, e cer-cano di dare loro una successione, di tracciare una linea tra ipunti discontinui che la memoria conserva isolati, strappatidalla vera esperienza dello spazio7.
Insomma un costruire, un progettare, non un semplice am-mirare lo “spettacolo” della natura (prima o seconda). Già il
6 A.G. Gargani, Sguardo e destino, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 3. Ma per unesempio si veda R. Shattuck, The Innocent Eye. On Modern Literature andthe Arts, Farrar Straus Giroux, New York 1984 (nuova ed.), trad. it. L’occhioinnocente. La letteratura moderna e le arti, Il Mulino, Bologna 1992, p. 25.
7 I. Calvino, Prefazione a E. Cavazzoni (a c. di), Esplorazioni sulla via Emilia:scritture nel paesaggio, Feltrinelli, Milano 1986, pp. 11-12.
Vincenzo Bagnoli
16
Goethe della Teoria dei colori (1808) notava che ogni guardarenon si risolve nel vedere, ma conduce a un “considerare”, quindial “riflettere” e infine al “congiungere”: il theoreîn conduce ine-vitabilmente verso lo spazio della teoria, un passo in là dallecose8. Qualcosa di analogo diceva Cassirer dell’esperienza esteti-ca del paesaggio, allorché notava che essa non si limitava al pia-cere della vista e del clima, ma consisteva proprio, al di làdell’“immediata realtà delle cose”, nell’“assorbirsi nell’aspetto di-namico della forma”, ossia nella ricerca, nella scoperta, nell’esal-tazione di regolarità: il “ritmo delle forme spaziali” l’“armonia” eil “contrasto dei colori”, l’“equilibrio tra luce e ombra”9.
Le due categorie assimilate nella lirica di Baudelaire dalla so-vrapposizione di sguardi trasferiscono insomma l’una le propriequalità sull’altra: secondo un’estetica che tra le prime riconoscevanella modernità la coesistenza di transitorio ed eterno, le immaginidi questa come di ogni altra ipotiposi della città moderna, “l’atelierqui chant et qui bavarde”, vengono così portate al livello della bel-lezza, dei “grands ciels” del repertorio letterario. In questa direzio-ne, nell’inscrivere entro il medesimo panorama tanto il moderno (“iltransitorio, il fuggitivo, il contingente”) quanto l’eterno e l’immuta-bile10, va letto il chiasmo che ai vv. 10 e 11 incrocia “la lampe à lafenêtre” e “l’étoile dans l’azur”, “les fleuves de charbon” e il “fir-mament”. Parallelamente alle immagini “infantili” dell’“Idylle” vie-ne riconosciuta non solo una qualità retorica, ma la capacità, attra-
8 J.W. Goethe, Teoria dei colori (1808), Saggiatore, Milano 19896, p. 57.9 E. Cassirer, An essay on man: an introduction to a Philosophy of Human Cul-
ture, Doubleday, Garden City (NY) 19532, trad. it. Saggio sull’uomo, Arman-do, Roma 1968, p. 264; poco oltre, a p. 286, aggiunge: “La scienza dà un or-dine ai pensieri, la morale alle azioni, l’arte alla percezione delle apparenzevisibili, tangibili e udibili”. Altra fondamentale riflessione è quella di R. As-sunto, Il paesaggio e l’estetica, Novecento, Palermo 1994. Si veda anche N.Goodman, Ways of worldmaking, Harvester Press, Hassocks 1978, trad. it.Vedere e costruire il mondo, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 204: l’atteggiamen-to estetico ha valore conoscitivo perché è “mobile”, è atteggiamento “di ri-cerca, di esplorazione”, insomma “azione”, nelle forme della “creazione e ri-creazione”, con valore tanto rispetto al passato quanto rispetto al futuro.
10 Queste sono, secondo il noto Peintre de la vie moderne, le due “metà del-l’arte”, Ch. Baudelaire, Il pittore della vita moderna, in Poesie e prose, Mon-dadori, Milano 1973, p. 944.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
17
verso la loro possibilità di progettare una “tiède atmosphère” (disfuggita si noti che questa è la sfera del respiro umano), di essere co-munque un “segno del mondo”, riabilitando la finzione letterariasottratta al ruolo di decorazione, e restituendole la funzione di rico-struire/rappresentare nella chiave della “percettibilità” l’ambientedegli uomini11. La presenza del paesaggio nel testo come “immagi-ne prodotta” (nel senso di “costruita”, non naturale: si potrebbedire artificiale, ma la parola darebbe luogo a equivoci, oppure cul-turale) è comunque il risultato di un tentativo di leggere il mondo edi renderlo leggibile. Lo spazio del testo in entrambi i casi prospet-ta un’immagine del mondo, non la convoca come presente; ce ne dàla consistenza, partendo dal sonoro per arrivare al visivo, attraversola mancanza. I Tableaux non pretendono dunque di essere vedutedi Parigi: sono, per così dire, sguardi sulle vedute di Parigi. Perquanto sembri un’osservazione scontata, è bene riflettere sul fattoche le parole – gli “occhi interiori” di Calvino – immaginano, manon sono immagini, anche se possono ambire a presentarsi cometali12; sono semeiosis, non mimesis.
11 Cfr. Ph. Hamon, Introduction a La description littéraire. De l’Antiquité à Ro-land Barthes: une anthologie, Macula, Paris 1991, p. 6, dove, ritornando allaconcezione classica di Boileau, della descrizione letteraria si dice che “elledoit instruire autant qui plaire, faire savoir autant qui faire montre d’un sa-voir-faire, et proposer un texte toujours lisible”; G. Genette, Finzione e di-zione, cit., pp. 8-9.
12 Cfr. J.M. Lotman, Struktura chudožestvennogo teksta, Iskusstvo, Moskva1970, trad. it. La struttura del testo poetico, Mursia, Milano 1985, pp. 71-73.Un interessante esempio nell’ambito delle lettere italiane è dato da M. Testi,G. Caproni: il viaggio e la parola nella città, la consistenza attraverso la man-canza e l’epifania “laica”, in «Critica letteraria», 70, 1991, pp. 168-188. Sullaparola-immagine, tanto come “idolatria della forma”, quanto come “modo dicomunicazione simbolico-musicale” con valore conoscitivo, si veda L. Ance-schi, D’Annunzio e il sistema dell’analogia, in D’Annunzio e il simbolismo eu-ropeo, in Atti del Convegno di studio (Gardone Riviera, 14-15-16 settembre1973), a c. di E. Mariano, Il Saggiatore, Milano 1976, p. 87. Sull’epifania let-teraria cfr. inoltre G. Melchiori, James Joyce e D’Annunzio, in D’Annunzio eil simbolismo europeo, cit., pp. 299-311 (dove si ricorda, oltre alla precoce se-gnalazione di U. Eco, la differenza tra gli usi dei due autori) nonché G. Mel-chiori, Nota introduttiva a J. Joyce, Ritratto dell’artista da giovane (1904), inRacconti e romanzi, a c. di G. Melchiori, Mondadori, Milano 19905, pp. 521-529. Per una breve bibliografia sul tema rimando al mio Futurismo e “societàdello spettacolo”, in «Intersezioni», XV, 3, 1995, pp. 425-438.
Vincenzo Bagnoli
18
2. Il senso dello sguardo, il senso del paesaggio in letteratura
L’interpretazione tradizionale della lirica di Baudelaire consi-dera la scoperta delle Correspondances come ulteriore, ma non ul-tima, tappa di un processo di identificazione fra l’io soggettivodel poeta e il paesaggio: il mondo esterno esisterebbe in lettera-tura solo in quanto pittoresca rappresentazione o rispecchiamen-to di stati interiori (magari con varie gradazioni di contrastività:per esempio Canzoniere, CCCX13). Nei versi appena letti si puòforse evidenziare qualche cosa di più, la traccia di un diversoorientamento, volto (secondo l’ammonimento di Lukács), a “nondissolvere il mondo in uno stato d’animo”14: un passo verso unadiversa attenzione all’esterno, che costringe anzi il poeta a modi-ficare profondamente il punto di vista e la posizione del perso-naggio che dice “io” nel testo. Si profila insomma un’attenzioneai “fenomeni” (sottoposti poi, chiuse le “imposte” del testo, alla“mnemotecnica del bello”15) che rende la presenza del paesaggionel testo una modalità di partecipazione a un diverso orizzonte disenso, una trama contestuale di referenzialità la quale, senza vo-ler implicare i realia, esce tuttavia dal cortocircuito dell’interioritàe coinvolge il tessuto di diversi dialoghi, le prospettive plurali diuna condivisione o, per usare le parole dello stesso Baudelaire,l’“infinita varietà”16. Anche il “paesaggio interiore” non è mai ri-
13 Dove alle quartine descrittive (vv. 1-2: “Zefiro torna, e ’l bel tempo rime-na / e i fiori e l’erbe, sua dolce famiglia…”; v. 5: “Ridono i prati, e ’l cielsi rasserena”) si contrappone la narrazione in prima persona delle terzine(vv. 9-10: “Ma per me, lasso, tornano i più gravi / sospiri, che del corprofondo tragge…”.
14 G. Lukács, Teoria del romanzo (1916), SE, Milano 1999, p. 58.15 Questa definizione dell’arte è nel capitolo “Dell’ideale e del modello”, in
Ch. Baudelaire, Salon del 1848, in Poesie e prose, cit., p. 729, dove è distin-to dallo chic, “abuso della memoria” o, meglio, “una memoria della mano”.
16 È il tema centrale del Salon sopra citato dov’è contrapposta alla poesia tra-gica proprio nella sezione dedicata al paesaggio, ibidem, p. 757. Analoga-mente, ma per altra via, si veda J.M. Lotman, La struttura del testo poeti-co, cit., pp. 335 e ss. Si possono anche chiamare in causa le “comunità in-terpretative” di Stanley Fish (Is there a text in this class? The Authority ofInterpretive Communities, Harvard University Press, Cambridge [MASS.]1980), senza tuttavia concedere loro l’assoluta autorità attribuitagli dal cri-
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
19
ducibile a una dialettica io-mondo, soggettivo-oggettivo, macomporta uno spostamento (poiché ciò avviene quando si tentadi raggiungere il significato) sul piano del linguaggio, della cultu-ra come comunità di parlanti. Anche questi inscape sono condi-visi, perché delineati in una struttura comunicativa (ambiente)17
che richiede la “cooperazione interpretativa” di vari dialoganti:l’autore, le sue fonti, le convenzioni tecniche e soprattutto il let-tore con la sua percezione ed esperienza spaziale. La poesia abi-ta uno spazio che non è solo quello della interdiscorsività retori-ca del genere, dello stile, né quello del sé, ma è spazio di una na-tura (che resta irriducibile alle leggi della “morale”) e di un’“epo-ca”: così facendo si rende spazio abitabile, percorribile dallosguardo dell’altro, della “maggioranza”, con le parole del Salondel 184618. Nell’epoca in cui il pubblico diviene il destinatario del-l’opera d’arte, stabilisce un riconoscimento e un contatto con lalontananza, con la molteplicità19.
Il paesaggio si propone allora come termine per eccellenza del-lo sguardo, con le sue lontananze, ampiezze, molteplicità. Esso haun’articolazione strutturata, non è “un” oggetto: guardare il mon-do è infatti diverso da guardare un oggetto, poiché significa guar-darne innanzitutto la complessità. Il paesaggio è dunque nel testoil “riflesso della realtà fenomenica”: indica cioè una conoscenza (oconsapevolezza, che è anche consapevolezza delle mediazioni im-poste dalla comunicazione, dal genere, dallo stile ecc.20) sulla cuibase si elaborano le strategie del testo e dell’esperienza, non come
tico statunitense, ma intendendo comunque qualcosa di più intensamentedialogico dell’estetica della ricezione jaussiana (ciò che importa è che an-che l’autore ne è parte in varia misura).
17 F. Lando (a c. di), Fatto e finzione: geografia e letteratura, Etaslibri, Milano1993, p. 307.
18 Nella dedica Ai borghesi, in Poesie e prose, cit., pp. 683-685. All’inizio delSalon del 1859, nello stesso registro, è l’elogio al “luogo comune”.
19 W. Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire, in Angelus Novus, Einaudi, To-rino 1962, pp. 99 e ss.; un altro esempio in Alison McCleery, Alistair Mc-Cleery, La personalità del luogo nel romanzo regionale urbano, in F. Lando (ac. di), Fatto e finzione, cit., pp. 143-158.
20 Si veda anche G. Olsson, Birds in Egg/Eggs in Bird, Pion, London 1980, trad.it. Uccelli nell’uovo/Uova nell’uccello, Theoria, Roma-Napoli 1987, pp. 34 e ss.
Vincenzo Bagnoli
20
leggi ma come reticoli di modelli. Lo sguardo sul paesaggio è laforma letteraria del rapporto con la conoscenza del mondo: “Al dilà del pittoresco”, scrive Bachelard a proposito di questa attenzio-ne fenomenologica dell’opera letteraria, “i legami dell’anima uma-na e del mondo sono forti. Vive allora in noi non una memoria sto-rica, ma una memoria cosmica”21; va allora detto (e si avrà modopoi di soffermarsi più a lungo) che, se parlando di “attenzione fe-nomenologica” veniva finora spontaneo il riferimento alla poesiadel primo Novecento o a Calvino, anche altre voci, come quella diLeopardi, possono entrare in questo dialogo.
Le difficoltà epistemologiche di una cultura (una cultura let-teraria in questo caso) nei confronti dell’“ambiente oggettivo de-gli uomini”, vale a dire la problematicità dei percorsi descrittivo-narrativi tesi a conoscerlo e nominarlo, a renderlo quindi dicibile,si misurano proprio nelle immagini di “paesaggio come spaziodello sguardo” che essa è capace di rappresentare22. Il paesaggioguardato dalla letteratura è allora il teatro delle azioni degli indi-vidui e della storia delle collettività, ma soprattutto lo spazio del-l’interpretazione, l’“interfaccia tra il fare e il vedere quello che sifa”23. Perciò si parla di “non leggibilità del paesaggio”24, riferen-
21 G. Bachelard, La poétique de la rêverie, PUF, Paris 1960, trad. it. La poeticadella rêverie, Dedalo, Bari 1972, p. 130.
22 Sul versante scientifico D. Lowenthal, Geography, experience and imagina-tion: towards a geographical epistemology, in «Annals of the Association ofAmerican Geographers», 51, 1961, pp. 241-260, citato però da F. Lando,Geografia e letteratura: immagine e immaginazione, premessa a Fatto e finzio-ne, cit., pp. 1-16, dove si inserisce nel contesto della proposta di una “geo-grafia umanistica”. Importante anche J.-M. Besse, Voir la terre. Six essais surla géographie et le paysage, Actes Sud/ENSP/Centre du paysage, Arles 2000.
23 E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresen-tato, Marsilio, Venezia 1998, p. 16, dov’è anche una illuminante riflessione sulrapporto con il paesaggio come teatro per un uomo che è non solo attore maanche spettatore. Sul versante di un rapporto specificamente con il letterarioe in particolare con la narrazione: P. Betta, Il paesaggio fra reale e immagina-rio, Maccari, Parma 1997 e Saggi sul paesaggio del “Mondo narrato”, Maccari,Parma 1999; M. Magnani, Paesaggio e letteratura, Maccari, Parma 1996. Cfr.inoltre W.H. Herendeen, From Landscape to Literature. The River and theMyth of Geography, Duquesne University Press, Pittsburgh 1986.
24 E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., p. 23. Analogamente D. Cosgrove, So-cial Formation and Symbolic Landscape, Croom Helm, London 1984, trad.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
21
dosi alla caratteristica delle civiltà postindustriali della tarda mo-dernità, ma la definizione potrebbe essere estesa anche alla “se-conda natura” nominata da Lukács25 e in genere a tutte quellespiegazioni del moderno (inclusa la stessa trasformazione delpaesaggio in una muta tela per il pennello dell’anima) che, ri-mosso il mito in ogni sua forma, scoprono la difficile conciliabi-lità tra la ricerca umana di sensi e l’irriducibile mancanza di sen-so della natura: quella dinamica illustrata dalla sabbia e dai maci-gni del giardino zen descritto da Calvino in Palomar:
Vede la specie umana nell’èra dei grandi numeri che s’e-stende in una folla livellata ma pur sempre fatta d’individua-lità distinte come questo mare di granelli di sabbia che som-merge il mondo… Vede il mondo ciononostante continuare amostrare i dorsi di macigno della sua natura indifferente al de-stino dell’umanità, la sua dura sostanza irreducibile all’assimi-lazione umana… Vede le forme in cui la sabbia umana s’ag-grega tendere a disporsi secondo linee di movimento, disegniche combinano regolarità e fluidità come le tracce rettilinee ocircolari d’un rastrello… E tra umanità-sabbia e mondo-sco-glio si intuisce un’armonia possibile come tra due armonienon omogenee: quella del non-umano in un equilibrio di for-ze che sembra non risponda a nessun disegno; quella dellestrutture umane che aspira a una razionalità di composizionegeometrica o musicale, mai definitiva…
Sempre in Calvino, ma questa volta in un saggio del 1962, Lasfida al labirinto, si trova un’altra immagine emblematica di que-sto difficile rapporto tra sguardo e paesaggio; già in precedentiinterventi lo scrittore aveva puntato il dito su un’inclinazione al“rapporto negativo col mondo” come espressione di una diffi-coltà intervenuta nel rapporto fra lo scrittore e il proprio tempo,
it. Realtà sociali e paesaggio simbolico, Unicopli, Milano 1990, considera il“paesaggio” nel testo come un “modo di vedere” degli europei attraversocui dare una “rappresentazione” e un “commento”.
25 G. Lukács, Teoria del romanzo, cit., p. 55.
Vincenzo Bagnoli
22
ossia in quel confronto dell’organizzazione coscienziale dell’uo-mo con “natura e storia”, con il “mare dell’oggettività”26, che è ri-chiesto alla letteratura, di là dalle singole scelte di engagement,dalla necessità di una verifica del nostro modo di “essere al mon-do”. Il “labirinto gnoseologico-culturale” di cui si parla nel sag-gio del 1962 è dato proprio dalla complessità delle sovrapposi-zioni storiche, divenuta evidente fra la prima e la seconda rivolu-zione industriale, e nello specifico frangente postmoderno e po-stindustriale (che confonde e cancella le tracce di miti rurali emiti borghesi), ma in realtà avviata fin dalle “rivoluzioni cultura-li” che segnano l’inizio della modernità all’insegna proprio diprofonde trasformazioni nella rappresentazione dello spazio27.
Riguardo al paesaggio moderno e all’impossibilità di vederlo,al punto che esso può presentarsi come schermo opaco o spari-zione, esistono per la letteratura specifici problemi di ottica, mala sostanza della difficoltà non sta nell’aver perduto un’immagi-ne, una percezione naturale preesistente, quanto nella crisi dellostrumento culturale messo a punto in precedenza per descrivere
26 Così s’intitola un altro saggio di Calvino del 1960 (in Una pietra sopra. Di-scorsi di letteratura e società, Einaudi, Torino 1980, pp. 39-45) nel quale siprendono in esame la caoticità dei linguaggi artistici moderni e l’imporsidella razionalità scientifica come segni di un superamento della dialettica frasoggettività e mondo: perdendo la sua centralità, l’io è ridotto a elementodell’esistente e quindi “annega” nel mare dell’oggettività, nel prevalere deidati. Cfr. N. Lorenzini, Il presente della poesia, Il Mulino, Bologna 1991, pp.13 e ss. e M. Belpoliti, L’occhio di Calvino, Einaudi, Torino 1996, p. 7. Inquesto vede una “abdicazione” dell’umano anche P. Ricoeur, Philosophie dela volonté, Aubier-Montaigne, Paris 1949, p. 326.
27 I. Calvino, La sfida al labirinto, in Una pietra sopra, cit., pp. 82-97. Gli altrisaggi citati sono compresi nella stessa raccolta: Il midollo del leone, p. 18;Natura e storia nel romanzo, pp. 19-38; Il mare dell’oggettività, pp. 39-45;Dialogo di due scrittori in crisi, pp. 64-69. Sull’analisi delle “rivoluzioni cul-turali” si rimanda a storici della cultura quali S. Kern, The Culture of Timeand Space 1880-1918, Harvard University Press, Cambridge (MASS.) 1983,trad. it. Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento,Il Mulino, Bologna 1988; P. Zumthor, La mesure du monde, Editions duSeuil, Paris 1993, trad. it. La misura del mondo. La rappresentazione dellospazio nel Medio Evo, Il Mulino, Bologna 1995; E.J. Leed, The Mind of theTraveller, Basic Book, New York 1991, trad. it. La mente del viaggiatore, IlMulino, Bologna 1992.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
23
le dinamiche dell’esperienza nello spazio ambientale. Di questostrumento, uno strumento linguistico di “geodesia”, così come lapittura ha i propri modelli geometrici di ricomposizione, Calvinosi serve poi per lanciare la sfida al labirinto, ricordando che trat-to distintivo di buona parte della letteratura moderna è propriola consapevolezza che la complessità richiede descrizioni accura-te, confronti serrati, anche a costo del “negativo”: “descrizionidella confusione” che tuttavia non siano “descrizioni confuse”,come ammonisce Benjamin, ma esatte. Certo si tratta di un’esat-tezza diversa da quella della scienza, che non pretende mai di rin-viare in maniera diretta, trasparente, a contenuti, realtà o verità,ma che attraverso i termini di confronto delle proprie figure puòrendere l’opera letteraria una sorta di rappresentazione su un’al-tra scala e per mezzo di convenzioni: ciò che Calvino chiama una“mappa del mondo e dello scibile”. Essenziale è l’atteggiamento,la “passione conoscitiva”, quale Calvino ravvisa in poeti comeWilliam Carlos Williams, Marianne Moore, Eugenio Montale,Francis Ponge (il più avvicinabile a Lucrezio, dal suo punto di vi-sta), e scrittori come Gadda, Musil, Proust28.
Questo tipo di esattezza viene immediatamente associata daCalvino alla chiarezza di un progetto (“un disegno dell’opera bendefinito e ben calcolato”); all’“icasticità”, che è proprio la capa-cità della parola di “rappresentare” alla maniera delle immaginivisive, intesa in particolare come nitidezza e incisività; alla preci-sione del linguaggio nella “resa di sfumature”, l’attenzione per laricchezza di articolazioni29. Rilevato che la tripartizione sembra ri-proporre, in una declinazione particolare, lo schema retorico diinventio, elocutio e actio, si potrà allora riflettere sul valore di “in-tenzione” progettuale implicita nel “disegno” dell’opera e sullesue peculiarità prospettiche. Lo faremo più avanti, ma va intantonotato come questo tipo di conoscenza attraverso lo “sguardo del
28 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Gar-zanti, Milano 1988 (ora Mondadori, Milano 1993), pp. 83 e ss. e 118 e ss.; aquesto canone lucreziano si possono aggiungere due poeti part-time comeQueneau e Borges, oltre a Wallace Stevens, per limitarsi al periodo preso inesame da Calvino.
29 Ibidem, pp. 65 e ss.
Vincenzo Bagnoli
24
linguaggio”, applicandosi alla molteplicità, finisca col risultare in-conciliabile con ogni tipo di metafisica. Lo sguardo è così resti-tuito alla concretezza dell’orizzonte, e quindi lo sguardo delle pa-role a quell’ambito comunicativo dal quale gli eccessi formalisticitendevano a svellerlo. In quanto “rappresentazione”, tale cono-scenza resta comunque un tentativo di “organizzazione” non del-la “vita” ma dell’esperienza, senza pretesa di alcun valore norma-tivo. Non offre soluzioni ai problemi posti da un paesaggio con-fuso, sfocato, ma aiuta a comprendere che esso è tale solo se guar-dato nell’ottica degli schemi statici: la meraviglia del linguaggio,delle sue immagini, sta nella sua quotidiana capacità di adattarsi aun mondo che cambia incessantemente grazie alla “plasticità con-testuale” propria della sua cadenza dialogica30.
3. Gli orizzonti del luogo comune
Per definire il modo che ha il testo di raccontare il paesaggio,per chiarire la specificità fenomenologica delle immagini poeti-che, si può tornare al Bachelard che notava un “nuovo modo diessere del linguaggio” proprio nella capacità di immaginare dellarêverie, da intendersi non solamente come distensione (né tantomeno sogno), assopimento della coscienza critica. Al contrarioessa esprime il desiderio che si ridesta e si lancia in una fuga obli-qua dall’angolo dell’occhio, lo spalancarsi della digressione comeun risveglio, ossia non un’illuminazione, ma un’ordinata e pro-gressiva comprensione sebbene laterale (per Diderot proprio inciò consisteva il piacere del racconto). Anche senza pensare alladescriptio documentaria, ossia all’elenco puntiglioso dei dati dal“vero”, l’effetto ritmico del “racconto del paesaggio” apre lo spa-zio del personaggio che vede31, poiché riattiva nel lettore, so-
30 Sulla “trama aperta” (open texture) del linguaggio, F. Waisman, Verifiability,in A.G.N. Flew (a c. di), Logic and Language: First Series, Basil Blackwell,Oxford 1951, pp. 117-144. Sulla plasticità anche J.M. Lotman, La strutturadel testo poetico, cit., pp. 34-40.
31 R. Bourneuf, R. Ouellet, L’univers du roman, PUF, Paris 1972, trad. it. L’uni-verso del romanzo, Einaudi, Torino 1976, p. 111; sulle specificità della di-
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
25
spendendo il coinvolgimento della trama narrativa, il senso dellapartecipazione volontaria: la “funzione spaziale” del testo preva-le sulla sua dinamica temporale sviluppando la dimensione in cuilo sguardo diventa un intelligo, lo strumento della comprensionecritica32. L’esempio più calzante credo sia quello delle loop-roadsche dall’autostrada si addentrano nel territorio, e dopo un lungogiro tornano a congiungersi alla stessa highway poco più avanti,esempio fornito qualche decennio fa da Roger Shattuck, e da luiutilizzato per definire lo statuto dell’opera d’arte rispetto al rea-le: “esperienze collaterali” che consentono – grazie alle differenzee convenzioni istituite dalle parole – di percorrere i rapporti po-tenziali tra carattere, azione, pensiero e mondo naturale33. Tale èla rêverie di Ariosto, che continua instancabilmente a raccontare,descrivere, tracciare percorsi davanti alla vertigine del nuovo,dello spazio bianco dentro e attorno alla mappa; tale lo sguardodi Leopardi, che libera lo spazio dalle mitologie umanistiche perriempirlo di cosmo, natura, tempo e storia; tale il paesaggio diUngaretti, nella materialità ostinata delle sue forme, della sualuce, della sua atmosfera davanti al rischio estremo della cancel-lazione assoluta.
Per capire il senso di questa prospettiva si può osservare comeessa modifichi le funzioni della descrizione letteraria, il principalestrumento di rappresentazione di paesaggi nel testo, tenendo con-to di quanto si è notato a proposito del Paysage baudelairiano. Lateoria della letteratura, appoggiandosi alla retorica tradizionale, siè concentrata sul rapporto che la descrizione stabilisce con lestrutture diegetiche; se viene concordemente identificata la fun-zione di pausa rispetto alla cadenza narrativa che essa svolge adesempio all’interno del romanzo o del poema epico, marcandocosì il discrimine tra le azioni e le condizioni delle azioni stesse,continuano tuttavia a sussistere, accanto alla percezione di una
mensione spaziale del testo in relazione alla scansione temporale cfr. U. Eco,Les sémaphores sous la pluie, in Sulla letteratura, Bompiani, Milano 2002,pp. 191-214.
32 F. Curi, Struttura del risveglio. Sade, Sanguineti, la modernità letteraria, IlMulino, Bologna 1991, pp. 29-63.
33 R. Shattuck, L’occhio innocente, cit., p. 173.
Vincenzo Bagnoli
26
netta diversità, molte perplessità circa un suo statuto semiologicodifferente dalla narrazione. Se sono stati identificati alcuni segna-li che ne delimiterebbero i confini (la posizione elevata del sog-getto, la trasparenza dell’aria che permette allo sguardo di spazia-re), tuttavia è osservazione condivisa che questi non bastino amarcare e isolare in maniera univoca la presenza della descrizione,che è in realtà presente nella narrazione; di conseguenza la diffe-renza non sarebbe, secondo questa logica, rilevabile al livello del-le strutture formali, ma solo a quello tematico-contenutistico.
Per vie diverse Barthes e Lukács osservano qualcosa di simile:il primo parla della presenza di alcuni dettagli “inutili” della de-scrizione dal punto di vista strutturale, elementi assolutamentenon funzionali ed eccessivi, come di una permanenza del reale(privo di senso) nell’intellegibile, e quindi di un’“insignificanza”mirata alla creazione di un “effetto di realtà”34; il secondo concor-da sulla necessità di siffatti elementi accidentali che evitano l’ec-cesso di astrattezza. A voler seguire Lotman, però, anche il “ru-more” dell’elemento “extrasistematico” viene in realtà ricondottodal testo letterario, particolarmente da quello poetico, al livellodella significazione mediante la sistematizzazione all’interno diuno dei suoi diversi “piani” semici; la sua “unicità casuale” risul-tando piuttosto simulata mediante il collocarsi all’intersezione didue diversi sistemi (ciò è possibile in virtù dell’ingresso in diverse“strutture contestuali”, dalle quali “ricevere corrispondentementeun diverso significato”) così che ciò che in una struttura è siste-matico risulterà “casuale” nell’altra (è il caso ad esempio della ri-petizione di fonemi, che può essere percepita come ridondante,ma che nella polisemia del linguaggio poetico acquista significatoa un diverso livello di funzionamento del testo). Dunque la pre-senza della descrizione paesaggistica non segna semplicementeuno spostamento della messa a fuoco dal primo piano allo sfondo.È vero che essa realizza una sorta di “eclissi della narrazione”, maciò avviene soprattutto perché attraverso la sua peculiare prospet-tiva viene a mutare la funzione del linguaggio, non perché esso
34 R. Barthes, L’effet de réel, in Ph. Hamon, La description littéraire, cit., pp.251-252, trad. it. R. Barthes, Il brusio della lingua, Einaudi, Torino 1988.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
27
miri a un “effetto di realtà”, ma perché ora esprime un diversomodo di rappresentare il funzionare delle cose, la loro topologia.
Perciò non si tratta di un collocarsi “dalla parte delle cose”,perché in realtà attraverso questo mutamento non viene assegna-ta al linguaggio una maggiore referenzialità; semplicemente il suomodo di raccontare da diegematico si trasforma in periegematico,non conduce attraverso ma intorno (il termine in Strabone signifi-ca “minuta descrizione, spiegazione”). E tuttavia proprio attra-verso il combinarsi di una profondità spaziale alla cadenza tem-porale si deve la capacità di porsi in rapporto di modellizzazionecon il reale. Il motivo intessuto dal ricorrere nel testo, variando se-condo il contesto, di tali elementi paesaggistici non resta, come sipuò ben vedere, mero “contenuto”, ma, nel cogliere attraverso lefigurativisations il dinamismo del senso poetico, svolge una fun-zione strutturale di orientamento, come avviene quando si pren-dono a punti di riferimento i tratti salienti del paesaggio in lonta-nanza (quello che Collot chiama la “struttura d’orizzonte”)35.
Per spiegare la specificità dell’arte rispetto ad altri “analoghidella realtà”, ossia ad altri modelli, il semiologo russo si serve del-l’esempio del viaggiatore che interrompe il viaggio per consulta-re la carta, esempio che bene si adatta a questo discorso: il movi-mento nello spazio reale e il movimento sulla carta corrispondo-no certo a due modelli di comportamento distinti, una condottapratica e una convenzionale, ma è comunque possibile ricono-scere fra essi “un rapporto di correlazione semantica”. La speci-ficità dell’arte consiste nel fatto che essa, oltre a presentare lastessa delimitazione fra condotta pratica e condotta convenzio-nale, permette di far coesistere entrambi i comportamenti, masolo nello spazio stesso del modello, attraverso tale spazio, chedeve di necessità includere non il viaggio vero (con il quale man-tiene comunque un rapporto di contiguità), ma una diversa seriestrutturale dotata di una propria “ritmicità” niente affatto riduci-bile alla precedente. Se il percorso tracciato sulla carta può esse-
35 D. Gullentops, Poétique du lisuel, Editions Paris-Méditerranée, Paris 2001,pp. 65-66; M. Collot, La poésie moderne et la structure d’horizon, PUF, Paris1989.
Vincenzo Bagnoli
28
re (più o meno esattamente) tradotto in un viaggio reale, al con-trario il percorso di quella peculiare “mappa” che è l’opera lette-raria non coincide con una (una sola) “interpretazione”, ma è“struttura di relazioni”:
… una struttura di relazioni non è una somma di particolarimateriali, ma una scorta di rapporti, che è primaria nell’operad’arte e costituisce la sua base, la sua realtà. Ma questa scorta èstrutturata non come una gerarchia a molti piani senza interse-cazioni interne, ma come una struttura complessa di sotto-strutture vicendevolmente intersecatesi con reiterati interventidi questo o quell’elemento in diversi contesti costruttivi. Que-ste intersecazioni costituiscono appunto “la realtà” del testo ar-tistico, il suo polimorfismo materiale, che respinge la bizzarraasistematicità del mondo circostante con una tale verosimi-glianza che nel lettore non attento sorge l’illusione, la fede nel-l’identità fra questa casualità, questa irripetibile individualitàdel testo artistico e le proprietà della realtà rappresentata36.
L’esperienza dello spazio nel testo letterario è insomma unmodello anche nel senso di “spazio progettuale” nel quale sonopossibili varie articolazioni in cui i sensi multipli trovano unorientamento comune: se muove da un primo livello “mimetico”,non rispetto alla realtà ma ad altre scritture, subentra poi un’e-sperienza dello spazio “vissuto”, in senso fenomenologico, comerisultante della percezione soggettiva che ne fa “una strutturazio-ne concettuale in divenire permanente”. Questa dinamica guidaquindi all’esperienza dello spazio del testo letterario come spazio“tensionale”, un ordine cioè non lineare, non narrativo e non uni-vocamente referenziale, il cui margine di indeterminatezza (al-l’interno di una struttura che pare quindi “orientata e instabile”)affida per così dire il proprio compiersi alla cooperazione di unalettura, a un esercizio ermeneutico37.
36 J.M. Lotman, La struttura del testo poetico, cit., pp. 75-99, in part. pp. 78-79 e 98.
37 D. Gullentops, Poétique du lisuel, cit., pp. 141-149.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
29
La digressione-descrizione si sviluppa dunque su un altropiano del testo letterario, non è lo spot pubblicitario della realtàche interrompe il racconto (come se obbligasse il lettore a com-piere il viaggio reale), né un “lusso” esorbitante che rimanda a undato extratestuale. L’idea di Lukács è invece ancora quella di unruolo accessorio dell’aspetto ambientale, nell’economia dell’ope-ra letteraria, rispetto alla centralità delle vicende umane (il suobersaglio è però la “falsa oggettività” del naturalismo, ma si puòpensare alla perplessità del Calvino del 1960 davanti al “maredell’oggettività”); tuttavia vi è in più un’intuizione importante,poiché egli nota che nella descrizione lo sguardo del lettore è ob-bligato a spostarsi dall’azione all’ambiente. Nella classificazionedi Genette questo spostamento può essere in funzione della de-corazione o di una sequenza testuale a carattere esplicativo sim-bolico (tipica dell’Ottocento, sia per il romantico che vede il pae-saggio rispecchiare lo stato d’animo del personaggio, come Fo-scolo o Novalis, sia per il naturalista che ne cerca l’“influsso” sulcarattere, come Zola o Verga), ma in effetti esiste anche una ter-za possibilità che va oltre la funzione di scenario: Lukács sottoli-nea infatti che mentre gli avvenimenti si vivono, i quadri si osser-vano, istituendo nel contrasto fra partecipare e osservare un par-ticolare atteggiamento richiesto al lettore che accentua la compo-nente del distacco necessario a un esercizio critico38. Genette in-fine esplica ciò che in Lukács resta fra le righe (ma pure è pre-sente): le partiture del paesaggio costruiscono un racconto privi-legiando non più l’asse temporale, ma quello spaziale39.
38 G. Lukács, Narrare o descrivere?, in Il marxismo e la critica letteraria, Ei-naudi, Torino 19645, pp. 269-323. È proprio quanto Auerbach mette in lucedell’opera di Stendhal (non per nulla accusata da Zola di avere “macchineintellettuali” per personaggi); E. Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirkli-chkeit in der abendländischen Literatur, A. Francke, Bern 1946, trad. it. Mi-mesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino 19642, pp.225-226.
39 G. Genette, Figures II, Editions du Seuil, Paris 1969, pp. 56 e ss., trad. it.Figure II. La parola letteraria, Einaudi, Torino 1972; in Figures III, Editionsdu Seuil, Paris 1972, trad. it. Figure III. Discorso del racconto, Einaudi, To-rino 1976, pp. 148-155, si distingue ulteriormente tra una descrizione cheresta nell’ambito della diegesi e l’ecphrasis completamente extratemporale.
Vincenzo Bagnoli
30
Se tale prospettiva sembra ben adattarsi alla calcolata struttu-ra del cronotopo di Bachtin40, Lukács teme al contrario che l’“au-tonomia dei dettagli” rispetto alla vicenda umana finisca col farperdere a questa la specificità del significato. È ancora la pauradel mare dell’oggettività, che pure deve in qualche modo esserenavigato: se non in prima persona, almeno da una “distanza di si-curezza”, come vuole Blumenberg. Dovrebbe essere ormai chia-ro che la presenza segnalata da Barthes di elementi non riducibi-li al senso (che ricordano un po’ i già citati “dorsi di macigno” delgiardino zen di Palomar, o anche le pietre come “maestri muti”in Goethe41) è qualcosa di più del fantasma delle cose dietro leparole; lo stesso Barthes, quando riconosce che “toute descrip-tion littéraire est une vue” (al passato: non un vedere ma un avervisto, come si diceva della visio), sa benissimo che de-scrivere (dé-crire come dé-peindre) non è un tradurre dal vero alla copia, maun trasferire da un codice all’altro, da una scrittura all’altra: ope-razione in cui il reale è “remis plus loin”42. Questi irriducibili det-tagli sono allora una metonimia (il cui funzionamento consisteappunto non nel “realismo” del testo, ma nello spostamento dauna “rappresentazione astratta di una nozione astratta” alla “rap-presentazione astratta di un oggetto concreto”43) della necessaria,
Anche M. Tison-Braun, Poétique du paysage, Nizet, Paris 1980, p. 109, ri-prendendo alcune osservazioni di Lessing, avverte che l’introduzione delpaesaggio, ben lungi da marcare una semplice pausa narrativa, costituiscepiuttosto un’altra forma di racconto.
40 La struttura spazio-temporale del romanzo, che viene teorizzata anche sullabase della fisica relativistica in M. Bachtin, Voprosy literatury i estetiki, Iz-datel’stvo Chudožestvennaja literatura, Moskva 1975, trad. it. Estetica e ro-manzo, Einaudi, Torino 1979, pp. 231-405.
41 Il timore del silenzio dell’inorganico in Goethe è riferito da H. Blumenberg,Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1981, trad. it. La leggi-bilità del mondo. Il libro come metafora della natura, Il Mulino, Bologna1984, pp. 236-237.
42 R. Barthes, L’effet de réel, cit.43 A. Henry, Metonimia e metafora, Einaudi, Torino 1971, pp. 19 e ss. e p. 55.
Il perno essendo dato dalla contiguità fra esperienza estetica ed esperienzanormale: I.A. Richards, Principles of Literary Criticism (1926), nuova ed.Routledge, London 2001, trad. it. I fondamenti della critica letteraria, Ei-naudi, Torino 19762, pp. 11-12.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
31
inevitabile alterità del mondo rispetto al senso, e insieme dellosforzo di orientamento, di quella dinamica di spaesamento e ri-conoscimento – ma soprattutto disorientamento e orientamento –con cui il testo letterario guarda e conosce44. Sono la metonimiadel naufragio dello sguardo nelle cose, Maelström dal quale però,grazie alle proprie specifiche virtù, lo sguardo della letteratura(protagonista e insieme spettatore) sa uscire, proprio come il per-sonaggio del racconto di Poe.
Nell’organizzazione spaziale, periegetica, anziché temporaledel testo letterario, consiste allora la differenza tra partecipare eosservare sottolineata da Lukács, fra l’uomo che guarda critica-mente, per agire e non per essere agito: l’uomo interpretante45.Come bene compendia Hamon, il descrittivo, nel cooperare alracconto, ha stretta relazione con la percezione del discontinuo,dello “sbriciolamento sineddotico”, la cui risposta testuale è la“mise en cadastre du réel et du lexique”; da questa posizione si-tuata “un passo indietro”, la topografia può trasformarsi così inlogica, permettendo al testo lo spazio dell’interpretazione sia checi si confronti con la confusione del brouillage, sia che si possascandire una “separation étanche et logique”.
In questo modo la descrizione non costituisce più una deco-razione, ma una piega del racconto verso l’asse aspettuale, una“sequenza fluttuante di stasi” (come la chiama altrove Barthes)46
che vìola la linearità del discorso e restituisce libertà all’occhiodell’osservatore-lettore. Secondo Bachelard infatti “certe rêveriespoetiche sono ipotesi di vita che ampliano la nostra vita metten-doci in contatto con l’universo”, prospezioni necessariamente“cosmiche”, come si diceva, perché l’immagine poetica assimila ilreale e si fa “mondo dei mondi” nella misura in cui apre un al-trove nel qui: “i ricordi stessi si fissano in quadri d’assieme. Gli
44 Sono le parole usate da I. Calvino, Cibernetica e fantasmi, in Una pietra so-pra, cit., pp. 164-181, a p. 179, citando un saggio di H.M. Enzensberger,Strutture topologiche nella letteratura moderna.
45 G. Lukács, Narrare o descrivere?, cit., p. 276 e E. Turri, Il paesaggio come tea-tro, cit., p. 20.
46 R. Barthes, L’ancienne rhétorique (1970), trad. it. La retorica antica, Bom-piani, Milano 1972, p. 96.
Vincenzo Bagnoli
32
scenari sopprimono il dramma”47. È ciò che Calvino, poco dopole righe sopra citate, chiamava “ricostruire una continuità”, e chepermette agli stessi geografi di riconoscere alle humanae litteraela capacità, dilatando l’esperienza, di riassumere “preferenze,modi di organizzazione e conoscenze ambientali”: “l’arte in ge-nere e la letteratura in particolare, con la loro possibilità di rap-presentare in modo suggestivo le geografie personali, hanno la ca-pacità di porre ordine nel nostro caotico modo di vedere e per-cepire la realtà”, proprio perché grazie a questo “ampliamento”possono trasmettere “la consapevolezza […] del mondo che cicirconda”48. Su questo stesso registro Gargani, echeggiandoMann (che aveva definito la lingua l’“atmosfera del luogo”), permettere in guardia dalla tentazione umana di universalizzare il séscrive: “noi, il nostro linguaggio, siamo l’ispirazione del luogo edel tempo nel quale veniamo a trovarci”49. Si può accostare aquesta affermazione la voce di Glissant proprio per chiarire cheil senso di tale “respiro del luogo” non rimanda a una chiusuralocalistica o al genius loci, ma a una dinamica fra parte e totalità50.
È poi quanto sostiene Augé quando, discutendo del rappor-to fra “densità” e capacità di abbracciare il totale di vari tipi di di-scorso, definisce la localizzazione (il senso del luogo ma anche il
47 G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., pp. 15-20. Da un altro punto divista M.E. Blanchard, Description: Sign, Self, Desire, Mouton, Den Haag-Pa-ris-New York 1980.
48 F. Lando, Geografia e letteratura, cit., pp. 2-3 (ma anche pp. 6-7), dove si fariferimento a I.G. Cook, Consciousness and the Novel: Fact or Fiction in theWorks of D.H. Lawrence, in D.C.D. Pocock (a c. di), Humanistic Geographyand Literature. Essay on the Experience of Place, Croom Helm, London1981, pp. 66-84; l’introduzione dello stesso Pocock (pp. 9-19) poi tradottain italiano col titolo La letteratura d’immaginazione ed il geografo, in G. Bot-ta (a c. di), Cultura del viaggio. Ricostruzione storico-geografica del territorio,Unicopli, Milano 1989, pp. 253-262. Certo l’espressione “suggestivo” nonpare soddisfacente rispetto alle questioni tecniche del fare letterario; bastiper ora osservare che, nell’economia di questo discorso, si riferisce appuntoalla capacità del testo letterario di andare oltre la nuda datità, cioè non solodi cogliere le immagini del reale ma di costruirne, di immaginare.
49 A.G. Gargani, Sguardo e destino, cit., pp. 40-41. 50 È. Glissant, Introduction à une poétique du divers, Gallimard, Paris 1996,
trad. it. Poetica del diverso, Meltemi, Roma 1998.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
33
senso dell’oggi) come operazione critica, eseguita nella percezio-ne della contiguità e continuità, attraverso le relazioni e la pro-spettiva51. In questo senso i luoghi non sono contenitori chiusi,ma territori aperti che rimandano all’altro, attraverso collega-menti che non devono essere visti come connessioni magiche oanalogie suggestive, ma reticolati da accertare. Si può allora torna-re a Gargani e raccogliere il suo invito alla scrittura che guarda ilpaesaggio, il suo obiettivo essendo “non un mondo da descrivere,ma un’esistenza da criticare”: invito non distante dalla propostaavanzata da Jameson per un’arte che, in particolare davanti alle pe-culiari difficoltà conoscitive del postmoderno, deve proporsi come“cartografia cognitiva” dello spazio dell’esperienza umana. Pro-prio la modalità di visione-rappresentazione del paesaggio diventainsomma il segno di una sorta di “funzione civica”, secondo unnesso del resto già rilevato da Romagnoli a proposito della poesiadi Parini, calata nello spazio-tempo dall’immaginitiva fondata suquello che, secondo Turri, è lo scenario dell’acting sociale52.
Per questo la presenza del paesaggio non è solo fatto esteticoma, come si diceva, segno di una tensione fenomenologica, quin-di fatto poetico, conoscitivo (ed etico), guidando a una letturadella stratificazione di segni e di esperienze che sviluppa la dina-mica di una situazione (intesa proprio come atto del collocarsi), incui si intrecciano, e perciò si danno reciprocamente senso, i lega-mi emotivi individuali e la griglia dei significati condivisi, le per-cezioni e le rappresentazioni. Nella concezione riduttiva del let-tore moderno, nota Mary McCarthy, le ecphraseis sarebbero solodecorazione: “a chi importa il paesaggio? Quel che preme è la de-stinazione”. Eppure esse rientrerebbero, secondo la sua conce-zione del romanzo, tra le forme di commento (così come le
51 M. Augé, Pour une antropologie des mondes contemporaines, Aubier, Paris1994, trad. it. Storie del presente. Per un’antropologia dei mondi contempora-nei, Il Saggiatore, Milano 1997, pp. 49 e ss.
52 A.G. Gargani, Sguardo e destino, cit., pp. 7 e ss.; F. Jameson, Il postmodernoo la logica culturale del tardo capitalismo, Garzanti, Milano 1989, pp. 95 e ss.;S. Romagnoli, Spazio pittorico e spazio letterario da Parini a Gadda, in Il pae-saggio, vol. V: Storia d’Italia. Annali, a c. di C. De Seta, Einaudi, Torino1982, pp. 431 e ss.; E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., pp. 17 e 32 e ss.
Vincenzo Bagnoli
34
“idee”) che servono a dare profondità e distanza, costituendol’impalcatura del distanziamento critico, della relazione attore-spettatore che viene innescata dal testo letterario53. Si può a que-sto punto richiamare una memorabile pagina di Hermann Broch,nella quale lo scrittore austriaco risponde al dubbio che, facen-dosi “specchio di tutte le altre immagini del mondo”, l’opera let-teraria perda il diritto alla propria esistenza: indubbiamente il ro-manzo e la poesia, nel servirsi di tali immagini come dei “vocabolidella realtà”, in qualche modo divengono “funzione sociologicadel mondo circostante una funzione, d’altronde, di cui nessunaazione umana può essere priva”, ma altrettanto inevitabilmentesistemano queste immagini entro una propria sintassi. La lettera-tura dunque, proprio perché deve “abbracciare nella sua unità ilmondo intero”, “rispecchiare nella scelta dei vocaboli la cosmo-gonia del mondo” (il suo farsi, la struttura) diventa un’interpre-tazione: nell’immagine che restituisce, proprio grazie all’ampiez-za, “deve lasciar trasparire l’infinità della volontà etica”54.
4. Lo sguardo e lo stile: dall’“io” al “qui”
Ritornando così allo specifico della letteratura, per chiederciquindi non cosa essa dia alla geografia, ma cosa al contrario l’e-lemento geografico-paesaggistico rappresenti nel testo letterario,si può capire perché la descrizione di tali “quadri d’assieme”non sia accessoria: proprio perché congiunge i personaggi al-l’habitat, all’ambiente, attraverso un processo di articolazioneche si sviluppa nella scansione dello sguardo come una sorta di
53 M. McCarthy, Ideas and the Novel, Weidenfeld & Nicholson, London 1981,trad. it. Il romanzo e le idee, Sellerio, Palermo 1985, pp. 22-24. Cfr. J. Sta-robinski, Stendhal pseudonyme, in L’œil vivant: Corneille, Racine, Rousseau,Stendhal, Gallimard, Paris 1981, trad. it. L’occhio vivente: studi su Corneille,Racine, Rousseau, Stendhal, Freud, Einaudi, Torino 1975, pp. 181 e ss., sultema di un “effetto di finzione” opposto all’“effetto di realtà” come viola-zione dell’asse evenemenziale.
54 H. Broch, Das Weltbild des Romans (1933), in Dichten und Erkennen. Es-says, Rhein, Zürich 1955, vol. I, pp. 211-238, trad. it. L’immagine del mondonel romanzo, in Il Kitsch, Einaudi, Torino 1990, pp. 61-101, a p. 97.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
35
“metonimia diffusa”. Essa opera tanto nello schema somma/det-taglio della successione propositio/narratio e propositio/argu-mentatio (o più modernamente tema/rema)55, dove – nello svi-luppo attorno a un’idea-nucleo delle articolazioni – è chiaro il“concatenarsi di un fenomeno della realtà con le realtà che la cir-condano”, quanto nelle altre cadenze della argumentatio che ani-mano l’evidentia quale forma di “accumulazione concretizzantecon funzione specificativa di dettagli”, dove lo scindersi (diere-si) dell’immagine nell’enumerazione di immagini parziali pre-senta la stessa semantica56. I temi danno luogo a espansioni pre-dicative che descrivono il mondo allargando il campo, includen-do dettagli, realizzando nel loro stesso sviluppo quel movimentoche è elemento essenziale del raccontare (non semplicementecome sviluppo della trama, ma come sussistere stesso del testoletterario in “profondità e prospettiva”57) e fondativo del pro-cesso semantico del linguaggio58, nonché, come ha notato ungeografo, attento lettore anche di testi letterari, è il principalevettore di costruzione spaziale59.
In una “poetica dello spazio” il movimento, che è certo attitu-dine alla conoscenza, è anche la sostanza della rappresentazione, inquanto essa è movimento anamorfico: nell’un caso e nell’altro (nelpercorrere e nel disporre, nell’abitare e nel rappresentare lo spazio)l’occhio si muove secondo le contiguità metonimiche. Nella dina-mica della significazione il testo si istituisce dunque, oltre che cometempo, come spazio, ben di là dal limite fisico delle pagine, comeorizzonte che il lettore è portato a condividere.
55 In proposito si veda E. Cassirer, Linguaggio e mito, Garzanti, Milano 1975,p. 19, per il quale il linguaggio scandisce il mondo in “oggetti e processi”, innomi e verbi.
56 H. Lausberg, Elementi di retorica, cit., pp. 123-127 e 196-198.57 M. McCarthy, Il romanzo e le idee, cit.; ovviamente ciò vale quindi non solo
per il romanzo.58 A. Henry, Metonimia e metafora, cit., pp. 26 e ss.59 Ph. Hamon, Cos’è una descrizione, cit., p. 68. I. Calvino, Introduzione a E.
Cavazzoni, Esplorazioni, cit., p. 12; F. Farinelli, Il labirinto anfibio: RiccardoBacchelli e gli scenari padani, in AA.VV., Discorrendo di Riccardo Bacchelli,Ricciardi, Milano-Napoli 1966, pp. 355-364, che a pp. 359 e ss. rimanda aH. Lefebvre, La produzione dello spazio, 2 voll., Moizzi, Milano 1976.
Vincenzo Bagnoli
36
Che la letteratura abbia la capacità di costruire spazi, nello spe-cifico spazi comuni, è abbastanza noto, ma non intendo riferirmialla semplice mobilitazione delle istanze emotive e ai riti di coesio-ne. La sua possibilità di realizzare la “condivisione di un luogo co-mune” passa infatti attraverso l’intersoggettività della ragione, ben-ché – per il suo carattere appunto “tensionale” – sia una ragionenon meramente strumentale, ma coniugata al desiderio60. E se lascrittura fondante del nostro spazio contemporaneo è dunquequella filosofico-scientifica, tuttavia lo strumento principale di con-divisione è l’immagine, alla quale è affidato il compito di “comuni-care”, inteso appunto come rendere comune lo spazio di significa-ti61. Risultano allora più chiare le parole di Stevens (che fanno ecoper certi versi a quelle di Bachelard), per le quali l’immaginazioneè una estensione della realtà, allo stesso modo in cui la “finzione su-prema” della poesia deve con le sue caratteristiche reinventare ilmondo che c’è, semplicemente trovandone la “pronuncia” (ossia ladicibilità), in un fluido scambio tra mondo e “retorica”62. Il pae-saggio letterario, giova ripeterlo, è sempre una rappresentazione,non soltanto perché si serve di segni, ma anche perché non ripro-duce una natura, bensì una costruzione dell’uomo: un ambienteculturale63.
Lukács, preso come tanti altri nel secolo scorso dal sacro fuo-co della prosa, ascrive al solo romanzo la possibilità di “ricostruire
60 R. Ronchi, Luogo comune. Verso un’etica della scrittura, Egea, Milano 1996,p. 23.
61 Per una rassegna dei problemi semiologici sulla natura del luogo comune siveda G. Marrone, Luoghi comuni. Un’ipotesi semiotica, in N. La Fauci (a c.di), Il telo di Pangloss. Linguaggio, lingue, testi, L’epos, Palermo 1994.
62 Si veda l’intelligente scritto di M. Bacigalupo, Un cittadino del cielo eppuredi Roma, posto in apertura di W. Stevens, Il mondo come meditazione,Guanda, Parma 1998, pp. 11-20.
63 A proposito di questa ambiguità F. Farinelli, L’arguzia del paesaggio, in Il di-segno del paesaggio italiano, a c. di V. Gregotti, in «Casabella», 1991, 575-576, pp. 10-12. Nota opportunamente come in Humboldt la parola designila cosa e insieme la sua rappresentazione. Ma si sconfina di nuovo nell’an-tropologia: cfr. C. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, NewYork 1973, trad. it. Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 19982, pp.9-45; V. Turner, The Anthropology of Performance, Paj, New York 1986, trad.it. Antropologia della performance, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 145-183.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
37
la totalità della vita per mezzo dell’atto figurativo”, ricomponendola “disordinata molteplicità” della seconda natura, vale a dire lasfera delle “concrezioni sociali”, né materia né senso. Alla poesiapuò competere, per lui, la prima natura, la cui qualità percettibile(benché a propria volta estranea al senso) può servire alla lirica, chene ignora ogni autonoma sostanza, come strumento sensibile per la“proiezione di un’interiorità”, come materiale per il mito simboli-co della soggettività sostanziale; la sua concretezza si illumina quin-di, solo perché un soggetto la sfrutta per scrivervi un senso, unicoe indelebile. Pare molto interessante l’idea di una plasticità sensi-bile conservata nel linguaggio proprio dalle caratteristiche fenome-niche di questo (sonore prima di tutto, come suggerisce una rifles-sione su verso tragico e verso epico che precede di poco queste pa-gine, ma anche visive), se non fosse che nella prospettiva di Lukácsessa rende la rappresentazione letteraria della natura solo “proie-zione” di uno “stato d’animo”. La percezione atmosferica dellacomplessità molteplice si risolve in sensazione, Stimmung; tutto ilresto, la varietà dei dettagli, avverte il critico, si riduce al “pittore-sco bugigattolo” stipato di simboli della “poesia della natura”64.
Indubbiamente, messa opportunamente da parte l’epica,Lukács sembra essere nel giusto a proposito di buona parte dellalirica. Eppure sembra propria della poesia anche un’attenzione fe-nomenologica al paesaggio, alla percezione spaziale, che sceglie,contro lo sfumato, un’esattezza che non è realismo, che riconoscenello spazio del testo la necessaria presenza di una irriducibile al-terità. Hamon addirittura nota una “parenté de fond entre poésieet description”65, proprio per il maggior rilievo che in essa assumequel diverso livello rispetto a récit e flusso temporale, che nel ro-manzo si addensa nella descrizione. Leopardi, per anticipare ciòche si avrà agio di vedere poi, nelle sue ultime poesie usa anzi la na-tura (una rappresentazione culturale della natura) per distruggerei miti, anche quelli che Maurron chiamava i miti personali. Apre ilproprio sguardo per costruire, grazie alle risorse specifiche del lin-guaggio, una sorta di “proiezioni cartografiche” a partire dal pro-
64 G. Lukács, Teoria del romanzo, cit., pp. 55 e ss.65 Ph. Hamon, Introduction a La description littéraire, cit., p. 10.
Vincenzo Bagnoli
38
prio ideîn, con cui delineare terreni condivisi: ciò si realizza nel cor-po del testo, dove l’intertestualità fortissima dimostra questo suo“guardare lo sguardo” dell’altro, costruendone, per così dire, rap-presentazioni cartografiche.
È evidente, in prospettive testuali di questo genere, un parteci-pare allo spazio che è teso a implicare il lettore, il testo prevedendo-ne lo sguardo, prospettandolo. Se però identificazione, intreccio emimesi, com’è stato notato, sono tutti strumenti di posizionamentonel testo, altrettanto importante pare la funzione dello spaesamento,che Proust descrive come primaria nell’esperienza della lettura. Èuna vertigine puntiforme che può cogliere davanti alla non ricono-scibilità del linguaggio stesso (l’effetto dello straniamento), ma che èconnessa al successivo riconoscimento: in questo processo disegna ilqui a partire dal quale si dà la sostanza etica del testo. Il parallelo diidentità e alterità si misura infatti sul paradigma di un asse più am-pio, metonimico, né l’io individuale né d’altro lato le ascisse e ordi-nate dello spazio neutro, ma – proprio in quanto è orientamento – apartire dalle posizioni relative dello spazio all’interno del testo: sini-stra e destra, alto e basso, davanti e dietro66. Non si può fare a menodi pensare, a proposito del qui, al carattere spaziale di quelle “unitàoggettive” come sorta di “nodi”, nuclei di addensamenti e aggrega-zioni (e quindi di senso) nel continuum percettivo indicate da Cassi-rer, il quale richiama poi alcune riflessioni heideggeriane sulla so-stanza spaziale del dato materiale: lo spazio (il “momento della spa-zialità”) identifica insomma la forma dell’oggetto, e nel caso dei te-sti di paesaggio definisce quindi la forma del mondo, le cui possibili“espressioni” sono date dalle direzioni dello spazio. Proprio la con-cretezza del corpo come sede della percezione è il segno dell’“esse-re al mondo”, anzi la stessa “modalità di attuazione del mondo”67.
66 Cfr. I. Calvino, Dall’opaco, in «Adelphiana 1971», Adelphi, Milano 1971, pp.299-311, ora in La strada di San Giovanni, Mondadori, Milano 1995, pp. 97-110, in part. pp. 99-102. Sul paesaggio come struttura di spazio “orientata”cfr. J. Starobinski, Paysages orientés, in R. Zorzi (a c. di), Il paesaggio. Dallapercezione alla descrizione, Marsilio, Venezia 1999, pp. 57-72, in part. p. 66,dove si richiama anche l’etica del descrivere contro la retorica dell’ineffabile.
67 E. Cassirer, Philosophie der Symbolischen Formen, 4 voll., Cassirer, Berlin1923-1929; trad. it. Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
39
Il sé diventa in questo modo una combinatoria di esperienze,una sorta di mappa multiprospettica, quale si trova in forma ele-mentare nella maniera dei cubisti, il cui corrispettivo testuale puòessere considerato Cortège di Apollinaire, dove l’io del poeta eanzi il suo stesso corpo, vanamente atteso come figura individua-le, si presenta invece sotto forma di insieme di dettagli:
Le cortège passait et j’y cherchais mon corpsTous ceux qui survenaient et n’étaient pas moi-mêmeAmenaient un à un les morceaux de moi-êmeOn me bâtit peu à peu comme on élève une tourLes peuples s’entassaient et je parus moi-mêmeQu’ont formé tous les corps et les choses humaines68.
Sulla stessa linea, ma in modo più preciso, Calvino poteva su-perare il confronto con il “mare dell’oggettività” e replicare ai ti-mori di chi vedeva, nel tendere alla moltiplicazione dell’opera let-teraria, un allontanamento da “quell’unicum che è il self di chiscrive”, rilevando come ogni vita costituisca una enciclopedia eun labirinto, e rilanciando anzi, sulle orme del suo Palomar, unavia per trovare la stevensiana “pronuncia del mondo”:
… magari fosse possibile un’opera concepita al di fuori delself, un’opera che ci permettesse d’uscire dalla prospettiva li-mitata d’un io individuale, non solo per entrare in altri io si-
1984-1988, vol. III, t. 1, pp. 189-215: in queste pagine viene esposta la sua Fe-nomenologia della conoscenza, dove alla “filosofia della natura”, che tentereb-be di interpretare l’esistente in chiave spiritualista, viene sostituita una “filo-sofia della civiltà”, consapevole di confrontarsi sempre con produzioni intel-lettuali scaturite però dal dato materiale. Si veda poi G. Bertone, Lo sguardoescluso. L’idea di paesaggio nella letteratura occidentale, Interlinea, Novara1999, pp. 17-18: se la vista restituisce la distanza, nel testo la percezione epi-dermica del clima (il senso non solo dell’atmosfera ma, fino alla scoperta del-le coordinate moderne, della posizione) è il segno della contiguità-continuità.
68 “Il corteo passava io vi cercavo il mio corpo / Tutti quelli che sopraggiun-gevano e non erano me / Portavano uno a uno i pezzi di me stesso / A pocoa poco fui costruito come s’innalza una torre / I popoli si ammassavano e ioapparvi / Formato da tutti i corpi e le cose umane”, in G. Apollinaire, Al-cool, Calligrammi, trad. di L. Frezza, Mondadori, Milano 1986, p. 77.
Vincenzo Bagnoli
40
mili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola, l’uc-cello che si posa sulla grondaia, l’albero in primavera e l’albe-ro in autunno, la pietra, il cemento, la plastica… Non era for-se questo il punto d’arrivo cui tendeva Ovidio nel raccontarela continuità delle forme, il punto d’arrivo cui tendeva Lucre-zio nell’identificarsi con la natura comune a tutte le cose?69
La “forma io” dell’arte diventa perciò tecnica di gestione del-l’esperienza, schema di simboli interpretabili dal lettore più cheforma dell’esperienza stessa, sfumando non in un “noi” (il farcentro sul quale espone sempre al rischio di censurare l’alterità eassolutizzare il parziale) ma in un “qui”, la cui parzialità-lateralitàè evidente: il “qui” del mondo che guarda il mondo e ne dispie-ga l’articolata, irrisolvibile complessità.
Ma non è un guardare il mondo, si è detto, perché le paroleguardano gli sguardi, non le cose, come a suo modo notava già Ri-chards introducendo appunto una nozione di “orientamento” im-portante nello stabilire il rapporto fra pensieri, parole e cose; ilmondo stesso è anzi costituito dall’insieme delle nostre “ammira-zioni”70. Il situarsi dello sguardo nel testo come sguardo sulla mol-teplicità degli sguardi nel mondo, che deve prevedere anche losguardo dei lettori, ricorda il modello registico71. Come nel teatro ilpalcoscenico diventa “testimonianza dell’attività riflessiva”, unasorta di specchio dell’agire umano nel mondo entro uno spazio, chedal Cinquecento in avanti è lo spazio geometrico formalizzato poi
69 I. Calvino, Lezioni americane, cit., p. 135.70 C.K. Ogden, I.A. Richards, The Meaning of Meaning. A Study of the In-
fluence of Language upon Thought and of the Science of Simbolism, Routled-ge & Kegan Paul, London 1923, trad. it. Il significato del significato. Studiodell’influsso del linguaggio sul pensiero e della scienza del simbolismo, Il Sag-giatore-Garzanti, Milano 19752, pp. 35 e ss.; G. Bachelard, La poetica dellarêverie, cit., p. 204.
71 Un esempio è la teatrale “forma del mondo” fatta di “tanti balconi che irre-golarmente s’affacciano su un unico grande balcone che s’apre sul vuotodell’aria” di I. Calvino, Dall’opaco, cit., p. 97. Lo sguardo registico è carat-teristico della narrativa “postmoderna” italiana secondo G.P. Biasin, Fram-menti di geografia romanzesca, in D.S. Cervigni (a c. di), Italy 1991. The Mo-dern and the Postmodern, in «Annali di Italianistica», North Carolina Uni-versity Press, Chapel Hill 1991, vol. IX, pp. 168-181.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
41
da Cartesio, la partecipazione al paesaggio (come teatro) in lettera-tura va ben oltre la sua presenza come fondale, e chiama in causa iprocessi di autointerpretazione dell’uomo (ancora una volta spazia-li, quindi, non solo temporali)72, spettatore e attore al tempo stessonell’atto di estraneazione o “allontanamento” generato proprio dal-la concentrazione visiva della descrizione esatta, mai assorta73. Que-sto guardare gli sguardi, che realizza il “mondo di mondi”, con-traddistingue in letteratura una predisposizione fenomenologica(un “occhio filosofico”) compresa, a voler servirsi di facili emblemi,fra la perplessità sistematica del signor Palomar di Calvino e il “pen-sare la realtà percepita” come “pensare di vedere il meccanismo del-lo sguardo” dell’uomo barbuto nella Diottrica di Cartesio: il qualeguarda con l’occhio di un cadavere, cioè guarda il processo delguardare, e vede non il vedere – aggiungo – ma l’aver visto, non unavisione ma la veduta74. E proprio questa “osservazione dell’atto stes-so dell’osservare” è ciò che Searle chiama “l’accesso soggettivo (insenso ontologico) alla realtà oggettiva”, un’ultima (forse) scialuppaa fronte del naufragio nel “mare dell’oggettività”75.
72 Significativa, credo, l’omologia tra lo spazio della “scena politica” e lo spa-zio del palcoscenico di Machiavelli; cfr. E. Raimondi, Politica e commedia, IlMulino, Bologna 19992; E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., pp. 30, 32 ess. e 37: il paesaggio sarebbe una sorta di “metacommento”. Sui rapporti fralo spazio cartesiano e quello empirista si veda E. Cassirer, Filosofia delle for-me simboliche, cit., vol. I, pp. 192 e ss.
73 I. Calvino, Lezioni americane, cit., pp. 73-75 propone l’esempio del Mon-sieur Teste di Valéry accanto a Leopardi. Qualcosa di analogo alla celebremetafora di H. Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Da-seinmetapher, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1979, trad. it. Naufragio con spet-tatore. Paradigma di una metafora dell’esistenza, Il Mulino, Bologna 1985,ma con altro tipo di distanza, che non è “distanza di sicurezza”.
74 Dioptrique (1637), Discours cinquième, in Œuvres de Descartes, Levrault, Pa-ris 1824-1826, pp. 42 e ss. e fig. 14, trad. it. Diottrica, in Opere scientifichedi René Descartes, Utet, Torino 1983, vol. II; G. Bertone, Lo sguardo esclu-so, cit., p. 38. Con altre parole M. Merleau-Ponty, Il corpo vissuto: l’ambi-guità dell’esistenza, la riscoperta della vita percettiva, la carne del mondo, dal-le prime opere a “L’occhio e lo spirito”, Il Saggiatore, Milano 1979, pp. 208-214, osserva che nella pittura si hanno “l’iconografia” e “la filosofia figura-ta” della visione: piuttosto che “vedere il quadro” si vede “con il quadro”.
75 J.R. Searle, The Rediscovery of the Mind, MIT Press, Cambridge (MASS.) 1992,trad. it. La riscoperta della mente, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 113.
Vincenzo Bagnoli
42
In questo equilibrio tra partecipazione e osservazione, ossia iltenersi a distanza critica per interpretare, la capacità di “immagi-nare” della parola (al tempo stesso mansarda e “volet” chiusa, “col-le” e “siepe”), in grado – come si è visto – di trasformare il suonoin immagine76, costituisce lo strumento decisivo. In particolare è“la fondazione di uno stile”, proprio in quanto “modo di guardare”dal momento che stabilisce con “rigore” lo “spazio poetico” di untesto, la premessa necessaria perché la parola letteraria possa vede-re davvero: il che significa non solo descrivere e rappresentare, maconfrontarsi con un’epoca-ambiente prospettando per la sua com-plessità “gnoseologico-culturale” non solo scorci e “vedute”, mauna ricomposizione di queste in una “mappa” che sia “la più am-pia e particolareggiata possibile”, ossia “un’immagine cosmica”77.
5. Il paesaggio e la sua mappa: il sorriso della musa
Lo stile è dunque ciò che garantisce la possibilità di produrre(e riprodurre) autonomamente immagini attraverso le parole; talefacoltà diventa essenziale dopo il Cinquecento, quando è ancorapiù urgente vedere anche ciò che non sarebbe visibile78. Se la ca-
76 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., pp. 20-24, dove è riassunta suggestiva-mente la trasformazione da una spazialità sonora della parola (la sua riso-nanza) a quella visiva attraverso la scrittura, la riproducibilità tecnica. Si ve-dano anche W.J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word,Methuen, London-New York 1982, trad. it. Oralità e scrittura, Il Mulino,Bologna 1986; M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typo-graphic Man, University of Toronto Press, Toronto 1962, trad. it. La galassiaGutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, Armando, Roma 1984; E.A. Ha-velock, Preface to Plato, Oxford University Press, Oxford 1963, trad. it. Cul-tura orale e cultura della scrittura: da Omero a Platone, Laterza, Roma-Bari1973, ivi citati, cui si aggiunga H. Blumenberg, La leggibilità del mondo, cit.e soprattutto E.L. Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Eu-rope, Cambridge University Press, Cambridge 1983, trad. it. La rivoluzionedel libro. L’invenzione della stampa e la nascita dell’età moderna, Il Mulino,Bologna 1995, in part. pp. 55 e ss.
77 I. Calvino, La sfida al labirinto, cit., pp. 89 e 96-97. Cfr. anche J. Starobin-ski, Paysages orientés, cit., p. 157.
78 I. Calvino, La sfida al labirinto, cit., p. 93; sulla compositio loci in Loyola si
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
43
pacità di creare immagini e ambienti sta al centro degli Esercizi diLoyola, tale procedimento non contrasta e anzi affianca la scienza,alla quale fornisce non solo stimoli ma soprattutto, nell’integrazio-ne di due qualità espressive, la possibilità di superare gli schemi79.Va allora preso in considerazione l’elogio rivolto da Carl GustavCarus a Goethe e Humboldt per aver concepito un’arte come cul-mine della scienza, culmine nel quale sono accostate la poesia e untipo di resoconto preoccupato di risolversi non in prosa artistica,ma nell’esattezza dello stile80, piuttosto che il Paesaggio interioredel McLuhan interprete della poesia inglese, nel quale, come av-verte Raimondi, suona troppo facile, e quindi falsa, l’analogia fral’ottica di Newton e le strutture percettive e linguistiche dell’im-magine paesaggistica, con la conseguente identificazione fra la na-tura e il linguaggio del poeta. In questa analisi, infatti, “tanto più sevi si aggiunge il contrasto quasi escatologico di oralità e grafema”,l’isomorfismo finisce col ricadere ancora verso la mera antropo-morfizzazione del mondo, quando invece i tratti essenziali dell’af-fiancarsi di scienza e letteratura consistono nella correlazione dellaforza immaginativa della letteratura stessa con la logica dei propriparadigmi (anche quella topografica chiamata in causa da Hamon),nella “riduzione problematica del soggetto”, nello spostamento dellinguaggio verso una facoltà descrittiva fenomenologica81.
Si è già visto, a livello delle dinamiche testuali, come il fun-zionamento della descrizione, pur chiamando in causa un conte-
veda anche M. Perniola, Del sentire cattolico. La forma culturale di una reli-gione universale, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 110 e ss.; cfr. inoltre R.Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Editions du Seuil, Paris 1971, trad. it. Sade,Fourier, Loyola, Einaudi, Torino 20012, pp. 38 e ss.
79 I. Calvino, Lezioni americane, cit., pp. 98 e ss. e Id., Due interviste su scien-za e letteratura, in Una pietra sopra, cit., pp. 184-191. Su Galilei, A. Battisti-ni (a c. di), Galileo e i gesuiti: miti letterari e retorica della scienza, Vita e pen-siero, Milano 2000; sulla geografia, quasi con le stesse parole di Calvino, F.Lando, Fatto e finzione, cit., pp. 3-4.
80 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., pp. 40-41; A. von Humboldt, Quadridella natura, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1998, p. 3.
81 E. Raimondi, La strada verso Xanadu, in Scienza e letteratura, Einaudi, Tori-no 1978, pp. 33 e 13; il riferimento è a E. McNamara (a c. di), The InteriorLandscape. The Literary Criticism of Marshall McLuhan 1943-1962, McGraw-Hill, New York 1969, trad. it. Il paesaggio interiore, SugarCo, Milano 1994.
Vincenzo Bagnoli
44
sto, non rimandi all’extratestuale. Si può allora concludere allostesso modo con Calvino, che l’esito di un incontro di scienza eletteratura in questo immaginare stia nella costruzione di uno sti-le, alla maniera di una teoria scientifica (al centro della quale èsempre un theaomai), ossia, com’è oggi ritenuto corretto, un’ipo-tesi di mondo, non nella possibilità di “fotografare” un paesag-gio. Come ricorda opportunamente Foucault, il risultato di que-sto processo, l’immaginario moderno,
si inserisce tra il libro e la lampada… non lo si attinge più dal-le incongruità della natura; lo si attinge all’esattezza del sape-re […]. Non c’è altro che il rumore assiduo della ripetizioneche possa trasmetterci quello che può accadere una sola volta.L’immaginario non lo si costituisce contro il reale per negarloo compensarlo, si stende tra i segni, da libro a libro, nell’in-terstizio delle ripetizioni e dei commentari; nasce nell’interca-pedine dei testi. È un fenomeno da biblioteca82.
Perciò, ritornando al problema dei riferimenti extratestuali, eservendosi di un altro emblema della sospensione tra realtà e fin-zione, si può osservare che “la realtà di Don Chisciotte non è nelrapporto tra parole e mondo, ma nella tenue e costante relazioneche i segni verbali intrecciano da sé a sé”: dopo che la “finzione del-le epopee” (che erano state capaci, secondo Lukács, di configurareuna “totalità vitale”) si è condensata nel potere rappresentativo dellinguaggio, “le parole si sono chiuse sulla loro natura di segni”, ac-quisendo tuttavia la possibilità di ricostruire in un altro piano laloro verità83. Se questo da un lato richiama la “mnemotecnica delbello” di Baudelaire, dall’altro vi accosta anche il metodo della si-
82 M. Foucault, Scritti letterari, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 137 e ss. 83 Id., Les mots et les choses, Gallimard, Paris 1966, trad. it. Le parole e le cose,
Rizzoli, Milano 19983, p. 63; G. Lukács, Teoria del romanzo, cit., p. 53. Èquanto osserva anche W.J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della paro-la, cit., pp. 186-189, a proposito della “chiusura” del testo e della sua spa-zializzazione indotta dalla stampa, dalla quale a suo avviso deriva l’idea cheil testo non possa nascere dall’esperienza diretta e si genera il fenomeno del-l’intertestualità.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
45
nossi lachmaniana84 alla base della progressiva testualizzazione delmondo, almeno (è ciò che qui importa) nell’opera letteraria.
È proprio questo continuo movimento (anamorfico, come si èdetto) a conservare l’attitudine alla conoscenza, la letteratura costi-tuendosi attraverso la sua finzione come “conoscenza della cono-scenza”. Infatti “il linguaggio possiede una sua physis autonoma ri-spetto alla realtà”, non è semplice simbolizzazione né mondo a par-te85: come la mappa, rimanda a un altrove ma non ne è l’immaginespeculare, la mimesi, bensì un’interpretazione, con qualcosa dipiù86. La specificità del discorso letterario rispetto a quello scienti-fico sta infatti nel suo organizzarsi sulla scala dei “valori”, senzaperò che questo comporti un’immediata applicazione al “compor-tamento pratico”, che può darsi solo attraverso “interpretazioni”,ossia letture e attraversamenti. La visività implicita nell’immaginaredel linguaggio fa sì che esso abbia come caratteristica una continuatensione, un tendere verso ma appunto mai fino a toccare, mante-nendo un “distacco” che è caratteristico dell’“osservare” rispetto al“partecipare” (anche quando sia un “osservar partecipando”, una“contemplatività nell’azione” o un’“azione sospesa”)87.
Si possono insomma mettere da parte tanto i pregiudizi pri-mitivi contro le rappresentazioni-falsificazioni (quali traspaiononella censura platonica) quanto le ansie postmoderne sulla totalesostituzione della rappresentazione al rappresentato: il senso in-fatti di questa prospettiva della letteratura, di questa sua partico-lare funzione (o modo di funzionare) non è trovare una verità, maprogettarla, come del resto fa, non solo una teoria scientifica, ma
84 Com’è stato acutamente fatto da G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., p. 49.85 L. Tassoni, Finzione e conoscenza, Lubrina, Bergamo 1989, p. 9; G. Genet-
te, Finzione e dizione, cit., pp. 28 e ss.86 L’idea della mappa come interpretazione in F. Farinelli, Omologie geografi-
che, inferenza, analogia: l’Atlante del Marinelli e l’origine dei Tipi, in A. DeBlasi (a c. di), Validità e attualità dell’Atlante dei Tipi Geografici di OlintoMarinelli, Università di Catania, 1988, pp. 125-128. Per quanto riguardal’attitudine del testo letterario come “mappa del mondo e dello scibile” nel-la letteratura italiana rimando nuovamente alle già citate pagine di I. Calvi-no, Due interviste, cit., pp. 187 e 190 e ss.
87 H. Blumenberg, Naufragio con spettatore, cit., pp. 89 e ss.; G. Baldissone, Gliocchi della letteratura. Miti, figure, generi, Interlinea, Novara 1999, pp. 23-28.
Vincenzo Bagnoli
46
la stessa opera d’arte. La “capacità ‘costruttiva’” del testo, che nonsi limita alla sua organizzazione architettonica (quella che si puòchiamare la sua architettura interna), diventa quindi una forma dispazializzazione dell’esperienza (la stessa che fa parlare Lowenthaldi un “paesaggio della memoria, del ricordo”): non è quindi un ri-produrre, ma un produrre il mondo88. La figuratività della lingua,ciò che Pierre Ouellet chiama “imagerie verbale” costituisce dun-que una sorta di logica di una filosofia sensibile89. Senza tali im-magini, del resto, finiremmo per non vedere il mondo, o almenoper averne un’immagine inadeguata, così come l’uomo senza cul-tura è destinato secondo l’antropologia di Geertz a rivelarsi nonun “buon selvaggio”, ma un guazzabuglio pulsionale privo di fini.
Il “senso del luogo” è dunque proprio la percezione condivi-sa di una organizzazione spaziale che gli stessi geografi ricercanonei testi letterari, tanto nella fruizione tattica quanto anche, graziealla dilatazione operata dalla metonimia diffusa della prospettivaletteraria, nel suo uso strategico, ossia consapevolmente proget-tuale. In ciò appunto la rappresentazione linguistica conserva unmargine di operatività, una capacità di modificare (non magico-persuasiva) l’ambiente. “L’uomo della rêverie”, secondo Bache-lard, “è sempre nello spazio di un volume. Abitando veramente eriempiendo tutto il volume del proprio spazio, l’uomo della rêve-rie è dovunque nel proprio mondo”: si potrebbe dire, aggiungequindi, che “lo spazio in cui è immerso il sognatore è un ‘media-tore plastico’ tra l’uomo e l’universo”90. In questa zona intermediasi ha la doppia malleabilità sincronica di mondo e uomo.
La realizzazione di questo spazio per lo sguardo, nel quale sipuò essere dentro e fuori al tempo stesso, rimanda ad altri mo-delli conoscitivi: vale a dire al teatro91, il luogo del theaomai dovesi svolge il play, e al gioco stesso. Il gioco è uno spazio di transi-
88 G. Contessi, Il luogo dell’immagine: scrittori, architettura, città, paesaggio,Lubrina, Bergamo 1989, p. 28; D. Lowenthal, Past time, present place: land-scape and memory, in «The Geographical Review», 65, 1975, pp. 1-36.
89 P. Ouellet, Poétique du regard. Litérature, perception, identité, Editions duSeptentrion, Sillery (Québec) 2000.
90 G. Bachelard, La poétique de la rêverie, cit., pp. 180-181.91 E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., pp. 40 e ss.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
47
zione, in cui si confrontano la realtà psichica e la realtà esterna,un terreno intermedio che permette l’esplorazione della realtàesterna e la definizione di quella interna; risultando da un siste-ma simbolico di significati, all’incontro fra una cultura privata epubblica, le sue regole fungono da confini, dai quali si può inqualsiasi momento uscire92. L’immagine letteraria realizzata attra-verso la parola è in effetti una finzione, una fictio (come nella fic-tion), che però rimanda al factus, al senso di un fare: il poieîn del-la poiesis è proprio questo. In essa “vi è un elemento di gioco, unfare o, almeno, una simulazione del fare”, cui è affidato il compi-to di evitare il “circolo della volgarità”, secondo la McCarthy, os-sia l’equivoco arte-vita in cui incorre sovente il romanzo93.
La geografia disegnata dalla mnemotecnica del bello non èperò solo promise de bonheur, confinata all’outopia e quindi allamenzogna, ma proprio nella sua capacità di progettare luoghicome territori di giunzione (fra dentro e fuori, fra qui e altrove,fra i tempi diversi dello scrivente e del lettore ecc.) e itinerari diattraversamento, ha un continuo irrinunciabile rimando al reale:proprio in questo il paesaggio immaginato dalla letteratura puòdirsi mappa, su una scala diversa94. Lotman nota una similitudi-ne e una differenza fra gioco e opera d’arte, che condividono un“comportamento ludico”, ma si distinguono per il fatto che nellaseconda la convenzionalità si unisce a un aspetto diverso: l’artenon si limita infatti a tradurre la conoscenza in azione, come fa ilgioco organizzando il comportamento, ma organizza la stessa lo-gica conoscitiva come fa la scienza95. La ragione è presente: c’è un
92 R. Caillois, Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige, Gallimard, Paris1967, trad. it. I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Bompiani, Mi-lano 1981; J. Huizinga, Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-ele-ment der cultuur, Tjeenk Willink, Haarlem 1938, trad. it. Homo ludens, Ei-naudi, Torino 1946.
93 M. McCarthy, Il romanzo e le idee, cit., p. 53.94 Sulla mappa cfr. F. Lando (a c. di), Fatto e finzione, cit., pp. 11-12; sulla di-
mensione del progetto cfr. Contessi, Il luogo dell’immaginazione, cit., p. 31.95 J.M. Lotman, La struttura del testo poetico, cit., pp. 79-89, in part. p. 89: “I
modelli artistici sono l’unione, unica nel suo genere, di un modello scienti-fico e di un modello ludico […]. Il gioco in confronto con l’arte è senza con-tenuto; la scienza, senza azione”.
Vincenzo Bagnoli
48
cogito che richiede al linguaggio una qualità particolare nella suanecessaria stratificazione e complessità, consistente per Richardsnel ricorso a condizioni di comunicabilità. Come il simbolo dellamappa, deve essere trasparente al lettore non verso il mondo, maverso una “lettura del mondo”, e deve avere anche qualcosa dipiù96.
Questa capacità progettuale, architettonica è affidata allaqualità visiva del linguaggio: non si intende con ciò solo un pre-dominio del visivo nelle opere letterarie che, a partire dall’orazia-no ut pictura poiesis, riflette semplicemente una specificità del-l’essere umano97, ma il particolare rapporto di somiglianza tra leparole e lo sguardo, come suggerisce fra gli altri Giusi Baldisso-ne. La vista è il senso della tensione verso e oltre (anche oltre ilvuoto o l’ostacolo), senza coinvolgere un contatto fisico; come lavista, il linguaggio tende verso le cose ma non le raggiunge, pro-duce immagini ma non approda alla materia, a differenza dellaplastica, e tuttavia mantiene costante tale tensione, sul filo dell’o-rizzonte e oltre, né si ferma davanti all’ostacolo98. Le parole san-no essere mappa del visibile e dell’invisibile facendosi, come vo-leva Breton, mappa del desiderio. La loro qualità metonimica èpropriamente quella dell’occhio, il cui congiungere non è un sym-ballein, né un movimento metà tà physika, ma un tendere ancora;allargare il campo e spaziare (muoversi nello spazio e fare spazio)sono i modi in cui si dispiega la tensione dell’atto conoscitivo, an-che attraverso lo spaesamento e la sovversione delle classificazio-ni abituali99. Scrivere è un modo di organizzare lo spazio, nel te-sto e attraverso, fin dalle origini della scrittura, fin dall’inizio diogni letteratura: come nell’indovinello veronese. Il senso dell’in-finità di questa tensione non viene tanto da una capacità di viola-
96 C.K. Ogden, I.A. Richards, Il significato del significato, cit., pp. 247 e ss., inpart. pp. 253 e 256. Su questi temi torna R. Shattuck, L’occhio innocente, cit.,pp. 171-172 e nota 3, alle cui puntualizzazioni rimando.
97 Il 90% delle nostre percezioni è visivo, come sottolinea la Environmental ae-sthetic di D.J. Porteous (Environmental and Behavior. Planning and Every-day Urban Life, Addison-Wesley, Reading [MASS.] 1977).
98 G. Baldissone, Gli occhi della letteratura, cit., pp. 7-31.99 Ibidem, p. 17.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
49
re i limiti, ma di funzionare in scala nel bianco sipario (o volet, osiepe) della pagina100; in questo modo lo spazio letterario diventala miniatura, il microcosmo, la mappa.
“Il potere della mappa deriva in gran parte dal fatto che ‘cer-ca di far vedere ciò che esiste’”101: allo stesso modo la descrizio-ne letteraria è, secondo Philippe Hamon, uno dei principali mez-zi semiotici (“a dominante referenziale”) di cui l’uomo disponeper “dire il reale” (insieme alla denominazione e alla designazio-ne, il gesto dell’indicare, la deissi); la differenza principale è laamplificatio102, poiché il testo letterario deve costruire il propriospazio, la propria profondità, come sosteneva la McCarthy, e haquindi bisogno di questa attitudine in modo particolare. Non èsolo un “effetto di realtà” la presenza di uno spazio organizzatoin paesaggio, di uno sviluppo geografico e del “senso del luogo”attraverso la descrizione, né realismo: è la base stessa che per-mette alla sua “finzione” di continuare ad esistere. Ecco perché,se il suono ne è per così dire la carne, le immagini, secondo Mal-larmé, sono “il sangue della poesia”. In una sorta di dualismo lemappe, così come le mappe e le immagini ottenute dalle parole,hanno il senso della verità, ma sono anche finzione; accendono ilfascino dell’immaginazione, dal Don Chisciotte (il cui modello èl’Ariosto) fino a Tolkien, e sono anche espressione di una cono-scenza chiara e completa, come in Wordsworth e Leopardi103. Inquesto modo coinvolgono il con-testo. Lo spazio colto dall’im-maginazione non è più lo spazio indifferente, diventa spazio vis-suto104: la rêverie descritta da Bachelard è dunque attiva perchétrasforma l’universo morale nell’universo della bellezza, come an-che per Baudelaire. Tutto si concentra nello sguardo e nell’oc-
100 G. Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, Paris 19644, p. 20. Cfr. anche R.Shattuck, L’occhio innocente, cit., p. 172: anche dove sembra prigioniera del“circuito chiuso della testualità”, l’opera letteraria “rappresenta e rivela lavita” proprio “grazie ad una serie di convenzioni variabili all’infinito”.
101 P.C. e O.J. Muehrcke, Le carte geografiche e la letteratura, in F. Lando (a c.di), Fatto e finzione, cit., p. 97.
102 Ph. Hamon, Introduction a La description littéraire, cit., p. 6; Id., Cos’è unadescrizione, cit., p. 56.
103 P.C. e O.J. Muehrcke, Le carte geografiche e la letteratura, cit., p. 83.104 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 17 e ss.
Vincenzo Bagnoli
50
chio, “il proiettore di una forza umana”, attraverso il quale “unpotere soggettivo illuminante aumenta le luci del mondo”, rico-struendo, come nel caso di Copernico e Nietzsche, il cosmos, l’or-dine e il disordine dell’universo105. Trasformando la solitudinedell’occhio del poeta in una “compagnia aperta a tutti gli esseridel mondo” (per Spitzer ciò significa raggiungere l’“armonia delmondo”), la letteratura realizza così l’“espace heureux”. “Ciò chel’immagine fa è dunque un comunicare”: non ha il compito diprodurre ma di “svelare”, ossia di rendere accessibile al sentire (eperciò reale) e quindi “mettere in comune”106.
L’anamorfosi della proiezione cartografica consente di vede-re il mondo in un colpo d’occhio, secondo uno dei sogni faustia-ni, ma inevitabilmente lo distorce. Nella topographia l’accumula-zione retorica dell’ipotiposi, per esempio, lo sgretola in dettagliframmentari; è la salda tenuta della metonimia diffusa, il senso dicontiguità di un intero ambiente a tenere assieme l’immagine di-segnata all’interno della dimensione spaziale del testo, il suo pae-saggio come microracconto, che associa una figura e un tema107.Vengono in mente allora le parole di Caillois, a proposito di quel-le forme metonimiche (o frattali?) che in piccolo sembrano de-scrivere, attraverso la scrittura, la figura o quasi la “pianta” di unpaesaggio: “Elles résument l’étendue, elles condensent la durée.Elles sont objets de longues rêveries, de méditations, d’hypno-ses”, ma soprattutto, per l’occhio-qui, “témoigne que le tissu del’univers est continu et qu’il n’est pas de point, en l’immenselabyrinthe du monde, où des cheminements incompatibles, venusd’antipodes bien plus radicaux que ceux de la géographie, nepuissent interférer en quelque carrefour que révèle soudain unestèle commune, porteuse des mêmes symboles, commémoratived’insondables et complémentaires fidélités”108. L’immediatezzadell’immagine isolata nella sua forza di frammento, tanto lo
105 Id., La poétique de la rêverie, cit., pp. 196-197 e 200-201.106 R. Ronchi, Luogo comune, cit., p. 5.107 P. Ouellet, Voir et savoir. La perception des univers du discours, Editions Bal-
zac, Candiac (Québec) 1992, pp. 205-222.108 R. Callois, L’écriture des pierres, Flammarion, Paris 1981, pp. 18 e 119.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
51
splendore gorgonico della “gemma” quanto il nitore dello slogan(entrambi comunque gravidi di connotazioni funerarie) – para-lizza invece lo sguardo; la moltiplicazione e la ripetizione delleimmagini sembrano provocare una sorta di coazione a guarda-re109. Vari commentatori hanno descritto gli effetti di siffattisprofondamenti, tanto d’en haut quanto d’en bas: la fascinazionedel sublime che, come nel Sandmann hoffmaniano, “ruba gli oc-chi”, così come la riduzione spettacolare che inchioda nel “nonuso”, la riduzione turistica del mondo, il “paesaggio privato”, lavirtualità spettacolare precipitano il mondo verso l’Atopia110. Ilsenso profondo della “menzogna” del testo letterario, vale a direla distanza del suo spazio (e del suo sistema segnico), sta proprionel fatto che, anche quando sia abolita ormai la “riva” da cuiguardare a distanza di sicurezza il naufragio e si sia costretti a “es-sere nel mondo”, il rischio del naufragio in quel mondo possa es-sere “dolce”, “allegro”. Navigare è pur necessario per l’uomomoderno, ma facendolo sulle mappe, come si scopre nel Don Chi-sciotte, si può viaggiare senza spese, fatica e inconvenienti111. Perla loro capacità di tracciare queste mappe Leopardi, e l’Ariostoletto da Calvino, si dimostrano allora portatori di un’etica diver-sa rispetto al fascino del gorgo e dell’abisso, coinvolta nell’atmo-sfera (la “tiepida atmosfera”) ma capace di elevarsi al di sopra deivicoli ciechi della topografia. Calvino riassume i criteri di questascelta del punto di vista nel Castello dei destini incrociati, con
109 G. Baldissone, Gli occhi della letteratura, cit., pp. 21 e 61. Sulle connotazionifunerarie J.P. Vernant, La morte negli occhi. Figure dell’Altro nell’antica Grecia,Il Mulino, Bologna, 1987, p. 83 (E. Raimondi, Dal simbolo al segno, in Il si-lenzio della Gorgone, Zanichelli, Bologna 1980, pp. 113-147 porta l’esempio diD’Annunzio) e E. Canetti, Massa e potere, Bompiani, Milano 1988, pp. 51-52.
110 G. Debord, La société du Spectacle, Buchet-Chastel, Paris 1967, trad. it. Lasocietà dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 1997, p. 133; si aggiungainoltre la definizione del nuovo uomo spersonalizzato da un paesaggio delgenere; E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., p. 131.
111 H. Blumenberg, Naufragio con spettatore, cit., pp. 89 e ss. Riguardo il coin-volgimento causato dalla “visione ravvicinata” cfr. E.T. Hall, Art, Space andthe Human Experience, in G. Kepes (a c. di), Arts of the environment, Bra-ziller, New York 1972, pp. 52 e ss., che tratta del superamento delle vecchiemetafore visuali, qualificate come “closed-score vision”, per effetto di unaesperienza spaziale “sinergetica”.
Vincenzo Bagnoli
52
un’immagine così simile alla posizione del poeta in Paysage, la cui“stanza-mente” (o anche testo?) dalle finestre chiuse diventa dav-vero “il luogo dove si registrano le oscillazioni dei sismografi”:
La forza dell’eremita si misura non da quanto lontano è an-dato a stare, ma dalla poca distanza che gli basta per staccarsidalla città, senza mai perderla di vista112.
Viene così stabilita, rispetto al “naufragio con spettatore”, unanuova distanza critica, un equilibrio fra distanza e coinvolgimento:il mondo osservato e immaginato ha una sua sicurezza, anche quan-do è il “grande fuori”, ma la camera di Baudelaire, il colle di Leo-pardi sono ormai diversi dai templa serena di Lucrezio113. Questoequilibrio si pone fra il desiderio e il riposo tracciato nel movimen-to delle ottave, fra il “sedendo” e il “mirando”, nello “sporgersi inbraccio al buon tempo” ungarettiano. È una particolare situazionedi benessere che “trasforma il mondo in ‘contesto’”114, dando cioèl’unica possibilità di significato a esso disponibile. L’“ampio respi-ro” cui tende lo sguardo nel suo già descritto spingersi oltre è qual-cosa di più che una comune metafora: indica una tensione a far col-limare la semiosfera con la sfera del respiro, la partecipazione a un“universo di voci”, a un cosmos umano di racconti115. La percezio-ne dello spazio non è consegnata solo alla topografia, che ne rap-presenta piuttosto l’organizzazione, la necessaria geometria dell’in-telligenza; si vale dell’atmosfera, attraverso la quale si esprime effet-tivamente un “essere immersi” che però è in grado di leggere leproprie coordinate, un’armonia fra “consenso e disincanto” dalquale discende un altro grado di qualità ambientale. Viene da pen-
112 I. Calvino, Il castello dei destini incrociati, Mondadori, Milano 1994, pp.100-101.
113 Le “alte regioni serene”, De rerum natura, II, 8.114 G. Bachelard, La poétique de la rêverie, cit., pp. 192-193. A quanto detto so-
pra si aggiunga G. Olsson, Il desiderio ardente di casa, in F. Lando (a c. di),Fatto e finzione, cit., pp. 253-262, che salomonicamente si appoggia a Marxe Wittgenstein.
115 N. Lorenzini, La voce nel testo poetico, in «Il Verri», 1-2, 1993, p. 85; si vedainoltre Id., Il presente della poesia, cit., pp. 136 e ss.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
53
sare, come fa Bertone, a Leonardo, alla proposta di una pittura cherilevi l’“ispessimento dell’atmosfera”, cioè le diverse densità e tra-sparenze, apprezzabili non solo visivamente, per riprodurre la per-cezione della distanza, l’esperienza dello spazio; è una “nuova con-cezione percettiva globale” che, sul piano testuale, corrisponde auna “valenza ‘cosmologica’”, un confronto con la “totalità” che ri-chiede di saper dosare una razionalità “densa”, quella del raccon-to, e una “trasparente”, quella della conoscenza116.
Restando ancora per un poco alla pittura, si osservi come nonsia questione di predominio del colore sulla linea, ma come a defi-nire l’intensità di un’esperienza spaziale, della profondità, conti laprecisione della luce: l’esattezza ottenuta attraverso il generico e iltotale. Baudelaire nel Salon del 1859 scrive di un pittore, Boudin,in grado di superare con i suoi “studi” i paesaggisti tradizionali:
… codesti studi, tanto rapidamente e fedelmente schizzatiprendendo a soggetto ciò che v’ha di più incostante, di piùinafferrabile nella forma e nel colore, onde e nuvole, portanosempre, scritti in margine, la data, l’ora e il vento; così, peresempio: 8 ottobre, mezzogiorno, vento di nord-ovest. Se tal-volta avete avuto modo di fare la conoscenza di queste bellez-ze meteorologiche, potete verificare a memoria l’esattezza del-le osservazioni di Boudin!117
Ciò che colpisce Baudelaire non è, come precisa qualche rigadopo, la rispondenza al vero: i pittori di paesaggio facendo “copiedal vero” limitano infatti l’immaginazione. È piuttosto la possibi-lità di far collimare un’impressione atmosferica col dettaglio crono-topografico, di ottenere dal reperto esperienziale un “punto di par-
116 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., pp. 38-39; M. Augé, Pour une antropo-logie des mondes contemporaines, Aubier, Paris 1994, trad. it. Storie del pre-sente. Per un’antropologia dei mondi contemporanei, Il Saggiatore, Milano1997, pp. 40-41.
117 Ch. Baudelaire, Salon del 1859, in Poesie e prose, cit., pp. 872-873. Si tro-vano utili commenti alle riflessioni baudelairiane nel Catalogo della mostratenutasi a Bologna nella Galleria d’arte moderna: Paesaggio. Immagine erealtà, Electa, Milano 1981.
Vincenzo Bagnoli
54
tenza” (o di vista) per immaginare, secondo i precetti della già ri-cordata “mnemotecnica del bello”. Se ciò richiama la tecnica pit-torica del surrealista Matta, al lettore di cose italiane più attentonon sfuggirà l’analogia tra questo metodo di racconto e quello diUngaretti, che datando i propri componimenti fissa il loro “puntodi partenza”, il qui, alla maniera del “colle” leopardiano; la poesia,poi, come vuole Bachelard, s’incarica con il suo sguardo di ripor-tare tutto sotto il segno della “stagione”, non dell’ora o del giorno.
Come la carta geografica, il testo si sviluppa perciò, con la tra-scrizione delle coordinate celesti sul globo terracqueo, nel confron-to tra due geografie, quella del cielo e quella della terra, la parte e iltutto118. Ciò che infatti colpisce particolarmente Calvino è il fattoche la geografia sia una scienza che si fonda e progredisce “attra-verso il dubbio e l’errore”, per prove successive e approssimazioni:esattamente come procede il suo Palomar, articolato attorno a verie propri “esercizi del vedere” con i quali si vuole cogliere la speci-ficità dell’umano. Sono operazioni di oggettività che però includo-no la spinta soggettiva, sforzi di cartografia globale che devono altempo stesso tenere conto delle geografie interiori, le mappe segre-te attraverso le quali si mettono a punto le strategie di riuso del ter-ritorio, tanto del nomade quanto del situazionista o del graffitista119.In una “cartografia cognitiva” che assecondi la proposta di Jamesonla mappa consegnata dall’opera d’arte dà il piacere di conoscere maanche, e soprattutto, di riconoscere, disegnando un ritratto in scaladi luoghi dell’esperienza umana come contesti della conoscenza.Alle accresciute competenze e all’allargamento dei saperi non ba-stano più i “teatri della memoria”, le semplici architetture: occorreun’intera urbanistica, una scienza del paesaggio, una topografia ge-nerale, una “geografia del sapere” da affiancare all’archeologiabenjaminiana120. Lo stesso Burke, nello scrivere la Storia della cono-scenza, si serve della mappa come immagine di questa, tracciando-ne i momenti salienti attraverso le tappe della scoperta geografica.
118 I. Calvino, Collezione di sabbia, Garzanti, Milano 1984 (ora Mondadori,Milano 1994), pp. 23-25.
119 Ibidem, pp. 27 e 106-107. Cfr. anche C. Milanini, L’utopia discontinua. Sag-gio su Italo Calvino, Garzanti, Milano 1990, p. 136.
120 G. Baldissone, Gli occhi della letteratura, cit., p. 7.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
55
Il significato gnoseologico di una visione del mondo è pro-prio la sua capacità di ordinare e scandire lo spazio, di trasfor-marlo – orientandolo – in senso attraverso il percorso di un rac-contare, una fiction dell’avere visto che sappia ricostruire nella si-mulazione di un’unità ambientale i frammenti lacerati dell’espe-rienza, i reperti della singolarità: “La carta geografica insomma,anche se statica, presuppone un’idea narrativa, è concepita infunzione d’un itinerario”. Secondo Calvino, dunque, ogni carto-grafia deve comprendere la dimensione del tempo121: lo spaziodel testo letterario viene a essere un’altra chiave di lettura del suotempo, del nesso delle coordinate con cui legge e traduce il mon-do (lo modellizza). Una chiave privilegiata in un’epoca postgu-temberghiana in cui si afferma, accanto alla temporalità del testo,anche la sua spazialità. Per il testo letterario questa inclusione delmovimento è anche più facile rispetto alla mappa, proprio perchéil testo congela nello spazio della parola la durata del suono, nel-l’architettura della pagina la musica del discorso. Hamon com-mentando un’affermazione contenuta nella Lettre sur le sourds etmuets di Diderot (“tout poésie est emblématique”) vi ravvisa lapropensione del testo a divenire diagramma (rappresentazione diun movimento) o calligramma (rappresentazione di un oggetto),trascendendo gli stessi limiti fra parola e immagine122.
Mettiamo ancora in parallelo geografia e testo: è un geografo,Y. Tuan, consapevole che le immagini contenute nelle descrizio-ni letterarie non sono soltanto simboli ma modellizzazioni delreale, a notare che la letteratura definisce, spiega l’esperienza e la“ricostruisce” anche123. È quanto Cassirer chiamava una forma
121 I. Calvino, Collezione di sabbia, cit., pp. 22-23.122 Ph. Hamon, La description littéraire, cit., p. 127. Sullo stesso argomento si
vedano le osservazioni di Meschonnic sulla natura linguistica e non solopoetica del ritmo (“il ritmo è l’organizzazione del movimento della parolaattraverso un soggetto”) e la sua resa corporea nel segno come sistema di or-ganizzazione-rappresentazione in H. Meschonnic, Se la teoria del ritmo cam-bia, tutta la teoria del linguaggio cambia, in «Studi di estetica», numero mo-nografico, pp. 11-30. Sul movimento-schema (a proposito del rapporto fraarchitettura e musica), H. Broch, Appunti per un’estetica sistematica, in IlKitsch, cit., pp. 7-39, in part. pp. 20 e ss.
123 Y. Tuan, Literature and geography: implications for geographical research, in
Vincenzo Bagnoli
56
simbolica, nozione con la quale accomunava scienza, arte e lin-guaggio (in una continuità fra sensibile ed intellettuale)124, ed èquanto, del resto, diceva Calvino: come la scienza, la letteraturaastrae dal flusso di dati, stabilisce una cornice, inquadra e seg-menta le immagini del mondo e, fissando le esperienze, dà unastabilità alla realtà (provvisoria, perché, come si è detto, il lin-guaggio si adatta al mutevole). Insomma la letteratura traccereb-be partizione e coordinate del mondo proprio definendo lo spa-zio e il percorso. Il linguaggio è – come scriveva Cassirer – unpercorrere il mondo: per lo scrittore del Novecento in particola-re le ecphraseis non possono essere sospensioni statiche della nar-razione, il racconto consistendo anzi nel disegnare i percorsi traspazi e nomi, come fa il Calvino della Speculazione edilizia e del-la Giornata dello scrutatore. Importante al proposito il rilievo diMilanini: tanto scrutare quanto speculare sono verbi connessi al-l’attività del percepire-pensare, alla “mobilità dello sguardo” che“riordina senza posa gli elementi della visione”125. Si potrebbedire insomma che questa necessità di percorrere sottopone lascrittura alla necessità di confrontarsi con la “plaine” di Bache-lard, il sentimento di una grandezza e di una uniformità che con-tiene le variazioni126. Un altro geografo, Alexander von Hum-boldt, si era posto il problema proprio di come raccontare lo spa-zio delle grandi pianure; la sua preoccupazione di fronte alla ne-cessità di trovare un denominatore comune fra l’immaginazionedei lettori ed esperienze così distanti da essa, di trovare la “sca-la” di un linguaggio che sapesse farsi mediatore, sembra riman-dare a preoccupazioni simili espresse da Leopardi nella Premes-sa all’ultimo canto di Saffo, dove però proprio la “grande distan-za” (il grande spazio tra noi e le vicende di Saffo) favorisce lapoesia attraverso il “vago e incerto”. Di questo “vago”, la cui ef-
D. Ley, M.S. Samuels, Humanistic Geography: Prospects and Problems,Croom Helm, London 1987, pp. 194-206.
124 E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, cit., vol. I, pp. 12-19.125 C. Milanini, L’utopia discontinua, cit., p. 84. Cfr. anche G. Luti, Il disegno
del mondo. Italo Calvino tra utopia e scrittura, in Passioni e inganni, Bi e Gi,Verona 1987, pp. 215-231.
126 G. Bachelard, Poétique de l’espace, cit., pp. 184-185.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
57
ficacia consiste nel fatto che “il non veder tutto” permette di“spaziare coll’immaginazione”, il poeta non trova poi miglioreesemplificazione, in altro luogo, che proprio nel vuoto “di unavasta e tutta uguale pianura”, accostata nell’effetto estetico a uncielo imperturbato simile a quello dell’Infinito127. Resta però ilproblema che tali misure sconfinate sono “meno simili a noi,meno proprie”, e quindi richiedono di essere accostate, come sivedrà più avanti, a forme dell’esperienza più immediate, coglien-do cielo e terra “in un medesimo punto di vista”, componendo-le in quadri più articolati.
Torniamo intanto a Humboldt (il cui Kosmos, comunque, do-veva essere qualcosa di più di una “descrizione della terra”: “inuna sola parola ‘cielo e terra’”), per osservare la soluzione da luiprospettata nelle due prefazioni ai Quadri della natura, il cui pri-mo libro è dedicato proprio alle steppe e ai deserti, all’insegna diquello “sguardo d’insieme” che sarebbe da raffrontare magarialle prospettive della ricerca del fratello Wilhelm sulle lingue. Ilproblema che viene posto è appunto quello della “trattazioneestetica degli oggetti”, di come essa debba essere condotta nellaprosa scientifica, per evitare che l’“accumulo” (la già descrittavertigine topografica) disturbi la “serenità”, ossia “l’impressionegenerale del quadro”: quella che poco fa è stata definita come laqualità dell’esperienza spaziale del testo, la sua atmosfera. Sonochiamate in causa quindi le due razionalità, densa e trasparente,e le due modalità di partecipazione, fra consenso e disincanto. PerHumboldt il sentimento e la fantasia portano allo sviamento ver-so la “prosa poetica”, verso quello che lui ritiene una “mancanzadi contegno” (questo nel pieno del romanticismo…). La soluzio-ne sta per lui in un equilibrio che permetta di “restituire il piùpossibile il piacere immediato della visione e al tempo stesso con-tribuire […] a una maggior comprensione dell’armonico nessoche governa l’agire delle forze naturali”. Che tale soluzione pos-sa valere anche per la letteratura lo dimostra il parallelo con lequasi coeve prime pagine del Rosso e il nero, nelle quali Stendhaldescrive nelle conformazioni dell’ambiente geografico un quadro
127 G. Leopardi, Zibaldone, 20 settembre 1821, 1745 e ss.
Vincenzo Bagnoli
58
anche storico. Tale equilibrio consiste nell’“unione di un intentoletterario con uno puramente scientifico”, quando vi sia “il desi-derio di accendere la fantasia e al tempo stesso di arricchire la vitadi idee attraverso la crescita del sapere”. Non c’è solo l’intentopedagogico del miscere utile dulci, ma una intentio che si potreb-be collegare di nuovo alla poesia di Leopardi.
Secondo Bertone si tratta della ricerca di una nuova formaespressiva e di un metodo capace di riprodurre e sostituire deltutto l’esperienza diretta, quale Humboldt andava mettendo apunto in Kosmos. Viene dunque chiamata in causa un’altra feno-menologia: come l’attenzione alle trasformazioni del mondo, alleforze fisiche che le operano, trova un parallelo nell’azione delmondo sulla forma del linguaggio e delle immagini (miti) del-l’uomo, così la stessa operazione percettiva e di rielaborazione in-terna operata dall’uomo appartiene al naturale, ed è degna di fi-gurare sull’atlante. Per Humboldt, insomma, la trasformazionefantastica del paesaggio, la sua trascrizione anamorfica, proietti-va operata dall’arte, resta un momento della conoscenza, non neè un tradimento, proprio per l’efficacia che l’opera letteraria puòavere non nell’imitare un ambiente ma nell’offrire attraverso il te-sto la possibilità di immaginarlo 128. Le descrizioni dei vari tipi dipianure (steppe, brughiere, pampas ecc.) diventano perciò mo-delli per il raccontare, con la loro necessità di esattezza, di legareinsieme i fatti e al tempo stesso di agire sulla fantasia (come ca-pacità di rappresentare). Produrre “immagini praticabili” è delresto la proposta di Brecht per la letteratura.
Il dialogo tra testi-mappe, senza pretendere di sostituire o eli-dere il reale, né di addomesticarlo o incantarlo, non è che l’insiemedelle linee-guida degli sguardi cui compete stabilire queste con-nessioni: “nell’universo infinito della letteratura s’aprono semprealtre vie da esplorare, nuovissime o antichissime, stili e forme che
128 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., pp. 49-51. Il riferimento è a A. vonHumboldt, Kosmos, Turati, Milano 1865, t. 3, p. 4; H. Blumenberg, La leg-gibilità del mondo, cit., p. 294, chiarisce quello che a giudizio di Humboldtdoveva essere l’obiettivo di una “descrizione del mondo”, usando le sue stes-se parole: “Un libro sulla natura deve fare l’impressione della natura stessa”.
Sguardi, letture e carte. Scrivere il paesaggio
59
60
possono cambiare la nostra immagine del mondo”, sostiene Calvi-no, e si può aggiungere che è lo stesso compito di una buona map-pa129. D’altro canto la ricerca del signor Palomar del giusto mododi guardare “dal di fuori” lo porta a scoprire l’altro lato dell’affer-mazione di Novalis: se “l’occhio non vede altro che l’occhio”, pureattraverso di esso, come in Cartesio, vede qualcos’altro, così chenella letteratura non avviene semplicemente che l’io finisce per ve-dere se stesso nello specchio del mondo, ma si scopre che: “forsel’io non è altro che la finestra attraverso la quale il mondo guardail mondo”. Allo stesso modo per Humboldt (che aveva trovato aproprio modo la via attraverso la quale “la natura inarticolata in-globa nel suo discorso il discorso umano”) “i fatti restano a lungoisolati prima che si riesca, attraverso una faticosa ricerca, a connet-terli insieme”130 nella forma di un senso: resta insomma quella cheCalvino chiama la “muta distesa delle cose”, finché non accade dicogliere l’“ammicco” di una cosa a un’altra, come nello sguardoche indugia sulle stelle micantes (per usare l’aggettivo latino cheLeopardi poteva sicuramente avere in mente) che disegnano, nodie nessi di senso nelle linee prospettiche delle costellazioni, delle or-bite, delle distanze. La possibilità dell’uomo di specchiarsi nel ko-smos, come “docile fibra / dell’universo”, è proprio in questo guar-dare che istituisce confronti fra paesaggi e cieli; e libri, senza i qua-li è perduta la leggibilità e la pronuncia del mondo.
129 I. Calvino, Lezioni americane, cit., p. 12.130 Id., Il castello dei destini incrociati, cit., p. 99; A. von Humboldt, Quadri del-
la natura, cit., p. 33.
Vincenzo Bagnoli
CAPITOLO SECONDO
La mappa del labirinto.L’Ariosto di Calvino
1. Rappresentare e riprodurre: la forma del mondo
Si potrebbe chiamarlo il “paradosso di Pierre Menard”, dalnome del personaggio di Borges che tentava di riscrivere il Chi-sciotte: accade talvolta che uno scrittore possa riconoscere nell’o-pera di un autore del passato una interlocutrice così importanteda assumerla come orizzonte totale della propria operazionecompositiva, in maniera ben più intensa delle normali relazioniintertestuali (allusive, imitative, parodiche) che è possibile istitui-re con un modello, fonte, archetipo, ipotesto, per quanto profon-de e decisive possano essere1. Come il protagonista del raccontoha quale scopo non “essere Cervantes”, dice Borges, ma “restarePierre Menard e giungere al Chisciotte attraverso le esperienze diPierre Menard”, così questo processo, che sembra prevedere unasorta di devozione esegetica simile a quella dei testi sacri, si arti-cola proprio attraverso un’istanza interpretativa che implica il ri-conoscimento di una duplice posizione, vale a dire l’essere con-temporaneamente lettore e scrittore2.
1 Obbligatorio rimandare a H. Bloom, The Anxiety of Influence, Oxford Uni-versity Press, New York-Oxford 1973, trad. it. L’angoscia dell’influenza. Unateoria della poesia, Feltrinelli, Milano 1983, nonché G. Genette, Palimpsestes.La littérature au second degré, Editions du Seuil, Paris 1982, trad. it. Palinse-sti. La letteratura al secondo grado, Einaudi, Torino 1997, in part. pp. 379 e ss.
2 Sull’avvicinamento del discorso artistico al discorso critico si veda L. Hut-cheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, Routledge,New York-London 1988, p. 53; nello specifico su Calvino cfr. G. Patrizi, Ilsignificato del grigio. Calvino e le forme del saggio, in «Nuova corrente»,XXXIV, 1987, pp. 297-328.
61
Pour l’enfant, amoureux de cartes e d’estampes,L’univers est égal à son vaste appétit.Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes!Aux yeux du souvenir que le monde est petit!
Ch. Baudelaire, Le voyage
L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto raccontato da ItaloCalvino3 nasce da una simile istanza, anche se l’occasione concre-ta è data da una delle sempre più frequenti operazioni divulgati-ve promosse dall’industria culturale (nello specifico un program-ma radiofonico); dipana infatti attraverso le sue pagine un dialo-go intenso, rivelatore di un’affinità profonda fra le due scritturenon tanto in termini di temi, quanto di immaginario, vale a diredi strutture costitutive e di “sguardo”. Alla Struttura dell’“Orlan-do” Calvino dedica un altro breve saggio, nel quale riconosce al-l’interno del poema, nonostante l’understatement di Ariosto (neldichiararlo soltanto una “gionta” dell’Innamorato), “una conce-zione del tempo e dello spazio che rinnega la chiusa configura-zione del cosmo tolemaico, e s’apre illimitata verso il passato e ilfuturo, così come verso una incalcolabile pluralità di mondi”, invirtù soprattutto del movimento che ne scandisce lo spazio e del-la peculiare natura delle sue linee:
… potremmo tracciare il disegno generale del poema seguen-do il continuo intersecarsi e divergere di queste linee su unamappa d’Europa e d’Africa4.
Questa poesia che segue il movimento a zigzag dei cavalli e del-le “intermittenze del cuore” pare tradurre il tempo del raccontonello spazio di un’immagine, proprio come fa la mappa, strumen-to conoscitivo della modernità per eccellenza perché non definiti-vo, ma sistematicamente perplesso, espressione di “un sapere percui ogni acquisizione apre la consapevolezza di nuove lacune”5.
3 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Cal-vino, Einaudi, Torino 1970 (ora Mondadori, Milano 1995).
4 Id., La struttura dell’“Orlando” (1975), in Perché leggere i classici, Monda-dori, Milano 1995 (nuova ed.), pp. 68-77 e 71 (si trova già in L’“Orlando Fu-rioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 30). Qualcosa di affine aveva scritto E.Sanguineti, La macchina narrativa dell’Ariosto (1974), ora in Il chierico orga-nico. Scritture e intellettuali, Feltrinelli, Milano 2000, pp. 65-71.
5 I. Calvino, Il viandante nella mappa, in Collezione di sabbia, Garzanti, Mila-no 1984, ora Mondadori, Milano 1994, pp. 22 e 25. Sull’argomento fonda-mentale G. Barlusconi, L’“Orlando Furioso” poema dello spazio, in E.N. Gi-rardi (a c. di), Studi sull’Ariosto, Vita e Pensiero, Milano 1977, pp. 39-130.
Vincenzo Bagnoli
62
In Ariosto, Calvino ritrova insomma lo sguardo della moder-nità, di quella modernità agli esordi che attraverso le navigazioniacquistava maggiore consapevolezza6: “Plus Ultra”, il motto (delquale si approprieranno non pochi filosofi) di Carlo V, le cui sco-perte sono celebrate nel Furioso (XV, XVIII-XXXVI)7, diviene quel-lo di un’intera epoca, forse anzi di una forma del mondo. L’esigen-za di comprendere in modo nuovo l’ambiente dell’esperienza por-ta quindi a inventare uno sguardo diverso, uno sguardo che misu-ra e calcola lo spazio geometrizzandolo, così come avviene in di-versi strumenti – proiezione prospettica, proiezione cartografica e“proiezione saggistica” (nello studio dei comportamenti umani) –negli anni di Paolo Uccello, di Mercator e di Machiavelli8. Proprioquesto atteggiamento indagatore, e non la mera contemplazione(lo notavano Gombrich e Turner), guida l’introduzione nei quadririnascimentali del paesaggio, la cui raffigurazione costituisce l’esi-to di una semiosi culturale dell’ambiente. Lo spazio si riempie disignificato nel paesaggio perché i luoghi vengono posti in relazio-ne fra di loro: per questa ragione Kenneth Burke, nello stabilireun’analogia tra la retorica e la cartografia, pare riconoscere che talirelazioni non si stabiliscono più a partire dalla guida normativa delcanone retorico, ma che anzi nella modernità la prima prende afunzionare secondo i metodi della seconda. Alcuni luoghi (il giar-dino o la biblioteca) acquisiscono anzi “la curiosa proprietà di es-sere in relazione con tutti gli altri luoghi”, proprietà che finisce colrenderli una sorta di rispecchiamento dell’ordine dei luoghi, po-
È una curiosità, ma non inutile, A. Lo Faso, La geografia nell’“Orlando Fu-rioso”, Tipografia Moderna studio editoriale, Canicattì 1949.
6 E. Garin, L’umanesimo italiano, Laterza, Roma-Bari 1985.7 Sul tema si veda D. Quint, Epic and Empire. Politics and generic form from
Virgil to Milton, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1993, p. 251,dove si richiama F. Yates, Astraea: the Imperial Theme in the Sixteenth Cen-tury, Routledge and Kegan Paul, London 1975, pp. 22-26.
8 Queste e le successive riflessioni sulla nascita del paesaggio si trovano benargomentate in P. Burke, The Italian Renaissance. Culture and Society inItaly, nuova ed. riv. Princeton University Press, Princeton (NJ) 1999, trad.it. Cultura e società nell’Italia del Rinascimento, nuova ed. Il Mulino, Bolo-gna 2002; per un’analisi più attenta allo specifico letterario G. Bertone, Losguardo escluso. L’idea di paesaggio nella letteratura occidentale, Interlinea,Novara 1999, p. 36.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
63
nendoli così al di fuori (al di sopra) dell’ordine stesso, in grado disospendere e rimettere in discussione le relazioni che essi rifletto-no. Negli affreschi rinascimentali, come quelli del Buono e Catti-vo Governo di Ambrogio Lorenzetti, coesistono, le une accantoalle altre, figure allegoriche e “realtà effettuale”, e addirittura lascrittura stessa, in un insieme “armonico” che è dipinto, mappa eracconto del paesaggio al tempo stesso: se nella disposizione oriz-zontale e panoramica di questo “sistema iconico laico” deve certoessere riconosciuto anche il contorno dell’utopia9, Foucault prefe-risce chiamare “eterotopia” un siffatto riflesso dell’ordine dei luo-ghi, ossia “contro-luogo” effettivamente realizzato (e localizzabi-le). È possibile sostenere che il paesaggio stesso rappresenti l’ete-rotopia propria del mondo moderno10:
… suscita emozioni non solo perché fa da scenario, diretta-mente o indirettamente, a vicende umane [ma] emoziona sem-plicemente in quanto specchio del mondo11.
Il paesaggio è insomma uno spazio costruito nel momento incui la vista prende possesso del mondo all’alba dell’età moderna,vale a dire quando, insieme alla scoperta del nuovo mondo, si of-fre alla coscienza un nuovo rapporto con il mondo, un rapporto diapertura sostanziato dal tentativo di inscrivere realtà più com-plesse entro il disegno armonico di linee più ampie e calcolate diquelle del Medioevo12. Leon Battista Alberti è l’autore che, in
9 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., pp. 26-29; G. Romano, Studi sul pae-saggio, Einaudi, Torino 1976, pp. 32 e ss.
10 M. Foucault, Eterotopia. Luoghi e non luoghi metropolitani, Mimesis, Mila-no 1994; V. Guarrasi, Eterotopia del paesaggio e retorica cartografica, inhttp://www.unipa.it/~labgeo/Virtualiscape/Ironia.htm. Sull’eterotopiacome pratica dell’inclusività in Calvino si trova un brevissimo accenno in U.Musarra-Schroeder, Il labirinto e la rete. Percorsi moderni e postmoderni nel-l’opera di Italo Calvino, Bulzoni, Roma 1996, pp. 39-40, nota 34.
11 E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappre-sentato, Marsilio, Venezia 1998, pp. 84-85: è il trapasso che segna il formar-si del paesaggio come oggetto della cultura.
12 Fino al punto di tentare calcoli della misura dei regni ultraterreni: P. Zumthor,La misura del mondo, Il Mulino, Bologna 1995; su fra’ Mauro, il più presti-gioso esponente della cartografia medievale, autore di carte azimutali prive di
Vincenzo Bagnoli
64
questa alba, meglio incarna la ricerca dell’ordine difficile dei luo-ghi, in un mondo che è palcoscenico dell’umano e non più thea-trum di Dio13, con il calcolo, con l’armonia, che è anche ritmo; nelsuo emblema della prospettiva, consistente in un occhio alato, èracchiusa la tensione conoscitiva di questo modo di guardare. Sedunque si può definire con Dilthey la letteratura come “organoper la comprensione del mondo”, senza dubbio nella modernitàtale organo ha appunto la struttura dell’occhio.
In letteratura, la funzione equivalente ai paesaggi pittorici puòessere ritrovata nell’allure descrittiva della narrazione poetica, il cuimiglior esempio è per Peter Burke proprio quello offerto da Ario-sto14. L’espressione può parere ossimorica, eppure è proprio almodello di una narrazione che il poema si viene accostando, pro-prio perché organizza in maniera diversa le relazioni spazio-tem-porali al proprio interno (ossia secondo una profondità prospetti-ca che, per la McCarthy, sarebbe specifica del romanzo), conce-dendo inoltre maggior rilievo alla problematica del rapporto me-tonimico fra individuo e totale15. Entra inoltre in gioco quella cheFoucault chiama la “prosa della vita”, con l’apparizione del feno-meno nella filigrana del segno: il mondo interessa insomma comesoggetto conoscibile dall’uomo, non perché è figura d’altro. Latraccia più evidente di questo interesse è, nello stesso periodo, la
meridiani e paralleli, dette “a ragnatela”: J. Cowan, A Mapmaker’s Dream: TheMeditation of Fra Mauro, Cartographer to the Court of Venice, Hodder & Stou-ghton, London 1997. Si veda inoltre I. Calvino, Com’era nuovo il nuovo mon-do, in Collezione di sabbia, cit., pp. 11-19, che torna anche sul tema del “ri-specchiamento”. Su questo aspetto è ricco di stimoli il saggio di R.R. Masio-la, Pianeti proibiti. Descrizione traduzione intertesti. La semiosi dell’Impero edelle colonie dal Vecchio al Nuovo Mondo, e viceversa, Guerra, Perugia 1997.
13 E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., p. 77. Si vedano inoltre le preziose ana-logie tra lo sguardo analitico del saggio e quello del teatro poste in evidenzada E. Raimondi, Politica e commedia, Il Mulino, Bologna 2000 (nuova ed.).
14 P. Burke, Culture and Society in Renaissance Italy 1420-1640, Batsford, Lon-don 1972, trad. it. Cultura e società nell’Italia del Rinascimento, Einaudi, To-rino 1984, p. 202. Cfr. anche L. Caretti, Introduzione a L. Ariosto, OrlandoFurioso, Einaudi, Torino 1992 (nuova ed.), vol. I, pp. XIV-XXIII.
15 Pare giusto quindi correggere la traiettoria indicata da Bachtin come fa C.Segre, Quello che Bachtin non ha detto. Le origini medievali del romanzo, inTeatro e romanzo, Einaudi, Torino 1984, pp. 61-84.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
65
passione per le autorappresentazioni di un’intera civiltà, qual è di-mostrata dai già citati affreschi senesi, ma che emerge anche dallaDescrittione di tutta Italia del bolognese Leandro Alberti (1550), odall’attenzione rivolta da signorie e principati alla cartografazionedei propri territori a fini di controllo16: la “conoscenza dell’ine-splorato”, insomma (un bisogno sempre più forte che porterà, apartire dal 1550, Giambattista Ramusio a raccogliere nei tre volu-mi Delle navigazioni et viaggi un grandissimo numero di relazionidi viaggio), si accompagna alla “conoscenza del proprio habitat”17.
Proprio da questo genere di esperienza Ariosto, che com’ènoto dovette suo malgrado viaggiare (seppur poco) ed ebbe incari-chi diplomatici e di amministrazione territoriale, apprende – comeMachiavelli – la necessità di ricorrere al documento, alla prova del-le carte, per affinare le proprie strategie: non bastano le “cornici”medievali, gli ordini sovrimposti dall’alto della teologia; come neigià citati affreschi di Lorenzetti, la rappresentazione dello spazio èinsieme paesaggio e mappa. La carta è un altro tipo di metafisica, sesi vuole, una metafisica cartesiana; ma resta una metafisica di segnila cui phantasia muove comunque dal fenomeno. Corrado Bolognaha compiuto in questo senso un’importante rilettura delle note diCroce sull’armonizzazione ariostesca entro lo “stile”, rilevando cheesso non è semplice legatura entro una cornice come in Boiardo, lacui materia può essere coerente solo nello spazio dell’utopia18. Ri-prendendo allora le osservazioni di Calvino sullo stile e la sua im-portanza specifica per la modernità (in bilico tra “stilizzazione” e“molteplicità”), risulta chiaro come ai suoi occhi di lettore e scrit-tore “sull’orlo del postmoderno” sia possibile trovare una simme-tria con l’altro estremo della modernità proprio nella volontà di af-fidarsi non all’“armonia prestabilita”, ma piuttosto alla ricerca in-quieta e alla verifica puntigliosa delle innumerevoli relazioni chel’eterotopia stabilisce: solo così lo stile non è ornamento, ma diven-ta davvero costruzione. Come già notava Caretti, Ariosto sa (alla
16 E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., p. 87.17 I. Calvino, Il viandante nella mappa, cit., p. 26.18 C. Bologna, La macchina del “Furioso”. Lettura dell’“Orlando” e delle “Sati-
re”, Einaudi, Torino 1998, pp. 86 e ss.
Vincenzo Bagnoli
66
maniera di Machiavelli e Guicciardini) “che la conoscenza delmondo si può attuare ovunque la sorte ci collochi”, tra gli umili otra i potenti, tra gli orrori della guerra o nell’idillio amoroso: e pro-prio questa prospettiva molteplice colpisce Calvino19. Ariosto com-pie dunque l’operazione di ricondurre all’orizzontalità del roman-zo la verticalità dei modelli, disponendoli l’uno accanto all’altronella loro molteplicità panoramica, e realizzando quindi l’armonia,attraverso l’ironia, vale a dire la presa di distanza che permette lacreazione di un “punto di vista (anzi di molti e dialettici punti di vi-sta)” che differenziano il Furioso dal tipo del poema cavallerescomanierista, nel quale, secondo Lukács, la “leggerezza” che permet-te di mantenersi a metà strada fra terra e cielo, “il sussistere beatodella totalità della vita è sospeso all’armonia prestabilita del versoepico”20.
19 L. Caretti, Introduzione a Orlando Furioso, cit., p. VII; I. Calvino, La sfidaal labirinto, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 1980, pp. 82-97, e Lezioniamericane, Garzanti, Milano 1988 (ora Mondadori, Milano 1994), p. 116: ilromanzo contemporaneo “come enciclopedia, come metodo di conoscenza,e soprattutto come rete di connessione tra i fatti, tra le persone, tra le cosedel mondo”. Cfr. U. Musarra-Schroeder, Il labirinto e la rete, cit., pp. 37 e40; M. Bresciani Califano, Uno spazio senza miti, Le Lettere, Firenze 1993,in part. pp. 95 e ss.
20 C. Bologna, La macchina del “Furioso”, cit., p. 87; G. Lukács, Theorie desRomans, Cassirer, Berlin 1920, trad. it. Teoria del romanzo, SE, Milano 1999,p. 50. La percezione di tale diversità e novità si ebbe del resto già presso icontemporanei, come provano le riflessioni di Giraldi Cinzio, che nel Di-scorso intorno al comporre dei romanzi (1554) apprezza proprio la varietà, edi Girolamo Ruscelli, che nel saggio Del modo di comporre in versi nella lin-gua italiana (1559) esalta la “cadenza armonica” dell’ottava per la sua capa-cità di condurre il flusso narrativo: cfr. C. Bologna, La macchina del “Furio-so”, cit., pp. 130-131; inoltre è da rilevare l’atteggiamento di Camões, chenel comporre il proprio poema epico rifiuta il modello ariostesco rinvenen-dovi il segno d’uno “sviamento” verso un altro genere: cfr. D. Quint, Epicand Empire, cit., p. 121. Sull’importanza della “formazione” e del “destino”,nonché dell’emanciparsi dallo sfondo epico nella formazione del nuovo ge-nere, si veda E.M. Meletinskij, Vvedenije v istoriceskuju poetiku eposa i ro-mana, Izdatel’stvo Nauka, Moskva 1966, trad. it. Introduzione alla poeticastorica dell’epos e del romanzo, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 250 e 320-321.Sul predominio degli axeis orizzontali cfr. D. Papotti, Geografie ariostesche.Coordinate verticali ed orizzontali nell’“Orlando Furioso”, in «Romance Lan-guages Annual», IX, 1997.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
67
L’analisi di Lukács, come si ha già avuto modo di vedere,prende posizione a favore della prosa, rilevando nell’epica nonuna lettura critica di uno “spazio dell’esperienza”, quella cheFoucault chiama eterotopia, ma soltanto “l’utopia del momentostorico”, poiché il verso riduce la sua capacità asoggettiva e tota-lizzante a gioco lirico o idillio. Eppure, guardando l’Orlando Fu-rioso con lo sguardo di Calvino, vi si ritrovano quei caratteri po-sitivi che Lukács riconosce al romanzo, poiché la libera invenzio-ne non si svolge più secondo la chiave allegorica, ma si trova sem-pre sulla scala delle esperienze umane (così l’isola di Alcina, cosìperfino il mondo della luna). In sostanza, una geografia in largaparte ignota deve essere immaginata non più sulla base di una re-gola codificata, ma ritrovata in re, nelle vicende umane, a partiredai contorni, dal profilo delle coste, come confessano di fare an-che i romanzieri contemporanei (Malerba, Tabucchi e lo stessoCalvino). Il gioco combinatorio di Ariosto, complessa costruzio-ne per corridoi e stanze, fughe e riposi, rime alternate e baciate,parte dal fenomeno; il suo paesaggio-mappa segna così lo sposta-mento dall’“interno” (il locus amoenus, il giardino) all’esterno, ciòche si trova sempre un passo in là, in cui però si ritrovano, se sivogliano leggere, come alla fine anche il conte Orlando deve fare,tutti i fili multiformi della storia.
La geografia (una geografia storica) è dunque un paradigmadella forma dell’Orlando Furioso agli occhi di Calvino, che iniziaa presentarlo proprio partendo dalla mappa:
… in ogni atlante storico del medioevo c’è una cartina in cui,colorate di solito in viola, sono segnate le conquiste di Carlo-magno, re dei Franchi e poi imperatore21.
E del resto anche nelle prime ottave del poema le vicende dei
21 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 9. La Presenta-zione è proposta anche in Orlando Furioso, cit., vol. I, pp. XXV e ss. Cfr.inoltre L. Waage Petersen, Il cavaliere e lo spazio: Ariosto e Boiardo nelle in-terpretazioni di Calvino e Celati, in P. Kuon (a c. di), Immagini e voci dellepianure, in Atti del Convegno (Salisburgo, 23-24 marzo 2000), Cesati, Fi-renze 2002.
Vincenzo Bagnoli
68
personaggi sono presentate proprio attraverso una dinamica diluoghi, in una sorta di scontro tra masse continentali:
… sotto i gran monti Pireneicon la gente di Francia e de Lamagnare Carlo era attendato alla campagna,per far al re Marsilio e al re Agramantebattersi ancor del folle ardir la guancia,d’aver condotto, l’un, d’Africa quantegenti erano atte a portar spada e lancia;l’altro, d’aver spinta la Spagna inantea destruzion del bel regno di Francia
(Orlando Furioso, I, V-VI).
In questo peculiare modo di costruire il proprio spazio lette-rario (nel duplice senso di spazio costruito dall’opera letterariama anche spazio delle opere letterarie, come si vedrà) il paesag-gio diventa modo di racconto. Lo era stato nella tarda antichitàper Rutilio Namaziano, che aveva saputo vedere, di là dal filtrodei manierismi virgiliani, la realtà storica del suo tempo e rac-contarla nel paesaggio, attraverso il paesaggio. Il Medioevo inve-ce, “nel ritrarre la natura, non si propone di rappresentare larealtà”: prevale la retorica, come spazio letterario dell’elencazio-ne enciclopedica, della lessicografia (nomina nuda tenemus è l’a-dagio), con temi e formule numeriche prefissate. È da notareperò che la riproduzione del sia pur stereotipato locus amoenus èritenuta “un necessario requisito della poesia”, la quale ha dun-que pur sempre l’ufficio (almeno teorico) di guardare al paesag-gio. In questo sguardo, inoltre, accanto all’epidittica sopravviveuna traccia della probatio della retorica giudiziale, l’argumentuma loco incaricato di rispondere alla domanda dove?22, una do-
22 E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Francke Ver-lag, Bern 1948, trad. it. Letteratura europea e medioevo latino, La Nuova Ita-lia, Firenze 1992, pp. 207 e ss., 217 e ss., 221. Si veda anche M. Liborio (a c.di), La descrizione. Le forme del romanzo medievale, Istituto universitarioorientale, Napoli 1991.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
69
manda di conoscenza. L’uomo moderno si trova quindi a doverreinventare le regole di costruzione dello spazio, con lo scardina-mento contemporaneo dell’assetto teologico del mondo e dellagriglia dei generi che possono descriverlo. Un nuovo modello èl’idillio geofisico, in cui la percezione della frammentarietà del-l’esperienza si accompagna alla consapevolezza della necessità diricomporre il totale attraverso leggi naturali, ricavando anche dalloro inumano (o extraumano) procedere un racconto e un senso,quale verrà proposto all’inizio dell’Ottocento da Humboldt23 eLeopardi, ma i cui antecedenti possono essere considerati Ario-sto e Galileo (o Machiavelli e Cartesio, o Sade e Diderot, o anco-ra altri binomi che accostino significativamente scienza e lettera-tura). Si accentua inoltre la spazializzazione della conoscenza, pereffetto dell’apertura degli orizzonti geografici e cosmologici ver-so il plurale, ma soprattutto con l’alterazione tipica dell’età de-mocratica, che richiede un’estensione e una parallela orizzonta-lizzazione del sapere, in chiave meno elitaria.
La letteratura entra così nell’età della prosa, e la geografia èfigura di una peculiare pluridiscorsività, che esiste anche nel poe-ma di Ariosto, nel sovrapporsi delle fonti in modo ironico: Boiar-do contro Virgilio, Dante contro Petrarca. Nato come “gionta”dal Boiardo, lo si è visto, entra subito in un rapporto critico-crea-tivo di variazioni e citazioni; quando per esempio richiama l’epi-sodio di Ziliante (XIX, XXXVII-XL), vi aggiunge il dettaglio deldono del braccialetto a Orlando, così che la citazione non risultisemplice ricamo, ma rifunzionalizzazione della fonte entro un di-verso contesto, ossia transcontestualizzazione24. Al tempo stesso
23 Per il quale proprio la lingua rappresenta il fattore determinante della “leg-gibilità del mondo”, permettendo ben più del disegno di attivare la dialetti-ca di “familiare” ed “estraneo”, e di scomporre inoltre il “quadro” nei “po-chi semplici tratti” e nella dinamica delle sue combinazioni, così da rag-giungere attraverso la raffigurazione stessa una migliore, superiore cono-scenza: cfr. H. Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurta.M. 1981, trad. it. La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della na-tura, Il Mulino, Bologna 1984, p. 310.
24 La definizione di transcontestualizzazione in L. Hutcheon, A Theory of Pa-rody: The Teaching of Twentieth-Century Art Form, Methuen, New York-London, p. 7; sul rapporto con le fonti, oltre a quanto detto da Bologna, si
Vincenzo Bagnoli
70
si confronta con un filone esterno e parallelo, il romanzo dell’a-nima del Canzoniere, del quale usa largamente stilemi (fino allaparodia diretta dell’epigrafe di Medoro tradotta da Orlando:“Liete piante, verdi erbe, limpide acque…”, XXIII, CVIII), matrasponendo la materia nei suoi colori “dal terreno lirico a quel-lo narrativo”25. Né mancano i ri-usi di Dante, come si avrà agio diricordare a breve, ma con la differenza fondamentale (è il trattodialettico della parodia) di ridisporre le ambientazioni secondopreoccupazioni che non sono dottrinarie (il contrario di ciò cheDante faceva in molti casi riusando lui stesso vari aspetti della tra-dizione a lui precedente), violando la topologia del “presepio”teologico, orizzontalizzando il viaggio sopra una scacchiera.
In questo senso dunque il poema è romanzo, nella prospetti-va di uno “spaesamento” (se non proprio straniamento) intesonon tanto a distruggere una forma, ma a costruirne una diversaricucendo assieme, rimettendo in relazione ciò che la storia hareso distante. Il genere cavalleresco ha del resto proprio tale fun-zione nell’Europa romanza: non tanto (non soltanto) l’avventurainiziatica (il passaggio all’“altra parte”), ma il senso, proprio diquella cultura, di uno sconfinare per riavvicinare. L’aventure perKöhler aveva lo scopo di elevare il destino a provvidenza e pre-destinazione, riconciliando individuo e comunità26. Perdersi perpoi ritrovarsi, riconoscendosi però non in un disegno superiorema in un destino comune: questo fanno agli occhi di Calvino ipersonaggi di Ariosto, questa è la scoperta di Astolfo sulla luna(ribadita dalla continua sottolineatura del poeta che si riconoscenella pazzia amorosa, anche se sviluppata su un registro diverso,
veda anche E. Sanguineti, La macchina narrativa dell’Ariosto, cit., p. 67: “loscarto è ancora parodico, e in senso tecnico: perché il contrasto non fa pre-mio sopra la continuità, ma si sviluppa in dialettica” (l’osservazione è riferi-ta ai titoli delle due opere). Un’analisi dettagliata e documentata dell’inter-testualità è di A. Casadei, Riusi (e rifiuti) del modello dell’“Innamorato” trail 1520 e il 1530, in La fine degli incanti. Vicende del poema epico-cavallere-sco nel Rinascimento, Franco Angeli, Milano 1997, pp. 25-44.
25 E. Sanguineti, La macchina narrativa dell’Ariosto, cit., p. 66.26 E. Köhler, Ideal und Wirklickheit in der höfischen Epik. Studien zur Form der
frühen Artus und Graldichtung, Max Niemeyer, Tübingen 1970, trad. it.L’avventura cavalleresca, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 113 e ss., 121 e ss.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
71
un altro ancora). Il senso delle “audaci imprese” pare dunquechiarito; la cortesia è la seconda coordinata del poema ariostesco,come l’autore dichiara, l’altro lato necessario dell’impresa, il suorisultato: il recupero e la condivisione della conoscenza ottenutiristabilendo una comunicazione simmetrica, atteggiamento ne-cessario per andare al di fuori dei confini e capire qualcosa, ren-dersi conto della propria parzialità, che magari, come Calvino os-serva, non può essere superata del tutto.
Il genere cavalleresco, costituito su un mito bretone raccon-tato da normanni trapiantati in Inghilterra, poi sviluppato inFrancia e in Germania, si pone sotto l’insegna della multicultura-lità come recupero di un orizzonte collettivo dopo il crollo dellaromanità27. Se nel Medioevo era servito a progettare una geogra-fia immaginaria di un’Europa che non c’era, così ora serve perun’immagine di geografia possibile, ma che ancora non c’è, di unmondo che si complica perché è più ampio e perché sono piùcomplessi i modi di conoscerlo: per una mappa del labirinto gno-seologico-culturale, direbbe Calvino. Köhler, rifacendosi a unadistinzione di Lukács, vede compiersi il trapasso dalla chanson degeste al romanzo cortese proprio nell’abbandono di una totalitàestensiva (inviolata unità di senso che permette il racconto comeserie di episodi slegati, che possono interrompersi e riprendere) afavore della totalità intensiva, quando si allontana l’immanenzatotale del senso e l’unità non preesiste in un mito ma è da rico-struire attraverso il senso di un percorso28. Che poi può esserefrustrato e deluso, o può sfaccettarsi in una miriade di episodi,non giungere mai al punto, ma non è questo che importa, diceCalvino:
… resta il dubbio che se ciò che veramente conta sia il lonta-no punto d’arrivo, il traguardo finale fissato dalle stelle, op-
27 K. Stierle, Le roman, une dimension de l’Europe littéraire, in M. Fumaroli, Y.Bonnefoy, H. Weinrich e M. Zink (a c. di), Identité littéraire de l’Europe,PUF, Paris 2000, pp. 35-51, in part. pp. 44 e ss.
28 E. Köhler, L’avventura cavalleresca, cit., p. 329, cita G. Lukács, Teoria del ro-manzo, cit., pp. 53 e ss.
Vincenzo Bagnoli
72
pure siano il labirinto interminabile, gli ostacoli, gli errori, leperipezie che danno forma all’esistenza.
Il che significa cercare “la struttura dei destini umani, per laprima volta in narrato, iuxta propria principia”29, vale a dire noncome destini ultimi tracciati nell’oltre, ma come i vari “qui” delpercorso rivisti in questa prospettiva orizzontale della memoria.Ma significa anche considerarli piuttosto desiderio, come la stes-sa struttura a inseguimento suggerisce.
Il compimento della metamorfosi in romanzo avviene dun-que con la riscrittura della mappa del mondo, ossia il trasferi-mento di una totalità epica a un’altra totalità, che non è l’unitàmetafisica di Dante, né quella monostilistica di Petrarca, né l’u-nità della cornice entro cui Boccaccio trattiene la pluralità sublu-nare. Non sono casuali quindi le metafore che sulla base di pae-saggi acquatici Foscolo sviluppa per i tre poeti: Dante è parago-nato a un lago montano, paesaggio spaventoso – sublime – macircoscritto; Petrarca a canali resi ormai “gore stagnanti”; Ariostoalle onde dell’oceano30. E con le onde dell’Atlantico nel Cinque-cento arrivava non solo la nuova forma della poesia ma anche lanuova forma del mondo.
2. La visione dall’alto: spazio, geografia e coordinate
Alla luce di quanto si è detto, risulta forse comprensibile ilparticolare valore conoscitivo che Calvino assegna alla leggerezzadel “gioco combinatorio”, alla “fantasia”, in opere come quella diAriosto, per lui chiaramente distinte dall’evasione, dalla “danzaserena” e dalla “vuota astrazione della vita”. Dopo aver osserva-to che “i giochi, da quelli infantili a quelli degli adulti, hanno
29 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 61. E. Sanguine-ti, La macchina narrativa dell’Ariosto, cit., p. 70, con l’instaurarsi nell’operadella “verità del romanzo” contro la “illusione cavalleresca”, la “parola ro-manzo” non è una “spiritosa metafora, ma una categoria necessaria”.
30 U. Foscolo, Notizia intorno a Didimo Chierico, in Viaggio sentimentale, Gar-zanti, Milano 1983, p. 341.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
73
sempre un fondamento serio”, sembra rinvenire infatti nella leg-gerezza del verso, nello sviluppo dell’ottava come “misura” (me-tro) dello “spazio ariostesco”, una risorsa fondamentale tanto peraffrontare la “larghezza” e la varietà, quanto per superare l’“opa-cità del mondo”, per divincolarsi dai labirinti (non ignorandoli):“quello d’Ariosto”, insomma, “è il gioco d’una società che si sen-te elaboratrice e depositaria di una visione del mondo, ma senteanche farsi il vuoto sotto i suoi piedi, tra scricchiolii di terremo-to”. È un gioco serio, che sta fra l’“addestramento tattico”, l’au-torappresentazione, il teatro quindi (e il saggio), la simulazione eperciò la mappa31.
Quale sia il fascino che Calvino sente emanare da questo inin-terrotto costruire storie che si incrociano le une nelle altre, so-vrapponendosi, intersecandosi, risulta chiaro, più ancora che dalsuo “raccontare” l’Ariosto (è Sanguineti a suggerirlo), dal Castel-lo dei destini incrociati, i cui tarocchi rappresentano un’altra im-portante suggestione rinascimentale. Accanto a Paolo Uccello,Mercator, Machiavelli, va allora chiamato alla ribalta un altro per-sonaggio della stessa epoca, quell’Enrico IV di Francia soggioga-to dai tarocchi al punto di chiudersi in una torre a “giocare” letragiche vicende delle guerre che sconvolgevano il suo regno32.
31 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., pp. 31-32, ripresoe ampliato in La struttura dell’“Orlando”, cit., pp. 76-77. Le obiezioni sonoquelle di G. Lukács, Teoria del romanzo, cit., pp. 50-51. Si riprendano an-che le osservazioni di W. Binni, Metodo e poesia di Ludovico Ariosto e altristudi ariosteschi, La Nuova Italia, Scandicci (FI) 1996, p. 109: “la creazionedi quel mondo perfetto è lontana dal ridursi a una pura libertà di giuoco”;p. 112: “prendendo un lato, un punto della realtà, ne crea una soprarealtàche in nuove dimensioni fantastiche si ricostruisce nel tono naturale e nellacomune visione del quotidiano”; e accanto le considerazioni di E. Turri, Ilpaesaggio come teatro, cit., pp. 26 e ss., che accosta gioco, teatro e paesaggio.
32 M. Corti, Il gioco dei tarocchi come creazione di intrecci, in Il viaggio testua-le. Le ideologie e le strutture semiotiche, Einaudi, Torino 1978, pp. 169-184.Sulle carte da gioco a Ferrara: G. Ortalli, Giovanni Cagnolo e don Messore:un laboratorio per fabbricare dei tarocchi alla corte di Borso d’Este; Id., ThePrince and the playing cards. The Este family and the role of courts at the timeof the “Kartenspiel-Invasion”; A. Franceschini, Note d’archivio sulle carte fer-raresi, tutti in «Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco», 2, 1996, rispett.alle pp. 163-169, 175-205, 170-174.
Vincenzo Bagnoli
74
Ma allora ha ragione Lukács quando vede nel poema cavallerescosoltanto le “fughe rassegnate verso le isole beate, non rilevabilisulla carta del mondo”? Il gioco, come insegnano i suoi interpre-ti, invita certamente a lasciarsi alle spalle il mondo come lo cono-sciamo, per entrare tuttavia in un diverso tipo di razionalità. L’in-gresso in un luogo condiviso e strutturato, ritualmente e ritmica-mente marcato come diverso dalla vita quotidiana, non pretendedi essere evasione o illusione assoluta (e come potrebbe, del re-sto?), ma definisce una modalità di coinvolgimento condizionata,un essere parte senza essere afferrati33; comportando uno spaesa-mento, ma controllabile, serve quindi ad affrontare la sfida delnuovo, a ricondurre nei limiti del familiare ciò che è estraneo34.Quella che Calvino nota non è tanto la giocosità della cultura po-polare, con la sua meccanica di rovesciamento35, e non è soltantoil gioco come simulazione, ma una messa in scena della cono-scenza ben più moderna dei teatri allegorici a essa contempora-nei: vi riconosce infatti i tratti di quella relazione da istituire conla realtà nella quale esploriamo noi stessi e la società, indaghiamola cultura e la creiamo, che altrove chiama la “sfida al labirinto”,alla quale non compete promettere via d’uscita o evasioni.
Il gioco, per poter esistere, ha bisogno di regole certe, di de-limitazioni spazio-temporali che traccino i confini attraverso iquali liberamente entrare o uscire. Per questa ragione altre operericorrono a chiusure artificiali in architetture o sotterranei(dall’Hypnerotomachia Poliphili al Manoscritto trovato a Saragoz-za), mentre nel Furioso il labirinto si svolge en plein air, sulla va-
33 Si veda il primo capitolo di J. Huizinga, Homo ludens. Proeve eener bepalingvan het spel-element der cultuur, Tjeenk Willink, Haarlem 1938, trad. it.Homo ludens, Einaudi, Torino 1946, pp. 10-15 e 28.
34 Calvino osserva qualcosa del genere anche a proposito di Enzensberger, inCibernetica e fantasmi; cfr. U. Musarra-Schroeder, Il labirinto e la rete, cit.,pp. 28-29.
35 Quella che Bachtin indaga nell’opera rabelesiana: M. Bachtin, TvorčestvoFransua Rable i narodnaja kul’tura srednevekov’ja i Renessansa, Chudožest-vennaja literatura, Moskva 1965, trad. it. François Rabelais e la cultura po-polare nel Medioevo e nel Rinascimento, Einaudi, Torino 19823. Essa rap-presenterebbe in questa prospettiva (che è quella di Lotman, cfr. cap. I) solouna delle possibili forme di contrapposizione dialettica.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
75
sta superficie del mondo e sotto un cielo (un’atmosfera) che èl’immagine della totalità ricompresa. Davanti allo stato di “con-fusione tattica” innescato dall’apertura del mondo, il volo aereonasce come fantasia reattiva e come figura della libera creativitàintellettuale (così nella metafora barocca e nelle avanguardie pri-monovecentesche)36; certo occorrono figure di ruolo e personag-gi adatti per condurre un simile gioco, come occorre una precisastruttura. Il personaggio più volatile, quello che alla fine piace dipiù a Calvino per la sua particolare posizione, per il suo ruolo eper il suo modo quindi di guardare al mondo, è Astolfo, le cui ca-valcature (per Calvino, ma non solo, la cavalcatura è il procederedel racconto) nel corso del poema sono Rabicano, destriero natoda una fiamma in forma di cavalla e un soffio di vento, e l’aereoippogrifo. In Astolfo, Calvino ritrova i contorni del mito di Per-seo e Medusa, l’unico a suo avviso in grado di permettere, neisuoi stessi processi creativi, una “sintonia” tra “il movimentatospettacolo del mondo” e “il ritmo interiore picaresco e avventu-roso che mi spingeva a scrivere”. Il problema è appunto che
tra i fatti della vita che avrebbero dovuto essere la mia mate-ria prima e l’agilità scattante e tagliente che volevo animasse lamia scrittura c’era un divario che mi costava sempre più sfor-zo superare. Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza,l’inerzia, l’opacità del mondo: qualità che s’attaccano subitoalla scrittura se non si trova modo di sfuggirle37.
Perseo è l’eroe in grado di resistere alla pietrificazione di Me-dusa, e di far scaturire addirittura dal sangue del mostro decapi-
36 E. Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, Venezia 1688, p. 161: la metafora,“portando a volo la mente da un genere all’altro, fa travedere in una sola pa-rola più di un obietto”, cit. da E. Raimondi, Ingegno e metafora nella poeticadel Tesauro, in Letteratura barocca. Studi sul Seicento italiano, Olschki, Firen-ze 1982, pp. 1-32; F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista,in L. Scrivo, Sintesi del futurismo. Storia e documenti, Bulzoni, Roma 1968,pp. 50 e ss.; cfr. inoltre J. Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque,Skira, Genève 1970, trad. it. Ritratto dell’artista da saltimbanco, Bollati Bo-ringhieri, Torino 1984.
37 I. Calvino, Lezioni americane, cit., p. 8.
Vincenzo Bagnoli
76
tato l’alato Pegaso, ma non solo: impara a servirsi anzi del poteredella “realtà del mondo” che porta sempre con sé e che, secondoOvidio, diventa persino motore di meravigliose metamorfosi.Astolfo incarna dunque tale figura di ruolo, con le sue molteplicie varie avventure, e vedremo meglio a breve come viene nel com-plesso del poema a contrapporsi al triste destino di Orlando, checontinua a percorrere la sua via come se si trovasse ancora nelcronotopo omerico della strada, il percorso unico e lineare del-l’eroe, ma cozza contro la prosa della vita e il vicolo cieco del la-birinto, fino a restare (non è un caso) accecato e pietrificato: “Ri-mase al fin con gli occhi e con la mente / fissi nel sasso, al sassoindifferente” (cioè non diverso dal sasso: XXIII, CXI, vv. 7-8)38.“Duro destino è l’avere un destino”, commenta Calvino, perché“la strada che il predestinato deve percorrere può essere non unalinea retta ma un interminabile labirinto” che alla fine diventa lastessa forma dell’esistenza, come si è detto39. Il riferimento è aRuggiero, per la precisione, ma si tratta comunque di un perso-naggio che a propria volta riesce a cavalcare l’ippogrifo ed è quin-di in grado di muoversi nello spazio e di guardarlo dall’alto, sco-prendone la dimensione labirintica.
Qual è dunque la forma che delimita lo spazio del gioco, inquesta visione, la struttura spazio-temporale (il cronotopo, si po-trebbe dire) che determina la forma dell’opera? Lo stesso Calvi-no ci ha offerto la sua chiave, nell’introdurre il suo “racconto”: lamappa, l’immagine della terra vista dall’alto40. I personaggi diAriosto volano dunque non perché sono in fuga, ma perché ve-dono il mondo sulle carte geografiche; se la visione zenitale è undistanziamento dalle cose, pure è al contempo un continuo con-fronto con la loro disposizione e le loro figure, non l’evasione inun’utopia ma una relazione con “tutti gli altri luoghi”, l’eteroto-pia di Foucault. Così il volo d’Astolfo sopra l’Africa verso il “Pre-
38 Sulla “cristallizzazione” del movimento implicita nel percorso labirintico in-siste G. Barlusconi, L’“Orlando Furioso” poema dello spazio, cit., p. 62; mami pare specifica del procedere di Orlando.
39 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 61.40 Su questa prospettiva come dominante nel poema cfr. A. Momigliano, Sag-
gi su l’“Orlando Furioso”, Laterza, Bari 1948, pp. 6-7.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
77
teianni” (nello spazio del mito) si dipana con minuziosi movi-menti (a zig zag) sulla concreta referenzialità della mappa, di unamappa “vera”41, almeno fino a un certo punto (XXXIII, XCVI-CVII): esso non è funzionale solo alla realizzazione di un accumu-lo catalogativo né al mero “effetto di realtà”, come hanno soste-nuto molti interpreti (ma Binni pure intuiva la “freschezza” deri-vante dalla geografia)42.
La mappa, dunque, non è solo “stratagemma” narrativo, mavera strategia, come si vede a proposito di un altro celebre volo,quello di Ruggiero verso l’isola di Alcina nel canto sesto (XVII-XX-VII)43: sempre a dorso d’ippogrifo l’eroe, che ne ha perso il con-trollo, viene suo malgrado portato oltre una delle soglie del Me-dioevo, dove fino ad allora nessuno era mai stato (almeno in lette-ratura). È questo dunque uno dei primi approdi letterarinell’“informe” del nuovo, ed è ben necessario che il poeta troviuno “sguardo” capace di organizzarlo, di raccontarlo. Tale sguar-do, che attirò l’attenzione di Binni per il proprio movimento, qua-si uno zoom, fino alla concretezza del dettaglio finale (i tre alberipresso i quali Ruggiero, arrivato a terra, lega l’ippogrifo, rispettoalla varietà della foresta prima descritta)44, può essere a ragione de-finito uno “sguardo strategico”: vi domina la preoccupazione delcartografo moderno, accanto alla nomenclatura del mito letterario,quella stessa che si ritrova negli elogi di Ferrara, articolati sulla suavantaggiosa posizione da un punto di vista militare (XXXV, VI eXLIII, XXXII). L’eco virgiliana, in questi come nell’episodio di Rug-giero, viene ricontestualizzata, e Calvino non manca di notarecome in tutto il poema coesistano i “due piani temporali”: “quellodella favola cavalleresca e quello del presente politico-militare”.
41 E. Cerulli, Il volo d’Astolfo nell’Etiopia nell’“Orlando Furioso”, in «Rendi-conti dell’Accademia dei Lincei», VI s., vol. VIII, 1932, p. 19-38, segnala frale fonti il planisfero di Angelino Dalorto (1325).
42 W. Binni, Metodo e poesia, cit., p. 119.43 Che Ruggiero dall’alto veda il mondo come una mappa lo suggerisce lo stes-
so Ariosto già all’inizio della “peripezia”, nel canto IV (XLIX, vv. 6-8), quan-do l’ippogrifo sale nel cielo al punto che Ruggiero “di sotto rimaner vedeogni cima / et abbassarsi in guisa, che non scorge / dove è piano il terren nédove sorge”.
44 W. Binni, Metodo e poesia, cit., p. 120.
Vincenzo Bagnoli
78
Il materiale usato per la descrizione è quello letterario, desun-to dalla stereotipia del locus amoenus: il paesaggio retorico deriva-to da Omero, il bosco con le varie specie di alberi, il tappeto flo-reale, il quadretto con albero, contrassegno di luoghi nodali, fon-te e prato45. Tuttavia con esso non si approda al catalogo e all’en-ciclopedismo lessicale, né all’effetto di pittoresco, poiché Ruggie-ro, che è spaventato e disorientato (XVII), vi desume anzi gli indi-zi di tranquillità che lo rassicurano però non a dedicarsi a ozi cam-pestri o a pastorelle, ma ad orientarsi, prendere terra e posare learmi. Vede prima la forma dell’isola, trovando un parallelo nell’e-sperienza (filtrata attraverso una “mappa” letteraria condivisa);poi i tratti generali della sua geografia, pianura, colli, corsi d’ac-qua, boschi; quindi la tipologia delle piante e, più ancora nel det-taglio, degli animali che vivono tra esse, notando che nel loro com-portamento non v’è traccia di spavento. Ne deduce quindi l’as-senza di minacce per sé, e prende terra in cerca di ristoro. Nell’e-pica classica il “bosco composito” di Virgilio era diventato unostereotipo privo di qualunque rapporto con l’osservazione dellanatura, ma ridotto a esercizio di nomenclatura lussuosa, alla va-rietà del catalogo. La descrizione di Ariosto, che pure risente diquesta stereotipia, non si limita alla decorazione, poiché il raccon-to del paesaggio visto da Ruggiero vuole descriverci il suo mododi guardare, con uno sguardo deduttivo che non si accontenta diuna generica “impressione” dal paesaggio, ma tenta un entimema.A suo modo, quindi, Ariosto usa il topos non come soluzione dipaesaggio, ma come strumento di misura, proprio come Colombonel nuovo mondo quando non capisce cosa sta vedendo.
Si nota infatti in questo passo come la somma dei dettagli nonresti statica descrizione decorativa, il catalogo accumulativo es-sendo l’antitesi del paesaggio come noi lo intendiamo, ma si svi-luppa in senso, costruisce una sorta di “racconto” topografico(capace di includere al proprio interno, procedendo poco oltre,anche le allegorie, come l’affresco già citato), cui verrà poi a som-marsi anche una descrizione storica. Quando infatti il poema “ri-schia” di tramutarsi in allegorico, Ruggiero, come nota Calvino,
45 E.R. Curtius, Letteratura europea e medioevo latino, cit., pp. 209 e ss.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
79
cerca di “uscirne al più presto”, divincolandosi da quel labirintodi significati per tornare al labirinto del suo destino: e lo fa otte-nendo proprio da Astolfo il compendio della situazione dell’iso-la nei termini di una mappa militare (XLIII-XLV, in particolare conil raffronto alla topografia di Scozia e Inghilterra)46. Questi movi-menti dal dettaglio al totale sviluppano quindi un’immagine di te-nuta d’insieme, che non è però la “totalità epica”: almeno nellalettura di Calvino il punto di partenza, il pregiudizio ermeneuti-co, l’orizzonte che sta alle spalle del poema è la carta geografica,sulla quale si inscrive il “movimento” delle sue linee narrative. Lelasse che sussistevano scomposte e disunite del poema cavallere-sco, le une accanto alle altre, vengono rilegate in un nuovo tipodi totalità attraverso la digressione, il sentiero laterale, che le ri-cuce in una trama (ben diversa dalla diegesi artificiale di Petrar-ca)47 la cui forma è la forma della geografia del mondo (come mo-stra anche un altro volo di Ruggiero a dorso d’ippogrifo: X, LXIX-LXXII), fra la rete ampia delle coordinate (una scacchiera anch’es-sa) e l’intrico della topografia che sotto di essa si articola, si mol-tiplica e si complica. Il passo del cavallo, dunque, contiene nonsolo lo scarto, la digressione, come ben sapevano Sterne e Dide-rot, la fuga dall’angolo dell’occhio (ogni fuga è una fuga dallamorte, postillava Tolkien, quindi anche dalla “pietrificazione”48),ma anche il volo, veloce come lo scorrere dell’occhio sulla map-pa, perché mediante tale sguardo è possibile rappresentare unatale complessità con la dovuta rapidità che compete allo stile poe-tico, ossia immaginare:
46 Cfr. I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 69. Si raf-fronti questa descrizione al sonetto dei fiumi di Petrarca, come lo legge G.Bertone, Lo sguardo escluso, cit., p. 97.
47 C. Bologna, La macchina del “Furioso”, cit., p. 116. Sul paesaggio in Petrar-ca rimando a K. Stierle, Paesaggi poetici del Petrarca, in R. Zorzi (a c. di), Ilpaesaggio. Della percezione alla descrizione, Marsilio, Venezia 1999, pp. 121-137, dove si osserva che il poeta è effettivamente tra i primi a cogliere quel-la fascinazione della visione paesaggistica che è uno dei tratti della moder-nità, senza approdare però a una realizzazione estetica.
48 J.R.R. Tolkien, Tree and Leaf, George Allen & Unwin, London 1964, trad.it. Albero e foglia, Rusconi, Milano 1976, pp. 82 e ss e p. 90.
Vincenzo Bagnoli
80
La rapidità e la concisione dello stile piace perché presentaall’anima una folla d’idee simultanee […]. La forza dello stilepoetico, che in gran parte è tutt’uno colla rapidità, non è pia-cevole per altro che per questi effetti […]. Perché è debole lostile d’Ovidio, e però non molto piacevole, quantunque eglisia un fedelissimo pittore degli oggetti ed un ostinatissimo eacutissimo cacciatore d’immagini? Perché queste immagini ri-sultano in lui da una copia di parole e di versi, che non desta-no l’immagine senza lungo circuito, e così poco o nulla v’ha disimultaneo […]. Perché lo stile di Dante è il più forte che maisi possa concepire, e per questa parte il più bello e dilettevolepossibile? Perché ogni parola presso di lui è un’immagine49.
Attraverso la strategia del piano di lontananza come terminedell’osservazione cominciano così le “battaglie della coscienzamoderna”50, delle quali sono caratteristiche lo spaesamento e ilriorientamento, la ricontestualizzazione: in quest’ottica è semprepossibile “riterritorializzare” l’esperienza, per dirla con Deleuze,nel campo del conoscibile, laddove in Dante essa poteva cadere interritori al di fuori del controllo umano, molto al di sopra delle fa-coltà cognitive, mnemoniche, espressive. L’episodio di Ruggierotraduce in termini moderni la quest, risolvendo le tappe e le ca-denze del percorso iniziatico in moderne strategie di conoscenza.
Tornando al canto sesto dell’Orlando Furioso, va notatocome cambia la prospettiva di Ruggiero una volta che ha presoterra: lo sguardo, lo stato d’animo, quello di chi è uscito dal pe-ricolo, i gesti che compie nel ristorarsi tradiscono ancora un’al-tra citazione: la “marina”, il “tremolar”, riferito però a faggi eabeti sulle “alte cime” (alberi, comunque, non allegorie), il vol-gersi ora dall’una ora dall’altra parte, il bagnarsi le palme e il visosono echi ben riconoscibili del primo canto del Purgatorio (can-to ricco di spunti paesistici)51. In fin dei conti l’isola su cui si tro-
49 G. Leopardi, Zibaldone, 3 novembre 1821, 2041-2043. 50 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., p. 121.51 Sulle presenze di Dante in Ariosto: C. Segre, Un repertorio linguistico e sti-
listico dell’Ariosto: la “Commedia”, in Esperienze ariostesche, Nistri-Lischi,
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
81
va l’eroe è posta anch’essa fuori dalle Colonne d’Ercole, e ci vie-ne presentata dal poeta con i tratti del locus amoenus, seppur svi-luppati come si è detto in altro modo: ripercorrendo brevemen-te la storia del topos, va ricordato che se in Isidoro ha una va-lenza tecnico-geografica, nell’epica filosofica successiva al XIIsecolo diventa il modo di rappresentare proprio il paradiso ter-restre52. È quindi logico che si presenti tale analogia con Dante,ma con alcune sostanziali e decisive differenze: l’eroe vi è giuntoinfatti non compiendo l’“altro viaggio”, attraverso la metafisica,ma davvero con un “folle volo” di “tremila miglia”, cifra iper-bolica, avvertono i commenti, comunque sempre misura di su-perficie. La sua stanchezza è stanchezza vera, non afflizione mo-rale, come il suo spavento: non è questione di maggiore o mino-re realismo, ma di un rapporto di scala delle esperienze, che peril pellegrino dantesco sono nettamente al di sopra dell’ordinario,in rapporto paradigmatico con l’umanità, mentre per l’eroe ario-stesco (per quanto eccezionali siano le sue avventure) si colloca-no in contiguità metonimica rispetto all’umano, come sottolineal’uso particolare – ironico, cioè obliquo – della prima personadel narratore che assimila alla propria esperienza quella del ca-valiere (“io non gli voglio creder che tremante / non abbia den-tro più che foglia il core”: XVII, vv. 3-4). Allo stesso modo la suafisica necessità di sicurezza e ristoro deve trovare soddisfazioneattraverso l’uso dei sensi e della ragione umana, non da un ritoné dal saggio avviso dello spirito di Catone o Virgilio. Lo sguar-do calcolante di cui si serve Ruggiero è simile a quello dei mer-canti viaggiatori (fino a Colombo che studia e descrive gli alberidi Hispaniola)53, i quali, a differenza dei pellegrini, devono rica-
Pisa 1966, pp. 51-83; L. Blasucci, Ancora sulla “Commedia” come fonte lin-guistica e stilistica del “Furioso”, in «Giornale storico della letteratura italia-na», LXXXV, 1968, pp. 188-231. La somiglianza di questo passo al paradi-so terrestre notata anche da D. Quint, Epic and Empire, cit., p. 282.
52 E.R. Curtius, Letteratura europea e medioevo latino, cit., pp. 216-221.53 Si veda Ch. Bec, Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence,
1375-1434, La Haye, Paris 1967. Un esempio sono i Ragionamenti di France-sco Carletti Fiorentino sopra le cose da lui vedute ne’ suoi viaggi si dell’Indie Oc-cidentali, e Orientali come d’altri paesi… (ora F. Carletti, Ragionamenti dei
Vincenzo Bagnoli
82
vare informazioni dal paesaggio, non decorarlo con le figure del-le loro aspettative54. I resoconti di viaggi sommati alla citazionedantesca e a quella virgiliana dell’arbusto parlante (in questa ve-ste metamorfica viene incontrato Astolfo), a propria volta già ci-tato in Dante, costituiscono la legenda della mappa: la spia checi rivela la presenza di altri sguardi, spiega anche la tecnica car-tografica di Ariosto, che non traccia la mappa di un territorioreale né la descrizione di un’utopia fantastica, ma realizza unatlante di viaggi, avventure, sguardi, insomma una mappa di li-bri e scritture, fra cui anche carte geografiche.
La “totalità” dell’Orlando Furioso, ben diversa da quella epi-ca, è la complessità delle rappresentazioni dell’esperienza neimolti codici coinvolti: la complessità del flusso del racconto nelquale gli stessi eroi divengono camminando, come anche della“descrizione in atto” di un mondo nuovo che comincia proprioin quegli anni. Sulla scorta di Mercator, che disegna le sue map-pe man mano che giungono dai viaggiatori le notizie, si colloca ilpadrón real, il planisfero nella Casa di Contratación a Siviglia cheregistra a beneficio dei commercianti ogni nuova scoperta, e ci sa-ranno le mappe di Cassini in continuo aggiornamento presso lacorte di Francia55. Ma prima di tutto questo c’è Ariosto, che,come si dedica a una paziente opera di correzione, rielaborazio-ne e aggiornamento del proprio testo, così parte dai contorni im-precisi di un mito o di un resoconto di scoperte in fieri (le Isolefortunate, le Azzorre) e vi disegna sopra le proprie immagini a vo-let clos, nel chiuso della città dalla quale non amava muoversi, percolmare gli spazi bianchi rimasti in un modo che può ricordarecerto quello del mito, ma che in realtà si vale ormai di coordina-
miei viaggi intorno al mondo, Einaudi, Torino 1989); C. Colombo, Giornale dibordo e del primo viaggio della scoperta delle Indie, Fabbri, Milano 1997. Siveda inoltre D. Perocco, Viaggiare e raccontare. Narrazione di viaggio ed espe-rienze di racconto tra Cinque e Seicento, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1997.
54 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., p. 42.55 I. Calvino, Il viandante nella mappa, cit., pp. 27-28. Su Cassini: D. Buisseret
(a c. di), Monarchs, Ministers and Maps. The Emergence of Cartography as aTool of Government in Early Modern Europe, University of Chicago Press,Chicago 1992.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
83
te diverse, considerando cioè tali spazi immaginati alla stregua dispazi misurabili (e va ricordata l’osservazione foscoliana secondola quale le “strane finzioni” erano rappresentate da Ariosto“come se fossero creazioni fantastiche veramente della natura”)56.Ariosto che costruisce quindi la sua phantasia sulle linee della to-pografia, come l’enfant baudelairiano di Le voyage (la CXXVI diLes Fleurs du Mal, dedicata non a caso al Du Camp grande viag-giatore e autore di Les Chants modernes), affidandone lo svilup-po nello spazio rimasto bianco ai personaggi, così come farannoil Marlowe di Heart of Darkness e il Frodo del Lord of the Ringsdopo aver a loro volta fantasticato sul bianco delle mappe in gio-vane età. Ariosto che interpreta insomma la mappa del mondo fi-sico – con le sue inevitabili lacune – non operando come gli au-tori delle chartes moralisées, che riempiono gli spazi bianchi configure allegoriche, ma proponendo il suo scrivere come una“gionta” a questi dati (tenendo a mente quanto si è detto al pro-posito), che li ricombina e li glossa gli uni con gli altri, con le di-verse forme dei loro racconti, così che nella lettura del poema“scorre una carta geografica sontuosamente istoriata di figure e dicartigli, dove le meraviglie dei viaggi di Marco Polo si sommanoalle profezie delle scoperte cinquecentesche, le notizie tramanda-te dagli autori classici agli echi delle spedizioni di Cortez”57.
La scarsa propensione al viaggio di Ariosto ha costituito inpassato la chiave per leggere nelle peripezie del poema una con-trapposizione fantastica alla geografia; pare tuttavia chiaro, alla
56 Sul primo si veda A. Casadei, I percorsi del “Furioso”, Il Mulino, Bologna2001 (nuova ed.); sul secondo A. Doroszlaï, Ptolòmée et l’hippogriffe. Lagéographie de l’Arioste soumise à l’épreuve des cartes, Edizioni dell’Orso,Alessandria 1998 e Id., Les sources cartographiques et le “Roland Furieux”:quelques hypothèses autour de l’“espace réel” chez l’Arioste, in Espaces réels etespaces imaginaires dans le “Roland Furieux”, Université de la SorbonneNouvelle, Paris 1991, pp. 11-46. La citazione di Foscolo è in W. Binni, Me-todo e poesia, cit., p. 80; cfr. inoltre ibidem, pp. 221 e ss. Più in generale sul-l’uso del mito nella costruzione di un modello moderno cfr. R. Ceserani,Due modelli culturali e narrativi nell’“Orlando Furioso”, in «Giornale stori-co della letteratura italiana», 1984, 516, pp. 481-508.
57 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 137: il riferi-mento è al già citato brano del XV canto, ottave XVIII-XXXVI.
Vincenzo Bagnoli
84
luce delle precedenti considerazioni, che la trattazione letteraria,la finzione (ma anche la mappa è una fictio, a suo modo) non deb-ba essere necessariamente posta in una relazione contrastiva conil viaggio e la mappa autografa, quanto piuttosto in un rapportodi integrazione, fra rielaborazione, citazione e variazione, con i“viaggi” che il poeta è comunque tenuto a compiere attraverso lalettura, di libri come di mappe58. Un esempio è dato dall’episodioungherese di Ruggiero aggiunto tardi (1532), dopo che la missio-ne del cardinale Ippolito, alla quale Ariosto aveva rifiutato di par-tecipare, aveva comunque portato a Ferrara informazioni di queiluoghi e della guerra turco-magiara. Se il poeta non viaggia, viag-giano comunque le notizie e viaggiano le carte, merce preziosissi-ma, al punto che i potenti ricorrevano alla corruzione per averle;e su questo rapporto fra topothesia e phantasia si può tornare aquanto si osservava su Baudelaire, non però senza aver ricordatola chiosa sul “cosmopolitismo” ariostesco di Gioberti, che vede-va introdurre, attraverso la commistione di massima precisionegeografica e località completamente immaginarie, “quell’arcanaperplessità di contorni” che giova all’immaginazione, nella qualeva infine riconosciuto non tanto il piacere dello sfumato ma, perun verso, certi tratti della “perplessità sistematica” di Calvino eper un altro il “vago” leopardiano necessario all’immaginazione,di cui si dirà oltre59. Che il poema abbia una “inspiration carto-graphique” e che le mappe siano un “campo d’azione privilegia-to” per la fantasia (da intendere dunque nell’accezione cui si èfatto riferimento), nonché “motivo di continua freschezza per la
58 Già W. Binni, Metodo e poesia, cit., p. 232, osservava: “È una specie di viag-gio fantastico, che presuppone, però, l’appoggio di una salda, sicura espe-rienza concreta di paesaggi”; ma si può integrare questo punto di vista conA. Rochon, La mer dans le Roland Furieux, in Espaces réels et espaces imagi-naires, cit., pp. 129-249, che corregge l’opinione secondo cui la geografia,pur col senso del vissuto, sia pronta a cedere alla fantasia. Nel poema è in-vece difficile distinguere la realtà da ciò che non lo è, perché l’immaginariosi nutre dei dati del reale non come libera evasione, ma con le regole del gio-co. Sul “piacere di percorrere”, ibidem, p. 195 e P. Fasano, Letteratura eviaggio, Laterza, Roma-Bari 1999.
59 V. Gioberti, Del primato morale e civile degli italiani, UTET, Torino 1920, vol.III, pp. 21-22, cit. in W. Binni, Metodo e poesia, cit., p. 83.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
85
poesia ariostesca”, la cui intonazione e armonia dipendono pro-prio dalla “varietà”, lo fa capire lo stesso Ariosto nella Satira III(vv. 58-66), quando dichiara di preferire il viaggio mentale “sicu-ro in su le carte” fatto “con Ptolomeo”, oppure con gli ufficiali dirotta che cercano la posizione sulle loro carte nautiche nel mezzodella tempesta60:
Chi sta col capo chino in una cassasu la carta appuntando il suo sentieroa lume di lanterna piccolina,[…]Un sotto poppe, un altro sotto proraSi tiene inanzi l’oriuol da polve;e torna a riveder ogni mezz’oraquanto è già corso, et a che via si volve:indi ciascun con la sua carta fuoraa mezza nave il suo parer risolve…
(Orlando Furioso, XIX, XLIV-XLV)
Se le mappe, insomma, per chi si trova in mare, sono un “oc-chio del ciclone” che permette di seguire con la debita distanzauna navigazione pericolosa e orientarsi, offrono invece a chi sta aterra un documento di ben maggior rilievo, rispetto al lucrezianospettacolo del naufragio, relativamente ai percorsi di un mondoin cui si è pure in qualche modo coinvolti. Si è accennato al fattoche per mestiere Ariosto aveva imparato a servirsi di quei mo-derni “strumenti” di conoscenza che erano le carte. Per le signo-rie italiane le mappe e i disegni che rappresentano le loro pro-prietà sono il “paesaggio-palcoscenico” della storia familiare edel prestigio, della legittimità del potere: se la cartografia catasta-le diventa uno “scudo d’Enea”, il poeta che deve scrivere un poe-ma celebrativo non può certo ignorarle. Inoltre le carte acquisi-vano una funzione tecnico-conoscitiva, finalizzata alla conquistadel territorio e all’organizzazione della battaglia, ma anche al con-
60 A. Doroszlaï, Les sources cartographiques et le “Roland Furieux”, cit., pp. 11e 14; W. Binni, Metodo e poesia, cit., pp. 119 e 149 e ss.
Vincenzo Bagnoli
86
trollo dello spazio che doveva esercitare un commissario ducaleinviato a governare una regione61. La familiarità che Ariosto esi-bisce con esse, familiarità certo maturata attraverso un’intensafrequentazione, come pure dei resoconti di viaggio (si veda peresempio XV, XXI-XXII)62, serve dunque come base alla moltepli-cità dei tragitti e alla loro precisione, e a uno sguardo che ab-braccia il mondo intero, ampliandosi alla grandezza della naturarerum, grazie alla scala ridotta, non però tentando di realizzarenell’opera un microcosmo che esaurisce il macrocosmo. La carta,la mappa zenitale catastatica, nella quale è comunque una traccia
61 E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., pp. 86 e 89, ma cfr. anche I. Calvino,L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 19. Sull’interesse della corted’Este per le carte si veda C. Greppi, Una carta per la corte: il viaggiatore im-mobile, in W. Moretti (a c. di), Il Rinascimento a Ferrara e i suoi orizzonti eu-ropei, Edizioni del Girasole, Ravenna 1984, pp. 199-222. L’uso della carta diParigi è ben studiato, come riassume A. Doroszlaï, L’Ariosto geografo-topo-grafo e stratega. L’assedio di Parigi nell’“Orlando Furioso”, Tesi di laurea, Uni-versité Paris VIII, 1985. Sulle connessioni e interferenze tra linearità del testoe sinossi dell’immagine in Ariosto cfr. A. Quondam, L’esperienza di un semi-nario, in La corte e lo spazio: Ferrara estense, a c. di G. Papagno e A. Quon-dam, Bulzoni, Roma 1982, pp. 1063-1089. Sull’uso attento dello spazio M.Plaisance, Lo spazio ferrarese nelle prime due commedie dell’Ariosto, in La cor-te e lo spazio: Ferrara estense, cit., pp. 247-255.
62 A. Doroszlaï, Les sources cartographiques et le “Roland Furieux”, cit., elencauna ricca serie di probabili fonti geografiche di Ariosto: Tolomeo, Strabone,Pomponio Mela, Pierre d’Ailly, Enea Silvio Piccolomini; i libri di viaggio dipellegrini, di mercanti ed esploratori come Marco Polo, Oderico da Porde-none, Nicolò dei Conti, Cardamosto, Vasco de Gama, Colombo e Vespuc-ci. Fra le carte e i portolani che gli erano accessibili ricorda il planisfero diMartellus Germanus (1490 ca.), documentando con precisione quelle di-sponibili presso la corte estense: il Mappamondo Catalano Estense, la Car-ta di Cantino (dal nome di un agente d’Ercole d’Este che la spedì dal Por-togallo), rimandando poi alle prove fornite da G.B. Bolza, corrette e com-pletate da Vernero, citando tre planisferi ritrovati all’inizio del Novecento erisalenti ai primi anni del Cinquecento. Mette conto qui aggiungere fra i re-soconti di viaggio anche la Topographia Terrae Promissionis dedicata a Bor-so d’Este dal francescano Alessandro Ariosto, autore anche di un dialogoplatonico sul tema geografico con il cugino Ludovico (omonimo del poeta).Un’utile panoramica sul genere in D. Defilippis, La rinascita della corografiatra scienza ed erudizione, Adriatica, Bari 2001; ma al proposito da vedere an-che G. Scaramellini (a c. di), Testi di viaggio e geografia, Unicopli, Milano 1985e La geografia dei viaggiatori: raffigurazioni individuali e immagini collettive neiresoconti di viaggio, Unicopli, Milano 1993.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
87
dell’interpretazione soggettiva, dell’emozione, del suo percepirel’atmosfera oltre che della topografia, può infatti insegnare il va-lore strumentale di lettura del mondo che consente nuove lettu-re: permette i progetti su ciò che è “bien au-delà de l’horizon”63.
Il poeta come regista e come stratega è ormai pronto a servirsidi tutte le risorse della conoscenza, incluse le “mappe testuali”,con un’estrema libertà nell’uso delle fonti, rifiutando ogni cano-ne imitativo, per tentare un’immagine, la più articolata possibile,del “labirinto gnoseologico-culturale” della sua epoca; al puntoche Voltaire, a propria volta autore di “giri del mondo” in “ful-minei fotogrammi” poté apprezzare l’inclinazione ironica nel riu-so della fonte virgiliana (XXXV, XXVI)64. “Sotto lo sguardo d’A-stolfo per l’ultima volta” dice Calvino “il mondo tenta di dispie-gare sulla stessa mappa tutte le dimensioni dell’immaginazioneumana”: così “l’Egitto è quello d’Erodoto e della Bibbia e insiemequello delle cronache dei pellegrini”65. Rispetto al cliché descritti-vo retorico, pure ancora attivo, comincia a manifestarsi anche l’in-terpretazione del dettaglio, che rende ragione di un altro ordinesemantico: non quello degli ordini teocentrici, ma dell’autonomaragione del mondo. È questa la differenza fra le elencazioni reto-riche, le ecphraseis nominaliste del Medioevo e la descrizione stra-tegica, anche se non vera, basata sulla ricerca, sull’orientamento,sull’interpretazione esercitata a partire non da un catalogo in cuitutto si tiene, ma da un ordine le cui leggi sono da dedurre66. Allaretorica dei luoghi letterari subentra una retorica di luoghi geo-grafici, come si è detto accennando a Burke, sviluppata non sullabase di un percorso reale ma comunque dall’eterotopia di unascrittura (considerando quindi anche atlanti e mappe, una sorta di
63 A. Doroszlaï, Les sources cartographiques et le “Roland Furieux”, cit., pp. 12-13. Cfr. W. Binni, Metodo e poesia, cit., p. 238.
64 Cfr. W. Binni, Metodo e poesia, cit., pp. 78-79. Il giudizio su Voltaire è di I.Calvino, Il “Candide” di Voltaire, in Voltaire, Candido ovvero l’ottimismo, inOpere, Sansoni, Firenze 1993, vol. I, pp. 5-10.
65 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 137.66 A. Quondam, (De)scrivere la terra. Il discorso geografico da Tolomeo all’A-
tlante, in Culture e Société en Italie du Moyen-Age à la Renaissance. Hom-mage a André Rochon, CIRRI, Paris 1985, pp. 11-35.
Vincenzo Bagnoli
88
trascrizione letteraria) e dalla molteplicità dei percorsi possibili suqueste. Ciò non comporta un mero realismo geografico (né è ilcaso del Furioso), ma la creazione di una struttura di relazioni piùcomplessa rispetto alla linearità (orizzontale o verticale) dei cro-notopi più antichi67. Anche il modello non è più trattato come ca-none immobile, ma viene sottoposto alla strategia della reinter-pretazione, e in questo l’uso delle mappe è fondamentale. Senza lamappa come spazio del racconto il romanzo moderno non sareb-be possibile: “Quel ramo del lago di Como…”.
È stata rilevata proprio questa dinamica fra il “modello”, l’In-namorato, e il Furioso: il primo è un libro-eden consegnato ai terri-tori dell’outópos perfetto entro una cornice, un hortus conclusus, in-somma l’ultimo romanzo cortese, mentre il Furioso è già un primogrande romanzo moderno, proprio perché, a suo modo, abita e per-corre un mondo visto e descritto secondo un’ottica moderna, la cuivasta totalità è un problema da afferrare e ricomporre dalle fram-mentarie parzialità, non un’armonia prestabilita, ma un’eterotopia,un labirinto che sfida se stesso. Diventa obbligatorio a questo pun-to riferirsi a Calvino e alla sua immagine del Furioso come “poemadel movimento”, quindi di una trama come scansione dello spaziosullo schema del labirinto o della scacchiera: il labirinto a questomodo non è più solo figura della peregrinatio in Terrasanta, maqualcosa di più, la “sommatoria delle infinite possibili permutazio-ni del movimento in uno spazio paradossalmente chiuso e aper-to”68. L’immagine della scacchiera suggerisce dunque una spazialitàcartesiana che libera i personaggi dalla fissa topologia dei ruoli pro-pria del metaracconto teologico derivato dalla Bibbia (già Frye av-vertiva che il “modo” romanzesco è versione secolarizzata dellaBibbia): il Furioso può allora essere letto da Calvino come “un’im-mensa partita di scacchi che si gioca sulla carta geografica del mon-do, una partita smisurata che si dirama in tante partite simultanee”.
67 M. Bachtin, Formy vremini i chronotopa v romane. Očerki po istoričeskojpoietike (1925), trad. it. Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo. Sag-gi di poetica storica, in Estetica e romanzo, Einaudi, Torino 1977, pp. 245 ess. e 302 e ss.
68 C. Bologna, La macchina del “Furioso”, cit., p. 91, che cita le riflessioni diAgamben e della Micocci.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
89
Non possono che venire alla mente ancora le partite simultanee ditarocchi nel Castello, però con l’avvertenza che “la carta del mon-do è ben più varia di una scacchiera, ma su di essa le mosse d’ognipersonaggio si susseguono secondo regole fisse come per i pezzi de-gli scacchi”69: Orlando segue la sua logica, Astolfo la sua, e se il rac-conto va avanti come il cavallo, l’ippogrifo, il “pezzo privilegiato” èla regina.
Tuttavia c’è anche un movimento dei luoghi, poiché la loronatura pare a tratti proteiforme nel fluttuare del senso, nel so-vrapporsi dei punti di vista e delle interpretazioni in maniera dav-vero quasi “cubista”. Il movimento dei “piani semantici, sintatti-ci e narrativi”70, i movimenti di camera e queste sovrapposizionidi prospettive rivelano dunque la consapevolezza nell’autore cheil guardare e nominare, il costruire paesaggi letterari non è con-cretamente creare o ricreare luoghi, reali o allegorici, ma dise-gnare mappe, e anche che queste mappe sono la possibilità di tra-sformare il labirinto se conservano la sua atmosfera, se in un qual-che modo recano il segno del navigatore che da sottocoperta le haportate “fuora” al confronto dialogico con le mappe disegnate daaltri e con l’esperienza. Non c’è la pretesa di “dare il mondo”,neppure in chiave allegorica, ma una sua mappa labirintica (tale èinevitabilmente la “mappa del labirinto”, che è pur tuttavia unostrumento operativo) la cui complessità sta tutta nel contenere in-sieme spazio e movimento: vale a dire la misurazione, la carto-grafia, la linearità uniforme della scacchiera e delle sue regole, in-sieme a un movimento che rappresenta l’irregolarità, l’attorci-gliarsi del racconto (nel momento in cui lo sguardo si confrontacon altri sguardi), il moltiplicarsi dei meridiani, il labirinto rap-presentato dalla forma del globo, nella quale la geometria delle li-nee rette della scacchiera si piega, torna su se stessa (ogni figuracircolare è un labirinto nella dialettica fra superficie e centro,come sa chi ne tenti la quadratura), così che lo stesso Colombo visi smarrisce finendo col ricorrere alle forme del mito71. “In ogni
69 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 87.70 C. Bologna, La macchina del “Furioso”, cit., p. 90.71 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., pp. 151-171.
Vincenzo Bagnoli
90
canto dell’Orlando Furioso la mappa del mondo si dispiega tuttacontemporaneamente sotto l’occhio del lettore”72: accanto al ten-tativo moderno di distendere il tutto nella chiarezza della mappac’è anche (ed è questo che i commentatori consideravano fanta-stico) l’improvviso riavvolgersi delle mappe, quando il compli-carsi del loro insieme, come Calvino intuisce, realizza il labirintognoseologico. Parlare di mappa e labirinto-mondo, insomma, èchiamare ancora una volta in causa l’endiadi di chiarezza e diffi-coltà che per Calvino costituisce l’esperimento più difficile dellascrittura73, o la coppia “cortesie” e “audaci imprese”, le coordi-nate fondamentali del poema.
Per riassumere, allora, la visione dall’alto, nella lettura calvi-niana del Furioso, non esprime solo il controllo della ragione cri-tica attraverso la distanza, la misura del mondo, ma una forma in-terpretativa più complessa. La storia letta sulle carte (l’atlantestorico, lo si è detto, è la prima immagine di tale lettura) non sidispone più nel tempo astratto dell’epos o nella cronologia stori-ca, nelle genealogie; ed è significativo come un poema che pureaveva anche il dovere dell’elogio dinastico, debba allargare losguardo di là dalle vicende individuali alle guerre di nazioni, aimovimenti di massa nello spazio della geografia. Proprio il pro-gressivo prevalere della dimensione spaziale su quella temporalenella modernità (con il passaggio in pittura dalla sequenza allaprospettiva, nella scrittura con l’invenzione della stampa e la ti-pografizzazione del mondo) rende possibile l’uso di uno stru-mento interpretativo quale il cronotopo, ed è da notare come neltratteggiarne le linee evolutive Bachtin proceda privilegiandosempre di più l’articolazione e la strutturazione spaziale a scapitodi quella temporale: fino al postmoderno di Calvino, che esaltaquesto aspetto appiattendo le distanze temporali e distribuendotutto sulla superficie estetica. Per Calvino dunque il guardare èsoprattutto la ricerca di una forma-paesaggio che dia il contornodi un’epoca, sfuggendo alle immobili quinte retoriche dell’idillio,
72 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 93.73 G. Bertone, Italo Calvino. Il castello della scrittura, Einaudi, Torino 1994, p.
146.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
91
dell’ecloga, per trovare le regole di uno spazio che muta74; è unosforzo gnoseologico che è anche e soprattutto etico, poiché lamappa non pretende di dire la verità del mondo agli uomini, madeve servire ad essi per chiarire il senso della loro posizione, perorientarsi anche attraverso il disorientamento.
3. Il personaggio e lo sfondo: i “lochi già descritti”
Da quanto si è appena detto possono essere dedotti alcuni de-cisivi corollari. In primo luogo la complessità policentrica del la-birinto richiede un montaggio, che avviene scavalcando le struttu-re paratestuali gerarchiche, violando quindi la divisione in canticon interruzioni, cambi di scena, dissolvenze improvvise, attra-verso un modulo seriale di continuità e variazione messo in atto,come si è visto, dall’ottava, dal movimento del cavallo ecc.75. De-terminante è il movimento dello sguardo, nel cambiare continuodei punti di vista: dalla soggettiva al primo piano fino alla pano-ramica all’inizio dei canti76, così come l’intromettersi della vocedell’autore non solo in funzione di pausa, ma per stabilire una di-stanza dalla narrazione, che problematizza l’incrociarsi dell’otticacoinvolta e della distanza critica, proprio perché lo spettatore nonè più a priori parte della totalità rappresentata nell’opera, ma puòrecuperare tale essere parte attraverso un atto critico, così comeinsegnano del resto le stesse vicende dei personaggi, che proprioper aver difettato in questo rischiano di essere estromessi dal flus-so (vegetalizzati come Astolfo o mineralizzati come Orlando). Ilcompito di realizzare tale scarto è sovente affidato da Ariosto al-l’ironia: all’inizio del canto XXXV l’ironico riferimento a sé e alla
74 I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, pp. 18-19.75 Id., La struttura dell’“Orlando”, cit., p. 69. Per quanto riguarda il montaggio
e le analogie cinematografiche si veda A.G. Bragaglia, L’Ariosto come cinea-sta, in L’ottava d’oro: la vita e l’opera di Ludovico Ariosto, Mondadori, Mila-no 1933, pp. 639-666. Su una “antropologia del ritmo” come propulsore dinarrazioni cfr. H. Meschonnic, Se la teoria del ritmo cambia, tutta la teoria dellinguaggio cambia, in «Studi di estetica», 2000, 21, pp. 11-30.
76 I. Calvino, La struttura dell’“Orlando”, cit., p. 70.
Vincenzo Bagnoli
92
propria vicenda, messa in parallelo a quella di Orlando, demoli-sce, attraverso la citazione parodistica di Dante e della tradizionepetrarchesca, ogni troppo facile identificazione nella fictio lettera-ria, tanto dalla parte del lettore quanto dalla parte dell’autore, chepotrebbe essere portato a fidare troppo nel canone, nell’imitazio-ne dello stile: non è infatti quella dei loci letterari (giardini, “dol-ci acque”, “aere sereno” ecc.), ma davvero ben altra, quella cor-porea dell’amata (II, vv. 5-8), la geografia da “correre” con le “lab-bia”! Come in questo passo, anche altrove (si è già dato qualcheesempio) il repentino porsi dell’autore (e con lui del lettore) a pa-ragone con i propri personaggi scardina il modello epico, intro-ducendo il problema della relatività dei vari sguardi sullo spazio.Con l’apertura dello spazio guardato dal lettore (che non è più ilmedesimo degli eroi) si propone un distanziamento del testo dase stesso che costituisce una prospettiva assolutamente modernae che si trasferisce sul verso, nella lirica (in quanto è spazio ancheil verso scritto-letto): il guardare fuori non è più solo Stimmungma confronto di organizzazioni ritmico-spaziali77.
L’immagine che Calvino propone è dunque quella del “campodi forze” dominato dal “piacere della rapidità” e dalla “larghezzanella disponibilità dello spazio e del tempo”, nel quale il movi-mento centrifugo viola la chiusura tolemaica. La varietà labirinticadell’ottava, che attraverso gli snodi delle rime alterne giunge alla“piazza” della rima baciata, riproduce su una scala ridotta, comeun frattale, la natura dello spazio del poema: non solo le modula-zioni del parlato, ma anche una forma del mondo, un ritmo quin-di come struttura della conoscenza, rendendo il verso strumento dimisurazione, strategia di racconto e cronotopo, non mera arte del-la fuga78. All’interno di questa struttura i principali agenti della
77 W. Binni, Metodo e poesia, cit., p. 231, riprende le osservazioni di Giobertisulla geografia del poema, nel quale si svolge “un continuo viaggio nello spa-zio, che […] corrisponde allo stesso ritmo narrativo-poetico che percorretutta l’opera”.
78 I. Calvino, La struttura dell’“Orlando”, cit., pp. 70-73 e L’“Orlando Furioso”di Ludovico Ariosto, cit., p. 31. Cfr. quanto si è detto nel primo capitolo aproposito delle osservazioni di Lukács sulla “leggerezza” del verso epico,che qui dimostra chiaramente di non essere strumento di evasione.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
93
complicazione sono le forme dello sviamento, come l’errore o lapazzia, entrambi dipendenti dalla dinamica del rapporto con lospazio, con la sua forma. La pazzia di Orlando deriva, come si ègià visto, dalla sua funzione di racconto, dal fatto cioè di seguireuna prospettiva lineare, unidimensionale di spazio che lo porta acozzare inevitabilmente nei tranelli del mondo labirintico: a per-dere il mondo, in buona sostanza, non potendone vedere la for-ma79. Per Astolfo, che in comune con l’altro ha comunque l’ideadella missione da compiere, si tratterà al contrario di raccapezzareuna linea fra le tante dei suoi percorsi, di non perdersi nelle infini-te possibilità del labirinto: egli è l’uomo della molteplicità, ma pro-prio per questo si rivelerà il più adatto a cavalcare l’ippogrifo(mentre Ruggiero ne resta comunque spaventato), valendosi dellavisione dall’alto per trarre dalla geoscopia l’orientamento.
Alcuni luoghi sono essi stessi attivi nel realizzare gli sviamen-ti e costituiscono per tale ragione importanti centri del romanzo:per Calvino tale è, a proprio modo, Parigi, dove tutti i protago-nisti sono assenti, ma soprattutto il castello di Atlante, ossia l’il-lusione ossessiva, lo specchio immobile, per così dire, dell’interopercorso di Orlando, sempre all’inseguimento della chimera del-l’amore di Angelica80. E c’è da ricordare anzi l’avvertenza di Cal-vino, secondo la quale il labirinto di Atlante alla fine si trasponenel “labirinto dei pensieri”, vale a dire uno degli aspetti del labi-rinto gnoseologico che assilla l’uomo moderno: insomma è un la-birinto nel labirinto81, la traccia di una mise en abyme della formalabirinto che coinvolge lo spazio del poema e dei lettori. Spazioesterno e spazio interno si rivelano così non separati in modo net-to, ma annodati uno nell’altro, attraversati l’uno dall’altro in unasorta di “iperlabirinto”, secondo la stessa dialettica che Conraddescrive nei suoi europei ai confini del mondo, discendenti diquegli esploratori che affascinavano Ariosto (nel canto XV).
79 Sulla follia amorosa come “perdita del mondo”, abbandono della vista in fa-vore della visione/illusione cfr. G. Baldissone, Gli occhi della letteratura.Miti, figure, generi, Interlinea, Novara 1999, p. 48.
80 I. Calvino, La struttura dell’“Orlando”, cit., pp. 75-76.81 Id., L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 167.
Vincenzo Bagnoli
94
Non poteva mancare fra i luoghi dell’errore, troppo forte es-sendo il modello di Dante, la selva, che però non ha necessaria-mente le caratteristiche dell’horridus. Il calco più fortementemarcato è, nel canto II, quello dell’ottava LXVIII, dove infatti laselva è detta “oscura”, in rima con “dura” e “paura” (e dove sitrovano anche altre espressioni di Inferno, I): qui però l’“uscir divia” non ha affatto un valore morale, perché Pinabello, comple-tamente assorbito dall’intento di liberarsi di Bradamante, proprionel bosco in cui è entrato inavvedutamente trova l’occasione pro-pizia (in modo analogo XLIII, CXXV). Se altre volte la “selvaoscura” diventa figura d’un altro tipo d’“errore”, quale la pazziad’Orlando, può però essere addirittura un riparo (per esempioXIII, XXV). Già in molta epica medievale si trova la ripresa delmotivo di Tempe, che unisce alla selva il locus amoenus; fin dalprimo canto del Furioso, d’altronde, Angelica in fuga trova pro-prio fra le “selve spaventose e scure” il sereno asilo di un “bo-schetto adorno”. Anche il bosco insomma, presentando accantoall’“aspro e stretto calle” (II, XII) e alla “torta via” (XIX, V) ancheil “camin dritto” (I, LXIV), accanto alla fuga veloce la pausa diquiete (proprio come l’ottava), è connotato della medesima va-rietas che caratterizza lo spazio del testo, intesa quindi non comesemplice giustapposizione di elementi decorativi, ma come formadi un complicarsi del racconto82. In particolare diventa un “luo-go d’azione”, il punto in cui i labirinti delle azioni dei personag-gi possono incontrarsi e conoscono i loro snodi: una forma d’in-treccio che distingue le “serie universali delle vite” in “piccolefaccende private” e le raccorda al tempo stesso in un quadro chenon è certo quello dell’unità antica, né l’unità del tempo folclori-co, ma la creazione di nuove contiguità attraverso lo “sconfina-mento” della poesia, dell’ironia e della parodia. Grazie a tali con-tiguità le vicende del singolo sono riannodate alle vicende deglialtri, non meramente nella forma dell’incontro, secondo il crono-topo della strada, ma in una più complessa dinamica tra il proce-dere dei singoli e il procedere della storia che ricomprende i de-
82 U. Musarra-Schroeder, Il labirinto e la rete, cit., pp. 76 e 98; sulla foresta-la-birinto in Calvino, si veda ibidem, pp. 114 e ss.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
95
stini umani in una forma, ossia lo sfondo (nel caso specifico lamappa labirintica del globo)83. Pur in una maniera ancora mec-canica, esemplifica insomma il ruolo che il paesaggio assume neiromanzi moderni84.
L’esempio più evidente è dato dall’episodio centrale della vi-cenda di Orlando, dove non si compie semplicemente un’agni-zione lungo lo sviluppo del dramma, ma dove il conte conosce larealtà attraverso la lettura (letteralmente) del paesaggio. Il suoprecipitare nella follia si svolge appunto all’interno di uno diquesti snodi, il cui carattere labirintico è ribadito dal poeta conla consueta disposizione a distanza dei nuclei narrativi all’inter-no della trama del racconto, dal momento che la vicenda si svol-ge appunto fra il canto XIX e il XXIII. Se la centralità è ribadi-ta dal collocarsi presso la metà del poema, è al tempo stesso sfu-mata dal sovrapporsi alla linea del racconto di un movimentodella memoria che la flette, la piega su se stessa. La follia non siscatena a causa di un incontro diretto, in una rivelazione che av-viene nello stesso luogo e nello stesso tempo, ma si svolge attra-verso una distanza, proprio mediante la “lettura” che il conteOrlando compie – insieme ai suoi lettori – di “quei lochi già de-scritti” (XXIII, CII, v. 5). Poiché la percezione della contiguitàtemporale degli eventi è impedita dallo svolgersi a distanza del-la diegesi, Ariosto deve insistere sulla contiguità spaziale, sul so-vrapporsi nella memoria dei due percorsi, dei due sguardi; dallatensione che ne scaturisce deriva l’aspetto disorientante del labi-rinto, soprattutto per gli uomini che vi stanno troppo immersi.Se l’immaginazione poetica, per non essere “vuota retorica” maconcreta eterotopia, ha il difficile compito di tracciare la mappadel labirinto in equilibrio tra phantasia e topothesia congiungen-do le diverse prospettive (le mappe già tracciate), tuttavia pro-prio la molteplicità delle prospettive, il depositarsi delle imma-gini fa sì che il labirinto non presenti pareti rigide e fisse, ma“molli”, come notava Nietzsche, ossia in continuo cambiamen-
83 A questo accenna Binni parlando della “vera trama profonda” del Furioso,in Metodo e poesia, cit., pp. 211 e ss.
84 M. Bachtin, Le forme del tempo e del cronotopo, cit., pp. 365 e 384.
Vincenzo Bagnoli
96
to: la memoria, pertanto (all’opera come “mnemotecnica del bel-lo”), deve considerare tutte le possibili variazioni nel mutare deipunti di vista, deve agire a un livello diverso, come una metam-nesi 85, una mappa delle mappe.
La ripresa a distanza del paesaggio avviene con la ripetizionedelle stesse parole, che però trasformano il loro senso; così, seAngelica e Medoro avevano inciso con “spillo o coltel” i loronomi legati in “nodi” (XIX, XXXVI), questi stessi diventano “chio-di” acuminati che allo stesso modo graffiano il cuore di Orlando(XXIII, CII-CIII). Come i due amanti avevano “fitto” quei coltellisugli elementi del paesaggio per lasciarvi uno “scritto”, così Or-lando riconosce questi “scritti” una volta che vi ha “fitti” gli oc-chi86. Il cambiamento principale riguarda però il mutare del rap-porto con lo scenario nei due tempi della vicenda: nel canto XIXil locus amoenus è degna cornice degli amori di Angelica e Me-doro, paragonati a quelli di Enea e Didone con tanto di citazionevirgiliana. Lo stesso luogo, inalterato nelle sue caratteristiche, sirivela luogo della catastrofe invece per Orlando, che pure vi eraentrato senza sospetto per via della bellezza dei luoghi. Vienedunque rovesciata la topica petrarchesca dell’amoenitas: il giardi-no di delizia si rivela luogo di dolore atroce per il protagonista, enon basta la retorica umana a riconciliare l’uomo col mondo, cheresta indifferente a lui. Se infatti per Petrarca, in virtù della reto-rica, il panorama si trasforma davanti al dolore, “e cantar augel-letti, e fiorir piagge, / e ’n belle donne oneste atti soavi / sono undeserto, e fere aspre e selvagge”87 (com’era “selvaggia e aspra” laselva dantesca), il paesaggio-labirinto non asseconda i desideri ele aspettative umane, resta indifferente, fedele alla propria retori-ca dei luoghi. Anzi la pazzia “furiosa” di Orlando si manifestaproprio quando, davanti alla poesia che Medoro ha compostoper celebrare il luogo dei suoi amori con Angelica, si dispone anegare quel paesaggio e a renderlo materialmente lo scenario più
85 G. Bachelard, La poétique de la rêverie, PUF, Paris 1960, trad. it. La poeticadella rêverie, Dedalo, Bari 1972, p. 123.
86 C. Bologna, La macchina del “Furioso”, cit., p. 201.87 F. Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, CCCX, vv. 12-14.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
97
acconcio a un “albergo travaglioso e crudo”, devastandolo: spez-za le rocce, taglia cespugli, piante e fiori, abbatte alberi e intorbi-da la fonte, così che le sue acque (che nell’iscrizione Medoro ave-va cantato come “limpide”) “non furo mai più chiare”. Rovescia-ta l’idea di una trasparenza lineare dell’immagine, di una sua uni-voca corrispondenza a un senso, il paesaggio “scritto” si rivela unpalinsesto su cui Angelica e Medoro compongono la propria vi-sione dei luoghi e su cui Orlando sovrappone la propria, fatta didistruzione e desolazione.
Il ritornare del testo sullo stesso paesaggio ha dunque un’altravalenza rispetto a quella intradiegetica: così il racconto del pasto-re, che – avendo i tratti del romanzo amoroso e dell’idillio campe-stre – dovrebbe secondo le convenzioni del genere essere consola-torio, non allevia la pena d’Orlando ma l’inasprisce; così l’epigra-fe poetica di Medoro, una sorta di canzone petrarchesca (che peròsuona tale in virtù del “tradurre” nella nostra lingua, come ricordail poeta, introducendo esplicitamente, con questa necessità d’adat-tare al diverso contesto, la problematica del cambiamento di pia-ni, dell’obliquità, dell’interpretazione), sortisce esattamente l’effet-to contrario. Tutto ci dimostra che ci troviamo sotto il segno dellaparodia, nel senso della riscrittura, alla quale Ariosto sottopone leproprie fonti, il proprio ipotesto, perfino lo stesso testo: un rove-sciamento non burlesco che marca una forte interdiscorsività, at-traverso la quale si ridefiniscono gli statuti letterari88, tanto la ge-rarchia interna dei generi quanto anche la loro interpretazione, laloro leggibilità e la leggibilità del mondo89.
L’ironia implicita – la lettura di Calvino si differenzia dalle al-tre nel sottolineare questo aspetto – sta nello iato che divide e iso-
88 C. Segre, Intertestualità e interdiscorsività nel romanzo e nella poesia, in Tea-tro e romanzo, cit., pp. 103-118. Si veda anche N. Borsellino, Ariosto, in Let-teratura italiana, Laterza, Bari 1973, vol. IV, p. 138, e più in generale, sulrapporto fra ironia e follia, P. De Man, La retorica della temporalità, in Ce-cità e visione, Liguori, Napoli 1975, pp. 237-293.
89 Su questa dimensione della “cartografia letteraria”, sulla selva come dina-mica di intrecci non solo intradiegetici ma intertestuali in Calvino cfr. C. Mi-lanini, L’utopia discontinua. Saggio su Italo Calvino, Garzanti, Milano 1990,pp. 141-145.
Vincenzo Bagnoli
98
la i personaggi e gli eventi di questo dramma, sospendendolo o,meglio, facendone un “dramma di prospettive”: proprio nelladialettica del senso (anzi dei sensi), nell’attrito fra la retorica deiluoghi letterari e la retorica dei luoghi del mondo (fra il “lin-guaggio dei segni” e il “linguaggio del mondo”) Orlando si rive-la precursore di Don Chisciotte90. La sua angoscia è concreta,palpabile, ma ad Ariosto non preme che il lettore veda le cose dalpunto di vista dei personaggi, immedesimandosi in essi, quantoche dall’alto tenga sott’occhio i “lochi già descritti” e possa veri-ficare, nel momento in cui insieme ad essi legge il racconto nelpaesaggio, le loro reciproche posizioni nel labirinto, la “misuradell’‘errore’”: l’allocuzione diretta al lettore, là dove il poeta di-chiara di capire lo stato d’animo del suo personaggio, non è in-fatti che lo strumento principale della phantasia per materializza-re il quadro di fronte a chi legge. Lo notava del resto già Binni,quando sosteneva che nel Furioso i personaggi non vivono unaloro vita “separata” e “drammatica” né si fanno allegorie di sen-timenti, ma si identificano attraverso i paesaggi, le avventure, in-somma attraverso i loro percorsi e il confronto del valore topolo-gico delle reciproche posizioni rispetto allo sfondo. La loro sog-gettività viene a coincidere con la loro posizione costruita lingui-sticamente attraverso l’intreccio, in un processo di identificazio-ne sviluppato dunque secondo lo schema della vista dall’alto91.
La moltiplicazione dei protagonisti e delle trame testimonia diun mondo che aveva cessato di credere nelle formule stabili e uni-voche della metafisica, e che si trovava in uno stato di inquietudi-ne molto simile a quello che si presenterà al crollo delle metanar-razioni, fra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento. Proprio taleschema di sguardo doveva quindi risultare congeniale a Calvino,che nella sua stessa opera non si limita a guardare, dalla posizioneextradiegetica del narratore onnisciente, ai contrasti con gli occhidel romanziere, ma – come è stato notato – al modo di Ariosto,
90 M. Foucault, Les mot et les choses, Gallimard, Paris 1966, trad. it. Le parolee le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Rizzoli, Milano 1998 (nuovaed.), p. 61.
91 W. Binni, Metodo e poesia, cit., p. 121.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
99
con l’intenzione di ricomporli. Se Lukács si mostrava interessatosoltanto allo “scheletro” dell’epica, poiché esso mostra lo schemadelle relazioni umane92, Calvino scorge invece nel Furioso un altrotipo di epos, per così dire, oltre l’epica precedente: quello che Se-gre chiama un “atlante della natura umana”93. Il suo avvicinarsi alromanzo moderno, insomma, non consiste soltanto nel rompersidell’unità epica in una moltitudine di frammenti irrelati, ma alcontrario in una più complessa forma di unità: essa non si trovanella diversa totalità della forma biografica (la Bildung che si com-pie nel romanzo, a differenza di quella epica preesistente) affidataal cammino del solo protagonista, ma nell’insieme dei cammini di-segnati su un terreno comune che rende superflua qualsiasi incor-niciatura abbracciando perfino gli stessi lettori (rappresentati nel-l’ultimo canto), e che realizza un incontro di caos e cosmos in gra-do di rimettere in discussione dentro e fuori94.
A titolo d’esempio si può pensare ai ritratti rinascimentali,con il paesaggio sullo sfondo; e proprio alcuni ritratti ariosteschici aiutano a capire l’importanza del paesaggio di sfondo nellospiegare ciò che è in primo piano, fin quasi a risolverlo in sé. Cal-vino lo nota a proposito dei celebri nudi femminili, soggetto sem-pre difficile da ritrarre poiché espone al rischio dell’“acciecamen-to retorico”, nel quale le parole guardano solo se stesse: infattiAriosto, che pure in qualche caso si mantiene sulla stereotipia flo-reale, riesce a raggiungere la massima originalità proprio in queinudi (come quello di Olimpia, XI, LXVII-LXVIII) il cui tratto di-stintivo è proprio la “non parzialità”, l’integrale95, piegando il ca-
92 G. Lukács, Narrare o descrivere?, in Il marxismo e la critica letteraria, Ei-naudi, Torino 19645, pp. 269-323 e p. 288.
93 Si vedano anche le riflessioni sull’“opera mondo” di F. Moretti, Opere mon-do: saggio sulla forma epica dal “Faust” a “Cent’anni di solitudine”, Einaudi,Torino 1994.
94 I. Calvino, La struttura dell’“Orlando”, cit., p. 77; M. Shapiro, The Poetics ofAriosto, Wayne University Press, Detroit 1988, parla di una “Labirintic ple-nitude”. Al proposito illuminante C. Bologna, La macchina del “Furioso”,cit., p. 188, che riprende opportunamente le osservazioni calviniane in Sul-la fiaba già sottolineate da Mario Lavagetto.
95 I. Calvino, Piccola antologia di ottave, in Perché leggere i classici, cit., pp.78-83.
Vincenzo Bagnoli
100
none dell’elogio fino ad arrivare a qualcosa di totalmente diverso.Infatti “non la fronte sola” era bella, con tutto il seguito dei trat-ti del viso, ma anche “le parti che solea coprir la stola”. Mentre losguardo percorre tutto, sotto il segno della continuità si imponela contiguità, che realizza una trasformazione metonimica dell’e-piteto “bianco come la neve”. Levigate come l’avorio, come siconviene, le carni della fanciulla “Vinceano di candor le nievi in-tatte”. Fin qui nulla di nuovo, ma poco dopo si avvia la trasfor-mazione metonimica (innescata già con l’osservazione: “Le popperitondette parean latte”) che identifica il corpo con lo sfondo:
Spazio fra lor discendea, qual fatteesser veggiàn fra piccolini collil’ombrose valli in sua stagione amene,che ’l verno abbia di nieve allora piene.
Il canone del biancore niveo si anima, diventa la forma delpaesaggio in una maniera che, se da un lato sembra accordarsi alleosservazioni di Arnheim e Wöfflin sulle trasformazioni del corpoumano in rapporto allo spazio indotte dall’uso di un ottica proiet-tiva “scientifica” nei pittori del Rinascimento, dall’altro ricorda ilBallard di Atrocity Exhibition (“La giovane donna era un’equa-zione geometrica, il modello di un paesaggio […] diorama di car-ne e paesaggio”) o certe trasfigurazioni della poesia di Campana96.
Il corpo diventa allora un paesaggio tutto da percorrere con losguardo, ma non solo! Sempre all’insegna del biancore, mentreAstolfo percorre le valli lunari alla ricerca del senno d’Orlando,Ariosto introduce uno di quei peculiari movimenti di camera cheriattualizzano agli occhi del lettore il quadro, togliendolo dalla cor-nice dell’episodio unico e rendendolo mappa su cui raffrontare l’e-
96 R. Arnheim, Art and visual perception. A Psychology of the Creative Eye,University of California Press, Berkeley 19742, trad. it. Arte e percezione vi-siva, Feltrinelli, Milano 1984, p. 119; J.G. Ballard, The Atrocity Exhibition,Cape, London 1970, trad. it. La mostra delle atrocità, Rizzoli, Milano 1991,pp. 80 e 83; per Campana rimando al mio commento in N. Lorenzini (a c.di), Dalle avanguardie storiche alla seconda guerra mondiale, in Poesia del No-vecento italiano, Carocci, Roma 2002, vol. I, pp. 89-98.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
101
sperienza (XXXV, I-II): avendo lui stesso patito le stesse pene d’a-more, dove sarà possibile ritrovare il suo “perduto ingegno”? Pro-babilmente, suggerisce il poeta, esso non si trova “tanto alto”, né“nel cerchio de la luna” né tanto meno “in paradiso” (bersagliodell’ironia, accanto a Orlando, ovviamente è anche Dante), e, ri-volgendosi alla donna che ne è stata causa, disegna un paesaggiosimile al “vallon fra due montagne istretto” (XXXIV, LXXIII, v. 4),dove si trova il senno d’Orlando, però su scala minore, più aggra-ziata, e ancor più vicino alla terra. A portata di labbra:
Ne’ bei vostri occhi e nel sereno viso,nel sen d’avorio e alabastrini poggise ne va errando; et io con queste labbialo corrò, se vi par ch’io lo rïabbia.
4. La “doppia maraviglia” del conoscere
Simili trasformazioni ci ricordano che nel poema il principio diidentità (quello che abbiamo visto affidato alla “funzione Orlan-do”, identificante la linea narrativa della quest) viene regolarmen-te deluso attraverso le improvvise metamorfosi (o piuttosto ana-morfosi?) del paesaggio. Non solo palazzi e castelli d’illusione sva-niscono nel nulla, ma anche il sereno panorama letterario del locusamoenus può diventare l’epicentro della furia d’Orlando, non tan-to rovesciando il suo aspetto fenomenico, quanto mostrando comeesso cambi senso a seconda degli occhi che lo vedono (e anche aseconda del segno che vi è iscritto sopra). Proprio per questa ra-gione, lo si è detto, Ariosto pare quasi anticipare Cervantes: per-ché sa scorgere, come poi farà soprattutto Galilei, che l’erudizionedei libri non descrive più la forma del mondo, che tra segno e cosanon è possibile rintracciare una lineare relazione univoca, e chesono da ridisegnare tutti i rapporti tra segno e segno, tra cosa ecosa. E sempre per questa ragione Calvino, nella sua lettura delpoema, preferisce affidarsi piuttosto alla “funzione Astolfo”, la li-nea della digressione paesaggistica (vale a dire la strategia di arti-colare il discorso nei particolari più minuti, fin quasi a perdersi,
Vincenzo Bagnoli
102
per cercare di raccapezzarsi, anziché saltare alle conclusioni) allaquale è affidato il vettore di costruzione spaziale: Lukács direbbeche l’osservatore prende il sopravvento sullo scrittore epico97. Vio-late e contaminate le gerarchie epiche (con il romanzo amoroso,con la lirica ecc.), tutto è infatti “da rivedere”: non c’è un ritualedi purificazione, com’era per il santo o il cavaliere medievale, unaformula iniziatica che assicura la riuscita del viaggio; per trovare ilPreteianni non basta semplicemente approfittare della pagina perentrare nella zona della leggenda, per quanto la velocità del volosemplificherebbe le cose rispetto alle navigazioni. Astolfo deve in-vece orientarsi come un turista (o come uno scolaro) seguendo lavia del suo cammino attraverso i punti di riferimento di un mon-do che, nella visione dall’alto, è diventato una carta geografica. Lachiave del viaggio non è più il labirinto raffigurato sul pavimentodelle chiese: al rito subentra il percorso.
Non è però né un mondo di fantasia né quello reale a scorre-re sotto gli occhi di Astolfo, si diceva, ma appunto una mappa: èquesto tipo di prospettiva che permette di riconoscere nel poemanon la pretesa di “descrivere il mondo” ma la rappresentazionedella “tenue e costante relazione che i segni verbali intrecciano dasé a sé”98, relazione che comunque non fa che riflettere, nella suapeculiare maniera di “rappresentare”, il modo che ha il mondo diassumere senso attraverso l’“ammiccarsi” delle cose, come lo de-scrive Calvino nelle Meditazioni di Palomar:
Che sia il fuori a guardare fuori non basta […]. Dalla mutadistesa delle cose deve partire un segno, un richiamo, un am-micco: una cosa si stacca dalle altre con l’intenzione di signifi-care qualcosa… che cosa? se stessa […] basta aspettare che siverifichi una di quelle fortunate coincidenze in cui il mondovuole guardare ed essere guardato nel medesimo istante e il si-gnor Palomar si trovi a passare lì in mezzo99.
97 G. Lukács, Narrare o descrivere?, cit., p. 290.98 M. Foucault, Le parole e le cose, cit., p. 63.99 I. Calvino, Palomar, Einaudi, Torino 1983, pp. 111-112: il brano s’intitola Il
mondo guarda il mondo.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
103
In questo senso sono fondamentali le ottave dedicate al pae-saggio della luna, nel cui mondo, ben prima di Cervantes, “la fin-zione delusa delle epopee è divenuta il potere rappresentativo dellinguaggio”100, vale a dire la capacità dei suoi “nuclei semantici”,nel rendere la memoria “dimensione percorribile” (ancora unamnemotecnica baudelairiana), di trasferire “a livello di organiz-zazione fantastica della materia l’accostamento percettivo dellarealtà, nel quale la successione delle manifestazioni accentua lapresenza degli oggetti, che si mostrano in tutte le loro facce”101,come ora si vedrà. Fin dall’inizio si nota come il topos delle “cosepiù grandi in cielo” che fanno apparire misera la terra, già pre-sente ad esempio nel Somnium ciceroniano, non si sviluppa in-fatti in una allegoria teologica come in Dante, ma in una rifles-sione prospettica di carattere relativista:
Quivi ebbe Astolfo doppia maraviglia:che quel paese appresso era sì grande,il quale a un picciol tondo rassimigliaa noi che lo miriam da queste bande;e ch’aguzzar conviengli ambe le ciglia,s’indi la terra e ’l mar ch’intorno spandediscerner vuol; che non avendo luce,l’imagin lor poco alta si conduce
(Orlando Furioso, XXXIV, LXXI).
Per di più questo nuovissimo paesaggio è articolato in ma-niera simile a quello della terra (e la loro comparazione, seppurcondotta secondo il registro della fantasia, anticipa quella che ilSalviati galileiano farà nella prima giornata del Dialogo sopra i duemassimi sistemi); al tempo stesso eppure è diverso, è qualcosad’altro, come spiega l’ottava seguente (e come Calvino rimarcanella sua lettura102):
100 M. Foucault, Le parole e le cose, cit., p. 63.101 G. Barlusconi, L’“Orlando Furioso” poema dello spazio, cit., pp. 101-102.102 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., p. 240.
Vincenzo Bagnoli
104
Altri fiumi, altri laghi, altre campagnesono là su, che non son qui tra noi;altri piani, altre valli, altre montagne,c’han le cittadi, hanno i castelli suoi,con case de le quai mai le più magnenon vide il paladin prima né poi:e vi sono ample e solitarie selve,ove le ninfe ognor cacciano belve.
Se Scipione è rimproverato dall’avo perché continua a guarda-re la terra, Astolfo invece non riceve nessun ammonimento del ge-nere, e può continuare a guardare cose della terra anche sulla luna,anche nella luna. Se Alano compie nella sfera celeste l’ascesa dellaragione alle verità trascendenti, Astolfo vi trova invece il sennoconservato non fra le idee platoniche, ma in mezzo a tutte le cose“vane” che gli uomini perdono: gli amori, il tempo, il “servir”, i“giorni e fatti” delle nostre vite103.
Questo peculiare gioco prospettico di distanza e ridimensiona-mento, questa variazione di scala (e di valori) in una sfera in cui –ben prima di scoprire le leggi fisiche della gravità – tutto sembrapiù leggero (“la luna, appena s’affaccia nei versi dei poeti, ha avutosempre il potere di comunicare una sensazione di levità, di sospen-sione”)104, questo “fare spazio”, in breve, attraverso la distanza co-stituisce precisamente la qualità specifica dell’opera letteraria. Ol-tre la “siepe del testo” (come nell’idillio leopardiano) è possibiletrovare lo spazio in cui costruire le immagini sfuggendo all’assediodelle cose; il “paesaggio nello specchio” disegna un mondo “dietrolo specchio” che non serve a eludere il “mare dell’oggettività”, maconsente di misurarsi con esso alle condizioni del soggetto. Torna
103 Sul topos cfr. E.R. Curtius, Letteratura europea e medioevo latino, cit., p. 399.In precedenza si è citato L.B. Alberti: Segre ne ricorda le Intercenales tra lefonti proprio dell’episodio lunare in Ariosto, in particolare Somnium. Cfr. C.Segre, Nel mondo della luna, in Studi in onore di Alfredo Schiaffini, Edizionidell’Ateneo, Roma 1965, vol. II, pp. 1025 e ss. e Id., Leon Battista Alberti eLudovico Ariosto in Esperienze ariostesche, cit., pp. 85-95.
104 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Gar-zanti, Milano 1988 (ora Mondadori, Milano 1993), p. 31.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
105
quindi fra le righe di Calvino l’identificazione di Astolfo con Per-seo: e alla leggerezza del volo (la stessa leggerezza di cui Lucrezio siserve proprio per scrivere della natura rerum105) si aggiunge cosìesplicitamente l’altra risorsa, quella dello specchio, che evita la pie-trificazione106. Astolfo a questo punto sospende l’indagine panora-mica (“Non stette il duca a ricercare il tutto”), perché, come Or-lando ha avuto la sua lezione, così egli ha già appreso (a propria vol-ta perdendo l’umanità, ma nella vegetalizzazione) che, pur doven-do considerare con attenzione la complessità, non può disperderela sua attenzione nei mille rivoli del molteplice. Ancora non può esi-mersi da una rappresentazione dei fenomeni che si offrono alla suavista lunga una dozzina di ottave (LXXIV-LXXXV). Ancora una voltaè da notare come l’elencazione protratta non si risolva in eserciziodi nomenclatura, ma si componga in un surreale paesaggio di rebus(vicino alle “visioni” di Roussel più che all’allegoria107) caratterizza-to dal senso del “vano” (si prendano a esempio i “sospiri”, l’“inutiltempo”, i “vani disegni”, i “vani desideri”, le “tumide vesciche”, le“cicale scoppiate”, i “mantici”, le “ruine”, le “boccie rotte”, le “ver-sate minestre”) e sia quindi una mappa misurabile dell’omnia vani-tas. Sembrano essere in gioco, allora, le due forme di “conoscenza”che la scrittura può compiere, descritte da Calvino:
… una che si muove nello spazio mentale d’una razionalitàscorporata, dove si possono tracciare linee che congiungonopunti, proiezioni, forme astratte, vettori di forze; l’altra che simuove in uno spazio gremito di oggetti e cerca di creare unequivalente verbale di quello spazio riempiendo la pagina diparole, con uno sforzo di adeguamento minuzioso dello scrit-to al non scritto, alla totalità del dicibile e del non dicibile108.
105 I. Calvino, Lezioni americane, cit., p. 13.106 C. Segre, Da uno specchio all’altro: la luna e la terra nell’“Orlando Furioso”,
in Fuori dal mondo. I modelli nella follia e nelle immagini dell’aldilà, Einau-di, Torino 1990, pp. 103-114. Cfr. inoltre J. Guidi, Imagination, maîtresse devérité: l’épisode lunaire du “Roland furieux”, in A. Doroszlaï (a c. di), Espa-ces réels et espaces imaginaires dans le “Roland Furieux”, cit., pp. 47-85.
107 I. Calvino, Piccola antologia di ottave, in Perché leggere i classici, cit., p. 79:nell’esempio scelto da Calvino le rime difficili accentuano l’effetto.
108 Id., Lezioni americane, cit., p. 82.
Vincenzo Bagnoli
106
La tecnica di Ariosto, come è stato notato, è quella di disegna-re il paesaggio mediante i nomi, “nella loro nuda essenza”: essonon è contraddistinto tanto dalle generiche realtà topografiche enaturali, ma è sostanziato da questa “impressione” di geografia,che disegna la vastità109. Infatti la modernità, con l’affermazionedella vista sugli altri sensi, porta a geometrizzare il mondo, così cheanche le parole lo misurano in altro modo110: è un processo lungo,che è già in corso nel Cinquecento e il cui inizio può essere fattorisalire alla sostituzione delle Etymologiae di Isidoro con lo Specu-lum di Vincenzo di Beauvais111. Per Calvino, ad esempio, anche inCavalcanti le elencazioni poetiche non fungono solo da nomencla-tura, nello stile medievale, ma diventano (cita Contini) una sorta distrumento di “parificazione dei reali”112. Maria Corti, in un’intelli-gente introduzione a Cavalcanti, cita un altro saggio di Calvino sulpoeta fiorentino; in esso l’attenzione si focalizza proprio sulla ca-pacità cavalcantiana di rappresentare per visibilia, fidando non suuna poetica dei referenti, ma dei segni, la cui principale caratteri-stica è di essere “spersonalizzati”, alla maniera quasi dei simbolicartografici. Questo processo di oltrepassamento dell’individuale,avverte la Corti, non è di semplice astrazione, perché attraverso unpercorso che ha comunque i tratti dell’espansione metonimica, siassiste alla definizione di “un ambiente letterario” con le sue “leg-gi ecologiche” (giusta l’indicazione del Gruppo m) che ha i con-torni del “disegno universale”113; ogni mappa ha le sue regole, sipuò chiosare. Ma perché questo ambiente delinei poi un paesag-gio occorre aggiungere un’altra dimensione, quella del “pubbli-co”, che restituisce la concretezza attraverso la presenza, non tan-to di un contesto storico-referenziale del poema, quanto di quello
109 G. Getto, L’“Orlando Furioso” e la poesia dello spazio, in Tempo e spazio nel-la letteratura italiana, Sansoni, Firenze 1983, pp. 77 e ss.
110 I. Calvino, Ariosto geometrico, in «Italianistica», III, 1974, 3, pp. 657-658.111 Cfr. E. Raimondi, La nuova scienza e la visione degli oggetti, ora in I sentieri
del lettore, Il Mulino, Bologna 1994, vol. II, pp. 9-60, che si appoggia al Ba-chelard della Formation de l’esprit scientifique oltre che a Ong e McLuhan(per la stampa) e Foucault, per anticipare le soglie proposte da Febvre.
112 I. Calvino, Lezioni americane, cit., pp. 17-18.113 M. Corti, Introduzione a G. Cavalcanti, Rime, Rizzoli, Milano 1978, pp. 5-27.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
107
determinato dall’insieme dei suoi destinatari “presenti e futuri[…] che parteciperanno al suo gioco”114.
Nella stessa direzione sembrano svolgersi alcune riflessioni diBinni, per il quale in Ariosto è appunto una “visione realistica dellavita”, “più oscura che serena”, a esigere il “cor sereno”, la mentesgombra, lo sguardo dall’alto; non basta la cornice, la griglia retori-ca del locus amoenus, nel quale può sempre nascondersi l’insidia(l’ambiguità del reale interpretato, letto come segno). Il sopramondoariostesco è dunque un “paesaggio concreto e soprareale”, non unordine teologico né una conferma fotografica, né una metafisicaidealistica: è ricerca di armonia (non prestabilita) che sta in equili-brio fra lo spazio illusorio e quello concreto. Non si risolve in no-menclatura, in elenco di augelli o di luoghi reali, ma in una ricom-posizione di senso, nel riflesso del corrispondersi delle cose delmondo in una rete di relazioni semiche. Tale ricomposizione si affi-da al ritmo come “legge ambientale” e come vettore di costruzionespaziale; ed è appunto il paesaggio a scandire una regola di movi-mento e stasi anche a livello musicale, rasentando – per Binni – l’i-dillio, ma senza abbandonarsi alla decorazione e ritornando inveceal “ritmo generale che supera ogni possibile chiusura calligrafica”115.
Quale filo lega insomma Lucrezio, Ovidio (poeta della “con-tiguità universale”), Cavalcanti, Ariosto, e poi Cervantes e Leo-pardi, ma anche Galilei e Newton?116 Il paesaggio lunare di Ario-sto con la sua leggerezza diventa il traguardo di un volo come tra-sferimento sciamanico in un altro ordine di realtà dove trovare lasoluzione ai problemi del qui 117. E il trasferimento di Astolfo allafine diventa figura di quello che il lettore compie entrando nellospazio del testo, nella “terra promessa” del linguaggio, dove esso“diventa quello che dovrebbe veramente essere”118. Nella fanta-
114 I. Calvino, L’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, cit., pp. 32-33.115 W. Binni, Metodo e poesia, cit., pp. 102, 112, 201-207, 214 e ss., 245. 116 Cfr. I. Calvino, Due interviste, cit., pp. 186 e ss. e Ovidio e la contiguità uni-
versale, ora in Perché leggere i classici?, pp. 29-40.117 Id., Lezioni americane, cit., p. 33.118 Ibidem, p. 66. Cfr. anche C. Bologna, La macchina del “Furioso”, cit., pp.
120-121.
Vincenzo Bagnoli
108
sia ariostesca non c’è solo evasione, frivolezza; essa anzi non per-de mai di vista la realtà (ci sono precisi segnali, richiami e riavvi-cinamenti alla terra nei prologhi ai canti XXXIV e XXXVI, o peraltro verso nel XXXV) poiché a questo è funzionale l’indietreg-giare, il “prendre du champ”, e non a disimpegnarsi, come nota-va già Dionisotti. Assodato ormai che l’invenzione di Ariosto “silascia animare dal concreto”, va ribadito che questo avviene peròappoggiandosi alle carte, quei “microcosmi in cui la coerenza hail valore di realtà”. Sono dunque testi “calcolati matematicamen-te” quelli che si prestano a meraviglia “aux rêves de voyages et deconquêtes” e che perciò “s’ouvrent à toutes fictions”119.
La cartografia trasforma il globus mundi in globus intellectua-lis, mentre il viaggio di scoperta dà nuovo valore all’evidenza deisensi rispetto alla teoria: il nuovo mondo costringe il vecchio a ri-guardarsi da un altro punto di vista, allarga le sue coordinate geo-grafiche, estende la rete dei riferimenti culturali e quindi i signifi-cati120. Il paesaggio di questa luna, mondo simile al nostro ma piùgrande, ha dunque la nuova forma di un’esperienza propria del-l’alba della modernità e dell’epoca moderna intera: un mondo piùvasto, più complesso e sconfinato che guarda il vecchio mondo.Ed ha anche la forma di una nuova cultura, una nuova poesia cheriflette sui propri statuti e sul proprio codice genetico con ironia.Il testo diventa così un itinerario che non deve guidare a una meta:è comunque un’opera chiusa, ma che, restando aperta all’inter-pretazione, si presenta come una mappa che continua a includerelo spazio bianco. Calvino lo ravvisa nell’atteggiamento che Ariostostesso tiene con la “lingua ricevuta” da Dante e Petrarca, nel qua-le si nota l’intenzione del linguaggio di farsi non tanto strumentodello scrittore, quanto del lettore, della comunità interpretante.
119 A. Doroszlaï, Les sources cartographiques et le “Roland Furieux”, cit., pp. 13e 45.
120 E.J. Leed, The Mind of the Traveller, Basic Book, New York 1991, trad. it.La mente del viaggiatore, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 191 e ss.; S. Green-blatt, Marvelous Possessions. The Wonder of the New World, ClarendonPress, Oxford 1991, trad. it. Meraviglia e possesso. Lo stupore di fronte alnuovo mondo, Il Mulino, Bologna 1994. E soprattutto I. Calvino, Com’eranuovo il nuovo mondo, cit.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
109
In conclusione, allora, è proprio questa la “funzione Astolfo”che il poeta affida al linguaggio della poesia, reso più necessarioproprio dall’imporsi della scienza quale linguaggio capace di af-fermare realtà perentorie, come ricordava Raimondi rileggendo ilRichards di Scienza e poesia e sottolineando l’importanza del“dialogo rischioso e inquietante” di scienza e letteratura. Il poetacostruisce infatti un sistema, capace di dare ordine e coesione aun insieme di esperienze in maniera da renderle comunicabili, mache non può, né pretende, d’esser preso come valido in sé: hapiuttosto il ruolo di guardare dubitosamente se stesso “nel labi-rinto del linguaggio comune”, riflettendo nel proprio conoscerel’operazione gnoseologica di un osservatore sempre interno alcampo, per quanto teso razionalmente a “discernere”, a stabiliredistanze, e rinunciando quindi all’illusione di una trasparenza as-soluta, di una pura referenzialità121. Attraverso la “finestra” degliocchi la luce delle cose acquista senso, e l’uomo trasforma, grazieai suoi “mito-ricettori”, la loro figura puntiforme in una figuraraggiata, in un segno capace di stabilire reti di significato122, ingriglie geografiche, accumuli di immagini o parole: forme dellaterra, che però sono tutte forme vane, come quella vista nellospecchio della luna.
La luna di Ariosto è insomma il linguaggio, la poesia (la suatradizione, poiché nel catalogo si riverberano i repertori medie-vali e petrarchisti), nonché lo stesso poema come immagine delmondo: una sua ulteriore mise en abyme, quindi, come già il libromagico di Logistilla o il castello di Atlante123. Proprio in quantotale, ossia specchio non di un uomo e dei suoi stati d’animo, madel mondo, dell’ordine complesso dei luoghi, il poema può esse-
121 E. Raimondi, Scienza e letteratura, Einaudi, Torino 1978, pp. 6-10; ma cfr. I.Calvino, Due interviste, cit., pp. 184 e ss. e L. Waage Petersen, Scienza e fanta-sia. Riflessioni sulla funzione della scienza nell’opera di Italo Calvino, in A. Ban-dau, A. Gelz, S. Kleinert e S. Zangenfeind (a c. di), Korrespondenzen. Literari-sche Imagination und kultureller Dialog in der Romania. Festschrift für HeleneHarth zum 60. Geburtstag, Stauffenburg, Tübingen 2000, pp. 185-194.
122 I. Calvino, La luce negli occhi, in Collezione di sabbia, Garzanti, Milano1984 (ora Mondadori, Milano 1994), pp. 121-129, in part. p. 129.
123 C. Bologna, La macchina del “Furioso”, cit., p. 197.
Vincenzo Bagnoli
110
re detto un’“opera mondo”. L’essenziale è che non si risolva inuna pura astrazione, che non sia immagine perfetta separata dal-le ondulazioni e sfumature che la natura rerum introduce nellosguardo dell’uomo. Deve tenersi in equilibrio, come una varia-zione di fase, fra il contrasto con i rugosi “dorsi di macigno delmondo” e la perfezione delle immagini letterarie che non muta-no, che si fanno astratti emblemi di perfezione. Non per nullauna delle pagine galileiane che più affascinano Calvino è quelladedicata, nella prima giornata del Dialogo sopra i due massimi si-stemi, all’elogio della natura composita e multiforme della terra(ma lo stesso varrà quindi per gli altri pianeti, per estensione me-tonimica), contrapposta all’immagine spaventosa di una “vastasolitudine d’arena o una massa di diaspro”, un “globo immensodi cristallo”, inutile come un cadavere rispetto all’essere vivente(Galilei augura anche a quanti auspicano l’immortalità e incor-ruttibilità di provare il piacere d’essere tramutati da “un capo dimedusa” in “istatue di diamante”)124.
Nella fantasia ariostesca Calvino trova allora quella capacitàdi immaginare, nel senso di produrre immagini non come puroestro combinatorio, ma come facoltà unitaria dell’attività intel-lettuale umana (quale si ritrova in Cartesio e in Diderot) di pro-spettare nuove forme a partire dai dati del reale, un fingere affi-ne a quello che prospetterà Leopardi; nel poeta rinascimentale,in particolare, il dislocamento metonimico esalta la sensazionedella continuità attraverso la dimensione dell’altrove. Questa let-teratura fatta sulle mappe non si limita dunque a essere un cata-logo d’immagini del mondo, o altrimenti sarebbe solo un’altratopica, nella quale un’altra stereotipia subentrerebbe al clichéletterario; è invece una retorica nuova, dotata di una propria in-ventio, quella del plus ultra, come nota lo stesso Calvino quandoscrive che il tratto saliente del poema è proprio la “spinta inavanti”125. Il movimento che attraversa l’intera opera riproducenon solo lo schema, l’ossatura dei destini umani, com’è stato no-tato, ma soprattutto il modo di guardare dell’uomo: “Con gli oc-
124 I. Calvino, Il libro della natura in Galilei, in Perché leggere i classici, cit., p. 96.125 Id., Piccola antologia di ottave, in Perché leggere i classici, cit., p. 78.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
111
chi cerca or questo lato or quello / lungo le ripe il paladin” (IX,IX; è Orlando questa volta, ma sembra l’atteggiamento più tipi-co di Astolfo). Il vero argomento è quindi descritto dal poema,per contrasto, attraverso il contenuto dichiarato (la follia d’Or-lando), e meglio chiarito proprio nell’episodio lunare: la ricercadel senno, ossia l’“ingegno”, la conoscenza.
Una felice metafora di Bachelard mi pare descrivere efficace-mente la novità ariostesca rispetto agli stereotipi retorici del lo-cus amoenus, alla notazione realistica o pararealistica, al gusto delpittoresco: ed è quella dei bouquets letterari. Al concetto, alla no-menclatura, al simbolo subentra la sinfonia delle parole, una de-scrizione che cerca l’armonia tutta verbale, ad esempio calibratasui “nomi del mondo, con una psicologia delle maiuscole”126. Equesta sinfonia corrisponde appunto all’immagine della mappaquale spiegazione del mondo, com’era nelle chartes moraliséesmedievali o in quelle allucinatorie di Opicino de Canistris, il mo-naco muto ossessionato dall’interpretazione della carte geografi-che127, ma secondo una diversa scala, una diversa tecnica pro-spettica, un diverso sistema di valori. Se è vero quanto affermaMaria Corti, parlando dell’invenzione artistica e della sua capa-cità di fondare una conoscenza del mondo, di sviluppare a pro-prio modo un sapere, cioè che “ogni invenzione artistica offreuna nuova mappa del mondo, ce la offre parlando d’altro”128, levisioni di uno spazio e di un tempo plurimo e ramificato, nellatradizione del moderno da Ariosto in giù, attraverso la stagionedel romanzo come polifonica enciclopedia del mondo sensibile,ma anche attraverso una poesia dell’esattezza dello sguardo, con-tribuiscono indubbiamente, come “discorsi secondari”, alla co-struzione di un “testo spaziale” primo, ossia la semantizzazionedello spazio, secondo la proposta di una semiotica topologica
126 G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., pp. 50 e 188.127 I. Calvino, Il viandante nella mappa, in Collezione di sabbia, cit., p. 28, dove
ricorda anche lo svilupparsi, nel Seicento, accanto all’arte allegorica, alla fi-siognomica e ad altre passioni tassonomiche, anche di una topografia psico-logica orizzontale che Freud rovescerà nel profondo.
128 M. Corti, Percorsi dell’invenzione. Il linguaggio poetico e Dante, Einaudi,Torino 1993, p. 25.
Vincenzo Bagnoli
112
avanzata da Greimas129. Così lo scrittore, “del qual lo studio ètutto umano”, e di cui “son […] suggetti i boschi e i colli, / ilmormorar d’un rio che righi il piano” (Satira, VI, 49-51), fondadavvero un nuovo e diverso senso della contiguità; delineandoquel “modello della rete”130 del quale abbiamo piena coscienzasolo adesso, dopo la sua realizzazione materiale, scrive non l’idil-lio di un mondo ideale ma la forma del nostro mondo, vale a direil suo senso. Senza l’orizzonte delle parole che ci saldano allospazio geografico, il koìnos kosmos, lo spazio del paesaggio (e delpaesaggio interiore) è destinato a restare un luogo scisso dalletrame dei dialoghi e privato, un idìos kosmos, come avverte Mer-leau-Ponty, condannato al mutismo e sprofondato nel delirioschizofrenico.
129 A.J. Greimas, Semiotica e scienze sociali (1976), Centro Scientifico Editore,Torino 1991.
130 I. Calvino, Lezioni americane, cit., p. 133.
La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino
113
CAPITOLO TERZO
L’idillio e l’ipotesi.Appunti sulla Ginestra
1. Lo sguardo e l’idillio (retorica)
Non è certo una forzatura affermare che una parte sostanzia-le dei Canti si costruisce a partire dallo sguardo, un’attività visivache rientra nella “cornice sensistica” entro cui la scrittura di Leo-pardi si compie, e in particolare da uno sguardo che ha come suotermine il paesaggio, vera “figura capitale” della sua poesia, checonfigura il rapporto con l’elemento naturale in maniera diversae più articolata rispetto al topos letterario del locus amoenus 1.Nella Ginestra o il fiore del deserto (il paesaggio è già nel titolo)in particolare, della quale è stato opportunamente detto che fon-de le modalità (senza dubbio strofico-espositive) della canzonecon quelle dell’idillio in modo originalissimo, le parti nelle qualil’occhio non sembra percorrere il paesaggio si limitano a una por-zione centrale, su 317 versi, costituita dai vv. 39-51 (che conten-gono però una meditazione sul paesaggio), 52-86 (che per altrocostituiscono una sorta di “panorama del XIX secolo”, con le pa-role di Dolf Sternberger) e la lunga sequenza 86-167 (che è pursempre, a suo modo, un “paesaggio umano”)2. La modalità do-
1 G. Sangirardi, Leopardi: il bello e il terribile, in «Compar(a)ison», 1998, 1,pp. 119-154 e p. 130; M. Santagata, I confini dell’idillio: “La sera del dì di fe-sta”, in «Strumenti critici», XVI, 1982, 47-48, pp. 34-63, a p. 48 parla di una“predominanza dell’‘occhio’”.
2 Cfr. E. Raimondi, Il mito e il moderno, ora in I sentieri del lettore, Il Muli-no, Bologna 1994, vol. II, p. 494; a p. 481 è ribadita l’importanza dell’“epi-stemologia empiristica di Locke” nella versione più radicale dei francesi. C.Galimberti, Messaggio e forma nella “Ginestra”, in L. Renzi (a c. di), Poeticae stile, Liviana, Padova 1976, pp. 45-73, in part. pp. 52 e ss., analizza la suc-cessione delle sequenze disegnandone quasi la “sceneggiatura”, e rileva nel-
115
Topography displays no favorites; North’s as near as West.More delicate than the historians’are the map-makers’ colors.
Elizabeth Bishop
minante di tale rapporto con il naturale è stata identificata dallacritica nell’idillio, sulla scorta delle indicazioni del poeta stesso,che si serve però del termine non senza ambiguità, limitandosi auna definizione contenutistica delle composizioni così designate(chiamandole “avventure storiche” del suo animo); un equivocodi fondo ha fatto poi sì che alcuni dei più noti commentatori (DeSanctis, Croce, De Robertis e Flora) ne leggessero il senso in chia-ve riduttiva come quadretto, mito evasivo, felice pausa di conci-liazione con l’esistente dal quale scaturisce la “poesia”, astrattadal contatto con il pensiero critico, la scoria inerte della “nonpoesia”3.
Pare piuttosto difficile concordare con una simile lettura, al-meno considerando quanto articolata e complessa sia in realtà lafunzione del rapporto con il paesaggio nell’insieme dell’opera diLeopardi, così come è difficile circoscrivere la dinamica dell’idil-lio – a maggior ragione dopo la formazione dei Canti, com’è sta-to efficacemente mostrato – a un’isolata sequenza giovanile diidilli “propriamente detti”, i quali oltretutto sono “testi di varia ea volte discordante morfologia” privi di parametri formali unifor-mi. All’interno di un percorso che, pur attraverso una trasforma-zione evolutiva, sviluppa una sostanziale continuità nello sguardorivolto al paesaggio4, questo non s’identifica infatti necessaria-mente con la “pausa idillica” né con il “quadretto”. È vero infat-ti che nei testi si incontrano i segni demarcativi caratteristici, se-condo la teoria della letteratura, della descrizione, quali la defini-zione di un punto di vista elevato, la trasparenza dell’aria, la lu-minosità5: si possono citare i ben noti “sedendo e mirando”dall’“ermo colle” dell’Infinito; “Dolce e chiara è la notte e senza
l’alternanza di spazi la costanza del “movimento sensorio-spirituale”, a ri-badire la natura intrecciata dell’empirico e dello speculativo.
3 Le obiezioni a questa lettura sono avanzate già da W. Binni, Introduzione, inG. Leopardi, Tutte le opere, Sansoni, Firenze 19762, vol. I, p. XVII; in ma-niera più articolata W. Binni, La protesta di Leopardi, Sansoni, Firenze 1973.
4 M. Santagata, Quella celeste naturalezza. Le canzoni e gli idilli di Leopardi, IlMulino, Bologna 1994, pp. 135 e ss.
5 Ph. Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif, Hachette, Paris 1981, pp.185 e ss., e Id., Cos’è una descrizione, in Semiologia lessico leggibilità del te-sto narrativo, Pratiche, Parma-Lucca 1977, pp. 55-83.
Vincenzo Bagnoli
116
vento, / E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti / Posa la luna, edi lontan rivela / Serena ogni montagna” della Sera del dì di festa;“Talor m’assido in solitaria parte, sovra un rialto” della Vita soli-taria; “tacito, seduto in verde zolla, / Delle sere io solea passargran parte / Mirando il cielo” delle Ricordanze. Ma è anche veroche queste descrizioni, nonostante tratteggino sull’asse del para-digma quello che Bachelard definiva un “espace heureux”, non siisolano mai dal ritmo sintagmatico dell’argomentazione, con laquale sviluppano un rapporto di “collaborazione”6. La funzionedell’“idillio” non è mai quella di prospettare una utopia dell’al-trove, staccata e perfetta nella luce artificiale del bello, sia checolleghi quegli altrove topici dell’etica leopardiana dell’“impossi-bile” (la ricordanza, il sogno) secondo quella che pare ancora unavolta una “mnemotecnica del bello”, come ad esempio nell’attac-co della Ginestra (dove i diversi spazi del Vesuvio e delle desola-te campagne romane vengono accostati sotto il segno della gine-stra “contenta dei deserti”: “Qui su l’arida schiena… Tuoi cespisolitari intorno spargi”, “Anco ti vidi…”, “Or ti riveggo…”); siaquando realizzi una vera e propria “metonimia diffusa”, ad esem-pio nei rapporti interni alla nomenclatura della quarta strofe (vv.158-185: “stelle”, “scintille”, “punto”, “globo”, “nodi quasi distelle”, “nebbia”, “granel di sabbia”, “terra”) e alle corrispon-denti espansioni predicative (nelle coordinate come nelle subor-dinate relative), metonimia che giunge a comprendere il punto divista dell’osservatore argomentante nella fisicità dei sensi (“E ri-membrando / il tuo stato quaggiù, di cui fa segno / Il suol ch’iopremo”). Al contrario tale funzione pare piuttosto quella – tra-sformando la topografia in logica – di connettere nel flusso del ra-gionamento quei riscontri sensistici (o piuttosto fenomenici?) im-maginati attraverso le parole, addensando la propria informazio-ne. L’allargamento ottenuto attraverso la accumulazione aggetti-vale e predicativa (“Qui su l’arida schiena / Del formidabil mon-te / sterminator Vesevo”, o i vv. 297-306 dell’ultima strofe doveogni sostantivo è accompagnato da un aggettivo), caratteristica
6 G. Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, Paris 19644, p. 17. Molto efficacela delucidazione dello stesso P. Hamon, Cos’è una descrizione, cit., pp. 78-79.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
117
dello spirito scientifico7, la stessa “oltranza” dello sguardo8, il ri-fiuto della luce artificiale (preferendo il notturno, il vago, come sivedrà meglio) svolgono dunque una diversa funzione, quella diconcretare la “tensione conoscitiva” attraverso il linguaggio poe-tico in quanto tale9, sempre più evidente a partire da una certaepoca in avanti, fino alle poesie dell’ultimo periodo, nelle quali èl’asse portante.
L’“idillio”, insomma, non caratterizza una particolare tipolo-gia testuale, e può costituire un’etichetta di genere solo in un sen-so molto particolare, applicata com’è a testi profondamente di-versi dai modelli classici cui pare richiamarsi. Se il punto di par-tenza è Mosco – ma dell’autore greco pare restare solo l’ambien-tazione campestre, mentre sembrano più vicini Gessner, il Pinde-monte delle Poesie campestri e certe composizioni di Monti10 – vatuttavia osservato che, a differenza di tutti questi, in Leopardi ac-canto alla rêverie amorosa si trova una differente sfera, legata allaconoscenza, quale pare del resto essere presente (seppure con de-clinazioni affatto diverse) in buona parte della poesia di paesaggioantica, cui occorrerà dunque riferirsi. A voler dare ascolto a Cur-tius, almeno, a partire dal topos omerico del locus amoenus un nonminimo tratto della sophia del poeta-filosofo consiste proprio nel-l’esperienza-conoscenza della natura: perciò si scrive meglio neiboschetti e Pan risulta “buona parte della filosofia”11. Un motivo
7 G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique (1938), Vrin, Paris 1970,p. 111.
8 G. Baldissone, Gli occhi della letteratura. Miti, figure, generi, Interlinea, No-vara 1999, pp. 14-15.
9 La tesi più convincente su questo aspetto della poesia leopardiana è quellasostenuta, sulla scorta delle letture di S. Solmi, da C. Galimberti, Linguag-gio del vero in Leopardi, Olschki, Firenze 1959; Id., Leopardi: meditazione ecanto, introd. all’edizione Mondadori, Milano 1987; Id., Cose che non soncose. Saggi su Leopardi, Marsilio, Venezia 2001. In parallelo A. Prete, Il pen-siero poetante, Feltrinelli, Milano 19882 e A. Folin, Pensare per affetti. Leo-pardi, la natura, l’immagine, Marsilio, Venezia 1996.
10 L. Blasucci, I tempi dei “Canti”. Nuovi studi leopardiani, Einaudi, Torino1996, p. 192.
11 E.R. Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, FranckeVerlag, Bern 1948, trad. it. Letteratura europea e medioevo latino, La NuovaItalia, Firenze 1992, pp. 211 e 232.
Vincenzo Bagnoli
118
autonomo è sviluppato poi nella poesia pastorale la cui fortuna,sempre secondo Curtius, è dovuta al fatto che nell’ambiente bu-colico tutti i mondi “si incontrano”, espressione che pare richia-mare le osservazioni di Foucault sull’eterotopia, il luogo del mon-do che ha rapporti con tutti gli altri luoghi e che perciò funge da“specchio del mondo”12; le impressioni concrete (non retoriche)di certi paesaggi virgiliani, la presenza nella tradizione successivasia dell’ecphrasis dell’epidittica sia della probatio del genere giudi-ziale nella descrizione della natura, il motivo della valle di Tempe,dove si ha l’unione dell’amoenus e dell’horridus 13, sono senza dub-bio da tenere presenti a un moderno che osservava, a propositodegli antichi, la loro tendenza a trattare anche le scienze “in modomezzo poetico, perché molto immaginavano e poco sperimentava-no” (Zibaldone di pensieri, d’ora in avanti Z, 30 maggio 1823,2728; corsivo mio). Fin dagli esordi poetici Leopardi si richiamainsomma al tipo di visione naturale qual era presente nei classici:non il bello deve esserne l’argomento, perché se lo fosse “si an-drebbe alla perfezion metafisica, la quale in vece di piacere fa sto-maco nelle arti” (Z, agosto 1817-dicembre 1818, 2-3), ma il vero(non circoscritto al “bello naturale”), secondo una concezionenon dissimile da quella vagheggiata, più che dagli arcadi, da GianVincenzo Gravina14. Una posizione, questa, che però, com’è faci-le capire, apre anche a soluzioni considerate proprie del paesaggioromantico, ma partendo, come si è visto, da premesse estetiche af-fatto diverse. Ben presto Leopardi prende anche posizione contro
12 Si veda infra secondo capitolo, nota 10.13 E.R. Curtius, Letteratura europea e medioevo latino, cit., pp. 217-218, 222,
224 e 231 e ss.: “nell’Eneide si vedono riunite due componenti, cioè veritàfilosofica e finzione poetica (figmentum)”. Oltre al richiamo a Dante occor-re tenere presenti le osservazioni a proposito delle personificazioni della na-tura medievali, da Bernardo Silvestre in giù, pp. 126 e ss. Si vedano ancheR. Mugellesi, Paesaggi latini, Sansoni, Firenze 1975; G. Traina, Ambiente epaesaggi di Roma antica, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1990.
14 T. Carena, Critica della ragion poetica di Gian Vincenzo Gravina: l’immagi-nazione, la fantasia, il delirio e la verosimiglianza, in appendice testo inte-grale di G.V. Gravina, Della ragion poetica, Mimesis, Milano 2001; cfr. an-che F. Ulivi, Gian Vincenzo Gravina, Marzorati, Milano 1958; A. Quondam,Cultura e ideologia in Gianvincenzo Gravina, Mursia, Milano 1968; M. Pic-colomini, L’estetica di Gian Vincenzo Gravina, Longo, Ravenna 1983.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
119
i limiti della poesia descrittiva (una “debolezza essenziale” e “in-genita sazietà”: Z, 3 novembre 1821, 2041-2043); l’imitazione nonbasta, se manca la “passione”, e per questo “le pitture di paesi,gl’idilli ec. ec. saranno sempre di poco effetto” (Z, 26 gennaio1822, 2361-2362). Occorre qualcosa di più alla poesia, che nondeve comportarsi secondo gli schemi della pittura descrittiva,come in fondo lo stesso Gessner ancora voleva (nella Brief über dieLandschaftmalerei), ma deve saper ottenere, attraverso le propriespecifiche forme, la stessa forza ed energia del “sentire”, come ri-badisce commentando Byron: “il lettore deve sentire e non impa-rare la conformità che ha la tua descrizione ec. colla verità e collanatura” (Z, 24 agosto 1820, 224). Del resto “il racconto è uffiziodella parola, la descrizione del disegno” (Z, 12 luglio 1820, 164).
Il superamento della fiducia giovanile nella riproduzione og-gettiva15 passa dunque attraverso l’idea di una riproduzione (asuo modo fittizia: il che significa appunto artistica) delle medesi-me sensazioni prodotte dal vero, secondo quello che era in fondol’insegnamento essenziale dello stesso Gravina:
Quindi è che il poeta, per mezzo delle immagini esprimentiil naturale e della rappresentazion viva e somigliante alla veraesistenza e natura delle cose immaginate, commove ed agita lafantasia nel modo che fanno gli oggetti reali, e produce dentrodi noi gli effetti medesimi che si destano dai veri successi:[…]. Alla qual opra son atte le parole, che portano in seno im-magini sensibili ed eccitano in mente nostra i ritratti delle cosesingolari, rassomigliando successi veri e modi naturali […].Onde l’animo in quel punto abbraccia la favola come vera ereale e si dispone verso i finti come verso i veri successi16.
Leopardi, tuttavia, muove oltre la poetica del verisimile,come si avrà agio di vedere oltre, ma sembra comunque seguire
15 L. Blasucci, I tempi dei “Canti”, cit., p. 178.16 G.V. Gravina, Della ragion poetica, I, 2: Dell’efficacia della poesia; si veda an-
che il successivo I, 3: Del verisimile e del convenevole. Cfr. D. Consoli, Realtàe fantasia nel classicismo di Gian Vincenzo Gravina, Bietti, Milano 1970.
Vincenzo Bagnoli
120
un procedimento affine a quello sopra descritto quando, nellacanzone Di pensier in pensier, nella Sera del dì di festa e nelle Ri-cordanze, mostra di abbandonare l’uso petrarchista di contem-plare il quadro già dato di una “situazione” e segue il formarsidelle sensazioni, in un modo che fu descritto bene da Fubini17.Proprio da questo critico vengono ottime indicazioni sui “gene-ri” della poesia leopardiana, il loro essere strutture articolate ecomplesse, varie; in particolare la definizione di “apologo-idillio”ben si accorda al tono di “rappresentazione-affermazione” coltoda Binni nella Ginestra18, rendendo inoltre giustizia al fatto che lerappresentazioni leopardiane della natura superano le idee cano-niche, per esempio di un Giuseppe Barbieri, in quanto distin-guevano una descrizione affettiva da una fisica e una fantastica,per proporre una soluzione diversa e originale19.
Cosa significa allora raccontare il paesaggio anziché semplice-mente descriverlo? È chiaro intanto che si è proceduto oltre la de-finizione dell’idillio come “quadretto”, “oleografia” e “pausa”; eche il paesaggio della Ginestra non consiste dunque in una seriedi amene vedute estranee all’argomentazione. L’idillio entra a farparte di composizioni più complesse, accanto all’oratoria dellecanzoni giovanili (declinata però su un registro diverso), apren-done le forme chiuse secondo un diverso principio di organizza-zione estetica, capovolgendo i “to‰poi della tradizione fondati su-gli schemi consolanti del locus amoenus”, respingendo la retoricadell’horridus, della scena teatrale, per presentare il mondo qual è,con gelida ironia20.
17 Per il quale il poeta è incline ad accogliere i segnali del mondo esterno qua-si si trattasse di una registrazione di eventi simultanea allo speech act poeti-co: cfr. Introduzione a G. Leopardi, Canti, Loescher, Torino 1971 (nuovaed.), pp. 12-13, il quale tuttavia nelle pagine seguenti continua a escluderel’“intervento della riflessione e della volontà”.
18 W. Binni, La protesta di Leopardi, cit., pp. 261-262.19 G. Barbieri, Ragionamento sulla poesia descrittiva letto alla R. Accademia di
Scienze, Lettere ed Arti di Padova, in Opere, Chiari, Firenze 1819, vol. IV, pp.7-19. Per una panoramica ampia: T. Henighan, Natural Space in Literature.Imagination and Environment in Nineteenth and Twentieth Century Fictionand Poetry, Golden Dog Press, Ottawa 1982.
20 A. Battistini, E. Raimondi, Le figure della retorica. Una storia letteraria ita-
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
121
Vale forse la pena di soffermarsi su quella che Bigongiari chia-mava l’“ottica idillica leopardiana”21, per ravvisarvi la traccia diquella “funzione idillio”, cui si accennava, attraversante tutta laproduzione (per lo meno poetica) di Leopardi, e il cui senso è daritrovare nella radice verbale greca. L’idillio segna dunque la pre-senza dello sguardo, la dinamica visiva del rapporto che la parolaistituisce con il reale: il che significa la ricerca di un modo di rac-contare per immagini poetiche nell’epoca in cui del mondo si hauna conoscenza sperimentale (come ricorda lo stesso Leopardi),di là da ogni ingenuo spontaneismo romantico nel rapporto con ilnaturale, e ritornando per questo a far centro sul “nudo refertosensorio” di ogni “sentire” o “sentimento” (o affetto), anche nel-l’immaginare. La più moderna consapevolezza esibita da Leopar-di consiste proprio nel riconoscere che l’uomo conosce per imma-gini, e che quindi della natura non si può che avere un’immagi-ne22: mito, teoria o poesia, a seconda della sua “praticabilità” ef-fettiva, a voler citare il Brecht delle “praktiblen abbildungen”23.Ma l’idillio è anche una rêverie (con le parole di Gravina un “de-lirio”: I, 1) ossia una produzione di immagini in absentia: nelle Ri-cordanze il poeta esordisce rivolgendosi alle stelle (ciò che ha, maanche ciò che ebbe, davanti agli occhi) dalle quali scaturiva (vv. 7-8), come in fondo succede nel presente della poesia, la rêverie diciò che sta di là dall’orizzonte, e che è a rigor di logica “escluso”dallo sguardo: allora il futuro, ora ciò che è assente24. È respinta la
liana, Einaudi, Torino 19902, p. 319; M. Santagata, I confini dell’idillio, cit.,pp. 34 e ss.; L. Blasucci, I tempi dei “Canti”, cit., p. 213. Essenziale il rilievodi P.G. Beltrami, La metrica italiana, Il Mulino, Bologna 2002 (nuova ed.),p. 143: il riferimento metrico per Leopardi non è Petrarca quanto la tradi-zione delle grandi canzoni sei-settecentesche, che già violavano lo schemadelle stanze. E dunque nella costruzione dell’ottica leopardiana si dovreb-bero forse tenere presenti autori come Filicaia, Manfredi e Savioli.
21 P. Bigongiari, Leopardi, La Nuova Italia, Firenze 1976, pp. 267 e ss.22 A. Folin, Pensare per affetti, cit., pp. 54 e 67 e ss. Si veda per confronto P.
Fasano, Geografia e storia del “romantico”. La parola, la cosa, in G. Patrizi (ac. di), Sylva, studi in onore di N. Borsellino, Bulzoni, Roma 2002.
23 Ma F. Fortini, Il passaggio della gioia, in «Quadeni piacentini», 30, 1967, orain Verifica dei poteri, Garzanti, Milano 19742, pp. 249-254, a p. 252 parla di“immagini di vita”.
24 Il cielo metonimia della terra per Baudelaire, si veda infra il primo capitolo.
Vincenzo Bagnoli
122
scelta entusiastica, che separa ragione e natura dissimulando la in-commensurabilità dell’uomo con il naturale, a favore della sceltadi immaginare per un atto di volontà25: se c’è entusiasmo in Leo-pardi è anzi l’ossimorico “entusiasmo quasi della ragione” (Z, 8settembre 1823, 3383) che caratterizza, come nella Ginestra, il ne-cessario incontro della poesia e della filosofia. E forse non solo diquesta, se è vero che l’estetica del sublime trova spazio “nella to-pologia dell’immaginario” europea “solo dopo che la geologia el’astronomia hanno rifatto radicalmente la mappa terrestre” e, tra-sformando “l’immagine globale della natura come prodotto ideo-logico di un sistema di convinzioni e desideri”, hanno attribuito,con la scoperta degli strumenti ottici, con il Sidereus Nuncius equindi i Principia newtoniani (tanto più rilevanti per l’autore diuna Storia dell’astronomia), nuovo senso al profondo, alla pro-spettiva, alla pluralità dei mondi, all’infinito, all’ordine del co-smos 26. Dallo studio di questa geografia fisica deriva una rivolu-zione copernicana della poesia moderna, anticipata da Leopardi ecompiuta più tardi; il soggetto non si proietta sul mondo circo-stante riconoscendosi in esso, ma si conosce “sperimentalmente”dallo studio dei fenomeni, si delinea nell’attenzione fenomenolo-gica, rappresentata dalla centralità dello sguardo27.
25 G. Ficara, Il punto di vista della natura. Saggio su Leopardi, Il Melangolo,Genova 1996, pp. 67 e ss. e 81 e ss.
26 E. Raimondi, La strada verso Xanadu, in Scienza e letteratura, Einaudi, Tori-no 1978, pp. 19-21; si veda anche P. Fasano, L’entusiasmo della ragione. Ilromantico e l’antico nell’esperienza leopardiana, Bulzoni, Roma 1985; A.Frattini, Letteratura e scienze in Leopardi, in «Italianistica», 3, 1976, pp. 426-439, poi in V. Branca (a c. di), Letteratura e scienza nella storia della culturaitaliana, in Atti del IX Congresso dell’Associazione internazionale per gli stu-di di lingua e letteratura italiana, Manfredi, Palermo 1978, pp. 663-675; R.Bacchelli, L’Illuminismo in Leopardi e Manzoni, in M. Fubini (a c. di), Lacultura illuministica in Italia, ERI, Torino 19642, pp. 300-310. Cfr. inoltre L.Bottoni, Paesaggio e utopia: il sublime, il pittoresco, il romantico, in Paesag-gio. Immagine e realtà, Electa, Milano 1981, pp. 76-83.
27 A. Valentini, Leopardi. Idillio metafisico e poesia copernicana, Bulzoni, Roma1991. In più ampia prospettiva va tenuto conto delle informazioni di W. Le-penies, Autoren und Wissenschaftler im 18. Jahrhundert: Buffon, Linne,Winckelmann, Georg Foster, Erasmus Darwin, Hanser, München 1988, trad.it Natura e scrittura: autori e scienziati nel XVIII secolo, Il Mulino, Bologna1992.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
123
Lo stesso Leopardi ci avverte che la fine delle “favole anti-che” ha un termine geografico oltre che storico, il quale riguardain una certa misura la mappa come immagine del globo, e quindiuna “fine dello spazio”28, nel momento in cui “figurato è il mon-do in breve carta” e “tutto è simile, e discoprendo / Solo il nullas’accresce”. Se perciò il vero “appena è giunto” vieta “il caro im-maginar”, segnando per così dire i “confini” dell’idillio tradizio-nale, un nuovo tipo di immagini sarà necessario, che potremmodire “immagini senza illusione” (per quanto Leopardi usi questotermine come sinonimo di immagine), e quindi una diversa con-cezione dell’idillio rispetto a quella “petrarchesco-arcadica, es-senzialmente edonistica”29. Se dunque questa “funzione idillio”ha un’analogia strutturale con il “frammento” (lo ha osservatoSantagata), è importante notare che in questo modo essa viene adefinirsi quale elemento del racconto poetico (e perciò partestrutturante di altre composizioni più complesse)30. Tale raccon-to – animato da un riflettere della poesia su se stessa e sulla crisidell’immaginazione, estesa “dal visibile all’invisibile” – si costrui-sce, proprio nel momento in cui vuole liberarsi di ogni “affetta-zione” per attingere al “patetico”, attraverso un “commercio coisensi”31, ossia sguardi e percorrimenti del fenomenico, senza pos-sedere a priori la certezza di una referenzialità (anzi sapendo dinon poter raggiungere la cosa), ma tentando comunque attraver-so il proprio scetticismo, facendo immaginare alle parole le cose,secondo una “logica del gioco” (che, va ricordato, permette di“essere nel mondo ma non del mondo”: un eludere più che un il-ludere, quindi) caratteristica di una cultura del “come se”; in-somma alla maniera – si potrebbe dire – di quanto sembra sug-gerire Colombo nel suo dialogo con Gutierrez proponendo una“congettura speculativa”. È un’analoga congettura che contrap-
28 G. Ficara, Il punto di vista della natura, cit., p. 54: è opportunamente ricor-dato anche il passo della Storia del genere umano sulle scoperte geografiche.
29 L. Blasucci, Leopardi e i segnali dell’infinito, Il Mulino, Bologna 1985.30 M. Santagata, Quella celeste naturalezza, cit., p. 168; Id, I confini dell’idillio,
cit., pp. 35 e ss., parla di una componente narrativa saldamente intrecciataall’autobiografia interiore e al discorso conoscitivo.
31 E. Raimondi, Il mito e il moderno, cit., p. 483.
Vincenzo Bagnoli
124
pone all’inafferrabilità dell’oggetto cercato un “simulacro d’infi-nito” o “un’arte dell’indefinito”32.
2. L’immaginazione dello sguardo (estetica)
Il problema che Leopardi si era posto consisteva dunque nelsuperare l’artificiosità del locus amoenus e l’arbitrarietà dei suoilimiti, non in virtù di un richiamo al naturale, al vero ecc., ma allapossibilità di immaginarlo mercé un nuovo genere di artificio.Come nota nel Discorso di un italiano intorno alla poesia roman-tica, noi non siamo più nella posizione degli “spettatori naturali”:nel considerare la natura e i suoi fenomeni, la condizione dei mo-derni, che coincide con quella degli scienziati (il cui obiettivosono – ci avverte – “le armonie della natura e le analogie e le sim-patie”), “è una condizione artificiata”, perché occorrono “mille
32 G. Guglielmi, L’infinito terreno. Saggio su Leopardi, Manni, Lecce 2000, pp. 75-76. Con altra terminologia, più tecnica, la semiologia spiega come la descrizio-ne saturi il discorso artistico della “tematica vuota” dello sguardo, segno non diuna dinamica referenziale rispetto al reale, ma anzi continua citazione autorefe-renziale del testo: il successo di un testo dotato di istanza conoscitiva consiste al-lora nell’“operare affinché questa proliferazione adiacente di sguardi, di am-bienti trasparenti ecc. sia indotta a svolgere una sua funzione nel racconto, nonsia dunque più una semplice colmatura, e di fare in modo che la ridondanzaanaforica dei contenuti diventi dialettica di contenuti” (Ph. Hamon, Cos’è unadescrizione, cit., p. 83). Sulla logica del gioco rimando alle osservazioni del pri-mo capitolo, aggiungendo solo alle osservazioni di R. Caillois (Les jeux et leshommes. Le masque et le vertige, Gallimard, Paris 1967, trad. it. I giochi e gli uo-mini. La maschera e la vertigine, Bompiani, Milano 1981, pp. 36-40) e di J. Hui-zinga (Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, Tjeenk Willink,Haarlem 1938, trad. it. Homo ludens, Einaudi, Torino 1996 [nuova ed.], pp. 10-30) sulla struttura dell’isolamento (alla quale sembrano rispondere l’“ermo col-le”, la “vetta della torre antica” ecc., come anche “l’arida schiena / Del formi-dabil monte / Sterminator Vesevo”): G. Bachelard, La poétique de la rêverie,PUF, Paris 1960, trad. it. La poetica della rêverie, Dedalo, Bari 1972, p. 109, diceche l’isolamento dei bambini nel gioco ha in sé “la felicità di sognare ciò che saràin seguito, la felicità dei poeti”); sul “confine” artificiale del gioco, la riflessionedi Calvino sul “mito epico” dell’infanzia coltivato nei “giardini dell’interiorità”come introiezione di questo spazio del gioco. Sulla condizione di “solitudine”della spazialità letteraria si veda M. Blanchot, L’éspace littéraire, Gallimard, Pa-ris 1995, trad. it. Lo spazio letterario, Einaudi, Torino 19752, tutto il cap. 1.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
125
astuzie e quasi frodi” per poterle estorcere i suoi segreti, a prez-zo però di “quei diletti che prima offeriva spontaneamente”33. Ilpercorso che guida alla genesi della Ginestra non è insomma mol-to distante da quello compiuto da Humboldt, di cui si è fattamenzione nel primo capitolo, e consiste soprattutto nella rimo-zione del mito (soprattutto del mito antropomorfico) dal paesag-gio per svelare (proprio al contrario di ciò che facevano i greci)l’incommensurabilità dell’umano con il naturale, un’incommen-surabilità insanabile e tutt’al più conciliabile solo all’interno diuna prospettiva completamente diversa34. Questo comporta l’a-bolizione della luce artificiale che illumina uniformemente la sce-na (Z, 28 luglio 1820, 190, da confrontare con le osservazioni del3 novembre 1821, 2042-2043), l’astratto nitore di tutti i dettaglientro il campo visivo, in altre parole l’ordine retorico imposto alleicone verbali. Se Ariosto aveva optato per la prospettiva dall’altoe la continua dialettica fra lo spazio misurato della mappa e quel-lo aggrovigliato della vita, anche Leopardi costruisce una distan-za dello sguardo che è diversa dalla “cornice” letteraria; la sua“poetica della distanza” (Z, 10 luglio 1823, 2936-1937) si affidaallora a una lingua che rifiuta la categoria del “puro” a favore del-la storicità35, a un’etica dell’inattuale (centrata sul sogno e sulla ri-cordanza)36, e soprattutto all’estetica del vago.
L’Infinito è senza dubbio il testo paradigmatico di tale opera-zione, nel quale la rimozione del paesaggio reale permette la li-bera azione dell’immaginare: è un “grado zero” del paesaggio, diun mondo le cui leggi fisiche, come per Humboldt, sono tutte dadescrivere37. In questa lirica si viene avvertiti di una serie di spe-cificità dello sguardo leopardiano; in primo luogo l’enfasi dellafinzione, come nel caso di Baudelaire, per così dire mette in pa-
33 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., p. 918.34 H. Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1981,
trad. it. La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, Il Mu-lino, Bologna 1984, pp. 291 e ss.
35 G. Guglielmi, L’infinito terreno, cit., pp. 68-69.36 C. Galimberti, Sulla Imagery della canzone “Alla sua donna”, in «Forum ita-
licum», 1990, p. 97.37 G. Bertone, Lo sguardo escluso. L’idea di paesaggio nella letteratura occiden-
tale, Interlinea, Novara 1999, p. 55.
Vincenzo Bagnoli
126
rodia la posizione elevata dell’“ermo colle”, che dovrebbe mar-care la descrizione “realistica”, negando con l’ostacolo della “sie-pe” la “trasparenza” dei luoghi postulata da Hamon, vale a direla possibilità dello sguardo38. Questo paradosso serve a ricordareche, nello scrivere, l’autore ha comunque davanti agli occhi la“siepe” dei segni e del foglio, e che quindi la sua azione è quelladi “rêver”: messo su tela o su carta non è l’atto del vedere, ma ilracconto di un aver visto, un’operazione che chiama in causa unadiversa dimensione temporale39. Già in Foscolo l’idillio paesisti-co si trasforma e sconfina nell’idillio mortuario (così che il ricor-do possessivo della fanciullezza si mescola con la rovina)40. Tut-tavia il paradosso ha un altro lato, poiché viene detto che il fin-gere “nel pensier” avviene comunque “sedendo e mirando”, eche “quello / infinito silenzio” viene comparato a “questa voce”(postulata presente ma in realtà passata). Il vettore di costruzionespaziale è il medesimo visto all’opera nell’incipit della Ginestra,dove all’immagine presente del fiore si accosta un’immaginemnemonica differente; allo stesso modo nella quarta strofe (sulla
38 Opportuno il rimando alla Storia del genere umano di A. Folin, Pensare peraffetti, cit., p. 32; J. Starobinski, La transparence et l’obstacle, Plon, Paris1958, trad. it. La trasparenza e l’ostacolo. Saggio su Jean-Jacques Rousseau, IlMulino, Bologna 1982; I. Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, inUna pietra sopra, Einaudi, Torino 1980, pp. 184-185.
39 A. Parronchi, II muro di Berkeley e la siepe di Leopardi, o la nascita della “ve-duta indiretta”, in «Paragone», X, 1959, 114; poi in Studi sulla “dolce” pro-spettiva, Martello, Milano 1964, pp. 549-580. Si può pensare alle osserva-zioni di Šklovskij sulla natura opaca della forma artificialis nell’opera d’arte,che comunica rapporti formali, non significati, come riassume G. Gugliel-mi, L’invenzione della letteratura, Liguori, Napoli 2001, pp. 4-5. Cfr. ancheG. Genette, Fiction et diction, Gallimard, Paris 1991, trad. it. Finzione e di-zione, Pratiche, Parma 1994, pp. 31-33.
40 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., p. 31. Sui riusi leopardiani di Foscolo,S. Romagnoli, Spazio pittorico e spazio letterario da Parini a Gadda, in Il pae-saggio, vol. V: Storia d’Italia. Annali, a c. di C. De Seta, Einaudi, Torino1982, p. 438 (dove è anche un’attenta analisi della costruzione del quadro edel punto di vista in maniera ben distinta dallo stereotipo letterario). Si vedainoltre M. Santagata, Il tramonto della luna e altri studi su Foscolo e Leopar-di, Liguori, Napoli 1999. Sulla natura paradossale di Leopardi già R. Bac-chelli, Leopardi. Commenti letterari, Mondadori, Milano 1962, che a propo-sito dell’ipotesi negativa parlava di “assurdo”.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
127
cui importanza, rimarcata anche dalla posizione centrale, vale lapena di insistere) la lunga phantasia cosmica è introdotta e con-clusa dai riferimenti alla posizione seduta, e dalla sua percezione“tattile”, di fronte al “quadro” naturale (vv. 158-161: “Sovente inqueste rive / […] Seggo la notte”; vv. 186-187: “…di cui fa segno/ Il suol ch’io premo”).
Il traguardo delle immagini della poesia, al di là e attraversola siepe del linguaggio (un ostacolo e una trasparenza), è pur sem-pre una sensazione analoga a quella prodotta dalla cosa reale,come voleva Gravina. Di più, l’immaginare si propone come unsistema di modellizzazione che deve quanto più possibile esserearmonizzato con quanto modella, ossia una visione del mondonaturale, che va facendosi sempre più complessa. Come osservaArnheim a proposito delle arti visive, la “forma” è “invenzione”:l’immagine artistica non parte dalla “proiezione ottica dell’ogget-to rappresentato, ma è un equivalente, reso tramite le caratteri-stiche di un determinato medium, di quanto si osserva nell’og-getto”. La forma figurativa non si trova insomma nel modello maè costruzione che dipende dal medium41; in questo caso dalla pa-rola. Qualcosa di analogo, in ambito letterario, è stato notato aproposito di Schiller, il quale, venuta meno la corrispondenza fra“sensazione” e “pensiero”, non può che riflettere sull’effetto cau-sato in interiore homine dagli oggetti, e fondare la propria “com-mozione” unicamente su questa attività speculativa dell’intellet-to42. A propria volta Novalis negli Hymnen an die Nacht (V, 452-457) lamenta:
Verschwunden waren die Götter.Einsam und leblosStand die NaturEntseelt von der strengen ZahlEnd der eisernen KetteGesetze wurden.
41 R. Arnheim, Art and visual perception. A Psychology of the Creative Eye,University of California Press, Berkeley 19742, trad. it. Arte e percezione vi-siva, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 122-123.
42 E. Raimondi, Il mito e il moderno, cit., p. 485.
Vincenzo Bagnoli
128
Aggiunge poi però: “Und des Himmels / Unendliche Fernen/ Füllten mit leuchtenden Welten sich”43. Il poeta tedesco, in ve-rità, prelude con ciò alla poesia della rivelazione, delineando inchiave mistica questo più ampio universo; tuttavia, considerataquesta specificità, in ogni caso resta analogo l’allargamento delcampo, da ricondurre nel caso di Leopardi sotto il segno del di-battito su un cartesianesimo poetico che da Gravina giungevafino a Breme (e a proposito del quale Leopardi però continuavaa ribadire la necessità di non sconfinare nella metafisica ma man-tenersi al “sensibile”, ossia al patetico, ma anche l’esperibile dal-l’uomo)44.
L’infinito non è allora che realizzazione della possibilità di“spaziare con l’immaginazione”: gli esempi che Leopardi offre,nella nota esposizione della “teoria del piacere”, sono appunto glieffetti di taluni paesaggi, la piacevolezza di una “vasta e tuttauguale pianura”, e “così un cielo senza un nuvolo” (Z, 20 settem-bre 1821, 1745-1747). È la scoperta di uno spazio nudo ed es-senziale: il cielo in Turner e Constable, la steppa in Humboldt, lecui osservazioni sembrano anticipare quelle leopardiane: “Comel’oceano, la steppa riempie l’animo del sentimento dell’infinito”.Infatti, “quasi con ciò liberandolo dalle impressioni sensibili del-lo spazio”, lo colma di una “più alta tensione spirituale”: ma,come osserva poi il geografo, con accenti che richiamano il Gali-lei rappresentatore di “altri mondi”,
se il limpido specchio del mare offre una piacevole vista, conle onde lievi che si increspano spumeggiando dolcemente [in-
43 “Scomparvero gli dei col loro seguito / Solitaria e inanimata / stava la natu-ra. / La legavano con ferrea catena / l’arido numero / e il metro severo”. Vv.473-475: “E le lontananze / del cielo si colmarono / di mondi luminosi”.
44 Le obiezioni di Leopardi nel Discorso di un italiano intorno alla poesia ro-mantica, in Tutte le opere, cit., vol. I, p. 943; si veda anche Z, 4 ottobre 1821,261. Sul “cartesianesimo poetico” A. Battistini, E. Raimondi, Le figure dellaretorica, cit., pp. 283 e ss.; G. Guglielmi, L’infinito terreno, cit., pp. 8-9. DiLeopardi si devono vedere però anche alcune pagine giovanili della Storiadell’astronomia sulla “pluralità dei mondi”, dove – nella foga delle citazioniletterarie – l’intonazione non è dissimile da quella di Novalis, anche se pre-sto l’autore si ricompone: Tutte le opere, cit., vol. I, pp. 630-631.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
129
fra si vedrà l’importanza della varietà anche in Leopardi], lasteppa al contrario si stende inanimata e immobile, come lanuda crosta rocciosa di un pianeta privo di vita45.
È proprio questo spazio vuoto (portato alla coscienza del-l’uomo da un’immaginazione di tipo non solo poetico ma – comesi è detto – scientifico) quasi una proiezione geometrica, un’e-stensione cartesiana, a permettere di superare i limiti tanto dell’i-dillio quanto della “breve carta”, nel territorio della finzione.
Il vedere è un atto di fingere in letteratura: un fabbricarespiega Leopardi, un mentire glossa Ungaretti, ma che vale co-munque per approssimare, come opportunamente correggeGuglielmi, ricordando che la finzione è condizione del moder-no46, oltre che spazio proprio della letteratura. Tanto nella fic-tion della prosa quanto nella poiesis è un fare, come si è già det-to. È l’operazione dell’artifex, indubbiamente, ma è soprattuttol’operazione implicita del produrre immagini: “immaginando iofingo”, avverte Leopardi (Alla mia donna, v. 25). È dunque an-che lo spazio della autorappresentazione del soggetto liricocome personaggio, al quale la relazione con il paesaggio poneun problema non indifferente: è in relazione con esso come at-tore o come spettatore? L’Infinito racconta proprio di comeLeopardi, nel farsi personaggio letterario (ossia nel rappresen-tarsi come io poetico, in un dialogo serrato con Petrarca, comeè stato dimostrato47, sostanziato da momenti di forte dialettica),provi questo spaesamento nel sovrapporsi di piani differenti.Per evitare la riduzione del mondo esterno a riflesso della sog-gettività (conciliazione), ridefinisce lo sguardo, dotando il sog-getto di un senso determinato topologicamente: e alla fine l’at-tività dell’io si concentra, tutto nel suo essere è un punto di vi-sta, tanto di un “fingere di vedere” gli elementi concreti del pae-
45 A. von Humboldt, Quadri della natura, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze)1998, p. 12: l’immagine a propria volta sembra riecheggiare quella della “va-sta solitudine d’arena o una massa di diaspro”, del “globo immenso di cristal-lo” di Galilei, cit. nel secondo capitolo.
46 G. Guglielmi, L’infinito terreno, cit., pp. 56-57 e 20-22.47 L. Blasucci, I tempi dei “Canti”, cit., pp. 73 e ss.
Vincenzo Bagnoli
130
saggio (“questo colle”, “questa siepe”, “queste piante”) quantodi un “fingere di immaginare” (“spazi di là da quella”, “quello/ infinito silenzio”), che si svolge però come un’attività di com-parazione tra sensazioni e finzioni48.
In ogni caso l’esperienza del sublime avviene non attraversolo spettacolo naturale, ma una calcolata finzione, l’immagine diuno spettacolo che non c’è49, segnando uno scarto anche dall’im-maginario romantico. Quello che Leopardi pare suggerire è chetale genere d’esperienza sia nient’altro che la letteratura: l’espe-rienza della trasformazione linguistica dell’esperienza, della suaelaborazione. La siepe dunque è il linguaggio, il testo, la distanzacritica della mappa: la finzione dello sguardo (lo sguardo dellafinzione) che calcola uno spazio cartesiano vuoto, ridotto a unaneutra quantità, permette così (come al marinaio di Poe l’uscitadel maelstrom) di stare nel naufragio che tocca l’esperienza po-stilluminista, ma di trovarlo dolce per la possibilità di raccontar-lo sulla carta.
Al tempo stesso, però, tale costruzione di distanze testualinon traccia la lontananza come astrattezza o idealità: dove l’in-finito per Schiller è segno di un’arte moderna, superiore a quel-la della limitazione, per Leopardi esso resta, come si è avutoagio di vedere, una finzione consapevole del limite, strumentodella letterarietà e non dell’autenticità della poesia, così comel’immaginazione non risarcisce della noia, della frustrazione diun desiderio destinato a espandersi a vuoto50. Non sono conci-liabili i due mondi (“questo è quel mondo?”, si chiede in A Sil-via, v. 56): quello dell’immaginazione non maschera le ferite diquello vero. L’operazione di Leopardi si mantiene consapevol-mente nel linguaggio, nello spazio intermedio, servendosi di unalfabeto di simboli che sono della sfera letteraria, ma al tempostesso conservando la tensione oltre la siepe e la fisicità del guar-
48 Caso estremo sarebbe “questo mare”, al tempo stesso “definizione dell’infi-nito” ma anche memoria ottica del mare reale di là dalla siepe secondo P. Bi-gongiari, Leopardi, cit., p. 312.
49 C. Galimberti, Il linguaggio del vero in Leopardi, cit., pp. 68 e ss.50 G. Guglielmi, L’infinito terreno, cit., pp. 37 e ss. e G. Sangirardi, Leopardi:
il bello e il terribile, cit., p. 130.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
131
dare anche al livello dell’intenzione comunicativa51. Da un latodunque si evita l’astrattezza del trattamento puramente retoricocon la presenza del desiderio, che non è utopia pura, ma si ra-dica nella fisicità del desiderare corporeo, dell’esserci, ed èquindi un’esperibile eterotopia, proprio perché il diletto dell’i-mitazione poetica consiste nel dare “sommo risalto alle nostresensazioni” (Z, 9 luglio 1821, 1303). Dall’altro però tale deside-rio resta pur sempre quel peculiare “desiderio intransitivo” del-la sua teoria del piacere, che ha come oggetto solo le immaginiche si finge (Z, 23 settembre 1823, 3500, ma si veda anche 10 lu-glio 1823, 2936): la felicità che l’uomo desidera è terrena, e an-che l’infinito è “un infinito terreno”, che pure è impossibile e al-lora non “può aver luogo quaggiù, altro che nell’immaginazio-ne e nel pensiero”. In letteratura insomma. È un ammonimentoa che lo “specchio” della letteratura, in quanto ricerca di “al-ternativa” (un’alternativa, per quanto riguarda questo discorso,almeno inizialmente ottica, prospettica), non cerchi di fondarsicome edificazione di una verità altra e autosufficiente, ma man-tenga appunto il carattere di ricerca che è di tutte le avventuredella conoscenza umana: evitando di chiudersi anche nella pri-gione della circostanza o della perfezione formale dell’immagi-ne artistica52. Per fare allora del “leopardismo” si possono cita-re i vv. 20-25 della settima e ultima parte di Un posto di vacanzadi Sereni:
51 G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., pp. 222-223. U. Dotti, Lo sguardo sulmondo. Introduzione a Leopardi, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 9: “Leopardiseppe trasformare la propria visione teorica in un importante motivo dell’a-gire”. Affascinante l’analisi di nature, solitude e imagination come premessestrettamente correlate di una rappresentazione che mantiene sempre unaconnessione con il mondo reale, nell’intenzione di modificare la percezionedelle cose in M. Wiley, Romantic Geography. Wordsworth and Anglo-euro-pean Spaces, Macmillan Press, Basingstoke 1998, in part. pp. 3 e ss., che peròresta nell’ambito della proposta utopica. Sulla poesia leopardiana come co-struzione di uno spazio comune si veda R. Ronchi, Luogo comune. Versoun’etica della scrittura, Egea, Milano 1996, pp. 31 e ss.
52 Riprendo l’intelligente proposta di F. Muzzioli, L’alternativa letteraria, Mel-temi, Roma 2001, legittimato anche dal riferimento a p. 57.
Vincenzo Bagnoli
132
– non una storia mia o di altrinon un amore nemmeno una poesia
ma un progettosempre in divenire sempre“in fieri” di cui essere parteper una volta senza umiltà né orgogliosapendo di non sapere.
Dove nella richiesta di un siffatto “essere parte” senza umiltàe orgoglio è stata notata l’eco fortissima dell’ultima strofe dellaGinestra. La dissimulazione della poesia è messa in atto comeconsapevolezza ironica della finzione letteraria e della sua nonautonomia, onde evitare e smascherare ogni inganno o illusione53.Obiettivo di Leopardi è non un pathos ma un ethos della distan-za e della partecipazione (quale sarà ripreso a oltre un secolo didistanza dal sistematicamente perplesso Palomar), un particolaretipo di conoscenza da ottenere mediante lo sguardo, sgomberatoil campo dalle quinte retoriche e dal dogma del già detto, senzacedere alla fiducia autoreferenziale nella virtù demiurgica dellafictio, all’assolutezza del cogito, ma assumendola quale strategiadi coinvolgimento metonimico nella res extensa, quasi un’epochéfenomenologica, come appunto nella Ginestra 54.
53 G. Guglielmi, L’infinito terreno, cit., p. 69. Cfr. anche G. Bàrberi Squarotti,Leopardi: le allegorie della poesia, in Dall’anima al sottosuolo, Longo, Ra-venna 1982, pp. 19 e ss. Sull’attualità di Leopardi presso moderni e con-temporanei cfr. il classico G. Lonardi, Leopardismo. Tre saggi sugli usi diLeopardi dall’Otto al Novecento, Sansoni, Firenze 1990 (nuova ed.); maesemplare è A. Zanzotto, Giacomo Leopardi, in Fantasie d’avvicinamento,Mondadori, Milano 1991, pp. 125-139.
54 B. Biral, Il sentimento del tempo. Leopardi, Baudelaire e Montale, in «Il Pon-te», agosto-settembre 1965, p. 1175; L. Tassoni, Finzione e conoscenza, Lu-brica, Bergamo 1989, pp. 15-16 e 55; A. Folin, Pensare per affetti, cit., pp.22-23: per Leopardi “la natura è immagine”, e la possibilità di vederla inquesto modo anche con la ragione significa “vedere le cose nella loro neces-sità ed evidenza; vederle, in una parola, nella loro verità di immagine”; il ri-chiamo è a Merleau-Ponty. Sulla poetica della distanza pp. 27 e ss.; cfr. inol-tre pp. 54-55. Al proposito si veda M. Merleau-Ponty, Phenomenologie de laperception, Gallimard, Paris 1945, trad. it. Fenomenologia della percezione,Il Saggiatore, Milano 1965, pp. 429 e 549: la poesia realizza la “condizione
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
133
Il procedimento di smascheramento (che comporta la rimo-zione dei miti costruiti dall’uomo, fra i quali quello del “Secol su-perbo e sciocco”) è ben esemplificato in Aspasia, canto che esibi-sce a propria volta il tema dello sdoppiamento tra la persona (inquesto caso l’oggetto amato) e la sua immagine55. E anche qui larisposta consiste nel ritorno al paesaggio come fenomeno. Il sem-biante fuggitivo di Aspasia lampeggia davanti allo sguardo comeun velo frapposto a ogni possibile paesaggio, con un contrasto, sipotrebbe dire, fra il primo piano e lo sfondo, fra l’“armonia ride-sta” della visione e le “tacenti stelle”, che sembrano quindi porreallo spettatore lo stesso muto interrogativo del Canto notturno(mentre nella Ginestra, come si vedrà, cambieranno radicalmen-te la loro funzione). Aspasia è letteralmente un’apocalisse dellosguardo, che fa apparire “novo ciel, nova terra”, (v. 27, come il“Pensiero dominante” schiudeva al poeta una “nova / immen-sità”). Il rischio di cui Leopardi si avvede è che l’infinito si risol-va come la “donna angelicata” in un’immagine idealizzata, unostereotipo letterario56: il compito dell’immaginazione non si develimitare all’utopia, alla promise de bonheur, che contrasterebbecon l’etica fondamentalmente ostile agli inganni di Leopardi. Larisposta è nei versi finali, nei quali il poeta torna a scegliere la po-sizione assunta in quasi tutte le liriche, di fronte al paesaggio (vv.106-112, corsivi miei):
di pensabilità” di un oggetto poetico (alla maniera in cui viene realizzataquella dell’oggetto scientifico) specificamente attraverso la figura del pae-saggio: esso rappresenta la configurazione intenzionale della percezione chesupera le stereotopie retoriche. Tale percezione, che identifica quindi un’at-tività critica del pensiero, non è però la percezione analitica e cristallizzatadel pensiero scientifico moderno, bensì “lo stile di tutti gli stili”, quindi il“senso di tutti i sensi”: l’eterotopia, la metonimia, la costellazione estetica.Cfr. poi con J.-P. Sartre, Che cos’è la letteratura?, Il Saggiatore, Milano 1960(nuova ed. 1995), pp. 12 e ss., ma anche pp. 140 e ss. e 323 e ss., per il qua-le l’immaginazione è categoria centrale dell’esperienza, quella estetica nonrappresentando una dimensione separata, ma espressione dell’esistenza stes-sa, contraddistinta però dal carattere intenzionale.
55 L. Spitzer, Studi italiani, Vita e pensiero, Milano 1976, pp. 251-292.56 Sulla presenza della terminologia religiosa secolarizzata tipica della lirica
d’amore in Aspasia si veda C. Galimberti, Novo ciel, nova terra, in Studi inonore di Alberto Chiari, Paideia, Brescia 1973, vol. I, pp. 537-547, a p. 539.
Vincenzo Bagnoli
134
… se d’affettiOrba la vita, e di gentili errori,È notte senza stelle a mezzo il verno,Già del fato mortale a me bastanteE conforto e vendetta è che su l’erbaQui neghittoso immobile giacendo,Il mar la terra e il ciel miro e sorrido.
Dove “qui” è parola chiave, come si avrà modo di vedere an-che per la Ginestra. Di questi endecasillabi sono state date diver-se interpretazioni, e diversamente interpretato è soprattutto ilsenso del sorriso del poeta sdraiato “neghittoso” (traduce la po-situra del kateu‰dw, “giaccio”, di Saffo? o piuttosto del recubanslentus? ma nella parola italiana domina a livello denotativo e con-notativo l’accezione negativa) con cui il canto si chiude: è sprez-zante o compassionevole? oppure ricambia “di natura il riso”,vale a dire il sorriso ambiguo della “scena del mondo” (nella qua-le male e bene coesistono per Leopardi, secondo Galimberti informa gnostica), ed è quindi il segno stesso della letteratura, chetrova nella natura l’immagine, ma per fare della sua forma altroda essa, fra “tenerezza e sdegno”?57 Per certo, con Spitzer, vi si
57 Le fonti solitamente citate (Testi e Monti) fanno propendere, seppur conqualche dubbio, taluni commentatori verso la prima ipotesi, confortata dalsenso del “riso” nella Ginestra o nel Dialogo di Tristano e un amico; di “ama-rezza e distacco” parla Galimberti, Novo ciel, nova terra, cit., p. 546 (che peròrichiama un’osservazione importante da Z, 23 settembre 1828, 4391: “chi hail coraggio di ridere è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire”).Tuttavia si può certo pensare a una duplicità d’atteggiamenti, come d’altron-de è duplice il volto della natura (S. Solmi, Le due “ideologie” di Leopardi, orain Studi leopardiani, Adelphi, Milano 1987, pp. 97-110; ambiguità delle coseanche in Galimberti, Messaggio e forma nella “Ginestra”, cit., p. 65). Spesso ipaesaggi naturali ridono o sorridono nei Canti: La vita solitaria, v. 47; Al con-te Carlo Pepoli, v. 129; Le ricordanze, v. 124; Il pensiero dominante, v. 29 (doveil “campo verde che lontan sorride” è contrapposto ai “nudi sassi / dello sca-bro Apennino”). Può essere interessante, ai fini di questo discorso, seguire lalettura, rapida ma efficace, di Folin, Pensare per affetti, cit., pp. 57-58 dellacanzone Alla sua donna (considerata, ci viene ricordato, “un inno all’idea pla-tonica di bellezza”), dove si mostra che la “beltà” non è una donna (figuradell’idea come a suo modo Aspasia), ma il “risplendere delle cose”, al qualesi riferisce “di natura il riso”. Si ribaltano dunque i rapporti retorici di sfon-
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
135
può leggere il recupero del paesaggio reale a danno di quello uto-pico del v. 27, e quindi un “recupero della vista”, della libertà del-la vista58. In tale preferenza per “questo” mondo, rispetto a quel-lo ideale, è una conferma della scelta sensistica, e anche la defini-zione del ruolo dell’immaginazione letteraria quale mezzo perporre la coscienza dell’uomo come spettatore davanti ai fenome-ni, nonché una concezione della lontananza che marca una nettadifferenza rispetto a Novalis59. La stessa “teoria del piacere” leo-pardiana viene in aiuto (Z, 20 settembre 1821, 1746): “il piaceredella varietà e dell’incertezza prevale a quello dell’apparente infi-nità, e dell’immensa uniformità”. Per questa ragione, continua,risulta uno spettacolo più piacevole “la vista di una moltitudineinnumerabile, come delle stelle, o di persone ec. Un moto molte-plice, incerto, confuso, irregolare, disordinato, un ondeggiamen-to vago ec.” (1747). Si ripensi al “mare agitato” di Humboldt, a
do e primo piano, perché è la figura umana a essere decorazione, ma soprat-tutto si osserva come in un analogo contesto di dialettica tra “immagine idea-lizzata” e “immagine (fenomenologica) del paesaggio” si intraveda già la pos-sibilità che l’“alta specie” della bellezza si trovi anche in ciò che può appari-re come “arido suolo”. La natura matrigna è anche altro da sé, se guardata inquesta prospettiva (si veda il finale del Dialogo della natura e di un islandese).Il duplice atteggiamento di “tenerezza e sdegno” della letteratura è quello ri-levato nella dinamica dei deittici da E. Raimondi, Il mito e il moderno, cit., p.491. Sull’atteggiamento critico o utopistico di Leopardi cfr. anche F. Fortini,Il passaggio della gioia, cit., p. 253: “non si può insomma omettere dal ‘pen-siero’ leopardiano l’enorme gioia dell’avventura formale”. Cfr. inoltre G.A.Camerino, “E il piacer… farsi paura”. Leopardi e la percezione di fenomeni na-turali, in «Italianistica», 3, 1987, pp. 337-346; Id., Le forme del diletto. Aspet-ti e fenomeni naturali nella percezione di Leopardi, Milella, Lecce 1990.
58 Siamo nell’ambito di un trapasso dall’io della lirica petrarchesca ad altro: ladialettica con l’antecedente è simile alla demonizzazione, secondo le catego-rie di H. Bloom, The Anxiety of Influence, Oxford University Press, NewYork-Oxford 1973, trad. it. L’angoscia dell’influenza. Una teoria della poesia,Feltrinelli, Milano 1983: il daimon qui sarebbe il platonismo. Si passa cosìdal petrarchesco “sguardo che fruga nel mondo alla ricerca dell’oggettoamato, perduto, per farlo riapparire” (G. Baldissone, Gli occhi della lettera-tura, cit., p. 138) a una sorta di “sguardo non intenzionato dell’infanzia”(A.G. Gargani, Sguardo e destino, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 74) che “sidistende in una scena di segni dove tutte le circostanze già conosciute e ap-prese ritornano come lo spettro di relazioni inaudite”.
59 A. Folin, Pensare per affetti, cit., p. 33.
Vincenzo Bagnoli
136
questo punto, ma anche alla Lettura di un’onda del signor Palo-mar, la cui difficoltà nell’“isolare un’onda separandola dall’ondache immediatamente la segue […] così come separarla dall’ondache la precede” spiega forse – partendo da un’ottica certo diver-sa e consapevole dei paradossi quantistici – il senso del vago leo-pardiano60, il cui tratto estetico essenziale è proprio quello di rap-presentare in immagini sintetiche una molteplicità, ciò che Leo-pardi valuta la migliore risorsa di uno stile, come nel caso di Ora-zio e Dante (Z, 3 novembre 1821, 2041-2043; non discostandosipoi da quanto suggeriva Gravina, Della ragion poetica, I, 3). Il si-gnificato del suo “ridur tutto ad immagine” consiste proprio nel-la “facilità mirabile di ravvicinare e rassomigliare gli oggetti dellespecie più distinte”, riproducendo la complessità del mondo chene è la forma stessa, e quindi il motivo d’incanto (la sottile reteche “la minuta e squisita analisi” non riesce a scoprire, giacchéoccorre invece vedere “molti” e “grandi rapporti”: Z, 5-6 ottobre1821, 1852), in maniera tale “d’incorporare vivissimamente ilpensiero il più astratto” (Z, 7 settembre 1821, 1650)61. Questo ilvantaggio di uno stile che sappia movere, non essere piacevole allettore bensì aiutarlo a superare la noia della propria finitezzamostrando da un altro punto di vista le cose, finendo così inevita-bilmente per docere, per avere insomma non una sterile pretesaedificante, bensì un reale valore conoscitivo.
Lo spazio vuoto dell’infinito si riempie così, trasformandosinello spazio che contraddistingue La ginestra. La possibilità diestendere lo sguardo oltre il dato (il già detto della letteratura,delle teorie, degli sguardi), non deve servire a sprofondarsi nellacontemplazione di un’immagine autoreferenziale, ma a costruireimmagini come “sistemi” o “congetture speculative”, a volerusare termini leopardiani, vale a dire per ipotizzare, per pro-spettare, mai rassegnandosi al chiuso delle formulazioni, mai ri-
60 P. Bigongiari, Leopardi, cit., p. 255, per il quale “immensità” corregge l’im-magine dell’infinità, suggerisce la presenza della materia, donando quindiall’immagine un “senso fisico”.
61 G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., p. 189: “l’immagine cosmica è im-mediata. Ci dà il tutto prima delle parti”.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
137
ducendo la ricerca dello stile a dogma: proposta tanto più rile-vante se è letta nel contesto della querelle in corso in quegli anni.E quando nella Ginestra ritorna la rugosa figura del terreno, cheinclude in sé la contorta linea della storia, lo specchiarsi dellestelle nel mare così come il passato dell’eruzione (anticipata aivv. 29-32 e raccontata nella quinta strofe) traguardato nel pre-sente del flutto indurato che pare tuttavia muoversi, è davveromondo che si guarda con l’“occhio del paesaggio”62, non sog-gettività proiettata dappertutto, come era ancora nei sonetti diFoscolo; la differenza saliente di questa veduta essendo la vastitàe la profondità.
Tra Sette e Ottocento l’immaginazione è stata più volte pro-posta come strumento creativo e anche percettivo: da Addison,da Pope, da Wolff, che porta l’attenzione sulla imaginatio comefacultas fingiendi (riproduttiva e produttiva), senza dimenticareMuratori (con la Perfetta poesia italiana e Della forza della fanta-sia umana), Fichte e lo Schiller di Spieltrieb 63. Leopardi tuttaviapare suggerirne una dimensione (pur nient’affatto sacrale) vici-na piuttosto a quella che sarà dispiegata da Poe in Eureka: lacontiguità del qui col tutto, cifra essenziale dello spazio della Gi-nestra, si delinea insomma non come apparizione, ma come co-struzione laboriosamente e attivamente perseguita a partire dal-le linee prospettiche dell’idillio, come si è visto, entro uno spa-zio dell’immensità da intendersi come regione della filosofia,non mera fascinazione del mostruosamente immane, proprioperché il “commercio intimo” delle metonimie di vicino e lonta-no, di presente e passato (e futuro), di grande e piccolo, prefi-gura una partecipazione distesa, appunto senza codardia né or-goglio, “col sorriso sulle labbra”64. Se valgono certo i “topoi cul-
62 G. Bachelard, Poétique de l’espace, cit., p. 190.63 J. Engell, The Creative Imagination. Enlightenment to Romanticism, Har-
vard University Press, London, Cambridge (MASS.) 1981, pp. 95 e ss.64 G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., pp. 192 e 196 e ss.; Id., Poétique
de l’espace, cit., pp. 168-169 e ss.: lavoro attivo dello sguardo che consistenel “costruire un cosmo della parola”, il cui scopo è, mettendo l’uomo “endehors du monde prochain” (ma sotto il segno dell’infinito, che è “l’espacede l’ailleurs”), rendere il mondo un “contesto”.
Vincenzo Bagnoli
138
turali del Settecento e del secolo romantico intorno al pathosdella spazialità”65, nel poeta italiano comunque non si afferma lavertigine dell’accumulo, poiché, pur nella necessità di mantene-re la sintesi, l’immagine artistica non deve semplicemente dareun’impressione del caos, ma permettere una lettura, per quantocomplessa e contraddittoria di un “cosmo intrecciato”66 davveroalla maniera del Poe ammiratore della scienza di Newton, Ke-plero e Laplace. Nel suo “sensismo paradossale” il vero viene aconsistere nel dubbio, vale a dire nell’uso della ragione, in sensocritico, più che negativo, nella verifica dell’“estensione immagi-nabile” (del piacere, Z, 12-23 luglio 1820, 165), poiché “imma-ginazione e intelletto è tutt’uno (Z, 20 novembre 1821, 2134):una stessa “qualità dell’animo” da cui scaturirono “i poemi diOmero e di Dante e i Principii matematici della filosofia natura-le di Newton”67.
Per tornare allora alla topologia dell’idillio, si deve notare ilrisultato di questo suo allargamento in un “teatro della teoria”: asuo modo anche Leopardi ci dà del paesaggio una mappa (nellaquale ancora una volta la “concretezza” della terra è proiettatanello spazio astratto e potenzialmente infinito della geometria),ma da questa rimuove la topografia, scegliendo altre coordinate.La sua, insomma, è una mappa del mondo fisico e dei fenomeninaturali, una mappa geologica della stratificazione e della diage-nesi, che pare condensare nelle sue linee non una descrizione maun racconto (Darwin e Hutton scoprono qualche decennio dopo,movendo dalla stessa strategia di sguardi, la profondità geologicae biologica del paesaggio, la sua continuità con l’ora – il qui – os-sia la sua dimensione, per così dire, storica). L’indagine della na-tura porta a una narrazione che varca i confini reali per immagi-nare come il mondo deve (o può) essere fatto: delinea, insomma,l’ipotesi di una spiegazione possibile, a partire dall’osservazione,però, e non solo dalla imagery letteraria, che viene in un certo
65 E. Raimondi, Il mito e il moderno, cit., p. 488.66 P. Guglielmoni, Introduzione a E.A. Poe, Eureka, Bompiani, Milano 2001,
p. XI.67 G. Guglielmi, L’infinito terreno, cit., p. 43.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
139
senso sottoposta alla prova dei fatti68. Per dirla con Bachelard,parla del mondo nel linguaggio del mondo69.
A riprova di questo carattere di racconto, cui si era fatto ac-cenno anche prima, basti l’acuta lettura che fa Blasucci della Seradel dì di festa: l’elemento di unità della sera non consiste solo nel-la cornice paesistica entro cui si dà la successione dei motivi, manel fatto che la successione sviluppi una vicenda come un movi-mento attraverso il paesaggio, un attraversamento-scansione del-lo spazio che viene a propria volta incluso nella rappresentazionesotto forma del canto finale dell’artigiano (sorta di mise en abymedel canto)70. Se dunque in ogni forma di conoscenza sono le pa-role dell’uomo a misurare lo spazio, è precisamente il canto, nonaltro, che nella poesia ha per Leopardi il compito di scandirlo: lostesso è per il perplesso pastore errante dell’Asia il cui Canto not-turno, a voler fare un’antropologia del personaggio poetico sullascorta del rimando leopardiano alla relazione di viaggio delMeyendorff, costituisce l’altra sponda del nomadismo diurno. Inquesta lirica, che infatti già per De Sanctis rappresentava un “idil-lio degli idilli”, si ha forse il migliore esempio di come, dopo l’In-finito, l’immaginazione proceda sempre più “per annessioni”,collegando vedute diverse, anche in chiave ironica, fino ad arri-vare a un “paesaggio che nulla tiene ormai del pittorico”, che èimmaginario proprio nella misura in cui si costituisce come“summa essenziale di elementi naturali elencati in opposizioneimmediata”, in una “riduzione del paesaggio terrestre” a una sor-ta di deserto lunare, “di allucinata geografia fisica preparatoriadell’incontro e del dialogo fatali tra l’Islandese e la natura”, e –aggiungo – anche della Ginestra 71.
68 Questo il senso del trapasso da una poesia immaginativa a una sentimenta-le rilevato da V. Dotti, Lo sguardo sul mondo, cit., p. 12.
69 G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., p. 202. Cfr. ancora Z, 3 novem-bre 1821, 2041-2043, in consonanza con quanto sostiene G.V. Gravina, Del-la ragion poetica, I, 3. Vedi supra, nota 54.
70 L. Blasucci, I tempi dei “Canti”, cit., pp. 195 e ss.71 S. Romagnoli, Spazio pittorico e spazio letterario da Parini a Gadda, cit., p.
457. Sulla qualità “topografica” dell’immaginazione leopardiana si vedano leacute osservazioni di A. Brilli, In viaggio con Leopardi, Il Mulino, Bologna2000, in part. pp. 82-83 e 97 ss., condotte sulla corrispondenza leopardiana,
Vincenzo Bagnoli
140
È significativo, credo, di là dall’intenzione “allegorica”, che laGinestra prenda l’avvio da un punto di vista collocato su un vulca-no proprio come il “poema postumo” di Poe (del resto anche unodei peculiari philosophes naturalisti di Sade occupa la medesimaposizione)72: per il poeta americano l’osservazione dalla cima del-l’Etna è certo la stereotipa posizione elevata che contraddistinguela descrizione letteraria, ma è anche qualcosa di più, poiché per-mette di vedere l’“extent” (estensione) e la “diversity” (varietà) delmondo fisico cogliendo non il mero accumulo, ma la sintesi, attra-verso la percezione di un punto di vista che dia una “individualityof impression”, come “riflessione” del totale: occorre, allora,
something like a mental gyration on the heel. We need so ra-pid a revolution of all things about the central point of sightthat, while the minutiae vanish altogether, even the more con-spicuous objects become blended into one. Among the vani-shing minutiae, in a survey of this kind, would be all exclusi-vely terrestrial matters73.
Nella Ginestra ci viene chiarito che il vulcano è il punto di in-tersezione dell’orizzontalità e di una verticalità che è stratifica-zione geologica e considerazione cosmologica (fuoco vivo pietri-ficato che richiama il “fiammeggiar” delle stelle74): il suo è dun-que paesaggio di luci e ombre, di vuoti siderali e pieni, dove coe-
a proposito di un’attitudine a “disegnare” mappe attraverso un montaggiodelle impressioni e descrizioni dei luoghi. Sul concreto dei dati paesaggisticileopardiani cfr. M. Farnetti, L’ermo colle e altri paesaggi, Liberty House, Fer-rara 1996.
72 M.A. Rigoni, Leopardi, Sade e il dio del male, in AA.VV., Leopardi e il pensie-ro moderno, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 101-108; circa l’immagine della na-tura in Sade e Leopardi: F. Curi, Struttura del risveglio. Sade, Sanguineti, la mo-dernità letteraria, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 142 e ss. Per quanto riguardariprese successive bisogna poi almeno almeno alludere alla “città della scien-za” da costruire, secondo Nietzsche, sul Vesuvio, e all’Ano solare di Bataille.
73 E.A. Poe, Eureka, cit., pp. 6-8, corsivo mio.74 G. Bachelard, La flamme d’une chandelle, PUF, Paris 1961, trad. it. La fiam-
ma di una candela, SE, Milano 1996, p. 35, sostiene che le immagini dellafiamma, per il loro valore, “uniscono la moralità del ‘piccolo mondo’ allamoralità maestosa dell’universo”.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
141
sistono passato e presente in modo concreto, come l’eruzione delpassato esiste nella forma dell’“indurato flutto”75. Un teatro ter-ribile, senza dubbio, ma la cui bellezza non è travalicare l’umanonel sublime, bensì poterlo includere. L’immaginazione poetica ar-riva così al teatro della ragione sulla cui scena l’uomo convoca leproprie ipotesi: “certe rêveries poetiche sono ipotesi di vita cheampliano la nostra vita mettendoci in contatto con l’universo”76.
Che ne è dell’io lirico in questa prospettiva? Un ottimo sugge-rimento può venire da un antico scritto di Raimondi, I gesti inte-riori, nel quale la poesia leopardiana è studiata come scena teatra-le, però avvertendo (sulla scorta dello Z, 11 aprile 1829, 4485) chein Leopardi il luogo non è semplice scenografia di contorno, masostanza di quello spazio, in cui si dispiegano le rimembranze:come vuole Bachelard, nella poesia cosmica della rêverie “i ricordistessi si fissano in quadri d’assieme. Gli scenari sopprimono ildramma”77. Tale capacità del poeta di rimanere neutrale quanto ase stesso rispetto a ciò che dice, non distaccandosi ma entrando inpiù viva comunicazione con le cose e le situazioni (con i fenomeni),può certo richiamare il modello dello scienziato, ma anche quantoKeats attribuiva a Shakespeare e ai suoi personaggi (nella nota let-tera all’amico Richard Woodhouse del 27 ottobre 1818 nella qualedichiarava che “Il Poeta è la più impoetica delle cose che esistono;perché non ha identità, è continuamente intento a riempire qual-che altro corpo”). La soggettività poetica si muove sulla scenacome un personaggio assente: non è attore in senso stretto, e gliunici suoi gesti sono quelli di additare attraverso pronomi deittici
75 L’importanza del paesaggio vulcanico nella costruzione del paesaggio lettera-rio è ribadita da C. Galimberti, Messaggio e forma nella “Ginestra”, cit., p. 49.
76 G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., p. 15; L. Russo, nei Classici ita-liani (Sansoni, Firenze 19652, vol. III, t. 1, p. 824) parlava di “regola di vita”,contrapposta alla “meditazione”. Si veda anche E. Landoni, Ragione e im-maginazione in Leopardi. La poesia come sintesi, in «Testo», XI, 1990, 19,pp. 145-188. Va almeno menzionato H. Hesse, Berg und See. Zwei Land-schaftsstudien, Büchergilde Gutenberg, Zürich 1948.
77 E. Raimondi, Il gesto e la scena, in I sentieri del lettore, cit., vol. II, p. 508.Importante anche la documentata relazione con la scrittura di Metastasio,allievo (seppure indisciplinato) di Gravina; G. Bachelard, La poetica della rê-verie, cit., pp. 21-22.
Vincenzo Bagnoli
142
e avverbi, secondo la medesima funzione analizzata più volte nel-l’Infinito. Così è anche nella Ginestra, dove qui, come si è accen-nato, svolge una funzione importante (in forte posizione incipitariaai vv. 1, dove fonda letteralmente l’intero canto; 52, con rafforza-mento anaforico, all’inizio della seconda strofe e di quella sezionecentrale che isola una differente spazialità, come si è detto; e 42,sempre all’inizio di verso, in funzione di nodo tra la prima sequen-za e la successiva)78: nel delineare chiaramente i diversi piani dellarappresentazione che entrano a comporre la lirica, si qualificacome determinazione principale del punto di vista, che sostituiscel’io in maniera netta, al punto che la prima persona verbale è riser-vata a verbi che designano il vedere o il prendere posizione, quin-di sempre una relazione rispetto al paesaggio (tranne “scenderò”,v. 64, che è per altro verbo di moto), il punto di vista, lo sguardo79.Il passaggio è dunque, come si è detto nel primo capitolo, dall’io alqui, a favore insomma di un modello di sguardo che non è dell’at-tore, non è dello spettatore, ma è piuttosto simile a quello che Bia-sin (in tutt’altro contesto) attribuirà al regista80.
In questo deserto “infinito” della teoria sensibile, che dallependici del vulcano si allarga in tutto il cosmo e in tutta la storia(così simile a quello lunare dell’Asia centrale che era puro spazio)e che, come la luna di Ariosto sembra riflettere l’immagine (ossiail senso) della terra, così (con un fondamento più solido nel sen-sibile), grazie al gioco delle prospettive contigue per metonimia,coinvolge una conoscenza cosmica, si convocano tra movimentoe stasi gli stessi attori del Canto notturno: i corpi celesti distanti,le greggi ignare, l’angoscia dell’uomo che nello sforzo di capirevuole porsi sopra la natura, aggiungendo però a questi la ginestra,
78 E. Raimondi, Il gesto e la scena, cit., p. 515; altrettante occorrenze si trovanosolo nelle Ricordanze, con funzioni però diverse (un carattere affettivo). Supaesaggio e teatro cfr. anche E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territoriovissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia 1998, pp. 16 e 92 e ss.
79 Un’altra analisi sul “qui” e sui pronomi deittici, attenta più al ruolo archi-tettonico, in C. Galimberti, Messaggio e forma nella “Ginestra”, cit., p. 50.
80 G.P. Biasin, Frammenti di geografia romanzesca, in D.S. Cervigni (a c. di),Italy 1991. The Modern and the Postmodern, volume monografico di «An-nali d’Italianistica», 1991, 9, pp. 168-181.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
143
figura della coscienza. La lettura del “libro del mondo”, attraver-so i processi di transcontestualizzazione messi in atto dalla pecu-liare prospettiva cartografica della rappresentazione, è diventataparodia 81.
3. La strategia dello sguardo (poetica)
“A che tante facelle?”. All’inquieta domanda paiono rispon-dere nella Ginestra i versi della quarta strofe, che riprendono inmaniera puntuale gli elementi di base dei vv. 84-89 del Canto not-turno: in entrambi i casi la scena è un notturno, ambientato nel“deserto piano” che “in suo giro lontano, al ciel confina” nelCanto, sulle “rive” del “flutto indurato”, accanto ai flutti invecemobili del mare, vale a dire la “mesta landa” del vulcano nella Gi-nestra. Così nel primo canto si ha: “miro in cielo arder le stelle”; enel secondo: “veggo dall’alto fiammeggiar le stelle”, con la medesi-ma immagine ignea e la parola stelle, che però nel primo rima con“facelle”, mentre nel secondo è in semplice consonanza con “tutto
81 L’occhio desertifica infatti il paesaggio nel costruire lo spazio cartesiano: la ri-duzione alla coordinata in G. Bertone, Lo sguardo escluso, cit., p. 220, circala variante di “ultimo orizzonte” in luogo di “celeste confine”; C. Galimber-ti, Messaggio e forma nella “Ginestra”, cit., p. 51 e nota 10, rimarca che ilmondo non pare, ma è un deserto, a differenza di Canzoniere CCCX. Si vedainoltre G. Guglielmi, L’infinito terreno, cit., p. 56, e sempre G. Bertone, Losguardo escluso, cit., p. 231, nota 1, per il quale la rappresentazione del de-serto asiatico tratta dal Voyage d’Orenbourg “assomiglia specularmente ai de-serti lunari”. Ha la medesima riflessione di Ariosto, ma rovesciata, proprioperché la fantasia non può più fingere quegli spazi al di fuori del sentire (cfr.Z, 3 ottobre 1828, 4399-4400): nel Furioso si ha l’ethos della veduta dall’alto,di cui il viaggio sulla luna rappresenta il massimo grado (si veda secondo ca-pitolo e A. Momigliano, Saggio su l’“Orlando Furioso”, Laterza, Bari 1946,pp. 6-7); Leopardi invece deve immaginare il punto di vista di un pastore er-rante che immagina il punto di vista della luna, per fondare su una base sen-sibile l’immaginazione. Su questi processi di transcontestualizzazione si vedal’ottima analisi condotta con scrupolo filologico da C. Dionisotti, Preistoriadel pastore errante, in Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, Manzoni ed al-tri, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 157-177, in part. pp. 158-159, dove si os-serva il rapporto tra “l’indeterminatezza geografica” e il movimento di allon-tanamento prospettico (ribadendo che non si tratta di “filosofica evasione”).
Vincenzo Bagnoli
144
di scintille in giro”. In ogni caso l’immagine è quella della moltitu-dine di piccole luci che si propagano attraverso un mezzo descrit-to dal pastore come “aria infinita” e “profondo infinito seren”(profondo viene a corrispondere a “dall’alto”), laddove nella Gine-stra si ha invece un “purissimo azzurro” e “lo vóto seren”: tenutoa mente che il “sereno” (oltre a riflettersi sensisticamente nellosguardo stesso, secondo il topos lucreziano dell’osservazione dauna “sicura sponda”) rientra nel cliché della trasparenza alla basedello “sguardo letterario”82, si deve prestare attenzione alla nota dicolore dell’“azzurro”, certo a contrastare con il “bruno” del “flut-to indurato”, ma soprattutto a rimarcare la stessa peculiare tonalitàdei “monti azzurri” delle Ricordanze, la lontananza, segnalata quin-di non più con la misura concettuale dell’“infinito” (cfr. nota 76),ma con quella “sensibile” della gradazione cromatica. La differen-za è senza dubbio la profondità di campo, come risulta da altri det-tagli: se nella prima lirica il confronto tra la “solitudine immensa”e “io” è rapidissimo, nella seconda si articola invece attraverso l’e-spansione dal sé al genere e (mediante il qui implicito dei vv. 186-187, sempre un dato dei sensi) a un “terreno”, una continuità dicielo e mare, quindi al sistema solare e alla galassia, i cui contornicominciano ormai a sfocarsi in “nebbia”. Tale direttrice metonimi-ca rivela la presenza di una “retorica dell’ostensione” propria del-la letteratura filosofica, nella quale l’indagine e l’esposizione – piùche la descrizione – attivano la funzione narrativa83. Così nel Can-to notturno il pastore resta distinto e isolato dalla sua greggiacome dagli astri, mentre l’espansione metonimica fino ai “nodiquasi di stelle” dai contorni imprecisi, figura della molteplicità, el’ulteriore moltiplicazione prodotta dalla loro riflessione nella su-perficie equorea, nella corrispondenza tra vastità di superfici evastità profonde (tema ripreso poco dopo, vv. 213-214: “Dall’u-tero tonante / Scagliata al ciel profondo”) e nel dialogo di centroe orizzonte che coinvolge lo stesso sguardo dell’uomo84, avvolgo-
82 Cfr. supra, nota 5. 83 F. Curi, Struttura del risveglio, cit., pp. 120 e ss.; C. Galimberti, Messaggio e
forma nella “Ginestra”, cit., pp. 54-55.84 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., pp. 180-187. Il mare che riflette il
cielo è “una viva similitudine dell’immensità” nella Storia del genere umano.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
145
no il mondo intero di una rete di relazioni che concatenano leparti. Il cielo riflesso nell’acqua aumenta la sensazione di superfi-ci che improvvisamente si aprono, svelano la loro profondità, lanatura abissale: ma ciò non si risolve nella vertigine perché un al-tro specchio, l’occhio del poeta (in quanto “mondo” anch’egli),ricollega tutte quelle scintille, stabilisce trame85. La riflessione di-venta immagine della presa di coscienza dell’universo: attraversodi essa la poesia propaga onde di calma, che dominano la naturaagitata del mondo, e permette di fissare anche la spiacevole im-mobilità delle distese di lava e del raggelato spettacolo di distru-zione in esse racchiuso, animandolo con l’immaginazione. Creaper così dire una mappa di senso, il cui segno evidente è la per-vasione della luce che fa “brillare il mondo”. Lo splendore dellecose è la manifestazione della “beltà”86, ma si tratta di una luce edi una bellezza particolari, la cui luminescenza pare non dissimi-le da quella che il Kreuzgang di Klingemann vede proiettata sul-la notte, alla maniera dei chiarori di Correggio, dall’atto estremodella razionalità umana, da un’esistenza che esplora il proprio li-mite senza orgoglio né umiltà: ancora una volta è un io diventatoqui, come dice lo stesso nome del protagonista (significa infattiincrocio), che nelle sardoniche Nachtwachen tenta di affiancare,nello sguardo sul paesaggio, alla ragione, la fantasia immaginativa.
Se infatti il “sereno” è anche spia di una reminescenza dante-sca (Purg. I, 14-15: “sereno aspetto / del mezzo”), le stelle che alpoeta medievale appaiono sono di tutt’altro genere, soprannatu-rali e “non viste mai”; il piacere che ricava dalle loro fiammelle ilcielo è altra cosa rispetto a questo brillare, nel quale per Leopardi
85 Fondamentali in tal senso le osservazioni di M. Merleau-Ponty, Il corpo vis-suto: l’ambiguità dell’esistenza, la riscoperta della vita percettiva, la carne delmondo, dalle prime opere a “L’occhio e lo spirito”, Il Saggiatore, Milano 1979,in part. p. 208: “le cose e il mio corpo son fatti della medesima stoffa” (allostesso modo Cézanne poteva dire – in tutt’altro senso rispetto alle esteticheromantiche – che “la natura è all’interno”). Cfr. anche G.M. Edelman, Bri-ght Air, Brilliant Fire. On the Matter of the Mind, Basic Books, New York1992, trad. it. Sulla materia della mente, Adelphi, Milano 1993.
86 Si veda supra, nota 54. P. Bigongiari, Leopardi, cit., p. 370: il mare della Gi-nestra riecheggia quello dell’Infinito, ma diventando “il volto stesso d’unanatura”.
Vincenzo Bagnoli
146
non si palesa nessun ordine provvidenziale, nessuna inclinazioneaffettiva verso l’uomo (cfr. Il Risorgimento, vv. 136-138). Questofiammeggiare di punti sembra piuttosto riprendere il galileianoDialogo sopra i massimi sistemi, in particolare il discorso di Salvia-ti nella terza giornata sulla determinazione delle relative dimen-sioni dei corpi, della vastità dell’universo e della difficoltà di con-cepirla e raffigurarla, la stessa moltiplicazione osservata al telesco-pio che ispirò nel 1611 la Anatomy of the World di Donne. Sicu-ramente si può pensare anche a fonti come Cicerone, De re publi-ca, VI, 16 (il famoso Somnium Scipionis) o Dante (Par., XXII, 133-154), ma osservando la profonda differenza che caratterizza que-sto testo, a partire (per quanto importa al discorso) dal punto divista, che non è trasferito in un altrove, ma resta qui, dalla partecioè del mondo materiale; mentre in Cicerone come in Dante l’os-servazione e la riflessione avvengono da un’altezza che è anche ladistanza morale dello sguardo, l’osservazione di Leopardi, purspecchiandosi nella distanza, non costruisce una sfera separata, in-corruttibile, ma resta in linea con le cose, orizzontalizzando nellacontinuità l’asse spaziale alto/basso87. La peculiarità dello spazioleopardiano consiste proprio nel rispondere a questa domandamoderna cercando le connessioni prospettiche, la nuova organiz-zazione del paesaggio, la nuova trama che ne racconta la storia. In-fatti “la miracolosa e stupenda opera della natura” e “l’immensaegualmente che artificiosissima macchina e mole dei mondi” ri-schia di provocare insoddisfazione nell’uomo: spetta all’immagi-nazione soccorrere la ragione che vede poco, perché “gli oggetti elo spazio tanto più le mancano quanto più ella n’abbraccia, e piùminutamente gli scorge” (Z, 11 luglio 1823, 2943), trovando ilmodo di trarre proprio dalla complessità degli scenari e quindi dauna sorta di paesaggio-cosmo la forma del mondo88. Infatti “non
87 Sulla topologia dello spazio dantesco J.M. Lotman, Testo e contesto, Later-za, Roma-Bari 1980, pp. 81 e ss.; sul topos classico, completato ai vv. se-guenti dall’immagine del formicaio, di origine platonica, cfr. A. Traina,“L’aiuola che ci fa tanto feroci”. Per la storia di un topos, in “Forma futuri”,Bottega d’Erasmo, Torino 1975, pp. 232-250, ora in Poeti latini (e neolati-ni). Note e saggi filologici, Patron, Bologna 19862, pp. 305-335.
88 Per un utile raffronto cfr. A.G. Baumgarten, Meditationes philosophicae de
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
147
si conosce perfettamente una verità se non si conoscono perfetta-mente tutti i suoi rapporti con tutte le altre verità”, e non ci si puòquindi astrarre da parti della natura: ma per afferrarne il senso di-stricandosi attraverso il “laberinto della natura” occorre, più del-la “minuta e squisita analisi” dei filosofi tedeschi, il “colpo d’oc-chio” dall’alto, grazie anche ad alcune “illusioni” (leggi immagini).L’immaginazione divenuta facoltà critica, che attraverso la finzio-ne delle prospettive ricuce le trame del senso, si orienta all’inter-no del “disegno del laberinto” (un’altra immagine), stabilisce laposizione: sottoporre a verifica ogni immagine, non accettare l’i-pse dixit dei linguaggi ricevuti è la lezione galileiana applicata a uncosto personale anche elevato89.
La relatività di terra e luna in Ariosto viene qui coinvolta inuna dinamica plurale ampia, nella quale l’unica via all’orienta-mento è quella che Foucault definisce il “luccichio delle somi-glianze”, il richiamarsi che i mondi diversi90 (anche quello dei se-gni e delle cose) istituiscono. Il “brillare” infatti designa una lucetremula, incerta: è un micare di stelle (come nella traduzione ci-ceroniana dei Fenomeni di Arato, ma anche come nel fiammeg-giare di luci virgiliano91), simile all’ammicco che può provenire
nonnullis ad poema pertinentibus, trad. it. Meditazioni filosofiche su alcuniaspetti filosofici del poema, Vita e pensiero, Milano 1992, p. 31.
89 G. Galilei, Il saggiatore, Einaudi, Torino 1977, p. 33: Leopardi sembra ri-prendere in Z, 5-6 ottobre 1821, 1853-1855 (da cui vengono i brani citati),proprio la figura di questo “oscuro laberinto”. Sull’ammirazione dello stiledi Galilei, che unisce eleganza ed esattezza, Z, 13 luglio 1821, 1313 e 30 ot-tobre 1821, 2013. Su una linea Ariosto-Galilei-Leopardi lo spunto è in I.Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, cit., p. 186. Si veda inoltre L.Polato, Lo stile e il labirinto. Leopardi e Galileo, e altri saggi, Franco Ange-li, Milano 1991; R. Macchioni Jodi, Leopardi e la prosa scientifica del Seicen-to, in AA.VV., Leopardi e la letteratura italiana dal Duecento al Seicento, inAtti del IV convegno internazionale di studi leopardiani (Recanati, 13-16 set-tembre 1976) Olschki, Firenze 1978, pp. 681-688.
90 G. Bachelard, La poetica della rêverie, cit., p. 219. 91 “Stella micans”. Aratea, 34, 4 e 38, 2 per indicare il tremolio; in Aeneide, I
90; II 734; VII 744; VII 392; IX 189, 496 e 794; XII 102, per esempio, desi-gna il fulmine, il guizzare della fiamma, il balenio negli occhi. La presenzadel modello di Virgilio (la vicinanza al quale può essere confermata dall’e-strema vicenda biografica: ma cfr. M. Marti, I tempi dell’ultimo Leopardi.Con una giunta su Leopardi e Virgilio, Congedo, Galatina 1988) sembra af-
Vincenzo Bagnoli
148
da un punto della muta distesa delle cose nel momento in cui “Ilmondo guarda il mondo”, come dice ancora il calviniano Palo-mar. Così nella Ginestra si trova davvero il risultato più alto del-la ricerca, secondo l’idea-guida dell’interpretazione di Galimber-ti, di una parola che abbandona l’analiticità razionale a favore diuna conoscenza compiuta abbracciando “una molteplicità diidee” (sistema è parola che Leopardi ama applicare alla sua visio-ne Z, 9-15 dicembre 1820, 393, 403, 406, 416, 420 e 19 dicembre1820, 435-437), riuscendo a cogliere la somiglianza delle cose tradi loro: e la bellezza che emerge dal suo quadro-sistema non èbellezza consolatoria, ma lo splendore ammiccante del riconosci-mento, che sembrava perduto e che può essere recuperato solonel riconoscersi dell’uomo parte della natura e delle sue leggi92.Per far ciò è tuttavia da abbandonare il “forsennato orgoglio” in-sito nella contrapposizione fra un “esterno” portatore del caos eun “interno” portatore di ordine, come pure nell’isomorfismo framicro e macrocosmo, che conduce a una concezione antropo-morfa di ogni organizzazione sovrumana, come avviene in Rous-seau (vv. 185-201)93.
Attraverso questo “riconoscimento”, sottolineato anche dallatrama di richiami lessicali e fonici che accompagnano le connes-sioni iconiche94 (nella Ginestra come altrove), il paesaggio si co-struisce dunque come assemblaggio di piani diversi, un “vicinosensibile” e un “lontano immaginato”95. Partendo dalle pendici
fiorare anche dal paragone tra Ecl., IV, 50-53 e la quarta strofe, dove si ri-trovano composti in maniera analoga, gli elementi di “terrasque, tractusquemaris, caelumque profundum” e poco oltre una riproposizione del “con-vexo nutantem pondere mundum”: ma si tratta ovviamente di una ripresaparodica, sottolineata dal ribaltarsi della “mole” in “granel di sabbia”, voltaa colpire proprio il successivo “venturo laetantur ut omnia saeclo”.
92 C. Galimberti, Un canto del destino, in S. Zecchi (a c. di), Estetica 1991. Suldestino, Il Mulino, Bologna 1991, p. 63. Da rilevare la diversità rispetto alla“blank-filled map of Wordsworth’s poems” segnalata da M. Wiley, Roman-tic Geography, cit., p. 33.
93 J.M. Lotman, B.A. Uspenskij, Tipologia della cultura, Bompiani, Milano1974, p. 171.
94 C. Galimberti, Messaggio e forma nella “Ginestra”, cit., p. 49.95 A. Folin, Pensare per affetti, cit., pp. 34 e ss. In Paralipomeni, VII, 24-41 il
sorvolo di Dedalo e Leccafondi ricorda la mappa dall’alto di Ariosto, ma la
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
149
del Vesuvio, il panorama oggettivo si allarga ad altri scenari chevanno ad aggiungersi per collegamenti metonimici, proponendo,mediante la metamnesi delle immagini di realtà (in Leopardi èproprio la rimembranza a trasformare la concretezza dei luoghi insentimento poetico: Z, 14 dicembre 1828, 4426)96, quello che hochiamato il teatro della teoria come una sorta di eterotopia, luogoche è in rapporto con tutti gli altri in base alle leggi fisiche97. Lastrada è quella del Poe di Eureka, nel quale la cosmogonia diven-ta la mappa totale dell’esperienza umana o, per usare le parole diCalvino, il “mosaico in cui l’uomo si trova incastrato”, il “giocodei rapporti” descritto non con la presunzione di trovarsi dallaparte delle cose, come nemmeno la scienza potrebbe fare, ma del-le ipotesi, ossia delle immagini culturali: “le storie che scrivo si co-struiscono all’interno d’un cervello umano, attraverso una com-binazione di segni elaborati dalle culture umane che mi hanno
peculiare prospettiva storica, la visione delle forze naturali, in particolare ivulcani dell’ottava XXIX, delineano piuttosto la stessa costruzione dei pae-saggi della Ginestra, una storia naturale del mondo come la intendeva Hum-boldt, scritta appunto dal vulcanesimo. Resta la somiglianza con la “geogra-fia composita” ariostesca descritta nel capitolo precedente: cfr. V. Terenzio,Realtà e immaginazione nel paesaggio leopardiano, in AA.VV., Le città di G.Leopardi, in Atti del VII Convegno di studi leopardiani (Recanati, 16-19 no-vembre 1987), Olschki, Firenze 1991, pp. 449-456.
96 Sulla definizione di metamnesi si veda G. Bachelard, Poetica della rêverie,cit., pp. 117 e ss. Sullo specifico leopardiano: C. Ferrucci, Memoria come im-maginazione in Leopardi, in «Lettere italiane», 4, 1987, pp. 502-514; Id., Me-moria letteraria e memoria cosmica; il caso della “Ginestra”, in «Lettere ita-liane», 3, 1990, pp. 361-373. Sulla somiglianza di questo procedimento alla“mnemotecnica del bello” baudelairiana cfr. primo capitolo, in part. nota 6.Per Ungaretti è proprio dal riflesso del cielo stellato nel “mare della mente”(immagine che ricorda proprio la situazione della Ginestra) che sorge la“spettrale amabilità dei ricordi”: G. Ungaretti, Immagini di Leopardi e no-stre, in «Nuova Antologia», 16 febbraio 1943, ora in Vita d’un uomo. Saggie interventi, Mondadori, Milano 19976, pp. 430-450, a p. 437.
97 Una tale estetica ricorda in effetti quella, articolata sulle categorie di esattez-za, velocità e molteplicità, che Calvino espone nelle Lezioni americane. Sei pro-poste per il prossimo millennio, Mondadori, Milano 1993, p. 49 e 69 richiamiespliciti. Si veda anche M.A. Bazzocchi, L’immaginazione mitologica. Leopar-di e Calvino, Pascoli e Pasolini, Pendragon, Bologna 1996, p. 52; U. Musarra-Schroeder, Il labirinto e la rete. Percorsi moderni e postmoderni nell’opera diItalo Calvino, Bulzoni, Roma 1996, p. 49 (cfr. capitolo secondo, nota 55).
Vincenzo Bagnoli
150
preceduto”98. (La trama dei rapporti non va più dalle cose al li-bro, dal mito alla realtà, e le favole antiche sono spente: le cosesomigliano alle cose, le parole alle parole in un riflettersi di pa-rallele somiglianze, come alle stelle “di lontan fa specchio / ilmare”). Questo contraddistingue l’ipotesi letteraria. La percezio-ne della natura, lo si è detto più volte, non si realizza come unquadro chiaro (la natura classica posta sotto una luce uniforme)o scandito analiticamente: è questo per Leopardi il limite princi-pale nell’interpretazione del mondo (lo dice esplicitamente nellaricordata nota dell’11 luglio 1823). Essa ha piuttosto la forma diuna pervasione di forze che coinvolge tutto l’universo e che vacolta con la “mental gyration” di Poe o con un “colpo d’occhio”,espressione che richiama invece la poetica di Baudelaire, anch’e-gli preoccupato a suo modo dell’esattezza99; attraverso questoaprirsi dell’occhio “Le monde moral ouvre ses vastes perspecti-ves, pleines de clartés nouvelles”100, ed è l’idea che sta alla basedelle correspondances, in virtù delle quali, ancora una volta, l’uo-mo con i suoi sensi è una parte del mondo fisico e delle forze checompenetrano i corpi. La velocità del colpo d’occhio pare dun-que quella di un diaframma che si apre e chiude rapidissima-mente, permettendo di collegare nel campo focale dello sguardopiani vicini e lontani. La profondità di campo, che aggiunge, nel-la maggiore o minore nitidezza, come nella gradazione cromaticadell’azzurro, una tonalità affettiva allo spazio cartesiano, un sen-so diverso alle categorie di “vicino” e “lontano” (oltre la sempli-ce misurabilità impersonale), introduce non solo una nuovaestensione rispetto a verticale e orizzontale, ma anche la dimen-sione “confusa” del mondo rispetto allo spazio ordinato dei ver-
98 I. Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, cit., p. 188.99 Si veda il brano del Salon del 1859 riportato nel primo capitolo. Sul fatto che
Leopardi anticipi l’estetica di Poe e Baudelaire, G. Singh, Leopardi and theTheory of Poetry, University of Kentucky Press, Lexington 1964. Sul colpod’occhio in Leopardi si veda A. Folin, Pensare per affetti, cit., pp. 24 e 38, eL. Tassoni, Finzione e conoscenza, cit., pp. 18-19 e 61.
100 La frase si trova all’inizio della sezione Le goût de l’infini (Ch. Baudelaire,Paradisi artificiali, Garzanti, Milano 1988, p. 48), e nelle immagini delle“clartés nouvelles” sembra racchiudere un altro elemento di somiglianzacon la poetica dello “splendore” del mondo.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
151
si, dimensione che rende necessaria la veduta a distanza e la musadel paesaggio.
La presenza di dettagli più o meno a fuoco contribuisce inol-tre a rafforzare i tratti della percettibilità dell’immagine, come delresto la densità particolare di talune inquadrature, la cui icasticitàè arricchita dagli stimoli sinestetici (la pervasione del profumodelle ginestre, il risuonare del terreno sotto i passi, per esempio,nella sequenza iniziale)101. A questa natura fisica è affidata la te-nuta dell’insieme di elementi prossimi e distanti, la coerenza deipiani diversi102: ben presto Leopardi aveva del resto preso posi-zione contro l’idealismo romantico, sostenendo che il sentimen-tale non può nascere dall’astrattezza dell’idea, bensì dalla con-cretezza della percezione come si trova nella natura o nello spa-zio sociale103. A descrivere il mondo, dunque, è il “desiderio del-lo sguardo incarnato in un corpo nello spazio vivente”104, come lostesso Leopardi conferma, parlando di “stile” e “parole” comedel “corpo de’ pensieri” (Z, 13 settembre 1821, 1694: “l’intellet-to umano è materiale in tutte le sue operazioni”): dal corpo comesede cartesiana dell’azione si approda così a un’immagine distraordinaria modernità, in base alla quale l’immaginazione nascedal corpo, centro dello spettacolo visibile e sostanza dell’“io na-turale” davanti allo spettacolo dei fenomeni nella Ginestra 105.
101 C. Galimberti, Messaggio e forma nella “Ginestra”, cit., pp. 67-73.102 M. Santagata, I confini dell’idillio, cit., p. 52, segnala il mutamento di una
“visione dall’esterno” in una visione da lontano, che può suggerire in effet-ti il movimento di messa a fuoco lungo la profondità (più che lo zoom) comestrategia metonimica; G. Sangirardi, Leopardi: il bello e il terribile, cit., pp.144 e 151, situa una svolta in questa direzione all’epoca delle Operette.
103 Z, agosto 1817-dicembre 1818, 15-16 commentando l’intervento di Breme sul-lo «Spettatore», 91; Z, 12-23 luglio 1820, 179 propone un esempio di naturamateriale dell’infinità. Si veda al proposito S. Romagnoli, Spazio pittorico e spa-zio letterario, cit., pp. 450 e ss.: nella lettera di Leopardi a Paolina e in quella aCarlo, entrambe del dicembre 1822, si delinea ad esempio in senso fisico la ri-flessione sullo spazio dell’uomo nelle grandi città e nel borgo; Romagnoli vivede anche una difesa della concretezza immaginativa radicata nel paesaggio ti-pico italiano. Si veda anche E. Turri, Il paesaggio come teatro, cit., pp. 97 e ss.
104 E. Raimondi, Il mito e il moderno, cit., p. 491. Cfr. anche M. Caesar, Leopar-di and the Knowledge of the Body, in «Romance studies», 19, 1991, pp. 21-36.
105 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione (1945), cit. Il corpo è
Vincenzo Bagnoli
152
Questa “avventura della conoscenza”, che – come si è piùvolte detto – assomiglia al gioco e all’esperimento scientifico maconserva la propria specificità nell’essere arte, si “finge” dunqueuna mappa per creare le artificiali condizioni di una parità conl’universo. Per quanto però ci si sforzi di trovare nodi, direzioni,calcoli, modelli e carte, la nostra comprensione non regge il con-fronto con la vastità: tuttavia resta la continua ricerca di tale con-fronto, non per amore dello spaesamento o fascino della resa, del-l’affogamento, che pure è inevitabile:
Il dolore o la disperazione che nasce dalle grandi passioni eillusioni o da qualunque sventura della vita, non è paragona-bile all’affogamento che nasce dalla certezza e dal sentimentovivo della nullità di tutte le cose, e della impossibilità di esserfelice a questo mondo, e dalla immensità del vuoto che si sen-te nell’anima (Z, 27 giugno 1820, 140).
Come può allora essere dolce il naufragio nell’infinito? La ri-sposta non è data da un motivo di natura estetica (il sublime), maetica, ossia la ricerca inesausta del “vero”, da cui discende la veranobiltà dell’animo dell’uomo, la stessa che Leopardi ammira inGalilei (Z, 6 gennaio 1827, 4241). Si confronti infatti il passo lu-creziano della Ginestra (vv. 111-125):
Nobil natura è quellaChe a sollevar s’ardisceGli occhi mortali incontraAl comun fato, e che con franca lingua,Nulla al ver detraendo,Confessa il mal che ci fu dato in sorte,E il basso stato e frale;
con un altro dei “pensieri” (Z, 12 agosto 1823, 3171):
poi qualcosa di più della fisicità: è anche il funzionare di questa (la psicoa-nalisi). Cfr. S. Timpanaro, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano,Nistri-Lischi, Pisa 19692, pp. 160 e ss.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
153
Niuna cosa maggiormente dimostra la grandezza e la potenzadell’umano intelletto, né l’altezza e nobiltà dell’uomo, che il po-ter l’uomo conoscere e interamente comprendere e fortementesentire la sua piccolezza. Quando egli considerando la pluralitàde’ mondi, si sente essere infinitesima parte di un globo ch’è mi-nima parte d’uno degli infiniti sistemi che compongono il mon-do, e in questa considerazione stupisce della sua piccolezza, eprofondamente sentendola e intentamente riguardandola, siconfonde quasi col nulla, e perde quasi se stesso nel pensierodella immensità delle cose, e si trova come smarrito nella vastitàincomprensibile dell’esistenza; allora con questo atto e con que-sto pensiero egli dà la maggior prova possibile della sua nobiltà,della forza e della immensa capacità della sua mente, la qualerinchiusa in sì piccolo e menomo essere, è potuta pervenire aconoscere e intender cose tanto superiori alla natura di lui, epuò abbracciare e contener col pensiero questa immensità me-desima della esistenza e delle cose.
Questa poesia, che deve “far vedere”, sceglie quindi la so-spensione delle garanzie (della convenzione letteraria ma anchesociale: si pensi al caso della Palinodia) e dei sensi dati per con-frontarsi con le forze fisiche cieche, inintelligenti. È la fine delmito consolatorio: tanto dell’idea che il paesaggio sia pura conso-lazione, emblema dell’armonia col mondo, quanto del fatto che laletteratura possa essere risarcimento estetico o promise debonheur106. Nel processo che porta a sentire con la ragione, im-maginare con i sensi e vedere con la parola107, la disarmonia nonè più l’isolamento e l’infelicità individuale, ma la percezione delruolo del disordine, alla quale corrisponde la ricerca di una ri-spondenza tra le cose (quella che il pastore del Canto notturno an-cora non sa trovare). In questo senso non bastano davvero più le
106 Sulla spoliazione del paesaggio anche dai miti illustri cfr. S. Romagnoli, Spa-zio pittorico e spazio letterario, cit., pp. 453-454: l’esempio preso è Il passerosolitario.
107 A. Folin, Pensare per affetti, cit., pp. 48 e ss.; G. Guglielmi, L’infinito terre-no, cit., p. 30.
Vincenzo Bagnoli
154
“enciclopedie retoriche” medievali e l’ordine consolatorio dell’e-stetico; non basta – se non come punto di partenza per un cla-moroso capovolgimento – la posizione elevata dello spettatore-fi-losofo classico né l’ottica distesa dell’eijduvllion (pur ritrovandosila posizione giacente), non basta nemmeno la Stimmung dei mo-derni, dimostrata con L’ultimo canto di Saffo un’inconciliabilitàdel singolo in questi notturni fatti di vastità e molteplicità, irridu-cibili al senso individuale (quello che era tutto sommato ancorapossibile nella contrapposizione dell’ e[gw de movna della poetes-sa) a meno che l’uomo vi si specchi solo come scheggia, parte delmondo fisico108.
Il topos dell’immagine edenica si rovescia, com’è stato acuta-mente osservato, nel “giardino della souffrance”, il quale primache figura metafisica, segna la riduzione del paesaggio al model-lo del giardino botanico109; in esso (come in Galilei) l’ecphrasisviene piegata alla tassonomia scientifica, ed è questa l’eredità del-l’ippogrifo (si ricordi il sorvolo “strategico” dell’isola di Alcina),che popola La ginestra di animali, piante, fenomeni naturali, for-ze fisiche. È dunque il genere della “storia naturale”110 a sostitui-re l’enciclopedia retorica, a partire dal meccanicismo cartesiano e
108 G. Ficara, Il punto di vista della natura, cit., pp. 11-12; cfr. anche L. Spitzer,Classical and Christian Ideas of World Harmony, Johns Hopkins UP, Balti-more 1963, trad. it. L’armonia del mondo. Storia semantica di un’idea, Il Mu-lino, Bologna 1967. Sul paesaggio dei classici sono abbondanti gli studi: si ve-dano almeno Ch. Mauduit e P. Luccioni (a c. di), Paysages et milieux naturelsdans la littérature antique, in Actes de la table ronde organisée au Centre d’é-tudes et de recherches sur l’Occident romain de l’Université Jean Moulin-Lyon3 (25 settembre 1997), Boccard, Paris 1998; G. Highet, Poets in a Landscape,Knopf, New York 1957; R. Mugellesi, Paesaggi latini, cit. Per prospettive piùspecifiche D. Gagliardi, Paesaggio, in Orazio, in Enciclopedia oraziana, Istitu-to della Enciclopedia italiana, Roma 1997, vol. II, pp. 595-599. F. Serpa, Pae-saggio, in Enciclopedia virgiliana, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma1987, vol. III, pp. 921-926.
109 G. Sangirardi, Leopardi: il bello e il terribile, cit., pp. 145-146.110 Cfr. E. Raimondi, La nuova scienza e la visione degli oggetti, ora in I sentie-
ri del lettore, Il Mulino, Bologna 1994, vol. II, pp. 9-60 e p. 35: ricorda F.Colonna, Ecphrasis, opera fondamentale di botanica d’inizio Seicento. SuGalilei e Torricelli cfr. ibidem, pp. 24-25; C. Galimberti, Messaggio e formanella “Ginestra”, cit., pp. 54-56, dove si ha anche un elenco delle apparizio-ni di animali e vegetali.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
155
dalla scoperta della razionalità “altra” del vivente. Accanto a di-verse parole la “storia nuova” porta una diversa costruzione, gli“spazi chiari in cui le cose si giustappongono” come erbari, col-lezioni e giardini, divisi da siepi reali o figurate: “Limitando e fil-trando il visibile, la struttura [in questo caso il paesaggio] con-sente a questo di trascriversi nel linguaggio. Per suo tramite, la vi-sibilità dell’animale o della pianta passa interamente nel discorsoche l’accoglie”, con la “semplicità manifesta d’un visibile descrit-to”. La percezione confusa ottiene così, attraverso questo imma-ginario, la scansione lineare del linguaggio: il racconto che è an-che mathesis111. Il locus amoenus precipita allora nella “naturaognor verde” (v. 292) della ginestra, una forza vitale naturale, ilsenso di una durata oltre le “storie dello spirito”, in ben altro or-dine, quello puramente biologico, lontano da ogni mito classicoo romantico. Il punto di vista, l’interpretazione critica comincia-no – nel passaggio dall’io al qui come punto di vista ravvicinato –a coincidere con un’assimilazione nel paesaggio che è tutt’altrodalla proiezione dell’immagine dell’uomo nell’universo: al con-trario in questa “reductio ad florem” si ha una disantropomorfiz-zazione radicale112. La ricerca da parte di Leopardi di una nuovamitologia per la modernità, nel senso di un nuovo sistema d’im-magini, era del resto cominciata molto tempo prima, nell’occa-sione della polemica con Breme, con una riflessione sulle me-tafore antropomorfe dalla quale trapela già, dietro la critica allaproposta romantica, la consapevolezza di una incommensurabi-lità tra la ragione umana e la natura rerum che non è semplice di-fesa d’ufficio dello statuto artificioso del letterario, ma prelude aquella sorta di rivoluzione copernicana della poesia che decen-trerà l’io nella lirica113. Così il fiore, la ginestra, questa figura del
111 M. Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, Paris 1966, trad. it. Le pa-role e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Rizzoli, Milano 1998 (nuo-va ed.), pp. 141, 144 e ss. e 151.
112 Su questo sguardo ravvicinato e sul carattere di una natura non divinizzatané umanizzata si veda C. Galimberti, Messaggio e forma nella “Ginestra”,cit., pp. 55 e 63; supra, nota 86.
113 E. Raimondi, Il mito e il moderno, cit., p. 485; G. Guglielmi, L’infinito ter-reno, cit., pp. 8-9 e 19.
Vincenzo Bagnoli
156
biologico, è “lenta”, in senso proprio flessibile, come già in Vir-gilio (Georgiche, II, 12); ma anche “placida” (impassibile perchéflessibile?) come Titiro, sempre in Virgilio, “lentus in umbra”(Ecl., I, 4)114. Attraverso questa peculiare intertestualità si rove-scia la rappresentazione che traspone le qualità umane sul mon-do naturale, ottenendo la proiezione del naturale sull’umano (eper di più sempre assecondando la lezione della parola “antica”,coerentemente alla propria poetica, visto che in Virgilio l’aggetti-vo si riferiva prevalentemente al mondo vegetale): non un pasto-re d’arcadia (o poeta) ma la ginestra ottiene così lo statuto di pa-radigma o, meglio, di ipotesi di vita, lungo il percorso di distru-zione del mito che rimuove il nome proprio del singolo oggetto afavore della tassonomia e di un “continuum marcato da tratti di-stintivi” (i deserti e la ginestra)115.
In Leopardi, inoltre, giunge a piena consapevolezza il conflittofra scienza e immaginazione, nella forma dell’inimicizia fra intellet-to e natura, e la necessità di un dialogo, senza che ciò porti a untentativo di conciliazione, come in Breme, ma piuttosto di rendereproduttiva questa “ferita”, a differenza di Hegel: si mostra infatticonsapevole dei condizionamenti della logica moderna sulla poesiae li usa a vantaggio della possibilità di rendere comunque dicibileil mondo116. Respinta la posizione della greggia insipiente, conten-ta del piolo nel presente come glossava Nietzsche, ma anche quel-la della luna distaccata in alto, insensibile alla storia, viene adotta-ta la prospettiva della ginestra, consapevole del dolore. Il fingerenon è più un non-vedere neanche in questo senso, ma è il modo pertracciare le similitudini, le riflessioni. Questo “stato di crisi” fra lanatura e la ragione e l’immaginazione (alle quali essa resta pari-
114 La sovrapposizione di sensi legittimata anche da Ovidio, a proposito di Ga-latea insensibile all’amore di Polifemo. In Virgilio ha il senso anche di tena-ce: Aen. XII, 773.
115 J.M. Lotman, B.A. Uspenskij, Tipologia della cultura, cit., pp. 87-90. Cfr. P.Pinotti, Lentus, in Enciclopedia virgiliana, Istituto della Enciclopedia italia-na, Roma 1987, ad vocem; sui rapporti con l’opera virgiliana M. Marti, Leo-pardi, in Enciclopedia virgiliana, cit.; Id., I tempi dell’ultimo Leopardi, cit.
116 E. Raimondi, Scienza e letteratura, Einaudi, Torino 1978, pp. 24-25. Hegelcitato in G. Genette, Finzione e dizione, cit., Pratiche, Parma 1994, p. 12.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
157
menti irriducibile, assegnando all’uomo e alla sua storia un diversoruolo nel quadro di una storia naturale, alla maniera di Humboldt)è il fondamentale impulso che anima lo sguardo verso un così va-sto paesaggio, la cui stessa “totalità” deve dare il senso e la misuradella naturalità: uno sforzo visivo senza precedenti che sottopone auna tensione fatale il canone per aprirsi al confronto con la meto-nimia delle forze fisiche e dell’universo, la geografia fisica ed astro-nomica. Il paesaggio si delinea così come gradinata del caos, sce-nario della distruzione: non stabilisce nessuna “pausa”, ma fondaun’altra struttura di racconto, una mappa della storia dalle linee co-munque più gentili di quelle di Clio, nel permettere un’osservazio-ne a freddo che lascia la percezione delle cicatrici, ma consente diconsiderare il disastro (passato e futuro) senza cedere alla dispera-zione. L’immagine non riassume l’eloquenza del ragionamento inun emblema, quello del fiore, ma sviluppa il percorso di una teoria(come theáomai) attraverso la relazione più complessa del primopiano con lo sfondo: nella ginestra che cresce là dove lava e cenerehanno cancellato le opere umane, la dinamica del paesaggio coin-cide con un racconto morale. Non è dunque semplice allegoria (unriscontro autoptico con intenzione didascalica), perché non si hasemplicemente un paesaggio che illustra una concezione, ma ancheil contrario: la teoria filosofica che descrive il mondo. La ginestrainfatti estroietta completamente in un paesaggio storico-fisico l’al-ternanza tra sguardo e riflessione degli altri componimenti117.
Il recupero della natura avviene allora entro questo spazio in-tellettualizzato, costruito tra ragione e finzione (ma comunque at-traverso il sentimento); spazio fatto quindi dalla relazione dei tan-ti spazi che hanno rapporto con il naturale (secondo lo schemadell’eterotopia), degli sguardi che sono già caduti su quello spa-zio, delle descrizioni che ne sono state date. È insomma quellache Lotman e Uspenskij chiamano una riflessione metaculturale,nella quale il “testo della cultura” (formato dagli elementi inva-rianti di una serie di testi: lo “sterminato corpus della ‘tradizione’greco-latino-italiana”118, ma in una certa misura anche europea)
117 M. Santagata, I confini dell’idillio, cit., pp. 49-51.118 C. Galimberti, Novo ciel, nova terra, cit., p. 537.
Vincenzo Bagnoli
158
viene a costituire il “quadro del mondo”119. In questo senso l’im-magine della natura è assolutamente non ingenua, eppure avvici-na nella sua finzione la forma del naturale proprio attraverso lacompletezza-complicatezza delle sue prospettive, dei suoi campidi energia. Viene in mente, pensando all’“ermo colle” e all’“aridaschiena” del Vesuvio, nonché ai panorami che da essi (dietro lesiepi, al di sotto dell’“impietrata lava” e oltre il “purissimo az-zurro” della notte) si scorgono, la forma del mondo che fa Calvi-no in Dall’opaco:
Se allora mi avessero domandato che forma ha il mondoavrei detto che è in pendenza, con dislivelli irregolari, consporgenze e rientranze, per cui mi trovo sempre in qualchemodo come su un balcone, affacciato a una balaustra, e vedociò che il mondo contiene disporsi alla destra e alla sinistra adiverse distanze, su altri balconi o palchi di teatro soprastantio sottostanti, d’un teatro il cui proscenio s’apre sul vuoto, sul-la striscia di mare alta contro il cielo attraversato dai venti edalle nuvole120.
Questa forma sembra non dissimile da quella immaginatadalla scrittura di Leopardi, non distante neppure dal teatro sa-diano della parola, come lo descrive Barthes121: come in questo ilmovimento non è semplicemente dalla parola al fatto, così la sie-pe del linguaggio non separa semplicemente il paesaggio dallarappresentazione; come in esso il testo genera un secondo testo,che viene sottoposto al lettore, così in questo lo sguardo-raccon-to cade su un precedente sguardo-racconto e, procedendo lascrittura nella Ginestra oltre la siepe, invita il lettore a fare altret-tanto122. La siepe, del resto, è il linguaggio, nel senso che stabili-
119 J.M. Lotman, B.A. Uspenskij, Tipologia della cultura, cit., p. 150.120 In «Adelphiana 1971», Adelphi, Milano 1971, p. 299 (ora in La strada di
San Giovanni, Mondadori, Milano 1995, p. 97).121 R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Editions du Seuil, Paris 1971, trad. it.
Sade, Fourier, Loyola, Einaudi, Torino 20012, pp. 134-136.122 G. Guglielmi, L’infinito terreno, cit., p. 29: per essere naturali dobbiamo
imitare l’arte.
L’idillio e l’ipotesi. Appunti sulla “Ginestra”
159
sce la separazione rispetto al fenomeno, la distanza teoretica, im-plicando però non il distacco ma la relazione intensa del theáo-mai: per usare le parole di Fortini, è “una tensione totale dellavita come linguaggio”123. L’idillio in realtà guarda non una natu-ralità retoricamente costruita, ma un’altra concettualizzazione, lageografia fisica e storica con le sue leggi: un sistema metonimicoche include lo sguardo nel sistema di leggi (non lo esclude comel’io romantico, reso assoluto e trascendente), lo lega nei rapporti.E che ha riscontro a livello testuale nella forte inclusività interte-stuale, segnalata dal rapporto intensamente dialogico che stabili-sce con testi e tradizioni.
Poe era fermamente convinto che la complessità dell’immagi-ne desse forza alla legge generale, fosse in grado di riunirla entroun’ipotesi124; e in effetti la sua immaginazione, prima della relati-vità e dei quanti, si era spinta a proporre, nell’immagine del cie-lo notturno e della lenta pervasione della luce, una forma delmondo, del cosmo, che è ancora oggi, secondo gli scienziati, allabase del modello della grande teoria unificata e del Big Bang125.In fondo l’immagine che ci consegna Leopardi nell’ultimo deisuoi Canti è quasi la medesima di Poe: un universo in espansio-ne, un etere azzurro della distanza che pervade lo sguardo co-munque teso, figura (null’altro che figura) della conoscenza del-l’uomo. Allo stesso modo anche la sua immaginazione letteraria,un tempo condensata in un punto è ora per il poeta un vasto in-sieme di galassie e costellazioni distanti, da cui i segni si richia-mano lungo tutto lo spettro della radiazione, muti, in attesa chequalcuno colga il loro ammicco, li colleghi e sviluppi nello spazio,che nel frattempo è diventato misura, il loro racconto.
123 F. Fortini, Il passaggio della gioia, cit., p. 252.124 E.A. Poe, Eureka, cit., pp. 148-149.125 G. Hasinger, R. Gilli, L’inventario cosmico, in «Le Scienze», 404, 2002, pp.
55-61.
Vincenzo Bagnoli
160
CAPITOLO QUARTO
La forma e il progetto.Scritture e poetiche 70-90
1. Forme (città)
È difficile dire quando la città divenga assoluta protagonistadella letteratura moderna: quella barocca di Quevedo, quella set-te-ottocentesca dei Bildungsroman, quella infine simbolista e delleavanguardie sono tali non per il semplice fatto di costituireun’“ambientazione privilegiata”, ma perché si propongono comeuna sorta di “allegoria totale” della loro Zeit (di una situazionemorale e antropologica), divenendo una forma complessiva dell’e-sperienza, il “codice di un ambiente”1, una metonimia anzichéuna metafora. Ciò che non è città, al contrario, diviene ora una ca-tegoria quasi incomprensibile in sé: “L’altro della nostra societànon è certo più, in questo senso, la Natura, come accadeva nellesocietà precapitaliste, ma qualcos’altro ancora che dobbiamoidentificare”. Ciò che per gli uomini del passato costituiva l’in-quietante spazio extra moenia si riduce a lotti in cui si allargano leperiferie, margini di autostrade e ferrovie, resi indifferenti ai no-stri occhi dalla velocità dei trasporti: terrain vague o al più “riser-ve”, ossia giardini, l’immagine dell’urbanizzazione del naturale2.
1 La definizione è di G. Deleuze, F. Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schi-zophrénie, Les Editions de Minuit, Paris 1980, trad. it. Mille piani. Capitalismoe schizofrenia, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1987, pp. 491 e ss.
2 F. Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, in«New Left Review», 1984, trad. it. Il Postmoderno, o la logica culturale deltardo capitalismo, Garzanti, Milano 1989, p. 66. Sulla velocità P. Virilio,Estetica della sparizione, Liguori, Napoli 1992; R. Dubbini, Geografie delloSguardo. Visione e Paesaggio in età moderna, Einaudi, Torino 1994.
161
O nature voile, mystérieux paysage vous ressemblezAux blocs des maisons géantes et aux avenues brumeuses
[ de la ville,Vous avez l’imprécis grandiose des horizons urbaine.
Valery Larbaud
Dalla città, dal suo saper essere inclusiva nel proprio tessuto diciò che le è disomogeneo o addirittura opposto, sorge anzi, secon-do l’Aragon del Paysan de Paris, una peculiare “metafisica dei luo-ghi” (quella che Caillois chiama un’“atmosphère mentale collecti-ve”, sostanziata dai percorrimenti quanto dalle immagini dei li-bri)3: questa non ha rapporto con un trascendente astratto o “ver-ticale”, ma orizzontale “o laterale”, “non più di essenza, ma di po-sizione”4. Coerentemente alla poetica del surrealismo, e prima an-cora a quella di Lautréamont e forse di Leopardi5, è una “perma-nenza sulla terra”, come si esprimeva Alberto Savinio. E infattiquesta concreta formula dell’immaginazione, questa “scienza dellavita” sensibile non fa che disegnare, alla maniera della carta topo-grafica, una planimetria del labirintico spazio umano in grado dimetamorfizzare la metropoli in figure inedite: “io non conosco –scrive sempre Savinio – immagini più poetiche, più affascinanti,più ispiratrici delle carte geografiche”6. Attraverso questo continuodescriversi e rappresentarsi, attraverso la fruizione tattica (quasi“tattile”)7 dei suoi spazi, la città forma così reti metonimiche di si-gnificato, come testimoniano i grandi romanzi d’inizio secolo, dal-l’Ulysses di Joyce al Berlin Alexanderplatz di Döblin, dall’Uomosenza qualità di Musil al Pasticciaccio gaddiano, ed estende il suodominio anche su ciò che non le apparterrebbe, proprio come unarete si sostanzia di vuoti e pieni. Il paesaggio viene “importato” nel-
3 R. Caillois, Paris, mythe moderne, in «Nouvelle Revue française», XXV,1937, 284, p. 648.
4 T. Todorov, Critique de la critique. Un roman d’apprentissage, Editions duSeuil, Paris 1984, trad. it. Critica della critica. Un romanzo d’apprendistato,Einaudi, Torino 1986, p. 98.
5 L’accostamento è suggerito, a proposito di Ungaretti, da G. Guglielmi, L’in-venzione della letteratura, Liguori, Napoli 2001, pp. 130-132, sulla base di al-cuni tratti comuni: combinatoria onirica e stato metamorfico delle immagini,accompagnato all’estensione dell’attributo della bellezza a oggetti inusuali,nonché al “sistema” della crudeltà che sovverte l’immagine della natura.
6 A. Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, Adelphi, Milano 1984, pp. 53 e 57.7 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit, in «Zeitschrift für Sozialforschung», 5, 1936, poi in GesammelteSchriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1955, vol. I, pp. 365-405, trad.it. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società dimassa, Einaudi, Torino 1966, pp. 44 e ss.
Vincenzo Bagnoli
162
la città, e “la città si amplia a paesaggio”, nei panorami (che perBenjamin erano l’allegoria del rapporto fra arte e tecnica ed“espressione di un nuovo sentimento della vita”) come anche nel-le esposizioni universali, nelle gallerie, nell’uso “strategico” dellospazio che traccia i grandi viali cancellando le tracce della prece-dente urbanizzazione, nel cinema8. Non è un caso, del resto, che leforme della città siano divenute metafore eccellenti per le comunitàtrasversali del World Wide Web; e sarebbe sbagliato credere che ilmezzo tecnico abbia avuto una funzione modellizzante, giacchéesso non ha fatto che recepire, come sempre accade, un’esigenzaformulata dall’arte9, vale a dire la tendenza della città stessa a di-ventare forma estesa: nel raccogliere la sfida di Humboldt e Nova-lis, gli scrittori moderni descrivono infatti “l’universo fisico” attra-verso quello che Calvino chiama – con una proposta davvero “peril nuovo millennio” – l’“iper-romanzo” costruito sul “modello del-la rete”, ma questo modello ha la forma e il nome di città10 (Dubli-no, Berlino, Vienna, Roma). Se dunque mezzi di comunicazionedalla forma di “rete” come quelli elettronici (internet, ma già la te-levisione, e prima ancora – a loro modo – radio e telegrafo) si af-fermano è perché è già diffusa la percezione (e l’abitudine) secon-do la quale tutta la forma del nostro vivere è un’ininterrotta città-ragnatela che abbraccia e comprende tutto: tutto ciò che è “civile”e “urbano” (e “umano”, a partire dall’epoca della Civilization), maanche ciò che non lo è… “Les banlieus se prolongent dans les prai-ries teigneuses, / Les réverbères éclairent les routes au delà desportes; / Les trains illuminés glissent dans les tranchées / […] Lesvilles tachent la nuit comme des constellations”11.
8 Id., Das Passagen-Werk, a c. di R. Tiedemann, Suhrkamp Verlag, Frankfurta.M. 1982, trad. it. Parigi capitale del XIX secolo, a c. di G. Agamben, Ei-naudi, Torino 1986, in part. p. 149; per dettagli più specifici: E. Castellani,Paesaggio urbano e narrativa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1970.
9 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 42.10 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Gar-
zanti, Milano 1988 (ora Mondadori, Milano 1993), pp. 124 e ss. e 131 e ss.11 V. Larbaud, Europe, I, vv. 52-54 e 60: “Le periferie si allungano nelle pia-
nure corrose / i lampioni rischiarano le strade al di là delle porte; / i trenisfolgoranti scivolano lungo i tracciati / […] le città macchiano la notte comecostellazioni”.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
163
Un distinguo a questo punto è essenziale: la forma della cittànella letteratura primonovecentesca (la Londra di Conrad, la Romadi Gadda ecc.) è inquieta e inquietante: parla, e parlando dice ilmale, la cattiveria resa trasparente dietro le superfici. La città veraormai addensata su tutti i nostri orizzonti è invece stordita, inno-cua, opaca; la fantasmagoria della merce, della tecnica, della pro-duzione, esibita e rappresentata attraverso quella fruizione tattica,tranquillizza con l’aria delle cose di ogni giorno. Nell’estetica co-siddetta postmoderna il “piacere della superficie” viene a coinci-dere con una alienazione euforica, quasi una forma di allegria: cosìnelle città i segni della disumanizzazione diventano uno spettacolopiacevole, allo stesso modo in cui il Nataniele hoffmanniano (ilprotagonista del Sandmann) è perversamente affascinato dallabambola meccanica del ladro di occhi. “Nell’estetica più recente”,osserva Jameson, si è “arrivati a percepire la rappresentazione del-lo spazio come incompatibile con la rappresentazione del corpo:una specie di divisione estetica del lavoro di gran lunga più accen-tuata che in ogni altra precedente generica concezione del paesag-gio”. Lo spazio dell’arte è diventato antiantropomorfico12.
Questa città invasiva, la cui artificialità tende a ricoprire ilmondo, giunge in conclusione a inchiodare l’osservatore nel non-uso dell’ambiente, negandone la corporeità, riducendone il sé a si-mulacro (è l’effetto dell’iperrealismo, ma anche del romanzo post-human)13. Lo percepiva già il romanticismo (la cui passione perl’Unheimlich è condivisa, come avverte Jameson, da tutte le este-
12 F. Jameson, Il postmoderno, cit., p. 65; M. Augé, La guerra dei sogni. Eserci-zi di etno-fiction, Elèuthera, Milano 1998, pp. 118-120: “L’io finzionale, col-mo di una fascinazione che spunta in ogni relazione esclusiva con l’immagi-ne, è un io senza relazioni e allo stesso tempo senza supporto identitario, su-scettibile di assorbimento da parte del mondo delle immagini in cui crede dipotersi ritrovare e riconoscere”.
13 J. Baudrillard, L’échange simbolique et la mort, Gallimard, Paris 1976, trad.it. Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 1990, p. 113; G. De-bord, La société du Spectacle, Buchet-Chastel, Paris 1967, trad. it. La societàdello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 1997, pp. 85 e ss.; per una disa-mina meno tecnica e più vicina al campo d’indagine si veda F. La Porta, Lanuova narrativa italiana. Travestimenti e stili di fine secolo, Bollati Boringhie-ri, Torino 1995.
Vincenzo Bagnoli
164
tiche della modernità e della “postmodernità”)14, per il qualel’imperativo etico si risolve in imperativo estetico, nelle forme diun virtuosismo all’infinito, permesso proprio dall’ostacolo-tra-sparenza del linguaggio (basti pensare al ruolo del “fingersi” nel-l’idillio leopardiano), e l’artificiale, di cui il lato tecnologico noncostituisce altro che un’iperbole (come nel Sandmann hoffman-niano), diviene l’elemento di fascinazione. Broch ravvisa nel kit-sch tale fenomeno di riduzione, all’interno del quale la perditad’una qualità ha modificato i modi della fruizione estetica nelsenso d’una loro meccanicizzazione15; pure esso riguarda, secon-do il Kandinskij dello Spirituale nell’arte, anche l’arte colta quan-do è posta nel museo, allorché l’opera viene guardata con occhifreddi, come si osserverebbe la bravura di un acrobata.
Pare inutile, davanti a questo stato di cose (o di immagini?) re-plicare il biasimo platonico verso una “seconda natura”, artificia-le e industriale, che sovrapponendo i propri simulacri alla rerumnatura e rapidamente acquistando autonomia da essa ha falsifica-to il rapporto fra l’occhio e il mondo. Il velo del significato co-munque si frappone e fluttua tra la cosa e l’immagine sociale: ogniassalto a quest’ordine in nome della “verità” rischierebbe di risol-versi in un inutile quanto pericoloso attacco alla cultura e alla ci-viltà. L’antropologia, infatti, ha bene dimostrato la dipendenzadell’essere umano dai modelli culturali, quei “meccanismi di con-trollo extragenetici ed extracorporei”, elaborati all’interno dell’u-niverso del simbolico e costituenti la summa delle sue esperienze,dai quali dipende la stessa forma di queste. Si può concludere al-lora con Clifford Geertz che “la cultura, la totalità accumulata diquesti modelli, non è un ornamento dell’esistenza umana, ma –base principale della sua specificità – una condizione essenzialeper essa”. Queste considerazioni paiono dunque lasciare pocospazio a un mito come quello del buon selvaggio o di età auree: seesistessero davvero, gli uomini senza cultura “sarebbero inguari-
14 F. Jameson, Il postmoderno, cit., p. 66.15 H. Broch, Das Weltbildt des Romans, in Dichten und Erkennen. Essays,
Rhein Verlag, Zürich, 1955, vol. I, pp. 211-238, trad. it. L’immagine del mon-do nel romanzo, in Il Kitsch, Einaudi, Torino 1990, pp. 61-101.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
165
bili mostruosità con pochissimi istinti utili, ancor meno sentimen-ti riconoscibili e nessun intelletto: casi mentali disperati”16.
È stato il Calvino dialogante con Vittorini ed Eco (le cui po-sizioni sono espresse sullo stesso n. 5 del «Menabò» con lo scrit-to Del modo di formare come impegno sulla realtà) a riconoscere,nel celebre saggio degli anni Sessanta, l’inevitabilità del “labirin-to gnoseologico culturale”: o piuttosto dei labirinti, al plurale,che sono sempre immagini di città, come traspare dai riferimentia Joyce, Musil, Queneau, Borges, Gadda. Calvino sottolineavatuttavia la legittima necessità della “sfida” che a tali labirinti deveessere portata, nei termini non dell’eversione, poiché ogni uscita“non sarà che il passaggio da un labirinto all’altro”, ma di una vo-lontà di non rassegnarsi (come per certi versi vuole poi il “pen-siero debole”) al loro fascino e di una conseguente loro continuamodificazione17. Liberatosi dalle nostalgie, allo scrittore “etico”non compete distruggere questa sola forma totalizzante dell’e-sperienza superstite: egli deve calarsi nel tessuto vivo delle ste-reotipie da essa attivate, alla maniera appunto di Baudelaire, diLarbaud e del Borges poeta, per costruire attorno a esse.
È poi uno scrittore come Don DeLillo a suggerire, in Whitenoise, una nuova forma di “aura” dell’opera d’arte, una volta dis-solta quella garantita dalla sua unicità, come nel caso della “stallapiù fotografata d’America”. Uno dei protagonisti infatti nota:“Noi non siamo qui per cogliere un’immagine, ma per perpetuar-la. Ogni foto rinforza l’aura”. È la stessa scoperta che compie, peraltra via, il signor Palomar nell’Aiola di sabbia, quando avverte cheil “proprio io è agglutinato in una folla compatta che guarda at-traverso i suoi mille occhi e percorre sui suoi mille piedi l’itinera-rio obbligato della visita turistica”, e quindi il “racconto” di unsenso, la costruzione di trame che danno una forma a tempo e spa-zio (come il giardino zen) può darsi solo nella percezione colletti-
16 C. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1973,trad. it. Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 19982, pp. 9-45.
17 I. Calvino, La sfida al labirinto, in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura esocietà, Einaudi, Torino 1980, pp. 82-97; cfr. anche Id., Lezioni americane,cit., pp. 83 e ss., 118 e ss. e supra, cap. I.
Vincenzo Bagnoli
166
va; la quale, per tornare a DeLillo, può essere la partecipazione alrito del consumo oppure un “tramonto postmoderno”, nel quale“il cielo assume contenuto, senso, una vita esaltata di narrazione”.Rinunciando a rimpiangere l’antica auctoritas della distanza e del-l’hic et nunc, tale aura può dunque scaturire viceversa proprio dal-la ripetizione e dalla serialità, non nei modi dell’isteria del sublimehi-tech, del pathos del simulacro, del disorientamento estatico del-le superfici, ma in un diverso ethos che metta in relazione superfi-cie e profondità, frammento e totale, in un “campo lungo” dotatodella qualità di ambiente che includa la soggettività dell’artistanon più come fuoco principale, modello universale, ma affiancataalla prospettiva di un “orizzonte di attesa”18, dotando questa for-ma/città, sostanziata dalla ricezione nella distrazione, della capa-cità di produrre senso: del resto, lo stesso Benjamin aveva intravi-sto nelle moderne forme d’arte una possibile istanza liberatoria,accanto all’autoritarismo del consumo e della propaganda19.
Il Novecento ha già offerto diversi esempi di un siffatto “ve-dersi dal di fuori”: con Paterson la poesia si è fatta “sistema dicose”, proponendo il passaggio dallo “stesso” all’“altro” non at-traverso un processo di identificazione, ma con l’attenzione almolteplice nella ripetizione dei “simili”. Scettico verso le astra-zioni, Williams ritiene che “comporre” significhi seguire “nessu-na idea se non nelle cose”. Di queste però non si hanno che sen-sazioni volatili: occorre allora che l’architettura dell’immagina-zione provveda con il linguaggio a rendere oggettive (condivisi-bili, abitabili) le sensazioni, producendo non immagini di realtà,ma nuovi oggetti, poesie quindi come edifici. E per Octavio Pazproprio in questo modo il poeta fa del mondo un luogo vivibile.Riflettendo sull’esperienza dell’opera d’arte, anche Gadamer hapoi osservato come le forme artistiche che per l’“arte dell’Erleb-nis rappresenterebbero casi periferici vengono a collocarsi al
18 D. LaCapra, History and Criticism, Ithaca Cornell University Press (NJ),London 1985, pp. 43 e ss. e 77, osserva che la fine delle “metanarrazioni”ideologiche sopraindividuali ridefinisce il senso del racconto proprio in di-rezione della molteplicità dei racconti e dei punti di vista, nella partecipa-zione collettiva degli individui ai “discourses” plurali.
19 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
167
centro: e sono quelle forme d’arte il cui contenuto proprio ri-manda, al di là di esse, alla totalità di un contesto da loro e perloro determinato. La più nobile e grandiosa di queste forme èl’architettura”20.
Come si può notare, a sostanziare l’opera letteraria in que-st’ottica è un cambiamento e non la perdita di orizzonte: pur es-sendo venuti a mancare i grandi sistemi di riferimento (i “meta-racconti”), e anzi proprio perché tali gerarchie verticali risultanoscardinate, diventa al contrario determinante davvero la capacitàdel racconto di farsi discorso, di prospettarsi entro coordinatepiù vaste e “orizzontali” (intendendo con ciò tanto l’amplitudinequanto la contiguità metonimica), alla maniera d’una Weltlitera-tur goethiana e all’incontro per di più tra arte e scienza. Non èquesto un universalismo totalitario; piuttosto è una tensione ver-so una “ricostruzione e integrazione” del senso in panorami di-versi, più vasti in tutti i sensi, soprattutto linguistico-letterario, inun processo di globalizzazione e di “espansione delle periferie”(ricorre ancora la forma/città) qual è indicato da Édouard Glis-sant con il termine creolizzazione 21. Già una concezione positiva(e non positivista) del secolo scorso portava l’attenzione sul latoambientale, si potrebbe dire geografico, del rapporto etica/este-tica: la bellezza di forme “insignificanti” fondandosi sulla combi-nazione in serie come dialogo tra particolare e generale. La per-dita di senso dei frammenti di esperienza che il nostro privatosperimenta trova dunque una via d’uscita attraverso il collettivo:non più riduzione al tipo unico, ma determinazione al plurale dei“luoghi comuni”22. In questo modo è possibile risolvere quelloche secondo Hannah Arendt è il nucleo problematico della mo-dernità: la perdita del mondo comune (più ancora della marxia-na alienazione della soggettività) quale convergenza di mondi pri-vati su base non affettiva né ideologica. La via d’uscita che la stes-
20 H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Mohr (Paul Siebeck), Tübingen1960, trad. it. Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. 192.
21 É. Glissant, Introduction à une poétique du divers, Gallimard, Paris 1996,trad. it. Poetica del diverso, Meltemi, Roma 1998, in part. pp. 34 e ss., 39 e ss.
22 R. Ronchi, Luogo comune. Verso un’etica della scrittura, Egea, Milano 1996,pp. 5 e ss. e 9.
Vincenzo Bagnoli
168
sa Arendt indica consiste proprio nel linguaggio come mondo co-mune, nella cultura come struttura di dialogo; è insomma lo spa-zio di ciò che Todorov chiama l’interumano, a suo avviso l’intui-zione più importante della critica bachtiniana, che evita di fer-marsi al “materiale” dell’opera d’arte, per concentrarsi invecesull’“architettonica”, la sua costruzione, attraverso la quale il ma-teriale entra in relazione con il binomio forma-contenuto, ossia lascelta stilistica dell’autore e il rapporto con il mondo23.
Non nell’altrove esotico, ma nell’uguale, all’interno di questaforma/città – appunto inclusiva – si trova l’altro, là dove è anni-dato l’inconscio della città intesa, con Benjamin, come “dimoraonirica del collettivo”. Queste stereotipie allora, quali sono de-scritte dall’Amour fou di Breton, ma anche dai blow-up alla Rau-schenberg di Liz Taylor distribuiti da Ballard su ossessivi cartello-ni nei labirinti delle periferie in The Atrocity Exhibition, sono dun-que tensioni elementari di desiderio (metonimico, come insegnaLacan) e parcelle di tessuto linguistico che continuano nelle lineedi sviluppo della città, nelle forme seriali e ripetitive (geometriz-zabili come frattali di Mandelbrot), e come tali appunto sede diuna sorta di “marché aux puces” dei “sedimenti ottici”, per esem-pio quell’“inconscio ottico” delle fotografie, secondo Benjamin,che è la traccia di “uno spazio elaborato inconsciamente”24.
Sono quindi non solo iterazioni, ma al tempo stesso – attra-verso la variabilità delle strutture in esse e da esse delineate,come le gocce d’acqua tutte uguali possono articolarsi in cristal-li tutti diversi e dare le infinite forme delle nuvole – anche ope-ratrici di caoticità (sempre per Breton), secondo una “strategiadel disordine” in cui la stereotipia si rivela quindi un ordine piùcomplesso, in cui ogni altrove ha una relazione con il qui e in cuila “forma di una città” è immediatamente analoga al testo che ladescrive. La voce che articola questa sintassi è l’epifania del di-
23 T. Todorov, Critica della critica, cit., p. 83.24 W. Benjamin, Kleine Geschichte der Photographie, in «Die Literarischen
Welt», 1931, ora in Gesammelte Schriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M.1974, vol. I, t. 2, trad. it. Piccola storia della fotografia, in L’opera d’arte nel-l’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., pp. 62-63.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
169
verso: ma solo nella forma di un confronto che è dialogo peradjectum si ha la “comunicazione profonda”, sull’asse del “desi-derio”. Come nella scrittura è la “sintassi della profondità” apossedere le matrici del vero ordine e a garantirne la trasparen-za, così nella città esse appartengono a quei punti in cui la telaurbanistica si lacera al proprio interno e mostra quello che c’èoltre la superficie, rivelando così nella contiguità, e non nell’e-sotico/esoterico, la profondità: tale è la “sferzata” che JohnBrunner fa subire al protagonista di The Squares of the City nel-lo scoprire il “terreno aborigeno” sotto l’asfalto.
2. Scritture (architetture)
Frammenti di carta topograficacon indicazione di alcuni crateriscavati per sempre, illusionipaure giochi misteri.
Con questo esergo Dino Buzzati apre il primo dei Due poe-metti da lui licenziati nel 1967, prova poetica forse estemporanearispetto alla vena dell’autore (ma non bisognerebbe dimenticarsidell’importantissimo Poema a fumetti del 1969), e tuttavia rile-vante testimonianza di un clima di attenzione, negli anni di undifficilissimo trapasso culturale, attorno all’esigenza di sperimen-tare una forma capace di descrivere le trasformazioni “in atto”. Sipotrebbe addirittura parlare, se il discorso non fosse lungo e me-ritevole quindi di ben altro approfondimento, di una necessariarelazione tra la percezione di questa nuova forma/città, la feno-menologia, per così dire, di una haussmannizzazione dell’imma-ginario (la stessa che Bianciardi racconta nei suoi romanzi più ce-lebri: Il lavoro culturale, La vita agra e L’integrazione), e uno spe-cifico genere, quello appunto del poemetto. Se del resto una lun-ga tradizione stilistica di matrice oraziana affidava a questo gene-re la descrizione di paesaggi urbani, una scuola anglosassone ave-va recuperato (tra Williams, Stevens e Ashbery) la valenza di in-dagine conoscitiva dove la vocazione empirica (“nessuna idea se
Vincenzo Bagnoli
170
non nelle cose”, secondo William Carlos Williams) stabilisce lanecessaria relazione al luogo, ma dove poi occorre far coesisterela “pressione delle cose” e la necessaria epoché per trovare unanuova pronuncia del mondo. Né si deve dimenticare la famosa li-nea razionalista discendente in terra lombarda da Parini25, la cuiintonazione didascalica però sembra defluire piuttosto nell’alveodel poemetto neorealista, di là quindi di un preciso spartiacque,dove resistono tentazioni di un “umanesimo anacronistico”26
(salvo alcune eccezioni) e dove si ha per lo più la percezione del-la città come non-forma o forma ostile. A tentare invece una ri-cerca di “immagini praticabili” della complessità, fra spaesamen-to e ricostruzione della territorialità (organizzazione e stratifica-zione dello spazio “liscio” della visione ravvicinata e tattile nellospazio “striato” della visione lontana)27 è una differente categoriadi scritture, raggruppabili per comodità sotto l’insegna di speri-mentali, il cui antesignano può essere riconosciuto nel disegnogeografico e anzi stratigrafico di Laborintus; ma certo contano lemediazioni di una tecnica rappresentativa che era appartenuta auna generazione precedente, com’è evidente per esempio nelleprove di Pagliarani o negli studi delle atmosfere segniche di Giu-seppe Guglielmi (Ipsometrie), o in Ruffato.
Un’ulteriore tappa di questa ricerca, con esiti ancora più effi-caci, può essere rinvenuta nella produzione di Zanzotto a partiredalla Beltà e ancor più dal Galateo in bosco in avanti: se la reazio-ne alla “saturazione” (indotta dalla quantità, dall’eccesso in di-mensioni, dalla serialità) comporta, come vuole Bachelard, l’affer-marsi del carattere corpuscolare degli eventi a scapito della se-quenza (tanto nella percezione dei fenomeni quanto nella finzioneartistica)28, tuttavia una scrittura distesa a partire dai minimi re-
25 S. Romagnoli, Spazio pittorico e spazio letterario da Parini a Gadda, in Il pae-saggio, vol. V: Storia d’Italia. Annali, a c. di C. De Seta, Einaudi, Torino1982, pp. 431 e ss.
26 N. Lorenzini, Il presente della poesia. 1960-1990, Il Mulino, Bologna 1991,p. 65.
27 G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani, cit., p. 719; cfr. G. Scaramuzza, L’espe-rienza della città e la poesia, in «Materiali di estetica», 6, 2002, pp. 67-72.
28 G. Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, Paris 19644.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
171
perti iconici (gli ideogrammi) può cercare un “rilancio metonimi-co”, anche a costo del “vuoto”, alla stessa maniera della ragionescientifica davanti alla dura irriducibilità del reale29. Non bisognapoi dimenticare il fondamentale percorso di Sereni, nel passaggiodagli Strumenti umani a Stella variabile, teso, mediante l’attenzio-ne concentrata all’“oggettualità fenomenologica”, a “stabilire lacosa” nella propria peculiare maniera, per mezzo di approssima-zioni e della fondamentale consapevolezza della natura artificialedelle immagini, ottenuta attraverso la sospensione della referenza:il risultato è, come notava Fortini, una “mappa del reale”, perquanto frammentaria, corrosa, ed esposta all’“annichilimento”30,quale si ritrova in Roversi. Per ricapitolare, può essere insommautile tenere in considerazione l’esistenza di un peculiare genere di“poemetto”, attento alle ragioni architetturali della poesia, che an-drebbe con maggior cura indagato; esso affronta la sfida al labi-rinto attraverso una cartografia fondata sulla soluzione del nomi-nare, come forma di aperto confronto con la molteplicità com-plessa e articolata delle immagini e delle loro rappresentazioni lin-guistiche, ma non esaurisce certo l’intero arco delle possibilità.
Lo dimostra l’opera articolata di Antonio Porta, fra gli scritto-ri italiani che sembrano meglio orientarsi in questo difficile sistemadi riferimenti, entrando in sintonia con le correnti provenienti dal-l’Europa e dal mondo (Enzensberger, Ponge e l’École du regard),mostrandosi attento ai toni del dibattito italiano (come attesta lasua adesione al movimento della neoavanguardia), ma soprattuttodeclinando questa molteplicità di spunti e le proprie personali pro-spettive in una ricerca che postula il letterario come “luogo delleinterazioni tra storia e immaginazione”31: per questo il suo tentati-vo di arrivare a una leggibilità aperta si affida alla “ricerca di unaforma radicata”, ossia calibrata non su gratuite alchimie del verbo,ma secondo modelli cognitivi di percezione visiva e sonora che ri-producono la scansione ritmica dello spazio condiviso, già a parti-
29 Ph. Di Meo, Cercle, vacuum, très riche nihil, in «Critique», 447-448, 1984,p. 650.
30 F. Fortini, Opus servile, in «Allegoria», 1, 1989, p. 193.31 A. Porta, Il progetto infinito, Edizioni del Fondo Pier Paolo Pasolini, Roma
1991, p. 15.
Vincenzo Bagnoli
172
re dai Rapporti umani. Il resoconto del labirinto, ancora, viene pro-posto nella congerie dei dettagli che si riflette nella stessa corpo-reità di un soggetto ridotto a un qui della continuità spaziale, mache in questo modo può superare l’incompatibilità tra la rappre-sentazione dello spazio e quella del corpo cui si è fatto cenno: sipuò riprendere In re, dove il labirinto si riverbera nell’immagine ri-flessa dallo specchio, o La palpebra rovesciata, dove la continuitàmaterica tra carne, fibre, minerali ricorda i corpi postmoderni; emagari leggere entrambi i testi in parallelo alle dichiarazioni di Poe-sia e poetica, dove, rifiutato il “poeta-io” a favore dell’evento ester-no, si sostiene che “lì ci si specchia noi, uomini”, con l’intento – at-traverso la continuità così ristabilita – di “definire le immagini del-l’uomo o degli uomini, delle cose e dei fatti”32. La “resa oggettua-le della parola a un linguaggio di eventi” è insomma a propria vol-ta la risposta all’affermarsi del carattere corpuscolare degli eventi edelle immagini, e di conseguenza dello stile, che torna così ad es-sere il “versante percepibile del discorso”33: lo sguardo interno edesterno insieme gettato dalla poetica degli oggetti sulla realtà feno-menologica, assunta come punto di riferimento, diventa a suomodo anche la sostanza di una sfida. Riuscire a rendere pronun-ciabile e leggibile il labirinto significa infatti cambiarlo, sovvertirlo;ma per riuscirci occorre abbandonare l’“univocità neo-classica”,“mettendosi in agguato da molti punti di vista”34.
Da questo punto di vista è notevole, all’interno di Week-end,la silloge Utopia del nomade del 1972, che sembra per certi versifar eco alle ricerche situazioniste di Debord; in realtà essa è par-te d’un percorso intrapreso già dall’epoca di I rapporti, dove in-fatti si tentavano le coordinate geografiche (Meridiani e paralleli)
32 Id., Poesia e poetica, in I novissimi, Einaudi, Torino 19652, p. 159.33 Cfr. G. Genette, Fiction et diction, Editions du Seuil, Paris 1991, trad. it.
Finzione e dizione, Pratiche, Parma 1994, pp. 107-108, dove si osserva op-portunamente che lo stile non costituisce uno scarto di codice distaccatodalla lingua, ma è aspetto inseparabile della lingua in ogni atto enunciativo.
34 N. Lorenzini, Il presente della poesia, cit., p. 94; cfr. anche A. Giuliani, In-troduzione, in I novissimi, cit., pp. XX e XXIX e ss.; A. Porta, Poesia e poe-tica, cit., p. 159, nonché S. Colangelo, L’usus vivendi di Antonio Porta, in«Poetiche», 1996, 4-5, pp. 59-69.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
173
o dei Rapporti umani, e proseguito poi con Il passeggero. All’in-terno di questo itinerario particolarmente rilevante è, a mio giu-dizio, il sesto dei Movimenti, nel quale ci è presentata una for-ma/città che è anche forma del linguaggio/desiderio: “la città sichiama Immagine non ha limite / né centri può specchiarsi in séstessa / luogo dove incontrarsi…”. Quella di Porta, avverte NivaLorenzini, è “parola-sguardo”35, che proprio in quanto tale sa es-sere quindi parola-luogo: parola che cerca di essere un terrenod’incontro, in cui il nomade può disegnare (lo dice lo stesso poe-ta) il proprio volto come fosse quello di un altro. Questi versidanno dunque il senso a quella linea che arriverà fino a Passi pae-saggi, segnando l’urgenza di un ritorno proprio all’esigenza di co-municare, dove il termine, scevro dalle “ansie retoriche” di in-fluenza mediatica, rimanda piuttosto alla volontà di costruire spa-zio (o luogo) comune36. Porta ha esplicitamente indicato la pro-pria opzione per la pars costruens dell’avanguardia, sottolineandocosì in maniera forte, in una stagione che è pure quella del pen-siero debole, la misura del proprio impegno nel senso di “fiducianel potere determinante della cultura”37. Egli ha coscienza dellacomplessità e della molteplicità delle forme di questa, e non s’il-lude di poter sfuggire alla difficoltà: matura però la consapevo-lezza che sia questa stessa scoperta a esigere una pervicace assun-zione di responsabilità: “si manifesta / il pensiero linguaggio cheva preso alla lettera / sistema di piani e curve per scendere e sali-re / dietro a donne dietro a figli e animali”. L’atteggiamento didubbio non si risolve nel disorientamento, ed essendo sistemati-co coincide anzi con l’esatto opposto, col tentativo insomma, perquanto difficile comunque fattivo e concreto, di orientarsi.
35 Nella Postfazione ad A. Porta, Poesie 1956-1988, Mondadori, Milano 1998,pp. 179-195.
36 La fondamentale proposta di una poetica della comunicazione in «Alfabe-ta», 81, 1985, p. 23.
37 Il nomadismo non come deriva, ma strategia di conoscenza, è di nuovo mo-dellato sull’esempio galileiano: E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal terri-torio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia 1998, p. 92. Sul“bisogno di proiettarsi verso l’esterno” come “bisogno di conoscere”; N.Lorenzini, Il presente della poesia, cit., p. 156.
Vincenzo Bagnoli
174
La città vuole tranquillizzare con un’aria tutto sommato in-nocua, vuole stordirci col monotono ronfare della storia che si ri-pete sempre uguale: a questo punto interviene una flânerie acci-diosa che riattiva la memoria nello sguardo, come tecnica combi-natoria, ricreando il paesaggio dalla sua assenza, a partire dai re-litti empirici, mnemonici, onirici, con la piena consapevolezzadella propria arbitrarietà. Con occhio clinico scopre quanto è se-polto sotto l’asfalto, dietro l’architettura, il vetro e il cemento; perdisilludere la rasserenante facciata di una immagine la cui super-ficie liscia non concede appigli, evitando la fascinazione autoapo-logetica di una “serena alienazione”, colloca il proprio punto divista in basso, come diceva Maturin, “a trenta piedi sotto il livel-lo adatto per un miracolo”. L’io è presente, ma in secondo piano,ritirato sul margine, e in questo distanziamento, attraverso l’obli-quitas, si gioca la possibilità di un recupero della piena facoltà cri-tica all’interno delle immagini38.
La consapevolezza che, nella scrittura, sull’immagine dell’au-tore in termini assoluti (sia del sé sia dell’altro) deve prevalere ladinamica delle relazioni, quindi la visione del mondo, spinge apreferire la problematicità innescata dal gioco prospettico disguardi differenti. Di qui deriva la estrema attenzione alla inqua-dratura, allo sguardo che si può ravvisare in Porta: in molti casiquesto procedimento ha connotati decisamente materialistici,operando come tecnica di disincanto rispetto all’affabulazioneiconica. Se lo spettacolo immobilizza dunque nel non-uso, e l’im-magine si precipita e si schiaccia sugli occhi facendo schermoopaco, fissando ipnoticamente nell’illusione di vedere, l’obliqui-tas si propone come mise en abyme della menzogna. È questa lacoscienza dello sguardo, quella necessaria prospettiva, quel ritirar-si della voce in secondo piano che non confonde l’oggetto delracconto col racconto stesso e con il suo narrare: grazie ad essa la
38 Cfr. S. Raimondi, Poesia come territorio. I tatuaggi della lingua sul paesaggio,in «Materiali di estetica», 6, 2002, pp. 26-36. Cfr. anche J. Starobinski, Pay-sages orientés, in R. Zorzi (a c. di), Il paesaggio. Dalla percezione alla descri-zione, Marsilio, Venezia 1999, pp. 57-72: commentando Proust osserva cheproprio il problema stilistico di accordare l’espressione all’impressione fe-nomenica del visibile porta all’annullamento dell’io.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
175
poesia si fa sintagmatica di ideogrammi, e la “vita del linguaggio”si manifesta, oltre che nella sua ritmica fonica, nella ritmica del-l’immagine, non riducendosi mai alla descrizione, ma ponendo iltesto nella condizione di creare il proprio contesto linguistica-mente come immagine, come sistema di senso consapevole dellapropria fragile natura di ipotesi39.
Sono molte le vicinanze tra l’opera di Porta e le riflessioni diItalo Calvino, e va oltre la semplice concomitanza di date l’ana-logia tra l’Utopia del nomade poco sopra citata e le Città invisibi-li, sempre del 1972. Anche per Calvino, non è mai sereno “il rap-porto tra luoghi reali e modo di pensarli o sentirli”40: perciò guar-dare una città non è un’operazione semplice, perché in fondo si-gnifica guardare una sorta di immagine frattale del “labirintognoseologico-culturale” della nostra civiltà. Occorre dunque sa-per compiere una serie di operazioni, quali “scartare”, “semplifi-care” e “collegare”41 per sostituire all’autosufficienza dell’eviden-tia dell’immagine una “descrizione” inquieta, che unisca all’esat-tezza della cartografia la qualità morale del racconto, alla manie-ra delle Chartes moralisées. A dispetto di alcune recenti critiche,nel suo “progetto conoscitivo”42 si profila una immagine di cittàcome luogo d’interazione addirittura fra umano e non-umano,nelle loro varie forme, laddove molti suoi contemporanei risento-no ancora della dialettica naturale/artificiale impostata secondo ilcriterio di attrazione-repulsione dell’Unheimlich. Tale è il sensodell’aiuola di sabbia in Palomar, dove la combinazione di regola-rità e fluidità del giardino zen descrive un’“armonia possibilecome tra due armonie non omogenee: quella del non umano chesembra non risponda a nessun disegno; quella delle struttureumane che aspira a una razionalità di composizione geometrica o
39 N. Lorenzini, Il presente della poesia, cit., pp. 93 e ss. (in part. sulle caden-ze metriche, p. 198).
40 I. Calvino, La città pensata: la misura degli spazi, in Collezione di sabbia, Gar-zanti, Milano 1984 (ora Mondadori, Milano 1994), pp. 111-115.
41 Id., Gli dei delle città (1975), citato in M. Belpoliti, L’occhio di Calvino, Ei-naudi, Torino 1996, pp. 195-196.
42 U. Musarra-Schroeder, Il labirinto e la rete. Percorsi moderni e postmoderninell’opera di Italo Calvino, Bulzoni, Roma 1996, p. 15.
Vincenzo Bagnoli
176
musicale, mai definitiva”. Accanto allo spazio dell’interpretazione(“la descrizione dello spazio è una descrizione delle ‘articolazio-ni della mente di chi esamina’”), anzi intrecciato ad esso, si arti-cola nella città lo spazio dell’opaco, la “grana” dura del mondo(la “pluralità delle cose corpose” che provocano “la vertigine del-la polverizzazione e dello spaesamento”) che impedisce o rendeper lo meno aleatoria la sinossi43.
Anche in Calvino la forma/città è immagine della complessità:le sue categorie, valide anche per l’immagine testuale a essa corri-spondente, sono processo e dinamica piuttosto che stasi, rete piut-tosto che stratificazione. Questa forma è infatti per lui la combi-nazione di leggi complesse che agiscono sui due piani: uomo e ter-ritorio, ambiente geografico e ambiente culturale, psicologia e tec-nologia. E per tale capacità di vedere la forma, come nella nota pa-rabola del ponte, sostanziata dalle singole pietre e non solo dalla li-nea dell’arco, la letteratura acquista un valore di ricerca più avan-zato della scienza, una capacità di prospettare, di rivolgere lo sguar-do avanti, di progettare. Il limite del letterario consiste nel fatto chetale operazione viene spesso compiuta inconsapevolmente, nonper una sorta di vaticinante ispirazione, ma perché mancano al-l’autore le risorse critiche per verificare e sviluppare l’essenzialitàdel proprio discorso. Proprio perché deve confrontarsi con lacomplessità, la scrittura, in quanto strumento di conoscenza, hadunque l’obbligo di non muoversi nel vago, ma deve porsi degliobiettivi misurati, quando anche siano irrealizzabili. Esattezza, vi-sibilità, rapidità – per citare solo alcuni dei canoni fissati da Calvi-no – rispondono alla logica di una alternativa forma di razionalità,che risente della natura dell’immagine (presente certo fin dall’ini-zio nella parola scritta, però ora riaffermata con diversa intensità edirettrice), ma sa poi farne non emblema definitivo né allegoriamuta, bensì – come Gadda – enciclopedia aperta, anche quandoabbia l’aspetto inestricabile del “groviglio conoscitivo”.
43 M. Belpoliti, L’occhio di Calvino, cit., pp. 201 e 165 e C. Milanini, L’utopiadiscontinua. Saggio su Italo Calvino, Garzanti, Milano 1990, pp. 136 e 144.Cfr. inoltre P. Ouellet, Voir et savoir. La perception des univers du discours,Editions Balzac, Candiac (Québec) 1992.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
177
In questo senso, secondo Dombroski, Le città invisibili hannoun valore paradigmatico per il fare letterario degli ultimi decenni;la realtà non è negata, come vorrebbe il cliché postmodernista, maviene usata nel farsi del testo, per quanto problematizzata comeinfinità di interpretazioni descritte attraverso un gioco combina-torio. Questo non è però fine a se stesso o mimesi dello sterile fun-zionare, ma serve a dare una immagine architetturale, entro laquale le stesse immagini risultino moralizzate da nuove coerenze:anche a costo di una connotazione infernale, verso la quale nonviene mostrata tuttavia nessuna rassegnazione né condiscendenza,alla maniera del Canetti della Missione dello scrittore44. In più l’au-tore riesce a sovrapporre magistralmente panorami interiori estrutture materiali, una pluralità di sistemi formali e assiomatici,cogliendo anche il valore modellizzante che tale sovrapposizioneha (come nel caso della forma/città, fatta di immagini mentali e ressolidamente corporee) rispetto a molti aspetti concettuali del no-stro vivere e alle modalità del discorso collettivo45.
Le forme/città di Calvino inoltre aboliscono la gerarchia cen-tripeta, includendo al loro interno, come si conviene, la moltepli-cità e differenza di una struttura che tende a replicare la propriaconformazione generale nelle articolazioni profonde. È questoprocedimento, in base al quale ad esempio ognuna delle città vi-sitate serba qualche tratto di quella nativa del viaggiatore, a per-mettere la gestione letteraria del dettaglio autobiografico dell’e-sperienza, il quale, come ha recentemente ribadito Edoardo Al-binati, non è destinato a diventare semplice materiale, ma si ri-solve in corpus di tecniche, mezzo per sperimentare. In questomodo il personale viene espropriato e diviene “comune”, e quin-di (aggiungo col Richards dei fondamenti della critica letteraria,ma rileggendolo attraverso Searle) “comunicabile”, rimovendonon l’origine, ma l’importanza esclusiva di tale origine, per rico-noscere l’oggettività della “pura esistenza” e ristabilirne quindi il
44 E. Canetti, La coscienza delle parole, Adelphi, Milano 1984, p. 396.45 R. Dombroski, R. Miller, Retorica del postmoderno: “Le città invisibili” e l’ar-
chitettura, in R. Luperini (a c. di), Teoria e critica letteraria oggi, Franco An-geli, Milano 1991, pp. 144-188.
Vincenzo Bagnoli
178
luogo46. Quello che da Calvino come da altri narratori (Del Giu-dice, Celati) viene compiuto è quindi, nella lettura di Gian PaoloBiasin, davvero una mise en abyme del proprio percorso, attra-verso la quale l’autore diventa una “guida turistica” di sé (o una“presenza registica”): questo sé perde descrizione e discorso a fa-vore dell’altro, e pure mantiene i tratti di omogeneità, non si alie-na del tutto47.
Accanto a ciò sta l’accettazione della inevitabile testualitàd’una riduzione a discorso della forma/città, rinunciando allepretese demiurgico-ontologiche che avevano neanche troppo na-scostamente animato molta écriture di quegli stessi anni: questo“farsi testo” invita a un rapporto fluido, scorrevole tra cose e se-gni, non bloccato da algebre del segno o rigori mimetici. Quellidell’architettura e della città sono paradigmi del costruire, e ri-chiamano l’attenzione sul dettaglio e sul processo materiale. Ilcompito della letteratura che si confronti con la forma/città è al-lora quello di riempire i vuoti e “rifare il mondo”, evitando l’an-gustia di un modello immobile e assecondando invece l’ampio emai lineare procedere della civitas.
3. Poetiche (processo)
Sulla scorta di queste indicazioni si muove in realtà un largospazio delle scritture dei due decenni successivi, quelle sufficien-temente avvertite da percepire la necessità di una riflessione sul-le ragioni critiche, di un “supplemento di pensiero”48 che varia-no da interessanti singolarità a movimenti organizzati in senso
46 E. Albinati, Io sono il tricheco, in «Il gallo silvestre», 11, 1999, pp. 118-122,ma si veda soprattutto M. Pieri, Biografia della poesia. Sul paesaggio menta-le della poesia italiana del Novecento, La Pilotta Editrice, Parma, 1979.
47 G.P. Biasin, Frammenti di geografia romanzesca, in D.S. Cervigni (a c. di), Italy1991. The Modern and the Postmodern, in «Annali di Italianistica», vol. IX,North Carolina University Press, Chapel Hill 1991, pp. 168-181. Ma si vedaanche P. Ouellet, Voir et savoir, cit., a proposito della capacità del testo lette-rario di far partecipare alla conoscenza il lettore rendendolo co-enunciatore.
48 Così A. Cortellessa, In fondo, in «Versodove», 13, 2001, p. 96.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
179
più o meno compatto. Se nel processo di avvicinamento recipro-co del discorso critico e di quello poetico aveva prevalso nel cor-so degli anni Settanta il movimento del primo verso il secondo,nei decenni successivi si registra la tendenza opposta49. Lungi dalproporre un uniforme o sostanziale arretramento su posizioni or-fico-entusiatiche (rivelatesi nel corso degli anni di portata assaipiù limitata rispetto ai proclami) il panorama del periodo in esa-me ha insomma continuato a proporre posizioni di scrittura comeprogetto, un’etica della scelta comunicativa, sebbene senza il ri-gore di dogmi e di una ragione unica, ma su posizioni articolate,sfaccettate50. Il nuovo esercizio della critica (da intendere soprat-tutto come sforzo di interpretazione e non mera, passiva “regi-strazione”) ha dovuto imparare a essere veloce ed esatto, molte-plice, visibile ma flessibile, poiché davanti all’artificiale che si im-pone come nuovo naturale non si richiede tanto una “resistenza”rigida (destinata alla nostalgia e alla marginalità), quanto la capa-cità di adattarsi alla rapidità e di applicare comunque un distan-ziamento rispetto alla fluidità di un processo che è necessario insé, proprio perché culturale è il nostro modo di evolverci. Servo-no discrezione ed essenzialità per misurarsi col tempo; moltepli-cità e velocità per esistere nello spazio. La risorsa principale del-lo scrittore sembra non essere più soltanto la metamorfosi, ma l’a-namorfosi: la modificazione prospettica deve restituire senso eti-co al variare del punto di vista. Di conseguenza la scelta della la-teralità non significa ritirarsi nella tranquillità del margine, chepotrebbe in fondo essere un’altra faccia della torre d’avorio; l’ur-genza è invece quella di essere consapevoli, partecipi criticamen-te, capaci di distinguere.
Una possibile etica della scrittura sembra quindi consisterenella dimensione relazionale delle sue prospettive, nella composi-zione visiva di spazi articolata su coordinate storiche e materiali(secondo il principio estetico di Mario Perniola e alla maniera
49 Si veda il mio Contemporanea. La nuova poesia italiana verso il 2000, Esedra,Padova 1996, pp. 46-47.
50 N. Lorenzini, Il presente della poesia, cit., pp. 137 e ss., 183 e ss.; e ancora ilmio Contemporanea, cit., pp. 41-43.
Vincenzo Bagnoli
180
della cartografia cognitiva di Jameson); non si affida alla posituradidattica, ad a priori morali o all’estensione di categorie soggetti-ve (emozioni e affetti fondati sul sentire dal di dentro), ma a unsentire fuori, nell’ambito dell’azione visibile, con la forma di de-scrizioni in atto, per citare un titolo di Roberto Roversi. La stessaimmagine del soggetto non viene postulata come precedente lascrittura, ma è un risultato della lettura, si definisce dalla posi-zione (anzi dalle posizioni) che il lettore riconosce entro un pae-saggio. E questo situarsi entro un paesaggio comune o comuni-cabile avviene, per così dire, fra tradizione e traduzione. Per alcu-ni poeti, come Giuliano Mesa e Gabriele Frasca, il confronto conle fonti, le forme e i linguaggi ricevuti diventa una riscrittura, unaricostituzione della tradizione di là dalle forzature del canone,non arbitrariamente ma con la consapevolezza della relatività del-la propria prospettiva: esempio di come il personale svolga unadiversa funzione in senso etico, non fondando un’autorità nel-l’angoscioso conflitto col predecessore, ma affiancando un quiche definisce una dimensione diversa di un territorio condiviso,ridisegnando la mappa con anamorfosi che danno un diversoprofilo ai rilievi, ai tracciati.
Entrambi gli autori si confrontano con il problema di superarela dialettica novecentesca (che ha scandito fra rotture e “ritorni” ilsecolo passato) muovendo oltre anche allo “smemoramento” delpostmoderno. Dove Mesa preferisce il confronto con strutture co-struttive “moderniste” che accettano la contaminazione con altrilinguaggi (quello musicale, nello specifico jazzistico), Frasca si mi-sura invece con forme istituzionali (è da rilevare l’ipogramma rimesotteso ai vari titoli delle sue raccolte: Rame, 1984 poi 1999; Lime,1995; Rive, 2001) alla ricerca di una rifunzionalizzazione di sonetti,sestine liriche e quartine; l’intento è costringere la forma chiusa adare non già il quadro fermo dell’“accaduto”, ma il flusso percetti-vo dell’accadere e il mutamento percettivo stesso. Questo è possi-bile perché in Frasca è presente anche l’ethos del traduttore, nonsolo in senso strettamente tecnico (è infatti traduttore delle poesiedi Beckett oltre che di Philip K. Dick), ma quale è attivo in una neo-ralità che si alimenta di reperti apparentemente deprivati, artificia-li, serializzati, come gli elementi linguistici della cultura pop, ai qua-
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
181
li però il riuso creativo (e non la piatta mimesi del pastiche), estra-polandoli dal “discorso d’occasione” legato al consumo, restituiscesignificato entro codici differenti e soprattutto in ambiti di espe-rienza diversi; compiendo insomma la transcontestualizzazione pro-pria della parodia51. Tale ethos definisce così una modalità di parte-cipazione collettiva alla memoria e quindi disegna i contorni di unnuovo paesaggio totale, la forma di un’eterotopia sviluppata dentroe fuori dai media (si pensi, d’altro lato, al percorso di Umberto Fio-ri, già songwriter e voce degli Stormy Six, o al percorso di RobertoRoversi, affine ma inverso, poeta e paroliere per Dalla)52: ciò signi-fica appunto che non si ripete più la situazione delle avanguardie,per le quali la crisi del “mestiere di immaginare” aveva reso i mass-media “mezzo e modello”53. Ne è consapevole lo stesso Frasca, peril quale i media non sono latori di un “parlato” opponibile alla “nor-ma scritta”, ma configurano una “lingua trasmessa”: un sistema diechi, accenti e pause che costituisce una sorta di “griglia”54, un pae-saggio all’interno del quale deve muoversi la “visione armata”.
Perciò tale oralità non è vuota fanfara di effetti allocutori, mapiuttosto una elettrica mobilità, un “furore metonimico” che col-lega territori, e così diventa davvero “collettivité et historicité”55.
51 Su parodia e pastiche: L. Hutcheon, A Theory of Parody. The Teaching of 20th
Century Art Forms, Methuen, London-New York 1985, pp. 7 e 33 e ss.52 Sulla contiguità dei territori del pop rispetto alla poesia contemporanea vi
sono importanti notazioni in L. Serianni, Introduzione alla lingua poetica,Carocci, Roma 2001; si veda anche Accademia degli Scrausi, Versi Rock. Lalingua della canzone italiana negli anni ’80 e ’90, Rizzoli, Milano 1996; sesono stati indagati in chiave letteraria i fenomeni della lingua nei testi dellecanzoni pop, manca però ancora uno studio specifico sui prestiti di questealla lingua della poesia. Vi è però un’importante notazione circa la ricezionedei testi delle canzoni da parte del pubblico giovane come “poesia di mas-sa”, o nella forma di un’“attesa di poesia”, in L.C. Coveri, Dallo scritto alcantato: l’italiano delle canzonette, in AA.VV., Gli italiani scritti, presso l’Ac-cademia della Crusca, Firenze 1992, pp. 153-185, in part. pp. 157-158.
53 M. Calvesi, Avanguardia di massa, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 28 e 78 e ss.54 G. Frasca, La galassia metrica. Per un’ulteriore scienza nuova, in «Moderna»,
I, 1999, 2; Id., Dopo la tipografia. La scrittura nell’età multimediale, in N.Borsellino, W. Pedullà (a c. di), Storia generale della letteratura, Sperimenta-lismo e tradizione del nuovo, Motta, Milano 1999, vol. XII, pp. 728-765.
55 H. Meschonnic, Critique du Rythme. Anthropologie historique du langage,Verdier, Dijon 1982, pp. 280 e 705 e ss.
Vincenzo Bagnoli
182
Nonostante alcune interpretazioni abbiano cercato forzatamentedi introdurre il già citato “contrasto quasi escatologico di oralitàe grafema”, la neoralità dei media elettronici non consiste affat-to in un recupero della dimensione orale pretipografica, poichél’oralità secondaria è “comunque basata sulla scrittura” (peresempio ne è modellata attraverso copioni, script ecc.), della qua-le finisce per riflettere le caratteristiche. Se da un lato qualcosadell’oralità penetra nei modi della scrittura (la partecipazione, lamobilità, ma soprattutto l’ascolto), questa viene d’altro lato a di-sporsi a propria volta secondo una scansione visivo-topografica,come nell’ipertesto (senza “feticismo tecnologico”: la forma cuitendono le trame intertestuali che sorreggono qualunque lettera-rietà). Lo rivela pienamente internet dove la spazializzazione siimpadronisce della dimensione orale del “senso della comunità”,nella forma appunto della città-rete (che sembra realizzare, informa scritta, gli auspici di Zumthor), trascrivendo i tratti persi-no soprasegmentali della comunicazione vis à vis; così come i fi-les sonori sono “scritti” sul cd-rom multimediale, e la loro ese-cuzione si realizza, letteralmente, attraverso una finestra (ed èproprio la ormai banale definizione di différance data da Derridache va chiamata in causa: il carattere di “differita” insito in tuttele forme di riproduzione elettronica quale sorta di mise en abymedella presenza della voce, proprio sul modello del testo scritto,quello scarto dall’identità voce-soggetto-autore, che, ponendol’autore stesso “tra virgolette”, alla stregua di una citazione, spa-zializza l’“atto” linguistico all’interno di una rete topologica,come una sorta di carta geografica: esempio ne siano i bechettia-ni quartetti di Frasca). Il computer insomma “massimalizza l’af-fidamento della parola allo spazio e al movimento”, “la trasfor-mazione elettronica dell’espressione verbale ha accresciuto quelcoinvolgimento della parola nello spazio che era iniziato con lascrittura”56. La metrica come schema è uno spazio, anche se poi si
56 W.J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, Methuen,London-New York 1982, trad. it. Oralità e scrittura. Le tecnologie della pa-rola, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 190-193; P. Zumthor, Introduction à lapoésie orale, Editions du Seuil, Paris 1983, trad. it. La presenza della voce. In-
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
183
affida all’esecuzione, nella quale il ritmo costituisce essenzialmenteuna forma di organizzazione dinamica, di nuovo la cadenza di unmovimento anche spaziale57. In una “società delle reti” lo spaziodiventa inevitabilmente “lo spazio dei flussi”, al punto che l’interaimmagine della società si costruisce attraverso il movimento: que-sto nomadismo tra spazi mediali diversi sempre più ricorrente nel-le scritture di fine secolo non può allora non ricordare quello diPorta, e la sua “tensione cinetica” che determina una mobilità ir-requieta, ossessiva58. E sono proprio i percorsi laterali (le loop-roadsdi Shattuck) dei flussi fenomenici – provenienti da un’immaginedel paesaggio (anche mediale) come immagine dell’esterno, anco-ra una volta immagine del non umano o dell’assenza dell’uomo – apermettere alla poesia, che proprio nel suo essere processo sposta lasua funzione dal metaforico al metonimico59, di superare quella in-
troduzione alla poesia orale, Il Mulino, Bologna 1984, p. 29. Sull’“irreversi-bilità” di elementi della “rivoluzione tipografica”, presenti anche nei nuoviprocessi, si veda E.L. Eisenstein, The Printing Revolution in Early ModernEurope, Cambridge University Press, Cambridge 1983, trad. it. Le rivoluzio-ni del libro. L’invenzione della stampa e la nascita dell’età moderna, Il Muli-no, Bologna 1995, pp. 283-284. Sull’importanza dell’esperienza della lettu-ra/scrittura nel superare (nell’espressione artistica come nell’interpretazio-ne) l’autoritarismo del soggetto, e rendere quindi comunicabile la mobilitàe molteplicità del senso, si veda M. Blanchot, L’éspace littéraire, Gallimard,Paris 1955, trad. it. Lo spazio letterario, Einaudi, Torino 19752, pp. 164 e ss.Infine sul rapporto fra testo scritto e recitato (fra interpretazione e partecipa-zione), si veda l’ottima riflessione di M. Corti, Nozione e funzione dell’oralitànel sistema letterario, in Oralità e scrittura nel sistema letterario, Atti del Con-vegno (Cagliari, 14-18 aprile 1980), Bulzoni, Roma 1982, pp. 7-21, dove si ri-chiama lo “spettatore ditirambico” di Frye.
57 H. Meschonnic, Critique du Rythme, cit., pp. 216-217.58 N. Lorenzini, Il presente della poesia, cit., pp. 154 e ss.; F. Curi, Struttura del
risveglio, Sade, Sanguineti, la modernità letteraria, Il Mulino, Bologna 1991,pp. 175 e ss. Sul movimento e sull’immagine cinestetica come strategia fe-nomenologica dell’“eterocezione” cfr. P. Ouellet, Poétique du regard. Litté-rature, perception, identité, Editions du Septentrion, Sillery (Québec) 2000.M. Castells, The Rise of the Network Society, Basic Blackwell, Oxford 1996,definisce “Space of flows” l’intelaiatura dinamica lungo la quale circolano idati nell’era dell’informazione; si veda anche M. Castells, V. Vagaggini, Spa-zio geografico e spazio sociale, Franco Angeli, Milano 19802.
59 T. Harrison, The Lyric and the Antilyric, in L. Ballerini (a c. di), Shearsmenof Sorts. Italian Poetry 1975-1993, supplemento di «Forum Italicum», 1992,pp. 109-130, alle pp. 111 e 116.
Vincenzo Bagnoli
184
compatibilità tra rappresentazione dello spazio e del corpo cui si èfatto cenno all’inizio del capitolo: a darci, con una battuta, “l’uo-mo assente ma tutto intero nel paesaggio”60, il qui.
Tale etica si rinviene anche, con un segno diverso ma non dis-simile, in Giovanni Nadiani, autore di poemetti e cd nei quali il te-sto in romagnolo, in inglese, in italiano, nella lingua letteraria e inquella dei mezzi di comunicazione si mescola alla musica, al jazz: lasua scelta si distingue da quella dialettale e neodialettale, proprioperché il problema della diglossia trapassa, secondo un’etica della“creolizzazione” delle lingue, esplicitamente richiamata a ÉdouardGlissant, nel multilinguismo, vale a dire in una dinamica di apertu-re dialogiche che supera la statica contrapposizione. Il suo multi-linguismo inclusivo del dialetto pone la tradizione colta accanto aquella locale, ma anche accanto alla tradizione povera del pop, del-l’impoetico quindi. Filtrando attraverso gli occhi della letteraturale voci di un paesaggio mai guardato prima da essa, facendone unlucido racconto, una mappa di senso, questa poesia descrive ancheun progetto, un’immagine di cultura volta a costruire territoricome luoghi di dialoghi e incontri, non di chiusure. Scoprendo leinvarianze nelle diversità, come suggerisce Glissant, si arriva a una“poetica della relazione” che non è “poetica del magma, dell’indif-ferenziato, del neutro” proprio perché presuppone la necessità deldiverso: nella presente “tragedia”, la varietà delle lingue e dei pun-ti di vista è indispensabile per la costruzione di un linguaggio nonstandardizzato, ossia un proprio dire come “creola corporeità del‘noi’”, che riesca a “tendere al caos-mondo”61.
Riflessioni analoghe potrebbero essere fatte, rilevando la di-versità dei registri e dei toni, per molti altri autori, fra i qualivorrei almeno ricordare Lello Voce, Biagio Cepollaro e RosariaLo Russo. Questa modalità non piattamente “partecipativa”,ma al contrario capace di “letture” critiche, ha portato molti in-
60 G. Deleuze, F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, Editions de Minuit,Paris 1991, trad. it. Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino 1996, pp. 173-174.
61 É. Glissant, Poetica del diverso, cit., p. 35 e pp. 103-116, dove si distinguesottilmente (ma con effetti rilevanti) tra poliglossia e multilinguismo. Cfr.inoltre lo stesso G. Nadiani, Questo linguaggio che ci sostiene e ci tiene inostaggio…, in «Diverse Lingue», XIII, 19-20, 1998, pp. 41-78, in part. p. 55.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
185
terpreti (fra i quali soprattutto Niva Lorenzini) a rilevare in unaparte della poesia più giovane, a livello linguistico, la capacità distare nell’“universo di voci”, nel flusso linguistico (a contattocon il pop e le “lingue di massa”) senza tuttavia arrendersi al“crollo della catena del significante” e senza “mimesi del rumo-re”62. Nel rumore, e nell’interferenza, si sta, e l’obiettivo nonconsiste nel farlo tacere o nel tacere a propria volta, ma piutto-sto nel sapersi destreggiare attraverso di esso, non riproducen-done le dissonanze e tentando invece di organizzarlo in discor-so. La natura stessa del discorso umano, persino del “canto”,come Amelia Rosselli ha rilevato nel suo originale scritto sugliSpazi metrici, contiene in sé il rumore, poiché dal punto di vistamusicale se le vocali costituiscono sonorità, le consonanti si de-finiscono proprio come rumore63. La partecipazione a questospazio di voci, si diceva, non ha i contorni dell’oralità tradizio-nale, affidata al tempo, poiché l’ascolto si organizza su unascansione spaziale visiva che definisce uno spazio sonoro (lonota Blanchot) secondo un mutamento nel rapporto fra spazioe discorso che la stampa ha introdotto e che i mezzi di riprodu-zione moderni, fino all’elettronica, hanno in realtà intensifica-to64: il display della sintonia di una radio o un ipertesto, figli di
62 N. Lorenzini, La voce nel testo poetico, in «Il Verri», 1-2, 1993, p. 85; si vedainoltre Id., Il presente della poesia, cit., pp. 136 e ss.
63 A. Rosselli, Spazi metrici, in M.I. Gaeta, G. Sica, La parola ritrovata. Ultimetendenze della poesia italiana, Marsilio, Venezia 1995, pp. 217-222. Sulla ca-pacità del testo poetico di trasformare il rumore in informazione si ricordi-no le importanti osservazioni di J.M. Lotman, Struktura chudožestvennogoteksta, Iskusstvo, Moskva 1970, trad. it. La struttura del testo poetico, Mur-sia, Milano 1985, pp. 96 e ss.
64 Come notava acutamente già un ventennio fa W.J. Ong, Oralità e scrittura,cit., pp. 65 e ss. e 190 e ss.; in questo senso trovo sterile la polemica controM. Collot, La poésie moderne et la structure d’horizon, PUF, Paris 1989, cheanima il recente saggio di H. Meschonnic, Célébration de la poésie, Verdier,Lagrasse 2001, p. 67 e pp. 252-253. Se sono condivisibili gli appunti versocerte concezioni heideggeriane, credo però di aver ampiamente dimostratoche la metafora visiva nella modernità letteraria non ha nella maggior partedei casi la pretesa di stabilire una continuità fra le parole e le cose, ma piut-tosto rimanda alla dinamica di rappresentazione su un’altra scala e per mez-zo di convenzioni proprie della semantica testuale.
Vincenzo Bagnoli
186
Pietro Ramo, sono forme, più o meno stilizzate, di un paesaggio(e mappa) di voci65.
Continuando questa riflessione sulla spazialità ritmica del ver-so, nella quale si avanza l’ipotesi di una metrica scandita sull’esten-sione “scritta” piuttosto che sulla durata della pronuncia66, la Ros-selli (antesignana del mélange linguistico contemporaneo, cosìcome del lapsus quale “sconfinamento” in territorio contiguo) spe-cifica che lo spazio che ha in mente non è quello astratto, percepi-to in maniera “meccanica o del tutto visuale”, ma lo spazio per-corso dalla scansione logica dello scrivere e del parlare. Questospazio grafico-dinamico è a propria volta condizionato dallo spaziodell’ambiente che circonda materialmente l’atto della scrittura, se-condo il suo ragionamento, tanto che si può parlare di una conti-nuità tra i due. Nello stare in uno spazio, infatti, la mente tende aformarsene un quadro che ne diventa la misura e la mappa, la for-ma di ogni “inquadratura”: e davvero la versificazione diventa unatecnica di ripresa, un “osservare ogni materialità esterna con la piùcompleta minuziosità possibile entro un immediato lasso di tempoe di spazio sperimentale”. La scelta di questa particolare forma diregolarità (a suo modo una forma chiusa) corrisponde poi al sensodi una responsabilità (che implica un rispondere) a uno spazio coa-bitato, non privato: abbandonato il verso libero, dice la Rosselli, “iritmi si adattavano non a un mio volere soltanto ma allo spazio giàdeciso, e questo spazio era del tutto ricoperto di esperienze, realtà,
65 Si veda J. Le Goff, Memoria, in www.einaudi.it, Piccola Biblioteca on line,pp. 50 e ss. Non si tratta dunque di “feticismo” del mezzo, si diceva: al con-trario è quest’ultimo a nascere in risposta a un modo di concepire la testua-lità. È proprio questa dimensione architettonica di “paesaggio” a permette-re una “funzione sociale” delle forme; cfr G. Mesa, Il verso libero e il versonecessario. Ipotesi ed esempi nella poesia contemporanea, in «Il Verri», 2002,20, pp. 135-148. Si pensi soprattutto alle osservazioni di M. Blanchot (Lospazio letterario, cit.), secondo il quale il suono esiste, insieme alla “figura”e alla “mobilità ritmica”, entro uno “spazio unificato”.
66 Interessanti le riflessioni sull’organizzazione metrico-spaziale indotta dalloscrivere a macchina rispetto alla scrittura manuale, osservazioni condivise inaltra sede da Sanguineti e Scarpa, cfr. Scrittura elettronica e scrittura creati-va, intervista presente fra i “Dialoghi della rete” in formato audiovisivo e te-stuale in www.educational.rai.it.
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
187
oggetti e sensazioni” (corsivo mio). Questo non esclude poi la plu-ralità, poiché “tutti i ritmi possibili immaginabili riempivano mi-nuziosamente il mio quadrato a profondità timbrica”67.
Anche la pronuncia è dunque uno spazio, da non intendersidunque in senso statico-astratto, ma come costruzione dinamica,architettura: si tratta davvero di una “corporea poetica del suono,dello sguardo, del gesto, in una spazialità riconquistata alla con-cretezza”68, che materializza il proprio spazio-estensione noncome semplice durata di un suono, ma come processo, “progettoin fieri”, un territorio comune a metà strada fra autore69, vale adire senza muovere da una fiducia ontologica in oggetto o sog-getto, per fare centro sull’enunciazione, secondo quanto avevanoindicato i mai troppo ascoltati Benveniste e Searle70.
È stato notato che molte scritture di questi anni possiedonouna qualità di racconto (sarebbe meglio dire di raccontare, per sot-tolineare il processo), ossia la capacità di distendersi in una narra-zione che sappia costruire l’individualità non come assunto a prio-ri e “a comando” (uno dei “miracoli” postmodernisti), ma affi-dandola al testo, al suo percorso, e soprattutto a una sorta di di-sciplina dello sguardo. Così in Voce, Cepollaro e altri dell’exGruppo ’93, ma anche in Held, Fiori, Pusterla, Lombardo, Ingle-se si ritrova una volontà di raccontare che è innanzitutto un guar-dare, un’intenzionata ricerca, la costruzione di una forma, e non unirriflessivo vedere l’accumulo di materiali irrelati, il puro calcolodei dati esteriori. A un livello formale non c’è dunque slittamentoverso la prosa, ma il recupero di alcune risorse di cui la prosa si èimpadronita con l’invenzione del romanzo: soprattutto, come si èvisto, la capacità di far coesistere piani di coscienza diversi in or-ganizzazioni linguistiche diverse. Se forse non si può parlare diplurilinguismo per tutta la poesia contemporanea, si nota chiara-
67 A. Rosselli, Spazi metrici, cit., pp. 220-221; al proposito E. Tandello, parla diuna “passione di ragione”.
68 N. Lorenzini, La voce nel testo poetico, cit., p. 77.69 B.L. Whorf, Language, Thought, Reality, MIT Press, Cambridge (MASS.)
1956, trad. it. Linguaggio pensiero realtà, Bollati Boringhieri, Torino 1970.70 Il primo in particolare accenna a queste “configurazioni instabili” in Pro-
blemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 396.
Vincenzo Bagnoli
188
71 U. Fiori, Tutti di tutti, in «Il gallo silvestre», 11, 1999, pp. 115-116; si vedapoi R. Ronchi, Luogo comune, cit. Utili indicazioni sul concreto del rappor-to paesaggio/sguardo sono fornite da A. Fabbri, Letteratura di paesag-gio/Paesaggio in letteratura, in «Tratti», XII, 1996, 41.
72 V. Bonito, Le crepe nella scrittura: lo sguardo poetico di Valerio Magrelli, in Ilgelo e lo sguardo, CLUEB, Bologna 1996, pp. 79, 86 e 90.
189
mente nella parte presa a campione, la ricerca dialogica di un direattraverso il confronto non solo con i canoni ma anche con la lin-gua dell’altro, dell’ambiente. È proprio l’oggettività dell’esistenzaa permettere di trovare e condividere il “luogo comune”71; par-tendo quindi dai suoi elementi base non si ha ripiegamento nelborborigma interno o intimo, ma l’apertura, la legge di funzionemetonimica che alla fine compone le microstorie in storia plurale.Essa è sostanziata appunto da un ampio panorama di voci consa-pevoli dei propri condizionamenti, composte senza obbedienze aun metaracconto trascendente e assolutamente “vero”, ma secon-do un procedere, si potrebbe dire con Gadamer, urbanistico.
E soprattutto, a un livello tematico, il passaggio dal singolareal molteplice attraverso la materialità: in particolare la topologiadel corpo (in Frasca e Magrelli soprattutto) funge da principio diinvarianza e permette il trapasso a una scala di esperienza collet-tiva. Dove in Porta la plasticità fisica dell’anatomia arrivava a esi-ti paragonati alla pittura di Bacon, in Frasca il furore metrico siaccompagna alla rigidità cadaverica di Beckett e all’inerte di Pyn-chon, rendendo il corpo mappa di ossessioni. Anche in Magrellila cartografia del corpo è tracciata dalle dissezioni: “da chirurgo,/ da anatomopatologo / va divisa la lingua”, infatti, “Da macel-laio, almeno, / che studia la cartografia / delle bestie, le regionidel corpo / numerate come paesi, / come linguaggi” o del macel-laio; ma questa apparente distruzione non è che autoscopia al“grado zero”, che permette di vedere “il proprio corpo spettro-grafato all’interno dei rapporti vivi tra le cose”; l’etica del pro-getto-processo si riaffaccia come ricerca delle rassomiglianze,“immaginazione visiva” che procede alla compositio loci, con vo-cazione cartografica, ancora secondo l’ottica di Calvino (ma te-nendo a mente anche Merleau-Ponty, per il quale non vi sonocorrispondenze date, ma tutte devono essere costruite)72. Queste
La forma e il progetto. Scritture e poetiche 70-90
scansioni spaziali, esplicitate in Magrelli nella forma della plani-metria, come quando in Ora serrata retinae propone un indice dellibro di poesia che sia fatto come un progetto per il cantiere diuna casa (non solo la descrizione, ma le quantità materiali, le pre-visioni di spesa, l’analisi del processo, insomma), in Frasca arri-vano invece a prospettare, nella sequenza delle unità ritmiche chetiene il ritmo della sceneggiatura (secondo la tecnica di spezzareil verso in emistichi e poi in piedi), una possibile divisione dellapagina, più che una sequenza di fotogrammi, come una tavola dicomics. Lo suggerisce del resto lo stesso di titolo di Fumetto:
giunto al frigo l’aprì, non c’era molto,solo l’austerità delle lamiered’alluminio, riempì d’acqua un bicchiere,restò a guardarlo, ed insipido il voltogalleggiò un po’, poi si mise in ascolto,niente, ovviamente, poteva sedereora, tranquillo, frugarsi, vederedentro, più dentro, ecco, non c’era molto
La risposta che la letteratura sembra trovare al caos o, me-glio, al “mare della complessità”, assomiglia al principio di inva-rianza delle scienze fisiche (la legge che vale sul minimo puòspiegare anche fenomeni della scala più vasta e viceversa). Equesta risposta consiste nel passaggio dall’“io” al “qui”, dallapersonalità “unica” alla coscienza del locus (anzi, dei loci) e del-le “identità-relazione”: con la scelta dello sguardo “fuori” di-venta quindi determinante il punto di osservazione, la tecnica diinquadratura, il luogo da cui il “soggetto” (o i soggetti, o quelloche si vuole) pronuncia la sua voce. Così lo stile non si risolve inornamento, ma diventa davvero costruzione; così il discorso ar-tistico, come il tessuto urbano, non deve mirare a sovvertire lesue linee, ma pure deve mettere in gioco i suoi codici, in un dia-logo continuo tra il prima e il dopo, tra una parte e l’altra, ride-finendo costantemente il proprio orizzonte non rispetto aun’“utopia”, ma all’“eterotopia”.
Vincenzo Bagnoli
190
191
Addison, J. – 138Agamben, G. – 89n,
163nAlano di Lilla – 105Alberti, L. – 66Alberti, L.B. – 64,
105n, 105nAlbinati, E. – 178,
179nAnceschi, L. – 18nApel, K.O. – 9Apollinaire, G. – 40,
40nAragon, L. – 162Arato di Soli – 148,
148nArendt, H. – 168Ariosto, A. – 87nAriosto, L. – 26, 50,
52, 62, 62n, 63,65n, 66-68, 68n,70-71, 71n, 73, 73n,77, 77n, 78n, 79,80n, 81n, 81n, 83-84, 84n, 85-87, 87n,87n, 88n, 90n, 91n,92, 92n, 93n, 94,94n, 96, 98, 98n,99-100, 100n, 101,104n, 105n, 107,107n, 108, 108n,109-110, 112, 126,143, 144n, 148,148n, 149n
Aristotele – 8Arnheim, R. – 101,
101n, 128, 128n
Ashbery, J. – 170Assunto, R. – 17nAuerbach, E. – 30nAugé, M. – 34, 54n,
164n
Bacchelli, R. – 36n,123n, 127n
Bachelard, G. – 15, 21,21n, 25, 32, 33n, 37,41n, 47, 47n, 50,50n, 53n, 55, 57,57n, 97n, 107n, 112,112n, 117, 117n,118n, 125n, 137n,138n, 140, 140n,141n, 142, 142n,145n, 148n, 151n,171, 171n
Bachtin, M. – 31, 31n,65n, 75n, 89n, 91n,96n
Bacigalupo, M. – 37nBacon, F. – 189Baldissone, G. – 46n,
49, 49n, 52n, 55n,136n
Ballard, J.G. – 101,101n, 169
Ballerini, L. – 184nBandau, A. – 110nBàrberi Squarotti, G.
– 133nBarbieri, G. – 121,
121nBarlusconi, G. – 62n,
77n, 104n
Barthes, R. – 27, 27n,31, 31n, 32, 32n,44n, 159, 159n
Bataille, G. – 141nBattistini, A. – 121n,
129nBaudelaire, Ch. – 13-
14, 17, 17n, 19, 19n,20n, 45, 50, 53-54,54n, 85, 122n, 126,133n, 151, 151n,166
Baudrillard, J. – 164nBaumgarten, A.G. –
147nBazzocchi, M.A. –
150nBec, Ch. – 82nBeckett, S. – 181, 189Belpoliti, M. – 23n,
176n, 177nBeltrami, P.G. – 122nBenjamin, W. – 13,
20n, 24, 162n, 163,163n, 167, 167n,169, 169n
Benveniste, É. – 188Bernardo Silvestre –
119Bertone, G. – 40n,
43n, 44n, 46n, 54,54n, 59, 59n, 63n,64n, 83n, 90n, 91n,126n, 127n, 132n,144n
Besse, J.-M. – 21nBetta, P. – 21n
INDICE DEI NOMI
192
Bianciardi, L. – 170Biasin, G.P. – 41n,
143n, 179, 179nBigongiari, P. – 122,
122n, 131, 137n,146n
Binni, W. – 74n,78, 78n, 84n, 85n,88n, 93n, 96n, 99,99n, 108, 108n,116n, 121, 121n
Biral, B. – 133nBlanchard, M.E. –
33nBlanchot, M. – 10,
10n, 125n, 184n,186, 187n
Blasucci, L. – 82n,118n, 120, 122n,124n, 130n,140, 140n
Bloom, H. – 61n, 136nBlumenberg, H. – 31,
31n, 42n, 43n, 46n,52n, 59n, 70n, 126n
Boccaccio, G. – 73Boiardo, M.M. – 66,
68n, 70Boileau, N. – 18nBologna, C. – 66, 66n,
67n, 89n, 90n, 97n,100n, 108, 110n
Bolza, G.B. – 87nBonito, V. – 189nBonnefoy, Y. – 72nBorges, J.L. – 24n, 61,
166Borsellino, N. – 98n,
122n, 182nBorso d’Este – 74n,
87nBotta, G. – 33nBottoni, L. – 123nBourneuf, R. – 25nBragaglia, A.G. – 92nBranca, V. – 123nBrecht, B. – 59, 122
Breme, L. di – 129,152n, 156-157
Bresciani Califano, M.– 67n
Breton, A. – 49, 169Brilli, A. – 140nBroch, H. – 35, 35n,
56n, 165, 165nBrunner, J. – 170Buffon, G.L. Leclerc –
123nBuisseret, D. – 83nBurke, K. – 63, 88Burke, P. – 13n, 55,
63n, 65, 65nBuzzati, D. – 170Byron, G. – 120
Caesar, M. – 152nCagnolo, G. – 74nCaillois, R. – 48n, 51,
51n, 125n, 162,162n
Calvesi, M. – 182nCalvino, I. – 16, 16n,
18, 21-22, 23n, 23n,24, 24n, 30, 32n, 33,36n, 39n, 40, 41n,42, 42n, 43n, 44n,45, 52, 53n, 55, 55n,55n, 56, 56n, 57,57n, 60n, 61n, 61n,62, 62n, 63, 63n,64n, 64n, 65n, 66,66n, 67, 67n, 68,68n, 71-73, 73n, 74,74n, 75, 75n, 76,76n, 77, 77n, 78-79,80, 80n, 83n, 84n,85, 87n, 88, 88n, 89,90n, 91, 91n, 92n,93, 93n, 94, 94n,95n, 98, 98n, 98n,99-100, 100n, 102-103, 103n, 104,104n, 106, 106n,107, 107n, 108n,
109, 109n, 110n,110n, 111, 111n,112n, 113, 125n,127, 148n, 150,150n, 150n, 151n,159, 163, 163n, 166,166n, 176, 176n,176n, 177, 177n,177n, 178-179, 189
Camerino, G.A. –136n
Camões, F. – 67nCampana, D. – 101,
101nCanetti, E. – 52n, 178,
178nCaproni, G. – 18nCardamosto – 87nCarena, T. – 119nCaretti, L. – 65n, 66,
67nCarletti, F. – 82nCartesio (R. Descartes)
– 41, 41n, 60, 70,111
Carus, C.G. – 44Casadei, A. – 71n, 84nCassini, C.F. – 83, 83nCassirer, E. – 17, 17n,
36n, 39, 39n, 56-57,57n
Castellani, E. – 163nCastells, M. – 184nCavalcanti, G. – 107,
107n, 108Cavazzoni, E. – 16n,
36nCelati, G. – 15n, 68n,
179Cepollaro, B. – 186,
188Cerulli, E. – 78nCervantes, M. Saave-
dra de – 61, 102,104, 108
Cervigni, D.S. – 41n,143n, 179n
Indice dei nomi
193
Ceserani, R. – 84nCézanne, P. – 146nChiari, A. – 134nCicerone, Marco Tul-
lio – 147Collot, M. – 9, 28,
28n, 186nColombo, C. – 79, 82,
83n, 87n, 90Colonna, F. – 155nConrad, J. – 94, 164Consoli, D. – 120nConstable, J. – 129Contessi, G. – 47n,
48nContini, G. – 107Cook, G.I. – 33nCopernico (N. Kop-
pernigk) – 51Corneille, P. – 35nCorreggio (A. Allegri)
– 146Cortellessa, A. – 179nCorti, M. – 74n, 107,
107n, 112, 112n,184n
Cosgrove, D. – 21nCoveri, L.C. – 182nCowan, J. – 65nCroce, B. – 66, 116Curi, F. – 26n, 141n,
145n, 184nCurtius, E.R. – 69n,
79n, 82n, 105n, 118,118n, 119, 119n
D’Ailly, P. – 87nDalla, L. – 182Dalorto, A. – 78nD’Annunzio, G. –
18n, 52nDante Alighieri – 70-
71, 73, 81, 81n, 82-83, 93, 95, 102, 104,109, 112n, 119n,137, 139, 147
Darwin, Ch. – 139
Darwin, E. – 123nDe Blasi, A. – 46nDebord, G. – 52n,
164n, 173Defilippis, D. – 87nDeleuze, G. – 81,
161n, 171n, 185nDel Giudice, D. – 179DeLillo, Don – 166-
167De Man, P. – 98nDe Robertis, R. – 116Derrida, J. – 183De Sanctis, F. – 116,
140De Seta, C. – 34n,
127n, 171nDi Meo, Ph. – 172nDick, P.K. – 181Diderot, D. – 25, 56,
70, 80, 111Dilthey, W. – 65Dionisotti, C. – 109,
144nDöblin, A. – 162Dombroski, R. – 178,
178nDonne, J. – 147Doroszlaï, A. – 84n,
86n, 87n, 88n, 106n,109n
Dotti, U. – 132n, 140nDubbini, R. – 161nDu Camp, M. – 84
Eco, U. – 18n, 26nEdelman, G.M. –
146nEisenstein, E.L. – 43n,
184nEngell, J. – 138nEnrico IV di Francia –
74Enzensberger, H.M. –
32n, 75n, 172Ercole d’Este – 87nErodoto – 88
Fabbri, A. – 189nFarinelli, F. – 36n, 37n,
46nFarnetti, M. – 141nFasano, P. – 85n, 122n,
123nFebvre, L. – 107nFerrucci, C. – 150nFicara, I.G. – 123n,
124n, 155nFichte, J.G. – 138Filicaia, V. da – 122nFiori, U. – 182, 188,
189nFish, S. – 19nFlew, A.G.N. – 25nFlora, F. – 116Folin, A. – 118n, 122n,
127n, 133n, 135n,136n, 149n, 151n,154n
Fortini, F. – 122n,136n, 160, 160n,172, 172n
Foscolo, U. – 30, 73n,84n, 127, 127n, 138,144n
Foster, G. – 123nFoucault, M. – 45,
45n, 64, 64n, 65, 68,77, 99n, 103n, 104n,107n, 119, 148,156n
Fourier, A. – 44n,159n
Franceschini, A. – 74nFrasca, G. – 181-182,
182n, 183, 189Frattini, A. – 123nFreud, S. – 35n, 112nFrezza, L. – 40nFrye, N. – 89Fubini, M. – 121, 123nFumaroli, M. – 72n
Gadamer, H.G. – 167,168n, 189
Indice dei nomi
194
Gadda, C.E. – 24, 34n,127n, 140n, 164,166, 171n, 177
Gaeta, M.I. – 186nGagliardi, D. – 155nGalilei, G. – 44n, 70,
102, 108, 111, 111n,129, 130n, 148n,148n, 153,155, 155n
Galimberti, C. – 115n,118n, 126n, 131n,134n, 135, 135n,142n, 143n, 144n,145n, 149, 149n,152n, 155n, 156n
Gargani, A.G. – 16n,33, 33n, 34, 34n,136n
Garin, E. – 63nGeertz, C. – 37n, 47,
165, 166nGelz, A. – 110nGenette, G. – 15, 15n,
18n, 30, 30n, 46n,61n, 127n, 157n,173n
Gessner, S. – 118, 120Getto, G. – 107, 107nGilli, R. – 160nGioberti, V. – 85, 85n,
93nGiraldi Cinzio, G.B. –
67nGirardi, E.N. – 62nGiuliani, A. – 173nGlissant, É. – 33, 33n,
168, 168n, 185,185n
Goethe, J.W. –17, 17n, 31, 31n, 44
Gombrich, E. – 63Goodman, N. – 17nGraff, H.J. – 10nGravina, G.V. – 119,
119n, 119n,120, 120n, 119n,
122, 128, 129, 137,142n
Greenblatt, S. – 109nGregotti, V. – 37nGreimas, A.-J. – 113,
113nGreppi, C. – 87nGuarrasi, V. – 64nGuattari, F. – 161n,
171n, 185nGuglielmi, Giuseppe
– 171Guglielmi, Guido –
125n, 126n, 127n,129n, 130, 130n,131n, 133n, 139n,144n, 154n, 159n,162n
Guglielmoni, P. –139n
Guicciardini, F. – 67Guidi, J. – 106nGullentops, D. – 28n,
29nGuyot, A. – 7n
Hall, T.E. – 52nHamon, Ph. – 14n,
18n, 27n, 32, 36n,38, 38n, 44, 50, 50n,56, 56n, 116n,117n, 125n, 127
Harrison, T. – 184nHarth, H. – 110nHasinger, G. – 160nHavelock, E.A. – 43nHegel, F. – 157, 157nHeidegger, M. – 9Held, R. – 188Henighan, T. – 121nHenry, A. – 31n, 36nHerendeen, W.H. –
21nHesse, H. – 142nHighet, G. – 155nHuizinga, J. – 48n,
75n, 125n
Humboldt, A. von –37n, 44, 44n, 57-59,59n, 60, 60n, 70,126, 129, 130n, 136,150n, 158, 163
Humboldt, W. von –58
Hutcheon, L. – 61n,70n, 182n
Hutton, J. – 139
Inglese, A. – 188Ippolito d’Este – 85Isidoro di Siviglia –
82, 107
Jameson, F. – 34, 34n,55, 161n, 164, 164n,165n, 181
Joyce, J. – 18n, 18n,162, 166
Kandinskij, V.V. – 165Keats, J. – 142Kepes, G. – 52nKeplero (J. Kepler) –
139Kern, S. – 23nKleinert, S. – 110nKlingemann, A. – 146Köhler, E. – 71, 71n,
72, 72nKuki Shuzo – 9Kuon, P. – 68n
La Capra, D. – 167nLacan, J. – 169Lando, F. – 20n, 21n,
33n, 44n, 48n, 50n,53n
Landoni, E. – 142nLaplace, P.S. de – 139La Porta, F. – 164nLarbaud, V. – 163n,
166Lausberg, H. – 15n,
36n
Indice dei nomi
195
Lautréamont (I. Du-casse) – 162
Lavagetto, M. – 100nLawrence, D.H. – 33nLe Goff, J. – 187nLeed, E.J. – 23n, 109nLefebvre, H. – 36nLeonardo da Vinci –
15, 54Leopardi, C. – 152nLeopardi, G. – 21, 26,
38, 42n, 50, 52-53,57, 58n, 59-60, 70,81n, 108, 111, 115,115n, 116, 116n,116n, 118, 118n,119-120, 121n, 122,122n, 123, 123n,124, 124n, 125,125n, 126, 126n,127n, 127n,129, 129n, 130-131,131n, 132n,133, 133n, 133n,134-135, 135n, 136,136n, 136n, 138-140, 140n, 141n,141n, 142, 142n,144n, 144n,146, 146n, 147,148n, 148n, 149-150, 150n, 150n,151, 151n, 151n,152, 152n, 152n,153, 155n, 156, 157,157n, 159-160, 162
Leopardi, P. – 152nLepenies, W. – 123nLessing, G.E. – 31nLey, D. – 57nLiborio, M. – 69nLinné, C. Von (Lin-
neo) – 123nLocke, J. – 115nLo Faso, A. – 63nLombardo, F. – 188Lonardi, G. – 133n
Lorenzetti, A. – 64, 66Lorenzini, N. – 23n,
53n, 101n, 171n,173n, 174, 176n,180n, 184n, 186,186n, 188
Lo Russo, R. – 185Lotman, J.M. – 18n,
19n, 27, 29n, 48,48n, 75n, 147n,149n, 157n, 158,159n, 186n
Lowenthal, D. – 21n,47n
Loyola, I. da – 43n, 44,44n, 159n
Luccioni, P. – 155nLucrezio Caro, Tito –
24, 41, 53, 106, 108Lukács, G. – 13n, 19,
19n, 22, 22n, 30,30n, 31-32, 32n, 37-38, 38n, 45, 45n, 67,67n, 68, 72, 72n,74n, 75, 93n,100, 100n, 103,103n
Luperini, R. – 178nLuti, G. – 57n
McCarthy, M. – 34,34n, 35n, 36n, 48,48n, 50, 65
Macchioni Jodi, R. –148n
McCleery, Alison –20n
McCleery, Alistair –20n
McLuhan, M. – 43n,44, 44n, 107n
Machiavelli, N. – 42n,63, 66-67, 70, 74
Magnani, M. – 21nMagrelli, V. – 189-190Malerba, L. – 68Mallarmé, S. – 50
Mandelbrot, B. – 169Manfredi, E. – 122nMann, Th. – 33Mannheim, K. – 13nManzoni, A. – 144nMarco Polo – 84, 87nMariano, E. – 18nMarinelli, O. – 46nMarinetti, F.T. – 76nMarrone, G. – 37nMartellus Germanus –
87nMarti, M. – 148n,
157nMarx, K. – 53nMasiola, R.R. – 65nMatta, R.S. – 55Maturin, Ch.R. – 175Mauduit, Ch. – 155nMaurron, Ch. – 38Mela, Pomponio – 87nMelchiori, G. – 18nMeletinskij, E.M. –
67nMercator (G. Kremer)
– 63, 74, 83Merleau-Ponty, M. –
42n, 113, 133n, 146,152n, 189
Mesa, G. – 181, 187nMeschonnic, H. – 56n,
92n, 182n, 184n,186n
Metastasio, P. – 142nMeyendorff, M. de –
140Micocci, C. – 89nMilanini, C. – 55n, 57,
57n, 98n, 177nMiller, R. – 178nMilton, J. – 63nMomigliano, A. – 77n,
144nMontale, E. – 24, 133nMonti, V. – 118, 135nMoore, M. – 24Moretti, F. – 100n
Indice dei nomi
Moretti, W. – 87nMosco – 118Muehrcke, P.C. – 50nMuehrcke, O.J. – 50nMugellesi, R. – 119n,
155nMuratori, L.A. – 138Musarra-Schroeder,
U. – 64n, 67n, 75n,95, 150n, 176n
Musil, R. – 24, 162,166
Muzzioli, F. – 132n
Nadiani, G. – 185,185n
Newton, I. – 108, 139Nicolò dei Conti –
87nNietzsche, F. – 51, 96,
141n, 157Novalis (F.L. von Har-
denberg) – 16, 30,60, 128, 129n, 136,163
Oderico da Pordeno-ne – 87n
Ogden, C.K. – 41n,49n
Olson, D.R. – 10nOlsson, G. – 20n, 53nOmero – 43n, 79, 139Ong, W.J. – 43n, 45n,
107n, 183n, 186nOpicino de Canistris –
112Orazio Flacco, Quinto
– 137Ortalli, G. – 74nOuellet, R. – 25n,
47, 47n, 51n, 177n,179n, 184n
Ovidio Nasone, Pu-blio – 41, 77, 81,108, 157n
Pagliarani, E. – 171Paolo Uccello – 63, 74Papagno, G. – 87nPapotti, D. – 67nParini, G. – 34, 34n,
127n, 140n, 171,171n
Parronchi, A. – 127nPascoli, G. – 9, 150nPasolini, P.P. – 150nPatrizi, G. – 61n, 122nPaz, O. – 167Pedullà, W. – 182nPepoli, C. – 135nPerniola, M. – 44n,
180Perocco, D. – 83nPetrarca, F. – 70, 73,
80, 80n, 97, 97n,109, 122n, 130
Piccolomini, E.S. –87n
Piccolomini, M. –119n
Pieri, M. – 179nPindemonte, I. – 118Pinotti, P. – 157nPlaisance, M. – 87nPlatone – 43nPocock, D.C.D. – 33nPoe, E.A. – 32, 131,
138, 139, 139n, 141,141n, 150-151,151n, 160, 160n
Polato, L. – 148nPonge, F. – 24, 172Pope, A. – 138Porta, A. – 172, 172n,
173n, 174, 174n,175-176, 184, 189
Porteous, J. – 49nPrete, A. – 118nProust, M. – 24, 39,
175nPusterla, F. – 188Pynchon, T. – 189
Queneau, R. – 24n,166n
Quevedo, F. de – 161Quint, D. – 63n, 67n,
72nQuondam, A. – 87n,
88n, 119n
Rabelais, F. – 75nRacine, J. – 35nRaimondi, E. – 8n,
42n, 44, 44n, 52n,65n, 76n, 107n, 110,110n, 115n, 121n,123n, 124n, 128n,129n, 136n, 142,142n, 143n, 152n,155n, 156n, 157n
Raimondi, S. – 175nRamo, P. – 187Ramusio, G. – 66Rauschenberg, R.M. –
169Renzi, L. – 115nRichards, I.A. – 31n,
41, 41n, 49, 49n,110, 178
Ricoeur, P. – 23nRigoni, M.A. – 141nRitter Santini, L. – 8nRochon, A. – 85n, 88nRomagnoli, S. – 34,
34n, 127n, 140n,152n, 154n, 171n
Ronchi, R. – 37n, 51n,132n, 168n
Rosselli, A. – 186,186n, 187, 188n
Rousseau, J.-J. – 35n,127n
Roussel, R. – 106Roversi, R. – 172, 181Ruffato, C. – 171Ruscelli, G. – 67nRusso, L. – 142nRutilio Namaziano –
69
Indice dei nomi
196
Sade, D.A.F. de – 26n,44n, 70, 141, 141n,141n, 159n
Saffo – 57, 57, 135Samuels, M.S. – 57nSangirardi, G. – 115n,
131n, 152n, 155nSanguineti, E. – 26n,
71n, 73n, 74, 141n,187n
Santagata, M. – 115n,116n, 122n, 124n,127n, 158n
Sartre, J.-P. – 134nSavinio, A. –
162, 162nSavioli Fontana Ca-
stelli, L.V. – 122nScaramellini, G. – 87nScaramuzza, G. – 171nScarpa, T. – 187nSchiaffini, A. – 105nSchiller, F. – 128, 131,
138Scrivo, L. – 76nSearle, J.R. – 42, 42n,
178, 188Segre, C. – 65n, 81n,
98n, 100, 105n,106n
Sereni, V. – 132, 172Serianni, L. – 182nSerpa, F. – 155nShakespeare, W. – 142Shapiro, M. – 100nShattuck, R. – 16n,
26, 26n, 49n, 50n,184
Sica, G. – 186nSingh, G. – 151nŠklovskij, V. – 127nSolmi, S. – 118n, 135nSpitzer, L. – 134n,
155nStarobinski, J. – 35n,
39n, 43n, 76n,127n, 175n
Stendhal (H. Beyle) –35n, 58
Sternberger, D. – 115Sterne, L. – 80Stevens, W. – 24n,
37, 37n, 170Stierle, K. – 72nStrabone – 28, 87nSvevo, I. – 15, 15n
Tabucchi, A. – 68Tandello, E. – 188nTassoni, L. – 46n,
133n, 151nTerenzio, V. – 150nTesauro, E. – 76nTesti, M. – 18n, 135nTiedemann, R. – 163nTimpanaro, S. – 153nTison-Braun, M. –
31nTodorov, T. – 162,
162n, 169, 169nTolkien, J.R.R. – 50,
80, 80nTolomeo – 86, 87nTorricelli, E. – 155nTraina, A. – 147nTraina, G. – 119nTuan, Y. – 56, 56nTurner, A.R. – 63Turner, J.M.V. – 129Turner, V. – 37nTurri, E. – 21n, 32n,
34, 34n, 42n, 47n,52n, 64n, 65n, 66n,74n, 87n, 143n,152n, 174n
Ulivi, F. – 119nUngaretti, G. – 55,
130, 150n, 162nUspenskij, B.A. –
149n, 157n, 158,159n
Vagaggini, V. – 184n
Valentini, A. – 123nValéry, P. – 42nVasco de Gama – 87nVerga, G. – 30Vernant, J.P. – 52nVespucci, A. – 87nVincenzo di Beauvais
– 107Virgilio Marone, Pu-
blio – 63n, 70, 79,148n, 148n, 157,157n
Virilio, P. – 161nVittorini, E. – 166Voce, L. – 185, 188Voltaire (F.M. Arouet)
– 88, 88n, 88n
Waage Petersen, L. –68n, 110n
Waisman, F. – 25nWeinrich, H. – 72nWhorf, B.L. – 188nWiley, M. – 132n,
149nWilliams, W.C. – 24,
167, 170, 171Winckelmann, J.J. –
123nWittgenstein, L. – 53nWolff, Ch. – 138Wölfflin, H. – 101Woodhouse, R. – 142Wordsworth, W. – 50,
149n
Yates, F. – 63n
Zangenfeind, S. – 110nZanzotto, A. – 133n,
171Zecchi, S. – 149nZink, M. – 72nZola, É. – 30Zorzi, R. – 39n, 175nZumthor, P. – 64n,
183, 183n
Indice dei nomi
197