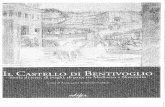Genealogia del testo
Transcript of Genealogia del testo
I.
Genealogia del testo: avventure di una nozione
Il testo, nella sua massa, è paragonabile a un cielo,piatto e insieme profondo, liscio, senza bordi esenza punti di riferimento; come l’augure chevi ritaglia con l’estremità del bastone un rettangolofittizio per interrogarvi secondo certi criteri il volodegli uccelli, il commentatore traccia lungo il testodelle zone di lettura, al fine di osservarvile migrazioni dei sensi, l’affiorare dei codici,il passaggio delle citazioni.
Roland Barthes
1. Sociosemiotica senza testualità
«Una scienza che studi la vita dei segni nel quadro della vita socia-le». È questa la definizione con la quale ai primi del Novecento Fer-dinand de Saussure, alla ricerca di un proprio sensato oggetto di co-noscenza, individua quella semiologia o scienza dei segni che tantaparte avrà, fra entusiasmi e rimbrotti, nella storia della cultura a ve-nire. In questa definizione colpisce, ancor prima del richiamo allascienza, il doppio riferimento alla vita: dei segni e della società altempo stesso, forse perché, come certamente il geniale linguista do-veva aver pensato, si tratta in fondo della medesima cosa. A frontedi tanta accigliata pubblicistica successiva che ha accusato lo strut-turalismo di astrattezza, formalismi e chiusura in se stesso, ecco, giàda subito, segni dinamici che circolano in una società vivace, di cuisi rende necessaria una scienza che si preoccupi di spiegarne il fun-zionamento, comprendendone le ragioni. Il linguaggio, i discorsi, lelingue, i segni sono processi sociali: la loro natura formale, necessa-
3
5
plicando i contemporanei successi della linguistica strutturale, sa-pesse proporre rigorosi metodi d’analisi per ogni possibile operad’espressione e di comunicazione. Autori come Algirdas J. Greimase Jurij M. Lotman, per non citare che i più noti, hanno saputo per-correre e incrociare entrambe le strade, riuscendo felicemente a pas-sare dalla modellizzazione culturologica generale all’esame puntua-le d’una singola opera – seguendo in questo il mai dimenticato mo-nito flaubertiano per cui Dio, chiamiamolo così, sta nel particolare.I modelli semiotici hanno in tal modo permesso all’antropologia cul-turale di foraggiare la critica letteraria e artistica, alla filologia e all’i-conologia di ripensarsi in senso etnologico, agli studi sui media diutilizzare metodologie linguistiche. E viceversa. Ciò che in questofrangente s’è perduto è, però, la verve critica insita nell’analisi for-male dei fatti sociali, o anche semplicemente l’ipotesi – chiarissimaper quel profeta delle pure differenze che era Saussure – d’un fon-damento sociale d’ogni fenomeno linguistico e comunicativo,espressivo e semiotico. Per lo più, in tal modo, è sulle singole opere– romanzi, racconti, poesie, film, quadri, fotografie, balletti, annun-ci pubblicitari, trasmissioni televisive, articoli di giornale, artefattiarchitettonici, oggetti – che ci si è concentrati, eleggendo come cam-po d’indagine tutto ciò che, secondo il dettato implicito della nostracultura, può avere le sembianze d’un testo: ovverosia d’un qualchesupporto espressivo atto a veicolare determinati contenuti, con suespecifiche fattezze, confini riconoscibili, processualità interna e viadicendo.
Progressivamente la scienza della significazione ha allargato lanozione di testo e l’ha utilizzata per studiare non solo entità semio-tiche che fanno uso di sostanze espressive non verbali, ma anche ma-nifestazioni culturali molto diverse fra loro che possono avere le stes-se proprietà fondamentali di un libro-testo – biplanarità, tenuta,chiusura, stratificazione dei livelli, processualità interna etc. – senzaaverne l’evidenza. In tal modo, palinsesti televisivi, campagne pub-blicitarie, flussi informativi, piattaforme comunicative, conversazio-ni orali, interazioni via web, strategie di marketing, stazioni della me-tropolitana, edifici, intere città, se pure non sono testi dal punto divista empirico, vengono esaminati dal punto di vista metodologico co-me se lo fossero, dato che è possibile riscontrare in essi le medesimeproprietà formali dei testi propriamente detti. Il testo, secondo taleprospettiva di studi, non è più una cosa, un oggetto empirico, ma unmodello teorico usato come strumento di descrizione, date alcune
4
ria ed essenziale, non fa che indicarlo e sottolinearlo, confermarlo,dimostrarlo.
Che cosa è accaduto dopo di allora? In un primo tempo, quandoil monito saussuriano è stato ripreso e sviluppato da autori come Ro-land Barthes e Umberto Eco, questa attenzione verso la socialità eracostitutiva. La nascente cultura di massa con i suoi specifici strumentidi comunicazione, l’emergenza di una società dei consumi, il design,ma anche la sperimentazione letteraria e artistica, la rinnovata at-tenzione logico-linguistica della filosofia, lo sviluppo di un’episte-mologia autonoma delle scienze umane rendono indispensabile unaprospettiva teorica attenta e disincantata, capace di allestire un me-todo d’analisi formale della società scevro da ogni ideologia soggia-cente. La semiotica – come da lì a poco fu ribattezzata la chimera diSaussure – risponde a questa domanda, e nasce come disciplina spe-cifica, con suoi autori e sue istituzioni, proprio a metà del secolo. Li-bri come Miti d’oggi (1957) e Apocalittici e integrati (1964) sono frale migliori dimostrazioni di questa attenzione della scienza dei segniverso la vita quotidiana e sociale, di questa vocazione critica – in tuttii sensi del termine – che una prospettiva di studio sui sistemi e pro-cessi di significazione non poteva non avere. Occuparsi di televisioneo di pubblicità, di canzoni di consumo o di fumetti, di giornalismoo di moda, di avanguardie artistiche o di romanzi sperimentali, di mi-tologie alimentari o d’incontri di catch esige la costruzione progres-siva di uno sguardo che coniughi competenze linguistiche e curiositàsociologica, attenzione metodologica e spirito polemico, vocazioneformale e profondità filosofica.
Le cronache successive della semiotica hanno però in gran parteabbandonato questa vena originaria, e non solo per prevedibili fili-steismi accademici. A eccezione della tradizione anglosassone dellasocial semiotics, destinata ben presto a rifluire nel gran mare dei cul-tural studies (perdendo in rigore metodologico, ma assumendo la lo-ro vena polemica), la scienza della significazione di matrice europeaha preferito percorrere altre strade. Da una parte ci si è soffermatisulla fondazione di una semiotica come indagine sulla cultura, dia-logando con scienze umane come il folklore e l’etnologia, il compa-rativismo linguistico e religioso, la storiografia, la psicanalisi e la stes-sa sociologia, e mirando alla costruzione di modelli generali per lostudio rigoroso dei meccanismi antropologici. Dall’altra ci si è con-centrati sulla scommessa di un esame dei linguaggi non verbali – im-magini, gestualità, audiovisivi, oggetti della vita quotidiana – che, re-
7
testuale ed esperienziale. Dal punto di vista sociosemiotico il conte-sto è, come vedremo, ciò che non è pertinente per l’analisi testuale:pertinenza che, prima ancora dell’analisi, è la cultura sociale a co-struire e a porre. E il testo non è l’appiglio materiale per possibili in-terpretazioni che lo completino o addirittura ne giustifichino l’esi-stenza, ma il dispositivo formale mediante cui il senso, articolando-si, si manifesta, circola nella società e nella cultura. Esso è pertantol’oggetto di studio specifico del semiologo che, analizzandolo, deveprovare a ricostruirne forme e dinamiche, articolazioni interne e li-velli di pertinenza, entrate e uscite. Il testo non è un dato, un’evi-denza fenomenica, ma l’esito di una doppia costruzione: configura-zione socioculturale prima, riconfigurazione analitica dopo. Da que-sto punto di vista, il testo è per forza di cose negoziato entro le di-namiche culturali che, ponendolo in essere, esistono e sussistono, inun intreccio continuo con altri testi, altri discorsi, altri linguaggi.Nulla di chiuso, dunque, ma semmai di permeabile ai bordi, dischiu -so, pronto a riconvertirsi in altre configurazioni testuali, a tradursi inaltri linguaggi, in quella catena intertestuale, interdiscorsiva, inter-mediatica senza fine che è, in fondo, la semiosfera.
L’ondata sociosemiotica sembra però – oggi – essersi radicaliz-zata e, così facendo, parzialmente vaporizzata. Radicalizzata perché,dando ascolto alle sirene di un certo sociologismo di maniera, essaha cominciato a opporre, in modo talvolta caricaturale, lo studio deicosiddetti testi a quello delle cosiddette pratiche. Vaporizzata per-ché, così facendo, essa ha finito con il dotare sia agli uni sia alle al-tre di una valenza fortemente ontologica, del tutto contraria alla di-sposizione costruttivista inscritta nel dettato epistemologico dellasemiotica, e a maggior ragione della sociosemiotica. I testi sarebbe-ro insomma, ancora una volta, le opere, ovvero ciò che secondo ilnostro assetto culturale ha una riconoscibilità significativa, al puntoda poter essere designati, grazie a un minimo sforzo, con il termineche si usa per ciò che la lingua comune chiama ‘testi’, cioè i libri oaltre consimili manifestazioni empiriche di comunicazione scritta.Una pratica sarebbe invece, sempre secondo questa ipotesi, un com-portamento sociale, cognitivo e sensoriale come la lettura di un li-bro, la visione di un film, la degustazione di un piatto, l’esperienzaconcreta di una danza, una strategia di marketing, una campagna dipromozione politica e simili. Si vede bene come riemerga il simula-cro, perennemente in agguato, di quell’epistemologia ‘classica’ ches’ostina a opporre parole e cose, discorsi e fatti, rappresentazioni e
6
specifiche ed esplicitate condizioni epistemologiche, in modo da ri-costruire i dispositivi formali più o meno ‘profondi’ di qualsiasi og-getto di conoscenza della scienza della significazione. Così come lanozione di narratività è stata costruita allargando progressivamentel’analisi di racconti concreti (fiabe, miti, romanzi, racconti e opereparaletterarie etc.) per spiegare discorsi apparentemente non narra-tivi (pubblicitari, politici, giornalistici, filosofici etc.), allo stesso mo-do la nozione di testualità è stata edificata a partire da testi ‘pro-priamente detti’ (romanzi, poesie, quadri, fotografie etc.) per rico-struire l’articolazione significativa di manifestazioni semiotiche ap-parentemente non testuali (ipermercati, modi di preparazione di unpiatto, esperimenti scientifici etc.). Il testo diviene il modello forma-le per la spiegazione di tutti i fenomeni umani e sociali, culturali estorici. È per questo che Greimas amava ripetere lo slogan «al di fuo-ri del testo non c’è salvezza», e che molti semiologi continuano a usa-re il termine ‘testo’ per indicare l’oggetto specifico dei loro studi,quale esso sia.
Da qui la nouvelle vague sociosemiotica. Sulla scorta di un semi-nale intervento di Paolo Fabbri dei primi anni Settanta, che oppo-neva al malocchio teorico della sociologia l’antidoto metodologicodello sguardo semiotico, autori come Jean-Marie Floch e Eric Lan-dowski hanno iniziato a esplorare la possibilità di uno studio forma-le e semiotico di fatti sociali come la comunicazione pubblicitaria,politica e giornalistica, la moda e il design, la cucina e la vita quoti-diana, gli oggetti e l’esperienza sensoriale, badando però, più che ailoro supporti testuali, alle loro più ampie valenze sociali e culturali,al loro risvolto discorsivo. E tanti altri con e dopo di loro. Analiz-zando non opere già date ma cose molto meno determinate come si-tuazioni, congiunture, pratiche, usi, esperienze sensoriali e corporee,flussi comunicativi e mediatici, interattività dei new media etc., quelche con la sociosemiotica viene a cadere è la dicotomia – che si sco-pre essere non pertinente – fra ciò che è dell’ordine del ‘testo’ e ciòche invece lo circonda in quanto ‘contesto’, poiché anche quest’ul-timo, se assunto in un coerente progetto di descrizione, ha e può ave-re una sua consistenza semiotica. Laddove la prospettiva linguistica,anche nella sua declinazione pragmatica, sapeva e poteva distingue-re fra fenomeni meramente linguistici e fenomeni extralinguistici,per la sociosemiotica questa differenza non può darsi a priori, poi-ché qualsiasi cosa, materia o situazione, in linea di principio, può es-sere al tempo stesso significativa e sociale, comunicativa e fattuale,
9
cerche che si giustificano nella misura in cui si sottopongono alla costri-zione minima di una solidarietà tra espressione e contenuti, non costi-tuendo dunque in alcun modo una fuga al di fuori della semiosi.
Conclusione:
Se è vero, come dice Hjelmslev, che i dati del linguista si presentanocome un ‘testo’, ciò non è più vero per il semiologo, il quale si occupa an-che di ‘oggetti’, ‘pratiche’ o ‘forme di vita’ che strutturano livelli interidella cultura. Lo slogan greimasiano deve pertanto essere oggi riformu-lato così: «al di fuori delle semiotiche-oggetto non c’è salvezza» – salvopoi assumerci il compito di definire tali ‘semiotiche-oggetto’.
L’abbandono della posizione cosiddetta ‘testualista’ porta cosìFontanille a una vera e propria re-ontologizzazione del testo, ossia auna nozione di testo come oggetto-opera da studiare nella sua im-manenza e sulla base di una sua preventiva chiusura, dunque comeun qualcosa da poter eccedere in nome di altre semiotiche-oggettoda definire come tali, ma certamente non assimilabili ai principi for-mali della testualità, nonché ai suoi formati standard. Esisterebbequalcosa come un ‘fuori testo’ che può essere oggetto di indagine se-miotica, mantenendo a quest’ultima una sua ‘salvezza’ epistemolo-gica. Così, la nozione di testo appare oggi fortemente in crisi neglistudi semiotici: viene messa in discussione in nome di un avanza-mento della teoria che, supportando le pressanti richieste di un al-largamento del campo d’indagine, finisce con il configurarsi comeun ritorno indietro nel tempo, e nella teoria medesima. A vacillare èproprio quella sociosemiotica che s’era concordemente affermatanegli studi semiolinguistici avanzati per risolvere i problemi teoricidella semiologia strutturalista: ovvero di quella teoria che, ragionan-do in termini di segno e di codice, pensava la scienza delle significa-zioni come un’estensione dei modelli linguistici saussuriani a ogget-ti sociali non linguistici: dalla moda alla pubblicità, dal cinema allastampa. La semiotica del testo appare oggi a molti semiologi comel’arte appariva a Hegel – una ‘cosa del passato’ – poiché non sembrain grado di gestire né le nuove istanze della cultura mediatica con-temporanea (dove il testo chiuso sembra non aver più corso) né lenuove esigenze epistemologiche della teoria semiotica (sociosemio-tica, studio della percezione, del corpo, delle nuove tecnologie co-municative etc.). L’imbarazzo provocato da questa situazione con-
8
realtà, finzioni e verità, contro cui la semiotica – e prima di essa lafilosofia fenomenologica e gran parte delle ricerche novecenteschenelle scienze umane e sociali – ha da sempre, e per forza di cose,combattuto.
Insomma, per quanto paradossalmente, l’allargamento progres-sivo del campo d’investigazione testuale attuato dalla sociosemioti-ca, il passaggio silenzioso dal testo-opera al testo-modello ha finitoper mettere in discussione la possibilità stessa di usare il termine ‘te-sto’ per designare il campo precipuo dell’analisi semiotica. E, con-seguentemente, ha condotto alcuni studiosi a reclamare un oltre-passamento del testo in nome di altre, più efficaci entità semiotichecome le attività individuali (cucinare un piatto, fumare un sigaro,passeggiare) o rituali (far la spesa al supermercato, parlare al telefo-no), ma anche esperienze in qualche modo intime (danzare, ridereinsieme, assaporare un vino). Ci sarebbero, secondo questa recenteprospettiva di ricerca, oggetti semiotici al di là del testo dei quali lateoria deve poter rendere conto, approntando nuovi, più sofisticatimodelli di descrizione. Le sollecitazioni che ci giungono dal mondodelle nuove tecnologie comunicative, da internet, dalle pratiche in-ter- e cross-mediatiche contemporanee di remake e remix non sa-rebbero per esempio analizzabili con gli strumenti della semioticastandard, di una semiotica testuale, dunque in fin dei conti tropporigidamente ‘testualista’. Ecco in proposito – tra i numerosi esempipossibili nella letteratura semiotica più recente – alcuni passi d’unarticolo di Jacques Fontanille:
«al di fuori del testo non c’è salvezza» è uno slogan che ha fatto il suo tem-po.
Dato che
la pratica semiotica stessa ha largamente oltrepassato i limiti testuali, inte-ressandosi, da una ventina d’anni a questa parte, all’architettura, all’urba-nistica, al design degli oggetti, alle strategie di mercato, o ancora alla de-gustazione di un sigaro o di un vino e, più generalmente, alla costruzionedi una semiotica delle situazioni e anche, oggi, dell’esperienza, a partire dauna problematica del contagio, dell’aggiustamento estetico, dell’alea.
Sembra dunque giunta l’ora di ridefinire la natura di ciò di cui si oc-cupa la semiotica (le ‘semiotiche-oggetto’), [...] per assumere teorica-mente queste multiple e necessarie ricerche condotte fuori dal testo, ri-
11
l’altro. Da qui le impasses terminologiche, metodologiche e teoricheche oggi – rispetto alla nozione di testo – la ricerca sociosemiotica staimboccando. E da qui la necessità di ricostruire il doppio movimen-to definitorio che dal linguaggio comune porta al metalinguaggio(senza cancellarne del tutto le valorizzazioni sociali implicite) e, vice-versa, da quest’ultimo torna verso la parlata quotidiana (senza assu-merne sino in fondo le valenze operative).
Di conseguenza, più che la natura o l’autenticità della cosa, ciinteresseranno di primo acchito gli usi semantici del termine nellalingua comune, per poi indagare se e in che modo la reinterpreta-zione di tale termine entro il metalinguaggio semio-linguistico nontracimi – più o meno consapevolmente – alcune sue connotazionitanto forti quanto silenziose. Ogni cultura e ogni società, forse ognidiscorso, definiscono a livello connotativo alcune entità culturalicome testi e altre come non-testi, istituendo un’opposizione di prin-cipio e diversamente graduandola al suo interno. E ogni cultura, so-cietà, discorso stabiliscono altresì le ragioni per cui queste deter-minate entità (poniamo, un libro, una legge, un codice miniato etc.)sono testi, mentre altre (un quadro, una piazza, un centro com-merciale etc.) non possono essere definiti tali. Le definizioni dei di-zionari – espansioni semantiche di denominazioni iperconcentrate– possono allora, nella loro determinazione storica e culturale, es-serci d’aiuto: punto di partenza consapevolmente arbitrario e tatti-camente proficuo d’una ricognizione semiotica dalle mille ramifi-cazioni.
Per esempio, fra i molti dizionari consultabili, nel Devoto-Oli al-la voce «Testo» troviamo:
testo (tè.sto) s.m. 1. Il contenuto di uno scritto, spec. in rapporto alla suaintegrità e funzionalità formale: il t. di una lettera, di un racconto, di undocumento; t. a stampa; t. commentato; pubblicare il t. di una sentenza; t.giuridico, legislativo. L’originale rispetto alla traduzione: traduzione col t.a fronte - In tipografia: caratteri di t. ordinari; tavola fuori t. • In musica,può indicare sia le parole alle quali è stata adattata la musica (lauda a trevoci su t. del sec. XIII), sia la parte, in recitativo, dello storico o narratorenegli oratori e nelle passioni. 2. estens. Opera, o singolo passo di un’ope-ra, cui si riconosce funzionalità specifica, importanza eccezionale o ancheautorità indiscussa: i t. classici; i t. sacri; testi di lingua; far t., costituireesempio paradigmatico, anche a proposito di persone: un trattato, un au-tore che fa t. - Enunciato o documento in quanto oggetto di indagine lin-guistica o filologica: critica del t. • Libri di t., quelli adottati nelle scuole
10
duce a porsi una serie di interrogativi: un’analisi semiotica dei feno-meni sociali impone un superamento dei limiti del testo? per ritro-vare che cosa? che cosa c’è al di fuori del testo? i contesti? le situa-zioni? le forme di vita? l’esperienza? Altrimenti, in nome di qualeidea di testo occorre restare all’interno di questi limiti? quali sono lecondizioni per continuare a conservare l’idea di un testo come mo-dello formale per la spiegazione di tutti gli oggetti di studio della se-miotica? Ossia, a ben pensarci: quali sono le condizioni per impor-tare all’interno della semiotica un altro slogan molto celebre – «il n’ya pas de hors-texte» (Derrida) –, già abbondantemente discusso nel-la teoria letteraria e nella filosofia cosiddetta post-strutturalista?
La sociosemiotica, e con essa la semiotica tout court, sembra in-somma arrivata a un bivio, imbarazzante per certi versi, decisivo peraltri. Una scelta che, prima d’esser fatta, va adeguatamente medita-ta. Una rapida ricognizione della genealogia della nozione semioticadi testo diviene così necessaria.
2. Senso comune e linguaggio
La genealogia del testo a cui pensiamo non vuol essere né un’archeo-logia (ricerca di un’origine – etimologica, contrattuale, storica oquant’altro – implicitamente essenziale e veritiera) né una storiogra-fia (ricostruzione cronologica di una trasformazione concettuale piùo meno unidirezionale). Le tappe di tale genealogia non seguirannopertanto una linea temporale né ambiranno a esaustività. Travalican-do steccati disciplinari, intercedendo fra regimi d’enunciazione teo-rica spesso non comunicanti, traducendo modelli epistemologici tra-dizionalmente considerati incommensurabili, proveremo ad accer-chiare tatticamente una nozione come quella di testo, la quale aspet-ta, prima ancora che d’essere definita in termini metalinguistici, di ve-nire posizionata in un campo di manovre qual è quello della sociose-miotica che vuol essere critico e analitico, polemico e descrittivo, so-spettoso e metodologico al tempo stesso. Le spirali che ci toccherà di-segnare, le ripetizioni e riformulazioni cui andremo incontro, le ri-modulazioni concettuali che incontreremo serviranno a far emergerei punti essenziali e critici di un processo abbastanza curioso: quelloche ha portato al successo di un termine e di una categoria il cui si-gnificato continua però a insinuarsi tra il metalinguaggio costruitodalla linguistica o dalla semiotica e il linguaggio comune che indiret-tamente lo supporta, finendo per non appartenere né all’uno né al-
13
a cadere), che dovrà volente o nolente ingaggiare una vera e proprialotta contro l’idea di testo del senso comune, e contro le connota-zioni autoritaristiche e metafisiche in essa presenti. Il testo, ci ricor-dano i dizionari, è il custode materiale dell’opera, la garanzia dellasua significazione univoca, la certezza che il senso d’ogni azione emanifestazione comunicativa non può circolare indisturbato per imeandri del discorso culturale poiché c’è pur sempre una base ma-teriale – la scrittura, con il suo ordine sequenziale di lettere e di se-gni – dalla quale essa non potrà distaccarsi del tutto. Il testo attesta,fa testo, distinguendosi da altre possibili sostanze espressive – l’im-magine e la musica, innanzitutto – e rivendicando l’implicito prima-to veritativo della lingua verbale, grazie alla prerogativa di cui soloquest’ultima godrebbe: saper fissarsi in supporto scritto, per defini-zione stabile e duraturo, agganciato a una qualche istituzione socia-le (giuridica, sacrale, scolastica, accademica), prodotto di un preci-so autore, garanzia di verità.
L’idea di testo del senso comune presuppone così una concezio-ne molto rigida della significazione, che distingue tra spiritualità edempiria, fissando nel basamento scrittorio la loro relazione gerar-chica: da una parte (più in alto) sta la riflessione concettuale, il pen-siero puro, l’opera dell’ingegno creativo; dall’altra (più in basso) sipone la loro traccia materiale, l’oggettualità empirica della loro evi-denza funzionale, della loro comunicazione esterna ed estrinseca. Edè in ragione di questo metafisico convincimento riguardante il lin-guaggio e il senso – implicito nella nozione comune di testo – chevengono ricusate tecniche come la retorica e la poetica (legate allaparola parlata e all’invenzione letteraria), legandosi invece a pratichescientifiche fra loro non comunicanti come la filologia (preoccupatadi restituire, con la materialità del testo, la legalità della lettera) e l’er-meneutica (il cui intento è far risaltare l’unicità del significato e il suovalore sacrale, autoritario). Vedremo come sia proprio a partire daqueste due discipline – e soprattutto ai ripensamenti interni che es-se hanno subìto – che la percezione diffusa della testualità progres-sivamente si sposta e si allarga. Al punto che, inseguendo il movi-mento inverso che dal metalinguaggio si dirige verso il linguaggio or-dinario, i lessici iniziano a includere nella lista dei possibili significa-ti del termine ‘testo’ anche le sue accezioni più tecniche, le quali, gra-zie al variegato lavoro e alla ambivalente fortuna delle arti e scienzedel testo, progressivamente si diffondono al di là dei loro ambiti di-sciplinari. Così, nel dizionario di De Mauro viene finalmente fuori
12
come basi per l’insegnamento delle varie discipline • T. unico, raccoltacoordinata di tutte le regole che disciplinano una determinata materia.[Dal lat. textus –us ‘intreccio’].
La complessità del brano rende sufficiente la sua unica presenzain questa trattazione. Come molti altri dizionari della lingua italiana,il Devoto-Oli tende programmaticamente a distinguere una defini-zione tecnica da una più sociale (sebbene in entrambe torni la fati-dica «funzionalità»). All’interno di queste due grandi aree semanti-che i principi impliciti cui ci si riferisce per individuare i significatidel termine ‘testo’ sono molto diversi. Lo si vede dagli esempi ri-portati, dove si mescolano, per quel che riguarda la prima area, cri-teri legati al contenuto (il t. di una lettera, di un racconto, di un do-cumento) con altri connessi solo a una parte del contenuto, ritenutapiù importante, e da distinguere da qualche altra sua parte che, nonessendo ‘testo’, diviene gerarchicamente inferiore (t. commentato);ma anche criteri riferiti al medium (t. a stampa, caratteri di t., tavolefuori t.) con criteri collegati alla sostanza dell’espressione (in musicalauda a tre voci su t. del sec. XIII, ma anche «la parte, in recitativo,dello storico o narratore negli oratori o nelle passioni») e altri legatiinvece alla forma dell’espressione (pubblicare il t. di una sentenza;«L’originale rispetto alla traduzione», t. a fronte); criteri legati al ge-nere discorsivo (t. giuridico, legislativo). La seconda area, più socio-linguistica, insiste sulla questione della gerarchia culturale fra testi(t. classici, t. sacri, libri di t., critica del t.) o implicitamente fra testi enon testi (far t., libro di t.). Il richiamo all’«importanza eccezionale»e all’«autorità indiscussa» è centrale. E ci accorgeremo come questavalorizzazione sociale rimanga sottotraccia in alcune definizioni tec-niche della testualità, nonché nelle parallele critiche all’uso indiscri-minato di tale nozione.
Al di là di questa testimonianza di polisemia insita nel termine ingioco, resta costante nella definizione dizionariale l’ancoraggio allalingua verbale (opposta per esempio alla musica) e, in essa, alla scrit-tura, che domina incontrastata ospite, ora declinata nelle sue formesostanziali (a mano, a stampa etc.), ora nei suoi ruoli funzionali (il te-sto unico di una serie legislativa), ora nelle sue valenze culturali (ilfare testo e l’attestazione). Da qui occorrerà partire per la ridefini-zione tecnica del termine nel metalinguaggio della linguistica prima(che include nel testo anche e innanzitutto l’oralità) e della semioti-ca poi (per la quale l’attenzione esclusiva alla sostanza verbale viene
15
3. Dalla filologia alla linguistica
L’attenzione scientifica per la testualità segue innanzitutto una dop-pia pista, per così dire, naturale. Da una parte gli studi filologici, en-tro cui si sviluppa la cosiddetta critica del testo. Dall’altra gli studi lin-guistici, al cui interno si costituisce una vera e propria linguistica te-stuale e, parallelamente, si diparte una critica letteraria immanente al-l’opera. Di entrambe queste direzioni di ricerca discuteremo esclusi-vamente quel che concerne le ricadute che esse possono avere per ilfocus semiotico che stiamo tenendo al centro della nostra attenzione.
Per ciò che riguarda la filologia, appare evidente come, in gene-rale, si tratti di una disciplina che va alla ricerca dell’autenticità di untesto materiale appartenente a un passato più o meno remoto che gliaccadimenti storici, sociali e culturali hanno in vario modo cancellato.L’operazione filologica ha uno scopo molto preciso (la paziente ri-costituzione di un testo originale di cui si son perse le tracce e,spesso, la presenza fisica), e presuppone alcune idee estetiche e me-tafisiche altrettanto precise (funzione autoriale, univocità della si-gnificazione, esistenza di un’oggettività e di una verità ultima). Essaha a che fare con un testo in quanto supporto fisico – libro, codice,manoscritto etc. – la cui ‘lezione’, comparata con tutte le altre rin-tracciabili, porta alla restituzione di qualcosa come un Testo ideale,quello originariamente scritto da un autore, qualora se ne individuil’esistenza, o il più vicino possibile con gli intendimenti autentici diun’epoca, un genere, uno stile etc. Tra il testo empirico e il Testoideale si dà pertanto una sospensione, una distanza, una discontinuità:le quali, per quanto si provi a superarle, restano comunque inelimi-nabili. L’acribia del filologo, che mira a far coincidere il Testo idealecon il testo empirico, finisce per trasformarsi in brillante, irrealizza-bile utopia. Non tanto, o non soltanto, per eventuale imperizia, perragioni statistiche, per diffrazione storico-ermeneutica, quanto per unprincipio costitutivo del linguaggio e della significazione: quello percui la relazione fra i due piani del linguaggio non è un accostamentoarbitrario fra un supporto materiale qualsiasi e una configurazioneconcettuale ‘pura’, ma una presupposizione reciproca di due formeche ri-articolano due sostanze. In tal modo un’eventuale perfetta ri-composizione del testo materiale (che è questione di sostanza espres-siva) non si fa automatica garanzia di una ricostituzione del Testoideale (che è questione di forme, dell’espressione ma anche e sopra-tutto del contenuto).
14
una definizione di ‘testo’ come «enunciato complesso, orale o scrit-to, considerato un’entità unitaria in base a proprietà particolari qua-li la compattezza morfosintattica e l’unità di significato», che ritro-veremo pertinente alla linguistica testuale. Finché nei meandri inde-terminati di Wikipedia, portatrice di una scienza pop senza autore oconfini, ma con un immenso desiderio d’ordine e innovatività, ritro-viamo le certezze e le oscillazioni di tanta semiotica contemporanea:
testo, dal latino textus (con significato originario di tessuto o trama), è uninsieme di parole, correlate tra loro per costituire un’unità logico-concet-tuale. Con il termine ‘testo’ si può anche indicare un insieme di segni qua-li: gesti, espressioni facciali, modi di esprimersi; in un certo senso è possi-bile definire il testo come un qualsiasi mezzo di comunicazione. Tra i varitipi di testo, quello più importante è sicuramente quello narrativo, in quan-to l’unico a essere riconosciuto come tale. Un testo si differenzia da un in-sieme di parole giustapposte casualmente in base alla presenza, in esso, diuna finalità comunicativa, riconoscibile da un lettore di media cultura.
L’estensore anonimo della voce di Wikipedia, linguisticamenteinformato e semioticamente competente, abbandona ogni presuntaprimarietà del supporto scrittorio; si apre ad altre materie dell’e-spressione (gesti, espressioni facciali etc.); manifesta un’attenzioneparticolare alla superficie transfrastica di tipo narrativo. Il tutto sen-za eliminare il privilegio della dimensione verbale, e ancorandosi alrassicurante teleologismo della comunicazione: soltanto ciò che è in-tenzionalmente espresso a scopi comunicativi, secondo Wikipedia,può essere testo; in altre parole: un film, un quotidiano, una canzo-ne, un fumetto, una conversazione possono essere considerati testi,a condizione che non si tratti di una giustapposizione casuale di se-gni ma di un insieme organizzato di elementi in vista di uno scopomolto preciso, quello della trasmissione intenzionale di un messag-gio. Ciò che manca è il passo successivo: quello di includere entrotale definizione la dimensione collettiva, non autoriale e soprattuttonon intenzionale della significazione sociale e culturale, in modo dacomprendere entro la categoria del testo qualsiasi fenomeno socialee culturale dotato di senso, fornito di un qualche supporto espressi-vo solidale con un qualche contenuto significato. Un successivo fre-quentatore di Wikipedia, più ferrato in sociosemiotica, forse un gior-no lo farà – avendo magari in mente le tappe concettuali che dob-biamo adesso passare a enucleare.
17
dagine, a prescindere dalla sostanza espressiva assunta da tale rea-lizzazione. La celebre definizione hjelmsleviana di testo – «una sin-tagmatica le cui catene, se si espandono indefinitamente, sono ma-nifestate da tutte le materie» – apre alla semiotica come studio diqualsiasi sistema di significazione, linguistico e non, proprio perchéa essere pertinente per essa è la forma e non la sostanza. Non chiari-sce tuttavia, in senso stretto, che cosa sia un testo, né quali siano lecondizioni minime della sua esistenza.
Un passo in avanti in questo senso compie la linguistica testualeche, nelle sue innumerevoli versioni teoriche e metodologiche (vanDijk, Petöfi, Dressler, Schmidt, Weinrich, Coseriu etc.), parte dal-l’assunto secondo cui occorre superare quei limiti della frase comeoggetto unico e ultimo dell’indagine che l’antica tradizione norma-tiva della grammatica, rinnovata dai successi del generativismo chom-skiano, ha posto. Che cosa accade al di là della frase? quali sono ledimensioni e le forme di un enunciato linguistico il cui senso non siesaurisce nella sua dimensione frastica? quali gli elementi formaliche compattano fra loro un insieme di frasi sino al punto da far ap-parire un’unità linguistica superiore qual è, appunto, il testo? Da quil’individuazione di una serie di regole (anafora, deissi, coreferenza,topicalizzazione, isotopia etc.) e di principi (coerenza, coesione,informatività etc.) che, riattualizzando alcune procedure della mille-naria arte retorica, finiscono per scontrarsi con una doppia diffi-coltà. Innanzitutto, l’analisi transfrastica continua implicitamente aconsiderare la frase come elemento centrale della lingua, di fatto ipo-statizzandola; di modo che il testo finisce per essere inteso come unasuccessione coerente di frasi, una specie di ‘superfrase’ priva di rea-le autonomia grammaticale e semantica. In secondo luogo, andandoalla ricerca di una realtà testuale come accumulo, per quanto coesoe coerente, di frasi, la linguistica testuale si trova costretta a invoca-re criteri e procedure che trascendono l’ordine linguistico stesso, co-me l’intenzionalità comunicativa del parlante, l’accettabilità seman-tica da parte del destinatario, la dimensione psicologica e cognitivadei soggetti coinvolti, il contesto situazionale e pragmatico, la con-dizione ermeneutica della interpretazione, lo sfondo referenziale ecosì via. Il testo resta sospeso fra l’interno e l’esterno della lingua,sorta di ambigua interfaccia fra il dire e il fare, le parole e le cose che,in fin dei conti, non sta né da un lato né dall’altro.
Si vede bene come, in entrambi i casi, il testo venga più invocatocome necessità che realmente individuato e circoscritto in quanto
16
Non è un caso se uno studioso come Cesare Segre, pur rivendi-cando l’importanza dell’atteggiamento e dell’esperienza filologiciper gli studi semiotici e la loro etica di ricerca, abbia insistito sul fat-to che nessun testo (empiricamente dato mediante la scrittura) puòessere identificato con il Testo (culturalmente e storicamente deter-minato), persino nei casi in cui si riesca fortunosamente a ritrovareil manoscritto originario scritto di pugno dal suo autore. Non soloperché ogni trascrizione, compresa quella dell’autore, è una modifi-cazione del Testo originario, ma anche perché la lettura, ivi compre-sa quella della critica testuale, è culturalmente situata, dunque sog-getta a codici culturali in continuo cambiamento. Tra input e outputcomunicativi c’è sempre uno scarto. Un testo, ripete Segre con Aval-le, non è una cosa, un oggetto, un supporto fisico ma un’«immaginementale», ora dell’autore, ora del lettore, ora del filologo, in una con-tinua negoziazione fra istanze individuali e collettive, storiche e so-ciali. Scopo del filologo è allora quello di stabilire una nuova imma-gine del testo, esplicitando le pertinenze della propria analisi rico-struttiva (uno stile individuale, un genere, un’epoca storica etc.) e as-sumendosene la responsabilità. Al punto che, dice Segre, lo studio-so non ritrova testi già dati e perduti ma li (ri)costruisce da sé, po-nendo esso stesso i limiti del testo, i suoi significati, i suoi valori cul-turali. Accade così che la filologia, se pure con motivazioni erme-neutiche e pragmatiche, assuma nei riguardi del testo un atteggia-mento anti-ontologico che sfida l’opinione comune. «Ogni testo –scrive Segre – è la voce di un mondo lontano che noi cerchiamo diricostruire». Non dunque uno scritto ma una voce, non un autorema un mondo: è così che il testo comincia a sganciarsi dalla sua ba-se scrittoria, perdendo gran parte di quelle connotazioni sacrali e au-toritaristiche che il dizionario ci aveva segnalato, e acquistando in-vece uno spessore socioantropologico di grande rilievo.
Colpisce invece che nell’ambito degli studi linguistici si sia arri-vati relativamente tardi alla nozione di testo, in qualche modo ag-ganciandosi alle conclusioni teoriche della pratica e della riflessionefilologiche. La nozione di testo sorge spontaneamente alla coscien-za del linguista solo quando ci si avvede, con Hjelmslev, che lo stu-dio della lingua come sistema formale («entità autonoma di dipen-denze interne») trascende l’opposizione fra oralità e scrittura: op-posizione che, come s’è visto, è questione di sostanze e non di for-me, pertanto estrinseca all’analisi strutturale. Il testo, per Hjelmslev,è la realizzazione del sistema, ciò a partire da cui inizia il lavoro d’in-
19
semiotiche, è stato però tanto produttivo in termini di risultati quan-to poco esplicitato dal punto di vista teorico e metodologico. Fra lafine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, si parla sempre menodi codici e sempre più di testi, ma non viene sufficientemente spie-gato il senso di questo passaggio terminologico, che sottende unaprofonda modificazione concettuale, se non una predisposizioneepistemologica del tutto nuova. Facendo riferimento, esplicito o im-plicito, a direzioni di ricerca anche molto diverse fra loro – dalla fi-lologia alla sociologia dei media, dalla glossematica alla linguisticatestuale, dalla pragmatica della comunicazione all’analisi del discor-so, dalla scienza letteraria alla narratologia, dalla teoria degli atti lin-guistici alla retorica e all’ermeneutica – i semiologi hanno adopera-to il termine ‘testo’ senza spesso definirlo, e in ogni caso intendendocon esso entità e fenomeni spesso non comparabili: avendo in men-te ora il modello linguistico, ora quello comunicazionale, ora quelloletterario e così via. Da qui, molto probabilmente, gran parte degliequivoci di cui si diceva all’inizio di questo capitolo, e i vicoli ciechida cui la sociosemiotica tarda a uscire.
Basti adesso, per tornare alla nostra ricostruzione genealogica edesplicitare alcuni dei passaggi rimasti allora non detti, riprendere duepunti chiave. Il primo è l’opposizione fra opera/testo rivendicata daRoland Barthes. Per quanto posta entro un contesto fondamental-mente letterario, e intessuta di riferimenti alla psicanalisi lacaniana,allo sperimentalismo artistico di Tel Quel e al dibattito politico di fi-ne anni Sessanta, la distinzione barthesiana fra opera e testo si rivelaoggi di straordinaria chiarezza e utilità, non foss’altro che per com-prendere cosa in quel periodo si intendesse quando si parlava di te-stualità. Innanzitutto, perché si tratta di una definizione relazionalee sistemica, dove il testo non viene definito in quanto tale ma in fun-zione di quel suo opposto simmetrico che è l’opera. In secondo luo-go, perché non si tratta di una distinzione fra cose ma fra sguardi,non considera assetti ontologici ma metodologici e teorici. Opera etesto sono due punti di vista dissonanti che, dirigendosi verso il me-desimo oggetto, finiscono per costruirlo in modi molto diversi. L’o-pera, infatti, è l’opera letteraria con tutti i crismi che l’aura estetica leconferisce: autorialità, sacralità, univocità significativa, iscrizione en-tro una tavola precostituita di generi, riferimento a un canone valo-riale e antropologico, una certa presunzione di obiettività. Il testo èuna visione diversa sul medesimo oggetto che mira innanzitutto a farsparire tale presunta obiettualità, e quindi il fatto di poter essere col-
18
oggetto autonomo d’analisi linguistica. Sia Hjelmslev sia la linguisti-ca testuale lo definiscono in negativo – ora per contrastare la prima-rietà della scrittura ora per opporsi ai limiti frastici –, senza fargli as-sumere il ruolo che realmente esso gioca nella comunicazione lin-guistica: quello di entità, per così dire, naturale, enunciato compiu-to, prodotto linguistico globale a partire da cui prendono forma esenso gli elementi locali che stanno al suo interno – ivi compresa lafrase – nonché assumono consistenza e valore le realtà a esso ester-ne come il genere discorsivo, il contesto situazionale o l’orizzonte er-meneutico. Affinché il testo possa assumere questa posizione cen-trale, rispetto ai suoi elementi intrinseci e alle sue polarità estrinse-che, è necessario invece che venga trattato soprattutto a partire dal-la sua dimensione semantica, adeguatamente supportata da specifi-che forme dell’espressione: che sia inteso cioè come un ‘tutto di si-gnificazione’, un’unità comunicativa globale, con una propria arti-colazione interna, una specifica gerarchia fra le sue parti, una pro-pria dimensione cognitiva e pragmatica, senza relazioni ancillari conrealtà esterne di qualsiasi tipo.
4. Estetica e metodologia
Numerose sono le direzioni di ricerca che, in linguistica, hanno pro-vato e provano ad affrontare la questione secondo una prospettivasemantica, sia proponendo nuove ipotesi teoriche (analisi del di-scorso, teoria degli atti linguistici, narratologia) sia, spesso o con-temporaneamente, riprendendo spunti e intuizioni di discipline piùtradizionali come la stilistica, la retorica, la poetica, la critica lettera-ria. La semiotica matura, per superare le evidenti impasses teorichederivanti dalle nozioni di segno e di codice, ma soprattutto per af-francarsi dalla sudditanza nei confronti del modello linguistico, haprovato a far dialogare questi diversi indirizzi di ricerca, ponendo iltesto come proprio specifico oggetto di conoscenza: e passando, co-me si dice con una formula sbrigativa, da una semiotica dei codici auna semiotica dei testi. Il testo, in semiotica, diviene una configura-zione complessiva di senso che, facendo ricorso a un qualche sup-porto espressivo, si fa garante della generazione, della circolazione edella interpretazione dei significati sociali e culturali. Configurazio-ne che ogni cultura istituzionalizza in vario modo, e che l’analisi de-ve saper e poter ricostruire.
Il passaggio dallo studio dei segni a quello dei testi, nelle ricerche
21
L’altro punto chiave su cui dobbiamo soffermarci, apparente-mente distante dalla posizione barthesiana, è lo studio della discor-sività e della narrazione. Anch’esso parte, come si sa, dai formalistirussi e da Propp e, attraverso studi comparatistici in etnologia, sto-ria delle religioni, folklore, letteratura e paraletteratura, comunica-zioni di massa, cinema e quant’altro, arriva alla costruzione di unagrammatica narrativa e di una sintassi discorsiva (Greimas). Quelche ci interessa adesso è però il momento in cui lo studio del discorsoe del racconto confluiscono entro il campo di ricerca della semioti-ca per affrontare i problemi semantici della testualità. Dinnanzi ai vi-coli ciechi della sintassi transfrastica, l’unica via per delineare la fi-sionomia di un testo sembra essere la ricostruzione della sua strut-tura semantica; la quale non può esaurirsi nella elencazione dei le-gami anaforici o coreferenziali fra parole e frasi. Il testo ha una suaarticolazione unitaria di senso, che fa riferimento a una serie di tipo-logie possibili – descrizione, argomentazione, dimostrazione etc. –,dove la narratività sembra avere un ruolo di primo piano. Non tan-to perché molti testi hanno valenze narrative esplicite, quanto per-ché anche testi apparentemente d’altro tipo rispettano forme e pro-cedure di tipo narrativo: processualità interna, polemica fra forze ingioco, trasformazione finale e via dicendo. Così Eco arriva a indica-re come l’Ethica di Spinoza, per quanto dimostrata more geometrico,sottenda una struttura narrativa; o Greimas rileva come una certadescrizione in Maupassant sia in realtà una mossa molto precisa al-l’interno di un racconto. Ed entrambi lo fanno proprio per far vale-re l’idea di una testualità autonoma sganciata dalla superficie di tipolinguistico, e ancorata invece a procedure semiotiche che in profon-dità ne configurano il senso.
Analogamente, al di sotto del testo soggiace un discorso, che con-tribuisce alla costituzione della sua struttura semantica unitaria.Spesso i termini ‘testo’ e ‘discorso’ vengono intesi come sinonimi,entrambi espressioni di occorrenze linguistiche che superano la fra-se, privilegiando a seconda delle tradizioni di ricerca ora un termineora l’altro, e finendo in qualche caso per riattribuire al primo la so-stanza scrittoria e al secondo quella orale. In molti altri casi invece siusa il termine ‘discorso’ per insistere sulla dimensione comunicativadel testo linguistico, lavorando ora sui modi in cui le forme lingui-stiche vengono usate nelle circostanze comunicative (pragmatica),ora invece sul modo in cui le lingue grammaticalizzano le proprie cir-costanze d’emissione e di ricezione, prefigurando al proprio interno
20
locato su uno scaffale, individuato entro un genere, ricondotto a unautore, circoscritto in una visione estetizzante. Il testo, dice Barthes,è l’assunzione della primarietà del metodo sull’oggetto, un «campometodologico» che per forza di cose moltiplica gli sguardi possibili,le letture, i significati. Per questo, ripete spesso Barthes, il testo è plu-rale: non tanto perché è un’opera aperta, soggetta per principio amolteplici interpretazioni; quanto perché esso ritiene, con strategicamodestia, che altre letture e altri metodi sono egualmente possibili,a condizione che si esplicitino le loro condizioni di esercizio, e primaancora il loro essere innanzitutto metodo e non cose, sguardi e nonfenomeni empirici. Se l’opera viene consumata, il testo produce. Daqui l’idea che un testo non si oppone alle pratiche, per la semplice ra-gione che esso stesso è, in primo luogo, una «pratica significante»,una produzione (Kristeva), un modo di far emergere – come l’aru-spice che punta il cielo con un bastone (senza per questo assumerele connotazioni sociali negative che oggi investono un tale gesto) –flussi di senso, assumendosi il carico di spiegarne le procedure for-mali, le pieghe linguistiche, i giochi retorici. Non esistono limiti pre-costituiti del testo, confini oggettivi del suo dipanarsi, poiché in essosono compresi molteplici «prospettive di citazioni», innumerevoli al-tri testi che dialogano con esso, al suo interno e al suo esterno. Il te-sto sfuma nell’intertestualità, così come quest’ultima è già al suo in-terno. È l’assetto culturale, più o meno istituzionalizzato, più o me-no silenzioso, a dettare i confini del testo e a costituire al suo esternole catene intertestuali. Assetto che lo sguardo metodologico dell’os-servatore deve preoccuparsi di individuare, additandone se occorrela valenza politica. Lo sguardo immanente del critico, sul quale daiformalisti russi in poi s’è tanto insistito, non è l’assunzione cieca deilimiti che le istituzioni culturali conferiscono all’opera, ma la costru-zione problematica di soglie liminari – come tali rivedibili – di cui l’a-nalista si assume la paternità e la responsabilità. L’immanenza non èdata ma costruita. In questo quadro va intesa la pratica d’analisi te-stuale dello stesso Barthes, che in scritti come S/Z rivendica la diffe-renza del singolo testo – un racconto di Balzac come un haiku giap-ponese – rispetto alle strutture profonde che lo accomunano ad altritesti consimili. Non si tratta di una pretesa di originalità estetica, cheriproporrebbe la nozione di opera, ma di una opzione teorica cheesalta le procedure metodologiche atte a far affiorare le moltepliciforme – retoriche, stilistiche, linguistiche etc. – mediante cui da ognitesto emana il flusso del senso.
23
ora emergendo ora sparendo, trasformandosi di continuo, dando luo-go a comprensioni e fraintendimenti, traduzioni e infedeltà.
Tale passo, però, almeno in un primo tempo non è stato per lopiù compiuto, o quanto meno non è stato compiuto esplicitamente:lo si rileva indirettamente negli studi applicativi, nelle ricerche di set-tore, nelle numerose analisi che in vari campi e linguaggi vengonoproposte, ma non viene quasi mai tematizzato e discusso nelle trat-tazioni teoriche e meno che mai nei trattati. Occorrerà attenderel’avvento della sociosemiotica. E forse non basterà.
5. Ermeneutica, decostruzionismo, testualismo
Laddove la filologia e la linguistica sembrano insistere sul versantemateriale del testo, l’ermeneutica, nelle sue varie forme, lavora sulversante opposto: quello del significato e del senso. È come se i duecampi disciplinari si dividessero il territorio del testo – il primo la‘lettera’, il secondo lo ‘spirito’ –, replicando sul piano del linguaggiol’antico dualismo che, sul piano della soggettività, separa il corpodalla mente. Per l’ermeneutica, allora, il contenuto testuale non sca-turisce da una solidarietà costitutiva con il piano espressivo del te-sto, secondo il magistero di Saussure e Hjelmslev, ma da una serie diprocedure anche molto diverse fra loro (psicologiche, logiche, co-gnitive, affettive etc.), tutte per lo più autonome dalla loro costituti-va base linguistica, non vincolate a un qualche tipo di semiosi. In talmodo, quel grosso filone di studi filosofici, largamente discusso, chequanto meno da Heidegger e Gadamer, via Derrida e Rorty, arriva aRicoeur (per citare solo i nomi che costituiscono i principali punti diriferimento del dibattito novecentesco sul tema), instaura una spe-cie di paradosso: rivendica l’importanza costitutiva del linguaggionon solo per la riflessione concettuale ma come mediazione neces-saria per qualsiasi forma di esperienza umana e sociale; sembra tut-tavia disinteressarsi agli insegnamenti delle scienze semiolinguisti-che che, per definizione, del linguaggio provano a descrivere il fun-zionamento interno. Da una parte si insiste sull’idea di una scritturafilosofica, dall’altra si rifiuta la descrizione formale di tale scrittura.Da una parte si sostiene che non c’è nulla al di là del testo, dall’altraci si vieta di indagare cosa c’è dentro questo testo, di cosa è fatto,quali sono le sue articolazioni, le sue ragioni. Per dirla con una bat-tuta: se pure viene ribadito, con Heidegger, che il linguaggio è la ‘ca-sa dell’essere’, nessuno studioso sembra interessarsi all’architettura
22
gli scenari comunicativi (teoria dell’enunciazione). In un modo co-me nell’altro si tende a configurare un insieme di regole specifiche,di natura precipuamente semantica, che costituiscono la testualità,facendone l’unità linguistica di base, il punto di partenza e d’arrivodi ogni fenomeno comunicativo.
Ogni testo, allora, fa propria una struttura semantica che lo tra-scende, accomunandolo e al tempo stesso differenziandolo da altritesti. Da una parte un testo è la manifestazione empirica di un di-scorso e di un racconto profondi, l’emergenza di una cultura socia-le molto più ampia di cui esso si fa testimone. Ciò non implica peròuno schiacciamento del testo nei modelli profondi che, compren-dendolo, lo accomunano a tanti altri testi, cancellandone ogni sin-golarità. Infatti, d’altra parte, un testo può mantenere una propriaspecificità, derivante dal modo in cui esso esplicita localmente strut-ture culturali più ampie di lui. L’esistenza di modelli discorsivi sog-giacenti al testo si fa dunque garanzia della sua circolazione nella sfe-ra culturale e, al tempo stesso, della sua autonomia significativa e deldialogo che esso intrattiene con altri testi.
Come si vede, sembrano esserci già molti elementi teorici percompiere il passo che porta la nozione di testo dall’ambito linguisti-co e letterario a quello più ampiamente comunicativo e semiotico, so-ciale e culturale: emancipazione dal modello scrittorio e in generalelinguistico, individuazione del testo come oggetto centrale di indagi-ne semiolinguistica, primarietà del metodo e conseguente dis-onto-logizzazione della testualità, moltiplicazione dei livelli di senso, privi-legio della semantica... Un passo che dà modo di usare tale nozionecome modello formale per studiare non soltanto occorrenze comuni-cative non verbali (immagini, film, canzoni, audiovisivi di vario ge-nere etc.), come è costitutivo d’una qualsiasi scienza semiotica, maanche fenomeni semiotici come campagne pubblicitarie e strategiepolitiche, rituali quotidiani e non, ampie porzioni di spazio e formedi socializzazione in esso inscritte, agglomerati urbani, pratiche difruizione mediatica e di consumo di beni e servizi, esperienze senso-riali e somatiche, e così via. Non si tratterebbe cioè di analizzare talifenomeni come se fossero dei testi, in qualche modo supponendoun’estensione metaforica del testo linguistico a quello non linguisti-co e non comunicativo. Ma di studiarli perché lo sono: ricostruendocioè la testualità in essi implicita – la struttura semantica soggiacente,discorsiva e narrativa – di tali fenomeni, quella testualità che fa sì cheessi siano dotati di senso, che tale senso circoli nella cultura sociale,
25
altri, per la sociosemiotica qualsiasi materia del mondo può farsi por-tatrice, in circostanze culturali date, di contenuti umani e sociali; o,in altri termini, ogni cultura parla di se stessa a se stessa moltiplican -do i linguaggi per farlo, i quali s’intrecciano fra loro secondo ordinivaloriali mutevoli nello spazio e nel tempo. A ben vedere, però, la ri-flessione ermeneutica può apportare alla sociosemiotica diversi con-tributi teorici e chiarimenti epistemologici. Innanzitutto, come si èdetto, con il rifiuto di ogni scientificità precostituita che fa capo a unontologismo ingenuo e a una concezione rappresentativa e referen-ziale della lingua: il ‘dato’ non è mai primo, poiché esito di una co-struzione culturale nella quale il ruolo dell’osservatore è giocoforzaimplicato; ogni posizione scientifica è situata in una determinazionestorico-culturale che contribuisce alla costruzione del proprio og-getto di conoscenza. Ciò comporta, sul versante semiolinguistico, laconvinzione che il testo non è una realtà empirica data una volta eper tutte – una cosa, un oggetto –, ma una struttura culturale che va-ria conformazione e senso a seconda delle condizioni storiche e so-ciali in cui emerge e dell’ambiente discorsivo in cui circola. E com-porta altresì una messa in gioco del metalinguaggio descrittivo, chenon è modello puro e astratto per ogni genere d’analisi, poiché siconfigura a sua volta come un testo da costruire e analizzare semio-ticamente. Tra linguaggio-oggetto e metalinguaggio, ripetono conBarthes e Derrida i cosiddetti ‘testualisti’ (post-strutturalisti, deco-struzionisti o come altro li si voglia definire), non c’è una reale dif-ferenza di natura ma solo di posizione discorsiva, in quanto tale sog-getta a possibili continue variazioni.
Un altro punto in cui l’ermeneutica contribuisce alla costruzionerigorosa di una sociosemiotica è quello, in qualche modo implicitoin quanto s’è detto sinora, del continuo ricorso a una tradizione chefa da sfondo a ogni occorrenza testuale e al tempo stesso da obietti-vo di qualsiasi atto di comprensione interpretativa. Basta non consi-derare questa tradizione come un canone dato e indiscusso, più omeno sacrale e autoritario, come spesso accade negli studi erme-neutici anche di deriva decostruzionista, i quali finiscono ingenua-mente per ipostatizzare la testualità poetica e letteraria come solu-zione ‘creativa’ a ogni assetto autoritaristico. Sostituendola con unapiù ampia e più generica culturalità (o ‘semiosfera’, come la chiamaeuforicamente Lotman) nella quale i testi si innestano parlandosi fraloro, facendosi ora discorso ora oggetto del discorso, testi e metate-sti che, ricorrendo alla mediazione di qualsiasi sostanza espressiva,
24
di tale casa, alle fondamenta, alla distinzione in ambienti, all’arreda-mento.
C’è una spiegazione di questo paradosso: il rifiuto di quello scien-tismo e oggettivismo che le discipline linguistiche e semiotiche più omeno consapevolmente fanno ancora proprio. L’ermeneutica, comeè noto, nutre una salutare diffidenza nei confronti del metodologi-smo razionalista cartesiano (o, come si usa dire, dell’‘epistemologia’),che molte versioni dello strutturalismo sembrano invece conservare,o non rifiutare esplicitamente. Da qui la scissione fra linguistica edermeneutica, che in nome del testo dovrebbero e potrebbe ro inveceincontrarsi – la prima importando l’interesse verso le strutture te-stuali; la seconda chiarendo la propria posizione epistemologica –,arricchendosi reciprocamente. Ne verrebbe fuori qualcosa come una‘ermeneutica materiale’ (Schleiermacher ripreso da Rastier), ossiauna prospettiva di studi che centrando la propria attenzione sul pro-blema della testualità in tutti i suoi differenti aspetti – filologico-ma-teriale, linguistico-formale, socioculturale, interpretativo-cognitivoetc. – possa superare al contempo le ingenue strettezze dell’empiri-smo e le divagazioni indeterminate dello spiritualismo. Vediamo al-lora un po’ più a fondo cosa gli studi ermeneutici apportano, volen-ti o nolenti, a una semiotica della testualità, e in che modo.
L’ermeneutica, per definizione, è disciplina che dipende a dop-pio filo dalla presenza anteriore di testi: sacri o giuridici prima, let-terari e filosofici dopo, ma in ogni caso da un qualcosa come una tra-dizione culturale consolidata che nei testi – nel senso 2 della defini-zione dizionariale del Devoto-Oli – si deposita, si istituzionalizza, siconsolida; in una parola: si attesta. Secondo tale prospettiva, il testoè manifestazione scritta, traccia rinvigorita e tramandata di una de-terminazione culturale che la trascende. Da qui opzioni teoriche for-ti come quelle relative al circolo ermeneutico (rifiuto d’ogni tabula ra-sa gnoseologica, in nome di un’inevitabile precomprensione delmondo) e alla linguisticità dell’essere o, meglio, del suo intendimen-to (mediazione inevitabile della parola per ogni accesso al mondo).La precomprensione è insomma linguistica, perché fa capo a testiche la tradizione ci rimanda, e che a ben vedere la costituiscono, fa-cendo ricorso a ciò che per definizione sedimenta la memoria (o, sesi vuole, rende vano l’oblio): la scrittura.
Niente sembra più lontano dall’impostazione sociosemiotica. Al-meno in apparenza. Laddove l’ermeneutica rivendica il primato del-la lingua, e con essa di testi scritti per definizione più autorevoli di
27
Per comprendere a fondo tale affermazione, basta osservare davicino il luogo – testuale – in cui viene formulata, che è una fitta di-scussione con Jean-Jacques Rousseau. In Della Grammatologia, perricostruire il pensiero di questo autore, Derrida compie un’opera-zione che, col senno di poi, scopriamo essere genuinamente semio-tica. Non solo, infatti, mette in gioco pressoché l’intera opera diRousseau (definita l’«epoca di Rousseau» – di modo che l’époque èanche un’epoché), dove si mescolano testi filosofici e testi narrativi.In più, entro tale opera non si limita a considerare lo ‘spirito’ dei te-sti (il pensiero del maestro ginevrino), ma prende in carico anche esoprattutto la loro ‘lettera’: la forma linguistico-espressiva, ma ancheargomentativa e narrativa, che, veicolando tale pensiero, gli donauna precisa conformazione semantica. Ne viene fuori un’analisi (o sesi vuole una decostruzione) del corpus dei testi di Rousseau che – edè questo il punto – completa di per sé la ricostruzione del suo intri-cato pensiero: un’analisi che, se e quando ha bisogno di uscir fuorida ogni singolo testo, ne trova un altro a cui appoggiarsi per com-prenderlo meglio.
Ecco il brano in questione, dove emergono alcune considerazio-ni importanti sulle ‘questioni di metodo’ insite nel modo in cui Der-rida legge Rousseau:
se la lettura non deve accontentarsi di raddoppiare il testo, non può le-gittimamente trasgredire il testo verso altro che esso stesso, e non versoun referente (realtà metafisica, storica, psicobiografica, ecc.) o verso unsignificato fuori testo il cui contenuto potrebbe aver luogo fuori dalla lin-gua, cioè, nel senso che diamo a questa parola, fuori dalla scrittura in ge-nerale. [...] Non c’è fuori-testo. E questo non perché la vita di Jean-Jac-ques Rousseau non ci interessi innanzitutto, né l’esistenza di Maman o diTeresa in se stesse, né perché non abbiamo accesso alla loro esistenza co-siddetta ‘reale’ se non nel testo e perché non abbiamo alcun mezzo perfare altrimenti, né alcun diritto di trascurare questa limitazione. Tutte leragioni di questo tipo sarebbero già sufficienti, certo, ma ve ne sono dipiù radicali. Ciò che abbiamo tentato di mostrare seguendo il filo con-duttore del ‘supplemento pericoloso’, è che in ciò che si chiama la vitareale di queste esistenze ‘in carne ed ossa’, al di là di ciò che si crede dipoter circoscrivere come l’opera di Rousseau, e dietro di essa, non c’è maistato altro che scrittura; non ci sono mai stati altro che supplementi, si-gnificati sostitutivi che non hanno potuto sorgere che in una catena di rin-vii differenziali, in quanto il ‘reale’ non sopraggiunge, non si aggiunge senon prendendo senso a partire da una traccia e da un richiamo di sup-
26
acquistano – a seconda dei loro orizzonti antropologici – differentivalori e molteplici funzioni. Se pure la cultura è serbatoio e macchi-na produttrice di testi, al suo interno tali testi non sono affatto tuttiuguali, né hanno il medesimo valore strumentale e discorsivo.
5.1. Il luogo del fuori-testo
Soffermiamoci su due punti problematici in particolare. Il primo èla celeberrima affermazione di Jacques Derrida – divenuta facileslogan del decostruzionismo, e con ciò fonte di rumors d’ogni tipo– per la quale «il n’y a pas de hors-texte». Come già accennato, dalpunto di vista sociosemiotico si tratta di un’affermazione sottoscri-vibile. Essa, infatti, non va ridotta a una ripresa, se pure problema-tica, di un’ermeneutica della tradizione che pone i Testi come ori-gine e fine d’ogni orizzonte di pensiero; né va soltanto intesa comerivendicazione, per quanto perplessa, di una chiusura precostituitadell’universo linguistico, sulla base della quale ci si vieta ogni ri-corso a referenti esterni al sistema della lingua e, con ciò, ogni ap-porto di contesti situazionali di tipo psicologico, sociale, economi-co e quant’altro. Non si tratta cioè di un’esclusiva esasperazionedello strutturalismo che pensa la lingua, alla Hjelmslev, come entitàautonoma di dipendenze interne, di contro all’idea di una corri-spondenza fra parole e cose in quanto criterio ultimo per la indivi-duazione della verità. Né va letta unicamente come un’ulteriore sot-toscrizione del programma di ricerca del primo formalismo russo odel new criticism statunitense, che si impegnano a studiare l’operaletteraria in quanto tale, a prescindere dal suo ambiente di produ-zione o di ricezione. «Il n’y a pas de hors-texte», soprattutto, nonva tradotto con «non c’è niente fuori dal testo», come recita la ver-sione inglese: «there is nothing outside the text» è il modo in cuiGayatri Spivak ha tradotto la frase di Derrida, dando adito a unavulgata decostruzionista che, è stato giustamente notato, ripresentatutti i tratti di una metafisica irriflessa. Il modo in cui va inteso loslogan è soprattutto un altro: non c’è un fuori-testo poiché, uscen-do da un testo, se ne ritrova un altro, e poi un altro ancora, e cosìall’infinito: non esiste altra natura della significazione umana e so-ciale che non prenda la forma di un testo, che non sia dell’ordinedel testuale. A prescindere dalla sostanza espressiva che tale formatestuale si incarica di veicolare. Ogni contesto è sempre un co-te-sto, oppure non è pertinente.
29
Quando parliamo dello scrittore e dello strapiombo della lingua cui èsottomesso, non pensiamo solo allo scrittore nella letteratura. Il filosofo,il cronista, il teorico in generale, e al limite ogni scrittore viene così sor-preso. Ma in ogni caso, lo scrittore è iscritto in un sistema testuale deter-minato. Anche se non c’è mai significato puro, ci sono rapporti differen-ti riguardo a ciò che del significante si dà come strato irriducibile di si-gnificato. Per esempio, il testo filosofico, benché sia di fatto sempre scrit-to, implica, precisamente come sua specificità filosofica il progetto dicancellarsi di fronte al contenuto significato che trasporta e in generaleinsegna. La lettura deve tener conto di questo proposito, anche se in ul-tima analisi intende far apparire il suo scacco. Ora tutta la storia dei te-sti, ed in essa la storia delle forme letterarie in Occidente, deve essere stu-diata da questo punto di vista.
È per questo che Rousseau, o chi per lui, «non si lascia separaredal sistema della sua scrittura». È per questo che lo scrittore «iscri-ve la testualità nel testo». È per questo che, «in qualsiasi parte ci tro-viamo» siamo «già in un testo in cui crediamo di essere». È per que-sto insomma che non c’è fuori-testo. Sarà poi il testualismo, comeconseguentemente lo ha definito Richard Rorty (pensandolo comeerede ironico dell’hegelismo ottocentesco), a declinare in vario mo-do queste riflessioni di Derrida, dando a esse valenze e letture anchemolto diverse, tutte però in qualche modo miranti a un’ipostasi del-la testualità intesa come dimensione scrittoria, traccia linguistica ir-rinunciabile non solo nelle opere letterarie ma anche in quelle filo-sofiche, storiografiche, delle scienze sociali e quant’altro. Ipostasiche ha condotto, come è noto, alla rivendicazione di una totale li-bertà interpretativa del lettore, per giunta privo d’ogni ancoraggiometalinguistico, basata sull’idea – pressoché antitetica a quella quiproposta – per cui non esisterebbe un senso vero del testo ma sol-tanto, ermeneuticamente, i suoi molteplici effetti nel teatro della sto-ria. Il testualismo, insomma, soprattutto nella sua versione strong,come la definisce lo stesso Rorty, non avrebbe alcun rispetto per iltesto in quanto tale, né tantomeno sarebbe interessato alle sue pro-cedure, ai suoi funzionamenti interni: in questo assumendo un’eti-chetta ambigua, che lo oppone drasticamente sia a ogni critica te-stuale (nel senso tradizionale della filologia) sia a una semiotica deltesto (che in seguito, per insipienza della storia, ‘testualista’ verrà de-finita). Eppure, la critica alla nozione di contesto come esterioritàextralinguistica e garanzia veritativa del significato ultimo del testo
28
plemento, ecc. E così all’infinito poiché abbiamo letto, nel testo, che ilpresente assoluto, la natura, ciò che designano le parole ‘madre reale’ecc., si sono già da sempre sottratti, non sono mai esistiti; che ciò che apreil senso ed il linguaggio è questa scrittura come sparizione della presenzanaturale.
Insomma, «non c’è fuori-testo» non significa che non c’è nullafuori del testo, ma, molto diversamente, che non c’è altra esperien-za umana e sociale se non d’ordine testuale. Quel che si chiama mon-do della vita, vissuto concreto, affettività, soggettività intima, corpo-rea e carnale – su cui tanto insiste l’ermeneutica di tipo fenomeno-logico – può venir compreso, se ne può cioè avere una qualche espe-rienza sensata, se e solo se è filtrato da una griglia di tipo testuale (cheper Derrida, come è noto, ha natura scrittoria). Ora, al di là delle va-lenze filosofiche della grammatologia decostruzionista, che non in-teressa rilevare e seguire qui nei dettagli, resta centrale l’idea di unatestualità a tutto campo dove non è possibile distinguere fra ciò cheè testo e ciò che gli si accompagna come suo commento esteriore.Quel che, seguendo alcuni tic lessicali di Rousseau, Derrida chiama‘supplemento pericoloso’ o ‘esorbitante’ è qualcosa che sta già den-tro la scrittura e la sua rivelazione testuale, e che lo sguardo criticodeve preoccuparsi non di svelare intuitivamente ma metodologica-mente di ‘produrre’. Si tratta – crediamo di poter dire, leggendo tat-ticamente fra le righe di Della Grammatologia – più che altro delladimensione enunciativa del testo, quella dimensione che è insiemeesterna e interna al testo stesso, e che permette non solo l’individua-zione ma la costruzione della soggettività discorsiva. L’io di Rous-seau, che emerga nelle pagine del romanzo autobiografico o in quel-le del saggio filosofico, è «iscritto in un sistema testuale determina-to», è cioè prodotto dai disuguali assetti enunciativi che i diversi te-sti hanno al loro interno. Un interno che, insiste Derrida, non si di-stingue mai dal suo esterno. Sia perché, come s’è detto, ogni testo èinserito in una catena testuale che lo trascende affermandolo. Siaperché ai bordi del testo, inteso come enunciato (narrativo, riflessi-vo etc.), sta la sua enunciazione, il processo della sua messa in di-scorso che è già presente sotto forma di regole grammaticali nella lin-gua, e che consente la costituzione – dinamica e cangiante – delle re-ti intertestuali. Ci sembra di poter leggere in direzione della discor-sività, mai esplicitamente nominata comunque, un’affermazione me-todologica forte come la seguente:
31
nalmente – letteratura, immaginario letterario (e che noi possiamogrosso modo ripensare in termini di intertestualità). Da questo pun-to di vista, afferma Ricoeur in accordo col testualismo, ogni testo èchiuso in se stesso, e non si pone alcuna questione di esteriorità, difuori-testo. Di contro, il testo scritto si riapre al mondo, al vissuto,all’esperienza soggettiva, ai sistemi di valori esistenziali e culturaliche gli sono esterni, in un momento molto preciso, che fa parte in-tegrante della dimensione testuale: quello della lettura. La letturareinstaura una sorta di dialogicità fra gli interlocutori del discorso,permettendo la riemersione di quella realtà effettuale che in un pri-mo tempo, nell’atto della scrittura, il testo aveva messo come fra pa-rentesi, se non cancellato. Leggere, per Ricoeur, è come eseguire unapartitura musicale: evocare la verità del testo grazie alla propria sog-gettività situata, al proprio mondo interiore, alle proprie esperienzevissute, ai propri valori; restaurando la continuità con una tradizio-ne, ancora una volta, di natura testuale, il cui senso altrimenti si sa-rebbe perduto nella distanza esercitata dal trascorrere del tempo.
Questo doppio movimento del testo – chiusura e riapertura – sireplica secondo Ricoeur al momento dell’interpretazione: che è inun primo momento analisi strutturale del mondo testuale, circo-scritto in se stesso e sospeso rispetto al mondo esterno, e in un se-condo momento interpretazione vera e propria, che riallaccia il si-stema di funzionamento interno del testo alla realtà culturale ester-na, in modo da ri-creare una sorta di continuità di problemi e di va-lori, di esperienze esistenziali e vissuti collettivi, annodando un nuo-vo discorso al discorso del testo (un po’ come la celebre ‘fusione diorizzonti’ pensata da Gadamer). Da qui l’esempio dell’analisi strut-turale del mito condotta da Lévi-Strauss – che, vedremo più avanti,non appare del tutto indovinato dal punto di vista della configura-zione testuale. L’etnologo, osserva Ricoeur, mostra come il mito d’E-dipo sia un sistema che prende coscienza delle contraddizioni uma-ne (relazioni di parentela, distanza dell’uomo dall’animale etc.) etenta di conciliarle a un altro livello: quello, appunto, della narra-zione mitologica. Ma l’individuazione di questo sistema di funzio-namento interno al mito non può essere fine a se stesso, poiché per-mette l’emersione di alcune problematiche umane fondamentali, didomande esistenziali tanto universali quanto inquietanti, come quel-la relativa alla relazione profonda fra vita e morte. Il mito d’Ediponon è altro che angoscia dell’origine: il combinato disposto dell’a-nalisi strutturale e dell’interpretazione – definito suggestivamente ar-
30
non implica affatto una rinuncia a ogni significazione testuale. Anzi,a ben vedere, la rafforza, addirittura la raddoppia, poiché individuaquesto ‘supplemento interno’ al testo che non è un divertente ossi-moro con cui giocare vorticosamente ma, riteniamo, la discorsivitàdel testo, la sua capacità di costruire forme di soggettività e proces-si d’intersoggettività sul piano della enunciazione.
5.2. Interpretazione, significatività, configurazione
Una strada molto diversa segue la riflessione di Paul Ricoeur, permolti versi in esplicito disaccordo con il decostruzionismo testualistache soprattutto negli Stati Uniti, in nome di Derrida, ha avuto unagran quantità di proseliti. Per quel che ci interessa in questa sede, lacui mira è la ricostruzione genealogica della nozione di testo (e del-la sua relativa pratica analitica e interpretativa), va immediatamentericordato che l’ermeneutica di Ricoeur ravvicina il comprendere sog-gettivistico delle scienze dello spirito allo spiegare oggettivista dellescienze della natura (per riprendere i termini classici di Dilthey), po-nendoli non come opposti ma come complementari: la spiegazioneaccresce la comprensione e viceversa. E giustifica tale complemen-tarità proprio ricorrendo alla nozione di testo e alla sua indubbiacentralità. In primo luogo, dice Ricoeur, perché il linguaggio cometale non può essere ricondotto a una qualsiasi entità naturale, e con-seguentemente la linguistica non può essere circoscritta a una sem-plice spiegazione naturalistica. In secondo luogo perché il testo, co-me dilazione scritta del processo linguistico-comunicativo, instaurauna sorta di gioco ermeneutico dove spiegazione e comprensione siintegrano a vicenda. La scrittura, per Ricoeur, non è semplice tra-sposizione di un’oralità che per principio la precede in un gioco disegni che, al massimo, ne consolida la memoria. Infatti, il testo (perdefinizione scritto, come in Derrida) differisce la dialogicità della pa-rola, rendendo vano il gioco di replica e controreplica sulla base delquale il senso scaturisce direttamente dai vissuti dei soggetti coinvol -ti. Così facendo, esso elimina ogni riferimento del discorso sia al con-testo situazionale sia al mondo esterno, senza cancellare del tutto larealtà referenziale. Ogni testo crea la propria specifica referenzialità,una sorta di mondo testuale che sta in sospensione fra la realtà em-pirica del testo e quella concreta del mondo esterno, agganciandositalvolta ad altri testi come lui, e producendo tutti insieme quella di-mensione trascendente che Ricoeur chiama – ancora molto tradizio-
33
zione critica – nel senso anche kantiano – delle condizioni di possi-bilità della società come oggetto di conoscenza scientifica, il reperi-mento delle procedure mediante cui determinati fenomeni umani esociali si presentano come interessanti, rilevanti, pertinenti per l’a-nalisi sociale, l’elaborazione delle ragioni semiotiche per cui si dàqualcosa come un oggetto sociale. Di conseguenza, il tentativo d’ac-costamento compiuto da Ricoeur fra i fenomeni sociali e i testi ap-pare di estremo interesse.
Seguiamo rapidamente la sua argomentazione. Come il testoscritto si differenzia dal discorso orale per alcune caratteristiche dibase (iscrizione e fissazione del contenuto enunciato, depsicologiz-zazione della soggettività enunciante, referenza non ostensiva, aper-tura a un’universalità di letture), analogamente l’evento sociale chediviene oggetto di indagine sociologica si differenzia dalle azioni co-muni degli individui sulla base delle medesime caratteristiche: obiet-tivazione dell’azione in una configurazione specifica che si dà all’in-terpretazione sulla base delle proprie connessioni interne; distaccodell’azione dall’agente; conseguente autonomizzazione da ogni re-sponsabilità soggettiva; superamento delle condizioni di produzio-ne dell’azione e sua riproposizione su un piano socioculturale, stori-co; apertura dell’azione a un’interpretazione non contemporanea,quasi universale. Fissate queste caratteristiche testuali dell’azionesensata, appare possibile trattarla appunto come un testo, e ripro-porre per essa la dialettica fra comprensione e spiegazione. Da unaparte la comprensione originaria, ingenua dell’azione sensata si ar-ricchisce grazie alla spiegazione intrinseca, strutturale dei fenomenisociali significativi; dall’altra tale spiegazione non è fine a se stessa,poiché sbocca in una comprensione profonda dell’evento che mettein collegamento il mondo dell’interprete con quello dell’evento si-gnificativo. Del tutto analogamente a quel che accade con i testi.
Detto ciò, valgono di più le premesse di tale tentativo che non irisultati effettivamente raggiunti, legati a un’ermeneutica che, perquanto linguisticamente fondata, appare ancora legata alla questio-ne della tradizione e della sua ri-valorizzazione filosofica. Per Ri-coeur, infatti, sono fatti sociali le ‘azioni sensate’ nell’accezione we-beriana: i comportamenti orientati in modo sensato, dove ‘sensato’va inteso più che altro come significativo, fortemente valorizzato equindi istituzionalizzato, dotato di un’importanza sociale che tra-scende la particolarità delle azioni individuali. Il paragone con il te-sto si basa su questa ipostasi, e retroagisce sulla nozione stessa di te-
32
co ermeneutico – lo rivela schiettamente. Dove però appare chiaroche per Ricoeur il ruolo basilare continua a mantenerlo l’interpreta-zione, un’interpretazione de-psicologizzata, relativamente oggetti-vata poiché agganciata a una linguisticità di fondo, a un testo di cuiessa si propone di rilevarne l’intenzionalità più propria. La qualesembra coincidere – non senza oscillazioni – con la sua struttura se-mantica profonda. Ricostruire il significato del testo, compito dell’a-nalisi strutturale, diviene complementare all’individuazione dellasua direzionalità, compito dell’interpretazione: in un modo comenell’altro, dice Ricoeur, è questione di senso, la cui riattivazione è ga-ranzia di una fusione fra mondi testuali e mondi dell’esperienza.L’opzione sociosemiotica sembra così avvicinarsi.
Ne è dimostrazione un’altra importante discussione condotta daRicoeur: quella relativa all’azione sensata considerata come un testo,alla possibilità cioè di trattare i fenomeni studiati dalle scienze uma-ne e sociali alla stregua dei testi, poiché dotati delle medesime ca-ratteristiche formali e procedurali di questi ultimi – che è grosso mo-do l’ipotesi che stiamo provando a enucleare in queste pagine. L’i-dea di Ricoeur è quella di ricostruire per le scienze umane un ogget-to specifico di conoscenza e una metodologia altrettanto specifica,di natura ermeneutica. Le scienze umane dirigono verso i loro og-getti d’indagine uno sguardo simile a quello che l’interprete usa perla lettura di testi (secondo la dialettica fra spiegare e comprendere),per la semplice ragione che i fenomeni socioculturali e i testi hannole medesime caratteristiche. Laddove molte scienze sociali e umaneperseguono un ideale di scientificità improntato all’epistemologiadelle scienze esatte e naturali (da cui tutta una mitologia del quanti-tativo, del numerico, della statistica etc.), Ricoeur insiste sull’aspet-to metodologico cosiddetto qualitativo di tali discipline: ponendosiperò il problema di fondare tale metodo qualitativo su una preven-tiva disamina di ciò che può essere considerato il suo precipuo og-getto di studio – costruito e non dato, fondato su un’appercezioneculturale piuttosto che su una conoscenza empirica. Da qui la straor-dinaria importanza, per noi, di questa riflessione ermeneutica, che siriallaccia in profondità al senso stesso della sociosemiotica – ossia al-la sua relazione, da un lato, con la teoria semiotica generale e so-prattutto, dall’altro, con le scienze umane e sociali. Come vedremo,la sociosemiotica non è né una banale estensione del campo semio-tico verso la socialità né l’ingenua offerta di una metodologia strut-turale sedicente rigorosa alla sociologia. Essa è semmai la ricostru-
35
soprattutto, la moda. Seguendo queste suggestioni di ricerca, moltistudiosi hanno provato in modo analogo a ripensare variegati ambi-ti di studio – pittura, fotografia, fumetti, teatro, cinema, architettu-ra, design, comunicazione gestuale, pubblicità etc. – in funzione delmodello linguistico, forzando la natura di tali oggetti di indagine tal-volta fino alla caricatura. È così per esempio che s’è parlato – sul mo-dello del fonema – del cinèma, del gestema, del mitema o del guste-ma. Ed è per questo che ci si è interrogati sulle possibili analogie fraun dipinto e un enunciato linguistico, sulla quantità di articolazionipresenti nel cinema, sulle possibili omologie fra una parola e un fo-togramma, sull’istituzione di un dizionario dei gesti e altre ipotesiteoriche che, oggi, appaiono più che altro come divertenti amenità.Finendo per appiattire l’idea di una specificità dei singoli linguaggisul linguaggio ritenuto unanimemente primario, qual è quello usatodalle varie lingue verbali. In realtà, il problema non era legato esclu-sivamente all’ipostasi teorica della verbalità. Più in profondità, essodipendeva da una presupposizione tanto silente quanto condivisa:quella per cui esistono nelle culture umane diversi linguaggi, e percui questa differenza dipende dalle materie espressive da essi utiliz-zate, dai relativi organi di senso necessari per metterli in moto, daimedia necessari per veicolarli (sovrapponendo, fra l’altro, proble-matiche di vario ordine e grado).
La nozione di testualità giunge all’interno del dibattito semioti-co proprio per scongiurare questo genere di difficoltà teoriche emetodologiche, grazie anche a una costante attenzione verso quan-to si va sviluppando in linguistica testuale, narratologia, pragmati-ca degli atti linguistici, teoria della comunicazione, ermeneutica edecostruzionismo. Il testo offre al semiologo la possibilità di indi-viduare come propri oggetti d’indagine unità comunicative e con-figurazioni di sen so molto ampie che possano prescindere dalle di-verse sostanze dell’espressione (da Hjelmslev in poi ritenute nonpertinenti all’analisi linguistica). Riuscendo altresì a trascendere latroppo rigida opposizione fra sistemi semiotici precostituiti e lororealizzazioni individuali, lingue e atti di discorso, codici e messag-gi: il testo usa sistemi già dati ma, realizzandoli, li modifica, li ren-de pertinenti agli ambienti comunicativi in cui circola, convocandoal suo interno tutte quelle configurazioni culturali già date che nepermettono la sua completa e complessa costruzione di senso. Daqui, lungo l’euforico decennio degli anni Settanta, il susseguirsi en-tro il dominio degli studi semiotici di esperienze teoriche ed espe-
34
sto proposta da Ricoeur, chiarendo una volta di più che per il filo-sofo francese i testi sono sempre e comunque testi scritti dotati diuna qualche intrinseca autoritarietà, di un valore culturale loro pro-prio, e non possono in alcun modo essere assimilati agli oggetti d’a-nalisi della sociosemiotica, del tutto svincolati da una valorizzazionea priori.
Più che questa discussione concernente una metodologia erme-neutica delle scienze sociali, dove pure emerge esplicitamente il ter-mine ‘testo’, è molto vicina alla prospettiva teorica della semioticatutta la riflessione ricoeuriana intorno al nesso fra tempo e raccon-to. Nei tre celebri volumi a ciò dedicati emerge con molta chiarezzacome prima del racconto propriamente detto (romanzo, poema epi-co, tragedia, fiaba etc.), già a livello del cosiddetto mondo della vita,quello dell’esperienza quotidiana vissuta, sia presente una sorta diistanza di comprensione di tipo narrativo. Per dar senso, circoscri-vere e comprendere il vissuto quotidiano, occorre che le azioni, non-ché gli eventi che accadono o con i quali entriamo in contatto, ven-gano organizzati secondo logiche fondamentalmente narrative. Do-ve cioè alcune categorie tipiche dei racconti (intenzionalità, motiva-zione, valore, azione e reazione, temporalità etc.) permettono dimuoverci in un modo sensato, di operare secondo progetti esisten-ziali coerenti perché, appunto, filtrati narrativamente. La narratività,che è una delle principali dimensioni mediante cui si costituisconosemioticamente i testi, è per Ricoeur la forma della nostra esperien-za. Non è un caso, del resto, che Ricoeur si sia dimostrato molto in-teressato alla semiotica del racconto e del testo esercitata da Grei-mas, la quale, vedremo, sembra rispondere a molti interrogativi la-sciati aperti dall’ermeneutica del testo.
6. Semiotiche del testo
S’è già detto come in semiotica la nozione di testo venga importata,a partire dai campi disciplinari limitrofi qui rapidamente individua-ti, per tentare di superare gran parte delle difficoltà della prima se-miologia del segno e del codice. Un autore come Barthes, per esem-pio, aveva provato a usare alcune categorie chiave della linguisticastrutturale (lingua/parole, significante/significato, sintagma/para-digma, denotazione/connotazione) per descrivere oggetti e fenome-ni sociali molto vari come la cucina o l’arredamento, l’urbanistica ela medicina, le mitologie piccolo-borghesi della cultura di massa e,
37
6.1. Cooperazione interpretativa
Per quel che riguarda Eco, la questione della testualità resta per certiversi intrecciata a una più generale riflessione sul segno, per quantoripensato secondo i principi della pragmatica filosofica di Charles S.Peirce. Secondo quest’ultimo il segno è una realtà dinamica, senzauna conformazione specifica né dal punto di vista materiale né daquello formale, che mette in moto un lavorio interpretativo in lineadi principio inesauribile dove significanti e significati si rimandanogli uni con gli altri. Il significato di un segno, afferma Peirce, è un al-tro segno in cui il primo deve venir tradotto, o se si vuole anche sol-tanto approssimativamente ricondotto, in un rinvio potenzialmentesenza fine dove materie espressive di qualsiasi genere (gestualità, ver-balità, immagine etc.) portano avanti l’interpretazione (idea che con-vince sia Derrida sia Ricoeur). Finché non si produce una qualchestabilizzazione istituzionale, un certo ‘abito’ interpretativo che bloc-ca – per un tempo più o meno lungo – la fuga continua degli inter-pretanti. Analogamente per Eco, la primarietà del piano semanticosu quello espressivo, che abbiamo visto essere decisiva per una se-miotica del testo, trova conferma nel concetto di interpretazione co-me attività non esterna ma costitutivamente inerente sia al segno siaal testo – i quali talvolta sembrano differenziarsi solo per taglia e percomplessità. Il testo, dice Eco, è un lessema espanso, così come il les-sema è un testo concentrato: il senso si allarga e si restringe in formeespressive differenti, che vanno dalla singola parola a un’intera ope-ra, dando luogo ogni volta ad attività interpretative più o meno com-plesse, più o meno fondamentali. In tal modo per Eco l’assunzionedella nozione di testo entro la ricerca semiotica, pur facendo ampi econtinui riferimenti alle linguistiche testuali, non comporta una ri-nuncia all’analisi semantica dei singoli termini, i quali, al loro speci-fico livello, non solo mantengono un qualche senso letterale ma pre-suppongono i contesti discorsivi e le situazioni di comunicazione en-tro cui acquistano tutto il loro senso effettuale (che il dizionario re-gistra e indica, in qualche modo istituzionalizzandoli).
Una parola, una frase, un testo, un insieme di testi sollecitano,grazie alle proprie strutture interne – semantiche e sintattiche –, uncostitutivo lavoro pragmatico del destinatario, che viene portato adattivare porzioni più o meno consistenti della propria ‘enciclopedia’(ossia della propria competenza linguistica, lessicale, testuale, inter-testuale, generalmente culturale), in modo da completare il senso
36
rimenti d’analisi che scommettono sull’ipotesi di una testualità conregole proprie, né legate esclusivamente alle grammatiche linguisti-che, né vincolate agli idioletti estetici o alle letture soggettivistichedel pubblico. Da una parte, è l’analisi letteraria a farla da padrone.Nel 1970 Barthes si cimenta col Sarrasine di Balzac, mostrandone lamolteplicità interna dei percorsi di senso (S/Z). Nel 1976 Greimascompie una operazione analoga con Deux amis di Maupassant, det-tando implicitamente le procedure per un’analisi semiotica dei testi(Maupassant). Nel 1979 Eco propone una propria teoria della coo-perazione interpretativa dei testi narrativi usando come esempio –accanto all’onnipresente Sylvie di Nerval – Un drame bien parisiendi Alphonse Allais (Lector in fabula). Dall’altra, parallelamente esuccessivamente, si moltiplicano ricerche e analisi testuali su quadri,film, pièces teatrali, fumetti, annunci pubblicitari, articoli giornali-stici, opere musicali, oggetti di design, artefatti architettonici – tut-ti casi di oggetti testuali legati a sostanze espressive diverse che, co-munque, la nostra cultura ci rimanda già come tali, grazie a criteridi riconoscibilità tanto impliciti quanto condivisi (comunicatività,presenza percepibile di confini, evidente lavorio di strutturazioneinterna etc.).
Quest’euforia legata all’analisi dei testi, che segna un enorme pas-so in avanti nelle ricerche semiotiche negli ultimi decenni del Nove-cento, mostrando la fecondità di una metodologia tanto rigorosaquanto dinamica e adattabile, tace però, per quanto paradossalmen-te, su una questione: di cosa parliamo quando parliamo di testo? Sia-mo certi di far riferimento alla medesima costruzione teorica? o difatto accettiamo concezioni molto diverse, provenienti ora dalla re-torica, ora dalla filologia, ora dalla linguistica, ora dalla filosofia, oradalla critica letteraria etc.? A prevalere è sempre e comunque il mo-dello linguistico, soprattutto nella sua declinazione letteraria, di mo-do che è dalla storia della letteratura che viene tratta la più grandequantità di esempi testuali: narrativi e poetici in primo luogo. Anchese l’apporto di discipline limitrofe – soprattutto la filmologia e lacommunication research – si rivela fondamentale. Tra gli autori chehanno provato più di tanti altri ad accompagnare una pratica d’ana-lisi dei testi con una definizione teorica della testualità spiccanosenz’altro, per certi versi opponendosi, Umberto Eco e Algirdas J.Greimas, sui quali converrà soffermarsi non solo per render ragionedel loro pensiero, ma anche per delineare le strade di ricerca che dal-la loro opera hanno preso avvio.
39
do ipotesi sul seguito della trama, tirando a indovinare sul finale etc.Le passioni del lettore modello sono sempre e comunque emozionimentali. In terzo luogo, dato che il lettore è inscritto nel testo e la suaattività è dal testo prevista, si dà una precisa differenza tra l’inter-pretazione vera e propria del testo, che in un modo o nell’altro attivapercorsi semantici in esso anticipati e prescritti, e l’uso del testo stes-so, che è di tipo idiosincratico, uscendo fuori dal testo per seguirepercorsi interpretativi in esso non presenti – i quali, dice Eco, se pu-re tengono in esercizio la semiosi, possono rivelarsi a lungo andarepericolosi. Il nemico dichiarato è qui il decostruzionismo, o se si vuo-le il testualismo, che pensa il testo come semplice pre-testo per elu-cubrazioni d’ogni genere. Il pendolo di Foucault, secondo romanzodi Eco, è la storia fantastica (ma verosimile) dei disastri provocati dauna serie di interpretazioni non previste di certi testi, di loro usi aber-ranti che portano a comportamenti insensati se non del tutto folli. Inquarto luogo, resta comunque evidente che questa dicotomia fra usiscorretti e interpretazioni consentite dei testi, che potrebbe esser let-ta in chiave prescrittiva, si determina sullo sfondo variabile dei pa-norami culturali, di configurazioni antropologiche complessive chenon dettano regole a priori ma si costituiscono come luoghi in cui siattuano continue negoziazioni fra autori e lettori, fra autori e autori,fra lettori e lettori, fra istituzioni autoritarie e istanze liberatorie, os-sia sostanzialmente fra testi e testi. L’enciclopedia grazie a cui il let-tore modello azzarda le proprie ipotesi interpretative, infatti, è lacompetenza che il testo richiede al proprio lettore per esser capito,la quale ha una natura anch’essa testuale, anzi, meglio, intertestuale,dunque generalmente culturale. La cultura è un insieme di testi sen-za alcuna gerarchia prestabilita, senza alcun albero di Porfirio chedecida scale assolute di valori logici o metafisici: è semmai un luogodinamico dove si negozia in continuazione fra attori della comuni-cazione, in modo da decidere ogni volta in modo diverso non soloche cos’è uso e che cosa interpretazione di un testo, ma più inprofondità – come vedremo anche in Greimas e Lotman – che cosa,a determinate condizioni e secondo certe pertinenze, è un testo e checosa non lo è. Da qui, per quanto senza enfasi, quello che Eco stes-so chiama pansemiotismo, secondo il quale l’intera vita quotidiana– e non solo la cultura – «appare come un reticolo testuale in cui imotivi e le azioni, le espressioni emesse a fini comunicativi così co-me le azioni che esse provocano, diventano elementi di un tessutosemiotico in cui qualsiasi cosa interpreta qualsiasi altra».
38
che il testo lascia come in sospeso. Il testo emerge, nella semioticainterpretativa di Eco, come una specie di configurazione culturaledinamica, una sorta di dialettica continua fra detto e non detto, fraciò che esso esplicitamente proferisce e ciò che invece si limita a pre-supporre, promettere, implicare, implicitare – e che il destinatario,grazie alle proprie competenze pregresse, deve saper cogliere. Il te-sto è una macchina pigra, piena di ‘buchi’, di interstizi, di spazi la-sciati vuoti, in attesa che il lettore (perché è soprattutto il testo scrit-to che Eco considera) li riempia di un significato che è al tempo stes-so inscritto e inferito, interno ed esterno, testuale e culturale, ogget-tivo e soggettivo. Da una parte, il lettore del testo – definito ‘lettoremodello’ – fa parte della macchina testuale, provvedendo a riparareall’innata pigrizia di quest’ultima con un’attività cognitiva in qualchemodo prevista in anticipo. D’altra parte, questa prefigurazione te-stuale del lettore agisce in modo che – non foss’altro che come uto-pia autoriale, aspettativa di una realizzazione perfetta dell’opera – illettore empirico si attivi per comprendere del testo anche, e soprat-tutto, ciò che esso non dice ma si limita a presupporre.
Da qui una serie di corollari. Innanzitutto, l’idea che non tutti itesti sono pigri allo stesso modo, e di conseguenza non tutti i lettorivengono sollecitati in termini simili: per mandato comunicativo, untesto pedagogico esplicita molto di più di uno estetico; una teleno-vela racconta molto di più della propria trama di quanto non facciaun racconto letterario; una trasmissione di promozione commercia-le si dilunga su un certo prodotto molto di più di quanto non facciauno spot pubblicitario. Ma non bisogna confondere il grado di espli-citazione del senso di un testo con la sua taglia espressiva e di con-seguenza con la quantità di informazione in esso contenuta. Una te-lenovela esplicita molto, forse troppo, della propria trama, la qualeè però poverissima dal punto di vista narrativo. Uno spot dura po-chissimo ma dice moltissimo. La dialettica fra concentrazione edespansione torna pertinente e, dipendendo dall’attività interpretati-va del destinatario, acquisisce un valore soprattutto pragmatico. Insecondo luogo, emerge abbastanza chiaramente come il testo di cuiEco discute sia una occorrenza di tipo cerebrale, di modo che l’atti-vità di interpretazione è un lavoro pressoché esclusivamente di na-tura inferenziale, cognitiva, quasi logica. Il problema della dialetticafra detto e non detto non fa scattare, per esempio, tensioni di tipopassionale, se non inserite in una più generale volontà di compren-sione del senso del testo, anticipando percorsi narrativi, arrischian-
41
di ciò che non lo è, dei suoi confini, della sua stessa articolazione in-terna. La predeterminazione del genere – una preghiera, un indovi-nello, una tragedia, una novella etc. – è una configurazione semanti-ca data che poi il testo, facendo ricorso al proprio supporto espres-sivo, specifica ulteriormente o, talvolta, è portato a negare, disatten-dendo le aspettative dei destinatari. Così, per esempio, nella cosid-detta neotelevisione la segmentazione del flusso televisivo in tra-smissioni e programmi non ha molto senso, poiché essi non vengo-no percepiti come (e dunque non sono) veri e propri testi, come era-no invece nella paleotelevisione. Da qui la sparizione o l’indeboli-mento delle sigle, la creazione di lunghe trasmissioni (i famosi con-tenitori) e di stacchi molto brevi (le ‘schegge’) etc., al punto che a di-ventare testo entro questa pratica discorsiva è il palinsesto nel suocomplesso. I confini fra testo e contesto non sono mai dati una vol-ta e per tutte, poiché i generi e le configurazioni sociali li modifica-no senza sosta.
6.3. Percorso generativo e progetti di descrizione
Rispetto alla semiotica di orientamento interpretativo, che pensa iltesto come spazio dinamico in cui si innesta una sorta di dialetticaermeneutica fra regole precostituite ed enciclopedia culturale, la se-miotica cosiddetta generativa, tenendo sullo sfondo la lezione diHjelmslev, concepisce la testualità come manifestazione empirica diun discorso sottostante, come l’unità per così dire naturale d’ogni si-gnificazione umana e sociale. A prescindere sia dalle sostanze dell’e-spressione che esso adopera sia dalle interpretazioni che riceve. Co-sì, nella riflessione di Algirdas J. Greimas il testo, di qualunque spe-cie e dimensione esso sia, costituisce l’oggetto della conoscenza se-miotica, oggetto di cui vanno spiegate le condizioni di possibilità, irequisiti d’esistenza, le leggi di trasformazione. E ciò per una ragio-ne abbastanza evidente: i testi (e non i segni, i codici, i linguaggi etc.)sono filtri formali mediante cui gli uomini – i gruppi, le società, leculture etc. – accedono a un senso che, per definizione, li precede,che essi cercano di cogliere per dare a loro volta un qualche signifi-cato alla propria esistenza fisica e culturale, sociale e politica, spessotrasformandolo. Compito della semiotica è quello di ri-costruire lagriglia testuale, nell’accezione precipua di costruire di nuovo: por-tandola alla luce, ove essa fosse stata occultata o rimossa; esplicitan-dola, ove essa fosse invece implicita e inconsapevole.
40
6.2. Culture e generi
Un’importante, doppia radicalizzazione della semiotica interpretati-va è il progetto teorico perseguito da François Rastier, studioso diHjelmslev e allievo di Greimas, fautore di una semantica del testoche stia rigorosamente all’interno di una semiotica delle culture. Lad-dove per Eco la cultura, intesa come enciclopedia o serbatoio me-moriale di testi pregressi, fa da sfondo per la ricostruzione di pro-cessi inferenziali a carattere cognitivo, per Rastier essa include anchele pratiche sociali a partire da cui i testi traggono, prima ancora chesenso e valore, la loro ragione d’esistenza. Di contro al progetto co-gnitivista d’una più o meno esplicita naturalizzazione del senso (allaquale lo stesso Eco, soprattutto nei suoi ultimi lavori, si riallaccia),Rastier rivendica la prospettiva opposta di una culturalizzazione delsenso, sorta di ipotesi regolativa generale entro cui incanalare ognidescrizione, analisi e teoria dei testi. Tre, secondo questo autore, lecaratteristiche fondamentali di un testo: la prima è quella di essereattestato, attivamente presente nella cultura, e non generato artifi-cialmente dallo studioso come exemplum fictum atto a dimostrareuna qualche teoria pregressa; la seconda è quella di costituirsi entrouna qualche prassi; la terza è d’essere fissato in un supporto empiri-camente riscontrabile (in linea di principio di qualsiasi natura, mapoi, ancora una volta, pensato come prodotto soltanto linguistico,verbale, e per lo più scritto). Ciò porta a radicalizzare, insieme allaprospettiva antropologica, anche la nozione di interpretazione, chenon viene intesa più come attribuzione di senso a una espressionedata, ma come riconoscimento anche dell’espressione medesima, delsignificante che supporta il significato. Se la semiosi è presupposi-zione reciproca di espressione e contenuto (e in questo Rastier segueHjelmslev, non Peirce), l’interpretazione è l’istanza variabile a parti-re da cui si istituisce, dentro una cultura data, questa relazione di si-gnificazione. Di modo che non è affatto detto, come generalmente siritiene, che l’espressione venga prima e solo dopo le si attribuisca uncontenuto. Molto spesso è il contrario: è a partire da alcune aspetta-tive semantiche pregresse, da certe precise anticipazioni di senso chesi è portati a individuare una determinata espressione come suppor-to per un testo, che si coglie cioè il testo come entità culturale spe-cifica. Rastier fa l’esempio del genere, tipo di discorso o di testo apartire da cui si determina una serie di aspettative che progressiva-mente portano al riconoscimento di ciò che è dell’ordine del testo e
43
essi vengono generati, senza con questo ripristinare ipotesi univer-salistiche e metafisiche.
Così, al momento di passare dai problemi teorici generali ai me-todi di descrizione degli universi semantici, Greimas sposta losguardo dalla combinazione di elementi semplici all’individuazionedi percorsi complessi entro i quali la significazione si articola e si di-spiega. Lo studioso di semantica finisce per incontrare la Morfolo-gia della fiaba di Propp, testo sul quale già Lévi-Strauss aveva ri-chiamato l’attenzione degli studiosi. Lavorando sulla tipologia del-le sfere d’azione e sulla stringa di funzioni narrative individuate dalfolklorista russo, Greimas concepisce l’ipotesi che gli eventuali uni-versali semantici debbano essere ricostruiti a partire da strutturetransfrastiche molto ampie, da qualcosa che, collocandosi a livelloimmanente, possa in qualche modo reggere sia la circolazione deidiscorsi sia la loro manifestazione espressiva. «La generazione dellasignificazione – scrive Greimas – non passa affatto, inizialmente, at-traverso la produzione degli enunciati e la loro combinazione in di-scorsi; essa è retta, nel proprio percorso, dalle strutture narrative, esono queste che producono il discorso articolato in enunciati». Ilsuperamento della soglia della frase non porta, come accade a mol-ta linguistica, verso un generico testo pensato come collegamentosuperiore di enunciati già dati, ma alla costruzione di una vera epropria grammatica narrativa che – appoggiandosi su alcune strut-ture elementari della significazione (il celebre quadrato semiotico)– trasforma l’iniziale progetto semantico in una più ampia ricercasemiotica. All’interno di una teoria della significazione così conce-pita, la narratività non è più il modello generale a partire da cui siarticolano i racconti, come ritiene la narratologia, ma un’ipotesi in-terpretativa che permette di spiegare qualsiasi fenomeno semiotico,ossia qualsiasi dato culturale, sia narrativo sia non narrativo.
Il testo si configura allora come la punta dell’iceberg del cosid-detto percorso generativo del senso, il luogo dove tale percorso, do-tandosi di una materia espressiva, assume una concretezza empiricae si manifesta, si rende comunicabile, conoscibile, contattabile. Maa sua volta il percorso generativo del senso non è che la simulazionedei diversi livelli di pertinenza in cui il senso si testualizza, si espri-me mediante una qualche specifica concrezione. Ogni significazio-ne umana e sociale, cioè, può essere descritta dal semiologo – e an-cor prima può essere colta dai soggetti sociali – a diversi livelli di per-tinenza, più o meno astratti, più o meno semplici: a livello per esem-
42
In termini più tecnici: punto di partenza di Greimas è il proget-to abbozzato da Hjelmslev di un’analisi del piano del contenuto del-le lingue condotta con metodi analoghi a quelli usati per il loro pia-no dell’espressione. Come in linguistica i fonemi sono unità costrui-te a partire da un piccolo numero di tratti minimi, analogamente i si-gnificati sono come entità scomponibili in un certo numero di ele-menti minimi. Solo che, laddove sul piano dell’espressione linguisti-ca si dà, in generale, un pacchetto ridotto di tratti acustici a partireda cui tutte le lingue producono, per combinazione e generazione,la loro specifica batteria di fonemi, sul piano del contenuto – so-prattutto se esteso dall’ambito delle lingue verbali a quello di qual-siasi sistema di significazione – le cose non possono funzionare allostesso modo: pena la ricaduta in una metafisica prescrittiva che pre-veda in anticipo le categorie fondamentali del dicibile e del signifi-cabile, gli atomi logici d’ogni discorso presente, passato e futuro,d’ogni forma di comunicazione umana e sociale. Così, la fondazionedi una semantica strutturale rigorosa, pensa Greimas, deve cancella-re l’ipotesi di un campo semantico globale di cui ricostruire l’archi-tettonica universale e necessaria, per concentrarsi su domini locali disignificati, circoscritti nello spazio e nel tempo, diversamente deter-minati dalle varie culture e nei differenti periodi storici. Tuttaviaquesti microuniversi semantici chiusi – un corpus di fiabe, un insie-me mitologico, un racconto letterario, una definizione dizionarialeetc. – non esauriscono il loro campo d’azione in se stessi, sorta di on-tologie regionali senza contatto reciproco. Per la semplice ragioneche, a partire da espliciti criteri di pertinenza che ne permettono vol-ta per volta la comparazione, al loro livello profondo essi rivelanotratti formali abbastanza simili.
Da qui la centralità del testo: se da un lato si tratta di costruireclassificazioni coerenti che rendano conto dei generi e delle speciedei microuniversi semantici, costruendo una tipologia formale deidiscorsi sociali, da un altro lato occorre interrogarsi sulle struttureche accomunano, dal punto di vista delle loro strutture soggiacenti,questi stessi discorsi. Non per combinazione di elementi minimi –come prevede la semantica componenziale, basata su una teoria deicodici –, ma per articolazioni complessive di configurazioni di sen-so, ossia appunti di testi, strutturate a vari livelli di profondità e dicomplessità. Riesce allora possibile, per Greimas, interrogarsi sullapossibilità di reperire, al di sotto degli universi discorsivi specifici,manifestati sotto forma di testi, un livello profondo a partire da cui
45
siderevolmente dal testo; ma esso è l’unico rapporto che abbiamo con ilnostro reale, diverso dal reale matematico, dal reale naturale e così via.
Poco dopo, rispondendo a un’altra domanda sulla fenomenolo-gia, diceva:
Ho spesso avuto occasione di parlare dell’importanza dei modelli fi-gurativi nella costruzione delle teorie del linguaggio. Considerate il giocodegli scacchi; è un esempio che si ritrova in tutti i grandi pensatori: Hus-serl, Saussure, Wittgenstein. In essi il linguaggio è costantemente con-frontato al gioco degli scacchi. Per quel che mi riguarda, il modello figu-rativo che mi ha guidato, l’ho trovato nell’opera di Merleau-Ponty: è il cu-bo. Cos’è il cubo? È un po’ – in una trasposizione verso la geometria del-l’immagine – ciò che la cera era per Descartes. Potete guardarlo da ogni la-to: è ogni volta una faccia diversa; ma il cubo in quanto tale resta identicoper l’eternità. Ecco una buona definizione del discorso come oggetto au-tonomo: «fuori dal testo non c’è salvezza!». È una definizione che ci per-mette di parlare del discorso indipendentemente dalle variabili costituitedall’emittente e dal ricevente. C’è sempre il testo, come il cubo; c’è la strut-tura testuale o narrativa, come un’invariante sulla quale possono fondarsile nostre analisi. Diversamente da quanto spesso si è fatto, quest’invarian-te non può essere ridotta né al soggetto dell’enunciazione né all’enuncia-tario (come per esempio nell’estetica di Jauss); non si può ricondurre tut-to al produttore o al lettore. Tra i due c’è di mezzo l’oggetto. Si può offu-scare il suo ruolo ma non impedire che l’oggetto semiotico esista. Questoè il punto di partenza che mi ha obbligato a mettere in scena il concetto diesistenza semiotica, un po’ come la realtà degli oggetti matematici. Pensoche la semiotica possa immaginare l’esistenza di questi simulacri, di que-ste costruzioni, di oggetti che possono essere definiti semioticamente e ilcui tipo di esistenza permette, in altri termini, di eliminare il problema del-l’essere, i problemi ontologici. Cosa molto importante.
La posizione di Greimas sembra abbastanza chiara: il testo è il‘referente’ del semiologo, l’oggetto specifico delle sue indagini, del-le sue ‘vociferazioni’. Ciò non significa però che esso sia un oggettodato, un referente al modo banale di un Morris. Il testo, infatti, co-me gli oggetti dei matematici, va progressivamente costituito, ‘pre-parato’ allo stesso modo in cui i filologi passano dai loro ‘testimoni’variabili nel tempo e nello spazio all’invariante testuale paziente-mente ricostruita. Tale preparazione si configura come l’eliminazio-ne di ogni dato produttivo o ricettivo esterno, come una chiusura te-
44
pio di strutture molto elementari, dove un pacchetto di relazioni eoperazioni di trasformazione fanno emergere i primi vagiti del sen-so (il quadrato); oppure a livello della narratività, dove le relazionielementari si antropomorfizzano dando luogo a tensioni e scontri fraforze in gioco, e le operazioni portano a trasformazioni identitarie;oppure ancora a livello discorsivo, dove un qualche soggetto enun-ciante fa proprie le strutture soggiacenti dotandole di precisi attori,spazi e tempi, e inscrivendole in tematiche e figurazioni. Il testo, inquesto quadro, è l’esito di una manovra differente: quella, appunto,della testualizzazione, che consiste nel bloccare il percorso generati-vo manifestando il livello in cui ci si trova: quello del quadrato, quel-lo del racconto, quello del discorso, con tutte le loro specificazioni esottospecificazioni.
Da qui la celebre affermazione di Greimas, secondo la quale«fuori dal testo, non c’è salvezza». Non c’è salvezza per il semiolo-go, altrimenti imbricato in oggetti di studio tanto sedimentati nellatradizione linguistica e filosofica quanto imbarazzanti dal punto divista di una teoria scientifica della significazione: il segno, il linguag-gio, la frase, il codice, le pratiche e simili. Non c’è salvezza per l’uo-mo qualunque, che trova nei testi – dati o meno, così definiti o no –l’àncora per fissare un qualche significato alla propria esistenza, unostrumento per costruire e modificare la propria soggettività, un pro-getto per inscriversi in un mondo sensato e, per questo, un po’ piùvivibile. Dai testi non si esce, insomma, come diceva Derrida; e perfortuna, aggiunge Greimas, altrimenti non avremmo scampo. Dia-mo un’occhiata, per approfondire la questione, al luogo testuale do-ve Greimas ha enunciato questo slogan. Nel 1983, alla fine di un im-portante convegno a lui dedicato, messo pubblicamente in discus-sione Greimas affermava:
la prima formazione che ho ricevuto è stata quella del filologo; e grazie aun maestro eccellente pretendo di esser stato formato come un buon filo-logo: che è già qualcosa! Voglio dire, quindi, che io ho rispetto per il testo,per la referenza, per il pensiero altrui. Questa influenza è ugualmente im-portante per ciò che concerne le pratiche testuali. I preliminari di ogni ana-lisi semiotica sono nella filologia, nella preparazione filologica del testo. È,questo, un sottinteso ineludibile. Che si sia storici, linguisti o logici, oc-corre innanzitutto sapere che cos’è un testo; il testo è il punto di partenzae il punto di ancoraggio delle nostre vociferazioni; potremmo dire: le giu-stifica e le fonda. In seguito, nel corso della descrizione, ci si allontana con-
47
gettivo ricorre fra i linguisti quando parlano di ‘lingue naturali’. C’èdunque alla base della prospettiva semiotica una doppia operazionecostitutiva, secondo la quale l’oggetto di conoscenza è qualcosa cheè al contempo dato, ossia punto di partenza delle descrizioni imma-nenti, e costruito, laddove la costruzione deve essere giustificata, mo-tivata al livello del metodo, della teoria e dell’epistemologia. Non acaso nel Dizionario ragionato delle scienze del linguaggio (alla voce«Semiotica») Greimas afferma molto chiaramente che ogni semioti-ca-oggetto, ossia «qualunque grandezza manifestata che ci si propo-ne di conoscere» (punto di partenza dell’analisi), esiste soltanto «nelquadro di un progetto di descrizione e presuppone perciò una me-tasemiotica che si ritiene se ne farà carico». L’empiria della semiosinon ha nulla di dato, di naturale, se non nel senso di ciò a cui siamoabituati (un po’ come l’‘abito’, in Peirce, è il blocco della fuga degliinterpretanti, l’assunzione culturale di un dato segnico). Alla voce«Testo», poi, si riprende la questione, precisando che le grandezzesemiotiche da analizzare, le semiotiche-oggetto, sono sempre e co-munque dei testi, i quali si edificano a partire dai livelli di pertinen-za che si decide di prendere in considerazione. Da qui appunto l’i-dea per cui «il testo è costituito unicamente dagli elementi semioti-ci conformi al progetto teorico della descrizione»: progetto che, ov-viamente va esplicitato e giustificato (per questo ‘teorico’), e non la-sciato all’arbitrio della soggettività del ricercatore (si ricordi il ri-chiamo iniziale alla filologia).
Di conseguenza, il lavoro del semiologo si divide in quattro di-versi ambiti – empirico, metodologico, teorico, epistemologico – chesi compenetrano fra loro giustificandosi vicendevolmente: è come sediverse ‘anime’ della ricerca (empirica, metodologica etc.) si faces-sero da sponda, senza che nessuna domini sull’altra. La semioticanon è allora una sorta di applicazione di una teoria e di una meto-dologia, filosoficamente controllate, a un dato empirico qualunque.Se, come s’è detto, l’empiria semiotica è costruita progressivamentea partire da una metodologia controllata teoricamente e filosofica-mente, occorre pensare agli ambiti di esercizio della semiotica comeinseriti in una circolarità, o forse in una rete, di modo che – per quelche ci riguarda in questa sede – l’epistemologico e l’empirico sonogià e sempre in relazione fra loro. Sono le scelte filosofiche a montecirca l’individuazione di un oggetto d’analisi a permettere di ri-co-struirlo come testo da analizzare. Così, per esempio, è la decisionefilosofica circa la natura della passione (qualcosa che non s’oppone
46
stuale nel senso dei formalisti o dei new critics. D’altra parte, però,questa chiusura – conformemente al principio di immanenza diHjelmslev – non è l’assunzione ontologica di un dato naturale, mauna strategia metodologica precisa che permette di passare – comeper il celebre cubo di Merleau-Ponty – dalle molteplici percezionidei singoli dati d’esperienza alla determinazione cognitiva di un tut-to unico. Così come il cubo paradossale della Fenomenologia dellapercezione non sta nella sua appercezione immediata ma nella sinte-si cognitiva che ne può venir fatta a posteriori, di modo che esso,progressivamente però, diviene oggetto di percezione possibile,egualmente il testo è per il semiologo un oggetto paradossale: vienecostruito come punto di partenza, sta alla fine solo in virtù dell’es-sersi già dall’inizio ancorati a esso. È grazie alle molteplici pertinen-ze con le quali viene messo a fuoco (i livelli del percorso generativo)che il testo si conferma essere, alla fine, l’oggetto sottoposto già dal-l’inizio ad analisi. Per questo motivo, e soltanto per questo, il testosta, come si dice, ‘alla fine’ del percorso: è alla fine del percorso –percorso conoscitivo, non genetico – che l’espressione riemerge co-me un piano autonomo, essendo stata per tutto il tempo dell’analisiun qualcosa che ci ha accompagnati momento dopo momento nellaricostruzione delle articolazioni semantiche del testo. Così, per Grei-mas, non c’è – come pure si dice – prima il contenuto e solo dopo l’e-spressione: i due piani si costruiscono reciprocamente, secondo la le-zione del solito Hjelmslev. Ma con una differenza: se per il linguistail contenuto è il supporto per far emergere le articolazioni del signi-ficante espressivo, per il semiologo (che vuol superare le impasses se-miologiche della ‘specificità’ dei singoli linguaggi) è il contrario: èl’espressione a essere supporto per far emergere le articolazioni diun contenuto culturale che, per definizione, trascende le differenzefra sostanze espressive, e viene semmai con esse incessantemente tra-dotto da un sistema di segni a un altro. E anche quando, seguendoil noto principio della non conformità dei piani, occorre studiare ilcontenuto come tale, è sempre sullo sfondo di un’espressione cheimmancabilmente lo supporta.
Da qui un certo numero di conseguenze teoriche. Innanzitutto,l’oggetto che la semiotica pone al suo cosiddetto ‘livello empirico’ –la semiosi – non ha nulla di banalmente empirico: non è un dato co-me tale, ma viene costruito culturalmente come se fosse un dato na-turale: naturale nel senso di ovvio, abitudinario, del ‘va-da-sé’ delBarthes nelle Mythologies, o, se si vuole, nel senso in cui questo ag-
49
getto semiotico che è senz’altro un testo, qualcosa che nella nostracultura definiamo senza alcuna difficoltà come opera letteraria. Maanche in questo caso si tratta di un effetto secondario dell’analisi.Come dimostrano le innumerevoli altre indagini testuali di Greimas(e dopo di lui dei tanti ricercatori della sua scuola) che hanno presoin considerazione situazioni pragmatiche concrete (si pensi all’ana-lisi della sfida), condizioni affettive inscritte nel significato di lesse-mi (collera, nostalgia), intere narrazioni mitologiche (come quella li-tuana), e poi ovviamente immagini, gestualità, poesie e quant’altro.
Così, l’epistemologia semiotica è per Greimas – al modo dell’er-meneutica e del testualismo americano – radicalmente costruttivista,e non potrebbe essere diversamente. Ed è questa, a ben pensarci, unadelle principali differenze fra la scienza della significazione e le altrescienze umane. Se pure queste ultime discutono costantemente pro-blemi metodologici, non si pongono quasi mai problemi di costru-zione del dato, finendo per cadere nell’illusione di un’empiria ester-na e oggettiva da conoscere a prescindere dalle ipotesi di descrizionedi cui pure preventivamente ci si dota, nonché dei saperi presuppo-sti e dei metodi già allestiti che servono per portar avanti quell’ipote-si. Non bisogna allora confondere, come pure accade, la questionedel metodo, che la semiotica condivide con altre scienze umane e so-ciali, con quella della costruzione dell’oggetto di conoscenza, della‘preparazione del testo’, che (in linea con certa filosofia o sociologiadella scienza) la semiotica costitutivamente si pone, e che propone –o dovrebbe proporre – come ricerca di maggiore consapevolezza epi-stemologica all’intero campo di studio sia di altre scienze umane sia,a ben pensarci, delle scienze cosiddette naturali o esatte.
Occorre tornare ancora una volta sulla distinzione fra testi-og-getto e testi-modello. In fondo, dice Greimas, tutti i testi sono co-struiti, salvo che certuni – obliando o nascondendo il lavoro neces-sario per produrli – divengono oggetti, dati ontologici; altri manten-gono la consapevolezza del loro essere costruiti, e possono essereusati per fabbricare realtà testuali ulteriori. Così, non esistono testi‘propriamente detti’ e, poi, altre cose che ‘metaforicamente’ pensia-mo, per nostra comodità interpretativa, alla stregua di testi. Se riu-scissimo a fuoriuscire per un momento dalla nostra specifica condi-zione culturale, saremmo portati ad ammettere che le cose stanno di-versamente. Ci sono, in generale, griglie formali d’ordine testuale,diverse da cultura a cultura, che permettono la costruzione e la ge-stione del senso umano e sociale. Alcune di queste, in particolare,
48
alla ragione e all’azione) a permettere l’analisi della dimensione te-stuale della passione medesima (Semiotica delle passioni). Oppure, èl’assunzione preventiva di una continuità fra percezione e significa-to a dar luogo a una testualizzazione dell’estesia (Dell’imperfezione).Il livello empirico non è il primo livello gerarchico della semiotica,ma viene posto come tale a partire da una preventiva operazione dicostruzione del dato, la quale può venire dimenticata, oppure na-scosta, oppure non sufficientemente giustificata, ma che in ogni ca-so è costitutiva della semiosi. Del resto, l’oggetto di conoscenza del-la semiotica, quanto meno da Saussure in poi, non è né una cosa néun concetto, ma soltanto una relazione fra l’una e l’altro. Occorredunque ipotizzare un’istanza di qualche tipo – culturale, storica, so-ciale, scientifica –, un soggetto costruttore individuale o collettivoche si occupi di porre la relazione, di renderla pertinente, di farla va-lere nell’universo socioculturale.
È all’interno di questo quadro concettuale che bisogna intende-re l’altra nota affermazione di Greimas, che introduce la sua celebre,lunga analisi di Deux amis di Maupassant, per la quale il testo è il‘selvaggio’ del semiologo: non un dato oscuro e incomprensibile daaggredire in un modo o nell’altro, ma l’esito di una negoziazionecontinua fra modelli precostituiti e resistenze socioculturali all’ana-lisi. Così come per l’etnologo il ‘selvaggio’ è condizione e stimolo peruna messa in discussione delle proprie categorie concettuali, e pri-ma ancora mentali, analogamente per il semiologo il testo dev’esse-re sollecitazione per un approfondimento dei propri modelli d’ana-lisi. E così come il selvaggio non è buon selvaggio, ossia umanità pu-ra e incontaminata, condizione naturale dell’esistenza umana masoggettività prodotta e condotta entro specifiche, altre condizioniculturali, analogamente il testo non è mai innocente, non è mai daprendere come elemento puro ma come ipotesi di descrizione dellasignificazione. Tutto il libro di Greimas su Deux amis non fa che con-fermarlo: non si tratta di presentare una lettura critica del racconto,né tantomeno di proporne un’interpretazione o di offrirne una va-lutazione estetica; ma, molto diversamente, di descrivere l’articola-zione interna della sua significazione, di rilevarne le condizioni dipossibilità in quanto ‘grandezza’ semiotica, unità di senso. Alla finedel libro, come ha notato Ricoeur, viene fuori una visione originaledel senso del racconto, una sorta di lettura ermeneutica; ma si trat-ta, per così dire, di un effetto collaterale dell’analisi, non del suoobiettivo di base. Certo, si potrebbe obiettare, Deux amis è un og-
51
ciale costruite in maniere del tutto implicite», e perciò consideratecome ‘naturali’.
7. Basi di sociosemiotica
Dovrebbe essere più chiaro, o quanto meno più esplicito, il motivoper cui, differentemente da quanto molti ritengono, non c’è alcunaopposizione – negli oggetti e nei metodi – fra sociosemiotica e se-miotica del testo. Le due prospettive, anzi, si integrano vicendevol-mente. Laddove la sociosemiotica si occupa della dimensione so-ciale dei testi, la semiotica del testo studia la dimensione testualedel sociale. O viceversa: la sociosemiotica esamina le condizioni dipossibilità e di esercizio del sociale, cogliendo in esse una dimen-sione intrinsecamente testuale, narrativa e discorsiva; la semioticadel testo, a sua volta, ricostruisce le condizioni di possibilità e diesercizio dei testi, ritrovando in esse una dimensione intrinseca-mente sociale e strategica, pragmatica e generalmente culturale.Non c’è, ripetiamolo ancora, da un lato il testo semiolinguistico edall’altro il contesto sociale: le due cose hanno la medesima doppianatura, ed è solamente il progetto di descrizione dello studioso av-vertito a decidere volta per volta che cosa è l’uno e che cosa l’altro,cosa risulta pertinente per l’analisi (ed è testo) e che cosa non lo è(ed è contesto).
Non è un caso se, come si è accennato, già nei primi anni Settan-ta la nozione di testo viene additata come antidoto alle metodologiesociologiche per lo studio della cultura di massa. In un interventofondamentale per la costruzione teorica della sociosemiotica, PaoloFabbri oppone alla cosiddetta ‘analisi del contenuto’, di cui si av-valgono generalmente i sociologi nelle loro descrizioni dei mass me-dia, un’analisi semiotica dei testi che circolano nella cultura di mas-sa. Laddove la prima «rileva di una epistemologia pre-saussuriana»che considera il messaggio come un insieme di entità lessicali, di pa-role che sono portatrici di significati singoli, la seconda vede in essouna configurazione complessiva di senso retta da strutture semanti-che soggiacenti. Il contenuto semantico veicolato dai mezzi di co-municazione di massa, la cui analisi è fondamentale per spiegare ecomprendere la cultura di cui essi sono produttori ed esiti, non puòessere spiegato come se si trattasse di qualcosa di evidente, sempli-ce e immediatamente comprensibile. Non solo il pubblico, infatti,può recepirlo in forma frammentaria e variabile sulla base delle pro-
50
ogni cultura tende a considerarle come testi ‘naturali’, a partire dal-l’apposizione di specifiche marche di riconoscimento, le quali ten-dono a istituzionalizzarne la valenza significativa: per esempio, nel-la nostra cultura, le copertine dei libri, i frontespizi, le cornici, le si-gle, i titoli di testa e di coda, i sipari; tutto ciò che in qualche modocostituisce una chiusura, una discontinuità fra un interno e un ester-no del testo. Ciò che tendiamo a considerare come testi ‘propria-mente detti’ – in quanto esseri umani semiotici, prima ancora che co-me soggetti costruttori di metalinguaggi semiotici per l’analisi te-stuale – è ciò che la nostra cultura ha voluto e saputo costruire cometali: si pensi per esempio alla costruzione del libro come oggetto-te-sto, che ha comportato non pochi secoli di lavoro (Genette), e cheperò noi oggi dimentichiamo, pensando i libri come strumenti ovviper la trasmissione del sapere; per non parlare dell’invenzione delquadro come oggetto artistico dotato di cornice (Stoikita), che hasubìto il medesimo destino d’oblio e di naturalizzazione dell’imma-gine in cornice. Tali operazioni di costruzione sono state per lo piùdimenticate – come le verità di Nietzsche: metafore che hanno di-menticato l’artificio retorico per costruirle –, di modo che siamo por-tati a considerare come testi ‘veri e propri’ quelli che sono dotati dei‘corretti’ segnali che li fanno appunto percepire come testi. Ci sa-rebbe insomma una preventiva testualizzazione nascosta che produ-ce una successiva naturalizzazione del testo, dalla quale discendonole differenze fra testi e non testi: fra testi ed esperienze, fra testi e pra-tiche, fra testi e oggetti, scene, situazioni, strategie e forme di vita.
Ogni testo-oggetto, se ne ricava, è in realtà un testo costruito apartire da modelli culturali preesistenti (ossia, in fin dei conti, altritesti). La sola differenza che possiamo proporre è allora quella fra leproduzioni culturali silenziose dei testi (date all’interno di ogni cul-tura, sulla base di forme implicite di valorizzazione e conseguente di-svalorizzazione del ‘noi’ e degli ‘altri’, del ‘qui’ e dell’‘altrove’, della‘cultura’ e della ‘natura’ etc.) e le produzioni semiotiche esplicite deitesti (che hanno obiettivi di conoscenza metalinguistica, e che sono,in fondo, operazioni culturali esse stesse, legate a precise mire valo-rizzanti). Per questa ragione, Greimas opera un’importante sostitu-zione: alla dicotomia «naturale vs costruito» preferisce quella di «se-miotiche scientifiche vs semiotiche non scientifiche», dove le primesono «semiotiche-oggetto trattate nel quadro di una teoria semioti-ca esplicita», e le seconde sono «grandezze del mondo umano e so-
53
dagine richiesta (si pensi a un punto vendita o all’esperienza quoti-diana dell’andare a far spese).
La neutralizzazione della distinzione fra testo e contesto porta al-la considerazione di una nozione chiave, di derivazione linguisticama in perfetta consonanza con il dettato dei cultural studies, la no-zione di discorso. Un testo, infatti, di qualsiasi natura esso sia, non silimita a trasmettere un certo numero di contenuti, come pensava lateoria della informazione; esso presenta al suo interno anche un’im-magine della situazione comunicativa in cui si trova, del suo mitten-te e del suo destinatario, e così facendo detta le regole pratiche perla sua fruizione. Ogni testo, in altre parole, svolge un discorso, nelsenso che si inserisce in un modello generico che, da un lato, lo tra-scende e, dall’altro, esso stesso contribuisce a creare. Il trailer di unfilm o un annuncio pubblicitario, per esempio, non offrono solo deicontenuti, più o meno nascosti, di tipo persuasivo, ma imbastisconoun’intera scena comunicativa grazie soprattutto al fatto che si inse-riscono in un tipo specifico di discorso: il discorso promozionale cheaccompagna l’uscita di un film o di un nuovo prodotto. Senza que-sto frame comunicativo, che esso porta al suo interno, non sarebbepossibile intenderne a fondo il senso. Da questo punto di vista, unulteriore ricorso alla nozione di contesto perde ogni utilità esplicati-va. Il discorso è una realtà sociale e testuale al tempo stesso, cultu-ralmente definita e semioticamente articolata: in quanto tale, può es-sere inteso, insieme al testo, come l’oggetto privilegiato dell’indagi-ne sociosemiotica.
La sociosemiotica è sorta, all’interno degli studi culturali, propo-nendo un apparato concettuale forte, capace di spiegare e di com-prendere una gran massa di fenomeni sociali, che vanno dall’ali-mentazione ai flussi televisivi, dalla pubblicità a internet, dal discor-so politico alla moda, dall’architettura al giornalismo, al design etc.Essa però non si limita a offrire i propri modelli d’indagine alle scien-ze sociali, non si presenta cioè, come pensava Barthes, come una me-todologia delle scienze umane e sociali. Occupandosi dei meccani-smi della produzione e della articolazione del senso, essa si colloca aun livello epistemologico diverso rispetto a tali scienze: quello del lo-ro esame critico, nel senso kantiano del termine, ossia del reperi-mento delle condizioni formali di possibilità della socialità in quan-to tale. Semioticamente, come s’è detto, il sociale non è un dato em-pirico di cui svelare le leggi più o meno nascoste, ma un effetto di sen-
52
prie competenze culturali. Non solo tale contenuto viene manifesta-to attraverso sostanze espressive diverse. Ma, soprattutto, esso assu-me una forma testuale che va al di là delle parole, delle immagini,delle melodie, dei segni che sembrano caratterizzarlo. Riversare i ri-sultati teorici dell’indagine linguistica e semiotica nell’analisi dei me-dia porta a una revisione radicale della content analysis. Il che per-mette l’emergenza di un’immagine del testo non più come ‘scatolanera’ di cui si osservano solo i flussi d’entrata e d’uscita, ma comecristallo formale di cui riesce possibile esaminare i funzionamentiformali interni ed esterni.
Analogamente, i principali protagonisti della svolta sociosemio-tica degli anni Ottanta e Novanta, Jean-Marie Floch ed Eric Lan-dowski innanzitutto, hanno già da subito chiarito il nesso fra studitestuali e studi sociali. Il primo insistendo a più riprese sul valore de-cisivo dello slogan di Greimas «fuori dal testo non c’è salvezza» perl’analisi di campagne pubblicitarie e meccanismi di marketing, og-getti di design e strategie di moda, organizzazioni spaziali e struttu-re prossemiche, fumetti e icone russe, progetti d’architettura e im-magini artistiche. Il secondo sottolineando molto chiaramente che«il reale che la sociosemiotica si assegna come oggetto, identificatocon le condizioni socialmente costruite della capacità di significaredei nostri discorsi e delle nostre azioni, non è per lei null’altro cheun’ulteriore forma del testuale». Il testo, insomma, non è secondo lasociosemiotica un oggetto ma un modello.
Si superano così anche le critiche che analisti della cultura me-diatica contemporanea (soprattutto nel campo della sociologia e deicultural studies) hanno rivolto alla semiotica, secondo le quali que-st’ultima, occupandosi di testi, non sarebbe in grado di rendereconto di tutte quelle prassi sociali complesse che trascendono i con-fini della testualità, tradizionalmente intesa, e che pure sono deci-sive per la produzione di senso. Si pensi alle pratiche di consumo,mediatico o di qualsiasi altro prodotto o marca, che, con de Cer-teau, sono produttive di significato senza per questo dipendere daun codice o essere inscritte in una qualche forma di testo. Tali cri-tiche non colgono nel segno perché continuano a pensare il testocome un oggetto, con una sua chiusura istituzionalmente determi-nata, e non come un modello d’indagine semiotica, negoziato voltaper volta fra gli attori della comunicazione (si pensi a una conver-sazione) o stabilito dall’a nalista in funzione della pertinenza d’in-
55
sue presunte decisioni razionali una propria visione del mondo, lecui logiche occorre appunto individuare. Può trattarsi di una logicadi tipo pratico (quando l’oggetto è pubblicizzato sulla base dei suoipossibili usi) o di tipo critico (quando entra in gioco una mentalitàeconomica di risparmio o di convenienza), ma può trattarsi anche diuna logica di tipo utopico (quando l’oggetto diviene funzione dellarealizzazione identitaria del soggetto che lo desidera) oppure ludico(quando l’uso viene soppiantato dalla bellezza o dal gioco). Così, laricerca sociosemiotica arretra lo sguardo rispetto a quella sociologi-ca: laddove quest’ultima si rivolge ai fenomeni empirici presenti nel-le forme collettive di vita vissuta, la prima si dà il compito di rico-struire le procedure di senso attraverso cui esiste qualcosa come unasocialità, una vita vissuta, un’empiria dei fenomeni istituzionali e col-lettivi. Per la semiotica il sociale non ha nulla di evidente, di imme-diato, se non il fatto che è esso stesso a costruire la sua presunta evi-denza, la sua immediatezza, facendo apparire come ovvio, normale,‘naturale’ ciò che in effetti è l’esito manifesto di processi immanentidi significazione.
8. Etnologia e semiotica della cultura
S’è detto del nesso molto stretto fra sociosemiotica e cultural studies.E s’è insistito sull’importanza degli assetti culturali per la costituzio-ne della testualità come anche, viceversa, degli apparati testuali perla formazione delle diverse culture. Per approfondire ancora la que-stione, è verso la ricca tradizione dello studio semiotico delle cultu-re che occorre dirigersi, incrociando autori come Claude Lévi-Strauss e Clifford J. Geertz, per raggiungere la fondamentale ricer-ca di Jurij M. Lotman e della sua scuola. Coniugando sociosemioti-ca e semiotica antropologica, infatti, lo studio dei fenomeni e degliavvenimenti culturali come testi riesce ancora più evidente, e non acaso alcuni studiosi usano per designare questa ipotesi di ricerca iltermine di ‘etnosemiotica’.
Sfrangiando molto, e concentrandoci sul problema testuale, sireincontra in campo antropologico quella opposizione fra analisistrutturale e interpretazione ermeneutica che attraverso l’esame del-la nozione di testo è finita per apparire piuttosto caricaturale. Da unaparte ci sarebbe Lévi-Strauss, promotore di uno studio formale econchiuso del funzionamento interno di fenomeni culturali come iltotemismo, il mito o la parentela. Dall’altra Geertz, che criticando il
54
so costruito di cui occorre individuare le procedure che lo hanno po-sto in essere. Scrive ancora Landowski:
A suo modo, la semiotica generale non ha mai cessato di occuparsi delreale e, a fortiori, del sociale, concepiti come effetti di senso. Formulatain termini succinti e volontariamente ingenui, la grande questione postaallo studioso di sociosemiotica sarà allora quella di rendere conto di ‘ciòche facciamo’ affinché il sociale esista in quanto tale per noi: in che mo-do ne costruiamo gli oggetti e come ci inscriviamo in essi in quanto sog-getti parlanti e agenti. L’oggetto empirico della sociosemiotica si defini-sce in questo senso come l’insieme dei discorsi che intervengono nella co-stituzione e/o nella trasformazione delle condizioni di interazione tra isoggetti (individuali e collettivi).
Così, in uno studio del discorso politico effettuato dallo stessoLandowski, la nozione di opinione pubblica viene descritta comeuna specie di personaggio che si trova inserito, a seconda dei casi, indiversi tipi di racconti. Da questo punto di vista, più che descriver-ne la nascita o individuarne gli esiti nella vita politica, l’analisi so-ciosemiotica si preoccupa di ricostruire il sistema formale che reggetutte le ‘storie’ in cui l’opinione viene inserita, il mondo fittizio a par-tire dal quale la vita politica stessa, in generale, sviluppa le sue dina-miche. Se pure l’opinione pubblica appare da alcuni secoli a questaparte come qualcosa di ovvio, tale per cui spesso si parla a suo nomerivendicandone le ragioni, essa è una costruzione semiotica, tantoimmaginaria quanto efficace, di cui si tratta di additare, prima deglieffetti ideologici, le condizioni di funzionamento. Discutere le even-tuali manipolazioni che essa subisce o rivendicare criteri obiettiviper la sua misurazione può voler dire – conclude Landowski – ne-garsi la possibilità di comprendere che la sua stessa esistenza è frut-to di una manipolazione più profonda, di cui la sociosemiotica rico-struisce le procedure sintattiche, semantiche e pragmatiche. Simil-mente, piuttosto che occuparsi dei modi in cui la pubblicità cerca dipersuadere i consumatori a comprare determinati prodotti, uno deiprimi studiosi di sociosemiotica del marketing, Floch, ha costruitoun modello generale, coerente e interdefinito al suo interno, che ri-costruisce a monte il sistema delle scelte di consumo che si trovanorappresentate nei testi pubblicitari. Emerge che, invece di limitarsia preferire un certo prodotto per ragioni di calcolo economico, ilconsumatore attribuisce a esso determinati valori, proiettando sulle
57
i miti non sono in senso proprio unità testuali ma macrotesti o, me-glio, processi di migrazione da un testo all’altro, flussi traduttivi, ca-tene intertestuali senza inizio né fine, individuabili più come generediscorsivo che non come singola occorrenza: il mito, ripete Lévi-Strauss è l’insieme delle sue trasformazioni; «l’unità del mito è solotendenziale e proiettiva, non si riflette mai uno stato o momento delmito» (principio non colto da Ricoeur). Cosa, anche questa, assolu-tamente tipica dell’universo mediatico, dove il singolo accadimentotestuale si delinea sempre all’orizzonte di un ricco flusso di altri ac-cadimenti testuali che si costituiscono e ricostruiscono di continuo en-tro cornici di genere, a loro volta continuamente riscritte.
Sia, ancora, perché nella percezione antropologica il confine traun testo narrativo, un artefatto oggettuale, la topologia di un luogoo l’organizzazione di un rituale non è così netto quanto potrebbe es-sere secondo altre prospettive disciplinari: una leggenda o un vaset-to di ceramica, un mito o una maschera possono essere testimoni dipari grado d’una qualche configurazione culturale. La celebre rico-struzione compiuta da Lévi-Strauss del villaggio Bororo, la cui strut-tura fissa si fa specchio simbolico della gerarchia sociale, è da que-sto punto di vista emblematica di una sociosemiotica della spazialitàe dell’organizzazione urbana. Per non parlare dello studio sulle ma-schere amerinde, ampiamente usato da Floch nella sua analisi deimarchi d’impresa.
Il testo, insomma, per Lévi-Strauss non va inteso come un arte-fatto linguistico più o meno elaborato ma come un qualsiasi oggettodella conoscenza antropologica, anche e soprattutto perché fa daponte fra emergenze espressive e portati di senso, ma anche fra seriecomplesse di manifestazioni della cultura materiale e grosse confi-gurazioni che lo studioso chiamerebbe, con termine ricco di ambi-guità, spirituali. Le ragioni di questa posizione sono abbastanza chia-re: innanzitutto, gli oggetti culturali sono testi poiché, come i testilinguistici, non sono elementi empirici ingenui ma dati costruiti dicui occorre dispiegare il sistema di costruzione, fatti semiotici deiquali è opportuno comprendere le condizioni d’esistenza; in secon-do luogo, perché questa operazione di costruzione si pone nel cri-nale di un’incomprensione di fondo tipicamente antropologica, eprova a superarla: quella fra il punto di vista (il sistema di codici) delcosiddetto indigeno e il punto di vista (la cultura) del ricercatore. Iltesto è l’esito di un processo traduttivo di cui vanno esplicitate le re-gole, le condizioni di esercizio, le necessarie negoziazioni.
56
presunto formalismo del primo propone una visione più dinamicadei fatti culturali e della loro analisi, nei termini di una serie di cate-ne interpretative che si innestano a partire da eventi a prima vistamolto di dettaglio, definiti testi, come il celebre combattimento deigalli a Bali. E anche questa volta vedremo, proprio grazie alla nozio-ne comune di testo – esplicita in Geertz, un po’ meno presente in Lé-vi-Strauss –, come il divario tra i due autori (e le correnti di pensie-ro che rappresentano) sia molto meno ampio del previsto. Lotman,a sua volta, ci servirà per individuare l’opera di uno studioso che, aldi là dell’immediata evidenza dei suoi scritti, si rivela di estrema uti-lità per riprendere, riassumere e riarticolare molte delle problemati-che sin qui emerse.
8.1. Antropologia strutturale
La figura di Claude Lévi-Strauss, nella sua grandezza e problemati-cità, appare a prima vista molto lontana dagli interessi sociosemioti-ci e, in particolare, dalla problematica della testualità. L’orizzonteteorico in cui questo studioso si muove – quello dell’antropologiastrutturale come esame sistemico dei fatti culturali in generale – èestremamente più ampio di quanto non possa essere quello dello stu-dio delle società dei consumi e della cultura di massa. Fra l’altro, legrandi configurazioni che egli sottopone ad analisi – le mitologieamerinde, i sistemi di parentela, il totemismo – sembrano non poteravere lo statuto di testi, almeno nel senso prevalente che attribui-scono a questo termine filologia, linguistica, letteratura, ermeneuti-ca e, spesso, anche semiotica: quello di un prodotto linguistico scrit-to, di natura per lo più letteraria, dunque fortemente idiosincratico.A ben vedere, le cose stanno diversamente. Proprio la maggior am-piezza dell’orizzonte d’indagine antropologica consente una consi-derazione del testo molto meno vincolata dalle sue accezioni più tra-dizionali.
Sia perché i testi – narrativi e non – studiati dagli antropologi sonoelementi etnici, folklorici, e cioè privi d’un autore riconosciuto, perlo più collettivi, tramandati oralmente, sino al punto da costituire unasorta di langue al contempo astratta e collettiva (Jakobson e Bo-gatyrëv): cosa che non può non interessare il semiologo alla ricercadi criteri di funzionamento della significazione che comprendano maoltrepassino la comunicazione linguistica interpersonale o i processidi scrittura/lettura. Sia perché, per esempio nel caso della mitologia,
59
Ogni cultura, pensa Geertz, si dota di una serie di strumenti percapire se stessa, per darsi un senso, per costituire una qualche im-magine – o serie di immagini – di se medesima. Questi strumenti so-no i testi, tanto immaginari quanto reali: invenzioni li chiama Geertz,creazioni fittizie non perché false ma perché confezionate, intenzio-nalmente prodotte. Siano essi discorsi, rituali, forme di comporta-mento, modi di sentire, affetti, oggetti o, soprattutto, intrecci di tut-to ciò. I testi circolano nella cultura. In quanto «documenti agiti»,stanno lì a disposizione per essere perennemente interpretati: inter-pretazione che – ermeneuticamente – costituisce per contraccolpol’identità (beninteso processuale, cangiante, fluttuante) dei soggettisociali. Il combattimento balinese dei galli, per riprendere un esem-pio celebre, è un testo per questa ragione: perché gli individui che invario modo vi sono coinvolti assistono al rito e al tempo stesso vi par-tecipano, provano e ‘scaricano’ emozioni sulla base di scale cultura-li di valori e implicite gerarchie sociali; esattamente come gli spettato-ri di una tragedia di Shakespeare o i lettori di un romanzo di Dickensche, interpretando quei testi, finiscono per comprendere meglio sestessi e l’ambiente culturale in cui si trovano – «colorando l’espe-rienza con la luce che essi vi gettano». I soggetti sociali vivono le lo-ro esperienze etniche grazie ai testi della cultura, collocandosi inqualche modo al loro stesso interno. E le interpretano nei vari sensi– cognitivo, teatrale, traduttivo – che questo termine può avere: percoglierne il senso, per vivificare dei ruoli, per tradurli in altri testi.Non è difficile cogliere in questa concezione l’influenza di Peirce, ol-tre a quella, più ovvia, di Ricoeur.
L’antropologo, a sua volta, non è un osservatore distaccato chegrazie a un preciso metalinguaggio descrittivo esterno coglie i mec-canismi semiotici propri di una certa cultura. In quanto soggetto so-ciale situato in una storia e una cultura proprie, e in quanto al tem-po stesso e innanzitutto etnografo, non potrebbe mai esserlo. Moltodiversamente, egli è sempre coinvolto nella cultura che intende de-scrivere, deve immergersi in essa senza per questo illudersi di poter-ne essere totalmente assorbito: «l’antropologo non studia i villaggi,studia nei villaggi». Il suo sguardo è dunque interno ed esterno altempo stesso: interpreta i segni culturali, non al livello dell’‘indige-no’ ma in quello secondario che gli è proprio, facendo interagire lapropria cultura con quella che sta esaminando. Interpreta interpre-tazioni, cercando di costruire quelle che Geertz, con Ryle, chiamathick descriptions, descrizioni dense, e non sottili (thin), poiché co-
58
Ma testo, in fondo, sostiene Lévi-Strauss di fatto anticipandomolte delle osservazioni di Geertz, è, più profondamente ancora, lostrumento della necessaria mediazione fra il mondo dei dati sensibi-li e la conoscenza stessa, il filtro mediante cui il sensibile si fa stru-mento dell’intelligibilità e, saussurianamente, viceversa. «Le opera-zioni della sensibilità – scrive l’antropologo nel finale delle sue Mi-tologiche – hanno già un aspetto intellettuale, e i dati esterni d’ordi-ne geologico, botanico, zoologico non sono mai intuitivamente col-ti in se stessi, bensì sotto forma di un testo elaborato attraverso l’a-zione congiunta degli organi dei sensi e dell’intelletto». Raccoglien-do la lezione della fenomenologia della percezione (a Merleau-Pontyè dedicato Il pensiero selvaggio), Lévi-Strauss riesce a superarla pro-ponendo una possibile analisi in senso testuale dell’esperienza sen-sibile. Il celebre bricolage di cui è composta la ‘scienza del concreto’dei cosiddetti primitivi (riciclo di materiali di risulta che produce og-getti originali) non è altro, come ha osservato Floch, che una proce-dura discorsiva mirante a produrre veri e propri testi: e non è un ca-so che molta attuale comunicazione di marca ne faccia uso per co-struire l’identità visiva ed estetica delle imprese.
8.2. Antropologia interpretativa
Nel lavoro etnologico di Clifford Geertz il riferimento alla semioti-ca è esplicito già dalla definizione che egli fornisce del concetto dicultura, concetto da egli esplicitamente definito come semiotico. Ri-chiamandosi a Weber, la cultura è per questo studioso identificabilecon la rete di significati che l’uomo produce, impigliandosi in essa:una serie di «sistemi interconnessi di segni interpretabili». Interpre-tabili, a ben vedere, quanto meno due volte: la prima dall’attore so-ciale determinato, dall’‘indigeno’ che vive entro una certa cultura co-me rete di significati, dando senso sociale e culturale alle cose e agliaccadimenti del mondo, nonché ai comportamenti propri e altrui; laseconda dall’antropologo che, sforzandosi di ricostruire la serie deisistemi interconnessi, si dota della capacità di interpretare a sua vol-ta quei segni, di fatto interpretando un’interpretazione. Ne vienefuori una visione della cultura non sostanzialistica e non cognitivi-sta, ma semmai estremamente dinamizzata, dove non sussistono da-ti ontologici (se non per astrazione filosofica naturalizzata) ma si-gnificati di cose e di eventi, non oggetti bruti ma processi di signifi-cazione, ossia, in fin dei conti, costruzioni testuali e loro catene.
61
metodologiche; sia perché, forse più interessante, non tutte le cultu-re pensano il testo allo stesso modo in cui viene inteso da molti teo-rici che sin qui abbiamo incontrato (prodotto scritto, verbale, con-chiuso etc.). Così Lotman ci mostra come, a fronte delle insistenti di-squisizioni circa il ‘preoccupante’ uso metaforico della nozione di te-sto per lo studio di qualcosa che di per sé non lo sarebbe (una pras-si concreta, un’esperienza, una porzione di spazio etc.), in periodistorici nemmeno così lontani da noi certe forme di comportamentoquotidiano, essendo estetizzate, venivano considerate a tutti gli ef-fetti come dei testi, oppure, in altre, certe città venivano intese allastregua di forme testuali, scritte e lette come codici miniati. In altreparole, non è affatto detto che nelle versioni emic il testo sia sempree soltanto l’oggetto libro, mentre in quelle etic esso sia un modellod’analisi: per la semplice ragione che anche per alcune culture il te-sto è usato come modello, al punto che, per esempio, non è il libroa farsi ‘metafora’ della città ma proprio il contrario: è l’agglomeratourbano a essere utile per comprendere, poniamo, i testi sacri o quel-li poetici.
Si spiega così l’equivoco (che tocca da vicino anche questa nostratrattazione), spesso additato come limite di certe metodologie te-stuali – o ‘testualiste’ –, secondo il quale l’idea semiotica del testo co-me modello formale d’analisi non fa che riprodurre l’ideale simboli-sta (che Lotman del resto conosce e considera) del Libro come im-magine del mondo, dunque collocandosi in una precisa prospettivaestetico-metafisica. Rilevare che il testo artistico come «opera d’arteè un modello finito di un mondo infinito» può effettivamente crea-re molti equivoci, poiché può essere letto sia in senso emic (per esem-pio a proposito di Mallarmé) sia in senso etic (per esempio additan-do un’opera di Puškin come caso tipico della cultura romantica rus-sa). E diverse altre affermazioni di Lotman fomentano queste ambi-guità enunciative. L’insieme della sua opera, comunque, sembra nonlasciar dubbi sullo scarto di livello fra le due posizioni, fermo re-stando l’interesse semiotico per entrambe. Il problema, come sem-pre, è la pertinenza con cui si imposta la problematica blumenber-ghiana della ‘leggibilità del mondo’, ora internamente ora esterna-mente a una cultura: rilevando, da un lato, la tendenza a considera-re il mondo come un testo e l’analisi filologica come modo precipuodella sua comprensione (che periodicamente risorge nella storia, daConfucio al folklore russo, da Galileo ai simbolisti); insistendo, dal-l’altro, sul fatto che è semioticamente possibile intendere come ‘te-
60
stituite in quanto «gerarchie stratificate di strutture significative».Ossia, ancora una volta, costruzioni testuali. Una descrizione densa,esito laborioso di un lungo lavoro metainterpretativo, finisce per co-struirsi esattamente come un testo: sia nel senso di griglia culturaleche legge dati culturali, molteplicità di livelli di senso disposti in or-dini molto precisi; sia nel senso più tradizionale di prodotti lingui-stici scritti: se l’etnografia è scrittura di resoconti (testi che Geertz usaanche come esempi per teorizzare sul proprio lavoro), l’etnologia ècreazione di opere (che alla stregua di opere letterarie egli analizzaper ricostruire il senso del lavoro antropologico di vari studiosi).
8.3. Modelli culturali
La nozione di testo in Jurij M. Lotman è al tempo stesso centrale eproblematica. Centrale poiché a più riprese, e non senza oscillazio-ni, egli la intende come perno e oggetto fondamentale di una semio-tica come studio di qualsiasi fenomeno umano dotato di senso, qual-siasi avvenimento culturale. Problematica per più ragioni: innanzi-tutto perché, avendo Lotman lavorato spesso di concerto con altriricercatori, è abbastanza complesso, ma in fin dei conti inutile, di-stinguere fra ciò che è di questo autore e ciò che è d’altri studiosi; insecondo luogo per una questione di lingua, il russo, e delle sue tra-duzioni non sempre convergenti; infine perché il termine in que-stione viene usato con molteplici accezioni di senso (ci dicono chenel costituendo lessico dell’opera lotmaniana se ne rintracciano se-dici), spesso divergenti fra loro, con tutti gli equivoci del caso. Duedi queste fluttuazioni semantiche del termine ‘testo’ costituiscono illuogo problematico che occorre qui provare a sviscerare. Da unaparte, l’oscillazione fra testo come opera letteraria e testo come pro-dotto culturale in senso più ampio, che comprende per esempio unrituale o un comportamento quotidiano, un artefatto o un quadro.D’altra parte, la tensione fra ciò che all’interno di ogni cultura vienepercepito come testo (che, con ascendenze linguistiche e antropolo-giche, definiremmo emic) e ciò che invece indipendentemente daciò, e talvolta in contrasto, lo studioso dall’esterno considera tale(versione etic). Ora, è evidente che queste due dialettiche, non coin-cidendo, si intersecano fra loro: sia perché, ovviamente, ogni stu-dioso, per quanto miri all’obiettività, è sempre coinvolto in una qual-che cultura (Geertz docet), finendo spesso per sovrapporre la pro-pria idea della testualità alle sue stesse modellizzazioni teoriche e
63
denze culturali, la vita quotidiana. Così per esempio la nozione distraniamento artistico coniata da Šklovskij cambia di senso a secon-da se la si intende come una deviazione dalle abitudini percettive,uno stravolgimento dei canoni letterari o una deviazione dalle rego-le linguistiche standard: sono la pertinenza descrittiva e il contestodi riferimento a determinare ciò che viene straniato, nonché il suo si-gnificato. Nella tensione costitutiva fra struttura testuale interna estrutture culturali esterne – pensata come relazione percettiva dina-mica fra una figura e il suo sfondo – si determina il senso dell’opera,ma soprattutto la possibilità di descriverlo coerentemente, di ogget-tivarne l’intenzionalità.
Piuttosto che limitarsi ad adeguare i testi ai contesti, cercando inquesti ultimi le spiegazioni dei primi, lo sforzo di Lotman è quello diricostruire modelli antropologici molto ampi a partire da analisi te-stuali molto minute, siano esse condotte entro l’ambito lette rario co-sì come entro quello religioso, storiografico, folklorico, culturale etc.La poesia, da questo punto di vista, è per Lotman il campo testualedove il lavoro sul linguaggio finisce per avere esiti che trascendonol’immediata intenzionalità artistica, producendo stili di vita che so-no al tempo stesso creazioni estetiche e organizzazioni sociali. Così,l’opera di Puškin, su cui Lotman è tornato più volte, non è sempli-cemente un corpus poetico dove ci si esercita in modo più o menogradevole nell’arte della composizione e della versificazione: essa èsoprattutto il luogo a partire da cui comprendere a fondo tutta unasensibilità, quella romantica, e, dunque, tutta un’epoca, quella tar-do-ottocentesca. Analizzare la struttura di un testo artistico signifi-ca, in questo quadro, spiegare come esso «diventi portatore di unpensiero determinato, di un’idea» e, nello stesso tempo, «come lastruttura del testo si rapporti a quest’idea». In altri termini, non c’è– secondo Lotman – da un lato il pensiero (contenuto) e dall’altro iltesto (forma) che lo dice a suo modo; c’è semmai un’organizzazionestrutturale interna del testo che produce un determinato pensiero,salvo poi prenderne le distanze e interagire con esso. La relazione tratesto e contesto si fa così dialettica, per quanto asimmetrica e con-flittuale. Da un lato il tempo storico viene identificato con il ‘rumo-re’ che, secondo la teoria dell’informazione, produce la necessariadose di entropia comunicativa. Da un altro lato l’esteticità del testoè quel sovrappiù di significazione che, garantendo al testo la sua ef-ficacia informativa, costituisce la configurazione generale del perio-do storico entro cui esso viene prodotto o circola. Se, in altri termi-
62
sto’ «in senso lato qualsiasi comunicazione registrata in un dato si-stema segnico [...]: possiamo parlare di un balletto, di uno spettaco-lo teatrale, di una sfilata militare e di tutti gli altri sistemi segnici dicomportamento come dei testi, nella stessa misura in cui applichia-mo questo termine a un testo scritto in una lingua naturale, a un poe-ma o a un quadro».
Punto di partenza della riflessione lotmaniana sul testo è l’ereditàdel formalismo russo, con la quale egli deve e vuol fare i conti, sullosfondo del marxismo sovietico che domina nell’ambiente cultura-le entro cui, per gran parte della sua carriera, lo studioso si trova aoperare. La nozione di testo viene adoperata da Lotman per indica-re la struttura interna all’opera letteraria, che si fa garante della suaespressività grazie ad alcune caratteristiche necessarie come la deli-mitazione e la gerarchia dei livelli di organizzazione interna, sia pa-radigmatici sia sintagmatici. Il testo, al modo dei formalisti, è unasorta di oggettivazione dell’opera o, meglio, la possibilità di una suadescrizione operativa, se non propriamente scientifica, quanto me-no discutibile e condivisibile, nient’affatto intuizionista e soggetti-vante. Questa oggettivazione dell’opera mediante la sua descrizionetestuale, però, non considera solo il lato formale del ‘procedimento’più o meno ‘straniante’, secondo il noto insegnamento di Šklovskij,Tomaševskij, Tynjanov e compagni, ma va arricchito, seguendo lalinguistica strutturale, anche del piano del contenuto, senza il qualeun testo non sarebbe propriamente tale. La solidarietà fra espressio-ne e contenuto permette una maggiore dinamicità dell’oggetto te-stuale, poiché inevitabilmente lo apre sia alle tattiche conoscitive dichi lo analizza sia al suo specifico contesto storico e culturale. Emer-ge la relatività del testo, la cui conformazione si stabilisce (e qui Lot-man già incontra Greimas) in funzione del progetto di descrizionedello studioso: il medesimo materiale documentario come il Viaggiosentimentale di Sterne acquista valori e significati diversi a secondase viene considerato come semplice frammento testuale, progettoestetico non finito e meccanicamente deteriorato, oppure come rea-lizzazione della poetica artistica dell’autore, dunque come un vero eproprio testo. Da cui l’importanza di una definizione del testo infunzione del suo contesto: che non è da intendere, alla maniera delmarxismo più greve, come struttura economica profonda che dettadeterministicamente la funzione all’opera spirituale, ma come colle-gamento semiotico con il progetto di poetica autoriale, la tradizioneletteraria, le norme di genere, la lingua comune, l’insieme delle cre-
65
alla cosa rispetto al segno etc. (come insegnano fenomeni a prima vi-sta di dettaglio come la natura morta, i ritratti pittorici o le bambo-le). La cultura è un insieme di testi dove il referente del primo di-viene significato per il secondo, e così all’infinito, e dove anche i me-tatesti – poetiche più o meno prescrittive – hanno il medesimo ruo-lo di testi culturali. La celebre nozione di semiosfera si innesta qui,descrivendo la cultura attraverso l’immagine dell’essere vivente, coninnumerevoli organi e innumerevoli funzioni, ma soprattutto contutti i problemi di adattamento all’ambiente e di conseguente tra-sformazione che vengono convocati da un simile immaginario bio-logico. Così, l’esistenza del testo è paragonabile a quella di un orga-nismo vivente: la sua vita è possibile sempre e soltanto in relazionead altri esseri, entro campi d’azione fortemente conflittuali in cui lalotta quotidiana per la sopravvivenza è al tempo stesso funzione del-la continua trasformazione delle lingue e delle culture. E la culturaumana non viene più intesa – alla stregua del primo strutturalismo –come un sistema statico che deriva da una primaria modellizzazionedel mondo compiuta dalla verbalizzazione linguistica. C’è invece unintreccio dinamico tra lingua e mondo, tra cultura ed extracultura: èl’atto semiotico che produce la lingua e, per contraccolpo, il mondo,la cultura e, per presupposizione, la natura. Così, scrive Lotman, «lospazio, che si estende al di fuori della lingua e al di là dei suoi confi-ni, entra nella sfera della lingua e si trasforma in ‘contenuto’ comeelemento costituente della dicotomia contenuto/espressione. Parla-re di contenuto non espresso è un nonsenso». Secondo Lotman, ilreferente esterno, in quanto oggetto inerte e privo di significazione,sostanzialmente non esiste. Non nel senso che non esiste la realtà(naturale e sociale), ma in quello per cui essa non esiste di per sé, aldi fuori di una lingua che lo fa proprio, che lo inserisce al suo inter-no come contenuto specifico, ogni volta diversamente strutturato. Sipone così, nella dinamica culturale, il problema non tanto di mette-re in relazione la lingua con il mondo, ma di ristabilizzare senza so-sta il mondo come contenuto della lingua e il mondo come realtà ex-tralinguistica, laddove sia il primo sia il secondo si danno in questacontinua problematizzazione e trasformazione. Ma cos’è la realtà ex-tralinguistica? La risposta di Lotman è lampante: è il contenuto diun’altra realtà linguistica. Se ci sono allora quanto meno due livellidi oggettività (uno interno e uno esterno a una data lingua, a una da-ta cultura) è perché ci sono sempre, in effetti, almeno due lingue, dueculture. Se in un’esperienza immediata prendiamo atto d’una rela-
64
ni, non si danno testo e poeticità senza un orizzonte socio-culturaleentro cui pensarli o fruirli, allo stesso modo è solo a partire dai testie dalla loro carica estetica interna che si producono e, soprattutto,sussistono gli orizzonti socioculturali stessi. Così, i grandi modelliculturali possono essere ricostruiti solo a partire dalle microstruttu-re, apparentemente inessenziali, dei singoli testi, in un gioco che, perLotman, non ha nulla di meccanico o di deterministico. Esso è sem-mai dinamico, imprevedibile, cangiante.
Da qui tutta la riflessione lotmaniana fra testo e contesto, che co-stituisce una delle chiavi di volta della intera opera di questo studio-so. Da una parte le strutture gerarchiche interne ai prodotti testua-li, da un’altra i vari fenomeni culturali che, agganciandosi ai primi,possiedono strutture semiotiche analoghe, da un’altra ancora i prin-cipi di autodescrizione interna d’ogni cultura affidati a metatesti chesoppesano i valori d’ogni testo e d’ogni fenomeno culturale. Il tuttoa partire da quei metameccanismi o modelli culturali che Lotman ri-costruisce per descrivere il modo in cui, opponendosi fra loro, le cul-ture erigono la propria identità specifica. Fra questi diversi elemen-ti non c’è una differenza ontologica a priori ma una gerarchia varia-bile di relazioni: ciò che è testo può diventare contesto secondo unadiversa prospettiva culturale (un componimento poetico che divie-ne modello di produzione estetica); ciò che è comportamento puòessere descritto e valutato da metatesti culturali interni (le dichiara-zioni di poetica, le tavole dei generi, i manifesti delle avanguardie,ma anche i manuali di buone maniere, i catechismi etc.); ciò che èmetatesto può a sua volta essere inteso come testo al grado zero (unaricetta di cucina letta come una poesia); ciò che appartiene a un ge-nere può col tempo essere ripensato in un altro (una preghiera o untrattato scientifico divengono per esempio opere letterarie). E cosìvia. Il testo della cultura è sia il singolo testo che una cultura produ-ce al suo interno sia la testualità intera di quella cultura: le due coseessendo, in molti casi, isomorfe, e facendo da modello l’una all’altra.
Appare evidente perché «il testo può essere inteso come il pro-gramma condensato di tutta una cultura». Una cultura è un insiemedi lingue somiglianti ma diverse, asimmetriche, in dialogo e conflit-to fra di esse, conviventi grazie a un metameccanismo culturale piùampio, che è esso stesso una lingua, o forse un testo, spesso a carat-tere normativo, che decide, per esempio, se è più importante l’im-magine o la parola, quale ruolo affidare all’oralità rispetto alla scrit-tura, che importanza dare alla vita vissuta rispetto all’opera d’arte,
67
originario, ne produce un altro: come un crocifisso che, quando tol-to dalla chiesa in cui valeva come oggetto religioso, genera un luogonuovo, il museo, entro cui esso vale come opera d’arte. Ogni testocrea la propria esteriorità in funzione del significato globale di cuiesso è portatore, entra in dialogo col suo esterno, come un edificioche col suo stile dà un senso agli altri che gli stanno intorno in unastrada, per analogia o per contrasto.
Torna così l’idea derridiana dell’impossibilità – teorica ed effet-tuale – del fuori-testo, dell’essenziale paradossalità del nesso inter-no/esterno: ogni volta che tale distinzione viene prodotta, qualun-que sia la sua declinazione specifica (testo/contesto, cultura/natura,città/campagna, noi/altri etc.), essa viene negata a un livello supe-riore, quello del metameccanismo culturale che pure la rende ope-rativa, in qualche modo producendola: il contesto è un testo, la na-tura è culturale, la campagna sta dentro le mura cittadine, gli altrisiamo noi... Non appena si produce una separazione (per esempio,città/periferia), ecco che immediatamente si genera un omeomorfi-smo, per definizione paradossale, fra il tutto e le sue parti (la perife-ria dentro la città o viceversa). È per questo che Lotman insiste, pra-ticamente lungo tutta la sua opera, sul fenomeno del testo nel testo(romanzo nel romanzo, teatro nel teatro, film nel film, casa nella ca-sa, città nella città etc.), che non è il caso sporadico, più o meno ri-levante esteticamente, della mise en abyme, ma una sorta di mecca-nismo essenziale della semiosfera, quello per cui, per esempio, la se-miosfera stessa è a sua volta il luogo unitario dove si generano mol-teplici semiosfere, e così all’infinito. Torna l’idea della pertinenza, dimodo che – sia per una determinata cultura sia per l’analisi testuale– un medesimo oggetto come le Novelle di Belkin di Puškin può es-sere considerato a seconda dei casi ora un testo unico ora un insie-me di testi ora la semplice parte di un testo più ampio (il genere del-la novella russa dell’Ottocento).
9. Congedo dalla rappresentazione
Da ciò che s’è detto sin qui apparirà ancora più chiaro quanto do-vrebbe stare alla base d’ogni prospettiva di studio di tipo sociose-miotico: la non pertinenza – metodologica e teorica al tempo stesso– della nozione di rappresentazione. Se espressione e contenuto so-no nel testo in presupposizione reciproca, e se testo e contesto si de-finiscono l’un l’altro, sia nella cultura sociale sia nell’analisi te-
66
zione immediata tra la lingua e il mondo (o tra il soggetto e l’ogget-to) è perché ipotizziamo la presenza di un solo linguaggio, il quale,se osservato in profondità, è invece la risultante di tante lingue di-verse, tra loro intersecantesi. A sua volta, il reale posto al di fuori del-la lingua è la risultante dei contenuti espressi in altre lingue.
Per quel che ci pertiene nel dettaglio, viene fuori in tal modo l’i-dea per cui ogni cultura stabilisce al suo interno che cosa è testo eche cosa non lo è, quali configurazioni semiotiche acquisiscono di-gnità testuale, hanno valore, dunque senso, per la cultura medesima(hanno un ‘significato globale’ per chi li enuncia e li recepisce, comeanche ‘funzione globale’ per lo studioso della cultura), e quali inve-ce non lo acquisiscono: da cui le opposizioni assiologiche fra oralitàe scrittura, testi religiosi e testi scientifici, vita e scrittura etc. E lo stu-dioso, sottolineando il carattere testuale di alcune configurazioni inquella cultura, rinverrà al contempo il carattere anti-testuale di altre,la culturalizzazione (dunque la testualizzazione) di ciò che, per quel-la cultura, non è testo. Per esempio, quando si diffonde la naturamorta, divenendo percepita come un testo degno di considerazione,accade che le cose, che prima venivano considerate come elementibruti del mondo, cambiano di statuto e iniziano a essere percepitecome segni: non ci sono più bottiglie, brocche, prugne o fagiani, mai segni di tutto ciò. L’esistenza culturalmente rilevante del genere pit-torico determina una trasformazione nel modo di percepire la realtà.
La conseguenza di tutto ciò, ancora una volta, è la constatazioneper cui, a ben vedere, non è lo studioso che, analizzando il mondoculturale, per esigenze di descrizione pone come testo qualcosa chenon lo è, studiando questo qualcosa ‘come se’ fosse un testo, for-zando un po’ le cose pur d’arrivare a un qualche risultato interes-sante. Più profondamente, sono le culture a modellizzare il mondo,generando un metameccanismo che distribuisce le sue emergenzeora in testi ora in cose che non lo sono, essendo in realtà modelliz-zate anch’esse in quanto, per esempio, anti-testi che si oppongono aiprimi, oppure in semplici non testi, pure ‘cose’. Le ‘cose’, in altri ter-mini, costituiscono l’anti-modello del modello testuale, sono dun-que modelli in negativo, modelli a loro volta. Una città può essereprogettata, in certi periodi, come modello razionale del mondo, rea-lizzazione dell’utopia illuministica; oppure può emergere in altreculture come anti-modello: luogo del disordine, del caos, dell’anti-ragione, della non cultura. Il fatto è che, dice ancora Lotman, «ognitesto emana la sua aura di contesto». Se pure tolto dal suo contesto
69
dialoghi fra i due personaggi protagonisti della storia, ricchi di frasifatte e opinioni banali, Greimas non intende studiare il dialogo let-terario in sé e per sé ma, più in generale, la conversazione quotidia-na. Analogamente, esaminando gli inutili tentativi da parte del ge-nerale nemico di ottenere la parola d’ordine per entrare in città,Greimas esamina le tecniche retoriche ed ermeneutiche di manipo-lazione, persuasione, interpretazione, controinterpretazione etc. Dipiù: analizzando il modo in cui Maupassant (fedele al dettato reali-sta dell’impersonalità dell’autore e del rifiuto d’ogni punto di vistainterno alla mente dei personaggi) rende conto della dimensione co-gnitiva degli attori in gioco, mai esplicitata ma inferibile dai lorocomportamenti, Greimas prova a ricostruire lo spazio cognitivo glo-bale – o, se si vuole, reale. È così che un racconto cosiddetto di fin-zione si fa strumento di mediazione per accedere alla spiegazione ealla comprensione di una serie di realtà e di fenomeni che esso in-scrive come propri contenuti, i quali pure in qualche modo lo tra-scendono. Analogamente in Dell’imperfezione, dove si propone distudiare in senso semiotico i processi sensoriali e percettivi del cor-po, Greimas non descrive direttamente tali processi (come dichiare-rebbe di fare, per esempio, uno psicologo), ma studia il modo in cuiessi vengono raccontati in alcuni testi letterari (di Tournier, Calvino,Rilke, Tanizaki etc.). Da quei singoli testi, o talvolta da alcuni lorobrevissimi frammenti, Greimas estrae modelli discorsivi che scom-mette possano avere una qualche esemplarità, aspirare cioè a una ge-neralizzazione: applicandoli ad altri fenomeni, ad altri testi, se nepuò avere una sorta di verifica.
In fondo, a ben pensarci, questa maniera di procedere non è néoriginale di Greimas né specifica della semiotica: Lotman, abbiamovisto, insiste spesso sul ruolo esemplare che certi testi (letterari enon) possono avere per la comprensione di certe epoche storiche, dicerti assetti culturali (Puškin o Leopardi sono il Romanticismo).Geertz fa la stessa cosa con la cultura balinese, per descrivere la qua-le esamina un lungo brano d’un romanzo dello scrittore daneseHelms. Ma è quel che fanno comunemente gli storici, i quali leggo-no Proust per capire la società francese di fine Ottocento; che fannoi sociologi dei consumi, quando cercano in un romanzo di Zola il va-lore sociale dei primi grandi magazzini; che fanno gli studiosi di con-versazione, che provano a ricostruire grazie ai celebri dialoghi di He-ming way le leggi della presupposizione; che fanno i sociologi urba-ni, quando leggono De Lillo per comprendere il senso della metro-
68
stual/socio/semiotica, perde definitivamente di sussistenza l’ideache i testi non siano realtà effettuali ma tutt’al più una loro rappre-sentazione – se non necessariamente fittizia (come pure surrettizia-mente si tende a pensare) in ogni caso orientata verso scopi oraespressivi, ora estetici, ora politici, ora ideologici e quant’altro. Co-me quando si dice che un romanzo rappresenta una certa porzionedi mondo, un film rappresenta una certa realtà sociale, uno spot rap-presenta un determinato stile di vita etc. – pur senza in effetti esser-lo. E che dunque studiare ‘direttamente’ la realtà sociale, l’effettivitàdel mondo, può essere più conducente che non soffermarsi su for-me testuali che realtà non sono ma soltanto, appunto, una sua rap-presentazione. Ora, questa idea, questo modo di argomentare, que-sta convinzione diffusa, come dicevamo sin dalle prime pagine diquesto scritto, sono retaggio più o meno consapevole di una posi-zione epistemologica positivistica, ingenuamente realista (o, che è lostesso, banalmente estetizzante) che gran parte della riflessione filo-sofica, soprattutto fenomenologica ed ermeneutica, della ricerca et-no-antropologica e sociale, della sociologia ed etnografia della scien-za, inclusa ovviamente la semiolinguistica, ha già da tempo, e ab-bondantemente, superato. Eppure, per tante ovvie ragioni, esse so-no incredibilmente dure a morire: supportate dal senso comune, rie-mergono non appena si abbassa anche solo per un momento la guar-dia contro la loro melliflua pervasività. Talvolta anche entro gli scrit-ti e i dibattiti dei semiologi.
Torniamo allora ancora una volta sulla questione. In primo luo-go, il testo non è rappresentazione del mondo per il semplice moti-vo che lo contiene al proprio interno come suo contenuto e, a benpensarci, fa parte di tale mondo, agisce in esso come forza sociale.Studiare il testo – ma innanzitutto leggerlo, fruirlo – non significasoffermarsi su elementi formal-espressivi che parlano di una realtà aessi esterna, ma cogliere il modo in cui espressioni e contenuti si co-stituiscono insieme, agendo nel sociale. Per questa ragione, uno stu-dioso come Greimas, quando deve studiare certi fenomeni sociali eculturali, va a cercare – motivando comunque la ragione della scelta– testi esemplari che ne parlino. Il libro su Maupassant, per esem-pio, non parla tanto o soltanto del racconto Deux amis, ma di tuttociò che in esso viene raccontato: la guerra franco-prussiana, la vitaquotidiana a Parigi in quel periodo, il sentimento di pace dei fran-cesi, la loro proverbiale autoironia opposta alla rigidezza morale deitedeschi e così via. Ma, ancora più in dettaglio, analizzando alcuni
71
è un problema di pertinenze. È per questo che la distinzione fra la-voro field e lavoro desk perde qualsiasi utilità, e si rivela essere unagrave ipostatizzazione di convinzioni epistemologiche tanto banaliquanto insistenti: sostanzialmente positivistiche. Qualsiasi ricercasociale seria è sempre sul campo e alla scrivania: ogni osservazionesul campo è analisi testuale, e/o la presuppone; ogni analisi testualeè lavoro sul campo, e/o lo presuppone.
Insomma, come i successivi capitoli di questo libro proverannoulteriormente a mostrare, si può fare sociosemiotica lavorando sia su‘testi’ sia su ‘non testi’: sia perché anche i secondi lo sono, sempre-ché abbiano un qualche senso; sia perché nei primi c’è già come lo-ro contenuto il mondo sociale che s’intende descrivere; sia perchésia gli uni sia gli altri sono attori sociali che agiscono nel mondo,spesso di contro ad altri attori sociali, con proprie competenze prag-matiche e passionali, capacità cognitive, valori di riferimento. Vice-versa, voler analizzare le sedicenti ‘pratiche’ come se non fossero te-sti, ma chissà quale altro dato presunto ‘puro’, non mediato, signifi-ca ricadere inconsapevolmente in forme di testualità che, essendonon individuate (e spesso rifluenti nel senso comune), non si riescea controllare – con evidenti conseguenze sul piano dei risultati co-noscitivi.
10. Criteri di fondo, con qualche perplessità
Su tutto ciò abbiamo provato a riferire e ad argomentare in altre sedi,e appare ridondante soffermarcisi ulteriormente. Piuttosto, tenendosullo sfondo le numerose ricerche sociosemiotiche che si sono mol-tiplicate in questi decenni, e riassumendo quanto detto sin qua, sem-bra di poter elencare alcuni principi o criteri di fondo per la costi-tuzione o il rinvenimento della testualità sociosemiotica. L’elenco èprovvisorio e parziale, ovviamente, per nulla esaustivo, derivantedalla necessità di fissare dei punti e invitare alla discussione.
Innanzitutto, è fondamentale il principio della negoziazione, cheelimina in partenza ogni preteso ontologismo. Non esistono testi conuna loro sostanza espressiva o una loro conformazione privilegiata:un piccolo segno, un emblema, un marchio, un logo possono essere,a determinate condizioni, veri e propri testi; così come, ad altre con-dizioni, essi possono diventare elementi di occorrenze testuali piùampie, come per esempio un’intera strategia di brand. Il segno e isuoi elementi minimi sono realtà polari che cambiano di volta in vol-
70
poli americana; che faceva in fondo Marx, quando cercava in Balzacla spiegazione della psicologia sociale del capitalismo. O ancora, la-sciando da parte la letteratura, è quel che fanno gli archeologi, cheda piccoli frammenti di oggetti, di costruzioni o di corpi ricostrui-scono progressivamente tutta un’epoca e una cultura: interpretanoe analizzano testi – né potrebbero fare diversamente.
I testi, in tal modo, sono anche e soprattutto documenti, monu-menti talvolta, a prescindere dalle – o nonostante le – intenzioni dichi li ha prodotti: le quali ovviamente vanno considerate nel corsodell’indagine sociosemiotica. Se studio una serie di campagne pub-blicitarie per cercare di comprendere come cambiano gli stili di vitaquotidiana grazie all’avvento e alla diffusione del telefono cellulare(o, con le dovute differenze, di qualsiasi altra odierna tecnologia: dalnavigatore satellitare all’iPod, dal notebook alla rete), devo tener con-to di che tipo di pubblicità si tratta, quali sono i suoi obiettivi strate-gici, qual è l’intenzionalità del testo, come la chiamerebbe Ricoeur,del resto assolutamente evidente, esplicita. Se prendo un brano lette-rario, devo tener conto che si tratta di un testo estetico. Se trascelgoun oggetto d’arredamento – il divano di casa, la lampada sul como-dino – non devo dimenticare la sua origine funzionale. E così via.
I testi-documenti, fra l’altro, hanno una importante caratteristi-ca: quella di essere attestati, esistenti, concretamente esperibili, aprescindere dalle esigenze dell’analisi. Non sono stati prodotti peressere analizzati, ma, appunto, per altri scopi, con altre intenziona-lità che – una volta evidenziate – non costituiscono un problema e,al contrario, sono una garanzia di ‘naturalità’, di ‘ingenuità’, di ‘au-roralità’. Prerogativa che non hanno, viceversa, tutti quegli altri te-sti verbali e circostanze esperienziali – interviste, test, focus group,esperimenti di laboratorio – che invece vengono prodotti ad hoc peressere analizzati, dunque in circostanze d’enunciazione che non so-lo risentono dell’intenzionalità osservativa e in ultima istanza scien-tifica, cioè generalizzante, del ricercatore, ma non circolano nellacultura se non come documenti per la ricerca, non hanno altro valo-re sociale se non quello di essere testimoni di un operare accademi-co. Se ne ricava che fra un annuncio pubblicitario e un’intervista ‘ru-bata’ estemporaneamente per strada, il primo è molto più spontaneoe naturale della seconda; la seconda è molto più artificiosa del pri-mo. O meglio: se dal punto di vista sociale e comunicativo l’annun-cio è costruito e l’intervista è spontanea, dal punto di vista della ri-cerca sociosemiotica è assolutamente il contrario. Ancora una volta
73
danno, per contraccolpo, una sostanzialità. In altre parole quel cheè importante affinché ci sia significazione testuale non è né la sceltadella materia che si adopera (sonorità, visualità etc.) né la sceltadelle tematiche da comunicare, ma la relazione fra le due cose, chepuò darsi se e solo se entrambe le cose, materia e tematica, vengonoin qualche modo articolate, manipolate, formate appunto. Così, nonc’è più una certa materia sonora ma una conformazione espressivaprecisa, la quale genera ed è generata dal movimento parallelo: quelloper cui non c’è in generale una certa tematica, ma un modo di argo-mentarla, di trattarla, di disporla, di formarla appunto. È solo quandole sue operazioni di formazione sono avvenute, parallelamente e infunzione reciproca, che si dà senso umano e sociale. Si capisce così, ancora una volta, la ragione per cui il testo non è un dato oggettivoma una costruzione formale (per giunta dinamica e cangiante): è ilprocesso di una messa in relazione fra due concomitanti operazionidi formazione, arbitraria in partenza ma necessaria strutturalmente,e quindi in continua trasformazione: negoziazione appunto. Si pensiper esempio al design, che non è mai progetto di cose, di oggetti eloro tecnologie, ma delle relazioni che si istituiscono fra queste cose,materialmente e fisicamente date, e il senso che socialmente hannoo possono avere – dove all’interno del senso sociale ci stanno anche,ovviamente, le loro funzioni pratiche. Non si progetta – vedremo –un paio d’occhiali ma un modo di voler manifestare (o nascondere)il viso. Analogamente per l’architettura: non si progetta un apparta-mento ma, volenti o nolenti, un certo modo di abitarlo, dunque unacerta immagine della famiglia, o della non famiglia, che lo vivrà. Cheè un altro modo in fondo per dire che un testo non è il libro, fisica-mente dato, ma ciò che emerge quando lo si legge.
Dal principio della negoziazione scaturisce anche il terzo punto,quello della chiusura testuale, che non è mai data una volta e per tut-te, se non entro canoni comunicativi abituali, più o meno accentua-ti. Una cerimonia, per esempio, ha suoi limiti ben percepibili: ne vadella cerimonia stessa, dove precisi enunciati performativi dettano,tra l’altro, l’apertura e chiusura dell’evento («introibo ad altare dei»,«andate in pace»; «dichiaro aperta – o chiusa – la seduta» etc.). Unevento mondano, come una festa in piazza, ha confini meno rigidi, ameno che non intervenga l’autorità pubblica per regolamentare gliorari. In generale, il confine testuale, semioticamente, è sempre va-riabile, di modo che anche le circostanze di enunciazione, di produ-zione talvolta del testo, possano entrare a far parte del testo. Basti
72
ta il loro ruolo: una parola può essere portatrice di significato in sé(e diventare un testo), ma per lo più è ora un composto di monemie fonemi ora una singola entità entro una frase, la quale a sua voltaè elemento minimo d’un intero discorso; analogamente la relazionefra il testo e le sue parti, o fra testo e macrotesto, è variabile: è la per-tinenza assunta a deciderlo volta per volta. Del testo, tutto è nego-ziato, a iniziare dai suoi confini, spaziali o temporali, fisici o seman-tici. Come si diceva sopra per le sigle televisive, per le cornici deiquadri, per le copertine dei libri, per i sipari teatrali, si tratta di en-tità che, per quanto abitudinariamente siamo portati a considerareovvie, non per questo sono meno negoziate, e in qualsiasi momentopossono tornare a essere oggetto di contrattazione: sia fra soggettisociali (attori che a teatro aboliscono il sipario e scendono in pla-tea...) sia fra l’oggetto ‘empirico’ di conoscenza e lo studioso (che de-cide per esempio di prendere un intero genere, e non una singolaopera, come proprio campo di indagine). Così, in una conversazio-ne quotidiana non esistono soltanto le norme che regolano i turni fragli interlocutori, ma anche norme che regolano l’apertura e la chiu-sura, le quali vengono negoziate in praesentia: come quando vogliochiudere una telefonata ripetendo «d’accordo», «è tardi», «ti devosalutare» e simili, ma dall’altro lato il mio interlocutore vuol conti-nuare a chiacchierare. Similmente questo processo funziona per quelche riguarda i luoghi, che pur avendo articolazioni interne e confiniprescritti, per esempio, dai progettisti, vengono per lo più vissuti dasoggetti che ne trasformano il senso modificandone la pianta e i con-fini fisici, rinegoziandoli fra loro. Una città, per esempio, è l’esitocontinuo di una serie di processi fra forze sociali spesso avverse fraloro, le quali mediante le loro relazioni polemico-contrattuali fini-scono per determinare il testo concreto della città, le sue articola-zioni interne, il sistema d’accenti e marcature, di valorizzazione e di-svalorizzazione dei luoghi, la produzione di centri di socializzazionee di simmetriche periferie ‘dormitorio’ e così via.
L’idea di negoziazione è costitutiva della realtà testuale per la sem-plice ragione, a ben pensarci, che la fondamentale caratteristica deltesto – delle lingue, della semiosi in generale – è quella della bipla-narità, della presupposizione reciproca di due piani, espressione econtenuto, ognuno dei quali è dotato di una materia (relativamentenon pertinente) e di una forma (invece costitutiva). A fondare il testo è la solidarietà di base fra una forma dell’espressione e unaforma del contenuto, le quali fanno emergere la significazione e le
75
colare. La tenuta testuale, in questo senso, non esclude affatto, an-zi richiede fortemente, la trasformazione interna, l’intrinseca pro-cessualità. Un testo, infatti, oltre a una sua organizzazione sistema-tica (cioè paradigmatica), ha anche un suo dispiegarsi sintagmatico,che può manifestarsi come temporalità nella comunicazione lingui-stica o in certi audiovisivi, dispiegamento spaziale degli elementi vi-sivi in una immagine, narrazione vera e propria – dove comunquesi danno regole precise sulla base delle quali ciò che è all’inizio e ciòche è alla fine non è mai la stessa cosa. A dispetto di ogni pretesacircolarità, per esempio in certi generi folklorici formulari, la per-cezione degli elementi, e dunque il loro valore semantico, si modi-fica sempre e comunque nel corso del testo. Certo, ci sono casi incui, come nel racconto mitico, il contenuto è inizialmente invertitoe solo alla fine posto, come ha indicato Greimas rileggendo le Mi-tologiche di Lévi-Strauss. E altri in cui non è così, come in certe im-magini fisse. In ogni caso, si dà nel testo un’organizzazione narrati-va profonda dove un programma pragmatico/passionale e unoscontro fra soggetti portano a una trasformazione soggettiva, indi-viduale o collettiva.
Da qui un ulteriore punto da ricordare, quello dei molteplici li-velli del testo, ossia il fatto che la conformazione semantica com-plessiva di un insieme testuale può essere colta in modo più o menosemplice o complesso, in modo più o meno astratto o concreto. InGreimas, come s’è detto, questo principio viene definito percorsogenerativo del senso, e descrive strutture profonde di tipo narrativoe strutture di superficie di tipo discorsivo, dove la testualizzazionepuò aver luogo in qualsiasi momento e livello. In generale, comun-que, è evidente che, sia al momento dell’esperienza vissuta sia inquello dell’analisi testuale, il medesimo senso può essere più o me-no espanso o concentrato, compreso ora dispiegandolo in elementinumerosi e intricati ora sussunto in pochi tratti definitori. Ogni te-sto è ridetto o ridicibile – come nella semiosi illimitata di Peirce –grazie agli infiniti modi in cui può venir tradotto, a cominciare daimolti livelli di pertinenza in cui esso, già al suo interno, può esserespiegato, aggredito. Sia esso il livello della narratività profonda, chefa da sfondo comune e da griglia interpretativa per ogni significa-zione umana e sociale, sia esso quello della discorsività, come un sog-getto enunciante (enunciatore o enunciatario) posiziona il testo inuna comunicazione sociale che gli permette di circolare, preesisten-do a esso ma comunque avvalendosene.
74
pensare ai testi cosiddetti interattivi, crossmediatici etc., dove la ri-sposta del destinatario contribuisce alla costruzione autoriale del te-sto. Ma basti pensare anche a molti prodotti dei mass media, doveper esempio la firma d’un regista o la presenza di un divo cinemato-grafico in un film predetermina la trama, innescando una serie diaspettative sui suoi esiti, che possono essere più o meno rispettate.Probabilmente, molti equivoci che sono sorti intorno alla famigera-ta chiusura testuale, imperativo categorico dell’analisi strutturale,potrebbero dissolversi se la si considerasse in modo debole, nego-ziabile appunto (com’è del resto nel termine francese clôture), e nonin senso forte, in quanto fissazione definitiva (com’è invece nel ter-mine fermeture, che difatti non viene mai usato per designare questaspecifica proprietà del testo). Ciò permetterebbe di mettere ben afuoco che, se pure i confini testuali non sono ontologici, essi co-munque debbono esserci: non foss’altro che per segnare quella di-scontinuità costitutiva, quella basilare percezione della differenzasenza le quali nessuna significazione potrebbe aver luogo, neancheemergerebbe. Una città, per esistere come oggetto di senso, per es-sere percepita come tale, deve avere dei confini: siano essi il solcotracciato con l’aratro da Romolo o il muro di Berlino o il cartellostradale che la denomina: è la ragione per cui, oggi, dinnanzi agli evi-denti fenomeni di diffusione e parcellizzazione urbana, alcuni stu-diosi sostengono che la città sta progressivamente venendo meno.Seguendo però il principio della biplanarità, la chiusura, se anchenon viene espressa, è comunque significata: come quando la guidaturistica dice «qui comincia la città vera e propria» indicando un edi-ficio o un punto stradale che altrimenti ai nostri occhi sarebberouguali a tutti gli altri, prima e dopo.
Più ancora che la chiusura, è allora la tenuta del testo a essereimportante, dove questo termine va inteso nel senso del celebre mo-nito strutturalista saussuriano per cui in una lingua tout se tient. Èla tenuta dell’insieme testuale a generare in un sol colpo sia la suaarticolazione interna (la sua strutturalità) sia i suoi bordi (che pos-sono pure esistere solo in negativo, come sfrangiamento, dispersio-ne progressiva degli elementi, sgocciolio interminabile da un serba-toio che comunque tiene e trattiene). Le celebri coerenza formale ecoesione semantica, di cui parla la linguistica testuale, possono es-sere ricondotte a questo principio basilare di organizzazione strut-turale, evitando con questo una certa tendenza alla regolamenta-zione a priori, alla fissità, che esse potrebbero connotativamente vei-
77
prospettiva di citazioni, per Barthes, perché contiene al suo internoquelli che Fabbri chiama ‘biglietti di invito’ per leggere testi ulterio-ri. Ogni scrittore crea i suoi predecessori, diceva Borges. In altri ter-mini, l’intertestualità non è filologico tornar indietro alle fonti, né er-meneutica storia degli effetti di lettura, né tantomeno postmodernastrizzata d’occhio ad autori e tradizioni letterarie del passato. Si trat-ta semmai di una presenza già nel testo di altri testi (quella che Ecochiama enciclopedia), o, che in fondo è lo stesso, di una base discor-siva del testo, che s’inscrive ‘naturalmente’ in una cultura medianteuna serie di rimandi che pongono al centro della sua conformazioneil processo della traduzione: interlinguistica o intralinguistica, inter-testuale o intratestuale, interdiscorsiva o intradiscorsiva.
Si comprende meglio, in questo quadro, la ragione per la qualeGreimas sostiene che la testualizzazione non sta alla fine del percor-so generativo, ossia nel solo momento in cui il discorso incontra ilpiano dell’espressione, ponendo problemi di linearizzazione (per lascrittura), di temporalizzazione (per l’oralità), di disposizione topo-logica (per le immagini), di sincronismo (per gli audiovisivi) etc. Alcontrario, si ha testualizzazione in ciascun livello del percorso gene-rativo: fondamentale, antropomorfo, discorsivo etc. Il quadrato se-miotico, ricorda lo studioso, è «la rappresentazione grafica dell’arti-colazione logica di una qualsiasi categoria semantica»: ha dunqueun’espressione e un contenuto. Di modo che, quando si ‘discendo-no’ i gradini del percorso, e si va, poniamo, dalle strutture testuali aquelle discorsive, non si abbandona affatto la sostanza dell’espres-sione, ma, molto diversamente, se ne ritrova un’altra, forse differen-te dalla prima, forse simile, ma in ogni caso altra rispetto a essa. Nonsi ha insomma una fuoriuscita dal testo verso una pura astrazione se-mantica, una considerazione esclusiva del piano del contenuto, co-me si dice spesso. Si costituisce semmai – per semiosi illimitata (Peir-ce), per transcodifica (Lotman), per trasposizione (Greimas), pertraduzione (Fabbri) – un secondo testo che investe direttamente ildiscorso tenuto dal primo, facendo economia del piano dell’espres-sione di quest’ultimo ma instaurandone uno nuovo. E questo secon-do testo può essere costruito ad hoc dalla teoria in quanto modelloformale, essere cioè una «metasemiotica scientifica» che prova aspiegare una configurazione testuale preesistente; oppure può esse-re effettivamente già presente in una determinata cultura come me-tatesto dato rispetto al testo primo. Per Lotman, abbiamo visto, i me-tatesti sono anch’essi a tutti gli effetti testi che circolano nella mede-
76
Si collega qui l’idea per cui ogni testo contiene al suo interno, ol-tre al suo contenuto enunciato, anche l’immagine della sua comuni-cazione (enunciazione): i principi per il suo funzionamento, i criteriper la sua produzione e fruizione, se si vuole: le sue istruzioni per l’u-so. Al di là del suo emittente e del suo destinatario, del suo produt-tore e ricettore reali, ci sono infatti all’interno del testo le loro im-magini simulacrali, l’enunciatore e l’enunciatario, attanti astratti chepossono essere in vario modo attorializzati. Tra emittente ed enun-ciatore, così come fra destinatario ed enunciatario, le relazioni sonobiunivoche, poiché se pure i secondi sono i simulacri dei primi, crea-ti a loro immagine e somiglianza, molto spesso sono invece proprioloro a determinarli, o quanto meno ad agire nella realtà sociale benpiù di essi. Una marca è l’immagine comunicativa di un’impresa, piùo meno corrispondente alla realtà produttiva e commerciale; ma fi-nisce per essere sul mercato ben più performativa dell’impresa stes-sa: fa e fa fare, propone progetti di senso e scene comunicative, co-stituisce processi di consumo assolutamente reali. Analogamente iltarget è l’immagine del consumatore ma finisce per generarlo, peristruirlo, per conformare i suoi comportamenti di consumo, i suoistessi stili di vita. È l’immagine del pubblico nelle trasmissioni tele-visive a determinare i comportamenti ricettivi dell’audience. È l’ideadell’interlocutore nel mio discorso che finisce per generarlo. È ilcomportamento progettato entro un edificio o un appartamento afar comportare chi li abita in quel determinato modo. E così via, ivicompresa la possibilità, perfettamente plausibile, di un ribaltamen-to di posizioni, di modo che, come diceva de Certeau, è la prassi diconsumo a costituire il senso dei testi, sono le tattiche di fruizione aribaltare le strutture molari mediante cui essi propongono determi-nati messaggi. In un modo come nell’altro, il livello dell’enunciazio-ne, con tutto quel che comporta nei termini di relazione fra internoed esterno del testo, sta dentro il testo, ma è sempre rivolto al suoesterno, al mondo culturale che, in un modo o nell’altro, lo ridirà inaltri suoi testi.
Ne consegue l’ultimo punto da menzionare, quello relativo all’in-tertestualità e alla traduzione. Se interno ed esterno del testo si defini-scono reciprocamente, la relazione fra un testo e un altro testo è co-stitutiva per l’identità di entrambi, non meno di quanto non sia quel-la della sua intrinseca distinzione in diversi livelli di senso. La chiusuratestuale non è isolamento di una monade che non comunica con altritesti altrettanto chiusi, ma esattamente il contrario. Ogni testo è una
79
con tutto ciò che comporta in termini di esperienze soggettive, pre-soggettive e intersoggettive, di attivazioni e passivazioni del corpo,di pratiche sociali e vissuti esistenziali, di effetti di senso ed efficaciasimbolica. Tali fenomeni, difatti, se rispetto a un testo dato si collo-cano a monte o a valle, rispetto a un quadro culturale più ampio tro-vano collocazione in testi ulteriori. Piuttosto che affrontare, comeoggi spesso si tende a fare, la questione metafisica della genesi delsenso o quella, più disforica, della sua dissoluzione, tematizzandoun’esperienza del senso tanto vaga nelle dimensioni quanto incon-trollabile metodologicamente, può essere più utile – e conducente –allargare o restringere a seconda delle occasioni la focale dell’anali-si, come dice Lotman, concentrandosi ora su un singolo testo (sen-za per questo invocare l’immarcescibile contesto) ora su un altro (in-teso come possibile metatesto del primo) ora su una rete interte-stuale più ampia (in cui la relazione fra di essi trova le sue regole difunzionamento). Come s’è detto, studiare le esperienze somatiche ele pratiche sociali analizzando il modo in cui esse si trovano raccon-tate e dette sul piano del contenuto di alcuni testi non significa pren-derne in considerazione la ‘rappresentazione’ che ricevono in queitesti. Significa semmai, a partire dal ruolo specifico che giocano nel-l’organizzazione semantica di quei testi, ricostruire modelli discorsi-vi – linguistici e sociali al tempo stesso – che ci permettano di spie-gare l’articolazione significativa di quelle esperienze e quelle prati-che in generale, e di altre dopo di loro. È quel che ha fatto Greimas,come sappiamo, quando per analizzare la sensorialità e l’estesia haanalizzato testi di Tournier e Calvino, Rilke, Tanizaki e Cortázar. Èquel che fa Landowski, che per ricostruire le esperienze di contagiointersomatico, parla delle pubblicità delle birre brasiliane. È quelche noi stessi abbiamo provato a fare usando Arancia meccanica perlavorare sul corpo sociale e le forme di vita dei tossicodipendenti. Èquel che fa Fontanille quando, per andar oltre i testi e lavorare sullepratiche, prende il caso delle Liaisons dangereuses...
Quel che comunque, in chiusura, va forse ribadito è che indivi-duare una volta e per tutte criteri formali di base per la costituzionesemiotica del testo è tanto utile quanto rischioso. Potrebbe infattiimplicare, ancora una volta, una visione surrettiziamente prescritti-va, etnocentrica, del senso. Certo, quelli che abbiamo inventariatosono concetti e categorie decisive per l’esercizio dell’analisi sociose-miotica, un’analisi che vuol essere critica – in tutti i sensi del termi-ne – della società e della cultura. Il rischio, però, è quello di iposta-
78
sima cultura dei testi di cui parlano, intrecciandosi con essi. Una di-chiarazione di poetica è metatesto rispetto alla poesia di cui è teoria,ed è testo rispetto alla cultura in cui circola. Una tavola dei generi èmetatesto rispetto al dramma o al romanzo o al poema epico che staclassificando, ma è testo nella cultura in cui viene prodotta e tra-smessa. Così un’opinione giornalistica rispetto all’articolo di crona-ca che le sta accanto nella medesima pagina; il libro del catechismorispetto alle preghiere che contiene; l’intervista a un pubblicitario ri-spetto allo spot che ha creato; un trattato di semiotica del testo ri-spetto all’analisi narrativa che prova a motivare. Le culture si costi-tuiscono e si trasformano grazie a una produzione testuale, interte-stuale e metatestuale senza fine. Ogni testo rinvia ad altri testi, uti-lizzando la stessa o altre sostanze dell’espressione, lo stesso mediumo un altro. Le pratiche di remake e remix non sono prerogativa esclu-siva della nostra condizione culturale, ma sono in qualche modo laregola su cui si regge la semiosfera. Il percorso generativo è una diqueste pratiche di remake testuale, coerente a livello metodologico,sorvegliato a livello teorico ed epistemologico. Ovviamente, infatti,in questo intreccio intertestuale, i testi non sono tutti uguali, nonhanno sempre la medesima funzione sociale, non ricevono tutti lamedesima valorizzazione. Ci sono testi più importanti di altri; testiche parlano di altri testi dicendo la loro strutturazione narrativa; te-sti che si pongono ‘naturalmente’ come prodotti discorsivi – i ma-nuali di istruzioni, per esempio –, facendosi matrice pertinente perla produzione di altri testi, per l’avvio di pratiche significanti ulterio -ri che si porranno rispetto a essi a livello di manifestazione espressivadiretta, istituzionale. Diviene allora ipotizzabile pensare insieme l’in-tertestualità traduttiva (inter- e intrasemiotica) come logica della cul-tura e il percorso generativo del senso. Ciò consente di abbandona-re l’idea oggi diffusa di due percorsi generativi – uno del contenutoe l’altro dell’espressione – che s’incontrano in pochi momenti felici.E permetterebbe altresì di pensare che tra i vari livelli di pertinenzadel senso all’interno di un testo e le catene intertestuali all’interno diuna cultura possa darsi, come si diceva un tempo, una forte omolo-gia. Se i livelli del percorso sono grandezze testuali, attraversarlovuol dire passare da un testo all’altro – laddove ognuno di questi te-sti ha comunque un diverso valore e una diversa funzione.
Assumere una posizione di questo tipo non significa comunquedimenticare, o anche semplicemente mettere fra parentesi, le que-stioni della costituzione a monte e della fruizione a valle di un testo,
81
II.
Parallelismi come menzogna: riscrivere Pinocchio
Un prete travestito da mummia non è né pretené mummia, ma forse sta raccontando qualcosasu entrambi gli affascinanti argomenti.
Giorgio Manganelli
1. Pinocchiesco e pinocchiologia
L’espressione ‘le avventure di Pinocchio’ può significare due cose: iltitolo del libro di Carlo Collodi, ovviamente, ma anche le peripezieche questo libro ha vissuto nel tempo e nello spazio. Da unaa parteci sono, nel testo, le avventure del burattino protagonista; dall’altra,nella semiosfera, le avventure del testo stesso, che ha attraversatoculture, lingue, media, arti molto diversi, restando però, in un modoo nell’altro, sempre uguale a se stesso. Il problema, per noi, è quellodi mettere in relazione questi due significati a prima vista molto lon-tani, e così di comprendere e spiegare se e in che modo la strutturadel libro (ai suoi diversi livelli) possa motivarne il successo. Si riu-scirebbe ad agganciare la presunta unicità e autonomia dell’opera al-la sua base culturale o, viceversa, a ricostruire il contesto pragmati-co della sua ricezione, più che come una catena unidirezionale difonti, come una rete di traduzioni, con regole discorsive locali voltaper volta esplicitabili dall’analisi.
In occasione del centenario dell’apparizione del personaggio sulGiornale per i bambini, Italo Calvino aveva provato a fornire unaspiegazione testuale interna della straordinaria fortuna dell’opera diCollodi:
tizzarli, ricadendo in una prospettiva teorica ingenuamente e incon-sapevolmente ancorata a un assetto culturale particolare e circo-scritto, con i suoi valori e le sue ideologie, le sue assunzioni natura-lizzanti, le sue piccole verità. Non riuscendo insomma a operare ilsalto, tanto impossibile nei fatti quanto auspicabile epistemologica-mente, verso un livello metasemiotico astratto – sfida d’ogni analisirigorosa delle culture – che spieghi appunto i meccanismi specifici,manco a dirlo testuali, mediante cui ogni assetto culturale specificosi costituisce e sopravvive, spesso in funzione di altri assetti a essoopposti o complementari.