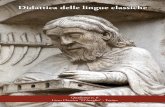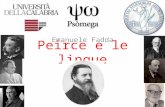Venezia, in: Città italiane, storie di lingue e di culture, a cura di P. Trifone, Roma, Carocci,...
Transcript of Venezia, in: Città italiane, storie di lingue e di culture, a cura di P. Trifone, Roma, Carocci,...
157
3.1 La specificità di Venezia*
Guardando alla storia linguistica di Venezia nel suo complesso e ai fe-nomeni di lunga durata che la caratterizzano rispetto ad altre città ita-liane, o che le conferiscono un particolare significato in un panorama linguistico più ampio, ve ne sono alcuni che invitano a considerare sot-to una luce diversa dall’usuale talune categorie della geografia e della sociologia linguistica.
Il séguito di questo testo documenterà più puntualmente alcuni fatti che converrà qui richiamare a grandi linee. Innanzitutto, la paci-fica convivenza di numerose varietà nel repertorio linguistico cittadi-no rappresenta a Venezia una costante molto antica. Data per scontata la compresenza di lingue e di varietà parlate in qualsiasi contesto ur-bano, e a maggior ragione in quelli più intensamente percorsi da flus-si economici e commerciali, già la Venezia medievale – e più ancora quella moderna – restituisce nella produzione scritta un ventaglio di soluzioni in cui si esprime una tipica tendenza alla somma di elementi,
* Questo paragrafo introduttivo è stato proposto, in forma solo lievemente di-versa, in occasione del convegno Città d’Italia: ruolo e funzioni dei centri urbani nel processo postunitario di italianizzazione. Per i 50 anni della Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro, svoltosi a Firenze, all’Accademia della Crusca, nell’apri-le del 2013. Il séguito di questo scritto rifonde completamente la materia della mia Storia linguistica di Venezia (Tomasin, 2010a), puntando a un aggiornamento che tenga conto delle molte novità emerse negli ultimi anni, tra le quali la recente storia linguistica del Veneto dal Medioevo al Rinascimento proposta da Paccagnella (2013a) assume il valore di uno sfondo complessivo alle vicende qui ripercorse nei primi tre paragrafi. Ringrazio Luca D’Onghia e Mattia Ferrari per aver discusso con me varie parti di questo lavoro, che dedico a Edward F. Tuttle.
3
Veneziadi Lorenzo Tomasin
città italiane, storie di lingue e culture
158
piuttosto che alla sostituzione o alla egemonia di una varietà domi-nante a scapito di varietà recessive. Un buon esempio è offerto dal-le lingue compresenti nella documentazione relativa alla vita civile e politica veneziana: non solo essa si dimostra aperta al contatto con le lingue del quadrante orientale del Mediterraneo, dal greco al francese “d’Oltremare”, ma anche il volgare locale e il latino vi si accompagna-no per secoli senza esercitare una vera concorrenza reciproca, bensì avvicendandosi in un processo lento, progressivo e non guidato da alcuna esplicita direttiva politico-culturale. Un analogo movimento inclusivo e non traumatico segnerà poi il trapasso dal volgare illustre locale d’ascendenza cancelleresca all’italiano venezianeggiante della fine della Repubblica.
Il veneziano ha, anche per il suo legame strettissimo con la storia civile, letteraria e culturale della città, uno status piuttosto diverso da quello di numerosi altri dialetti italiani, e segnatamente da quelli non cittadini. Di nuovo schematizzando: nella maggior parte dei contesti locali italiani, i dipoli che potremmo indicare come +urbano/–ur-bano, +popolare/–popolare, +standardizzato/–standardizzato sono usualmente correlabili all’opposizione tra lingua e dialetto nel senso che quest’ultimo è in genere caratterizzabile come varietà –urbana e +popolare, ossia tanto più forte e radicata quanto più ci si allontana dal centro cittadino e dalla sua classe dirigente, per definizione aperti alle novità e ai modelli di prestigio. Se poi il termine popolare si voglia intendere nella specifica accezione che lo oppone a dotto, la presenza di latinismi nei dialetti comunemente intesi è di norma esclusa per prin-cipio, o riguardata come occasionale e paradossale rarità, cui di rado si presta la dovuta attenzione.
Quanto alla standardizzazione, intorno a questo concetto si po-trebbe addirittura costruire una definizione di dialetto come varietà naturaliter lontana dalla scrittura e dai fenomeni di codificazione e di uniformazione che forzatamente vi si accompagnano.
All’opposto, la lingua nazionale è di solito percepita come +urba-na, –popolare, +standardizzata: si tratta, nella maggior parte dei casi, di una novità “esterna” giunta perlopiù nelle città attraverso la media-zione dei più alti milieux sociali e rigidamente codificata da istituti scritti come la letteratura, e modernamente anche la lessicografia e la grammatica. Tali correlazioni non sembrano facilmente applicabili al caso veneziano per quasi tutto l’arco della sua storia.
3. venezia
159
Quanto all’opposizione +urbano/–urbano, non esiste (o piuttosto, a lungo non è esistito: la situazione è forse in parte mutata con le mo-dificazioni dell’assetto urbano e suburbano contemporaneo) un vene-ziano di campagna, dal momento che non esiste un contado veneziano che non si identifichi con l’ampio e linguisticamente disomogeneo ter-ritorio della Terraferma veneta, il cui rapporto con il dialetto della città lagunare non si pone in termini di semplice continuità, o magari nella disposizione classica dell’attardato Randgebiet: ciò che vale, ma solo in parte e solo in forme del tutto peculiari, al massimo per alcune isole e località della Laguna, molte delle quali si dimostrano peraltro ben più strutturalmente “innovative” rispetto alla varietà urbana.
Quanto all’opposizione +popolare/–popolare, esiste una varietà locale molto articolata sia diatopicamente, sia diastraticamente, fino a dare materia alle plurime rilevazioni – geografiche, sì, ma anche so-ciologiche – fornite dalla mirabile raccolta del Papanti (1875) (che pure provvedeva a registrare molteplici testimonianze anche per altre e meno illustri città): Giudecca, Venezia (senza specificazioni), «Ca-narègio», Punta di Santa Marta, Castello e isole di Vignole, Sant’Era-smo ecc., cui s’aggiungono per la Laguna Burano, Murano, Pellestrina, Chioggia. Più che come un coeso centro urbano, Venezia finisce per apparirvi come un agglomerato in cui si integrano svariati microco-smi linguistici, sovrastati da quella che si vorrebbe chiamare una Dach-Mundart. Difficile parlare semplicemente di una koiné, e magari koiné regionale, adattandosi a una definizione controversa, ma certo più correttamente impiegata per altri contesti. Posto che esista, una koiné regionale veneta altro non è che la replica continentale del veneziano, cosa diversa da un ipotetico conguaglio dia-sistematico tra varietà lo-cali largamente sovrapponibili.
Quanto all’opposizione +standardizzato/–standardizzato, esiste infine una plurisecolare consuetudine scritta del veneziano. Quand’an-che non attinga alla codificazione esplicita di una grammatica (pur non mancando esperimenti in tal senso già in età prescientifica), essa espri-me una poderosa e ininterrotta tradizione letteraria e non letteraria, ol-treché una precoce vocazione lessicografica. Quanto tale consuetudine sia intrinseca e non solamente legata a usi artificiosi di una varietà “po-polare”, potrebbe documentarsi attraverso un censimento dell’ingen-te quota di lessico dotto incorporato dal veneziano lungo tutta la sua storia. Il Dizionario del Boerio (1829 e 1856), che ne ritrae la fase più
città italiane, storie di lingue e culture
160
1. Nell’Italia dialettale, il veneziano è infatti incluso tra i «Dialetti che si scosta-no, più o meno, dal tipo schiettamente italiano e toscano, ma pur possono entrare a formare col toscano uno speciale sistema di dialetti neo-latini» (Ascoli, 1885, p. 110).
matura, abbonda ad esempio di tecnicismi giuridici in parte o in tutto sottratti alla regolarità del cambio linguistico propria della tradizione ininterrotta (e l’indagine andrebbe certo estesa ad altri àmbiti).
Nel contesto ora evocato, un ruolo particolare spetta all’italiano, lingua che a Venezia ha uno stato di servizio parzialmente diverso da quello di molte altre città della penisola. Non mi riferisco tanto alla notevole omogeneità strutturale che già Graziadio Isaia Ascoli (1885) coglieva tra veneziano e fiorentino, e che è evidente funzione della for-te conservatività di entrambi quei volgari rispetto alle comuni struttu-re romanze1; né mi riferisco alla precocità dei contatti culturali con la Toscana e i toscani nella storia linguistica di Venezia. Mi riferisco piut-tosto al fatto che all’inizio dell’età moderna è Venezia il luogo in cui di fatto si vara la prima codificazione della lingua comune e la sua si-stematica assunzione nei nuovi standard dell’industria editoriale. Con una formula solo apparentemente paradossale, si potrebbe insomma dire che a Venezia l’italiano arriva da dentro, e non da fuori. O alme-no: arriva solo in parte da fuori. Sebbene non manchino, anche qui (ma soprattutto in età contemporanea, e si direbbe quasi per influenza di altre situazioni geografiche e culturali) le dinamiche tipiche della contrapposizione tra lingua e dialetto, Venezia mostra di norma un’ar-monica convivenza diglossica tra le due varietà, o in altre parole una complessiva non-conflittualità tra i due codici.
Fatti come quelli appena richiamati ben si prestano se non a spiegare, almeno a inquadrare coerentemente alcune delle cause che hanno portato Venezia a maturare l’assetto geo- e sociolinguistico odierno, in cui la perdurante, ottima salute della varietà locale – e la sua tendenza al contatto con l’italiano, nelle forme del prestito reci-proco, della commutazione e della mescolanza di codici – non pos-sono essere in alcun modo descritte come forme di “resistenza” alla lingua comune, né come fenomeni sociolinguisticamente recessivi o diastraticamente marcati. Fatti generali come la sdialettizzazione e la riduzione della diversità culturale, da cui pure la città non può dirsi indenne, hanno insomma origini, svolgimenti e forse traiettorie fu-ture piuttosto peculiari rispetto alla vicenda complessiva della storia linguistica dell’Italia unita.
3. venezia
161
3.2 L’età del Comune
Con la denominazione di «età del Comune» (consacrata, alla fine del Novecento, dalla Storia di Venezia pubblicata dall’Istituto dell’Enci-clopedia Italiana) si suole indicare il periodo, di cruciale importanza per le vicende politiche sociali economiche e culturali veneziane, posto tra la metà del secolo xii e la fine del xiii. È l’epoca in cui Venezia, ormai affrancata dalla soggezione originaria all’Impero bizantino, di-viene protagonista dell’ampio quadrante geo-politico posto tra il mare Adriatico e le sponde orientali del Mediterraneo, con propaggini che si spingono ancor più a est, verso l’Asia centrale. Per ragioni che nel complesso riguardano l’insieme del dominio linguistico italo-roman-zo, questo periodo coincide con quello di formazione di un uso scritto del volgare, ben documentato qui sia in àmbito documentario, sia nel dominio della produzione più tipicamente libraria, cioè letteraria o para-letteraria (ad esempio giuridica).
3.2.1. la formazione della scripta volgare
I più antichi testi veneziani «scritti in schietto volgare che siano tra-mandati in originale o in copia coeva» (secondo la formula di For-mentin, 2012, p. 63) sono contenuti nel Liber Plegiorum, cioè in un re-gistro della cancelleria comunale veneziana dedicato alla registrazione delle fideiussioni. Si tratta di testimonianze esigue, segnalate già dall’e-rudizione ottocentesca, e solo di recente edite con attenzione alla loro lingua (Tomasin, 2001, pp. 19-21). La più antica è un inventario del 1223 che, iniziante in latino, trapassa di continuo al volgare, per con-cludersi con varie annotazioni scritte in forma decisamente più vicina alla lingua parlata che alla lingua grammaticale.
Già al secolo precedente, in verità, datano numerose scritture do-cumentarie che, pur redatte in un latino normalmente intriso dei tratti locali della scripta, debordano verso il volgare, cioè in concreto verso l’adozione di elementi morfosintattici come l’uso dell’articolo, l’a-dozione di morfemi romanzi o la complementazione esclusivamente preposizionale. Una certa autonomia rispetto al latino grammaticale mostrano in particolare alcune zone del testo, anche altrove istituzio-nalmente più fluide, come ad esempio le scritture tergali delle perga-
città italiane, storie di lingue e culture
162
2. Un caso particolarmente notevole è quello delle carte conservate presso l’archi-vio della famiglia di cui faceva parte Guglielma De Niola, vedova di Stefano Venier: di origine provenzale per parte di padre, Guglielma è riconoscibile come l’autrice di numerosi attergati volgari risalenti alla prima metà del Duecento e caratterizzati da un veneziano di continuo interferito da tratti d’ascendenza occitanica; cfr. ancora Formentin (2012).
mene contenenti attestati di quietanze o cartae securitatis rogate da no-tai, ma conservate presso archivi privati di mercanti, o presso i conventi spesso implicati nelle esecuzioni testamentarie2. In queste sedi, le per-gamene – di norma arrotolate – potevano essere dotate di brevi note identificative sulla parte del dorso che restava visibile senza bisogno di srotolarle; simili annotazioni (largamente documentate da Formentin, 2012 già per il secolo xii) potevano giungere a gradi di vicinanza al vol-gare paragonabili a quelli di una famosa reliquia tardo-centesca (non datata), cioè la recordacione con cui il mercante Pietro Corner annota gli estremi di una «spedizione [...] di lana, di formaggio e di due bot-ticelle di vino al padre Filippo che sta a Venezia, usando come vettore la nave di Marco Gritti, con spese di noleggio a carico del destinatario; dato il tipo di merci, è probabile che il luogo di spedizione fosse la Pu-glia o il Salento»: così Stussi (2000, p. 274), a cui si deve la scoperta e l’edizione del documento.
A partire dalla seconda metà del secolo xiii, la produzione di testi documentari in volgare supera progressivamente simili forme frammen-tarie e occasionali per approdare a tipologie testuali più definite. Non stupisce che – a parte i documenti politico-diplomatici redatti fuori Ve-nezia, di cui si dirà oltre – il più antico testo pratico datato e interamen-te scritto in veneziano sia ancora un inventario. Si tratta di un elenco di proprietà terriere appartenenti a due membri della famiglia Moro, del 1253, per il quale si ripete una circostanza tipica degli albori di molti volgari romanzi, cioè l’impiego di una varietà ancor poco formalizzata nella sua veste scritta in un testo dalla sintassi assai povera, dominato da una nomenclatura e da una toponomastica intrinsecamente volgari. Nella classica raccolta dei Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento di Alfredo Stussi (1965), questo documento occupa il primo posto di una serie proseguita, per il secolo xiii, da vari altri testi di pro-venienza notarile, tra i quali una notevole frequenza hanno le cedole testamentarie, la cui struttura è ben più articolata e mostra chiaramente l’avvenuta istaurazione di nuove abitudini di scrittura in volgare.
3. venezia
163
3.2.2. testi veneziani e venezianeggianti: il contatto linguistico
Vari altri testi databili al secolo xiii (ma non sempre pervenuti in ori-ginale) documentano ulteriormente l’uso del volgare, anche scritto, nella vivace società mercantile veneziana di quell’epoca. Essendo re-lativi ai rapporti tra Venezia e i suoi avamposti d’oltremare, essi pre-sentano spesso fattezze linguisticamente ibride, riconducibili a quella multiforme entità che Gianfranco Folena (1968-70) denominò «ve-neziano de là da mar» (o come altrimenti lo si è chiamato, «vene-ziano coloniale»), riferendosi in particolare ai casi in cui la varietà lagunare funge da precoce modello per la formazione di scriptae can-celleresche o commerciali in ambiente straniero. Più in generale, la stessa qualifica si può estendere al composito insieme di varietà frutto del contatto linguistico tra il veneziano e altre lingue, sia non roman-ze – come quelle locali dell’Oriente – sia, più spesso, romanze, quali quelle impiegate dagli altri attori europei occidentali della vita econo-mica mediterranea.
Già al tardo Duecento risalgono dunque alcuni dei testi redatti a Ragusa (oggi Dubrovnik) che il più recente editore Diego Dotto (2008a, p. 13) ha opportunamente definito venezianeggianti con ag-gettivo «che consente di specificare la base veneziana di tale scripta ita-lo-romanza [...] e allo stesso tempo il suo allineamento solo imperfetto alla stessa scripta veneziana»: caratteri che si ritrovano, ad esempio, nella suggestiva registrazione di una lite tra mercanti a bordo di una nave, redatta a Ragusa attorno al 1284, e da ultimo èdita dallo stesso Dotto (2008b).
Passando dalla sponda balcanica dell’Adriatico a quella asiatica del Mediterraneo, crocevia del commercio veneziano, una vicenda esemplare e particolarmente antica rappresentano i patti stipulati tra i veneziani e il Sultanato di Aleppo negli anni successivi al 604 dell’e-gira (1207-08 dell’era cristiana): come in altri casi simili relativi ai rap-porti tra città italiane e orientali, i documenti originali furono scritti in arabo, e tradotti nella stessa città siriana, molto probabilmente da interpreti, forse da schiavi cristiani. Leggibile in copie successive (la più antica in un registro cancelleresco della fine del Duecento), la se-rie di questi Pacta alterna il latino della tradizione diplomatica a un veneziano venato di elementi galloromanzi e forse toscani (attribui-bili evidentemente ai traduttori/intermediari), al tipico francese im-
città italiane, storie di lingue e culture
164
piegato nell’Oriente latino le cui complessive, caratteristiche fattezze sono state di recente descritte – con riferimento a un ben più ampio corpus documentario – da Laura Minervini (2010). Non è arbitra-rio, tuttavia, considerare il primo di questi patti come il più antico documento in veneziano (così Belloni, Pozza, 1990): in assenza – for-se non irrimediabile, data la generosità con cui gli archivi veneziani restituiscono ancora oggi materiale sconosciuto – di testimonianze conservate in originale e redatte da mano sicuramente veneziana, il testo pattizio consacra questo volgare come varietà naturalmente e, si direbbe, originariamente incline al contatto con altre lingue, soprat-tutto in ambiente commerciale. Una tendenza destinata a prolungarsi lungo un arco plurisecolare.
Ancora in Oriente riportano vari casi duecenteschi relativi a mer-canti veneziani che rogano testamenti in un volgare diverso dalla loro lingua materna, per l’influenza dell’ambiente straniero in cui opera-no o per il diretto intervento di notai che, come alcuni degl’interpreti presenti nelle corti orientali, non conoscono il veneziano. Tale è il caso del testamento di Pietro Veglione, redatto a Tabriz, in Persia, nel 1263 e (tra)scritto da un notaio pisano o lucchese in un volgare praticamente privo di elementi veneti (Stussi, 1962); probabilmente pisano è anche il notaio che roga, nel 1294 a Negroponte (Cipro), il testamento del mercante veneziano Obertin, della contrada di Sant’Antonin: in que-
figura 3.1 Jacopo de’ Barbari, Veduta di Venezia (1500)
3. venezia
165
sto caso, il testo è scritto in francese (Bertolucci Pizzorusso, 2011). Per una curiosa coincidenza, proprio questo testo – in cui è citato quale testimone un Marco Polo che potrebbe corrispondere al famoso mer-cante-viaggiatore: ma l’identificazione non è affatto certa – riproduce quello che potremmo chiamare il triangolo linguistico (testo francese, redattore pisano, dettatore veneziano) che caratterizza la vicenda com-positiva del Milione, cioè di un capolavoro della letteratura veneziana (lato sensu) del Duecento.
3.2.3. la dimensione letteraria
Ben disposti all’uso della lingua materna nei testi di carattere pratico, i membri dell’aristocrazia mercantile veneziana duecentesca si appli-cano raramente alla redazione di testi letterari, e quando lo fanno si rivolgono spesso alle lingue galloromanze e alla loro già consolidata tradizione culturale. Se il caso appena richiamato del Divisament dou monde di Marco Polo nasce in una circostanza eccezionale ed è con-dizionato dalla raffinata dotazione linguistica e letteraria del redatto-re (il pisano Rustichello), per diversa via giunge al francese il Martin da Canal non altrimenti noto che come autore delle Estoires de Venise (1265-75, edito da Limentani; cfr. da Canal, 1972). Sotto le vesti di una cronaca, esse costituiscono in realtà un elegante testo propagandistico, volto a promuovere la fama di Venezia e della sua compagine stata-le presso un pubblico internazionale, il che ben giustifica l’uso della lingua di maggiore circolazione – assieme al greco – negli ambienti politici, diplomatici e commerciali in cui si concentravano gli interessi veneziani: ma si tratta, com’è lecito attendersi, di un francese appreso sui libri e punteggiato di venezianismi.
Ancora a una varietà galloromanza, cioè al provenzale, si rivolge l’u-nico poeta del Duecento veneziano di cui ci sia nota la precisa identità: si tratta del Bartolomè Zorzi imprigionato dai genovesi negli anni Ses-santa del Duecento e venuto in contatto, proprio a Genova, con la po-esia provenzale di cui diviene uno dei migliori rappresentanti al di qua delle Alpi: sebbene la tradizione dei suoi testi ne abbia notevolmente appannato la fisionomia linguistica originaria, una nuova e desiderabi-le edizione (che sostituisca quella di Levy, 1883) permetterebbe certo un suo migliore inquadramento.
Italoromanze, ma solo parzialmente compatibili con il veneziano duecentesco, e dunque frutto di una stratificazione linguistica non
città italiane, storie di lingue e culture
166
ancora completamente districata, sono le testimonianze poetiche contenute nel codice Hamilton 390 (già Saibante) della Biblioteca di Stato di Berlino, indicate da Gianfranco Contini (1960) nei suoi Poeti del Duecento come i massimi esempi della poesia didattica e moraleg-giante dell’Italia nord-orientale. Si tratta dei Proverbia super natura feminarum, testo misogino in quartine monorime di alessandrini ri-conducibile alla fortuna del francese Chastiemusart; del Cato, raccolta di proverbi morali attribuiti a Dionisio Catone, qui riportati sia in latino sia in volgare (come di norma avveniva in funzione del loro im-piego scolastico); e del Pamphilus, traduzione interlineare in prosa di una commedia in distici latini risalente al secolo xii e indebitamente attribuita a Ovidio. Riconsiderando accuratamente il complesso de-gli indizi linguistici e codicologici relativi alla provenienza del ma-noscritto hamiltoniano, Sandro Bertelli, Maria Luisa Meneghetti e Roberto Tagliani (2012, p. 119) hanno recentemente ipotizzato «che il codice sia stato commissionato ad un atelier di terraferma specializ-zato nella trascrizione e illustrazione di testi volgari, italiani e non (ma sarà l’analisi complessiva della scripta a corroborare definitivamente quest’ipotesi) da un committente veneziano di buon livello sociale e culturale». La questione, come dimostra la formula appena citata, può considerarsi ancora aperta, ma la non-venezianità di un redattore pur legato all’ambiente lagunare sembra confermata.
3.2.4. caratteri originali del volgare veneziano
Nella documentazione più antica finora disponibile, il volgare vene-ziano si presenta come una delle varietà più complessivamente con-servative rispetto al quadro italoromanzo di riferimento: l’astinenza del veneziano da una parte cospicua delle innovazioni fonetiche e morfologiche proprie non solo delle varietà galloitaliche, ma anche di quelle della vicina Terraferma potrebbe caratterizzarlo come varietà in origine “isolata” (anche geograficamente) e perciò tenacemente con-servativa di tratti propri della romanità della Venetia; gli stessi caratteri potrebbero, tuttavia, anche considerarsi come frutto di un conguaglio tra componenti originarie di diversa origine, ossia come riduzione ai comuni denominatori delle varietà romanze circostanti. Sebbene la prima delle due ipotesi paia rendere ragione in modo più convincente dei caratteri originali del veneziano, mancano – al momento – prove decisive in favore di ciascuna.
3. venezia
167
3. I tempi sarebbero ormai maturi per una vera grammatica diacronica del vene-ziano; quanto alla fase più antica, la conoscenza delle sue strutture poggia ancora stabilmente sui lavori di Alfredo Stussi (1965 e 2005, per citare solo le due sintesi più ampie).
Diversi sono i tratti conservativi che, nella fase più antica oggi rico-struibile, caratterizzano il veneziano antico rispetto alla maggior parte delle varietà italoromanze3.– La conservazione di [Ɔ] e di [Ɛ] romanze in tutti i contesti, o in al-tre parole l’assenza di dittongamento. Mentre la vocale palatale inizia a mostrare esiti dittongati (non metafonetici) già alla fine del secolo xiii, solo agli anni Trenta del Trecento risalgono le prime attestazioni sicure del dittongo uo in sillaba aperta (Baglioni, in corso di stampa).– Il mantenimento del nesso au, probabilmente «favorito dal contem-poraneo coesistere di au e di o in corrispondenza di a + l + consonante dentale (cioè di autro e otro)» (Stussi, 2005, p. 68), di cui si dirà sotto.– La conservazione dei nessi consonantici con l, tratto già notato da Dante nel De vulgari Eloquentia, in cui il veneziano è rappresentato dalla frase «per le plaghe de Dio, tu no veràs» (i xiv 6), dove si noterà anche la registrazione del carattere seguente.– L’uscita in -s nei morfemi verbali di seconda persona, documenta-bile con una certa ampiezza ancora nei documenti primotrecenteschi (da ultimo, Tomasin, 2013a, p. 11).
Numerosi tratti innovativi propri in generale delle varietà italoro-manze settentrionali sono attestati in veneziano in misura solo parziale o molto ridotta.– Metafonesi. La sua presenza parrebbe limitata a poche forme verba-li (come i perfetti spisi ‘spesi’, fisi ‘feci’) e pronominali (nui, vui, talora anche quilli): più che di un fenomeno attivo, si dovrà dunque parlare di pochi residui lessicalizzati di un’innovazione forse innescatasi in fase pre-letteraria, ma in seguito rientrata.– Occasionale innalzamento della vocale velare tonica medioalta [o] in contesto nasalizzante, e in particolare nella terminazione -un<-onem, la quale alterna comunque con -on (ma entrambi i tipi sono coerente-mente veneziani, cfr. ivi, p. 8). – Limitata apocope delle vocali finali: -e cade dopo n, l, r (anche in forme sdrucciole, come è stato recentemente chiarito: per i dettagli, cfr. ivi, p. 9), -o cade dopo n in parole piane e dopo l e r limitatamente ai suffissi tonici -ol, -er.
città italiane, storie di lingue e culture
168
– Lenizione consonantica e trattamento degli iati secondari che ne derivano. Allo scempiamento delle consonanti intense, probabilmente piuttosto tardivo per la laterale e in generale per le sonoranti, si ac-compagna un limitato decadimento delle sonore intervocaliche, che di rado giunge al dileguo, e in tal caso preserva normalmente gli iati secondari: «mentre infatti, per esempio, nel padovano -ào passa ad -ò e -àe passa ad -è (si ricordino mercò e bontè citati da Dante, De vulgari Eloquentia ix iv 5), il veneziano è conservatore e ammette, per quelle stesse sequenze, solo l’alternanza tra forma integra e forma tronca: dao e dà ‘dato’» (Stussi, 2005, p. 67).
Complessivamente rari sono dunque gli esiti innovativi che caratte-rizzano positivamente il veneziano rispetto alle varietà circostanti. Ne citeremo alcuni.– L’esito del suffisso -arju, che evolve in -er(o), evidentemente per tramite di una fase -airo, non documentata, a sua volta riconducibile a vari altri casi, tipici del veneziano duecentesco, di anticipo di /j/ e di /w/ in nessi consonantici, tipo aiba (e eba) ‘abbia’, aibui ‘avuti’, saupe ‘seppe’ (da sapuit).– L’interferenza degli esiti di au e di al davanti alle consonanti /t, d, s/, con forme tipo aldir ‘udire’, galder ‘godere’, colsa ‘cosa’, autar ‘altare’, coldera ‘caldaia’; ma «si noti – osservava Stussi (1965, p. xlvii) – che di tutto questo complesso rimescolio di esiti e di ricostruzioni più o meno legittime, nel Veneziano moderno non resta traccia avendosi per au sempre o e ben saldo il tipo altro»: è probabile dunque che anche in que-sto caso gli esiti innovativi abbiano sempre convissuto con quelli conser-vativi (si è detto sopra della particolare tenacia di au in altri contesti).– La terminazione -emo della quarta persona, la quale distingue il ve-neziano dalle molte varietà di Terraferma che presentano i tipi -om, -on, -um.
3.3 L’autunno del Medioevo
Nei due secoli – il Tre e il Quattrocento – che precedono l’assestamen-to dell’italiano comune, il veneziano conosce la sua massima espansio-ne nell’uso scritto, venendo largamente impiegato sia in àmbito lette-rario (in prosa e in poesia), sia nell’ambito documentario (pubblico e privato), nonché nell’ampia fascia della produzione paraletteraria
3. venezia
169
tecnica e scientifica. È l’epoca nella quale la città cambia progressiva-mente le direttrici principali del suo orientamento, non solo dal punto di vista economico-politico, ma anche da quello culturale: oltre o più che all’Oriente in cui aveva costruito le sue fortune nei secoli prece-denti, Venezia guarda sempre di più verso Occidente, cioè verso l’Italia e l’Europa. Conquistando vari centri della vicina Terraferma, la città lagunare ne influenza pesantemente le parlate urbane, che vanno in-contro a una massiccia venezianizzazione. D’altra parte, le campagne e la zona prealpina divengono anche punti di partenza per un’immigra-zione verso la città dominante che non mancherà di ripercuotersi sugli equilibri del volgare urbano. Ricchissima, poi, è la partita degli scambi culturali e letterari con il resto dell’Italia, e in particolare con la Tosca-na, della cui letteratura trecentesca Venezia è una delle prime ospiti. È l’epoca, insomma, in cui la lingua letteraria a base fiorentina inizia ad acclimarsi pienamente anche nella città dei Dogi.
3.3.1. scritture documentarie private
La produzione di testi pratici privati, che doveva essere già cospicua – ma è oggi poco documentata – nel secolo xiii, raggiunge nel Tre-cento livelli paragonabili, per l’Italia, solo alle città toscane. Oltre alla grande massa dei documenti d’àmbito notarile, come i testamenti (per il primo Trecento, risponde ancora la raccolta di Stussi, 1965, per il primo Quattrocento si può contare su quella di Sattin, 1986), Venezia tramanda già per il secolo xiv vari libri di conti relativi alla gestione dell’economia domestica di famiglie mercantili.
Si tratta di documenti poco noti, e finora studiati soprattutto dagli storici dell’economia sebbene essi rivestano un grande interesse anche per quelli della lingua: tali testi sono redatti direttamente da privati cit-tadini, cioè senza la mediazione dei notai (che a Venezia sono di norma chierici secolari), e conservati di solito nei faldoni archivistici relativi alle Commissarìe, cioè alle esecuzioni testamentarie. Oltre ai testamen-ti di mercanti, artigiani e altri membri della cosiddetta classe «cittadi-nesca», tali fascicoli contengono anche i materiali utili alla gestione dei loro patrimoni, quali il registro stilato dai commissarii (‘esecutori testamentari’), di norma in latino, e appunto i quaderni relativi alla tenuta di affitti o alla rendicontazione di spese, debiti e crediti. A parte il caso delle sparse annotazioni studiate da Formentin (2014), tra gli esempi più antichi finora noti per questa tipologia, vi è il quadernet-
città italiane, storie di lingue e culture
170
4. Archivio di Stato di Venezia, Procuratori di San Marco, Misti, b. 126, Commis-saria Maddalena Pagano: inedito, se ne darà conto in altra sede. Ringrazio Reinhold Mueller per avermelo segnalato.
5. Archivio di Stato di Venezia, Procuratori di San Marco, Misti, b. 94, Commis-saria Andrea Malipiero.
6. Archivio di Stato di Venezia, Sentenze a interdetto, b. 3.7. Il testo è edito e commentato da Tomasin (2000).
to cartaceo con le annotazioni dell’orefice Benedetto Pagano, relative agli anni 1315-32, probabilmente in copia posteriore di qualche decen-nio4; o il grande registro in cui, a metà Trecento, si annotano crediti e debiti del defunto Andrea Malipiero: «Cora(n)do m iijc l d(e) primo de março, / questo sì è quaderno de Andrea Manipiero / da S(anto) Se-vero trato de oltro quaderno de tuto / ço che li devese eser dadho e de ço ch’elo devese / dar a oltri de tute raxio(n) e de comisaria»5. Va detto che a simili testi non corrisponde una produzione di “libri di famiglia” a carattere più narrativo e memoriale, del tipo di quelli attestati nella coeva Toscana: gli esempi veneziani di questo genere sono – a quanto risulta e salvo ulteriori scoperte – piuttosto rari e piuttosto tardi (cioè quattrocenteschi: Grubb, 2009).
Parimenti ascrivibili all’àmbito delle scritture private sono numero-se lettere disponibili per il secolo xiv: tra le altre, quelle scambiate con destinatari linguisticamente eterogenei dal mercante Pignol Zucchello, pubblicate a metà del secolo scorso da Raimondo Morozzo della Rocca (1957) in un’edizione purtroppo «filologicamente disarmata» (Stussi, 2000, p. 270). Non meno interessanti, e ancora poco studiate, anche le molte carte private tramandatesi come materiali avventizi nei regi-stri giudiziari: gli atti dei Giudici di Petizion (una delle corti civili della città) conservano ad esempio la lettera (ancora inedita) rivolta nel 1332 circa a Benedetto da Modena, taverniere a Santo Stefano di Murano, dai cognati di una donna con cui egli era in causa6; o ancora, le note di conto presentate allo stesso tribunale dal mercante Maffio Salamon nel 1313, interessanti anche per lo spaccato che esse offrono sull’antroponi-mia veneziana medievale (si tratta in effetti di una lunga lista di nomi e soprannomi delle persone verso le quali Maffio vantava crediti)7.
Ancor più abbondanti dei carteggi intercorsi tra privati cittadini e pervenuti in originale sono poi, fin dai primi anni del Trecento, le lettere e gli analoghi documenti che, per varie ragioni, vengono copiati nei registri della Cancelleria ducale: esemplare il caso dei libri Com-
3. venezia
171
8. I testi più antichi di questa serie sono stati pubblicati in varie circostanze, da ultimo da Tomasin (2013).
memoriali, grandi volumi pergamenacei nei quali a partire dall’anno 1300 viene trascritta tutta la corrispondenza rivolta al Palatium che per qualche ragione si riteneva interessante, ma non aveva altre e più specifiche sedi di destinazione archivistica8: ciò ha reso possibile la conservazione di vari testi volgari di provenienza esterna, cioè redat-ti da privati cittadini veneziani, o addirittura straniera, come nel caso dei testi in francese, in provenzale e – in un caso – in catalano che si trovano nei primi volumi di questa serie, e risalgono dunque ai primi decenni del Trecento.
3.3.2. scritture documentarie pubbliche
Nella medesima Cancelleria ducale s’andava sviluppando, durante il secolo xiv, un altro genere di scritture composte direttamente in vol-gare: documenti giuridici veri e propri, inizialmente sotto forma di traduzioni da originali latini. Tale è il caso dei numerosi regolamenti di magistrature (detti a Venezia capitolari) che nel corso del Trecento vengono riformati o integrati, e in quell’occasione sono volgarizzati. È possibile che sulla progressiva espansione del volgare in quest’àmbito abbia agito l’influsso di testi assai simili nella struttura e nel contenuto, quali i Capitolari delle arti cittadine, cioè gli atti fondativi o regolativi delle confraternite professionali, che a Venezia come altrove tendono ad essere scritti, a partire dal secolo xiv, in volgare. Accanto a questi ultimi, dei quali sono pervenuti pochi originali trecenteschi scritti in veneziano (ma più frequente è il caso di copie o di rifacimenti del seco-lo xv, o anche più tardi), un buon numero di capitolari di magistrature documenta puntualmente l’uso del volgare nella Cancelleria veneziana trecentesca, affiancandosi da un lato ai testi di legge veri e propri (che iniziano ad essere redatti direttamente in volgare a partire dalla fine del secolo xiv: Tomasin, 2001, p. 66), da un altro ai volgarizzamenti degli Statuti promulgati nel 1242 dal doge Iacopo Tiepolo.
Scritti originariamente in latino, questi ultimi furono assai presto volgarizzati, ma non – a quanto pare – per impulso dell’autorità, né probabilmente, in origine, nell’ambiente della Cancelleria ducale, ben-sì forse in quello del notariato cittadino, se non addirittura in àmbito mercantile. Ben diverso dagli eleganti codici miniati che conservano gli
città italiane, storie di lingue e culture
172
9. Archivio di Stato di Venezia, Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta, b. 1, ex Brera 99: inedito.
Statuti in volgare di altre città italiane coeve, il manoscritto più antico che contiene un volgarizzamento degli Statuta veneta è l’attuale Pal. 2613 della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, databile tra gli ultimi anni del secolo xiii e i primi del xiv (il codice non contiene il sesto e ultimo libro, che fu aggiunto nel 1346 dal doge Andrea Dan-dolo). Il medesimo volgarizzamento è testimoniato anche da un codice dell’Archivio di Stato di Venezia9, che riporta anche varie aggiunte pri-motrecentesche al codice degli Statuti, le più recenti delle quali risalgo-no al 1333: anche qui, dunque, manca il sesto libro di Dandolo.
Se nemmeno per il testo latino originario si può individuare alcun testimone cui potesse attribuirsi un carattere di ufficialità, lo stesso può dirsi anche dei volgarizzamenti: così, mentre il legislatore vieta-va (con un decreto del 1401) l’apposizione di «pustille» al testo sta-tutario che potessero aprire la strada all’opera dei commentatori e ad un’interpretazione dottrinale della norma, nessuna iniziativa provve-deva a mettere in circolazione un testo ufficiale, latino o volgare, degli Statuta tiepoleschi.
La produzione di volgarizzamenti statutari prosegue anche nel secolo xv. L’editio princeps esce presso Filippo di Piero nel 1477 e contiene la sola redazione volgare, anonima: in forme tipografiche classicheggianti e umanisticamente polite, questa stampa mostra uno stato di lingua piuttosto innovativo rispetto a quello dei manoscrit-ti tre-quattrocenteschi. Vi emerge infatti la volontà di elaborare un volgare “illustre”, depurato dai tratti più marcatamente locali e acco-gliente nei confronti di forme latine e toscane, specie se fonomor-fologicamente convergenti, ma ancora caratterizzato da una decisa patina venezianeggiante.
Simile, per certi aspetti, la seconda edizione a stampa che, allesti-ta tre lustri dopo la princeps (1492, per i tipi di Dionisio Bertocchi), se ne differenzia completamente per l’impostazione generale: il vol-garizzamento si accompagna qui al testo latino, e la messa in pagina tipografica recupera la disposizione su due colonne, la grafia libraria antica (ossia la littera textualis), la rubricatura, l’alternanza tra capito-li in latino e corrispondenti brani del volgarizzamento, tutti caratteri tipici della tradizione manoscritta più antica. Quanto al testo volgare, esso si presenta in una redazione diversa rispetto alla princeps: nel senso
3. venezia
173
che appare come una traduzione nuova, ma in molti casi così simile a quella stampata nel 1477 da far sospettare una dipendenza da essa.
3.3.3. prosa e poesia volgari
Fra Tre e Quattrocento, gli spazi letterari del veneziano si estendono a vari àmbiti della prosa, soprattutto paraletteraria. In mancanza di una novellistica in volgare, fioriscono a Venezia sia le traduzioni della nar-rativa cavalleresca d’Oltralpe (ad esempio il Tristano, per la cui fortuna veneta cfr. ora Tagliani, 2011), sia la letteratura agiografica e moraleg-giante (ad esempio, la vita di sant’Albano edita da Burgio, 1995): al li-mite di quest’ultima sta la traduzione in prosa dei Quattro Vangeli con-servata da un codice della Biblioteca Marciana, redatta probabilmente a partire da una versione francese duecentesca della Vulgata e trascritta in un carcere di Venezia da un prigioniero triestino, che la completò nel 1369 (ne ha procurato l’edizione Francesca Gambino, 2007).
Un notevole sviluppo ha la letteratura tecnica relativa alla naviga-zione e al commercio, che almeno in un caso si sviluppa a stretto con-tatto con quella di pura evasione: mi riferisco allo Zibaldone da Canal (Stussi, 1967), prezioso testimone mediotrecentesco di un genere di libro che sarà stato assai diffuso nella società mercantile veneziana, ma anche molto esposto al deperimento e alla dispersione. Si tratta di una miscellanea che riunisce ragguagli di pratico interesse mercantile (problemi aritmetici, prontuari merceologici, notizie astronomiche e astrologiche, ricette mediche e ammaestramenti morali) e testi let-terari o paraletterari (un frammento d’un romanzo di Tristano, due serventesi, proverbi) destinati all’edificazione e all’intrattenimento. Più spesso, la documentazione superstite ci tramanda separatamente simili testi: per quanto riguarda quelli commerciali e nautici, molto resta ancora da scoprire o da pubblicare anche dopo l’edizione – non sempre filologicamente ineccepibile – di testi come le Ragioni antique spettanti all’arte del mare (manoscritto veneziano compilato tra il 1470 e il 1529 da almeno otto mani diverse, alcune delle quali identificate dalla curatrice Bonfiglio Dosio, 1987), le quattrocentesche Raxion de’ Marineri del «comito» (cioè ‘ammiraglio’) veneziano Pietro di Versi (edizione Conterio, cfr. di Versi, 1991), o il coevo manuale contenente Algune raxion per marineri curato da Pittarello (2006); interesse ancor maggiore, anche per lo studio dei linguaggi tecnici della marineria, ha l’opera di Michele da Rodi, uomo di mare passato dal rango di sem-
città italiane, storie di lingue e culture
174
10. Long, Mc Gee, Stahl (2009) hanno procurato l’edizione del Libro composto da Michele, con il corredo di una riproduzione fotografica del manoscritto e di una raccolta di studi storici che offrono una buona base a futuri, auspicabili approfondi-menti linguistici.
plice rematore a quello di ammiraglio nel corso del primo quarto del secolo xv, e dèdito, nei primi anni Trenta, a un’impegnativa sistema-zione delle sue conoscenze marinaresche10.
Quanto alla letteratura in versi, la società veneziana del Trecento assorbe precocemente, e rielabora in forme proprie, i grandi modelli dantesco e petrarchesco (quest’ultimo, soprattutto nella sua compo-nente preumanistica e “civile”). Il veneziano Giovanni Quirini, nato alla fine del secolo xiii, può considerarsi in assoluto uno dei primi imitatori di Dante (autore con il quale è anzi documentato un diretto rapporto di conoscenza): nella sua produzione lirica, composta in un volgare toscano appena tinto di venezianismi (con frequenti incursio-ni nel latino, fino al limite degli esperimenti di poesia bilingue, cioè di sonetti semilitterati), egli sviluppa soprattutto il versante mistico e religioso della poesia dantesca, impegnandosi in soluzioni stilistiche di notevole raffinatezza, oggi apprezzabili grazie all’edizione di Duso (Quirini, 2002). Sulle orme dell’Alighieri, ma in direzione piuttosto narrativa e dottrinale che propriamente lirica, si muovono anche Gio-vanni Girolamo Nadal (nato dopo il 1334 e morto entro il 1382) con la sua Leandreride (edizione Lippi, cfr. Nadal, 1996) e lo Jacopo Gradeni-go autore nella seconda metà del Trecento di una riscrittura in terzine, ben più nettamente venezianeggianti, dei Vangeli (edizione Gambino, cfr. Gradenigo, 1999). Per avere un grande poeta, Venezia dovrà però attendere i primi del Quattrocento e l’opera di Leonardo Giustinian, uno degli autori italiani di cui è più deplorevole la perdurante man-canza di un’edizione critica moderna e completa. Membro, al pari di Quirini e Gradenigo, di un’illustre famiglia patrizia, Giustinian in-trecciò il cursus di una carriera dedicata, come si conveniva a un nobile del suo lignaggio, agli affari di Stato, con una vivace attività culturale: traduzioni in latino di Plutarco, orazioni, studia humanitatis, e accan-to ad essi, un fortunato esercizio di poeta volgare e di musicista. Ai versi per musica è dedicata la parte migliore della sua produzione, che attraversa il repertorio quattrocentesco della poesia popolareggiante rivisitandolo in forme aristocraticamente elaborate. Strambotti, can-zonette, contrasti e componimenti frottolistici del Giustinian conob-
3. venezia
175
11. A Ferguson (2013, p. 84) va il merito di aver segnalato l’iscrizione, sfuggita a tutti i precedenti studi d’epigrafia volgare veneziana: si propone qui un’edizione interpretativa che migliora in vari punti la sua trascrizione.
bero, tra Quattro e Cinquecento, una fortuna così vasta e ramificata da dar luogo a un genere eponimo, quello della «giustiniana», ossia della canzonetta veneziana arieggiante i canti popolari d’argomento amo-roso. Spesso, tuttavia, i componimenti (perlopiù anonimi) di questo genere semplificano fino a banalizzarlo il peculiare impasto linguistico dei testi giustinianei, il cui accorto dosaggio di elementi vernacolari e di tratti letterari e addirittura latineggianti è ancor oggi intuibile nei numerosi e spesso contaminati testimoni.
3.3.4. la scrittura esposta
Merita di essere inquadrato a parte un genere di produzione scritta vol-gare che a Venezia conosce, nel corso del Trecento, uno sviluppo non isolato, ma certo eccezionale in rapporto ad altre città coeve italiane: si tratta dell’epigrafia, e in particolare di quella prodotta nell’àmbito del-le Scuole, ossia confraternite religiose intorno alle quali s’organizzava la vita sociale ed economica di larghi strati della popolazione urbana, cioè del cosiddetto ceto cittadinesco. Alcune decine di scritture esposte trecentesche in volgare scolpite su pietra in luoghi pubblici commemo-rano l’erezione o la dedicazione di manufatti legati alla vita delle Scuole, ne ricordano la fondazione o ne celebrano singoli eventi di particolare importanza. A questa tipologia, che è la più frequente, si accompagna-no varie altre scritture d’apparato (secondo la classica definizione di Ar-mando Petrucci) generalmente riferite alla costruzione di edifici o alla loro precipua destinazione per iniziativa di privati. Simili epigrafi sono di solito realizzate in una elegante grafia gotica maiuscola, sobriamente ornata, che diviene quasi il contrassegno dell’epigrafia veneziana del se-colo xiv. Se si prescinde da una breve scritta dipinta su un’icona lignea nella chiesa di San Donato di Murano, datata 1310, la più antica epigrafe veneziana scolpita in volgare è quella funebre che orna un sepolcro dei confratelli della Scuola grande di San Giovanni Evangelista: «+ Sepul-tura deli / frari batudi d(e)la / scola de S. Ioh(ann)e Eva(n)/g(e)l(ista) fata cora(n)do m / ccc xi soto ser / Çane da Tressaga / guardian (e) i soi oficiali»11. Tra le epigrafi più ricche dal punto di vista testuale e insieme paleografico e artistico vi è la lunga iscrizione “narrativa” che
città italiane, storie di lingue e culture
176
commemora il terremoto e la peste del 1348 in relazione ai lutti subìti dalla confraternita di Santa Maria della Carità (l’edizione più recente si legge in Stussi, 2005, p. 60). Non mancano casi di scritte non datate, ma certamente trecentesche, riconducibili alla tipologia delle «esortazioni morali» (secondo la classificazione di Petrucci, 2011), come quella che attualmente si trova al livello del suolo in piazzetta San Marco, a pochi metri dalla Porta della Carta di Palazzo Ducale: «L’om pò far e / diè inpensar / e vega quel /o che li pò in / chontrar»: si tratta di un mònito scolpito su quello che era forse in origine lo stipite di una porta d’in-gresso al Palazzo, secondo un uso documentato anche altrove, in Italia, negli edifici pubblici d’età comunale.
La produzione di scritture esposte in volgare prosegue di pari passo con la storia della grafia monumentale in cui esse sono realizzate: de-clinando, nel corso del Quattrocento, l’uso della gotica maiuscola per le scritture di questo genere, anche l’epigrafia veneziana cede progres-sivamente ai modelli classicheggianti, e linguisticamente latineggianti, dell’epigrafia umanistica.
3.4 Il Rinascimento
Lo schiudersi dell’età della stampa segna, per Venezia più ancora che per altre città italiane, un momento di svolta anche per il paesaggio lin-guistico urbano. La Serenissima Repubblica – come ormai la si chiama già dal secolo xv – è ai primi del Cinquecento una delle metropoli più vivaci d’Europa. Densamente popolata da una compagine sociale as-sai varia, sede di poderose intraprese economiche e finanziarie, snodo politico e diplomatico di cruciale importanza, Venezia è anche – e so-prattutto, dal punto di vista che qui interessa – capitale dell’industria editoriale e quindi luogo di concreto svolgimento della rivoluzione in-dustriale e intellettuale che, assieme alla Riforma, segna l’inizio della storia moderna nella cultura europea. Per Venezia passano, insedian-dosi per periodi più o meno lunghi, pressoché tutti i protagonisti del dibattito culturale italiano del primo Cinquecento: anche per questo qui nasce, di fatto, l’italiano moderno. Uno degli aspetti più notevoli di tale processo storico riguarda lo status del dialetto veneziano. An-ziché essere indebolito o addirittura messo in pericolo dall’avanzata dell’italiano, fortissima a Venezia anche al di fuori della stretta cerchia
3. venezia
177
dei letterati, il volgare locale conosce nel corso del Cinquecento una straordinaria fioritura non solo negli usi meno formalizzati, ma anche in campo letterario, nel quale anzi inaugura – portandoli a livelli d’ec-cellenza – nuovi campi d’impiego.
3.4.1. l’italiano a venezia
L’irradiazione precisamente veneziana e cinquecentesca dell’italiano come lingua nazionale condivisa per la scrittura letteraria e in generale per la comunicazione di livello colto è stata efficacemente indicata da Dionisotti (2009, p. 278) in un passo famoso:
La lingua italiana che nel Cinquecento e oltre si impose all’Europa, dopo il sacco di Roma, dopo il fallimento della politica nazionale medicea, dopo la caduta della Repubblica fiorentina, dopo l’asservimento dell’Italia al predo-minio straniero, non fu la lingua del Machiavelli. Fu senza dubbio una lingua fondamentalmente toscana, ma recisa dalla continuità e dalla varia fortuna del-la tradizione toscana, cristallizzata nel suo assetto trecentesco, remoto ormai e inattaccabile dagli eventi, al modo stesso come cristallizzata era, nel suo splen-dore di gemma, la lingua degli antichi. Questa cristallizzazione, a dispetto dei Fiorentini, dei Toscani e d’altri, fu operata nel primo Cinquecento a Venezia.
Il preciso valore di questo primato è stato chiarito illuminando nei det-tagli la produzione a stampa veneziana (fondamentali i lavori di Tro-vato, 1991, 1998 e Richardson, 1994), che nel corso del secolo xvi è la più generosamente aperta ai testi volgari. Qui si assestano gli standard della revisione editoriale che tanto influiscono sulla definizione degli usi di scrittura e delle abitudini di lettura nell’Italia moderna; e qui (come ha da ultimo documentato Ivano Paccagnella, 2013b) si realizza originariamente la saldatura tra industria editoriale, lessicografia e te-oresi grammaticale: il percorso che conduce alla stampa – non a caso veneziana – del Vocabolario degli Accademici della Crusca del 1612 si compone di una lunga serie d’edizioni veneziane di autori del canone trecentesco, di studi filologici su di essi e di elaborazioni grammatica-li e lessicografiche di cui le Prose del Bembo sono solo l’esempio più famoso e più longevo, ma non certo l’unico né sempre il più influen-te in un panorama di trattati linguistici e di grammatiche sempre più sviluppato e sempre più ecletticamente gestito dai professionisti della scrittura e della revisione editoriale.
città italiane, storie di lingue e culture
178
12. Tra i meno studiati, sebbene si tratti di testimonianze interessantissime della cosiddetta lingua degli illitterati, vi sono certo le scritture murali dipinte, già nel cor-so del Cinquecento, sulle pareti del Tezon Grando dell’isola del Lazzaretto vecchio, dove gli equipaggi delle navi in arrivo a Venezia trascorrevano la quarantena profi-lattica in caso di pestilenze o di epidemie. Una vera ricognizione testuale di questi manufatti, attenta al loro valore linguistico, dev’essere ancora compiuta.
In una città in cui dunque l’italiano – inteso come lingua comune per la comunicazione, distinta dal livello più riconoscibilmente locale del veneziano – può dirsi pienamente acclimato, se non proprio au-toctono, fin dall’inizio dell’età moderna, anche i generi di produzione testuale più lontani dalla poesia e dalla letteratura risentono diretta-mente della situazione appena descritta. Nel campo della scrittura giu-ridica, ad esempio, persino documenti connessi alla registrazione del parlato, come le verbalizzazioni giudiziarie, mostrano un bilanciato equilibrio fra tratti locali e tratti sovraregionali progressivamente sem-pre più estesi (cfr. da ultimo Telve, 2014). E se il pretto e tradizionale veneziano “illustre” cancelleresco – omogeneamente cosparso di tratti locali a tutti i livelli della struttura – sopravviveva largamente nell’uso dei tribunali civili della Repubblica (trovando occasionale registrazio-ne nella stampa di arringhe reali e fittizie in dialetto: Tomasin, 2009), la lingua della legislazione veneziana del Cinquecento, testimoniata dai registri di cancelleria ma anche dagli opuscoli a stampa nei qua-li essa comincia a circolare in città, mostra interessanti fenomeni di microrevisione linguistica in direzione antidialettale (Tomasin, 2001, pp. 147-56). Se dunque il volgare locale dispone, nel Cinquecento, di un ampio uso nel parlato e di un cospicuo ventaglio di impieghi scrit-ti12, si assiste a Venezia a una variegata compresenza di tratti locali e tratti sovraregionali in domini sempre più vasti che dallo scritto più rigidamente codificato si estendono in progresso di tempo a generi meno formalizzati, lambendo di certo anche il parlato, almeno nelle sue forme più controllate.
Studi recenti, come quello che Sandro Bianconi (2013) ha condotto su interessanti materiali inediti, hanno persuasivamente documentato l’uso di una varietà ben distinta dai dialetti nella produzione di scriven-ti illitterati d’area lombarda già nel corso del secolo xvi, richiamando l’attenzione anche sulla diffusione di un italiano popolare nell’ambien-te della predicazione e della didassi ecclesiastica. A paragone di simili realtà, il paesaggio linguistico urbano di Venezia appare almeno in par-
3. venezia
179
13. Attorno al suo ambiente fiorisce a Venezia nel Cinquecento un intero filone letterario, che oggi s’indica spesso come bulesco con riferimento al titolo (La bulesca) di un’anonima commedia di buli (cioè appunto piccoli rappresentanti della malavi-ta cittadina) e di vari altri analoghi componimenti conservati dal medesimo codice marciano che tramanda anche la Veniexiana di cui si dirà sotto. E allo stesso filone è riconducibile gran parte dell’opera di Alessandro Caravia (1503-1568), inquieto e interessantissimo autore legato agli ambienti che simpatizzavano per la Riforma pro-testante: la sua opera di poeta meriterebbe certo nuove e più approfondite attenzioni.
te diverso. Per la lunga tradizione di scrittura che caratterizzava la sua storia, il veneziano disponeva infatti, già all’inizio dell’età moderna, di una gamma di soluzioni intermedie tra quelle più rudemente vernaco-lari (oggi attingibili, di fatto, solo nella letteratura più espressivistica-mente caricata) e quelle comprensibili a un pubblico sovraregionale. Più che di un italiano nascosto rimasto ai margini della consapevolezza e della storia culturale, secondo la formula di Testa (2014), bisognerà insomma parlare di un ampio e ben evidente continuum sociolinguisti-co variamente aperto all’attenuazione dei tratti locali ossia alla valoriz-zazione di tratti condivisi con gli altri volgari italiani.
3.4.2. plurilinguismo rinascimentale
Durante il Rinascimento, il panorama linguistico di Venezia è anco-ra così vario che buona parte dei suoi abitanti vive costantemente im-mersa in un ambiente di fatto plurilingue. La popolazione autoctona è fortemente stratificata e articolata, comprendendo ampie zone di al-meno relativo isolamento, nelle quali fioriscono varietà gergali – come quelle della ben documentata malavita urbana13 – o per diverse ragioni periferiche – come l’arcaico linguaggio dei pescatori “nicolotti” (cioè abitanti della popolare zona di San Nicolò dei Mendicoli), pure as-surto a fortuna letteraria. Ancora, la presenza di quote consistenti di immigrati di modesta condizione sociale provenienti dall’Italia setten-trionale (Terraferma veneta, Friuli, Lombardia) si somma all’ingente immigrazione mediterranea ed europea legata ai commerci della Sere-nissima. Dalmati, schiavoni, albanesi, turchi, tedeschi, spagnoli e vari altri gruppi etnici forestieri sono numerosi e organizzati in comunità ben strutturate, spesso più influenti nella vita cittadina rispetto agli analoghi gruppi provenienti dall’Italia centrale o meridionale, alcuni dei quali – come ad esempio i lucchesi – vi si erano stabiliti ormai da
città italiane, storie di lingue e culture
180
14. Sulla testura linguistica della Veniexiana, si rinvia a Tomasin (2007).
secoli. Ciascuno di questi gruppi porta con sé lingue, dialetti e lettera-ture proprie delle rispettive tradizioni culturali, e si capisce bene come tale contesto, unito alla vivacità dell’ambiente teatrale veneziano, dia origine al cospicuo filone del teatro dialettale e plurilingue. Un mira-bile riflesso di tali sviluppi si ha nell’anonima commedia Veniexiana conservata da un manoscritto marciano e databile attorno al 1536, in cui agiscono, accanto a una serie di personaggi femminili parlanti un veneziano variamente declinato, anche un facchino bergamasco e un giovanotto che parla una lingua simile all’italiano artificioso degli au-tori cortigiani14. Ma lo sviluppo più notevole di questa tendenza si ma-nifesta nelle opere del veneziano Andrea Calmo (1510 ca.-1571) e di Gi-gio Artemio Giancarli (nativo di Rovigo, morto prima del 1561), i quali portano a un estremo di deformazione espressionistica il plurilinguismo già sperimentato – ma nei limiti di una più misurata commistione – dal padovano Ruzante. Nelle commedie di Calmo, «l’italiano letterario e alcuni dialetti settentrionali (veneziano, pavano, bergamasco) si alter-nano [...] con l’imitazione di lingue straniere effettivamente risonan-ti a Venezia: lo spagnolo (Spagnolas), il greco nella sua stilizzazione “greghesca” (Spagnolas, Rodiana) e il turco (Travaglia), cui s’aggiunge l’arabo egiziano usato dalla protagonista nella Zingana (1545) del [...] Giancarli»: così D’Onghia (2014, p. 189), che ha peraltro avvertito come la carriera teatrale di Calmo non possa ridursi ai soli fuochi d’ar-tificio di un plurilinguismo edonistico e puramente spettacolare (lo dimostra, ad esempio, un’altra commedia calmiana, il Saltuzza curato dallo stesso D’Onghia: cfr. Calmo, 2006).
La variegata tavolozza linguistica del teatro veneziano cinquecente-sco è così ampiamente documentata da aver dato materia, recentemen-te, a un intero Dizionario venezianodella lingua e della cultura popolare nel xvi secolo, realizzato da Manlio Cortelazzo (2007) a partire dalla poderosa produzione letteraria e non letteraria di quel secolo. In essa si rispecchiano, con le prevedibili alterazioni proprie della trasposizione scritta, l’effettiva varietà del panorama linguistico cittadino e il pecu-liare ruolo che vi giocava il volgare locale. Il veneziano, d’altra parte, è uno dei pochi dialetti cittadini di età rinascimentale ad essere impiega-to a fini artistici persino da scrittori di provenienza diversa: non solo dai poco lontani autori della Terraferma (Ruzante in testa), ma addi-rittura da siciliani come Caio Ponzio Caloiro o Vincenzo Belando e da
3. venezia
181
15. Sull’uso di tale denominazione, cfr. Tomasin (2012, p. 14).
un toscano come Giovan Battista Andreini, nella cui Veneziana (1619) il dialetto è «sottratto all’impiego contrastivo tipico del teatro profes-sionistico, e la monodialettalità si lega a una differenziazione stilistica interna dei diversi personaggi, con una tecnica che rammenta seppur di lontano quella di Machiavelli» (D’Onghia, 2014, p. 180). Con simili esperimenti, sia per ragioni letterarie sia per ragioni cronologiche, sia-mo già nei pressi della Commedia dell’Arte.
3.4.3. la letteratura, tra classicismo e rivendicazione
La produzione veneziana in prosa dell’età rinascimentale non è limi-tata al fiorente àmbito della letteratura teatrale: dal tronco già trecen-tesco della tradizione cancelleresca e cronachistica si diramano i diarii di Marin Sanudo, Pietro Dolfin o Girolamo Priuli; è vano chiedersi se essi vadano ascritti alla storia linguistica del veneziano o a quella dell’italiano, i quali mai come in questi testi si dimostrano uniti da un continuum difficilmente frazionabile. Certa è, d’altra parte, la volon-tà di adesione del Sanudo a una sorta d’ideologia culturale cittadina ch’egli esprime, con sorprendente consapevolezza, dichiarando il pro-prio attaccamento alla tradizione linguistica locale, che in lui acquista una sfumatura di rivendicazione ideologica della «lengua materna» (opposta, si noti bene, al latino umanistico, non all’italiano lettera-rio). In effetti, pur in un quadro che ne prevede in generale la pacifica convivenza, il latino, il volgare locale e la lingua comune si alternano nelle opere legate alla pubblicistica politica (ad esempio, nella crona-chistica ufficiale) secondo criteri non sempre casuali o neutri: pur non apparendo mutualmente esclusivi, essi tendono a rappresentare visioni almeno parzialmente diverse della Repubblica.
Un esibito (e perciò stesso dubbio) valore ideale ha la scelta della «vulgar antiqua lengua Veneta» nelle Lettere15 del già citato Andrea Calmo, «che costituiscono un unicum nell’epistolografia cinquecen-tesca per l’uso del dialetto veneziano» (Matt, 2014, p. 265). Defor-mando espressivisticamente il genere della lettera fittizia, assai fortu-nato nella letteratura classicista, Calmo immagina che a scrivere a vari personaggi suoi contemporanei, scelti soprattutto fra intellettuali e let-terati, siano improbabili pescatori della laguna, stravaganti portatori di un sistema di valori arcaico e di una demotica veracità polemicamente
città italiane, storie di lingue e culture
182
opposta all’artificiosa raffinatezza (anche linguistica) della cultura do-minante: è, con la formula dello stesso Calmo, «la idioma de l’anti-ghitae de sti nostri palui» (Libro i. Dedica), cioè il linguaggio misto di tratti propriamente veneziani e di elementi che arieggiano i parlari della Laguna e delle zone periferiche dell’area metropolitana che aveva Venezia come baricentro. Per una successiva adozione ideologicamen-te marcata del veneziano (questa volta in versi) bisognerà attendere la Carta del navigar pitoresco (1660) di Marco Boschini, trattato in forma di poema in cui la scelta dialettale fa tutt’uno con la polemica contro la pittura toscana del Rinascimento, qui apertamente contrapposta alla “linea veneta” e ai suoi legami con l’arte fiamminga.
Volgendosi dunque alla poesia veneziana di età rinascimentale, si osserverà che Venezia, attivo centro di produzione (anzi d’irradiazio-ne, grazie al Bembo) della lirica petrarchista – riunita qui in circoli tra i più celebri e coltivata anche da individualità peculiari, come alcune tra le migliori poetesse italiane dell’epoca –, presenta anche in questo campo un tipico bifrontismo, che è poi intrinseco di tanta parte del-la letteratura italiana. Così, accanto alla poesia di stretta osservanza classicista (per cui si rimanda qui alla recente sintesi di Carrai, 2006), la poesia dialettale viene adibita soprattutto al controcanto ironico di quella produzione, alla sua decisa sovversione in chiave comica, burle-sca o decisamente oscena, pur non mancando vari esperimenti di de-licato lirismo dialettale. Tale ampio ventaglio di soluzioni stilistiche si estende dai versi del già citato Andrea Calmo – che assembla un vero e proprio canzoniere dialettale, rivisitando tutti i generi principali della coeva produzione in versi: lo si legge ora nell’edizione di Belloni, cfr. Calmo (2003) – a quello diviso tra lingua e dialetto (ma più efficace in questo che in quella) di Maffìo Venier (1550-1586), capace di spazia-re da una vena disimpegnata e goliardica tipica di tanti sonetti all’ele-ganza di un componimento come La strazzosa, canzone dedicata alla bellezza di una popolana che rappresenta uno dei prodotti più riusciti della poesia dialettale cinquecentesca.
Posizione culturalmente defilata, ma linguisticamente molto inte-ressante, hanno alcuni testi popolareggianti nel tono e nel soggetto: se anche Calmo, come si è detto, mette taluni dei suoi componimenti in bocca a pescatori e abitanti delle isole della Laguna, ancor più marcata è la scelta dell’anonimo autore di un Lamento dei pescatori conservato da un manoscritto marciano e databile agli anni della battaglia di Le-
3. venezia
183
panto, cioè del prodotto forse più maturo della moda “piscatoria” che attraversa la poesia veneziana di quegli anni (una nuova edizione e una compiuta illustrazione del testo si deve ora a Ferrari, 2013). Si manife-stano qui i segnali di un fenomeno di lunga durata, per cui il venezia-no cittadino, percepito come varietà illustre e ormai consacrata da una lunga tradizione colta, si dimostra inadatto o poco adatto alla ricerca di soluzioni stilistiche ed espressive che meglio si attingono nelle varie-tà circostanti: varietà isolate e isolane, o comunque deformate da una torsione che trasforma il dialetto in un idioletto marcato e artificioso.
3.5 Gli ultimi due secoli della Serenissima
Trascorsi i fasti politici, sociali, economici e culturali dell’età del Rina-scimento, Venezia si avvia tra Sei e Settecento verso quello che a lungo è stato descritto come un semplice declino, ma che – almeno dal punto di vista della storia linguistica – si potrebbe inquadrare meglio come un consolidamento di alcuni peculiari assetti sociolinguistici. Da un lato, l’ormai antica diglossia italiano comune/volgare locale si rafforza e si esprime in fenomeni notevoli d’interazione, quali le fortunate versioni in dialetto di opere della letteratura illustre. Da un altro, il veneziano raggiunge una perfetta riconoscibilità nazionale e internazionale gra-zie a canali di diffusione (anche) popolari come il teatro, e a un sempre più capillare ampliamento del mutuo prestito lessicale con le grandi lingue europee. Queste ultime, a loro volta, ricevono un buon numero di venezianismi e li consacrano, in molti casi, nei rispettivi vocabolari, come parte integrante di una lingua italiana ormai comunemente rico-nosciuta e diffusa in Europa. Ancora, i topoi linguistico-letterari legati al veneziano e alla sua grazia e nobiltà si affermano nella cultura euro-pea d’Antico regime sia per tràmite di scrittori veneziani – emblema-tici i casi di Goldoni e Casanova –, sia attraverso la voce di estimatori stranieri, come Rousseau e Voltaire. A tale fortuna esterna corrisponde, in patria, un fenomeno almeno incipiente di standardizzazione scritta del dialetto, soprattutto in àmbito letterario, che ha pochi eguali nel coevo panorama linguistico italoromanzo: i precoci esperimenti di les-sicografia dialettale appaiono, a tal proposito, rivelatori di una tenden-za destinata a piena maturazione nel secolo xix.
città italiane, storie di lingue e culture
184
16. Un’edizione purtroppo largamente deficitaria e di fatto inservibile per l’as-senza di indici e l’evidente inaffidabilità della trascrizione ne ha di recente procurato Crevatin: cfr. Zorzi Muazzo (2008).
17. Lo si ritrova in effetti già in Marcantonio Sabellico, il quale nella Secunda pars Enneadum (1504) parlava della «veneta lingua [...] quae compta est et gravis pluriumque lingua rum flore conflata, quod facile contigit in frequentissimo italica rum gentium commercio» (cit. da Dionisotti, 1968, p. 16).
3.5.1. fenomeni di (pre-)standardizzazione
Come abbiamo accennato in apertura, la nozione di dialetto e quella di standardizzazione linguistica sono di fatto antitetiche e incompatibili nella tradizione degli studi italiani. La storia linguistica urbana di Vene-zia mostra tuttavia come proprio nel caso di varietà cittadine particolar-mente ricche di tradizione scritta, in età moderna si siano prodotte con-suetudini di scrittura piuttosto stabili, favorite dalla stampa e dall’ampia circolazione testuale, pur se non (ancora) da una precisa codificazione grammaticale o lessicografica. Se già le citate Lettere di Andrea Calmo contribuiscono, grazie alla fortuna delle loro plurime edizioni, alla fis-sazione di taluni caratteri, ad esempio nel campo della grafia dialettale (complessivamente omogenea, a Venezia, già nei testi del secolo xvi: Tomasin, 2013b, pp. 149-53), di una «ortografia Veneziana» parla espli-citamente Carlo Goldoni nell’Autore a chi legge dei Rusteghi (1762), riferendosi com’è ovvio non a una norma precisamente codificata, ma a una consuetudine ormai assestata. Lo stesso Goldoni, peraltro, acca-rezza a lungo l’idea di realizzare un vocabolario del dialetto veneziano, dichiarandone addirittura in corso la redazione («Sto facondo ora un Vocabolario con la spiegazione dei termini, delle frasi e dei proverbi del-la nostra lingua per uso delle mie Commedie, e questo servirà comoda-mente per tutte quelle che si sono stampate finora», dichiara nel 1755 presentando Lemassere), ma non giungendo mai a realizzarlo. Allo stato di un disordinato brogliaccio resta, circa un ventennio più tardi, anche la Raccolta de’ proverbii, detti, sentenze, parole e frasi veneziane, arricchita d’alcuni esempii ed istorielle compilata dal nobile barnaboto (cioè ‘deca-duto’) Francesco Zorzi Muazzo durante la sua reclusione in un manico-mio16. Che tuttavia i tempi fossero maturi per la redazione di un’ordinata raccolta del lessico veneziano era convinzione diffusa, e riecheggiata, tra l’altro, da Apostolo Zeno, che nell’annotare la Biblioteca dell’Eloquenza italiana di Giusto Fontanini, riprende il topos – già umanistico17 – della
3. venezia
185
18. Citiamo dall’edizione di Pasquali, Venezia 1753, p. 72.
varietà “translinguistica” del lessico veneziano, frutto degli antichi com-merci, e correda un commento all’Ortografia del Sansovino con l’auspi-cio che si realizzi presto un simile vocabolario18:
Il dialetto veneziano è ricchissimo di voci tutte sue proprie, ed è quello, che ha più di grazia e di vezzo fra quanti se ne parlano corrottamente in Italia. Moltissime di queste nostre voci dirivano a dirittura dal greco, dall’illirico, e dall’arabico, e da altre lingue orientali: il che provenne dal lungo e conti-nuato commerzio, che ebbero i nostri con quelle nazioni. Chi si mettesse a formare espressamente un Vocabolario veneziano, ne farebbe conoscere l’a-nalogìa e la ricchezza.
Del resto, al «patriotico zelo de’ veneziani», come lo chiamava il na-poletano Ferdinando Galiani nel raccomandarlo anche ai suoi con-cittadini, corrispondeva anche all’esterno la consapevolezza della pe-culiare situazione sociolinguistica (come diremmo oggi) della città: così, il piemontese Giovanni Francesco Galeani Napione riconosceva nel 1791 al veneziano di essere «troppo bello [...] per un dialetto sem-plice, non abbastanza per formare una lingua», e il suo conterraneo Carlo Denina nel Discorso sopra le vicende della letteratura (1788) am-metteva che solo il declino politico di Venezia dopo l’età delle guerre primocinquecentesche aveva precluso «la via di rendere universale per Italia, e nei lidi dell’Adriatico e del Mediterraneo il dialetto di Venezia».
A un dizionario dialettale veneziano si arriverà giusto alla fine del Settecento. Ma l’esperimento dell’abate padovano Gasparo Patriarchi (ossia il Vocabolario Veneziano e Padovano co’ termini e modi corrispon-denti Toscani: i edizione, 1779) nasce da un’esigenza ben diversa da quella cui alludono i Goldoni e gli Zeno: si tratta infatti di un’opera presentata come funzionale alla sostituzione dei termini dialettali con quelli toscani cari al purismo dell’autore; un’esigenza ben compren-sibile nella prospettiva appunto padovana e non veneziana da cui egli moveva, ma ben difficilmente ambientabile nella città lagunare, in cui un atteggiamento oppositivo o addirittura mutuamente esclusivo tra lingua e dialetto avrebbe difficilmente allignato, anche nei circoli puri-sti come la goliardica Accademia dei Granelleschi, che vi promuove il culto della «lingua litterale italiana» e di Dante in particolare.
città italiane, storie di lingue e culture
186
3.5.2. dalla lingua al dialetto, dal dialetto alla lingua
L’opposizione tra veneziano e italiano è in generale assente nella cul-tura veneziana del Sei e del Settecento: manca qui la correlazione so-cio-culturale che altrove poteva istaurarsi tra le due varietà, e mancano quindi gli effetti che ne potevano derivare, e che ne erano derivati o ne deriveranno, soprattutto in età contemporanea, laddove il dialetto verrà connotato come varietà demotica e subalterna opposta all’italia-no visto come lingua socialmente e culturalmente superiore. Ciò non avviene nella Venezia d’età moderna, dove gli assi della variazione dia-stratica e diafasica e il tracciato che dai testi letterari più raffinati di-grada verso le testimonianze più popolaresche intersecano di continuo lingua e dialetto, tra loro più spesso combinati che nettamente distin-guibili. È questo il terreno su cui si sviluppa, qui come altrove, il para-digma tipicamente moderno e contemporaneo dell’italiano regionale.
Ai classici lavori di Gianfranco Folena (1983) si deve l’analitica de-scrizione del caso più illustre di gestione perfettamente disinvolta e simultanea, in ambito letterario, delle due varietà (con il francese in aggiunta, come si conveniva all’ambiente culturale dell’epoca), cioè l’o-pera di Carlo Goldoni. La tecnica goldoniana del dialogo – in lingua e in dialetto –, la sua elaborazione di un italiano contaminato da elemen-ti eterogenei e perciò stesso naturalissimo, la capacità di modulare la lingua in un’ampia raggiera di varietà sociali, di modulazioni emotive e talora persino di realizzazioni geograficamente e sociologicamente marcate, a partire da un italiano vivacemente antipuristico e saturo di regionalismi: tutti questi elementi formano ormai un capitolo della sto-ria letteraria italiana che esorbita largamente dall’orizzonte cittadino e riscatta la circolazione, ampia ma fortemente stereotipata, del dialet-to di Pantalone, in cui la tradizione pregoldoniana aveva prolungato gli episodi già cinquecenteschi di uso del veneziano da parte di autori non veneti. Nelle commedie di Goldoni, il veneziano raggiunge una varietà di modulazioni che gli era ignota, nella produzione teatrale, dai tempi dei capolavori rinascimentali, e che si articola in direzioni nuove e ancora intentate: dalla caratterizzazione del linguaggio senile con i suoi caratteristici tic nell’eloquio dei Rusteghi (1760: «vegnimo a dire el merito» di Lunardo, «figurarse» di sua moglie), a quella, insieme sociolinguistica, anagrafica e psicologica della Gasparina del Cam-piello (1756), «giovine caricata, che parlando usa la lettera Z in luogo dell’S», fino alla varia cromìa linguistica dei personaggi delle Baruffe
3. venezia
187
19. Per i grecismi in particolare cfr. Cortelazzo (1970, e da ultimo ancora Cortelaz-zo, 2002), per gli arabismi nel veneziano, Pellegrini (1972), in particolare pp. 575-99.
chiozzotte, in cui la caratterizzazione dei personaggi «sfrutta pertinenti divergenze d’ordine fono-morfologico: ricorrono infatti in immediata successione il chioggiotto “Oggio da zurare” di Checca e il veneziano “No, adesso no avé più da zurar” di Isidoro ben distinti dalla presenza/assenza di -e dopo erre; e poi ancora, a Toffolo che dice “In stra, lustris-simo, se fa l’amore”, Isidoro risponde “Chiamemole in strada donca”, contrapponendo strada e stra con dileguo chioggiotto dell’occlusiva dentale anche in morfema femminile» (Stussi, 2005, pp. 181-2).
La produzione goldoniana si colloca a un estremo di raffinatezza e di valorizzazione delle risorse linguistiche e stilistiche offerte dall’am-biente veneziano. Ma non meno interessante se si vuole misurare local-mente il rapporto tra lingua e dialetto, riportandolo a un grado di ben minore raffinatezza letteraria, è la fortuna tipicamente sei-settecente-sca delle traduzioni di opere della letteratura nazionale – o addirittura di quella classica – in dialetto veneziano. Più che di semplici versioni, si tratta spesso – ad esempio nel caso di Tomaso Mondini e del suo Gof-fredo del Tasso cantà alla barcariola (1691-93) – di rifacimenti parodici adattati a peculiari contesti sociali e culturali, come quello del canto in gondola e del riuso popolare dei prodotti della letteratura illustre: fatto, ancora una volta, non esclusivamente veneziano, ma qui leggi-bile con particolare chiarezza e dovizia di articolazioni. E se Giacomo Casanova s’esercita, nel secolo successivo, in una traduzione dialettale dell’Iliade di Omero, anche in questo caso la versione piega la solenni-tà originaria a un tono tra il confidenziale e lo scherzoso che inevitabil-mente approda alla pura e semplice parodia.
3.5.3. venezia e le lingue d’europa
Agl’intensi contatti con le lingue dell’Adriatico e del Mediterraneo orientali, tipici della prima fase della sua espansione, il veneziano ag-giunge, soprattutto nel corso dell’età moderna, svariati scambi con le principali lingue dell’Europa occidentale. E come già era avvenuto nel-la prima fase – nella quale altrettanto intensi erano stati i prestiti al e dal veneziano in rapporto al greco e alle lingue del Vicino Oriente19 –, anche con francese, tedesco, inglese e spagnolo il flusso dei prestiti è bidirezionale.
città italiane, storie di lingue e culture
188
20. Ma per la preistoria di questo probabile catalanismo, è da tener presente Vàr-varo (1977).
Un caso particolare, in tal senso, è costituito dalla presenza di vene-zianismi nei più antichi vocabolari bilingui di italiano, realizzati all’e-stero: così, «del centinaio di vocaboli di schietto stampo settentrionale (spesso registrati assieme alla variante toscana) presente nel Vocabolario de las dos lenguas toscana y castellana di Cristóbal de las Casas [1570], la maggior parte è di provenienza veneta», e si tratta perlopiù di «voci appartenenti alle attività sul mare (peotta = pedotto “guia por la mar”, saorna, schiras “genere de navio”) ed ai suoi muti abitanti (angusigola, folpo = pulpo, grance(v)ole, ostrega = ostreca, sepa = sepia, sgombro)» (Cortelazzo, 1983, p. 374). Numerosi sono anche i venezianismi indivi-duati da Ronnie Ferguson (2012) nel primo grande dizionario inglese-italiano, A Worlde of Wordes di John Florio (pubblicato nel 1598 e poi in una nuova edizione nel 1611: cfr. ora l’edizione di Haller, in Florio, 2013). Del resto, lo stesso Ferguson (2012, p. 60) osserva che tra la cin-quantina di parole inglesi che possono considerarsi di origine venezia-na, per poco meno di quaranta la più antica attestazione oltre Manica risale ai secoli xvi e xvii: si tratta di termini come Arsenal (1511), ballot ‘pallina di votazione’ (1549), Lazzaretto (1549), Pantaloon, la maschera e il capo d’abbigliamento (1592), Ghetto (1611), regatta ‘regata’ (1612)20, quarantine ‘quarantena marittima’ (1663). Si noterà la presenza di vari termini del linguaggio marinaresco, che già in età medievale e ancora in quella moderna è uno dei principali àmbiti di diffusione del lessico veneziano così in Italia come nel resto d’Europa (cfr. Tomasin, 2010b).
A una simile fortuna internazionale corrispondeva un’analoga apertura del dialetto cittadino all’influsso delle principali lingue di cultura europee: inevitabile, tra Sei e Settecento, quello del francese, che si fa sentire anche sul lessico cittadino, non diversamente da quan-to avveniva, nella stessa epoca, all’italiano avviatosi a divenire «lingua d’Europa»: tra il materiale indicato da Paolo Zolli (1971), numero-si francesismi spesso adattati fonomorfologicamente e non mediati dall’italiano. Tali sono, per fare qualche esempio, vari termini della cucina come bigné, bodin ‘budino’, crocante ‘preparato in pasta frolla’, ragù, rosolin ‘tipo di liquore’.
Meno intenso, ma altrettanto interessante e certo meritevole di ul-teriori approfondimenti è l’influsso inglese sul veneziano, per il qua-le ci si dovrà per il momento accontentare di sparute testimonianze
3. venezia
189
21. Da ultimo, la panoramica di Fortis (2006), giudicata «la migliore monografia su una parlata giudeo-italiana» dal recente e informatissimo Aprile (2012, p. 14).
come quella del Boerio (ottocentesca, ma riferita a eventi del secolo precedente) relativa alla voce club, giunta probabilmente per tràmi-te francese: «voce inglese che significa Crocchio. I Francesi la tolsero dagl’Inglesi e l’applicarono particolarmente a crocchi destinati a trat-tar cose politiche; quindi l’abbiamo avuta anche noi all’epoca della nostra rivoluzione politica l’anno 1797, nel significato specialmente di Conventicolo o Conventicola, cioè di segreto raunamento di persone, e dicesi in mala parte» (Boerio, 1829, p. 134).
Del tutto peculiare è poi lo scambio indiretto che il veneziano in-trattiene con alcune lingue europee – e segnatamente con lo spagnolo e con il tedesco – per il tràmite della varietà giudeo-italiana parlata nel-la fiorentissima comunità ebraica della città. Grazie soprattutto ai la-vori di Alberto Fortis21, si può ricostruire la trafila appunto askenazita (quindi ibero-romanza) di termini caratteristici come meldàr ‘veglia di studio e meditazione sui testi sacri’, «giudeo-spagnolo meldár [...] dal latino tardo meletare, a sua volta dal greco meletân ‘esercitarsi’» (For-tis, 2006, p. 332), o quella jiddish di tipici termini della cucina ebraica locale, come grìbole ‘pezzetti di pelle d’oca fritti’, corrispondente allo jiddish gribene, a sua volta dal tedesco Griebe (ivi, p. 233).
3.6 Dopo la Serenissima
La fine della Repubblica (1797), i successivi due periodi di dominazio-ne straniera (francese e austriaca), l’unione al Regno d’Italia (1866) e il definitivo assestamento come città-capoluogo di una regione del-la quale non è più il baricentro politico, economico, sociale: la storia di Venezia negli ultimi due secoli è una vicenda di profonde trasfor-mazioni, che da un lato predispongono la città a fenomeni evolutivi comuni con la storia linguistica di altri centri italiani, ma da un altro preservano la sua specificità. Il periodo otto-novecentesco è segnato da una fioritura della riflessione sul veneziano, sulla sua storia e sulle sue strutture. Ciò porta alla realizzazione di vari vocabolari (tra i quali un capolavoro: il Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio, uscito per la prima volta nel 1829, e poi ancora nel 1856), di interessan-
città italiane, storie di lingue e culture
190
22. Sulla lingua di Noventa cfr. Tomasin (2005) e, più di recente, i contributi di Marco Praloran e Antonio Girardi raccolti in Daniele (2008, pp. 19-45).
ti esperimenti grammaticali (come quello lasciato incompiuto, negli stessi anni, da Daniele Manin), di repertori specifici (come il Lessico veneto che Fabio Mutinelli dedica, nel 1851, al linguaggio archivistico e giuridico veneto), di antologie della poesia veneziana, come quelle realizzate nel secolo xix da Bartolommeo Gamba, sorta di moderno poligrafo, originario di Bassano del Grappa, o quella pubblicata nel secolo successivo da un altro raffinato amateur, Manlio Dazzi (è il Fio-re della lirica veneziana, uscito in quattro volumi tra il 1956 e il 1959).
3.6.1. una peculiarità letteraria
Il veneziano continua ad essere, anche in età contemporanea, un dia-letto adibito alla produzione letteraria. Ma il particolare statuto del dialetto di città e la sua notevole differenza da quelli della vicina Ter-raferma trovano conferma in un aspetto della letteratura dialettale veneziana tra Otto e Novecento. Esauritasi, col tentativo di recupero in chiave verista promosso da Giacinto Gallina (1852-1897), la grande tradizione del teatro dialettale cittadino, la produzione lirica rimane la via maestra – se non proprio l’unica – per una sperimentazione lette-raria che tuttavia manca di un requisito tipico della miglior parte della poesia dialettale novecentesca. Mi riferisco alla netta preferenza accor-data a varietà dialettali geograficamente o culturalmente marginali, in-somma prive di tradizione scritta – e a maggior ragione di ascendenti letterari – e perciò assumibili come lingue nuove, vergini e completa-mente disponibili alla voce del poeta (fin troppo noti i casi del santar-cangelese di Baldini o del solighese di Zanzotto, del gradese di Marin o del tursitano di Pierro). Così, l’unico poeta in veneziano del canone novecentesco è un poeta che si dichiara non veneziano fin nel nome, e che ostenta apertamente l’autonomia del proprio idioletto dalla realtà sociale e storica del dialetto di città. Celebre la dichiarazione: «Mi me son fato ’na lengua mia / Del venezian, de l’italian. / Gà sti diritti la poesia, / Che vien dai lioghi che regna Pan»22. Si tratta di Giacomo Noventa, il quale peraltro fa dialogare il proprio idiosincratico vene-ziano non con altri dialetti o con la sola lingua-tetto italiana, ma con grandi lingue straniere di cultura, come avviene ad esempio nelle tra-duzioni dal tedesco di Goethe: traduzioni au pair, si noti bene, ben
3. venezia
191
diverse nello spirito e nel significato poetico dai rifacimenti burleschi sei-settecenteschi in veneziano.
E se, tornando alla poesia del Novecento, lo Zanzotto dei testi scritti per il Casanova di Fellini attinge direttamente al veneziano della tradizione, si tratta appunto di un recupero dotto, sottolineato nella sua stravolta natura libresca e ben diverso dalla voce “ingenua”, o se si preferisce primigenia, del dialetto rurale: «koiné veneta», secondo le parole dello stesso Zanzotto, che tuttavia tradisce in tale formulazione l’insofferenza tipicamente novecentesca per un veneziano così poco caratterizzato da divenire quasi irriconoscibile in una Terraferma dap-prima venezianizzata, ma già pronta a invertire i rapporti di forza del prestigio linguistico.
Per un apparente paradosso, il cui senso andrà cercato ancora una volta nella peculiare relazione che a Venezia intrattengono l’italiano e il dialetto, la miglior fortuna letteraria del veneziano tra xx e xxi secolo è di fatto affidata a scrittori che non scrivono in dialetto. Non si tratta solo – o non tanto – dei numerosi autori italiani e stranieri che fanno della macchia dialettale un indispensabile elemento di caratte-rizzazione ambientale di Venezia, quasi un topos letterario accanto ai molti altri che riguardano la città (e gli esempi, dai tempi di D’An-nunzio e Pound fino ai contemporanei, sarebbero innumerevoli). Vi sono infatti vari scrittori veneziani che, pur eleggendo l’italiano come lingua prevalente o esclusiva di creazione letteraria, appaiono pervasi dalla peculiare esperienza linguistica cittadina. Significativo il caso di Diego Valeri e del suo dialogo (riferito da Zanzotto) con il trevigiano Giovanni Comisso, che lo ritiene quasi istintivamente poeta dialettale (commento di Zanzotto: «vero: Valeri scrive in italiano, ma facendo sentire una cantabilità interna a una tradizione che era dialettale come d’altra parte Comisso scrive in un italiano splendido ma che è anche veneto splendido»; cit. in Tomasin, 2010a, p. 135).
In anni più recenti, e in un contesto culturale decisamente muta-to, uno scrittore come Tiziano Scarpa (nato nel 1963), autore di un fortunato (ma anticonvenzionale, o forse perché non convenzionale) ritratto letterario della Venezia tardonovecentesca (Venezia è un pesce, 2000), fa dell’esperienza linguistica – intesa come esperienza di liber-tà e di rottura degli schemi abituali – una componente essenziale del suo attraversamento della città. Del resto, la stessa apertura di Scarpa allo sperimentalismo linguistico, che si spinge fino all’elaborazione di
città italiane, storie di lingue e culture
192
23. Lo ha bene argomentato da ultimo Baglioni (in corso di stampa), offrendo una valida e convincente alternativa alle ipotesi che avevamo avanzato in Tomasin (2010a, p. 89).
un dialetto fittizio – quello dai tratti mediani o meridionali di Groppi d’amore nella scuraglia, 2010 – sembra implicare la concreta esperien-za plurilingue (o: tendenzialmente plurilingue) di un veneziano della generazione in cui una generale censura educativa antidialettale si è ri-solta nella ricerca di una tastiera linguistica più ricca e culturalmente impegnativa del grigio monolinguismo talora promosso dalla scuola italiana tardonovecentesca ma estraneo alla tradizione veneziana.
3.6.2. caratteri del veneziano contemporaneo
Non è possibile, nell’economia di questo lavoro, ripercorrere dettaglia-tamente le linee evolutive che portano dal veneziano medievale sopra descritto (par. 3.2.4) a quello attuale. Di séguito, si darà conto solo dei principali cambiamenti verificatisi nelle strutture fonomorfologiche del veneziano (ché quelle sintattiche coinvolgerebbero un panorama linguistico ben più vasto di quello urbano) durante l’età moderna e contemporanea, concentrandosi in particolare su quelli che rendono il dialetto cittadino odierno riconoscibile rispetto alle non meno vitali varietà limitrofe (cioè ai dialetti dell’Estuario lagunare e della Terrafer-ma). Ricorderemo in particolare:– Lo sviluppo (iniziato già nel secolo xiv) del dittongo /wƆ/ da /Ɔ/ romanza, e il suo successivo ulteriore sviluppo in /jo/ per una serie li-mitata di voci (liogo, niovo ecc.) per condizionamento della consonante coronale precedente23, cui fa séguito, tra Otto e Novecento, la chiusura di entrambi i dittonghi nella medio-alta /o/ (quindi: /’bon/, /’novo/ ecc.).– La perdita – più lenta qui che nelle varietà galloromanze – dell’e-lemento dentale nelle affricate /ts/ e /dz/, per cui si hanno oggi forme come /'sento/<centum e /'dzente/<gentem: Boerio (1829) testi-monia lo sviluppo di tali esiti a partire dai precedenti con /ts-/, /dz-/ (ancora oggi sporadicamente attestati nelle varietà vicine).– L’insorgenza di due caratteristiche varianti allofoniche di /-l-/ (an-che succedanea di ll) rispettivamente a contatto con vocali non pala-tali (dove si ha un suono simile a [e ̯]) e a contatto con vocali palatali (dove dilegua), donde forme come /'gondoea/ ‘gondola’, /'bƐo/ ‘bello’. Si tratta di uno sviluppo relativamente recente, probabilmente non
3. venezia
193
anteriore al secolo xx, e rapidamente estesosi alle varietà, soprattutto urbane, della Terraferma (per i dettagli, Tomasin, 2010c).– Parallelamente (forse) al fenomeno appena illustrato, l’articolazio-ne del fonema /r/ come monovibrante [ɾ], che non sembra essere con-dizionata dal contesto.– La perdita delle forme pronominali nominativali di 1a e 2a persona (eo, tu, ancor vive all’altezza del secolo xvi) e la loro sostituzione con le forme oblique mi, ti, esclusive nel dialetto contemporaneo.– La generalizzazione della forma “debole” dell’articolo determi-nativo maschile singolare, el, a scapito dell’antico lo, definitivamente scomparso già da alcuni secoli nella varietà cittadina (solidale, in que-sto, con l’andamento generale dei dialetti italiani settentrionali).– La generalizzazione del condizionale da -habebam, quindi il tipo vorìa, a scapito di quello da -habui, quindi vorave, prevalente nel ve-neziano antico, la cui sopravvivenza giunge fino al secolo xx in città e addirittura fino ad oggi in altri centri lagunari (ad esempio Chioggia, che in vari altri casi mantiene in vita fenomeni ormai estinti nel ve-neziano offrendo un caso paradigmatico di conservatività delle aree marginali).– Il morfema ossitono (cioè apocopato) del participio passato debole maschile singolare della prima coniugazione: tipo amà, laddove il fem-minile singolare conserva la consonante (amada), e le restanti forme di tutte le coniugazioni mantengono lo iato secondario (plurale: amai, amae; altre coniugazioni: avùo, -ùa, -ùi, -ùe; sentìo, -ìa, -ìi, -ìe).– La caratteristica forma /'ze/ della terza persona singolare del pre-sente indicativo di essere (grafia consueta: xe), che si è imposta dive-nendo esclusiva nel veneziano di epoca moderna e contemporanea: nei testi medievali essa conviveva con altre forme.
3.6.3. l’italiano regionale in città
I caratteri propri dell’italiano regionale veneziano odierno, in parte assimilabili a quello di vari altri centri urbani italiani, risentono del peculiare status del dialetto: «Venezia – con le parole di Sullam Ca-limani (2009, p. 174) vive ancora oggi una situazione (parzialmente) anomala che vede persone di strato sociale elevato innalzare un dialet-to largamente italianizzato ad un registro alto ed arricchirlo di inserti italiani o di lingue straniere, oppure usare una lingua che oscilla tra una variante medio-alta di italiano regionale e un italiano neostandard
città italiane, storie di lingue e culture
194
24. Giusto i materiali raccolti da De Blasi smentiscono l’ipotesi successivamente formulata da Massimo Fanfani (2012), secondo cui l’italiano ciao non sarebbe forma di origine veneziana, bensì parola italiana (schiavo) modernamente adattata al dialet-to di Milano e di qui irradiata, all’inizio del secolo xix, alla lingua nazionale. La te-
costellato di citazioni dialettali». Un’indagine sistematica e aggior-nata – dopo i pionieristici lavori di Canepari (1986) – sulla fisiono-mia dell’italiano regionale a Venezia andrebbe certamente svolta. Se ne trarrebbero informazioni preziose su tutti i livelli che distinguono l’italiano parlato – e per alcuni aspetti anche scritto – a Venezia. Tra i fenomeni fonetici vi è la penetrazione di alcune peculiari articolazioni dialettali, come quella di /r/ come monovibrante [ɾ] di cui abbiamo detto sopra, nel par. 3.6.2 (mentre assai minore si direbbe l’incidenza della cosiddetta “elle evanescente” dialettale sulla varietà locale dell’i-taliano). Tra quelli morfosintattici, un’indagine recentemente pro-posta da Cardinaletti, Munaro (2009) ha isolato taluni caratteristici costrutti esclamativi (tipo Quanto che sei stupido!, o, ancor più diret-tamente influenzato da un tratto dialettale, Cosa che non mangiava!: Chinellato, 2009), o l’interferenza dei precipui caratteri sintattici dei costrutti verbo+preposizione tra dialetto e italiano (tipo: I soldi si è mangiato fuori, e non *Fuori i soldi si è mangiato, con trasferimento in italiano dello statuto sintattico proprio dei verbi dialettali con fora «terminativo o completivo»: Poletto, 2009).
Ovvio, tuttavia, che i referti più abbondanti si raccolgano nel cam-po lessicale, e documentino un ampio bacino di venezianismi ormai stabilmente entrati nel parlato cittadino, e penetrati anche nei suoi re-gistri meno informali: si tratta di termini talora condivisi in generale con l’italiano regionale di tutto o quasi il Nord d’Italia (ad esempio: moroso/morosa ‘fidanzato’/‘fidanzata’), talaltra tipicamente veneziani, ma così famosi da divenire, anche all’esterno, blasoni della parlata lagu-nare (com’è il caso di mona, termine la cui etimologia e storia sono state finemente discusse da D’Onghia, 2011); per questa via, del resto, un al-tro venezianismo è penetrato nell’italiano nazionale senza lasciar tracce della sua origine nella coscienza dei parlanti, e venendo anzi largamente esportato anche in molte altre lingue: è il ciao divenuto formula inter-nazionale di saluto (e soprattutto di congedo), di cui De Blasi (2009, pp. 13-23) ha raccolto gli indizi della circolazione già settecentesca (nella forma sciavo poi censita dal Boerio, 1829 s.v. schiavo: «Modo di salutare altrui con molta confidenza»24). A dimostrazione, si direbbe, di come i
3. venezia
195
stimonianza dei materiali adunati per confortare l’ipotesi non appare persuasiva. Se è possibile che Milano possa fungere, nell’Ottocento, da centro di diffusione di questo termine (ulteriore o successivo rispetto a una fase iniziale e probabilmente settecen-tesca), la sua origine veneziana appare garantita non solo da ragioni fonetiche (ciao è forma possibile nel veneziano, ma non nei dialetti lombardi), ma anche da ragioni storiche. La voce schiao, in cui chi sta per l’affricata palatale, del Boerio (1829, dove le varie altre locuzioni censite la mostrano pienamente acclimata), unita alle occorrenze settecentesche (non solo veneziane, ma certamente da qui irradiate) della forma con s-, indicano che a Venezia la voce era non solo fonomorfologicamente autoctona, ma anche socialmente diffusa e radicata. Se pure l’assestamento sul tipo senza s- (forse er-roneamente interpretata come prefisso) si fosse verificato altrove, non sembra esservi ragione per revocare in dubbio l’origine di una forma perfettamente compatibile con la storia interna ed esterna del veneziano.
confini tra italiano regionale, lingua nazionale e materiale linguistico di larga circolazione europea sono, per Venezia, assai difficili da tracciare.
3.6.4. sulla venezia linguistica del xxi secolo
Al giorno d’oggi, Venezia si trova al centro di un’area linguistica ca-ratterizzata da una forte permanenza del dialetto accanto all’italiano: un’area della quale la città lagunare è stata per secoli il centro sociale e politico, e quindi anche il modello linguistico di riferimento, e di cui oggi è – dal punto di vista economico e demografico – una zona non certo marginale, ma nemmeno cruciale. Da un rapporto pubblicato nel 2006 dall’Istituto centrale di Statistica italiano, risulta che «al Nord il Veneto e la provincia di Trento sono le uniche zone dove è prevalente l’uso, seppure non esclusivo, del dialetto in famiglia (69,9% in Vene-to e 64,1% nella provincia di Trento)». Secondo lo stesso rapporto, il Veneto è la regione del Nord in cui è minore la quota di persone che parlano prevalentemente italiano (23,6%): un dato che, nonostante la percentuale non schiacciante, mostra come fenomeni generali quali la sdialettizzazione, l’attenuazione della differenza culturale e l’ap-piattimento del repertorio linguistico, spesso considerati come tratti dominanti dell’Italia contemporanea, trovino in questa zona un utile antidoto nella diffusa resistenza di un dialetto interclassista e socio-linguisticamente prestigioso, del quale abbiamo già indicato l’influsso sull’italiano regionale cittadino.
Tuttavia, contro una visione troppo schematica e idealizzata del panorama sociolinguistico contemporaneo, occorrerà sottolineare le
città italiane, storie di lingue e culture
196
profonde differenze che tuttora separano il contesto della città lagu-nare e quello della regione retrostante: la Terraferma veneta, per secoli appendice politica, sociale e culturale di quella che non a caso veniva chiamata Dominante, compete ormai, a partire dal Novecento, con la città capoluogo in termini di dinamismo economico e socio-cultura-le, nonché di equilibrio demografico. Anche per questo i dati relativi a uso, vitalità ed espansione del dialetto si riferiscono piuttosto alla regione e ai suoi nuovi e variegati contesti urbani, che all’antica me-tropoli, e hanno dunque radici storiche e presupposti in parte diversi da quelli che si sono descritti nelle pagine precedenti, ripercorrendo l’antica convivenza di italiano e veneziano in città.
Lo spostamento del baricentro urbano dall’antico nucleo insulare, sempre meno popolato, alla nuova zona d’espansione continentale, se-gnata da una netta continuità culturale e quindi anche linguistica con la Terraferma, sta modificando decisamente gli assetti sociolinguistici reali, pur restando assai vivo, e largamente diffuso anche nella popola-zione extra-urbana, il prestigio storico e culturale del veneziano.
Un esempio recentissimo, tratto dalla cronaca cittadina, illustra forse meglio di tante indagini demoscopiche la percezione diffusa di tale prestigio. Nel 2013, il Comune di Venezia ha deciso di avviare un riordino e un’uniformazione delle indicazioni stradali del centro stori-co lagunare: toponimi tradizionali dipinti sui muri delle case con am-pia, pur se discontinua e disomogenea concessione a forme grafiche, fonetiche e morfologiche dialettali, oltreché a un lessico tipicamente locale; insomma toponimi dialettali, e come tali percepiti dalla popo-lazione. Nel far ridipingere tali indicazioni (popolarmente chiamate nizioleti, cioè ‘lenzuolini’, con allusione ai rettangoli bianchi su cui si accampano i toponimi), il Comune ha ripristinato sistematicamente le denominazioni e le forme riportate nell’ultimo catastico realizzato dalla Serenissima, alla fine del Settecento. Poiché le forme presenti in quella fonte storica includevano scrizioni percepite oggi come meno “dialettali” (ad esempio, consonanti raddoppiate per ragioni etimolo-giche, ovviamente non riflesse dalla pronuncia), l’operazione è apparsa a molti veneziani come un’indebita “italianizzazione” della peculiare toponomastica cittadina, e ha perciò suscitato un intervento geografi-camente ampio e culturalmente trasversale contro la presunta minac-cia della tradizione linguistica veneziana e dei suoi delicati equilibri: intervento che ha coinvolto tutti i mezzi di informazione più tipici del
3. venezia
197
giorno d’oggi, a partire da internet, ambiente di per sé non particolar-mente favorevole alla vitalità di altre tradizioni dialettali.
Anche astraendo dalla circostanza specifica e dagli equivoci su cui si è fondato questo incidente toponomastico, l’episodio dimostra la capa-cità del veneziano di mobilitare, in nome di una difesa non puramente passatista, l’opinione pubblica – né solo quella della città –, e di essere percepito da fasce assai vaste della popolazione come un elemento de-cisivo dell’identità culturale e della stessa riconoscibilità di Venezia. Se ciò è vero in molte altre città d’Italia – e più ancora, forse, in molte aree non urbane del paese –, la situazione veneziana continua a distinguersi piuttosto nettamente da quella di altri contesti urbani nei quali gli ele-menti di continuità (anche fisica, architettonica e paesaggistica) sono stati più seriamente intaccati dall’omologazione contemporanea, con pesanti ripercussioni anche sui tradizionali assetti linguistici.
Bibliografia
aprile m. (2012), Grammatica storica delle parlate giudeo-italiane, Congedo, Galatina.
ascoli g. i. (1885), L’Italia dialettale, in “L’Italia dialettale”, viii, pp. 98-128.baglioni d. (in corso di stampa), Sulle sorti di [Ɔ] in veneziano, in E. Buchi,
J.-P. Chauveau, J.-M. Pierrel (éds.), Actes du xxviie Congrès international de linguistique et philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013), 3 voll., So-ciété de linguistique romane/EliPhi, Strasbourg.
belloni g., pozza m. (1990), Il più antico documento in veneziano. Proposta di edizione, in M. Cortelazzo (a cura di), Guida ai dialetti veneti, vol. xii, cleup, Padova, pp. 5-32.
bertelli s., meneghetti m. l., tagliani r. (2012), Nuove acquisizioni per la protostoria del codice Hamilton 390 (già Saibante), in “La critica del testo”, 15, pp. 75-126.
bertolucci pizzorusso v. (2011), Testamento in francese di un mercan-te veneziano (Famagosta, 1294), in Ead., Scritture di Viaggio. Relazioni di viaggiatori ed altre scritture letterarie e documentarie, Aracne, Roma, pp. 243-68 (i ed. 1988).
bianconi s. (2013), L’italiano lingua popolare. La comunicazione scritta e parlata dei «senza lettere» nella Svizzera italiana dal Cinque al Novecen-to, Accademia della Crusca, Firenze-Casagrande, Bellinzona.
boerio g. (1829), Dizionario del dialetto veneziano, Santini, Venezia.id. (1856), Dizionario del dialetto veneziano, Cecchini, Venezia.
città italiane, storie di lingue e culture
198
bonfiglio dosio g. (a cura di) (1987), Ragioni antique spettanti all’arte del mare et fabriche de vasselli. Manoscritto nautico del sec. xv, Comitato per la Pubblicazione delle Fonti relative alla Storia di Venezia, Venezia.
burgio e. (a cura di) (1995), Legenda de misier sento Alban: volgarizzamento veneziano in prosa del 14. secolo, Marsilio, Venezia.
calmo a. (2003), Le bizzarre, faconde et ingegnose rime pescatorie, a cura di G. Belloni, Marsilio, Venezia.
id. (2006), Il Saltuzza, a cura di L. D’Onghia, Esedra, Padova.canepari l. (1986), Lingua italiana nel Veneto, clesp, Padova.cardinaletti a., munaro n. (a cura di) (2009), Italiano, italiani regiona-
li e dialetti, FrancoAngeli, Milano.carrai s. (2006), L’usignolo di Bembo. Un’idea della lirica italiana del Ri-
nascimento, Carocci, Roma.chinellato p. (2009), Strutture esclamative nell’italiano regionale del Vene-
to, in Cardinaletti, Munaro (2009), pp. 55-68.contini g. (a cura di) (1960), Poeti del Duecento, Ricciardi, Milano-Napoli.cortelazzo m. (1970), L’influsso linguistico greco a Venezia, Pàtron, Bo-
logna.id. (1983), Uso, vitalità e espansione del dialetto, in Storia della cultura veneta,
4.i, Il Seicento. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Neri Pozza, Vicenza, pp. 363-79.
id. (2002), Influsso greco sull’antroponimia e la toponomastica veneziane, in M. F. Tiepolo, E. Tonetti (a cura di), I greci a Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, pp. 315-23.
id. (2007), Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel xvi secolo, La Linea editrice, Limena.
da canal m. (1972), Les Estoires de Venise, a cura di A. Limentani, Olschki, Firenze.
daniele a. (a cura di) (2008), Giacomo Noventa, Esedra, Padova.de blasi n. (2009), Parole nella storia quotidiana. Studi e note lessicali, Li-
guori, Napoli.dionisotti c. (1968), Gli umanisti e il volgare tra Quattro e Cinquecento, Le
Monnier, Firenze.id. (2009), La lingua italiana da Venezia all’Europa, in Id., Scritti di storia
della letteratura italiana. ii. 1963-1971, a cura di T. Basile, V. Fera, S. Villari, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, pp. 271-9 (i ed. 1967).
di versi p. (1991), Raxion de’ marineri. Taccuino nautico del xv secolo, a cura di A. Conterio, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla sto-ria di Venezia, Venezia.
d’onghia l. (2011), Un’esperienza etimologica veneta. Per la storia di mona, Esedra, Padova.
3. venezia
199
id. (2014), Drammaturgia, in sis, vol. ii, pp. 153-202.dotto d. (2008a), Scriptae venezianeggianti a Ragusa nel xiv secolo, Viella,
Roma.id. (2008b), Nuova ricognizione di un testo veneziano del xiii secolo: Ragusa,
1284, in “Quaderni Veneti”, 46, pp. 9-36.fanfani m. (2012), ‘Ciao’ e il problema della datazione, in “Lingua nostra”,
lxxiii, pp. 7-18.ferguson r. (2012), Primi influssi culturali italo-veneti sull’inglese: la testi-
monianza dei venezianismi in Florio, Coryate e Jonson, in “Quaderni ve-neti”, n.s., 1, pp. 57-82.
id. (2013), Saggi di lingua e cultura veneta, cleup, Padova.ferrari m. (2013), Il Lamento dei pescatori veneziani. Edizione e commento,
in “Filologia italiana”, 10.florio j. (2013), A Worlde of Wordes, ed. by H. Haller, University Press, To-
ronto.folena g. (1968-70), Introduzione al veneziano “de là da mar”, in “Bollet-
tino dell’Atlante linguistico mediterraneo”, 10-12, pp. 332-76, rist. in Id., Culture e lingue nel Veneto medievale, Editoriale Programma, Padova 1990, pp. 227-67.
id. (1983), L’italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, Einau-di, Torino.
formentin v. (2012), La scripta dei mercanti veneziani del Medioevo (secoli xii e xiii), in “Medioevo romanzo”, xxxvi, pp. 62-97.
id. (2014), Rendiconti duecenteschi in volgare dall’archivio dei Procuratori di San Marco, in “Lingua e Stile”, 49, pp. 5-42.
fortis a. (2006), La parlata degli ebrei di Venezia, Giuntina, Firenze. gambino f. (a cura di)(2007), I Vangeli in antico veneziano. Ms. Marciano It.
I 3 (4889), Antenore, Roma-Padova.gradenigo j. (1999), Gli Quatro Evangelii concordati in uno, a cura di F.
Gambino, Commissione per i testi di lingua, Bologna.grubb j. s. (ed.) (2009), Family Memoirs from Venice (15th-17thCenturies),
Viella, Roma.levy e. (1883), Der Trobadour Bertolome Zorzi, Niemeyer, Halle.long p., mc gee d., stahl a. m. (eds.) (2009), The Book of Michael of Rho-
des: A Fifteenth-Century Maritime Manuscript, i: Facsimile, ed. by D. McGee; ii: Transcription and Translation, ed. by A. M. Stahl; iii: Studies, ed. by P. O. Long, mit, Cambridge (ma).
matt l. (2014), Epistolografia letteraria, in sis, vol. ii, pp. 255-82.minervini l. (2010), Le français dans l’Orient latin (xiiie-xive siècles). Élé-
ments pour la caractérisation d’une scripta du Levant, in “Revue de Lin-guistique Romane”, 74, pp. 119-98.
città italiane, storie di lingue e culture
200
morozzo della rocca r. (a cura di) (1957), Lettere di mercanti a Pignol Zucchello, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, Venezia.
nadal g. g. (1996), Leandreride, a cura di E. Lippi, Antenore, Padova.paccagnella i. (2013a), Per una storia linguistica del Veneto. Dal Medioevo
al Rinascimento, in Id., Tramature. Questioni di lingua nel Rinascimento tra Veneto e Toscana, cleup, Padova, pp. 25-139.
id. (2013b), L’editoria veneziana e la lessicografia prima della Crusca, in To-masin (2013b), pp. 47-64.
papanti g. (1875), I parlari italiani in Certaldo alla festa del v centenario di messer Giovanni Boccacci, Vigo, Livorno.
pellegrini g. b. (1972), Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale ri-guardo all’Italia, Paideia, Brescia.
petrucci l. (2011), Alle origini dell’epigrafia volgare. Iscrizioni italiane e ro-manze fino al 1275, Plus, Pisa.
pittarello o. (a cura di) (2006), Algune raxion per marineri: un manuale veneziano del secolo 15. per gente di mare, Il Poligrafo, Padova.
poletto c. (2009), I costrutti verbo+preposizione: l’interferenza tra veneto e italiano regionale, in Cardinaletti, Munaro (2009), pp. 155-72.
quirini g. (2002) Rime, a cura di E. M. Duso, Antenore, Roma-Padova.richardson b. (1994), Print Culture in Renaissance Italy, University Press,
Cambridge.sattin a. (1986), Ricerche sul veneziano del sec. xv (con edizione di testi), in
“L’Italia dialettale”, xlix, pp. 1-172.sis = antonelli g., motolese m., tomasin l. (a cura di) (2014), Storia
dell’Italiano scritto, vol. i, La poesia, vol. ii, La prosa letteraria, vol. iii, Italiano dell’uso, Carocci, Roma.
stussi a. (1962), Un testamento volgare scritto in Persia nel 1263, in “L’Italia dialettale”, xxv, pp. 23-37.
id. (1965), Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento, Nistri-Lischi, Pisa.
id. (a cura di) (1967), Zibaldone da Canal. Manoscritto mercantile del sec. xiv, Comitato per la Pubblicazione delle Fonti relative alla storia di Venezia, Venezia.
id. (2000), Filologia mercantile, in Studi di filologia e letteratura italiana in onore di Gianvito Resta, Salerno Editrice, Roma, pp. 269-83.
id. (2005), Storia linguistica e storia letteraria, il Mulino, Bologna.sullam calimani a. v. (2009), Italiano regionale a Venezia, in Cardinalet-
ti, Munaro (2009), pp. 173-92.tagliani r. (a cura di) (2011), Il Tristano corsiniano. Edizione critica, Acca-
demia dei Lincei, Roma.telve s. (2014), Il parlato riportato, in sis, vol. iii, pp. 15-55.
3. venezia
201
testa e. (2014), L’italiano nascosto. Una storia linguistica e culturale, Einau-di, Torino.
tomasin l. (2000), Note di antroponimia veneziana medievale (con un testo inedito del primo Trecento), in “Studi linguistici italiani”, xxvi, pp. 130-48.
id. (2001), Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano, Esedra, Padova.
id. (2005), Appunti su Noventa, in “Neophilologische Mitteilungen”, 106, pp. 31-44.
id. (2007), Lettura linguistica della Veniexiana, in “Per leggere”, 12, pp. 151-69.id. (2009), Fortuna e sfortuna letteraria del lessico giuridico veneziano, in C.
Marcato (a cura di), Lessico colto, lessico popolare, Edizioni dell’Orso, Ales-sandria, pp. 85-100.
id. (2010a), Storia linguistica di Venezia, Carocci, Roma.id. (2010b), Sulla diffusione del lessico marinaresco italiano, in “Studi lingui-
stici italiani”, xxxvi, pp. 263-92.id. (2010c), La cosiddetta «elle evanescente» del veneziano: fra dialettologia
e storia linguistica, in G. Ruffino, M. D’Agostino (a cura di), Storia della lingua italiana e dialettologia, Centro di Studi filologici e linguistici sici-liani, Palermo, pp. 729-51.
id. (2012), «Da le Veniesie, vinizian di buoni e di maore». Per la storia delle parole Venezia, veneziano e veneto, in A. Cecchinato, C. Schiavon (a cura di), «Una brigata di voci». Studi offerti a Ivano Paccagnella per i suoi ses-santacinque anni, cleup, Padova, pp. 1-18.
id. (2013a), Quindici testi veneziani (1300-1310), in “Lingua e Stile”, 48, pp. 3-48.id. (a cura di) (2013b), Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e
la storia della lessicografia italiana, Cesati, Firenze. trovato p. (1991), Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni edito-
riali dei testi letterari italiani (1470-1570), il Mulino, Bologna.id. (1998), L’ordine dei tipografi. Lettori, stampatori correttori tra Quattro e
Cinquecento, Bulzoni, Roma.vàrvaro a. (1977), Per la storia di ‘regata’, ‘ricattare’, ‘rigattiere’, in Studi
filologici, letterari e storici in memoria di Guido Favati, Antenore, Padova, vol. ii, pp. 639-52.
zolli p. (1971), L’influsso francese sul veneziano del 18. secolo, ivsla, Venezia.zorzi muazzo f. (2008), Raccolta de’ proverbii, detti, sentenze, parole e fra-
si veneziane, arricchita d’alcuni esempi ed istorielle, a cura di F. Crevatin, Angelo Colla, s.l.