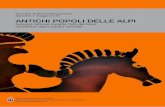L'esemplificazione. Natura e funzione di un procedimento di composizione testuale, in: L’italiano...
Transcript of L'esemplificazione. Natura e funzione di un procedimento di composizione testuale, in: L’italiano...
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
1
Emilio Manzotti
L ’ E S E M P L I F I C A Z I O N E N a t u r a e f u n z i o n i d i u n p r o c e d i m e n t o
d i c o m p o s i z i o n e t e s t u a l e
ad parandam copiam, exempla primas te-nent, sive deliberes, sive exhorteris, sive consoleris, sive laudes, sive vituperes. Et ut summatim dicam, sive fidem facere stu-deas, sive movere, sive delectare [Erasmo, de copia, 1534)]
1. Preliminari.
1.1. Che cosa vuol dire ‘esemplificare’. Il senso comune non esita a riconoscere nell’esemplificare un momento importante nel costituirsi di un ragionamento e, pertanto, della elaborazione di un testo, scritto o orale, monologico o dialogico che esso sia. Secondo la intuizione, ‘esemplificare’ vale in effetti qualcosa come ’riprendere in maniera più concreta, indicandone uno o più casi specifici (= esempi) una precedente affermazione di carattere generale’: questo per un intento di chiarezza, cioè per far capire meglio all’interlocutore che cosa si intende e quindi agevo-larlo nel compito – accogliere una affermazione come vera, rispondere a una domanda, agire in certo mo-do, ecc. – a cui lo si chiama. D’altronde è lo stesso interlocutore a volte ad esigere l’aiuto degli esempi: si pensi a repliche usuali come «Per esempio?», «Fammi un esempio», e così via1. Concreti e perspicui per loro natura, gli esempi, così come l’attività che li produce, l’esemplificare, ri-cevono valutazioni di segno opposto. Da una parte, e il giudizio sarà allora decisamente positivo, l’esempio, oltre che come una indispensabile forma argomentativa, è visto come un potente antidoto al pensiero astratto, un ausilio all’intelligenza che rischia altrimenti di perdersi. Ma, d’altra parte, il fatto che l’esempio sia sbilanciato sul versante della ‘pratica’ e della concretezza può essere ritenuto in qualche modo riduttivo: l’esempio appare allora subalterno rispetto al ragionamento puro, un movimento argomentativo tutto sommato superfluo per una intelligenza superiore. Queste due concezioni possono a volte coesistere senza contraddizione, come accade in un sorprendente passo della Welt als Wille und Vorstellung di Arthur Schopenhauer2, che rovescia implicitamente nella chiusa («...in modo da non lasciar dubbi che...») la seve- 1 Caratteristiche le battute d’uno sprovveduto personaggio di un romanzo d’intrattenimento: «“tutto risale alla lin-guistica di Saussure. L’arbitrarietà del significante. Il linguaggio come sistema di differenze senza termini assoluti” – “Dammi un esempio”, disse Persse. “Non riesco a seguire un ragionamento senza esempi” – “Be’, prendi le parole cane e gatto. Non c’è una vera ragione per cui la combinazione dei fonemi c-a-n-e debba significare un quadrupede che fa ‘bau bau’, anziché uno che fa ‘miao miao’. È una connessione solo arbitraria e non esiste un motivo per il qua-le chi parla inglese non debba decidere che da domani cane significhi gatto e viceversa”» (D. Lodge, Il professore va al congresso, Milano, Bompiani, 1990, pp. 37-38). 2 II: Ergänzungen, cap. 8 «Zur Theorie des Lächerlichen». La traduzione qui citata è dal volume dei Meridiani Mon-dadori (Il mondo come volontà e rappresentazione, Milano 1989) a cura di A. Vigliani (pp. 852-3). Mio, naturalmente,
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
2
rità spregiativa dell’apertura: «Nel primo volume ho ritenuto superfluo illustrare questa teoria [= la teoria del Lächerlichen, del ridicolo, del riso] con degli esempi, poiché chiunque può farlo facilmente, se solo riflette un poco sui casi [...] che ricorda. Ma ora, per venire in aiuto anche di quei lettori che, per la loro pigrizia intel-lettuale, continuano ad essere passivi, voglio darmi la pena di offrire qualche esempio. Anzi, in questa terza edizione, ne voglio presentare una quantità considerevole, in modo da non lasciar dubbi sul fatto che qui, do-po tanti tentativi precedenti rivelatisi infruttuosi, viene data la vera teoria [...] e viene risolto definitiva-mente il problema sollevato, ma anche abbandonato, da Cicerone». Ma al di fuori di quel che l’intuizione ci rivela – che cioè come s’è detto l’esemplificare equivale ad in-trodurre in un certo punto di un testo una sezione che intrattiene con quanto precede un legame di un ti-po specifico – e valutazioni positive o negative a parte, è un dato di fatto che della ‘grammatica’ e della pratica della esemplificazione si conosce molto poco o per meglio dire quasi nulla. Basta, per convincerse-ne, nominare alcuni dei problemi posti dall’esemplificazione – problemi per niente peregrini, a dire il vero – che pure non sono mai stati affrontati in maniera sistematica:
(i) ‘illustrazione’ e ‘esemplificazione’ sono concetti impiegati a volte, ma non sempre, come equivalenti. È possibile stabilire tra di essi una distinzione sistematica? Si tratta di declina-zioni di uno stesso concetto, o di concetti indipendenti?
(ii) che cosa distingue l’esemplificazione da movimenti testuali prossimi, quali la specificazione (= l’introdurre qualcosa dello stesso genere dell’antecedente ma di più specifico), la giustifi-cazione, e così via? In particolare, che cosa è caratteristico del legame di esemplificazione?
(iii) i segnali di esemplificazione: è necessario segnalare linguisticamente come tale la sezione esemplificativa? in altri termini, locuzioni del tipo di ad esempio sono indispensabile per poter riconoscere una sezione di testo come esemplificativa? quali sono, accanto a ad esempio, gli altri segnali di esemplificazione?;
(iv) la scelta dell’esempio: perché certi casi particolari funzionano bene da esempio mentre altri no? al ‘buon’ esempio è forse necessaria una certa centralità o tipicità?;
(v) le dimensioni dell’esempio; un esempio troppo protratto non rischia di pregiudicare l’equilibrio strutturale del testo, sconfinando nella digressione?
(vi) la conclusione dell’esempio: con cosa proseguire una volta concluso l’esempio? Gli esempi in effetti non fanno progredire argomentativamente il testo, sono statici, inclinano all’indietro piuttosto che in avanti. Riprendere il filo del discorso, dopo un esempio di dimensioni sostanziale, risulta così un compito non elementare.
Gli interrogativi posti da simili quesiti richiedono una riflessione che va al di là dei suggerimenti della intuizione o delle informazioni, del resto scarne, dei manuali di retorica o di composizione. Noi ci limite-remo qui ad un primo orientamento, privilegiando tra le molte possibili3 la problematica linguistica e in particolare testuale della esemplificazione. Converrà tuttavia prima di entrare nel vivo della discussione fermarci più in dettaglio, per mostrarne la complessità del funzionamento, su un caso particolare di esem-plificazione entro un frammento di prosa argomentativa.
il rilievo grafico. 3 Un panorama delle altre problematiche è presentato nella prima sezione di un più ampio studio sulla esemplifica-zione («Aspetti linguistici della esemplificazione») destinato alla rivista «Versus»».
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
3
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
4
1.2. Un esempio (complicato) di esempio Si consideri il passo (1), tratto da una redazione preliminare di uno studio letterario:
(1) Margherita è un personaggio che assume un ruolo di primo piano nel capitolo d’apertura, perché è lei a introdurre il lettore nell’universo romanzesco nominando per la prima volta luoghi e perso-naggi che acquisteranno nel seguito un rilievo centrale. È infatti Margherita ad esempio a farsi ca-rico della presentazione di Giovanna: [seguono otto righe di citazione]. Come si vede, l’immagine di Giovanna che esce dal ritratto popolaresco di Margherita è piuttosto quello di un intraprendente personaggio da feuilleton. Ma la menzione conta soprattutto per il suo effetto di prolessi, anticipando la conclusione (negativa) della vicenda giovanile che verrà nel segui-to confermata dai ricordi di Marco. Importa rilevare ecc. [si ritorna sul fatto che il lettore venga introdotto in medias res da anticipazioni di un personaggio secondario].
Percorrendo (1) si incontra in primo luogo l’asserzione veicolata dalla dichiarativa copulativa «Marghe-rita è un personaggio che [...] capitolo d’apertura». L’asserzione – cioè essenzialmente il contenuto della relativa – viene poi giustificata due volte: una prima volta da una subordinata causale, e poi, permanendo sintatticamente ancora all’interno della causale, da una subordinata gerundiva («nominando per la prima volta ecc.»), la quale in effetti possiede oltre al valore modale anche una chiara componente strumentale-causale (“grazie al nominare ecc. si introduce il lettore ecc.”); la gerundiva, insomma, viene a specificare la causale. L’apertura di (1) potrà dunque essere schematizzata come
p perché q SPECIF r
dove il simbolo SPECIF sta ad indicare la relazione di specificazione, non segnalata linguisticamente, tra q e r, e dove r intrattiene ancora con p, in quanto specificazione di q, una relazione di giustificazione. Segue quindi una frase («È infatti Margherita ad esempio ecc.») la cui struttura sintattica di scissa4 ricalca quella della causale, e che un duplice segnale lessicale (infatti, ad esempio) presenta ad un tempo come giustifica-zione (la terza, per tenere il conto) e come esemplificazione. Lo schema complessivo del primo paragrafo sarà allora
p perché q SPECIF r. ESEMPLIF / GIUSTIFIC s
Giustificazione o esemplificazione? o le due funzioni assieme? e che cosa esattamente viene esemplifica-to? E in che senso viene esemplificato? A ben guardare, quel che viene esemplificato è la subordinata ge-rundiva («nominando per la prima volta luoghi e personaggi ecc.», e non la frase in cui essa funziona da avverbiale («a introdurre il lettore nell’universo romanzesco ecc.»). L’esemplificazione si effettua cioè te-nendo fissa la struttura sintattica (con gli effetti che vedremo) e mutando la predicazione iniziale (Predic0) in una predicazione più specifica (Predic1) della quale la locuzione avverbiale ad esempio, collocata in posi-zione iniziale, segnala il rapporto alla predicazione iniziale. Schematicamente, la struttura sintattico-semantica
è Sogg che Predic0
4 Una (frase) ‘scissa’ è una struttura del tipo È Patrizia che si è fatta carico / a farsi carico della presentazione di Mar-gherita – struttura distinta dalla identificazione ‘x è y’ identificabile ad es. in (Questa) è Margherita(,) che era uscita a
fare tre passi – in cui un costituente è separato (= ‘scisso’ – donde il nome) dalla struttura originaria della frase per ve-nire presentato come comunicativamente in primo piano (= focalizzato).
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
5
viene così duplicata nella struttura
è Sogg che ad esempio Predic1
Ora, il fatto che questa nuova proposizione sia un esempio della prima comporta naturalmente che l’esempio non è isolato, ma che esso è estratto come rappresentante da tutta una classe di esempi. Si tratta di una sorta di ‘effetto paradigmatizzante’ della esemplificazione, sul quale torneremo più avanti. È pro-prio l’esistenza d’una intera classe di esempi a costituire una prova della asserzione iniziale, ed a permettere quindi la presenza, forse leggermente ridondante, del connettivo di giustificazione infatti. Al tutto, già ab-bastanza complicato, si somma il fatto che l’esemplificazione è calata in una struttura, come si è detto, di scissa, che ricalca quella della scissa iniziale. Di maniera che l’esemplificazione si applica in certo senso an-che alla opposizione veicolata dalla scissione: «è Margherita che Predic1 e non altri» è cioè anche un esem-
pio di «è Margherita che Predic0 e non altri».
2. L’esemplificazione come procedimento testuale All’inizio di § 1.1. si era parlato intuitivamente della esemplificazione come di “un momento impor-tante della elaborazione di un testo”. Si vuole ora esaminare che valore vada esattamente attribuito al ter-mine di ‘elaborazione testuale’.
2.1. Procedimenti di organizzazione/costituzione testuale Nel 1982, in un capitolo di uno studio pionieristico sulla produzione dei testi – Grundlagen einer Theorie des Formulierens. Textherstellung in geschriebener und gesprochener Sprache5 – G. Antos aveva isola-to, sulla scorta dei redeorganisierenden Sprechakte di Wunderlich6, una categoria di azioni linguistiche a cui aveva dato il nome di ‘azioni di organizzazione testuale’ (= textorganisierende Handlungen). Si tratta della categoria delle «Handlungen (und Prozeduren [cioè successioni di azioni fissate in routine]), die bei der Herstellung von Texten als Darstellung propositionaler und illokutiver Komplexe ausgeführt werden können / müssen» (p. 63). Queste azioni di organizzazione testuale vengono suddivise da Antos, con l’aiuto delle espressioni usate per designarle (verbi e in generale locuzioni di ‘organizzazione testuale’7), in sei classi distinte a seconda degli aspetti della produzione testuale che sono in gioco, e cioè:
(I) pianificazione ed elaborazione (cfr. verbi come pianificare, schizzare, sviluppare, ecc. ); (II) menzione, evocazione, trattazione ecc. di singoli blocchi proposizionali o illocutivi (cfr.
trattare, tematizzare, ecc.); (III) loro decorso e seriazione (cfr. anticipare, interrompersi, concludere, ecc.); (IV) loro importanza relativa (cfr. sottolineare, attenuare, ecc.); (V) loro differenziazione e collegamento (cfr. differenziare, suddividere, specificare, ecc.); (VI) comprensione del testo (cfr. spiegare, chiarire, riassumere, ecc.).
Ne risulta una tipologia funzionale a sei classi, classi che, si noterà, non sono necessariamente disgiunte (un singolo procedimento può cioè essere utilizzato in funzioni diverse): 5 Tubinga, Niemeyer, 1982, § 2.4. «Textorganisierende Ausdrücke», pp. 57-65. 6 Cfr. D. Wunderlich, Studien zur Sprechakttheorie, Frankfurt a/M., Suhrkamp, 1976, VII.4, pp. 330-51. I redeorga-nisierende Sprechakte (= ‘atti (o azioni) di organizzazione del discorso’) sono «solche Sprechakte [...], die ein Sprecher zur Organisierung seines eigenen Redebeitrags verwendet» (p. 332). 7 Cfr. ancora Antos, op. cit., p. 58 «textorganisierende Ausdrücke».
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
6
(I') azioni di rappresentazione o produzione testuale: quelle designate da verbi come pianifi-care, schizzare, sviluppare, elaborare, esprimere, formulare, ecc.
(II') azioni di trattazione [= Darstellung] testuale: rappresentare, trattare, occuparsi di, men-zionare, discutere qualcosa, tematizzare, problematizzare, ecc.
(III') azioni di decorso testuale, come anticipare, premettere, introdurre, interrompersi, fermar-si su, tornare indietro, proseguire, iniziare, concludere, ecc.
(IV') azioni di preferenza testuale: sottolineare, accentuare, attenuare, trascurare, lasciare in so-speso (una questione), ecc.
(V') azioni di organizzazione proposizionale del testo: differenziare, suddividere, specificare, precisare, generalizzare, semplificare, complicare, completare, limitare, suddividere, sot-tintendere, dedurre, trarre conseguenze, ecc.
(VI') azioni che assicurano la comprensione: spiegare, chiarire, illustrare, esemplificare, mostra-re collegamenti, cercare di precisare, cercare di giustificare, riassumere, parafrasare, ricapi-tolare, ecc.
L’esemplificazione, denotata dal verbo di ‘organizzazione testuale’ esemplificare, compare dunque in questa tipologia delle azioni di organizzazione testuale entro la classe delle azioni – o ’procedimenti‘, come anche diremo – destinate ad assicurare la comprensione del testo. Ritroviamo qui, nella sostanza, la caratte-rizzazione intuitiva proposta in apertura di esemplificazione come ’retta da un intento di chiarezza‘, desti-nata a ’chiarire’, a far capire meglio il valore dell’enunciato o della sezione di testo a cui si riferisce. La trat-tazione di Antos, in effetti, ha essenzialmente il merito di inserire l’esemplificazione entro un quadro gene-rale. Per un ulteriore approfondimento converrà rivolgersi ad uno studio più recente di E. Gülich e Th. Ko-tschi8, che dedica la sezione iniziale al posto della esemplificazione tra le azioni di organizzazione testuale e in generale alla natura e classificazione di simili azioni. Seguiamo lo sviluppo del ragionamento nella se-zione iniziale. Gli autori innanzitutto riprendono, etichettandola di ‘composizione testuale’ (= Textkonsti-tution), la nozione di ‘organizzazione testuale’ di Antos, che determinano in modo che si direbbe a prima vista diverso; la diversità, tuttavia, credo risieda unicamente nella maggiore generalità delle classi indivi-duate rispetto alle (I)-(VI) di Antos. Per essi, ad ogni modo, la ‘composizione testuale’ ricopre o compren-de tre àmbiti di attività: (i) la conformazione (= Beschaffenheit) di un testo o di sue parti, con gli effetti comunicativi (chiarezza, efficacia, ecc.) che ne conseguono; (ii) il processo genetico che conduce alla strut-tura linguistica del testo; (iii) l’intenzionalità che regge il processo genetico e la struttura linguistica che ne risulta. Gli autori confrontano poi la ‘composizione testuale’ così intesa alla categorizzazione generale delle azioni linguistiche (= sprachliche Handlungen9) proposta in un influente studio di W. Motsch e R. Pasch10,
8 «Reformulierungshandlungen als Mittel der Textkonstitution. Untersuchungen zu französischen Texten aus mündlicher Kommunikation», in W. Motsch (a cura di), Satz, Text, sprachliche Handlung [= studia grammatica XXV], Berlino, Akademie-Verlag, 1987, pp. 206 sgg., e in partic. 214. 9 Definite con una quaterna di componenti: <enunciazione, intenzione di conseguire uno scopo, condizioni per il conseguimento dello scopo, conseguenze del raggiungimento dello scopo>. 10 W. Motsch e R. Pasch, «Illokutive Handlungen», in W. Motsch (a cura di), Satz, Text, sprachliche Handlung cit., pp. 11-79.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
7
dove si distingue (pp. 18-19) tra:
(a) azioni illocutive (promettere, chiedere, ecc.); (b) atti perlocutivi (divertire, spaventare, ecc.); (c) azioni – come raccontare, argomentare, descrivere, rappresentare, ecc., – che determinano
l’organizzazione propria a particolari tipi testuali, la loro ’costituzione’11; (d) azioni dialogiche (rispondere, contraddire, ecc.);
e infine: (e) «azioni che concernono aspetti particolari della organizzazione [= Gestaltung] testuale».
Gli esempi che Motsch e Pasch danno per (e) includono azioni quali completare, parafrasare, riassumere, ripetere, sottolineare e in particolare giustificare e spiegare, ed è del tutto naturale pensarvi inclusa, alla stessa stregua del parafrasare ed accanto ad una azione a funzione analoga come spiegare, anche la nostra esempli-ficazione. Motsch e Pasch procedono quindi valutando le azioni linguistiche raccolte in (e) alla luce della concezione gerarchia degli obiettivi illocutivi12 da loro proposta nello stesso articolo (pp. 25-28), alla luce in particolare della distinzione tra obiettivo ‘di esecuzione’ (o obiettivo fondamentale obf), obiettivo ’di ac-cettazione’ (obf-1) e obiettivo ‘di comprensione’ o ‘diretto’ (obf-2): per ‘far fare’ qualcosa all’interlocutore (obf), il locutore deve prima mirare a fargli capire quel che desidera (conseguendo cioè l’obiettivo elemen-tare, ’diretto’, obf-2), e quindi (obf-1) a fargli accogliere la propria volontà. Le azioni di (e) sono allora carat-terizzate come quelle che «in linea di principio» stabiliscono «tra azioni illocutive relazioni intese ad assicu-rare la comprensione e l’accettazione degli obiettivi fondamentali del locutore. Le giustificazioni si riferi-scono all’accettazione, il riassumere alla comprensione» (ibid.). Dunque, le azioni di (e) – relazionali, che cioè introducendo una sezione B di testo la legano ad una precedente sezione A (A e B essendo per gli au-tori il risultato di due azioni illocutive) – vengono concepite come subalterne all’azione che pone in essere la sezione A: esse agevolano il conseguimento del suo obiettivo fondamentale assicurando / aiutando quel-lo dei due obiettivi immediatamente anteriori: dell’obiettivo intermedio, l’accettazione, e dell’obiettivo di-retto, la comprensione. In altri termini, le azioni di (e) selezionano come obiettivo fondamentale (si ricordi tuttavia l’attenuazione «in linea di principio») un obiettivo preliminare dell’obiettivo fondamentale di un’altra azione. Ora, accolta questa caratterizzazione funzionale delle azioni di (e), Gülich e Kotschi rilevano (p. 211) che essa comporta in modo naturale una suddivisione delle azioni di Gestaltung testuale in due sottoclassi: quella (e-I) delle
(e-I) azioni che intervengono o possono intervenire sulla comprensione (parafrasare, completa-re, ecc.);
e quella (e-II) delle (e-II) azioni che possono intervenire sulla accettazione (giustificare, spiegare, ecc.).
Sulla scorta ad un tempo del valore intuitivo di ‘costituzione’ e della sua corrispondente delimitazione in termini di ‘conformazione’, ‘processo genetico’ e ‘intenzionalità’ (cfr. sopra), Gülich e Kotschi giungo-no allora ad identificare le loro ‘azioni di costituzione testuale’ con la prima sottoclasse (= e-I) di Motsch e Pasch. Le azioni della seconda classe (= e-II) vengono escluse dall’ambito della costituzione testuale perché 11 Si noterà che Motsch e Pasch riservano appunto a queste azioni il nome di ‘azioni di composizione testuale’. 12 Gli obiettivi perseguiti dall’intenzione del locutore entro una azione linguistica.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
8
probabilmente più ‘argomentative’ che ‘costitutive’. Sia come sia (e certo questo modo di tracciare i confi-ni è in parte arbitrario), le azioni di costituzione testuale così delimitate hanno come obiettivo la compren-sione degli scopi fondamentali del locutore. Si tratta essenzialmente, come suggeriscono le molte attenuazioni (cfr. Gülich e Kotschi, p. 211: non tutte le azioni di costituzione testuale avrebbero questa funzione; e vi sarebbero azioni di costituzione non impiegate essenzialmente a questo scopo), di una caratterizzazione es-senzialmente prototipica, cioè valida per azioni più ‘centrali’. All’interno delle azioni di costituzione te-stuale, infine, Gülich e Kotschi propongono tentativamente di individuare tre sottoclassi, vale a dire le se-guenti:
i) la sottoclasse delle azioni come differenziare, specificare, generalizzare, precisare, comple-tare, esemplificare, chiarire, parafrasare, ricapitolare, relativizzare;
ii) quella di azioni come valutare, interpretare, commentare; iii) quella di azioni come designare, etichettare, classificare, identificare.
In questa finale proposta classificatoria, che tuttavia più che altro possiede carattere illustrativo, l’esemplificazione figura dunque accanto ad azioni che ‘elaborano’, ‘sviluppano’ in vari modi una sezione di testo (specificare, completare, ecc.), e si oppone alle azioni che veicolano un giudizio sul testo o su una sua sezione o che ne chiariscono il senso (la seconda classe), così come alle azioni di riconoscimento e clas-sificazione (la terza classe). Noi assumeremo nelle grandi linee la caratterizzazione di Motsch e Pasch (che inserisce quella analoga di Antos in un quadro teorico elaborato, arricchendola in particolare della nozione di obiettivi illocutivi), generalizzando però, per le ragioni che vedremo, la concezione della funzione dell’esemplificazione: dire-mo che questa non si limita alla comprensione dell’obiettivo fondamentale dell’esemplificato ma va for-mulata più in generale come ’favorire in vario modo il suo raggiungimento‘. Sull’argomento, comunque, si ritornerà nel seguito.
2.2. Delimitazioni concettuali e terminologiche: azione di esemplificazione, esemplificazione, esempio, relazione di esemplificazione, connettivo di esemplificazione Sulla scorta di quanto si è detto nei paragrafi precedenti, e senza entrare ulteriormente nel merito di come si possano definire le azioni di composizione testuale, è ragionevole assumere per l’esemplificazione le delimitazioni concettuali e terminologiche seguenti:
(I) azione di esemplificazione. L’esemplificazione è un procedimento (= azione) di composizione testuale determinato, come ogni azione linguistica comunicativa, da una ‘inscrizione’ materiale, cioè, per noi, lin-guistica, e da una intenzione del produttore (che, al solito, è sottoposta a condizioni ed è portatrice, se rea-lizzata, di conseguenze). La ‘inscrizione’ è la sezione esemplificante stessa che risulta dall’azione – (sezione eventualmente compattata ellitticamente in una parte di periodo, come vedremo), provvista di particolari rapporti con una precedente sezione (= l’‘esemplificato’); l’intenzione consiste nella volontà di conseguire uno scopo che è, come si è stipulato, il favorire il conseguimento dell’obbiettivo fondamentale della (ma-cro) azione che ha prodotto la sezione esemplificata;
(II) esemplificazione, esempio. L’esemplificare produce in quanto azione linguistica uno o più enunciati – per lo scritto: uno o più periodi – a cui daremo complessivamente il nome di esemplificazione (il nomen actionis designa in effetti normalmente anche il risultato della azione). L’esemplificazione potrà essere semplice o complessa, cioè, come converremo costituita, da uno o più esempi. Nel caso di esemplificazio-
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
9
ne semplice i termini esemplificazione ed esempio sono intercambiabili;
(III) relazione di esemplificazione. Tra l’esemplificazione e la porzione di testo a cui la esemplificazione si riferisce (= cioè, come lo si è chiamato, l’‘esemplificato‘) si instaura una relazione di esemplificazione, che ha grosso modo il contenuto seguente: l’esemplificazione è una specializzazione, un caso particolare tra al-tri dell’esemplificato, destinato a favorire il conseguimento del suo obiettivo fondamentale. Tale relazione è, in conseguenza della caratterizzazione che si è data per l’azione dell’esemplificare, una relazione ‘di com-posizione’ nel senso di Daneš13, una relazione cioè che, a differenza delle ‘relazioni interproposizionali’, che rappresentano le relazioni sussistenti tra stati di cose del mondo, lega tra loro porzioni di testo.
(IV) connettivo. L’esemplificazione in quanto azione deve essere segnalata in qualche modo (altrimenti essa potrebbe essere confusa con azioni linguistiche apparentate che ad es. ‘specificano’, cioè mettono in opera la stessa relazione caso generale-caso particolare che è una componente, ma solo accanto ad altre, della relazione di esemplificazione14). Il segnale di esemplificazione molto spesso è l’ avverbio frasale ad esempio (o per esempio). A volte, specie quando l’esemplificazione ha dimensioni importanti, in luogo di un connettivo viene utilizzata a dichiarare il tipo di movimento testuale una intera proposizione, in cui com-pare come predicato o argomento uno dei termini esempio, esemplificazione, esemplificare15.
3. Aspetti linguistici della esemplificazione. Riprenderemo ora per approfondire il discorso alcuni degli aspetti della esemplificazione riconosciuti nei paragrafi precedenti, e in particolare la semantica dei segnali di esemplificazione e i modi della funzio-nalizzazione dell’esempio all’esemplificato. Inizieremo con l’analisi semantica del segnale prototipico di esemplificazione, la locuzione ad esempio. Una simile analisi in effetti rende linguisticamente accessibile e controllabile la relazione che sussiste tra esempio ed esemplificato, e fornisce una base linguistica ad un re-perimento di varietà di rapporti concettuali che rischierebbe altrimenti di divenire un esercizio di tasso-nomia cognitiva.
3.1. La semantica di «ad esempio»
3.1.1. Premessa: «ad esempio» («per esempio») nei dizionari
13 «Welche Ebenen der Textstruktur soll man annehmen?», in F. Daneš e D. Viehweger (a cura di), Ebenen der Text-struktur = Linguistische Studien des ZISW der AdW der DDR, Reihe A, H. 112, Berlino, 1983, p. 2. 14 Si noti che è perfettamente lecito riconoscere – ad es. post factum – come relazione di esemplificazione una partico-lare relazione esistente tra due segmenti di testo di cui uno è la generalizzazione dell’altro. Solo che in quel caso il let-tore, o chi scrive, dà in realtà un giudizio metalinguistico sul testo, reinterpreta (il risultato di) una precedente azione, e non esegue una azione di esemplificazione. Così chi scrive può asserire – grazie ad una espressione come «questo era un esempio di...» – che un caso particolare anteposto funziona da esempio illustrativo di una seguente generalizza-zione, senza tuttavia individuare una ‘azione di composizione testuale di esemplificazione’. 15 È così in (a) qui sotto, in cui compare un annuncio del tipo di azione testuale che si sta per fare: «[Diamo] ancora due esempi ecc.», combinato con una esplicitazione («riconducono ecc.») della sua funzione argomentativa:
(a) Ancora due esempi, attinti al Carpaccio, riconducono il cerchio delle reciproche relazioni a questa fase di trapasso tra le due sfere, spirituale e mondana, e al mutevole giuoco degli scambi tra il simbo-lico e l’immaginario. Partiamo dalla nota tavola di Strasburgo [...]. / L’altro esempio a cui intendia-mo riferirci, il Ritratto di cavaliere della collezione von Thyssen, è, se possibile, di tempra ancora più alta. La porta ecc. [L. Zorzi, Carpaccio e la rappresentazione di sant’Orsola, Torino, Einaudi, 1988, pp. 86-87].
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
10
È ragionevole pensare, per affrontare la semantica dei segnali di esemplificazione16, di rivolgersi preli-minarmente alle informazioni che i dizionari forniscono sul connettivo-prototipo: la locuzione ad esempio (o la sua equivalente di registro leggermente più basso per esempio), anche se prevedibilmente il frutto che se ne può trarre è piuttosto ridotto. Le due trattazioni più estese credo siano quelle del GDLI (= il ‘Batta-glia’) e del VLI (= il Vocabolario della Fondazione Treccani). Nel GDLI ad esempio e per esempio sono sorprendentemente (ma non troppo per chi abbia familiarità col Battaglia) trattati in due voci separate con informazioni in parte diverse: (i) ad esempio, si apprende, è usato nell’italiano contemporaneo «per recare una prova, una conferma, un paragone»; (ii) per esempio, dal canto suo, è usato «per fare un paragone, per addurre una prova, per dare una dimostrazione, per impartire un insegnamento, un monito (e per lo più si pone come intercalare quando ci disponiamo a citare un fatto che renda più chiaro e convincente il discorso)» (inoltre, le varianti a mo’ /modo d'esempio, per at-to/cagione/modo/ragione/via /grazia d'esempio servono «per chiarire, per spiegare mediante un paragone; per confermare con una dimostrazione pratica». Nel VLI, dove ‘esempio’ è un «Fatto particolare che serve ad illustrare un’affermazione generica, a dare evidenza a un principio teorico»17), ad esempio è una «formula con cui si introduce un esempio a conforto
16 Degna di nota è anche la sistematica del campo semantico di ‘esempio’ che viene tentata nell’inserto ragionato del Dizionario Garzanti dei sinonimi e dei contrari, Milano, 1991, p. 452: «MODELLO è il termine più generale per indi-care una qualsiasi cosa, concreta o astratta, cioè oggetto, schema teorico, procedimento operativo ecc., che venga proposta per essere copiata, riprodotta, imitata, o anche una persona a cui si attribuisca un valore esemplare e che si considera pertanto degna di imitazione (il modello di una nuova utilitaria; Il Partenone è un modello dell’architettura classica, una sfilata di modelli di abbigliamento, un modello di comportamento, un modello matematico; un ragazzo che a scuola è un modello, far da modello per un pittore); il carattere generico della parola ‘modello’ è dimostrato anche dal fatto che il modello non è soltanto ciò che viene proposto all’imitazione o a cui ci si debba conformare, ma anche il prodotto materiale che deriva dall’applicazione di un modello (in vetrina sono esposti i nuovi modelli). [...] Il TIPO è il modello specifico a cui si può ricondurre un gruppo di cose o di individui sulla base di caratteristiche comuni (un tipo di giacca; il tipo fisico mediterraneo); non si tratta dunque né di un modello assolutamente generale come l’archetipo né di un modello che ne genera altri come il prototipo, ma solo di un modello fra gli altri. Per spiegare il significato dei termini restanti bisogna ritornare ai significati di ‘modello’. Il PARADIGMA è un modello teorico, uno schema concettuale (il paradigma della coniugazione del verbo; paradigmi morali). L’ESEMPIO, nel significato che inte-ressa più da vicino le parole di questo gruppo, è qualunque cosa o persona che possa essere presa come modello posi-tivo o negativo, e serva di guida, di ammaestramento (sua madre è un esempio di bontà; non seguite i cattivi esempi!); ma ‘esempio’ può anche essere una qualsiasi persona, animale o cosa che ben rappresenti tutti gli altri della stessa spe-cie, e in questo caso il suo significato si avvicina a quello di ‘tipo’ (il falco è un esempio di uccello rapace). Se l’esempio riguarda una piccola quantità di prodotto prelevata da un insieme, per saggiarne o dimostrarne la qualità, abbiamo un CAMPIONE». 17 Varrà la pena di segnalare che ‘esempio’, inoltre, veniva inteso tradizionalmente come ‘particolare tecnica argomen-tativa’. Una estrema traccia di questa concezione è reperibile nella voce relativa della Enciclopedia Treccani, che di-stingue d’esempio una accezione morale (esempio come «realizzazione concreta del principio etico in una persona o in un atto».) e una retorica, secondo cui l’esempio è una «specie d’argomentazione, che si ha quando medio extremum inesse monstratum sit». L’esempio «è, quindi, un’argomentazione, simile all’induzione, ma, come non va dal tutto alla parte, così non va dalla parte al tutto, bensì dalla parte alla parte». Si rinvia quindi alla Retorica aristotelica, la dove si «distingue tra due specie di esempî: storici e inventati, e questi in parabole e favole, concludendo che si deve fare uso degli esempî come di dimostrazioni, quando non si possiedano argomenti più forti, come l’entimema; ma quando ci siano questi, si deve ricorrere agli esempî come ad epiloghi in luogo delle testimonianze». Sempre sotto l’etichetta di ‘retorica’ si accenna quindi all’accezione medievale di esempio-exemplum come «racconto a scopo didattico-religioso».
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
11
d’una regola, o per chiarire o restringere un’affermazione generica [...]. Anche con funzione attenuativa, nel fare una proposta: per passare queste due ore, si potrebbe andare al cinema, per esempio. È inoltre modo interrogativo per invitare altri a rendere più esplicito il discorso, a citare casi concreti: Affermi di sapere molte cose sul suo conto. Per esempio?». Il dato più inatteso è forse, nel GDLI, il ripetuto richiamo alla comparazione (‘paragonÈ), che apre l’inedito capitolo della ‘esemplificazione analogica’, che deve render conto di equivalenze del genere di «Portale qualcosa di casalingo, ad esempio una crostata», «Portale qualcosa di casalingo, come una crosta-ta», e un cui capitolo aneddotico registrerà confusioni di esempio e paragone come (in un manualetto geo-grafico) «Einige Gipfel, wie der Ulu Dağ, erheben sich zu einer Höhe von 1543 m». In realtà si può dimo-strare (ma qui non lo faremo) che la esemplificazione espressa da ad esempio, per quanto apparentata alla comparazione, si comporta in modo diverso, tanto da poter comparire combinata alla comparazione, come ad esempio in questo stesso periodo. Quel che si ricava dai dizionari, in definitiva, è unicamente una ulteriore (e certo preziosa) conferma della polivalenza funzionale di ad esempio – di volta in volta prova, dimostrazione, chiarimento, illustra-zione, attenuazione di proposta, e così via – Di tale polivalenza, che è essenzialmente quella della esempli-ficazione (si ricordi la citazione dal de copia18 erasmiano posta in epigrafe), occorrerà tenere conto nella no-stra analisi.
3.1.2. La semantica di «ad esempio»
Per andare oltre le indicazioni generiche dei lessici, chiediamoci in generale quale sia l’apporto della locu-zione ad esempio alla semantica della frase o della porzione di testo in cui essa occorre, e quali siano le sue condizioni di impiego, vale a dire quali caratteristiche semantiche debba avere una porzione di testo per potervi inserire ad esempio. Cominciamo a distinguere tra un impiego frasale ed extra-frasale di ad esempio. Ad esempio, in effetti, può segnalare una azione e relazione di esemplificazione tra sezioni di un testo – nel caso più semplice tra due enunciati successivi – oppure tra costituenti omologhi di una frase. Casi tipici di esemplificazione tra enunciati successivi sono (2) e (3):
(2) Lei è una persona difficile. Ad esempio, ieri si è messa in testa di... (3) Sai, occuparsi della bambina per una settimana non è mica facile. Ad esempio, che cos’è
che le faccio da mangiare?
In (2) una asserzione è esemplificata da un’altra asserzione; in (3), invece, da una domanda, da una do-manda tuttavia da cui è inducibile una incertezza deliberativa direttamente pertinente per lo stato di cose descritto dalla asserzione da esemplificare: cioè una manifestazione particolare della ‘difficoltà di occuparsi di’. In entrambi i casi un enunciato frasale illocutivamente assertivo viene esemplificato da un altro enun-ciato frasale, che è, almeno ad un livello abbastanza alto di elaborazione (è il caso di (3)), dello stesso tipo illocutivo. Ma ad esempio può segnalare, come accade molto spesso, una esemplificazione interna alla frase. Sintat-ticamente, allora, l’esemplificazione si manifesta come ripresa appositiva, a contatto o meno, di un altro costituente (di vario genere); cfr. (4)-(6): 18 Erasmo da Rotterdam, De duplici copia verborum ac rerum commentarii duo, Basilea, Froben e Episcopius, 1534 (15121) – ma cito dal tomo I degli Opera omnia, Leiden, Vander, 1703, p. 90.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
12
(4) Alcune persone – certi nostri amici ad esempio – ci riescono benissimo (5) Vacci con un’amica, con Maria ad esempio (6) Venite da noi una sera se avete tempo, domani o dopodomani ad esempio.
Questo secondo tipo di esemplificazione va in realtà visto come un caso particolare del primo: enuncia-ti come (4)-(6), in effetti, sono semanticamente la riduzione di coppie di enunciati il secondo dei quali, l’esemplificativo, differisce dal primo solo per un costituente (cfr. «Vacci con un’amica, vacci con Maria ad esempio»). I confini sono ancora più difficili da tracciare quando il costituente ripreso è un intero SV, co-me in (7):
(7) Lei dovrebbe proprio fare un po’ di sport, andare un’ora al giorno in bicicletta, ad esem-pio.
In generale è vero che la relazione di esemplificazione (segnalata da ad esempio) non sussiste tra entità, non è cioè una relazione elemento-insieme; essa è piuttosto una relazione tra stati di cose – proposizioni – o più esattamente ancora tra enunciazioni, vale a dire tra azioni linguistiche. Nell’impiego frasale di ad esempio vanno ancora riconosciute due varianti: quella con esemplificato esplicitamente realizzato nella frase (cfr. «Portale qualcosa, ad esempio un disco») e quella con esemplifica-to ‘assente’, ricostruibile a partire dall’esempio (cfr. «Portale ad esempio un disco»). Parleremo rispettiva-mente di esemplificazione in praesentia o in absentia (del costituente esemplificato). La presenza/assenza dell’esemplificato è naturalmente funzione del suo statuto comunicativo. L’esemplificato è di regola assen-te quando esso è direttamente o indirettamente tematizzato (grazie ad es. ad una precedente interrogativa di costituente – cfr. (8) sotto). Viceversa, esso tenderà ad essere presente quando non è tematizzato (la sua ellissi produrrebbe allora un gap informativo). Le due situazioni comunicative tipiche sono presentate, ri-spettivamente, in (8) e (9) qui sotto, mentre (10) illustra una situazione che permette di trattare a piacere l’esemplificato come tematizzato o non tematizzato:
(8) Che cosa potremmo bere? – *Potremmo bere qualcosa, ad esempio una birra / Potremmo bere ad esempio una birra / *Qualcosa, ad esempio una birra / Ad esempio una birra
(9) Ti ricordi che siamo da Brigitte domani sera?! – *Sì sì; credo che dovremmo portare ad esempio un libro / Sì sì; credo che dovremmo portare qualcosa, ad esempio un libro.
(10) Che caldo che fa! – Eh sì! Mah, forse potremmo bere una birra, ad esempio / Mah, forse potremmo bere qualcosa, una birra ad esempio.
Limitandoci ora per semplicità al solo impiego frasale e ad esemplificazioni di sintagma nominale, cer-chiamo di schematizzare in ‘punti’ successivi le condizioni di impiego e il contributo semantico di ad esempio. Ad esempio comparirà allora, se si fa astrazione dal caso marginale di inserzione parentetica entro il sintagma nominale esempio, in una delle configurazioni sintattiche seguenti:
( [SNex.to
] ) (...) ad esempio (...) [SNex
]
( [SNex.to
] ) (...) [SNex
] (...) ad esempio
col SN esemplificato (= SNex.to) sempre a sinistra e assente nelle particolari condizioni contestuali che si so-no dette (le parentesi tonde ne segnalano appunto la facoltatività), e con l’avverbio ad esempio inserito in uno dei luoghi indicati, cioè a destra o a sinistra del SN esempio (= SNex) e nei due casi a contatto o meno
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
13
di esso (cfr. ancora le parentesi tonde). Innanzitutto, ed è la condizione più evidente, occorre che l’esempio sia in qualche modo una specializ-zazione dell’esemplificato, ad es. un suo caso particolare. Mentre posso scambiare tra di loro apposizione e apposto in «Portale un fiore, una rosa» (la generalizzazione di «Portale una rosa, un fiore» avendo come effetto di attenuare il consiglio), il passaggio da «Portale un fiore, una rosa, ad esempio» a «Portale una ro-sa, un fiore, ad esempio» produce una chiara inaccettabilità (a meno di intendere globalmente «una rosa, un fiore» come una esemplificazione in absentia – «Portale qualcosa» – attenuata come prima al suo inter-no dalla generalizzazione). Dunque:
(I) per poter inserire in una frase ad esempio occorre che tra SNex e SNex.to intercorra un rap-porto semantico di specificazione: di elemento a insieme, di caso particolare a caso gene-rale, di designazione specifica a designazione generica (nel senso non tecnico dei due ter-mini).
Perché ad esempio sia inseribile davanti ad una apposizione, questa deve dunque intrattenere col suo ante-cedente una relazione di ‘caso particolare a caso generale’. Va da sé che (I), condizione necessaria, non è
una condizione sufficiente, come mostra facilmente l’inaccettabilità di enunciati quali *«Le ho portato un dolce, ad esempio una crostata». Si noterà che è proprio la presenza del connettivo ad esempio a pregiudi-care l’accettabilità, perché «Le ho portato un dolce, una crostata» è del tutto normale.
La seconda condizione per l’inseribilità di ad esempio può essere formulata, semplificando, in termini dello statuto referenziale dell’esemplificato. La configurazione usuale in cui compare l’esemplificazione (nominale) interna alla frase è in effetti quella di un esemplificato non specifico19 ripreso da un esempio anch’esso non specifico, come ad es. nell’enunciato «Portale un giornale: il Corriere, ad esempio», in cui «un giornale» non designa una particolare testata o copia (né «il Corriere» una particolare copia). Se l’esemplificato è specifico e se non intervengono altre condizioni aggiuntive (tra cui in particolare la plura-lità del referente), l’esemplificazione non è ammessa, come mostra l’inaccettabilità di *«Le ha portato un giornale: il Corriere, ad esempio» (in cui esempio e esemplificato, argomenti di uno stato di cose realizzato-si, sono entrambi specifici, e al singolare. Questa situazione dai confini (apparentemente) netti si manifesta nella opposta accettabilità di (11) e (12) (il secondo dei quali è accettabile, al più, solo intendendo «qual-cuno» con valore plurale):
(11) Ma cerca qualcuno che ti dia una mano: ad esempio una ragazza che venga un paio di ore al giorno
(12) *Ha trovato qualcuno che le dà una mano: ad esempio una ragazza che venga un paio di ore al giorno.
A complicare la situazione interviene il fatto, a cui si è già alluso, che enunciati come (13):
(13) Falle ascoltare i dischi che abbiamo comperato: lo Haydn di Andreas Staier ad esempio,
o peggio ancora (14) (perché in (13), malgrado che l’esemplificato sia specifico, l’esempio perlomeno aiuta l’interlocutore ad estrarne una entità particolarmente interessante):
(14) (Passa a dare una occhiata) Gli [= al proprietario della libreria antiquaria] sono arrivate un
19 La ‘specificità’ (o ‘referenzialità’) è notoriamente la capacità di un sintagma di designare una determinata entità extralinguistica.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
14
sacco di cose interessanti la settimana scorsa, ad esempio belle edizioni di classici latini
sembrano normalmente accettabili, anche se l’esemplificato è specifico, mentre non lo sono, o lo sono po-co, enunciati come (15):
(15) Oggi si è preso ancora altri libri, ad esempio un Dictionnaire du jardinage in cinque vo-lumi,
nei quali la reazione più spontanea è di sostituire ad esempio con tra l’altro. In realtà, a ben guardare, la condizione di non specificità è solo una manifestazione di superficie di una restrizione più generale che di-scende dalla necessaria funzionalizzazione della esemplificazione. Una sua discussione esauriente ci porte-rebbe però troppo lontano e ci accontenteremo qui di una formulazione ‘superficiale’ quale la seguente:
(II) per poter inserire in una frase ad esempio occorre che il SNex.to sia non specifico, o che al-trimenti – e allora con minore naturalezza funzionale, e corrispondentemente maggiori esigenze sul contesto – esso designi una pluralità.
La terza condizione su ad esempio può essere formulata in termini di ‘equipollenza comunicativa’: l’esemplificazione deve essere compatibile con ciò che nell’esemplificato è in primo piano comunicativo. Un enunciato come (16):
(16) *Voi portate DUE dolci, ad esempio una crostata»;
in cui il numerale è focalizzato intonativamente20 non è ben costruito semanticamente, vale a dire comuni-cativamente. Ad esempio, in effetti, è un avverbiale focalizzante, un avverbiale cioè che individua il sintag-ma a cui si riferisce come fuoco dell’enunciato: come fuoco della variante dell’enunciato di partenza otte-nuta sostituendo all’esemplificato l’esempio, ma anche come fuoco dell’enunciato complessivo. Di più, l’esemplificazione richiede che l’esemplificato non sia incompatibile con l’effetto retroattivo di preminenza comunicativa indotta dalla esemplificazione. In (16) appena sopra vi è discrepanza tra la focalizzazione sul sostantivo (è il tipo infatti che viene esemplificato) che viene indotta dall’esempio, e la focalizzazione pro-pria dell’esemplificato, che è sul numerale. Analogo è il discorso in (17) e in (18) qui sotto:
(17) *VOI portate dei dolci, ad esempio una crostata (18) ??Voi portate due dolci, ad esempio una crostata;
in (17) viene focalizzato tutt’altro componente dell’esemplificato (e anche il tentativo di salvare l’accettabilità dell’enunciato intendendolo come ripresa-eco – con diversa focalizzazione – di un preceden-te enunciato si scontra con la presenza ingombrante dell’esemplificazione); la scarsa naturalezza di (18), infine, discende dal fatto che nell’esemplificato il numerale, anche se non enfatizzato intonativamente, tende a diventare l’elemento comunicativamente prominente, in disaccordo dunque con la focalizzazione indotta dall’esempio. In definitiva, dunque:
(III) esemplificato ed esempio devono essere equipollenti per ciò che riguarda il rilievo comu-nicativo.
Ora, inserito in contesti che soddisfino le condizioni (I)-(III), ad esempio ha conseguenze di due generi. In primo luogo esso crea o comunque evoca un insieme di alternative, un ’paradigma‘, come diremo.
20 È questo il senso del maiuscoletto nell’esempio.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
15
L’effetto ’paradigmatizzante’21 appare con grande chiarezza nella esemplificazione (singola) di entità singo-le, come in (19):
(19) Portale un regalino, ad esempio un disco,
che rispetto alla precisazione («Portale un regalino, un disco» impone l’evocazione di alternative, di altre possibilità (è per questo, d’altra parte, che l’enunciato con ad esempio viene sentito come meno direttivo, meno impositivo dell’enunciato che ne è privo). Si noti che questa nozione di ’paradigma di alternative’ non è riducibile alla usuale nozione linguistica di paradigma, per cui ad es. l’oggetto «un libro» di «Ho comperato un libro» evoca per associazione le altre entità che avrebbero potuto occorrere al suo posto. Il paradigma associativo non è sufficiente per poter inserire ad esempio (cfr. 20)), e ciò anche se del paradig-ma si impone la presenza realizzandolo esplicitamente nella frase come in (21):
(20) *Le ha fatto un regalo, ad esempio un foulard (21) *Le ha fatto un regalo, ad esempio tra tutto quello a cui poteva pensare la cosa più banale:
un foulard.
Anche qui, come nel caso della condizione (II) di non specificità il problema è più complesso di come lo si è schematizzato: grosso modo, il paradigma andrebbe inteso come paradigma di scelte in rapporto ad una funzionalizzazione. Noi ci limiteremo comunque alla formulazione semplificata (IV):
(IV) ad esempio introduce l’idea di un paradigma di alternative entro cui l’esempio è una scelta particolare.
Il secondo genere di conseguenza semantica della inserzione di ad esempio è la funzionalizzazione di SNex a SNex.to: l’esempio (nel caso almeno della esemplificazione di SN) facilita l’identificazione di una entità o in-sieme, e tramite questa, in genere, l’effettuazione di un compito particolare in cui intervenga l’entità (l’insieme). Concretamente, negli enunciati (21)-(23):
(21) Portale un giornale, ad esempio il Corriere
(22) Portale dei giornali, ad esempio il Corriere (23) Portale tre giornali, ad esempio il Corriere, la Repubblica e il Manifesto,
la funzionalizzazione si concretizza come aiuto ad eseguire un compito, e ciò rispettivamente nei tre modi seguenti:
(a) precisando l’entità su cui esso si esercita (cfr. (21)) – entità che era stata circoscritta solo in modo generale come ‘giornale’; si ha allora esemplificazione di elemento singolo.
(b) Dando una idea di che cosa potrebbe contenere l’insieme, con quali elementi esso po-trebbe essere costituito (cfr. (22)).
E infine: (c) indicando come l’insieme potrebbe essere completamente determinato (cfr. (23)); si ha al-
lora esemplificazione di insieme.
In definitiva dunque:
(V) ad esempio aiuta a specificare l’esemplificato, suggerendone realizzazioni concrete. Questo per rendere più agevole l’esecuzione di un compito, più perspicuo un suggerimento,
21 Per il termine cfr. Henning Nølke, Les adverbes paradigmatisants: Fonction et analyse, Etudes romanes de l’Université de Copenhague (= Revue Romane 23), Copenhagen, 1983.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
16
ecc.22.
Questa determinazione funzionale va vista non in opposizione a quanto si era affermato alla fine di § 2.1. ma come suo caso particolare in corrispondenza ad un particolare tipo di esemplificazione: quella (interna alla frase) di SN.
3.2. L’esemplificazione nel testo Il paragrafo precedente ci ha provvisto di indicazioni sul comportamento della esemplificazione all’interno della frase. Estenderemo ora, ma solo per accenni, in modo non sistematico, il discorso alla esemplificazione esterna alla frase – esemplificazione testuale – aiutandoci in particolare con quanto si è stabilito sulla semantica di ad esempio. Converrà preliminarmente ricordare, tuttavia, che in quanto azione di costituzione testuale, l’esemplificazione segue di regola la sezione a cui si riferisce (si avrebbe altrimenti una transizione da ‘caso particolare’ a ‘caso generale’, cioè una generalizzazione, anche se un caso particolare anteposto può essere chiamato metalinguisticamente post factum esemplificazione). Si ricorderà inoltre che l’esemplificazione deve necessariamente essere segnalata23, proposizionalmente o in modo ‘obliquo’ (= non proposizionale) con un avverbiale frasale (ad esempio) collocato all’inizio – oppure, se l’estensione del segmento esemplifi-cativo è molto ridotta, anche al suo interno o alla sua fine. Come si è accennato sopra, la presenza di un segnale è costitutiva dell’esemplificazione, che altrimenti viene sentita, quando è possibile, come incremen-to di dettaglio informativo, cioè grosso modo come ‘precisazione’24.
3.2.1. Alcune caratteristiche dell’esemplificazione testuale
22 Si noti che la funzionalizzazione dell’esempio è più facile, come del resto era prevedibile, con l’ordine che con la promessa: cfr. ?Ti porterò/ Portami dei giornali, ad es. il «Corriere». 23 Interessante, a questo riguardo, è il problema sollevato dall’esemplificazione in codici non linguistici, in cui ovvia-mente non si può ricorrere a segnali del tipo di ad esempio. Così, in una pagina di un mensile geografico-turistico, uno slogan auto-pubblicitario, organizzato schematicamente come segue:
Dovunque andiate, comunque ci andiate
*********************************
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
*********************************
*********************************
*********************************
Non dimenticate il diario di viaggio Che Atlante vi regala a maggio
include fra le tre righe di testo cinque righe di ‘illustrazione’ grafica – orme di passi, binari, strisce di pneumatici, ecc. – della quantificazione modale «comunque ci andiate» (una illustrazione che per la sua tendenziale esaustività produ-ce un effetto complessivo di parafrasi). Si tratta davvero, malgrado l’assenza di segnale di esemplificazione, di una esemplificazione? 24 ‘Quando è possibile’, perché transizioni come «I suoi amici l’hanno molto aiutata. Maria si è occupata di tutte le cose pratiche» (seguite da mutamento tematico) sono, a differenza di «.... Ad esempio Maria si è occupata ecc.», senza dubbio poco felici in quanto precisazioni. La presenza di un segnale di precisazione, anzi, influisce qui negativamente – sempre se dopo l’aggiunta si cambia argomento – sull’accettabilità: cfr. «.... *Precisamente, Maria si è occupata ecc.».
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
17
La prima approssimazione ai principi della esemplificazione testuale sarà negativa. Individueremo in effetti in primo luogo dei casi di esemplificazione impossibile.
(i) L’esemplificazione è impossibile quando tra esemplificato ed esempio sussiste una relazione di para-frasi. Si tratta evidentemente di una estensione del principio (I) sulla maggiore specificità dell’esempio. In (24) qui sotto non è possibile introdurre ad esempio, come mostra l’inaccettabilità di (25):
(24) Questa bambina è ostinata come un mulo. È una zuccona (25) *Questa bambina è ostinata come un mulo. Ad esempio è una zuccona.
Naturalmente il ritenere due proposizioni dello stesso livello di genericità e quindi in relazione di parafrasi è in certi casi lasciato alla decisione del locutore, così che la variante (26) di (25) può essere intesa come giustapposizione di una asserzione e di una specificazione dell’asserzione (una tra altre possibili), accettan-do quindi senza difficoltà (cfr. (27)) la presenza di ad esempio:
(26) Questa bambina è ostinata come un mulo. Fa sempre il contrario di quel che le si dice (27) Questa bambina è ostinata come un mulo. Ad esempio fa sempre il contrario di quel che
le si dice.
(ii) l’esemplificazione è impossibile quando la proposizione esemplificata non ricopre una pluralità di manifestazioni: ad esempio impone infatti (si ricordi il principio (IV) sopra) un paradigma di alternative. Così, l’enunciato (28)
(28) Martine è belga
può certo essere precisato dall’aggiunta «È nata in un paesino della campagna vallona». Questa aggiunta, però, non può essere presentata come esemplificazione:
(29) *Martine è belga. Ad esempio è nata in un paesino della campagna vallona25,
mentre può essere esemplificata una asserzione come (30) che ammette una pluralità di manifestazioni:
(30 L’ha trattata male. Ad esempio non si è mai interessato di quello che lei faceva26.
Analogamente esclusa è l’esemplificazione come aggiunta di (31):
(30) È tardi. Sono le sette (31) *È tardi. Ad esempio sono le sette.
(iii) l’esemplificazione è in linea di principio impossibile in una struttura coordinata. Questa restrizione è illustrata da (32) contrapposto a (33):
25 La pluralità di manifestazioni, tuttavia, può essere forzata nella frase mediante un avverbiale quantificante. E’ am-messa allora l’esemplificazione di manifestazioni in un certo senso collaterali: cfr. (i):
(i) Martine è proprio belga / belga in tutti i sensi del termine. Ad esempio, a lasciarla fare, mangerebbe patatine fritte mezzogiorno e sera,
mentre rimane inaccettabile la esemplificazione di una manifestazione ‘centrale’: cfr. (ii):
(ii) *Martine è proprio belga / belga in tutti i sensi del termine. Ad esempio è nata in un pae-sino della campagna vallona.
26 Si noterà che la restrizione sulla specificità, che si potrebbe pensare di trasporre in una restrizione sulla ’datità’, cioè sul carattere di ‘dato di fatto’ dell’esemplificato, non svolge qui un ruolo analogo a quello visto per la esemplificazio-ne frasale.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
18
(32) ??Potrebbe fare molte cose e ad esempio potrebbe iscriversi ad un corso di specializzazione (33) Potrebbe fare molte cose. Ad esempio potrebbe iscriversi ad un corso di specializzazione.
Quando però il secondo congiunto della coordinazione è già specializzato da un apposito connettivo nei termini di altra relazione (ad es. la conseguenza), allora l’esemplificazione è possibile all’interno della nuo-va relazione (di tutte le conseguenze possibili, ad es., una in particolare viene addotta ad esempio); è quel che spiega l’accettabilità di (34), di contro a (35):
(34) È stata male tutto il mese e così ad esempio ha dovuto rinunciare anche al viaggio
(35) ??È stata male tutto il mese e ad esempio ha dovuto rinunciare anche al viaggio.
Si venga ora ad una caratterizzazione positiva delle condizioni di esemplificazione nel testo. Direi che l’esemplificazione è inseribile in un testo essenzialmente in due modi:
(a) in quanto esemplificazione appositiva, che tiene immutata parte della frase (della sezione di testo) per sostituire ad un costituente – tipicamente il predicato27 – un caso particolare, una sua ‘manifestazione’. È quel che accade in (36), in cui il soggetto di esemplificato ed esempio è identico, e la predicazione del secondo è una manifestazione della predicazione del primo:
(36) È molto nervosa. Ad esempio non si può farle una osservazione
Un caso analogo più complicato (tanto da rendere arduo a prima vista capire che cosa esattamente venga esemplificato) è (37), in cui la quantificazione esplicita («quante volte») facilita la pluralità delle manifesta-zioni del predicato:
(37) Altre volte la digressione avviene per congiunzione metonimica, allorché una sensazione, un dettaglio diventano lo spunto di una espansione divagativa. Ad esempio, certo a causa anche del chiacchierio di fondo che è nella camera, mentre il protagonista è a colloquio con Margherita a un certo punto “il discorso si decompose nella mente di Marco, diventò séguito di suoni ecc. [stessa fonte di (1), con mutamenti]
Spesso il costituente da esemplificare viene ripreso all’interno di strutture copulative o locative; così in (38): «... altri procedimenti narrativi ... Fra questi [procedimenti narrativi] è ad esempio ...» o in (39): « ...ha notato ... Un primo esempio di queste suggestioni ... troviamo nel ...»:
(38) Ma accanto al funerale altri procedimenti narrativi di carattere più formale sono utilizzati dall’autore per disciplinare la composita e divagante materia. Fra questi ad esempio la scomposizione in brani. Il romanzo infatti ecc. [stessa fonte di (1), con mutamenti]
(39) Il Segre, particolarmente attento a cogliere i nessi tra la cultura ariostesca e la tradizione romanza, ha notato nel suo commento all’Orlando Furioso la suggestione esercitata sull’Ariosto da quel re-pertorio di immagini, vivo presso gli scrittori ecclesiastici e da secoli radicato nel linguaggio poeti-co italiano sia lirico che narrativo. Un primo esempio di queste suggestioni, ben inteso mediate dalla stessa tradizione narrativa in ottave, troviamo [= annuncio dell’esempio] nel canto XXVII: Gradas-so chiede a Mandricardo come egli abbia ottenuto Durindana, e il tartaro gli espone una sua visio-ne dei fatti, ricorrendo ad un immaginoso linguaggio, ben conveniente alla sua rozza personalità [...]. A commento del passo alcuni studiosi, ad esempio il Casella, citano senz’altro Giovenale (Sat.
27 Se fosse il predicato ad venir tenuto fisso verrebbe preferibilmente scelta, se non si decide di elidere il predicato ri-petuto, l’altra soluzione della esemplificazione interna alla frase: «Certi sono a casa ammalati. (E’ a casa ammalata) ad esempio Maria. / Certi, ad esempio Maria, sono a casa ammalati».
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
19
XII 34-36); il Segre invece osserva che la notizia sul castoro, offerta già da Plinio (Nat. hist., XXXII 3), «è poi passata in tutti i ‘bestiari’ medievali» [C. Delcorno, Exemplum e letteratura. Tra Medioevo e Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 317-18].
(b) Il secondo modo di inserire in un testo una esemplificazione è all’interno – ‘in subordine’, per così dire, di un’altra relazione tra proposizioni o sezioni del testo. Si potrà cioè costruire una giustificazione esemplificante (...infatti, ad esempio, ...), una spiegazione esemplificante (...cioè, ad esempio,...), una conse-cuzione esemplificante (...così, ad esempio, ...), una conclusione esemplificante (...quindi, ad esempio,...), e così via. L’esemplificazione, dunque, si comporta sistematicamente come la più ‘bassa’, la più interna, delle relazioni testuale: essa non può a sua volta essere superordinata ad un’altra relazione. Un caso simile per la giustificazione è (40), per la consecuzione (41), e per la finalità, con realizzazione subordinata dell’esempio, (42):
(40) Non riuscirà facilmente a trovare un lavoro che le vada (per tante ragioni). Prima era abi-tuata, ad esempio, ad essere indipendente
(41) È molto nervosa. Tanto che ad esempio ieri sera è riuscita a litigare anche con sua sorella (42) Lo ha fatto ad esempio per farle piacere.
3.2.2. Funzioni della esemplificazione Ritorniamo ora sul problema delle funzioni della esemplificazione: il modo in cui l’esemplificazione appoggia il conseguimento dello scopo fondamentale dell’esemplificato. Nel caso dei SN, si era detto, l’esemplificazione aiuta a precisare l’esemplificato, suggerendone realizzazioni concrete. Che cosa accade, esattamente, nella esemplificazione di enunciati?
3.2.2.1. Esemplificazioni di domande, di ordini, ecc. Occorrerà riconoscere in primo luogo che non vi è esemplificazione solo di asserzioni, ma anche di altri tipi illocutivi. Così una domanda può essere ripresa esemplificativamente da una domanda (cfr. (43)) o da una asserzione che insinui una possibilità (cfr. (44)), ecc.; un ordine potrà essere ripreso da un ordine (cfr. (45)), da una asserzione di necessità (cfr. 46)), ecc.:
(43) Ma tu l’hai offesa? Le hai detto ad esempio qualcosa su sua madre? (44) Ma tu l’hai offesa? Ad esempio, tu certe volte sei un po’ eccessiva (45) Su, aiuta un po’ anche tu! Ad esempio, sparecchia la tavola (46) Su, aiuta un po’ anche tu! Ad esempio, il bagno ha bisogno di essere pulito.
In ogni caso, e tenuto conto della minore flessibilità che le illocuzioni non assertive presentano nei con-fronti di esemplificazioni di altro tipo, l’esemplificazione si fa tra illocuzioni che ad un livello sufficiente-mente elevato di obiettivo illocutivo sono omologhe: asserzione e asserzione, domanda e domanda e così via. Una volta stabilito questo, ci si può chiedere quali aspetti particolari della rispettiva illocuzione siano prescelti dalla relazione di esemplificazione. Se ora si riprende alla luce degli ultimi enunciati introdotti il problema della funzione della esemplifi-cazione, si può osservare, schematicamente, quanto segue. In (43) l’esempio in primo luogo facilita all’interlocutore il compito della risposta (donde il tono un po’ inquisitorio o se si vuole confessionale del-la formulazione con ad esempio rispetto a quella puramente giustappositiva: «L’hai offesa? Le hai detto qualcosa su sua madre?»): gli fornisce una versione certo parziale ma più specifica della domanda alla quale dovrebbe essere agevole rispondere senza esitazione. È dunque l’obiettivo fondamentale dell’enunciato
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
20
esemplificato – l’obbiettivo d’esecuzione – di cui l’esemplificazione favorisce il raggiungimento. Mentre dal canto suo l’obiettivo d’accettazione – il riuscire a fare sì che l’interlocutore voglia rispondere – non è interessato che marginalmente28, l’obiettivo ‘diretto’, quello di comprensione, è in qualche modo coinvolto dalla esemplificazione. Si può infatti con ragione sostenere che essa aiuta a cogliere la portata della do-manda, a renderne più perspicuo, concreto, il senso col mostrarne l’ambito di applicazione. (44), poi, che introduce delle ipotetiche («certe volte», «un po’») ragioni d’offesa, è riconducibile alle funzioni osservate in (43): l’esemplificazione facilita con l’evocazione di casi specifici la risposta, rendendo nel contempo più concreto il senso della domanda. Il ragionamento è riproponibile in maniera analoga per i due enunciati (45) e (46), in cui predomina ancora più nettamente la funzionalizzazione dell’esempio all’obiettivo fon-damentale, l’esecuzione, piuttosto che alla comprensione. La conclusione che si impone all’esame della funzione dell’esempio negli enunciati precedenti è dun-que in favore della formulazione più generale assunta alla fine di § 2.1.: l’esemplificazione aiuta ‘in vario modo’ il conseguimento dell’obiettivo fondamentale, coinvolgendo in questo l’obiettivo diretto della comprensione.
3.2.2.2. Esemplificazione di asserzioni: esemplificazione in senso stretto e illustrazione La compresenza di una doppia finalizzazione, all’obiettivo fondamentale e all’obiettivo diretto (in quanto tramite all’obiettivo fondamentale), si manifesta in maniera particolarmente evidente nella esem-plificazione di asserzioni. Accade cioè che quando l’obiettivo fondamentale (consistente qui nel registrare come vero il contenuto proposizionale dell’enunciato assertivo) sia di per sé assicurato, l’esemplificazione venga a concentrarsi sull’obiettivo diretto, divenendo esemplificazione ‘di comprensione’: esemplificazione ‘illustrativa’. Si profila dunque per gli enunciati assertivi una distinzione tra esemplificazione per così dire ‘argomentativa’, che corrobora la verità dell’enunciato, e esemplificazione ‘illustrativa’, che ne chiarisce il senso – una distinzione insomma (restringendo il valore dei termine) tra ‘esemplificazione’ in senso stretto e ‘illustrazione’29. L’opposizione che qui si introduce tra i termini e (concetti) tradizionali30 di ’esempio‘ e ’illustrazione’ non è certo inedita. Essa è stata posta con rigore (anche se naturalmente in un diverso quadro teorico) in alcuni paragrafi del cap. III del Trattato dell’argomentazione di Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca31: §§ 78 «L'argomentazione per mezzo dell'esempio», 79 «L’illustrazione» e § 80 «Il modello e
28 Direttamente rilevante per l’obiettivo d’accettazione sarebbe invece l’aggiunta giustificativa (di non certissima ac-cettabilità, a dire il vero) in «Vai a fare tre passi. Ad esempio, ti farebbe bene per il tuo mal di testa». 29 A rigore il termine ‘illustrazione’ ricopre attività molteplici, e non solo una declinazione dell’esemplificazione: si può ad es. illustrare commentando, parafrasando, espandendo, e così via. 30 E in parte almeno intercambiabili nell’uso, come mostra ad es. la traduzione francese di un passo degli Ambassadors di H. James: «All sorts of other pleasant small things thath were yet large for him – flowered in the air of the occa-sion; but the bearing of the occasion itself on matters still remote concerns us too closely to permit us to multiply our illustrations. Two or three, however, in truth, we should perhaps regret to lose» (“Penguin Modern Classics”, 1973, p. 13) – «Nombre de petits détails aimables (et qui continuaient à frapper énormément Strether, si menus fussent-ils) s’épanouirent à la faveur de cette rencontre ; mais la portée du hasard même qui l’avait provoquée, son contrecoup sur des problèmes fort éloignés de nous pour l’instant, nous intéresse trop directement pour nous permettre de mul-tiplier ici les exemples. Pourtant, à vrai dire, il en est deux ou trois que nous regretterions peut-être de laisser se perdre» (trad. de G. Belmont, Parigi, Laffont “Pavillons”, 1978, p. 33).
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
21
l’antimodello»32. Schematicamente, Perelman e Olbrechts-Tyteca affermano proprio che un ’esempio‘ sostiene argomen-tativamente la o le affermazioni che precedono, mentre una ‘illustrazione’ ne ostende la portata, le applica-zioni. Nei termini stessi del Trattato (pp. 377-78): «L’illustrazione differisce dall’esempio a seconda dello statuto della regola che l’uno e l’altra servono ad appoggiare. Mentre l’esempio aveva il compito di dare un fondamento alla regola, l’illustrazione ha quello di rafforzare l’adesione a una regola conosciuta e ammessa, fornendo dei casi particolari che chiariscono l’enunciato generale, mostrano l’interesse di quest’ultimo at-traverso la varietà delle possibili applicazioni, aumentano la sua presenza nella coscienza». Gli autori proseguono rilevando che l’esistenza di casi dubbi, in cui è difficile discriminare tra le due funzioni, non sminuisce l’importanza della distinzione, «perché, essendo la funzione dell’illustrazione di-versa da quella dell’esempio, la sua scelta sarà sottoposta ad altri criteri. Mentre l’esempio dev’essere incon-testabile, l’illustrazione, da cui non dipende l’adesione alla regola, può essere più discutibile, ma deve col-pire vivamente l’immaginazione per imporsi all’attenzione». Si può ora, se si vogliono indicare applicazioni della distinzione in diversi tipi di ’discorso‘, segnalare che tipicamente illustrativo è l’impiego degli esempi in discipline non empiriche, come la geometria, l’algebra, il calcolo differenziale, la logica formale. La validità delle proposizioni del discorso matematico, siano esse definizioni o tappe deduttive di un ragionamento, si fonda sulla non-contraddittorietà e produt-tività definitoria, sull’accordo con le leggi classiche della dimostrazione, ma in nessun caso può basarsi su degli esempi. Gli esempi vi hanno funzione puramente illustrativa: essi mostrano, nel loro impiego più ti-pico, l’estensione del campo d’applicazione della definizione a cui si riferiscono. Così, gli esempi tendono ad infittirsi là dove le definizioni risultano di carattere molto generale, rarefacendosi attorno a definizioni più specifiche, e scompaiono del tutto nei passi dimostrativi. Ecco, della esemplificazione di definizioni di carattere generale, un paio di casi correnti33:
(47) DEFINIZIONE Una relazione f definita in A x B si dice applicazione (o funzione) di A in B se per ogni x ∈ A esiste uno e un solo y ∈ B tale che (x, y) ∈ f. [...]
Osservazione In certi casi si usa indicare il valore di un’applicazione scrivendo la variabile indipen-dente a mo’ di indice: fx, anziché f(x). Ad esempio, se il dominio dell’applicazione è l’insieme N degli interi naturali, l’applicazione viene detta successione; i valori di una successione a (ma più frequentemente si parla dei termini della successione) sono indicati con la notazione a0, a1, ..., an, .... Le nozioni di funzione di variabile reale e di successione, che nei testi matematici più recenti sono comprese nella nozione generale di applicazione, venivano un tempo considerate come diver-se: ciò spiega la difformità di notazione, che è rimasta.
Esempi banali ma importanti
a) Dato un qualunque insieme A, l’applicazione {x → x : A → A} si dice applicazione identica di A e si indica con IA.
b) Dato l’insieme A e un suo sottinsieme B, l’applicazione {x → x : B →A} si dice applicazione di inclusione di B in A.
31 Traduzione italiana (per i passi rilevanti) di Maria Mayer, Torino, Einaudi, 1966, originale francese Parigi, PUF, 1958, pp. 370 sgg. 32 Più recentemente, la distinzione è stata ripresa da B. Mortara Garavelli nel Manuale di retorica, Milano, Bompia-ni, 1988, pp. 77-79. 33 Tratti da G. Prodi, Analisi matematica, Torino, Boringhieri, 1970, pp. 31-33 e 34 rispettivamente.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
22
c) Siano A e B insiemi qualunque; l’applicazione {(x, y) → x : A x B → A} si dice proiezione canoni-ca su A; l’applicazione { (x, y) → y : A x B → B } si dice proiezione canonica su B.
(48) DEFINIZIONE Un’applicazione f: A → B si dice iniettiva se essa porta punti distinti in punti distinti. [...] Ad esempio, l’applicazione identica in un insieme, l’applicazione di inclusione di un sottoin-sieme in un insieme (esempi a) e b)) sono iniettive. La proiezione canonica A x B → A non è iniettiva (a meno che...).
È curioso osservare che questa stessa distinzione tra valore illustrativo e argomentativo, ‘di prova’, è sta-ta impiegata da un filosofo della scienza34 per distinguere tra diverse accezioni di quegli ‘esempi’ di per sé essenzialmente e tipicamente dimostrativi che sono gli esperimenti: nella scuola, si sostiene, «perfino l’uso degli esperimenti di laboratorio non intacca questa impostazione: essi hanno infatti una funzione essen-zialmente illustrativa, nel senso che non possono mai dar luogo a un risultato inatteso e ‘falsificante’ rispet-to ad una certa legge che essi debbono illustrare (vuoi in senso fintamente induttivo, vuoi in senso corro-borativo)». Ricapitolando, si avrà dunque illustrazione ogni volta che l’esempio si allaccia al contenuto proposizio-nale di una asserzione, il cui statuto illocutivo non ha bisogno di rinforzo (ad es. ‘esemplificare una defini-zione’ vuol dire illustrare la portata della stipulazione: cfr. «Un anello è per definizione un insieme dotato di ecc. – Ad esempio, è un anello l’insieme dei ecc.»). Si ha invece esemplificazione argomentativa (o esem-plificazione in senso stretto) quando l’esemplificazione si collega (anche) allo statuto assertivo dell’esemplificato, provvedendolo di una sorta di giustificazione. Va forse precisato che il tipo di giustifica-zione fornita dall’esemplificazione argomentativa non è assimilabile a quello di una causa o ragione o mo-tivo di uno stato di cose o della sua enunciazione con pretesa di verità. Il segnale di esemplificazione, ad es., non può in genere essere sostituito da un segnale di giustificazione, come ben mostra (49):
(49) Maria ha letto molti libri ultimamente. Ad esempio / ??Infatti ieri sera ha finito l’Adalgisa.
È vero però che in particolari condizioni una serie di esempi (non un singolo esempio) di uno stato di cose, la quale di per sè, segnalata da ad esempio, è una giustificazione parziale, può fungere anche da giusti-ficazione totale del suo sussistere. Infatti – che presuppone che i dati elencati bastano a fondare l’asserzione – potrà allora sostituire ad esempio, come appare da (50) e (51):
(50) Maria ha passato una brutta estate. Ad esempio / Infatti, è stata ammalata, poi ha avuto problemi in famiglia, e poi ha litigato col fidanzato
(51) Maria ha letto molti libri ultimamente. Ad esempio / Infatti le ultime due settimane ha letto l’Adalgisa, Pomo Pero, Signorina Rosina e Si riparano bambole.
4. Una parola di conclusione Si è dunque mostrato nelle pagine precedenti che l’esemplificazione è un particolare procedimento te-stuale, che (i) introduce nel testo una sezione in rapporto di caso particolare / concretizzazione con una precedente sezione (l’esemplificato); (ii) è segnalato avverbialmente o proposizionalmente (la presenza di un segnale è obbligatoria, l’esemplificazione venendo altrimenti a confondersi con la precisazione); (iii) è funzionalizzato a favorire (in vari modi) il conseguimento dell’obiettivo fondamentale dell’enunciato, aiu-tando:
(a) a cogliere la portata di una definizione, di un concetto, di una asserzione il cui valore di
34 Evandro Agazzi, in un editoriale di «Nuova Secondaria», a. IX, n. 9 (15 maggio 1992), p. 3.
L’italiano (e altre lingue). Strumenti e modelli di analisi. Atti del IV Seminario di Studi [della S.S.I.T.], Milano, 13-14 settembre 1991, a c. di V. Bonini e M. Mazzoleni, Pavia, Iuculano, 1993, pp. 47-98
23
verità è assunto come scontato; (b) a giustificare in maniera particolare, ‘per campioni’, una asserzione; (c) a rispondere ad una domanda; (d) a eseguire un ordine,
e così via. Si è visto inoltre che l’esemplificazione ammette realizzazioni interne alla frase – l’esempio essendo allo-ra sintatticamente una apposizione dell’esemplificato, (questo, a volte, non presente nella frase, ma solo inducibile) – o realizzazioni esterne, testuali. Infine, si è mostrato come il connettivo prototipico di esem-plificazione, l’avverbiale ad esempio, richieda tra l’altro, per poter essere inserito a segnalare l’esemplificazione frasale, un rapporto di specificazione tra esemplificato ed esempio, la non specificità dell’esemplificato e l’equipollenza comunicativa tra esemplificato ed esempio; e introduca nella semantica della frase l’evocazione di un paradigma di alternative dell’esempio e una esigenza di funzionalizzazione dell’esempio all’esemplificato.