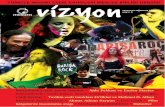“Non temere arditezze se anche possono sembrare oggi soverchie”, Enrico di San Martino e le arti...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of “Non temere arditezze se anche possono sembrare oggi soverchie”, Enrico di San Martino e le arti...
L’Arte ArmonicaCollana di facsimili e testi musicali
Direttore di collanaAlberto Basso
Responsabile editorialeAnnalisa Bini
Art directorSilvana Amato
Enrico di San Martinoe la cultura musicale europea
Atti del convegno di studiRoma, 11-13 maggio 2009
a cura di
Annalisa Bini
9 Bruno CagliLa figura di Enrico di San Martino e Valperga
13 Roman VladRicordi del conte di San Martino
17 Alberto BassoLa casata dei San Martino e gli anni torinesi del conte Enrico
31 Marcello RuggieriAlle origini del progetto di una politica pubblica dello spettacolo:proposte, successi, insuccessi del conte di San Martino (1899-1905)
125 Franco BottoneIl conte di San Martino e l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia:“il possente organismo produttivo”
177 Guido RicciTra musica e politica:il repertorio sinfonico negli anni dell’Augusteo (1910-1935)
195 Bianca Maria AntoliniL’Esposizione musicale del 1911
247 Gaia BottoniRoma 1912-1925. Le attività nelle sale da concerto e nei teatri.
259 Chiara MastromoroGli eventi di tipo celebrativo a Roma tra il 1912 e il 1925
SommarioQuesto volume è stato pubblicato grazie al contributo di ARCUS Spa
Progetto grafico Silvana Amato
RedazionePaola Pacetti
Impaginazione e revisione degli esempi musicaliRoberto GrisleyFederica Passarelli, Davide Romualdi
Un ringraziamento agli Amici di Santa Ceciliaper aver collaborato alla realizzazione del convegnoe a Ra∂aella Barbetti, Nicole Botti, Lina Di Lembo e Daniele Iovanellaper il lavoro svolto durante le prime fasi di impaginazione e redazione di questo volume
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore
Composizione tipografica in Cycles di Summer Stone
© 2012 Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Fondazione, RomaTutti i diritti riservatiisbn 978-88-95341-43-9
www.santacecilia.it
Soci Fondatori dell’Accademia Nazionale di Santa CeciliaStato Italiano, Roma Capitale, Regione Lazio, Provincia di Roma, Camera di Commercio Roma, enel, Telecom, bnl-Paribas, Finmeccanica, Autostrade per l’Italia, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Astaldi
523 Teresa ChiricoIl Liceo musicale fra la fondazione e la regificazione
553 Cristina Cimagalli“La creazione di un’università musicale”:progetti, lotte (e illusioni) del conte di San Martino riguardo ai corsi di perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia
578 Tabella dei coe∑cienti istat per la conversione dei valori monetari (1861-2010)
271 Chiara PellicciaAlberghi, circoli, salotti: cornici inconsuete per la vita musicale romana (1912-1925)
287 Guido SalvettiMusica da camera: le specifiche ragioni
305 Luca Aversano I rapporti del conte di San Martino con il teatro lirico e di prosa a Roma
339 Fiamma NicolodiBernardino Molinari direttore artistico e d’orchestra
371 Umberto Nicoletti AltimariLe scelte artistiche: le stagioni sinfoniche
381 Silvia Cecchini“Non temere arditezze se anche possono sembrare oggi soverchie”Le imprese di Enrico di San Martino per le arti figurative a Romatra Società Amatori e Cultori di Belle Arti e Secessione (1898-1913)
431 Carlo Fabrizio CarliIl conte Enrico di San Martino e le Quadriennali
447 Alfredo BaldiEnrico di San Martino e la cinematografia: produzione e formazione
463 Maria Elena MoroL’Unione nazionale dei concerti: profilo storico-giuridicodella prima associazione italiana delle istituzioni dei concerti
475 Annalisa BiniEnrico di San Martino e la Federazione internazionale dei concerti
* Ringrazio Angela Cipriani, Laura Francescangeli e Daniela Ronzitti per l’aiuto durante le ricer-che. Un ringraziamento particolare a Giovanni Emiliani – che ha dato avvio al recupero dellafigura di Enrico di San Martino – e a Marcello Ruggieri per il cammino fatto insieme.
381
Nonostante la sua importanza per la vita culturale romana e italiana tra la finedell’Ottocento e il 1947, anno della sua morte, Enrico di San Martino e Valperga èrimasto, fino ad oggi, quasi del tutto ignoto agli studi storici.
La volontà di recuperarne la memoria ha portato in passato l’amministrazio-ne capitolina a dedicargli una strada. Ma è una strada che pochi conoscono, aimargini del quartiere romano del Trullo. E così il suo nome ha continuato a rima-nere, fino ad oggi, nell’oscurità.
Ho cominciato a seguire le tracce del conte Enrico di San Martino con l’inten-to di ritrovarne l’archivio personale che, vista la messe di cariche da lui ricoperte,si profilava di considerevole importanza per la ricostruzione di molti aspettidella vita culturale romana, sicuramente prioritario quello della musica, maimportante anche per le arti figurative, il teatro, il cinema.
Questa parte della ricerca si è conclusa al Cottolengo di Torino. Lì ho trovatoquello che rimane dell’archivio, un elenco stilato dal cancelliere della Procura diRoma. L’archivio personale di San Martino è rimasto lì fino al 1989. È stato custo-dito per trentacinque anni all’interno dei bauli di Maddalena Fourton, moglie di
“Non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”. Le imprese di Enrico di San Martino per le arti figurative a Romatra Società Amatori e Cultori di Belle Arti e Secessione (1898 - 1913)*Silvia Cecchini
a Ceciliaal tempo passato insieme
383
Enrico, che aveva destinato all’istituto la sua intera eredità.1 Poi, per carenza dispazi, alla fine del 1989 è stato dato al macero.2
Oggi dell’archivio possiamo consultare solo l’elenco stilato con precisionedal cancelliere della Procura di Roma; un elenco che ci dice ancora qualcosa. Sitrattava di un archivio cospicuo, che conteneva la corrispondenza diretta a Enri-co di San Martino e sue minute, dalla fine Ottocento fino al 1947; appunti emanoscritti relativi a viaggi e missioni; dattiloscritti che attestano un’attività discrittura (un volume dattiloscritto recava il titolo “Romanzo” e un altro “Novel-le”); libri e registri di contabilità, ricevute e notule, bollettari di cassa e poi unaconsiderevole quantità di album fotografici di ricordi del conte, scatole di foto-grafie di viaggio e ricordi familiari. Chi ha stilato il documento, a conclusionedell’elenco dei beni relativi a San Martino, scrive una frase che conferma l’im-portanza dell’archivio per la conoscenza della storia culturale della città di Roma:“si dà atto che oltre al carteggio inventariato fin qui è stata rinvenuta altra discre-
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
1 Maddalena Fourton muore il 13-settembre-1955 all’età di sessantasette anni. A lei Enrico di SanMartino aveva lasciato in eredità tutti i suoi beni nominandola erede universale, come risulta daltestamento trascritto in appendice [v. doc. 1].Nella medesima appendice è riportato inoltre iltestamento con cui Maddalena lascia la totalità dei suoi averi al Cottolengo, con alcune eccezioni[append. v. doc. 2]. L’ultimo contributo in appendice è una selezione di documenti contenuti indue faldoni titolati “eredità Maddalena Fourton”. Ho donato le foto di una cospicua selezione deidocumenti conservata presso l’archivio del Cottolengo all’Archivio dell’Accademia di Santa Ceci-lia che le metterà a disposizione per la consultazione. La scelta di devolvere tutti i beni al Cotto-lengo è da connettere all’estrema solitudine nella quale la vedova Fourton si è trovata dopo lamorte del marito, una solitudine che è espressa nelle volontà da lei stabilite il 31 maggio 1954 neldocumento titolato “Disposizioni per i miei funerali”. Sulla contessa Maddalena Fourton vediGuido Boni, “La morte della Contessa San Martino. Un lascito di dieci milioni alla Sezione Assistenzadell’Accademia”, in “Santa Cecilia”, anno IV, n. 4 (1955), pp. 42-45, in cui scrive: “Aveva crisi disconforto e preoccupazioni immaginarie di povertà”. Per quanto si può comprendere dalla lettu-ra dei documenti reperiti presso l’archivio del Cottolengo, le angosce della contessa avevano unfondamento di verità nella complessa vicenda delle proprietà in Ungheria che lei mai riuscì ariscattare. Nell’impresa riuscirà, solo molti anni dopo, il Cottolengo.2 Ho raccolto le informazioni qui riferite nell’aprile del 2009, grazie alla disponibilità di DonLino Piano, responsabile dell’Archivio, e alla testimonianza di suor Rita, già presente al Cottolen-go nel 1989 e testimone diretta dei fatti. Suor Rita testimonia che la documentazione cartacea, adesclusione della parte relativa all’eredità del Cottolengo, è stata consegnata ad una ditta a∑nchèprovvedesse allo smaltimento, mentre i vestiti di Maddalena Fourton sono stati donati agli ospitidel Cottolengo.
silvia cecchini
382
3 La parte dell’elenco relativa ai beni direttamente riguardanti Enrico di San Martino è trascrittain appendice, v. doc. 4. 4 L’Archivio Ricci, conservato presso la Biblioteca Classense di Ravenna, contiene cinquantunolettere inviate da San Martino a Ricci e minute di risposta inviate tra il 19 marzo 1908 e il 30 dicem-bre 1933, protocollate con i numeri 32713-32757, 41877-41881.5 Le parole di risposta di San Martino fanno desumere un tentativo di diniego e∑cacementecontrastato:“Caro amico, non trovo altro rimedio che quello di farti cortese violenza, perché tuaccetti e sia dei nostri. I vicepresidenti della professione sono Mascagni e Falchi; lascia che ci per-mettiamo il lusso di un vicepresidente amatore. Dopo aver rubato il tuo nome, che ci è prezioso,non ruberemo il tuo tempo, se non, forse, nei pochi giorni del congresso che ci auguriamo debbariuscire una splendida festa dell'arte musicale”, lettera di San Martino a Ricci del 14 dicembre1909, prot 32729, conservata a Ravenna, Biblioteca Classense, Archivio Ricci. Un rifiuto inderoga-bile viene espresso invece rispetto alla nomina quale membro della Commissione aggiudicatricedei premi agli studi di critica sulle opere esposte all’Esposizione internazionale di Valle Giulia nel1911. Vedi lettera di invito di San Martino a Ricci del 4 dicembre 1911, prot. 32742 e risposta di Riccidatata 6 dicembre 1911, prot 32743, ove Ricci rifiuta l’incarico così motivando: “purtroppo le curedell’u∑cio mio sono tali da non consentirmi tempo nemmeno per il più ragionevole riposo.Immagini quindi la S.V. se potrei mettermi a un lavoro che fatto con la doverosa coscienza mi por-
ta quantità di carta di carattere privato – familiare – e di tipo u∑ciale per le cari-che ricoperte dal conte di San Martino”.3
Sopravvive, come sempre, la speranza che la qualità dei materiali – ad esem-pio le stampe fotografiche – possa aver convinto chi doveva trasportarli al mace-ro a salvarne una parte. Tuttavia oggi, constatata la perdita, possiamo procederenella ricerca indagando negli archivi personali di personaggi contemporanei o diistituzioni con cui San Martino ha avuto contatti.
Un’amiciziaLa corrispondenza ritrovata fra le carte dell’Archivio Ricci4 documenta rapportiamichevoli e cordiali tra Enrico di San Martino e Corrado Ricci. Lettere dai toniper lo più confidenziali ritraggono un rapporto alimentato dalle frequenti solle-citazioni di San Martino che cerca assai spesso di avere Ricci al suo fianco, pro-ponendogli cariche all’interno degli organi direttivi delle istituzioni e degli even-ti di cui è responsabile. La confidenza emerge anche dalla schiettezza dei toni edelle motivazioni con cui Corrado Ricci tenta talvolta di declinare le proposte,finendo poi spesso con il cedere alle sue sollecitazioni. È ciò che accade, ad esem-pio, in occasione della proposta di assumere la carica di vicepresidente del Comi-tato esecutivo per le feste commemorative del 1911.5 E già nel 1908 l’occasione
terebbe a lunghi confronti tra articoli nella maggior parte nuovi per me, ed opere che non ho esa-minate nei riguardi critici. L’accettare mi è quindi assolutamente impossibile”. Vedi inoltre lette-re del 3 febbraio 1913 prot. 32745, 5 febbraio 1913 prot. 32746.6 Alla lettera del 21 luglio 1908, prot. 32717 (Ravenna, Biblioteca Classense, Archivio Ricci), in cuiSan Martino comunica a Ricci che l’assemblea generale dei soci lo ha eletto consigliere per il bien-nio 1908-1909, Ricci risponde il 23 luglio (prot. 32718) scrivendo che avrebbe accettato, se nonfosse per l’orario della convocazione, le 21.30: “Ora io dopo le fatiche diurne – le quali talora siproducono oltre alle nove – non riesco ad occuparmi d’altro”. L’orario delle convocazioni verràcambiato in modo che Ricci possa far parte dell’Assemblea.7 La rete di contatti di Ricci ha un componente fondamentale in Luigi Rava, suo conterraneo eministro della pubblica istruzione tra il 1906 e il 1909, durante il terzo ministero Giolitti. In prece-denza Rava aveva ricoperto le cariche di sottosegretario al Ministero per le poste e i telegrafi nel1893, a due soli anni dall’ingresso a Montecitorio, poi sottosegretario al ministero dell’Agricoltu-ra nel Gabinetto Saracco del 1900; quindi ministro di Agricoltura, industria e commercio dal 1903al 1905, nel secondo Ministero Giolitti.8 Vedi nota 50.9 Enrico di San Martino viene nominato senatore del Regno il 3 giugno 1911; la sua nomina vieneconvalidata il 16 giugno 1911 e non è ascritta ad alcun gruppo politico.
384
silvia cecchini “non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
385
dell’invito di San Martino ad accettare la nomina a consigliere dell’Accademia diSanta Cecilia era stata dimostrazione della sua disponibilità verso le esigenzeespresse da Ricci, pur di averlo al suo fianco.6
Quanto importante fosse per il conte la presenza di Ricci, la cui autorevolezzae il cui potere erano fondati sia sulla carica di direttore generale delle Antichità eBelle Arti sia sui solidi contatti da lui intrattenuti con il mondo politico,7 è resoevidente, oltre che dalla frequenza delle proposte, anche dai risultati che la loroazione congiunta riesce a ottenere sul piano dei finanziamenti per l’arte.8
Il rapporto tra i due, impostato anche su una certa a∑nità di carattere, va viavia ra∂orzandosi. Invitato al banchetto in onore di Enrico di San Martino, di cuisi festeggia la nomina a senatore ottenuta per il suo personale successo nelle cele-brazioni per il cinquantenario dell’unità d’Italia9, Ricci nel declinare l’invitoinvia una risposta in cui celebra un’amicizia cresciuta negli anni: “Più che unavecchia consuetudine, mi tolgono il piacere d’intervenire al banchetto d’onoran-za che si darà al mio amico Conte di San Martino, condizioni speciali di famigliadove ora si trova una persona inferma. Io però amo ripetere che sono un forteestimatore di lui, della sua operosità, del suo fervore, di tutte, insomma, le suequalità di cuore e d’ingegno rivolte sempre al servizio di nobilissimi ideali. L’artea Roma deve molto a lui, né solo nell’occasione delle mostre u∑ciali, se anche
10 Ravenna, Biblioteca Classense, Archivio Ricci, lettera del 23 giugno 1911, prot. 32742.11 Enrico di San Martino, Ricordi, Roma, Danesi Editore, 1943, pp. 21-22.12 Ivi, p. 22.13 Erano tradizionalmente invitate cinque Accademie: Académie française, l’Académie des beauxarts, l’Académie des sciences, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des scien-ces morales et politiques.
queste sono la prova più evidente di quelle sue qualità. Io perciò plaudo alla suanomina a Senatore e plaudo alla festa”.10
Tra Ricci e San Martino il sodalizio è destinato a durare negli anni. Nel 1920, inoccasione della celebrazione del venticinquesimo anniversario dell’istituzione deiConcerti, Ricci interviene parlando di San Martino nella sala accademica: “Quan-do alla Direzione Generale delle Belle Arti fu annunziata la fondazione dei Con-certi, non mancò chi mi avvertisse che il Presidente San Martino era un grandeaccentratore, piuttosto prepotente, che intendeva comandare da solo, fare tuttoda sé. L’avvertimento era ispirato a malignità, prevedeva pericoli, disastri; ma iorisposi: se il capo è prepotente, le cose andranno bene. E fui buon profeta!”.11
Autorevolezza e determinazione erano per San Martino doti indispensabili –“operar deciso molto giova” era il suo motto – e una simile indole trovava certocorrispondenze con il carattere di Corrado Ricci.12
Quindici anni più tardi, nel 1935, sarà Enrico di San Martino a esprimere ilsuo tributo a quell’amicizia. Nell’estate era scomparso Corrado Ricci e il conteviene chiamato a sostituire l’amico nel ruolo di socio dell’Académie des beauxarts. A ottobre cade la celebrazione dei centoquarant’anni dall’istituzione del-l’Institut de France. La ricorrenza viene festeggiata annualmente dall’Istitutoche invita a partecipare le cinque Accademie.13 Ognuna di esse nominava unsuo membro come relatore e quell’anno, per la prima volta, l’Académie desbeaux arts indica come proprio rappresentante uno straniero, Enrico di SanMartino. La vicinanza alla cultura francese, che per San Martino era fondata siasu un’a∑nità elettiva che su ragioni familiari – sua moglie Maddalena Fourtonera di Parigi – era una tra le numerose liaisons tra i due amici. San Martinoaccetta l’incarico e propone come tema della propria relazione l’illustrazionedella vita e delle opere di Corrado Ricci, ricordando il legame che li ha uniti percinquant’anni: “Si l’oeuvre de l’historien, de l’archéologue, de l’écrivain, dufunctionnaire, du critique, du musicologue, m’inspirait une admiration infinie,
14 Annuario dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 1934-1935, pp. 367-374, in particolare p. 368.15 Enrico di San Martino, Ricordi, cit., p. 13. Ancora nei Ricordi San Martino scrive: “Quantunquela musica rimanga sempre la mia passione predominante, la mia vita musicale, di fatto, non haassunto un vero interesse che dal momento in cui, abbandonando la città natale, presi stabiledimora a Roma”, Ibid., p. 11.16 Guido di San Martino e Valperga (21 febbraio 1834-11 agosto 1916) fù nominato senatore delRegno il 7 giugno 1886. edi Alberto Basso in questo volume.
386
silvia cecchini “non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
387
la droiture, la noblesse du caractère, la bonté, la simplicité de cet être m’avaitinspiré une amitié durée pendant un demi siècle”.14
L’innovazione nella Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti“Certo nelle varie occupazioni che ho avuto nella mia esistenza – scrive il contenei Ricordi – la musica rimase sempre la preferita. Fu questa l’attività che mi o∂rìmaggiori soddisfazioni e che mi permise, io credo, di svolgere un’opera non inu-tile per l’arte italiana”.15
L’azione svolta a favore della musica fu assolutamente prioritaria. Tuttaviacredo non sia possibile conoscere il personaggio, né tanto meno le strategie e leragioni ultime del suo operare, senza indagarne l’opera complessiva, rivolta adambiti molto diversi tra loro, dalle arti alla produzione industriale. Compren-dendo quindi, oltre alla musica, anche il teatro e le arti figurative.
A una parte, seppur assai circoscritta, della sua attività dedicata alle arti figu-rative dall’inizio del Novecento agli anni che precedono la prima guerra mondia-le è dedicato lo spazio del mio contributo.
Arrivato a Roma dal Piemonte nel 1887, il conte fa presto a inserirsi nelmondo politico e amministrativo della capitale. Le sue abilità nell’intessererelazioni con l’alta società e le conoscenze acquisite anche grazie al padre,Guido San Martino Valperga,16 gli permettono di entrare rapidamente nella vitaculturale romana.
Sarebbe lungo e fuorviante elencare qui le cariche da lui cumulate in queglianni ma, ripercorrendo le attività connesse alle arti figurative, non si può pre-scindere dall’accennare al suo coinvolgimento nell’amministrazione comuna-le. Negli anni che precedono il suo incarico come presidente della Società Ama-tori e Cultori di Belle Arti la stessa nobiltà romana che occupava le più alte cari-che dell’amministrazione capitolina deteneva i ruoli dirigenziali della Societàartistica. Quando, nel 1898, San Martino viene eletto presidente, va a sostituire
17 Nel 1883 era presidente della Società il principe Leopoldo Torlonia, che ricopriva contempora-neamente la carica di sindaco di Roma.18 Nella stessa istituzione ricoprirà, negli anni successivi, importanti cariche fra cui consigliere,censore, vicepresidente, fino alla nomina a presidente nel 1895, alla morte di Ruggiero Bonghi.Vedi Enrico di San Martino, Ricordi, cit., p. 13; Annuario dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,1933-1934, p. 105.19 L’anno seguente verrà incaricato di rappresentare l'Accademia di San Luca ai festeggiamentiorganizzati a Berlino per celebrare il secondo centenario della locale Accademia di belle arti, cfr.Roma, Archivio dell’Accademia di san Luca, vol.160, cc.8, 41, 61.20 Roma, Accademia di san Luca, inv. 190.21 Emanuele Ruspoli viene eletto sindaco di Roma il 7 luglio 1899, vedi Atti del Consiglio Comu-nale di Roma, convocazione straordinaria, seduta pubblica del 3 luglio 1899, pp. 30-31. ProsperoColonna succede a Emanuele Ruspoli nel ruolo di sindaco il 21 dicembre 1899, vedi Atti del Con-siglio Comunale di Roma, convocazione straordinaria, seduta pubblica del 21 dicembre 1899, pp.136-138, e rimarrà in carica fino al 21 ottobre 1904. Enrico di San Martino viene nominato asses-sore supplente con delega all’u∑cio VII competente sulla Polizia urbana e viene inoltre chiama-to a collaborare con l’assessore Enrico Cruciani Alibrandi all’u∑cio VI, per la parte relativa aiservizi storici e artistici, vedi Atti del Consiglio Comunale di Roma, convocazione straordinaria,seduta pubblica del 12 gennaio 1900, p. 15. Cruciani Alibrandi sarà chiamato a svolgere per seimesi, dal dicembre 1904 al 10 luglio 1905, mantenendo il ruolo di assessore, le funzioni di sinda-co e sarà poi eletto sindaco il 10 luglio 1905. A lui seguirà Ernesto Nathan. Sulle vicende dell’am-ministrazione comunale di Roma vedi Giuseppe Talamo, Gaetano Bonetta, Roma nel Novecento.Da Giolitti alla Repubblica, in Storia di Roma, vol. xxxi, Istituto nazionale di studi romani, Bolo-gna, Cappelli, 1987, pp. 109-117.
il sindaco Prospero Colonna e già prima di lui altri sindaci ed ex-sindaci aveva-no ricoperto la stessa carica.17
L’ingresso di San Martino come protagonista nella vita culturale romana nonpuò quindi essere scisso dal suo impegno negli organi amministrativi della città,ove riesce da subito a coagulare l’attenzione su obiettivi connessi alle arti e a con-quistare spazi di azione per alcune istituzioni artistiche cittadine.
Nel 1891 diviene accademico di Santa Cecilia18 e nel 1895 viene eletto accade-mico d’onore dell’Accademia di San Luca,19 ove si conserva ancora oggi un suobusto bronzeo realizzato dallo scultore Filippo Cifariello.20 Già consigliere comu-nale nel 1899 durante il mandato a sindaco di Emanuele Ruspoli, pochi mesi dopo,in seguito alla nomina a sindaco di Prospero Colonna, il conte viene eletto asses-sore supplente, con delega alla Polizia urbana e ai servizi storici ed artistici.21
L’elezione di Prospero Colonna è decretata dalla vittoria dell’Unione liberalesull’Unione romana, a cui fanno riferimento i cattolici. A questa data la contrap-
389
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
Il moltiplicarsi degli impegni che lo conducono spesso lontano da Roma lo spin-ge, nel gennaio 1902, a dimettersi dal ruolo di assessore. Ed è questa la motivazioneesposta nella lettera di dimissioni presentata al sindaco.25 Anche a Roma, in quellostesso anno, gli impegni non sono pochi, vista la concomitanza delle cariche. Presi-dente dell’Accademia di Santa Cecilia, San Martino è impegnato anche come presi-dente della Società Amatori e Cultori di Belle Arti, organizzazione artistica romanadi gloriose origini – nata nel 1829 – da lui presieduta dal 1895 fino al 1910.
La stessa carica, assunta da altri prima di lui come attestazione onorifica, èinvece per San Martino occasione per avviare un processo di trasformazionedella Società Amatori e Cultori e per sostenere l’a∂ermazione culturale dellacapitale a livello nazionale.26 Un processo che risponde, in quel momento, alleaspettative di buona parte del mondo artistico romano.
Fin dalla sua nascita nella Roma papalina, la Società era stata espressione diuna cultura accademica nobiliare e filoclericale, e la sua funzione di stimolo almercato dell’arte contemporanea era stata sostenuta vigorosamente dalla nobil-tà romana, che ne aveva così indirizzato la linea artistica e culturale.27
25 Il 13 gennaio 1902 Enrico di San Martino rassegna le dimissioni dalla carica di assessore:“Costretto da a∂ari importanti ad assentarmi spesso e non brevemente da Roma, reputo assoluta-mente necessario di rassegnare le mie dimissioni da Assessore municipale, non potendo più con-sacrare all’alto u∑cio il tempo necessario per coprirlo degnamente. Voglia il sig, Sindaco acco-gliere i sensi del mio profondo rincrescimento nello staccarmi dall’Amministrazione tanto degna-mente presieduta dalla S.V. e rendersi interprete presso la Giunta ed il Consigli della mia inaltera-bile gratitudine per la costante benevolenza addimostratami”, Atti del Consiglio Comunale di Roma,seduta ordinaria del 13 gennaio 1902, pp. 5-7. Tornerà nuovamente a ricoprire il ruolo di assessorecon le elezioni del 28 novembre 1904.26 Essendo l’archivio della Società Amatori e Cultori di Belle Arti ancora oggi irreperibile, ènecessario ricostruire le scelte e gli indirizzi dati dal conte negli anni della sua presidenza attra-verso l’analisi dei cataloghi delle esposizioni annuali della Società, degli album ricordo, attraversola stampa quotidiana e periodica e la pur rara documentazione specifica reperibile in archivi pri-vati, fra cui il fondo Ettore Ferrari presso l’Archivio centrale dello Stato.27 Vedi Statuto della Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti in Roma, Roma, Antonio Boulza-ler, 1830, ove si stabilisce che la Società “conta la sua esistenza dal dì 24 novembre 1829 in cui SuaEm.nza R.ma il Sig. Card. Camerlengo. Di S.R.C. si degnò approvarla, e accoglierla sotto la validasua protezione”. Al titolo III, comma 5, pp. 6-7, si stabilisce che “per ciò che riguarda la convenien-za delle opere, in quelle parti che si riferiscono alla morale, ed alla politica” esse verranno giudica-te da una Deputazione composta dal presidente e da due consiglieri nominati dal cardinal Camer-lengo. Vedi inoltre Rosella Siligato, Le due anime del palazzo: il Museo artistico industriale e la Società
posizione tra le due forze politiche è assai meno rigida di quanto non sia stata inpassato. Lo testimonia il fatto che la nuova Giunta è composta da sette assessoriin carica dello schieramento liberale e tre clericali e, fra gli assessori supplenti, dadue liberali e due clericali.22 Di fatto – come ricostruito da Giuseppe Talamo eGaetano Bonetta – a quest’epoca la maggioranza liberale attua una politica dicompromesso cercando l’accordo con l’Unione romana.
In questo clima politico i numerosi interventi di San Martino in Consigliocomunale si distinguono per diplomazia e lucidità strategica.23 Mostra da subito,e per tutti gli ambiti artistici dalla musica al teatro alle arti figurative, una visionecomplessiva in cui gli obiettivi culturali non sono mai disgiunti dall’analisi delcontesto amministrativo, politico, economico, sociale.24
silvia cecchini
388
22 Alle elezioni sono presenti settantacinque consiglieri su settantotto e l’Unione liberale vinceper quarantuno voti contro trentaquattro, vedi Talamo, Bonetta, Roma nel Novecento cit., p. 110.23 Da subito impegnato sui temi legati all’arte e al suo sviluppo in relazione all’amministrazionedella città, conduce un importante intervento nel 1899 a favore di una riorganizzazione del Comi-tato storia ed arte, organo comunale chiamato a decidere sia degli acquisti delle opere d’arte chedell’organizzazione delle esposizioni e dei restauri. Sul tema cfr. Silvia Cecchini, Necessario e supe-rfluo. Il ruolo delle arti nella Roma di Ernesto Nathan, Roma, Palombi, 2006, pp. 30-32. 24 Emblematico del pensiero di San Martino è il metodo da lui seguito nel proporre, come consi-gliere comunale, il finanziamento del Teatro lirico. Nell’intervento del 15 maggio 1903, a sostegnodella propria proposta, espone assieme ragioni di ordine culturale ed economico: “convinto dellanecessità di assicurare il funzionamento di un teatro lirico, non solo per ragioni di tradizionaledecoro artistico, ma ancora per il vantaggio d’indole economica che ne deriva alla città ed a mol-teplici classi di cittadini, invita il Sindaco ad aggregarsi quelle persone di speciale competenza,che egli crederà utili, per compilare e presentare, prima della fine della sessione, un progetto con-creto sulla questione, promovendo all’uopo anche il concorso di tutti gli Enti, cui sta a cuore ladignità di Roma e dell’Arte italiana”, in Atti del Consiglio Comunale di Roma, seduta ordinaria del 15maggio 1903, pp. 21-27. La mozione viene approvata a grande maggioranza e nella discussione suc-cessiva, il 18 maggio, pone nuovamente l’accento sul vantaggio economico per la città: “altreragioni di ordine economico non hanno minore importanza. In Roma accorrono circa centomilaforestieri all’anno, la più gran parte dei quali non avendo conoscenze, non sa dove passar la serataed uno spettacolo di prim’ordine costituirebbe per essi tale attrattiva, da prolungare la loro per-manenza in città con sensibile vantaggio del bilancio economico locale”. Sottolinea inoltre i van-taggi connessi all’occupazione, adducendo a prova i dati sull’impiego connesso all’attività teatralerelativi a Milano. Vedi Atti del Consiglio Comunale di Roma, seduta ordinaria del 18 maggio 1903, pp.70-76, in particolare p. 70. Sull’ attività di San Martino per il teatro di prosa e musicale vedi i con-tributi di Luca Aversano e di Marcello Ruggeri in questo volume.
Società ‘In Arte Libertas’ – Società degli Acquarellisti – Associazione fra i Cultori di Architettura.[…] Se il successo della mostra fu notevole finanziariamente, fu grandissimo moralmente, essen-dosi potuto e∂ettuare quell’a∂ratellamento fra le diverse associazioni artistiche della Capitale,tanto desiderato quanto insperato negli anni precedenti. L’augurio vivo che noi facciamo è cheprosegua e si ra∂orzi per l’avvenire questa unione, a∑nché nella cooperazione di tutti, Romagiunga ad avere una grande Esposizione di Belle Arti degna del suo nome e delle sue tradizioni.”Nel testo già compare la determinazione nel realizzare a Roma un’esposizione di richiamo nazio-nale, obiettivo che si concretizzerà negli impegni futuri.29 L’ambizione di portare Roma a competere con Venezia, che dal 1895 detiene il primato per l’a-pertura alla scena artistica internazionale, verrà sottolineato più tardi da Ugo Ojetti, Le esposizionidi Roma, ovvero i Capuleti e i Montecchi, in “Corriere della Sera”, 18 aprile 1913. 30 Il catalogo della mostra, pubblicato come un numero della rivista “Vita Nova” indica, a di∂e -
degli Amatori e Cultori di Belle Arti, in Rosella Siligato, Il Palazzo delle Esposizioni: urbanistica e archi-tettura, Carte Segrete, Roma 1990, p. 165-181. Vedi inoltre Pasqualina Spadini, Lela Djokic, Societàdegli Amatori e Cultori tra Otto e Novecento, catalogo della mostra (Galleria Campo dei Fiori, aprile1998), Roma, s.e., 1998.28 Vedi Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti, Catalogo delle Esposizioni riunite della SocietàAmatori e Cultori di Belle Arti, dell’Associazione degli Acquarellisti, In Arte Libertas e dei Cultori di Archi-tettura, Roma, Tipografia D. Squarci, 1900. Che San Martino perseguisse quest’obiettivo già daqualche tempo è attestato dal suo scritto introduttivo all’Album ricordo della LXVIII esposizione(1898), Roma, Fototipia Danesi, p. 1:“Preoccupati del concorso modesto di visitatori alle diverseesposizioni di Belle Arti, che di consueto si tengono in Roma dalle varie associazioni artistiche,causa la pluralità di dette esposizioni in uno stesso anno, la Presidenza e il Consiglio direttivodella Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti ebbero in animo di riunire in una sola mostra iprodotti dei diverso gruppi artistici della Capitale. Se felice era l’idea, non facile l’e∂ettuazione.Tuttavia un brillante risultato coronò le lunghe e di∑cili trattative. Accettarono l’invito ed invia-rono le loro opere all’Esposizione indetta dalla nostra Società per l’anno 1898, i sodalizi seguenti:
390
silvia cecchini
L’impegno di San Martino nella Società inizia in un periodo in cui il mondoartistico romano è lacerato da vivaci polemiche locali tra organizzazioni diverse– Società Amatori e Cultori, Associazione degli Acquarellisti, Associazione ArtisticaInternazionale e In Arte Libertas di Nino Costa – che non riescono tuttavia adesprimere una proposta innovativa. A Roma la carenza di luoghi espositivicostringe gli artisti a mostrare le opere a pochi selezionati visitatori nel chiusodei loro studi privati o nei negozi degli antiquari, una condizione che penalizzain modo particolare i giovani artisti. La di∑coltà nel creare occasioni di fruizio-ne allargata li porta a confluire numerosi nell’unica esposizione romana, orga-nizzata dalla Società degli Amatori e Cultori. Al malcontento dei giovani sisomma un’insoddisfazione di∂usa verso la rinuncia da parte delle istituzioniartistiche romane ad accogliere mostre internazionali, costringendo così ilmondo artistico cittadino in un clima di conformistico provincialismo. Ne deri-va un clima culturale che lascia insoddisfatte le aspettative di giovani artisti, cheemigrano numerosi verso altre città, come Venezia, Milano, Parigi.
Una volta nominato presidente, San Martino inizia a tessere la tela del suo pro-getto di rinnovamento. Vuole mettere insieme tutte le forze più vivaci e in e∂ettiriesce, tra il 1898 e il 1900, a unire sotto l’egida della Società tutte le associazioniartistiche romane. Occasione per ricomporre vecchi e nuovi dissidi è una mostraconsiderata da subito un evento, e non solo per la quantità di opere esposte, ben751.28 [v. foto 3] L’intento è addirittura dare scacco alle biennali veneziane inseren-
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
391
do nella mostra romana una personale di Costantino Barbella, artista che l’annoprecedente aveva esposto in quella di Venezia.29 San Martino vuole aprire, attra-verso la Società, il mondo artistico romano agli stimoli e alle esperienze interna-zionali, e persegue l’obiettivo fino a quando, nel 1903, riesce a cambiare l’imposta-zione e il nome delle esposizioni, da nazionali a internazionali.
La sua strategia di innovazione segue la via della conciliazione e della diplo-mazia, cerca il consenso della stampa e delle istituzioni. Vuole attirare imprendi-tori, acquirenti, pubblico, mettendo in atto quella che oggi chiameremmo unagrande attività di lobbing.
La mostra del 1901 riscuote un buon successo. Il catalogo, pubblicato all’in-terno della rivista “Vita Nova”, contiene lodi rivolte sia alla mostra che all’ope-ra:“L’esposizione di quest’anno è, a parere di tutti gli intelligenti d’arte, assaimigliore di quella dell’anno scorso. […] tutto sommato, adunque, v’è da sperareche l’odierna mostra, così com’è segno non dubbio, nelle varie manifestazioniartistiche, di un progressivo continuo miglioramento, dia pur buoni risultatifinanziari da ripromettere non lontano il giorno in cui anche in Roma le esposi-zioni promotrici raggiungeranno quella importanza cui si aspira. Non chiudere-mo questo cenno sintetico senza tributare ben meritate lodi al conte di San Mar-tino che tanto contribuì, quale presidente della Società degli Amatori e Cultori diBelle Arti, con l’ingegno e l’attività esemplari, ai lieti successi della passata e pre-sente mostra: come non sapremmo tacere della somma negligenza, del niunamore per l’arte dell’Amministrazione del Comune, che relegava l’Esposizionenella parte più infelice di quell’edificio che per essa appunto fu innalzato”.30 Se sitiene conto che San Martino ricopre ancora nel 1901 il ruolo di assessore sup-
32 Vedi Atti del Consiglio comunale di Roma, sedute ordinarie del 15, 24, 28 novembre 1904. L’8luglio viene approvata la legge titolata “Provvedimenti per la città di Roma”, n. 320. Sull’impattodella nuova legge emanata da Giolitti vedi Talamo, Bonetta, Roma nel Novecento, cit., p. 111 e ItaloInsolera, Roma moderna, Torino, Einaudi 1993, p. 79; Antonio Parisella, Le leggi speciali per Romanel Novecento, in L’amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie,storiografia, a cura di Marco de Nicolò, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 163-200.33 La designazione degli assessori avviene con votazione del 28 novembre 1904 (vedi Atti del Con-siglio comunale di Roma, seduta ordinaria del 28 novembre 1904, pp. 143-149) e l’assegnazione dellecompetenze avviene quasi un mese dopo (vedi Atti del Consiglio comunale di Roma, seduta ordina-ria del 23 dicembre 1904, pp. 151-154). Secondo quanto ricostruito da Laura Francescangeli, finoalla deliberazione di giunta n. 19 del 26 settembre 1906 che riordina e definisce le attribuzionidella Sezione storia ed arte, all’U∑cio vi a∑dato ad Enrico di San Martino competeva essenzial-mente di “coadiuvare per la parte amministrativa ed esecutiva il ‘Comitato generale di storia edarte’, organo consultivo tecnico, composto di esperti dei diversi settori (eruditi, archeologi, pitto-ri, scultori, architetti, ecc.)”, vedi Laura Francescangeli, Fonti archivistiche per la storia dell’ammini-strazione comunale dopo il 1870 nell’Archivio storico capitolino, in L’amministrazione comunale di Roma,cit., pp. 317-318. Alla riorganizzazione del Comitato aveva contribuito nel 1899 lo stesso San Mar-tino (vedi Archivio Storico Capitolino, Roma, Fondo x Ripartizione (1907-1920), titolo 1, b. 1.Fasc. 1; Cecchini, Necessario e superfluo, cit., p. 30); la struttura era stata successivamente riorga-nizzata e resa più snella nel 1900 (delibera di Giunta n. 8 del 16 giugno 1900). 34 Con l’astensione di una parte del Consiglio fermamente contraria alla formazione della “giun-ta mista”, di cui fa parte il repubblicano e massone Ettore Ferrari che fa esplicita dichiarazione dinon voto, su 59 votanti la maggioranza assoluta viene ottenuta da una Giunta così composta: Cru-ciani Alibrandi voti 42, Di San Martino e Valperga Enrico voti 41, Iacovacci Francesco voti 41,Benucci Francesco Saverio voti 41, Giovenale Giovanni Battista voti 41, Persichetti Augusto voti41, Berti Vincenzo voti 40, Palomba Carlo voti 40, Salvati Giovanni Battista voti 39, FranchettiSimone Enrico voti 39. Vedi Atti del Consiglio Comunale di Roma, seduta ordinaria del 28 novembre1904, p. 147 e sgg.
renza dell’anno precedente, la Società Amatori e Cultori come istituzione promotrice, mentre lealtre associazioni come aderenti all’esposizione: Esposizione di Belle Arti della Società degli Amatori eCultori. Associazioni aderenti: In Arte Libertas, Acquarellisti, Roma (Palazzo delle Esposizioni,aprile-giugno 1901), Roma 1901, p. 1.31 Ivi, pp. 3-4.
392
silvia cecchini
plente, il commento rivolto all’Amministrazione comunale appare, anche allaluce dei fatti che seguiranno, un suggerimento che diverrà suo intento program-matico. Sarà proprio grazie al suo impegno ancor più attivo all’interno dell’Am-ministrazione che la Società otterrà risultati allora inimmaginabili.
Oltre a riconoscere i meriti dell’organizzatore e a denunciare problemi di spa-zio, l’anonimo autore entra nel merito delle questioni d’arte e contesta l’atteggia-mento della critica d’arte contemporanea: “altro fatto ingiustificabile si è chemolti critici siano esclusivisti in sommo grado; biasimano, per deplorevole siste-ma, tutto ciò che s’allontana dai loro criteri, andando così contro i principii ele-mentari dell’estetica moderna, la quale vuole sieno considerate tutte le opered’arte come fatti e prodotti di cui si devono rilevare i caratteri e ricercare le causesenza preconcetti contro scuole o tendenze, ma devesi d’ogni opera d’arte direcon serenità e indi∂erenza. Vuolsi, insomma, ammettere pei fini suoi ogni formad’arte, quando sia giusta e schietta emanazione di un temperamento artistico”.31
Visto il temperamento autocratico del conte e i suoi modi accentratori, è diffi-cile immaginare che l’anonimo autore non avesse concordato con lui il testo pub-blicato sul catalogo della mostra del 1901, seppur inserito all’interno di una rivi-sta. Se così è, non si può trascurare che in quell’articolo l’autore si pronunci afavore dell’ “estetica moderna” e di un’apertura all’innovazione in ambito arti-stico che non riusciva allora a trovare alcuno spazio di azione nel contesto roma-no. Il rinnovamento che San Martino ha in mente non è obiettivo che si ottengarapidamente. I frutti della sua strategia si osservano attraverso gli anni e sono ilportato di un abile attento lavoro nella creazione di relazioni, nell’orientamentodi investimenti e nella scelta di indirizzi culturali.
Il segno di quel rinnovamento lo leggiamo anche nelle trasformazioni appor-tate alle copertine dei cataloghi che documentano le esposizioni annuali dellaSocietà: dal 1903 si ingentiliranno con cornici in stile art nouveau e dal 1908 sianimeranno di figure simboliche: un cavallo alato rampante che evoca la creati-vità e l’ispirazione artistica viene tenuto al morso da due figure femminili, lapittura e la scultura. [v. foto nn. 4, 5, 6]
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
Nell’estate del 1904 la Giunta comunale presieduta dal sindaco EmanueleRuspoli entra in crisi. Indebolita dalle gravi di∑coltà di bilancio, si impegnacomunque a rimanere in carica fino all’approvazione, da parte del Governo, diuna legge straordinaria che risani le gravi condizioni finanziarie del Comune.Una volta approvata la legge l’8 luglio 1904, il 21 ottobre la Giunta si dimette eviene sostituita da una “giunta mista”.32 Nel novembre del 1904 il conte assumeancora una volta la carica di assessore comunale e riceve l’a∑damento dell’u∑ciovi Storia ed arte.33
I risultati delle votazioni tenute il 28 novembre dimostrano quanto ampio siail consenso che San Martino è riuscito a convogliare attorno a sé.34
393
37 Ibid.38 Vedi nota 24.39 Atti del Consiglio Comunale di Roma, seduta ordinaria del 19 gennaio 1906, p. 87.40 Ivi, pp. 88-89.
35 Atti del Consiglio Comunale di Roma, seduta ordinaria del 19 gennaio 1906, p. 86.36 Ivi, p. 87.
394
silvia cecchini
Ricoprire la carica di assessore vuol dire, per San Martino, ottenere nuovispazi d’azione per promuovere la propria linea strategica sulle arti e sull’econo-mia della cultura. I risultati non tardano a manifestarsi. Nella varietà dei temia∂rontati, e di cui troviamo traccia negli atti delle discussioni del Consigliocomunale, uno riguarda proprio la Società degli Amatori e Cultori, ed è indicati-vo di un passaggio cruciale della storia della Società e di alcuni tratti essenzialidel carattere politico e diplomatico di San Martino.
La mozione presentata in Consiglio comunale dal consigliere Adolfo Apolloniil 19 gennaio 1906, partendo dal problema della carenza di spazi per le esposizio-ni artistiche, arriva a perorare la causa della Società Amatori e Cultori adducendomotivazioni che rispecchiano perfettamente il pensiero di San Martino.
Apolloni apre la mozione contestando l’uso del Palazzo delle esposizioni invia Nazionale. Illustra come, una volta costruito, il palazzo sia stato sede di duegrandi esposizioni e poi, mentre alcune parti dovevano essere ancora completa-te, sia caduto in disuso fino ad essere utilizzato come deposito e sede di esposi-zioni campionarie. Deplora che per le numerose sale adibite a deposito della Gal-leria d’arte moderna sia stato corrisposto un prezzo irrisorio di 15.000 lire, stan-ziate come finanziamento pubblico. Riferisce che in alcuni spazi rimasti liberi sisvolsero annualmente le esposizioni della Società Amatori e Cultori, ma le condi-zioni si mostrarono insoddisfacenti. Queste le sue parole: “La Società Promotri-ce iniziò le sue esposizioni in modo molto modesto e progredì in seguito, mercèl’opera dell’illustre suo Presidente Conte di San Martino, Assessore municipale,ma rimanendo tuttavia in limiti molto ristretti, per deficienza di mezzi. Sicchéquelle esposizioni non possono tenersi rispondenti al decoro artistico di una cittàcome Roma”.35 Se la Società, dotata di mezzi limitati, è pertanto nell’impossibi-lità di “fare esposizioni degne di stare a confronto con quelle di altre città”, perApolloni si deve aver chiaro che “Roma, che è stata maestra e faro del bello, nondeve rimanere al di sotto delle più piccole città d’Italia e dell’estero”.36 Il provve-dimento da lui proposto consiste, innanzitutto, nell’allontanare dal Palazzo laGalleria d’arte moderna; quindi nel completare le parti mancanti dell’edificio enel destinarlo esclusivamente “alle arti belle ed a quelle applicate alle industrie,che oggi occupano il posto più bello e più decoroso e che costituiscono la ricchez-
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
395
za di altre Nazioni”.37 È da notare che, nell’auspicare l’appoggio del Consiglio,Apolloni fa riferimento alla battaglia vinta a favore del teatro lirico, di cui pro-prio San Martino era stato protagonista nel 1903.38
Anche altri temi sollevati da Apolloni a sostegno della mozione richiamano inmodo evidente le argomentazioni assai spesso addotte da San Martino, non ulti-mo il tema dell’internazionalismo –“Tal genere di esposizioni dovrebbe farsi coningresso spesso gratuito, sempre a prezzo popolare, come si fa a Londra nel WhiteChapel Art Gallery ed al Louvre nell’Exposition des primitifs”– o ancora il tema del-l’educazione popolare – “Devesi entrare a bandiere spiegate nel palazzo delleesposizioni, largheggiando in mostre delle varie specie, dalle arti retrospettivealle arti moderne, a∑nché il popolo possa ritrarre da esse salutare insegnamentoed a∑nché risorgano le gloriose tradizioni artistiche di Roma”.39
Terminata la perorazione di Apolloni, in appoggio alla mozione si susseguonogli interventi dei consiglieri Galli, Casciani, Aureli, Staderini. Solo a questopunto, quando il tono dei pronunciamenti fa già intuire l’approvazione della pro-posta, Enrico di San Martino interviene con una dichiarazione da considerareindicativa del suo metodo: “I concetti espressi dai vari consiglieri rispondonoperfettamente ai desideri della Giunta. […] Anche l’Amministrazione, come sivede, riconosce la necessità del trasloco della Galleria, ma deve tuttavia cercaredi non mettere in imbarazzo il Governo. Le trattative saranno riprese e condur-ranno certo ad un risultato soddisfacente, se un voto del Consiglio verrà ad inco-raggiare la Giunta”.40 Il conte sollecita cioè l’appoggio del Consiglio comunale afavore dell’azione che lui stesso, in quanto assessore competente, dovrà condur-re all’interno della Giunta per convincerla a votare l’estromissione delle varieassociazioni e della Galleria d’arte moderna dal Palazzo delle esposizioni.
Appoggiata la proposta relativa all’uso degli spazi del Palazzo, San Martinovuole prendere posizione in modo esplicito anche sulla necessità di istituire aRoma esposizioni d’arte che possano reggere il confronto con quelle di altre cittàitaliane e straniere. A questo proposito dichiara: “l’Amministrazione non puònon plaudire all’iniziativa degli artisti”. Egli legittima così le richieste e si fa
sono proposti, nella loro qualità di componenti del consiglio direttivo o della giuriadi accettazione, di svecchiare l’annosa società e di rinnovarla profondamente.43
Nel 1909 il successo del cambiamento è attestato anche dalla nuova a∏uenza diartisti stranieri, richiamati per la prima volta dal buon nome che la Società èriuscita a costruirsi anche a livello internazionale.44 Sono esposte opere di MaxKlinger, Auguste Rodin, Felicien Rops, Jan Toorop, Edvard Munch.
Arturo Lancellotti, su “Emporium”, lo definirà “un rinnovamento fecondonon solo negli ideali artistici, ma anche nelle disposizioni regolamentari e neicriteri amministrativi, che sono tanta parte del successo di una esposizione”, unrinnovamento da cui deriva “alle nostre mostre attuali di belle arti una costanteelevazione che si traduce in un progressivo e notevole aumento delle vendite”.45
L’anno successivo, il 1910, Arduino Colasanti scrive ancora su “Emporium” aproposito della Società Amatori e Cultori:“vecchia di anni, ma ringiovanita neipropositi, da quando la fede di pochi uomini intese che una esposizione non vive difacili vittorie, ma deve essere centro di progresso, di emulazione ardente, di educa-zione civile e, rompendo risolutamente la vergognosa tradizione delle compiacen-ze e del disordine, lottando con l’indi∂erenza delle autorità, […] con la di∑denzadel pubblico, con le di∑coltà finanziarie più aspre, seppe raccogliere le migliorienergie, disciplinandone gli sforzi prima disuniti. Contro questa organizzazione,[…] cerca di muover guerra lo scontento dei disillusi, ma ogni armeggìo è destinatoa cader nel vuoto, perché, fortunatamente, indietro non si torna”.46 La convinzio-
397
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
forte, di fronte alla Giunta, dell’approvazione unanime del Consiglio.41 La batta-glia è vinta. Ed è chiaro che quella condotta da Apolloni è una battaglia anche sua.
Dopo il pronunciamento del Consiglio e della Giunta, San Martino porterà acompimento prima dell’estate l’iniziativa, ottenendo che lo spazio dell’interopiano superiore del palazzo destinato alla Galleria d’arte moderna venga ridottoad un’unica stanza. La capacità politica e diplomatica di San Martino emergeanche nella sua abilità a creare alleanze. Il suo intento di dare nuova forza allaSocietà Amatori e Cultori viene condiviso dal sindaco che, tra il 1907 e il 1908, siadopera per allontanare dal Palazzo la Società degli acquarellisti, lasciando cosìpadrona indiscussa del Palazzo la Società degli Amatori e Cultori.42 Il passo suc-cessivo è la trasformazione interna della Società.
San Martino sigla un’alleanza con un gruppo di giovani artisti – fra cui Giaco-mo Balla – che di lì a poco entreranno negli organi dirigenziali della Società.Assieme a loro avvia una nuova fase del processo di rinnovamento. È un rinnova-mento graduale, come si evince dai discorsi di San Martino pubblicati sugli Albumricordo annuali delle Esposizioni. Ma è un rinnovamento che trasforma profon-damente il mondo artistico che ruota attorno alla Società, dalle esposizioni fino almercato delle opere. Ne troviamo eco nella stampa quotidiana e periodica. CosìVittorio Pica nel 1909 su “Emporium”:
Il successo vivo, schietto e quasi unanime che ha ottenuto, fino al suo primo aprire leporte al pubblico, la lxxix esposizione degli ‘Amatori e cultori di belle arti in Roma’deve riuscire di conforto e d’incoraggiamento a quel gruppo di animosi, i quali si
silvia cecchini
396
41 Ivi, pp. 89-90. L’ordine del giorno approvato prevede che “l’Assessore [San Martino] vogliaprovvedere nel più breve tempo possibile alla disponibilità del Palazzo per l’Esposizione dellebelle arti ed a presentare un progetto di compimento e di adattamento del medesimo, in modo dapoter essere decorosa sede d’importanti mostre annuali d’Arte, anche applicata, sotto gli auspicidel Comune, di Congressi scientifici ed artistici, di conferenze, di concerti popolari, e di provve-dere in genere, come edificio, alle esigenze di una grande città”. 42 Vedi Siligato, cit., pp. 165-181, in particolare pp. 176 e 18. La Siligato rimanda a documenti con-servati presso l’Archivio storico capitolino (lettera del sindaco al ministro della pubblica istruzio-ne, 16 luglio 1906 e corrispondenza tra il sindaco e la Società degli acquarellisti intercorsa tra il1907 e il 1908) che dalle collocazioni archivistiche riportate non è stato possibile reperire nelnuovo inventario. Documenti che attestano l’allontanamento dell’Associazione degli acquarelli-sti dal Palazzo delle belle arti sono stati reperiti in Roma, Archivio storico capitolino, U∑cio vi,serie I, b. 128, fasc. 27, titolo 66, Esposizioni, 190. Richiesta non accolta per esposizione dal febbraio almaggio 1906.
43 Vittorio Pica, L’Esposizione degli Amatori e Cultori di Belle Arti in Roma: gli stranieri, in “Empo-rium”, xxix, n. 171, marzo 1909, pp. 163-176.44 È quanto Pica scrive:“E di conforto e di non scarsa soddisfazione al loro amor proprio di ordi-natori intelligenti e zelanti deve riuscire il concorso vario, eletto e numeroso all’odierna mostra dipittori, scultori e incisori stranieri di chiara fama, con quadri, statue e stampe di non comune inte-resse artistico. Anche nella mostra dell’anno scorso vi era una piccola falange di artisti stranieri,ma essi erano per la maggior parte artisti dimoranti in Roma o pittori alemanni attratti dal vistosopremio Muller [...] mentre invece stavolta gli artisti che hanno mandato le loro opere da Parigi oda Londra, da Berlino o da Pietroburgo, dall’Aia o da Bruxelles, da Stoccolma o da Cristiania nonsono stati richiamati che dal buon nome che ha saputo procurarsi anche all’estero, con le suemostre più recenti, la società romana”, in Pica, L’Esposizione ..., cit., marzo 1909, pp. 163-176.45 Arturo Lancellotti, Le esposizioni di Belle Arti a Roma. La mostra della Società Amatori e Cultori. LaSecessione, in “Emporium”, xxvii, n. 222, giugno 1913, pp. 424-443, in particolare p. 427.46 Arduino Colasanti, L’Esposizione internazionale d’arte in Roma, in “Emporium”, xxxi, n. 185,
L’avvio di una nuova impresa: la SecessioneL’e∂ettiva estromissione di San Martino dalla Società avviene – secondo quantoricostruito da Rosella Siligato – tra gennaio e febbraio del 1911, anno in cui lamostra della Società viene annullata per lasciare spazio all’esposizione interna-zionale per la celebrazione del cinquantenario dell’unità d’Italia. Il grande even-to fa di Roma, per un anno, un centro propulsivo e di richiamo a livello nazionalee internazionale. Enrico di San Martino ne è presidente e il successo della mani-festazione è la sua risposta – potrei dire la sua rivincita rispetto alla sconfittainflittagli dalle forze localistiche ed anti-internazionaliste interne alla SocietàAmatori e Cultori.49
Al successo delle manifestazioni del 1911 hanno contribuito in modo determi-nante i contatti instaurati dal conte sia sul piano politico che culturale e CorradoRicci è stato ancora una volta suo buon alleato.50 A riconoscimento del successoottenuto, San Martino viene nominato senatore del Regno51 e la conclusione del-l’Esposizione viene celebrata con un banchetto indetto in suo onore per la fine digiugno.52
Per San Martino l’esperienza del 1911 è un’importante occasione per mostra-re le proprie abilità. E a coglierne il valore sia organizzativo che manageriale sonoanche gli artisti. Tre mesi dopo la conclusione dei festeggiamenti, nel marzo del
399
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
ne di Colasanti – “indietro non si torna” – verrà contraddetta, di lì a poco, dai fatti. La parte più tradizionalista della Società non si rassegna al cambiamento
impresso dal sodalizio tra San Martino e quei giovani artisti. L’aumento dellevendite alle esposizioni, la maggiore disponibilità del mercato a nuove tendenzedeterminano l’acuirsi delle tensioni interne fra innovatori e conservatori. E cosìnel 1910, con un colpo di mano, Enrico di San Martino viene destituito dalla cari-ca di presidente della Società a favore del duca Leopoldo Torlonia, che già in pas-sato aveva ricoperto quell’incarico. In una lettera a Boccioni, Balla preannunciaall’amico il “nuovo avvenimento della Società Amatori e Cultori di via Naziona-le” e lo avverte che l’Associazione si è “purtroppo rinnovata con la vittoria dimestieranti ciociareschi e cardinali”.47
Un punto di vista in linea con quello di Balla emerge dalle parole di Lancellot-ti che, nel ripercorrere gli eventi di quell’anno, scriverà:“Ma è naturale che illivello di una esposizione non si tiene alto senza il sacrificio di molte ambizioni edi molti interessi, i quali un bel giorno si coalizzarono, diedero l’assalto alla pre-sidenza della Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti, con la violenza delnumero predominante si impadronirono di tutte le cariche direttive e si studia-rono subito di far rientrare trionfalmente nelle mostre romane tutta la zavorracommerciale che da qualche anno si tentava di tenere lontana”.48
silvia cecchini
398
maggio 1910, pp. 375-393.47 La lettera di Balla a Boccioni viene datata dall’autore al 1910, datazione con la quale concordo.Vedi G. Lista, Balla, Modena, Galleria Fonte d'Abisso, 1982, p. 471. 48 A. Lancellotti, Le esposizioni cit., pp. 424-443, in part. 427. Vedi anche R. Siligato, Le dueanime... cit., pp. 177-178 ove chiarisce che il colpo di mano venne orchestrato grazie a un articolodel regolamento sociale, il n. 35, che stabiliva: “I soci che hanno esposto in almeno tre mostreinternazionali o in cinque grandi mostre nazionali, o in cinque tra internazionali e nazionali, oche abbiano conseguito onorificenze in grandi mostre estere o italiane, o che infine abbianoqualche opera in una galleria nazionale, italiana o estera, hanno il diritto di esporre un’opera aloro scelta con ogni sezione dell’Esposizione, senza sottostare all’esame della Giuria. Se deside-rano esporne più d’una, debbono per le altre sottoporsi a tale esame”. La Siligato indica nel conteLemmo Rossi-Scotti la persona che assieme al duca Leopoldo di Torlonia organizzò l’estromis-sione di San Martino firmando il nuovo statuto inclusivo dell’articolo 35, che riferisce sia statovotato nelle assemblee straordinarie del 17 e 23 gennaio e del 4 febbraio 1911. L’inaccessibilitàdella documentazione dell’Archivio storico capitolino, dovuta a lavori di ristrutturazione, nonha reso possibili le opportune verifiche e approfondimenti su questo episodio.
49 L’esperienza di Enrico di San Martino alla presidenza dell’Esposizione del 1911 merita un’analisi piùapprofondita e per la quale le ricerche sono ancora in corso. Per una ricostruzione dell’Esposizione vediin particolare Roma 1911, a cura di Gianna Piantoni, catalogo della mostra (Roma 4 giugno-15 luglio1980), Roma, De Luca, 1980, ove l’evento viene analizzato nelle sue molteplici articolazioni, ma la figuradel conte viene considerata solo marginalmente. Cfr. inoltre il saggio di Antolini in questo volume.50 Ritengo che la lettera inviata da San Martino a Corrado Ricci, conservata in Ravenna, Bibliote-ca Classense, Archivio Ricci, datata 1 agosto 1911, prot. 32740, in cui lo ringrazia di aver fatto pres-sione sul ministro perché acquistasse quadri della collezione, si riferisca agli acquisti statali delleopere esposte all’Esposizione internazionale da lui presieduta per i festeggiamenti del cinquante-nario. Riporto qui il testo della lettera: “Ho appreso la parte che hai avuto per spingere il Ministroall’acquisto delle collezioni il che rappresenta per noi una grande risorsa, e non voglio tardare aringraziartene a∂ettuosamente tanto in nome mio quanto in quello del Comitato”.51 La nomina avvenne quindi per meriti acquisiti nel lavoro svolto per l’Esposizione e non percenso, come ho scritto in Cecchini, Necessario e superfluo, cit., p. 122.52 Vedi Ravenna, Biblioteca Classense, Archivio Ricci, lettera del presidente del Comitato orga-nizzatore del banchetto in onore di San Martino, 15 giugno 1911, prot. 32741; lettera di Ricci, 23giugno 1911, prot. 32742 in risposta alla lettera del Comitato ordinatore per il banchetto in onoredi Enrico di San Martino.
che con lui avevano dato vita al rinnovamento della Società Amatori e Cultori.Ma ora sono ancor più numerosi e gli chiedono di essere il presidente del loromovimento, di garantire alla Secessione l’attenzione di acquirenti e finanziatori,delle istituzioni, della stampa e del pubblico.
San Martino accetta la proposta56 e assume la presidenza della Secessionenonché, assieme a Camillo Innocenti, l’incarico di curare i contatti internaziona-li del movimento. Nella mostra del 1913 riesce a portare a Roma gli Impressioni-sti. Il dipinto più discusso della disomogenea esposizione è I pesci rossi di Matis-se. Il clamore suscitato dall’opera è tale che anche i Reali decidono di andare all’e-sposizione, accompagnati dal conte che illustra loro il dipinto.57
La prima mostra della Secessione prosegue l’impostazione già avviata da SanMartino nelle mostre della Società Amatori e Cultori del 1909 e 1910: internazio-nalismo e attenta apertura all’innovazione.
San Martino e i secessionisti avevano in progetto di esporre quell’anno anchele opere dei secessionisti viennesi, ma il loro diniego, motivato da precedentiimpegni, mette ancor più in risalto la presenza degli impressionisti. Con la loropresenza l’obiettivo di portare un importante movimento internazionale sullescene romane può comunque considerarsi raggiunto.58
401
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”silvia cecchini
400
1912, un particolare evento sta ad indicare quanto forte sia il sodalizio che èriuscito a instaurare con gli artisti più innovatori della Società Amatori e Cultori.Il pittore Camillo Innocenti53 gli propone, a nome di un gruppo di giovani artistie con la compiacenza di Ettore Ferrari,54 di capitanare una nuova ardita impresa,la Secessione.55 Alcuni di loro sono ben noti a San Martino poichè sono gli stessi
53 A quest’epoca Camillo Innocenti è già un pittore a∂ermato. Il suo successo è sancito da unaserie di riconoscimenti, prima per il dipinto I costumi di Scanno esposto a Venezia nel 1905 e a Mila-no nel 1906, poi per l’esposizione di una sua opera a Venezia nel 1907 e, ancora a Venezia alla Bien-nale del 1909, per la mostra presentata da Ugo Ojetti, quindi per la partecipazione alla Biennaledel 1910 con il compito di ordinatore della sala del Lazio.54 La scelta di Camillo Innocenti di cercare, oltre al coinvolgimento di San Martino, anche l’ap-poggio di Ettore Ferrari, ne denota la scaltrezza nel muoversi all’interno delle dinamiche delmondo culturale e artistico romano. L’ampio potere di Ettore Ferrari nello scenario artistico epolitico della capitale è qui evocabile attraverso il richiamo di alcune delle sue più importanti cari-che: scultore di fama, è consigliere comunale negli anni dell’impegno di San Martino al Comune,ricoprendo anche le cariche di membro del Consiglio direttivo del Museo d’arte applicata all’indu-stria (dal 23 gennaio 1893, cfr. Atti del Consiglio Comunale di Roma, sessione straordinaria del 23 gen-naio 1893, pp. 69-71; Atti del Consiglio Comunale di Roma, seduta pubblica del 19 maggio 1893, pp.461.464) e di membro della commissione edilizia (Atti del Consiglio Comunale di Roma, seduta pub-blica dell’8 aprile 1895, pp. 319-321). Poi deputato al Parlamento, sarà direttore dell’Istituto di bellearti di Roma, presidente della Giunta superiore per le belle arti del Ministero e Gran Maestro dellaMassoneria dal 1904 al 1918. Sull’attività politica di Ettore Ferrari vedi Il progetto liberal-democraticodi Ettore Ferrari. Un percorso tra politica ed arte, a cura di Anna Maria Isastia, Roma, Franco Angeli,1997, in cui non si trova notizia dei rapporti tra Ettore Ferrari e Enrico di San Martino. I due, giàincontratisi nel ruolo di consiglieri comunali, avevano anche collaborato in occasione dell’Esposi-zione del 1911, in cui Ettore Ferrari aveva il ruolo di presidente della sezione di Belle Arti.55 Testimonianze dei contatti tra San Martino e i secessionisti emergono dalle carte dell’archiviodi Ettore Ferrari, che attestano anche stretti e a∂ettuosi contatti tra il conte e l’artista massone:Roma, Archivio centrale dello Stato, Fondo Ettore Ferrari, b. 14, fasc. 690, lettera di Camillo Inno-centi a Ettore Ferrari, la lettera è senza data ma databile, per riferimenti interni a questa e ad altrelettere, ai primi tre mesi del 1912: “mercoledì mattina. Carissimo Ettore, il gruppo secessionistami pregò di chiedere un appuntamento al Conte di S. Martino per interessarlo alla Esposizioniche, molto vagamente ancora, desiderano fare in ottobre. Il Conte ci riceverà domani mattina, maio l’ho fatto prevenire a∑nché procuri soltanto di tenere unito se è possibile, questo gruppo nonindi∂erente come valore e che, selezionato un poco, e soprattutto con delle buone aggiunte, ci ser-virà per la grande impresa. Non vedo possibilità di fare Esposizioni ora, e, senza denari, e di que-sto è certo se ne avvedranno, al momento, anche i più entusiasti; ma quello che vorrei è di non dis-perdere questa bella unione di elementi. Se hai qualche cosa da dirmi in proposito scrivi o telefo-nami (153, sempre tra le 8-9 di sera). Tuo a∂.to Camillo”. A distanza di tre giorni da questa lettera
Innocenti scrive ancora a Ferrari:“sabato. Carissimo Ettore, tu avrai già visto S. Martino che tiavrà informato. Il gruppo secessionista è, diciamo le cose chiaramente, un po’ impaziente di bat-tersi, poco riflessivo perciò, e, direi anche pieno di quel coraggio che l’inesperienza può dare. Iot’informerò di tutto e, se sarà opportuno vederci, verrò da te quando e dove ti resterà più comodo.Io li rivedrò col Conte domani mattina. Circa Bruxelles, dopo le ultime lettere, mi sembra sia soloquestione di tempo ma di Pica, invece, temo sempre un poco. Se quest’a∂are di Bruxelles m’avessea sfuggire, non ti nascondo che mi sarebbe assai dannoso! A∂.to tuo Camillo”. Sulla Secessioneromana vedi Secessione romana 1913-1916, a cura di Rossana Bossaglia, Mario Quesada e PasqualinaSpadini, Roma, Fratelli Palombi, 1987; Siligato, Le due anime... cit., pp. 178-179; Cecchini, Necessa-rio e superfluo, cit., pp. 116-124.56 Roma, Archivio centrale dello Stato, Fondo Ettore Ferrari, b. 14, fasc. 690, lettera di CamilloInnocenti a Ettore Ferrari:“2 aprile 1912 , S. Basilio, 13, Carissimo Ettore, la riunione con San Mar-tino andò bene. Il gruppo secessionista si metterà al lavoro con tutte le forze per il 1913. Nel casosolo (che speriamo non avvenga) non si facesse nulla noi nel 1913, si farebbe una mostra in novem-bre. T’accludo lo statuto rimandatomi da Apolloni, statuto che fu prima abbozzato da Guastalla eda me. Quello di Apolloni è scritto a macchina, il nostro è quello scritto da me. Conservali tu.Addio. A∂.to tuo Camillo”.57 S.A., I sovrani alla “Secessione” e agli “Amatori e Cultori”, in “Il Messaggero”, 17 maggio 1913.58 Sull’ allestimento della sala degli Impressionisti e sulle polemiche nate attorno alla scelta delle
derà con lanci di ortaggi, risse e arresti.62 E per l’insistenza di Marinetti legato daamicizia a Walter Mocchi, l’evento si ripeterà ancora nello stesso luogo il 9marzo. La mostra della pittura futurista allestita nel ridotto del teatro vieneaccolta con ilarità dal pubblico e i discorsi di Marinetti e Papini provocano risse econtestazioni.63
I toni diplomatici e calibrati usati in Senato, di lì a qualche mese, da Enrico diSan Martino – mentre a Palazzo delle esposizioni sono ancora in mostra le operedella Secessione – sono assai diversi da quelli usati dai futuristi, ma anche daitoni entusiastici di Curt Siedel: “Anzitutto giova notare che in Italia l’arte moder-na trova spesso il suo cammino inceppato da due ostacoli: il primo formidabile,la grandezza schiacciante dell’arte antica, ed il secondo meno temibile, che pureha qualche peso, gli eccessi, gli errori di alcuni pionieri, forse troppo arditi, del-l’avvenire. [...] Noi stessi nell’esistenza nostra [...] abbiamo assistito a mutamen-ti di opinione come quelli avvenuti intorno a Wagner sopra il quale basterebbericonfrontare la critica di quaranta anni fa, e quella di oggi, per renderci contodella rapidità della evoluzione del pensiero e del gusto, e per consigliarci quindi anon temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”.64
Quei “pionieri, forse troppo arditi, dell’avvenire” cui fa riferimento San Mar-tino richiamano alla mente i futuristi. Per lui promuovere l’arte moderna vuoldire dedicarle uno spazio in cui non venga posta in alternativa all’antico, ma vuoldire anche emendarla da estremismi ed eccessi di provocazione, che nell’ambien-te romano ne determinerebbero a suo giudizio il rifiuto.
403
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
Alla vigilia della prima Esposizione, a sottolineare la validità della scelta, ilcritico Curt Siedel, pubblica sulle pagine dell’ “Artista moderno” un articolo daltitolo “L’impressionismo non è morto”, in cui scrive: “ha il merito di averci datoattraverso le proprie conquiste, una più grande spontaneità di vita, una più nobi-le comprensione delle cose, una più sicura, individuale, coscienza artistica. Tuttii mezzi sono leciti: tutti i mezzi sono sacri. Ci siamo svegliati: ora andremo inseno al futuro, al cubismo, alla pazzia, alla delinquenza, alla forsennatezza. Ora,a costo di qualsiasi anarchia, di qualsiasi conseguenza, noi andremo fissi e fierifino alle stelle”.59
San Martino intende aprire Roma a una fertile comunicazione internazionalema, contrario a estremismi e provocazioni, fautore di trasformazioni condotte dal-l’interno delle istituzioni sfruttando il potere economico e politico, segue lo svi-luppo della Secessione talora correggendone gli indirizzi ed evitandone estremisti-che contaminazioni. È quanto accade quando, di∂usasi a livello nazionale la famadei futuristi, la loro presenza mette a rischio l’elargizione da parte del Ministerodella pubblica istruzione del contributo per la prima esposizione. Nel giro di tremesi Tomaso Bencivenga, fedele collaboratore di San Martino già come segretariodella Società Amatori e Cultori, ne ottiene con graduale e ferma strategia l’estro-missione riducendo gradualmente lo spazio espositivo a loro disposizione.60
Una soluzione per non negare del tutto ai futuristi la scena romana viene tro-vata in extremis grazie alla collaborazione di Walter Mocchi e dell’amministra-zione del teatro Costanzi. In quel teatro vengono invitate nel pomeriggio del 21febbraio, un mese prima dell’apertura della Secessione, le più distinte personali-tà di Roma e una gran folla di giornalisti per prendere parte a un tè e a “un’im-portante manifestazione futurista”. Scrive Lelio Antonioni: “chi avesse suggeri-to l’idea di addolcire palati così ostici con pasticcini sandwiches e cioccolatininon si è mai saputo”.61 Lì si svolge la clamorosa esibizione dei futuristi, cui pren-de parte anche Giovanni Papini, che verrà raccontata dalle cronache e si conclu-
silvia cecchini
402
opere, provenienti dalla galleria Barnheim-Jeune vedi Mario Quesada, Storia della Secessione roma-na, in Secessione romana, cit., pp. 7-27, in particolare p. 14. 59 Curt Siedel, L’impressionismo non è morto, in “L’Artista Moderno”, a. xii, vol. xii, 1913, pp. 43-46.60 Vedi Pasqualina Spadini, Dalla Secessione romana alla prima Quadriennale: l’impervio itinerariodi una politica espositiva, in Secessione romana, cit., pp. 59-80.61 Lelio Antonioni, Cronache vissute della Roma umbertina, Roma, Edizioni Mediterranee, 1970,p. 200.
62 Ivi, pp. 199-208.63 La trascrizione del “discorso ai romani” di Papini, emendata delle più acri invettive, è pubbli-cata sulla rivista “Lacerba”, da lui fondata. 64 Enrico di San Martino, Sulle Belle Arti, in Atti Parlamentari, leg. xxiii, 1a sessione 1901-1913,tornata dell’11 giugno 1913, p. 1146 e sgg.
tà di Enrico di San Martino, impegnati da Maddalena Fourton per il pagamentodelle imposte di successione, una fonte quindi parziale e che potrebbe escludereproprio i titoli su cui San Martino aveva investito con maggiore continuità.
Nelle tavole fotografiche sono riprodotte, infine, mappe e alzati delle proprie-tà immobiliari dei coniugi San Martino, la cui descrizione dettagliata è consulta-bile nel Verbale d’inventario1.
Si tratta di materiale solo in parte considerato nei contributi di questo volu-me, da cui potranno scaturire nuovi percorsi di ricerca per la ricostruzione diun’ampia biografia di Enrico di San Martino e Valperga.
Documento 1Testamento di Enrico di San Martino Valperga
Estratto per riassunto dal registro degli Atti di Morte dell’anno 1947Parte prima – Serie III – volume III n. 1170L’anno millenovecentoquarantasette il giorno quattordici del mese di luglio
alle ore diciotto e minuti venti nella casa posta in Via delle Terme Diocleziane 4 èmorto San Martino Valperga Enrico Teodorico di anni ottantaquattro di condi-zione Ministro di Stato, residente in Roma nato a Torino fu Guido e fu MayerRosalia, di stato civile marito di Fourton Maddalena Giovanna.
Denuncianti: 1° Di Marco Augusto di anni 28 – domiciliato in Roma in condi-zione commesso.
Testimoni: 1° Spiga Alfredo di anni 27 domiciliato in Roma di condizione auti-sta. 2° Piermattei Marcello di anni 61 domiciliato in Roma, di condizione impiegato.
Roma lì 16.7.1947.L’Impiegato estensore l’U∂. di Stato Civilef° illeggibile f° Lolli
Revoco ogni precedente mia disposizione ed istituisco mia erede universale
405
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
RegestoDocumenti per una biografia
Questo breve regesto è concepito come un contributo alla raccolta di materialidocumentari che riguardano l’attività di Enrico di San Martino nel vasto campodella produzione e trasmissione della cultura. Il forte impatto della sua azionenell’orizzonte culturale romano e nazionale è determinato da una strategia chefinalizza investimenti finanziari e una fitta rete di relazioni a una progettazioneculturale a lungo termine. Nel suo agire integra molteplici abilità: un’imposta-zione imprenditoriale, capacità politiche e diplomatiche, una fervida passioneper la musica e le arti figurative e performative, la convinzione che sia necessarioriuscire a coinvolgere e formare strati sempre più ampi di popolazione. Aspetto,quest’ultimo, che accomuna il ceto intellettuale formatosi nei decenni in cui sicostituisce lo stato unitario e protagonista di importanti imprese culturali con-dotte tra fine Ottocento e la prima guerra mondiale.
È per recuperare il profilo di un’attività così articolata e complessa che si èavviato lo studio sulle scelte finanziarie di Enrico di San Martino, da cui emerge,ad esempio, che gli investimenti presso istituti bancari sono stati spesso lo stru-mento che assicurava a San Martino la liquidità necessaria ad avviare o a garanti-re la stabilità dei suoi progetti culturali, in attesa di investimenti privati o finan-ziamenti pubblici.
Il regesto raccoglie i documenti riguardanti Enrico di San Martino contenutiall’interno dei faldoni denominati “Eredità Maddalena Fourton” e conservatipresso la Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo di Torino. Nel documento 3si è scelto di omettere il cospicuo elenco di oggetti di uso quotidiano, includendoinvece tutti i beni, mobili e immobili che contribuiscono alla ricostruzione delprofilo culturale di Enrico di San Martino. La documentazione integrale relativaa Enrico di San Martino che ho reperito negli archivi della Casa della DivinaProvvidenza – Cottolengo di Torino, grazie alla disponibilità di don Lino Piano edi suor Rita, è ora consultabile in formato digitale anche presso la Bibliomediate-ca dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Nella tabella in calce al regesto sono elencati alcuni degli investimenti di Enri-co di San Martino. È un primo elenco elaborato a partire dalla documentazionequi trascritta e a cui molti dati ancora andranno aggiunti. Bisogna tener presenteche molti dei dati riportati emergono dalla Distinta dei titoli azionari di proprie-
silvia cecchini
404
1 La descrizione dettagliata degli immobili è consultabile in Verbale di inventario, fascicolo n.5716/55, foglio 24 recto e verso; altra descrizione è in Mandato, Repertorio n. 42551, atto n. 18048,documenti consultabili in forma digitale presso l’Archivio dell’Accademia di Santa Cecilia e incartaceo presso l’Archivio della Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo di Torino.
presente il Signor Dottor Ing. Arturo Hoerner fu Ermanno nato e domiciliato inRoma via Po numero 162.
Il comparente della cui identità personale sono certo mi richiede di procederealla pubblicazione del testamento olografo della compianta contessa MaddalenaFourton fu Carlo Emilio vedova San Martino di Valperga ed all’uopo mi presental’estratto dell’atto di morte rilasciato in data 15 settembre 1955 dall’U∑ciale delloStato Civile del Comune di Roma, dal quale risulta che la suddetta Contessa Four-ton di San Martino Valperga cessò di vivere in Roma ove era in vita domiciliata iltredici (13) settembre 1955 (millenovecentocinquantacinque). Detto estratto quisi allega sotto la lettera A previa lettura.
Quindi il richiedente mi consegna una busta bianca a∑data in vita dalla decuius, sulla quale busta si legge la seguente scritta “il mio testamento – Maddale-na Fourton vedova di San Martino Valperga”.
Aperta, in presenza delle testimoni, detta busta, vi si rinviene un foglio da let-tere di carta bianca non rigata, scritta a foglio spiegato in inchiostro nero pallidoda uguale carattere che il comparente riconosce di pugno della testatrice – Non visi notano correzioni né cancellature ed abrasioni. Lo scritto occupa ventiduerighe nella prima pagina delle quali la quarta, la settima, la nona e la diciassette-sima e la diciannovesima sono incomplete; nella seconda pagina sono scritte tre-dici righe compresa la data e la firma e di queste la nona e l’undicesima sonoincomplete.
Di detta scheda ne do pubblicazione mediante lettura da me datane in presen-za delle testi al chiedente, ed è del seguente preciso tenore:
Revoco ogni mia precedente disposizione ed istituisco mio erede universale ilCottolengo a carico suo di soddisfare i seguenti legati:
Accademia Nazionale di Santa Cecilia lire 10.000.000 (dieci milioni) allaSezione Assistenza;
Signora Mary Panatta, nata Viano lire 10.000.000 (dieci milioni);Signor Gino e Signora Michelina Bu∑ lire 4.000.000 (quattro milioni) que-
sta somma sarà data complessivamente ad ambedue e sarà data pure complessi-vamente al superstite se venisse a mancare uno dei due;
Signora Maria Farina nata Enrico lire 1.000.000 (un milione);Signor Michele Panvini Rosati lire 1.000.000 (un milione);Galleria di Arte Moderna di Roma una statuetta di donna che alza la gamba in
terracotta di Rodin, su zoccolo di marmo verde;
407
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
mia moglie Maddalena FourtonRoma sette giugno millenovecentoquarantacinqueEnrico di San Martino Valpergaf° Maddalena Fourton di San Martino Valperga“ Mandolesi Lina teste“ Motta Lidia testeCarlo Capo notaio
È copia conforme ai suoi originali allegati sotto le lettere A e B al mio rogito indata 22 luglio 1947 registrato a Roma il 26 luglio 1947 al n. 1775 – vol. 743 – attipubblici – portante: pubblicazione del testamento olografo delconte enrico di san martino valperga fu guido e si rilascia a richie-sta dell’Erede.
Roma 8 agosto 1947f° Carlo Capo notaio
Repertorio n. 57013-23856, trascrizione autenticata del verbale di “Pubblica-zione del testamento olografo del Conte Enrico di San Martino Valperga fuGuido”, di quattro cartelle.
Documento 2Testamento di Maddalena Fourton
Repertorio n. 42114, atto n. 17913Pubblicazione di testamento olografo della Bo.me Maddalena Fourton vedo-
va San Martino ValpergaRepubblica Italiana
L’anno millenovecentocinquantacinque il giorno quindici (15) del mese disettembre in Roma nel mio studio alle ore sedici e trenta (h.16.30).
Avanti di me Avvocato Francesco Antonelli Notaio residente in Roma con stu-dio alla Corsia Agonale 10 ed iscritto al Ruolo Notarile dei Distretti Riuniti di Romae Velletri; alla presenza delle testimoni signora Angela Maria Broglia fu Paolo inVassalli, nata in Roma e qui domiciliata via Fozza n. 32, e Fanny Binetti fu Fausto,nata in Modena e domiciliata in Roma, Via dello Statuto 32, impiegati testi abili è
silvia cecchini
406
Documento 3Inventario dei beni lasciati in eredità da Maddalena Fourton al Cottolengo di Torino
Fasc. n. 5716/55
Verbale di inventario3
Oggi 24 ottobre 1955 alle ore 17,15 nella sala di attesa del Grand Hotel, in RomaVia delle Terme si Diocleziano, io sottoscritto, delegato dal Pretore di Roma aprocedere all’inventario dei beni della defunta Contessa fourton maddale-na ved. S. Martino di Valperga, con decreto 1° ottobre 1955.
Sono presenti i Signori [...](foglio 5) Dissuggellato il mobile di cui al n. 27 si rinviene una busta in carta
bianca recante quattro suggelli in ceralacca integri e tre rimossi, legato con dellospago e annodato. I suggelli predetti recano l’iscrizione Banca Commerciale Ita-liana, in ovale e la sigla b.c.i.
Sulla busta è incollata una etichetta su cui è scritto il contenuto della busta, can-cellata in matita nera; reca la data 17/10/1952 ed una firma illeggibile ed il n. 6375.La busta è intestata Di S. Martino Valperga Conte Enrico e Contessa Maddalena.Nella suddetta busta si contengono: n. 60 azioni al portatore di 500 franchi francesidella Società Nouvelle Des Minas De Communay; n. 60 quote di fondazione al por-tatore della Societé Commerciale et Industrielle, senza valore nominale con sede inParigi; n. 2 azioni ordinarie della S. Fenes (?) Théâtre Des Champs Elysées, consede a Parigi; n. 10 certificati per azioni preferenziali della Ferro Cascil [Carril]Terminal Central de Buenos Ayres del valore di 100 pesos oro ciascuna; n. 1 titolodi 100 azioni al portatore della Société d’ Exportation Industrielle con sede inParigi, valore nominale di 100 franchi francesi; numero 10 quote di fondazione alportatore della Societé d’Exportation Industrielle. n. 1 certificato nominativo diuna azione di 1000 franchi francesi della Societé Anonyme Immobiliare; n. 4 titolida 100 azioni al portatore della s.a. Gestione Amministrazione CompartecipazioniIndustriali Azionarie; n. 1 certificato d’azione nominativa de “La Revue musicale”con sede in Parigi del valore di 500 franchi francesi; n. 2 certificati di venti azioni cia-scuna dell’Anglo American Supply States con sede in Firenze.
[...](foglio 5+1 verso)
409
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, due pitture tibetane incor-niciate ed una testina greca in terracotta su piccolo zoccolo di legno.
Tutte le tasse relative alla successione comprese quelle a∂erenti ai legatisaranno a carico del mio erede.
Roma quattro giugno millenovecentocinquantaquattro.Maddalena FourtonVedova di San Martino ValpergaDetta scheda viene allegata al presente atto sotto la lettera B e la busta che la
conteneva viene parimenti qui allegata sotto la lettera C.Dichiara il comparente di non essere in grado di indicare il valore dei beni
ereditati che si riserva d’indicare successivamente.Richiesto il Notaio ho ricevuto il presente atto che in presenza delle testimoni
ho letto al comparente il quale da me interpellato l’approva e con le testi e nota-ro lo firma a senso di legge.
Consta l’atto di due fogli bollati scritti da me notaro ed in parte da persona inmia fiducia in cinque pagine interne e parte della presente e viene schiuso alle orediciotto a un quarto (18 ¼).
f/to Arturo Hoerner“ Angela Maria Broglia in Vassalli – teste“ Fanny Binetti – teste“ avv. Francesco Antonelli . NotaioRegistrato a Roma il 21 settembre 1955 al n. 3507 vol. 29/3 Atti Pubblici – Esat-
te lire 880.Il Direttore f/to Lo Iudice.2
silvia cecchini
408
3 L’inventario viene stilato a Roma tra il 24 ottobre 1955 e l’11 gennaio 1956.
2 Presente agli atti depositati in copia digitale presso l’Accademia di Santa Cecilia in Roma l’attodi morte di Maddalena Fourton in data 13 settembre 1955, con il titolo “Estratto per riassunto delregistro degli atti di morte nell’anno 1955”.
[...]2) Una cartella di corrispondenza ed appunti relativi agli a∂ari tra i conti di S.
Martino e la Banca Commerciale Italiana in Roma.3) Una cartella contenente corrispondenza con autorità italiane ed Estere,
gazzette u∑ciali, fascicoli di atti parlamentari ecc. relativi, il tutto ai beni deiConti di S. Martino all’estero.
4) Una cartella contenente corrispondenza, appunti, relativi alla successionedi Enrico Valperga con società diverse.
[...]6) Una cartella contenente minute di bilanci di titoli azionari e personali.7) Una cartella contenente atti, corrispondenza appunti ricorsi, relativi alla
successione Enrico di Valperga (5 fascicoli).Si rinvengono inoltre:1) Dichiarazioni di ricevuta redatta dal Presidente della s.a. “Vigilanza di
Lugano, dei certificati di 25 azioni comuni e di 150 preferite della “De NobiliCigar C.” di New York, di proprietà del Conte di S. Martino, in data 23 dicembre1940, con allegata copia fotografica della medesima.
2) Copia di lettera non firmata, diretta al prefetto di Roma, denunziante ilpossesso, da parte del Conte di S. Martino di n. 460 azioni della Società RadioItalia, e di proprietà della Compagnia Generale di Telegraphie Sans Fil di Parigicon allegata ricevuta di ritorno.
[...](foglio 14+1 recto)A questo punto si procede all’inventario di quanto si rinviene in questo
appartamento [Via dell’Arancio 47, Roma]:203) Pittura Tibetana attribuita a “Golon” cm. 50x70 circa rappresentante
“Divinità” su fondo azzurro, contornata di simboli e figure varie; cornice doratae vetro L. 40.000.
204) Altra pittura Tibetana, attribuita a “Haichin” di cm. 40x15 circa, ra∑gu -rante Divinità nel centro contornata da ventitrè personaggi in vari atteggiamen-ti; accentuati e allegorie varie; il tutto si fondo verde scuro e decorazioni in rosso,cornice di noce e vetro. Trattasi delle due pitture, che unitamente alla testa di“Dama greca” inventariata in una precedente seduta, costituiscono legatoall’i.s.m.e.o. L. 30.000.
205) Tela d’olio cm. 35x69 circa a firma “B.C. (Bery Constante) ra∑gurante
411
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
A questo punto si dà atto inoltre che nei tre tiretti inferiori si rinvengono n. 5cartelle di corrispondenza diretta al Conte Enrico di S. Martino che si ferma al 1947.Un certo quantitativo di carta da lettere e buste intestate al Conte di S. Martino.
[...](foglio 12 + 1 recto)Poiché la descrizione delle cose mobili qui esistenti ha avuto termine con la
seduta dell’1/11/u.s. la seduta odierna è dedicata alla descrizione sommaria delvoluminoso carteggio e dei documenti che vi si rinvengono. Tra questi ultimi sirinvengono:
a) Lettera della Banque Française e Italiana diretta al conte di S. Martino Val-perga in data 18/3/47 relativa ad azioni preferenziali della Buenos Aires CentralBaileways [Railways] and Terminal C. 7%.
b) Certificati di un’azione ciascuna n. 00132-00133 della Cassa di PiccoloSconto di Roma del valore di L. 50 cadauna.
c) n. 4 di titoli di una azione ciascuna della “Società per Azienda Libraria,giornalistiche e tipografiche”, con sede in Roma, del valore di L. 30 cadauna.
d) Copia autentica di contratto compravendita tra i Sigg. Amerigo Marinelli,Vincenzo Gioia e i Conti di S. Martino Valperga relativo all’immobile terreno esovrastante fabbricato di Via Matera in Roma; n. 3169 rep. per notaio avv. CarloCapo di Roma;
e) Copia autentica di un contratto compravendita tra la medesime parti rela-tive allo stesso immobile, notaio Capo, rep. 32170.
f ) Contratto di attualità partita 145141 Catasto Urbano di Roma intestato aFourton Maddalena fu Emilio e di S. Martino Valperga Enrico fu Guido, relativoagli immobili in Roma Via Matera n. 4 25 27 29 31.
[...][foglio 13 recto]l) Nota di trascrizione alla R. Conservatoria delle ipoteche di Roma dell’Istru-
mento rogato dal notaio Carlo Capo in Roma in data 15/5/1939 (per mq. 1030 areadi terreno in Roma Via Matera con sovrastante casa civile di abitazione di piani 7).
m) procura speciale rilasciata al Comm. Cagli Aldo in Roma, notaio avv. CapoCarlo di Roma, n. 47379 del 10/10/1944.
[...][foglio 13 verso]Si rinviene inoltre il seguente altro carteggio:
silvia cecchini
410
“Romanzo” di complessive 95 pagine;7) Una cartella contenente un dattiloscritto sul frontespizio è scritto “Novelle”;8) Lettera 17 ottobre 1955 indirizzata al Conte di S. Martino dal suo amministratorecirca il ritiro di alcuni titoli da una Banca non identificabile, la firma è illeggibile;9) n. 6 fascicoli di carteggio vario;10) n. 8 raccoglitori contenenti carteggio vario riferiti a diverse annualità;11) n. 9 libri e registri di contabilità riferita a vecchie annate;12) n. 46 bollettari con matrici di ricevute a∑tti stabili;13) n. 2 bollettari di cassa;14) n. 12 raccoglitori contenenti altro vecchio carteggio e due libri contabili;15) n. 13 cassette porta carteggio contenenti carte, documenti, corrispondenza,conteggi ecc. relativo al Conte di S. Martino (quasi il tutto di vecchissima data);16) Una cartella contenente carte e documenti, corrispondenza relativi a“Valperga”; 17) Altre 4 cassette raccoglitrici ricolmi di fascicoli di corrispondenza – docu-menti amministrativi ed altro (12 cassette n. 18);Si dà atto che oltre al carteggio inventariato fin qui, è stata rinvenuta altra discre-ta quantità di carta di carattere privato-familiare e di tipo u∑ciale per le carichericoperte dal Conte di S. Martino (inviti – cerimonie – feste – ricevimenti ecc.);[...](foglio 18 + 1 recto)
271) Una statuetta ra∑gurante donna che alza una gamba (contorsionista) interracotta di Rodin su zoccolo di marmo verde delle Alpi. La statuina è sorret-ta da una cintura che la fissa ad un asticciola di ferro. La gamba destra è lesio-nata e fasciata per precauzione (trattasi di legato all’i.s.m.e.o.) L. 6.000.272) Una statuetta di bisquit ra∑gurante la Musa Euterpe; nell’astuccio inlegno foderati in pelle verde e velluto interno si rinvengono, le due estremitàdello strumento sorretto dalla musa. L. 5.000. 273) Una testina in terracotta ra∑gurante un giovanetto con basamento inlegno. L. 1.000.274) un frammento di statuetta egiziana visibile il dorso di un uomo e duebraccia. L. 1.000.[...](foglio 19 + 1 verso)294) un astuccio custodia in tela marrone contenente decreti reali di ricono-
413
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
un mezzo busto di donna con tunica a mani riunite in atto di preghiera, cornicein mogano con vetro L. 2.000.
207) Tre disegni a tempera ra∑guranti la “Contessa di S. Martino” a firma“Hellen” macchiati dall’umidità in più punti L. 1.500.
208) Pittura ad acquarello ra∑gurante “madame Martha Letellier nata Four-ton” a firma “Hellen” macchiata in più parti dall’umidità con vetro e cornicettaall’inglese L. 2.000.
209) Pittura ad olio a ritratto della Contessa di S. Martino, con vetro e cornicedorata ed intagliata, cm. 40x50 circa; la pittura è macchiata in qualche punto dal-l’umidità L. 3.000.
210) Acquarello [sic!] 60x70 cm. circa, ra∑gurante “Cavallo a dondolo” consopra un giovinetto con casacca a mantello, nella mano destra impugna unaspada e nella sinistra una lancia con bandierina di famiglia e stemma gentilizio,nel centro “S. Martino” – L’acquarello si presenta macchiato in parte dall’umidi-tà ed è corredato da vetro e cornicetta dorata L. 1.000.
211) Ritratto a tempera della contessa Aurelia Ambron Roma 1915, macchiatain più punti dall’umidità con vetro e cornicetta dorata cm. 50x70 circa
L. 1.000.212) Disegno a colore su carta 30x40 circa con vetro montato all’inglese
L. 1.000.A questo punto, poiché i locali a disposizione non consentono la prosecuzio-
ne delle operazioni, anche perché si sono rinvenuti numerosi bauli e casse, non-ché mobili accatastati in piccolo spazio, io Cancelliere ho ritenuto invitare Mons.Luigi Rabbia a far trasportare quanto di competenza dell’eredità Fourton pressoil suo Istituto come già proceduto per i bagagli già esistenti al Grand Hotel.Rimangono presso questa casa soltanto carte e documenti per le quali procederòall’esame in giorno da stabilirsi.
Mons. Rabbia mi avvertirà dell’avvenuto trasporto di quanto sopra dopodi-ché fisserò i giorni per la prosecuzione delle operazioni presso l’Istituto Cotto-lengo in Via di Villa Alberici 14.
[...](foglio 15+1 verso)5) Una cartella contenente appunti, manoscritti, acc. relativi a viaggi e mis-sioni del conte di S. Martino (con due sottofascicoli);6) Una cartella, contenente una borsa dattiloscritta, su cui è scritto in rosso
silvia cecchini
412
420 (quattrocentoventi) azioni Società Elettrica Sarda2.340 (duemilatrecentoquaranta) azioni Pirelli156 (centocinquantasei) azioni Società Idroelettrica Piemontese s.i.p.2.450 (duemilaquattrocentocinquanta) azioni Società Nazionale SviluppoImprese Elettriche 1872 (milleottocentosettantadue) azioni Società Romana Fabbricazioni Zucchero250 (duecentocinquanta) azioni Società Torinese Esercizi Telefonici s.t.e.t.366 (trecentosessantasei) azioni Società La Centrale400 (quattrocento) azioni Società Gestioni Amministrazione Compartecipa-zioni Industriali Azionari Torino77 (settantasette) azioni Air Liquide50 (cinquanta) parts Air LiquideN.B. Depositate presso Banca Paris et Pays Bas a Parigi sotto tutela della BancaCommerciale di Milano.F.to Antonio Virgilio n.n.“ Vincenzo Grossi n.n.“ Domenico Paolicelli n.n.“ Maddalena Fourton Ved. di San Martino Valperga“ Carlo Capo =notaio
Registrato a Roma il 26 luglio 1949 al n. 1089vol. 771 atti pubblici – Esatte £ 11.185Il Direttore f.to [illeggibile]Spedita la presente copia in conformità al suo originale firmato a forma dilegge che si rilascia a richiesta dell’U∑cio Successioni di Roma.Roma 26 luglio 1949F.to Carlo Capo notaio
415
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
scimento titoli e stemmi gentilizi dei Conti di S. Martino. L. 1.000.[...](foglio 20 recto)
302) n. 10 copie di volumi “Ricordi”, di Enrico di S: Martino; 2 volumi (i e ii) dilegislazione fascista anni 1929-1934; un volume : La Cassa di Risparmio di Torinonel suo primo centenario 4 luglio 1827-4 luglio 1927; un volume “Gli atti delComune di Milano fino all’anno 1926, a cura di C. Manaresi; un volume “NozzeBoncompagni Ludovisi Borromeo” – Arese – Milano 14 giugno 1917 L. 10.000.
Documento 4Allegato aDistinta dei titoli azionari della successione San Martino costituiti in pegno afavore dell’amministrazione delle imposte indirette sugli a∂ari.760 azioni della Società Acqua Pia12.621 (dodicimilaseicentoventuno) azioni della Società Edison300 (trecento) azioni Società Assicurazioni Generali400 (quattrocento) azioni Finsider160 (centosessanta) azioni Fondiaria Finanziaria12.500 /dodicimila cinquecento) azioni Società Immobiliare105 (centocinque) azioni Società Acquedotti di Napoli500 (cinquecento) azioni Società Metallurgica Italiana1.700 (millesettecento) azioni Società Dalmine350 (trecentocinquanta) azioni Società Amiata40 (quaranta) azioni Valdarno nuove760 (settecentosessanta) azioni Società Meridionale di Elettricità980 (novecentottanta) azioni Società Romana di Elettricità225 (duecentoventicinque) azioni Società Mira Lanza cat. B390 (trecentonovanta) azioni Fibre Tessili già Chatillon95 (novantacinque) azioni Snia Viscosa205 (duecentocinque) azioni Cascami seta19.380 (diciannovemilatrecentottanta) azioni Società Molini Pastificio Pantanella775 (settecentosettantacinque) azioni Società Cartiera Burgo450 (quattrocentocinquanta) azioni c.i.g.a. Grandi Alberghi Venezia7.700 (settemilasettecento) azioni Italgas33.074 (trentatremilasettantaquattro) azioni Montecatini
silvia cecchini
414
417
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”silvia cecchini
416
Società Acqua Pia 760 azioni Titoli di E. di San Martino impegnatiper pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Edison 12.621 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società AssicurazioniGenerali
300 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Finsider 400 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Fondiaria Finanziaria 160 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Immobiliare 12.500 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Acquedottidi Napoli
105 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società MetallurgicaItaliana
500 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Dalmine 1.700 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Amiata 350 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Valdarno nuove 40 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Prospetto sintetico di settori di investimento di Enrico di San Martino e ValpergaSocietà Meridionale di Elettricità 760 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati
per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Romana di Elettricità 980 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Mira Lanza cat. b 225 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Fibre Tessili già Chatillon 390 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Snia Viscosa 95 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Cascami seta 205 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società MoliniPastificio Pantanella
19.380 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Cartiera Burgo 775 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
c.i.g.a.Grandi Alberghi Venezia
450 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Italgas 7.700 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Montecatini 33.074 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Elettrica Sarda 420 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Pirelli 2.340 azioni Titoli di E. di San Martino impegnati per pagamento imposte di successione, 26 luglio 1949
Società Numero delle azioni Data
419
silvia cecchini
s.i.p.Società Idroelettrica Piemontese
156 azioni Titoli di E. di San Martinoimpegnati per pagamentoimposte di successione, 26 luglio 1949
Società Nazionale SviluppoImprese Elettriche
2.450 azioni Titoli di E. di San Martinoimpegnati per pagamentoimposte di successione, 26 luglio 1949
Società RomanaFabbricazioni Zucchero
1872 azioni Titoli di E. di San Martinoimpegnati per pagamentoimposte di successione, 26 luglio 1949
s.t.e.t.Società Torinese Esercizi Telefonici
250 azioni Titoli di E. di San Martinoimpegnati per pagamentoimposte di successione, 26 luglio 1949
Società La Centrale 366 azioni Titoli di E. di San Martinoimpegnati per pagamentoimposte di successione, 26 luglio 1949
Società Gestioni AmministrazioneCompartecipazioni Industriali Azionari Torino
400 azioni Titoli di E. di San Martinoimpegnati per pagamentoimposte di successione, 26 luglio 1949
Air Liquide 77 azioni Titoli di E. di San Martinoimpegnati per pagamentoimposte di successione, 26 luglio 1949
Air Liquide 50 parts Titoli di E. di San Martinoimpegnati per pagamentoimposte di successione, 26 luglio 1949
Société NouvelleDes Minas De Communay
60 azioni al portatoredi 500 franchi francesi
Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Société Commercialeet Industrielle (Parigi)
60 quote di fondazioneal portatore
Verbale d’inventario7 ottobre 1955
418
S. Fenes (?) Théâtre Des ChampsElysées, con sede a Parigi;
2 azioni ordinarie Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Ferro Cascil Terminal Central de Buenos Ayres
10 certificati per azionipreferenziali del valoredi 100 pesos oro ciascuna
Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Société d’ExportationIndustrielle con sede in Parigi
1 titolo di 100 azionial portatore, valore nominaledi 100 franchi francesi
Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Société d’Exportation Industrielle 10 quote di fondazione al portatore Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Société Anonyme Immobiliaire 1 certificato nominativo di una azione di 1000 franchi francesi
Verbale d’inventario7 ottobre 1955
S. A. Gestione AmministrazioneCompartecipazioni Industriali Azionarie
4 titoli da 100 azioni al portatore Verbale d’inventario7 ottobre 1955
“La Revue musicale” (Parigi) 1 certificato d’azione nominativadel valore di 500 franchi francesi
Verbale d’inventario7 ottobre 1955
American Supply States(sede Firenze)
2 certificati di venti azioni ciascuna Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Cassa di Piccolo Sconto di Roma 2 azioni del valore di L. 50 cadauna Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Società per Azienda Libraria,giornalistiche e tipografiche(Roma)
4 titoli di un’azione ciascunodel valore di L. 30 cadauna
Verbale d’inventario7 ottobre 1955
De Nobili Cigar Co.(sede New York)
25 azioni comuni e 150 preferite Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Società Radio Italia 460 azioni Verbale d’inventario7 ottobre 1955
Compagnia Generaledi Télégraphie Sans Fil di Parigi
460 azioni Verbale d’inventario7 ottobre 1955
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”
421
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”silvia cecchini
420
figura 1: Philip Alexius de László, Ritratto della Contessa di San Martino e Valperga, olio sucartone, Roma, Accademia di Santa Cecilia, inv. n. o24
figura 2: Filippo Cifariello, Busto di Enrico di San Martino Valperga, bronzo, Roma, Accademiadi San Luca, inv. 190
423
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”silvia cecchini
422
figura 3: Copertina del catalogo Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti – Catalogo delleEsposizioni riunite della Società Amatori e Cultori di Belle Arti, dell’Associazione degliAcquarellisti, In Arte Libertas e dei Cultori di Architettura, Roma, Tipografia D. Squarci, 1900
figura 4: Copertina del catalogo Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti in Roma.lxxiii Esposizione internazionale di belle arti della Società degli Amatori e Cultori di BelleArti, Mostra dell’Associazione degli Acquarellisti, catalogo, Roma, Premiata Tipografia D.Squarci, 1903
425
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”silvia cecchini
424
figura 5: Copertina del catalogo Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti in Roma,Associazione degli acquarellisti, lxxvii Esposizione internazionale di belle arti della Socie-tà degli Amatori e Cultori di Belle Arti in Roma e dell’Associazione degli Acquarellisti,Roma, Tipografia dell’Unione Coop. Editrice, 1907
figura 6: Copertina del catalogo Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti in Roma,lxxix Esposizione internazionale di belle arti della Società degli Amatori e Cultori di BelleArti in Roma, Roma, Tipografia dell’Unione Coop. Editrice, 1909
427
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”silvia cecchini
426
figura 7: Prospetto dell’edificio tutt’ora sito tra Via Matera, via Taranto, via Nicastro epiazza Casalmaggiore a Roma, acquistato per 1.400.000 lire da Enrico di San Martino e Mad-dalena Fourton il 16 maggio 1939, con annesso terreno di 1030 mq (Conservatoria, atto 7682,16/05/1939). Foto tratta dal Fondo Maddalena Fourton presso Cottolengo di Torino databileal 1959. Al 18 gennaio 1943 risale un altro investimento immobiliare. I due coniugi acquista-no per 224.000 lire quattro appartamenti al primo piano dell’edificio di recente costruzionein via Sinuessa 6 a Roma (Conservatoria di Roma, atto 866, 18/01/1943)
figura 8: Planimetria del Castello di San Martino e Valperga e del relativo portico
429
“non temere arditezze, se anche possono sembrare oggi soverchie”silvia cecchini
428
figura 9: Mappa catastale di parte della tenuta di proprietà dei conti di San Martino e Valperganel Comune di Kis Szállás, provincia di Baks-Kiskun, in Ungheria
figura 10: Mappa catastale di parte della tenuta di proprietà dei conti di San Martino e Valperganel Comune di Kis Szállás, provincia di Baks-Kiskun, in Ungheria































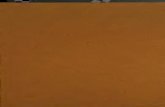

![I nostri rifiuti dalla preistoria all’età moderna, San Martino in Rio 2004, pp. 28-43 [Donato Labate].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f1ff73b43b66d3c0f9f37/i-nostri-rifiuti-dalla-preistoria-alleta-moderna-san-martino-in-rio-2004-pp.jpg)