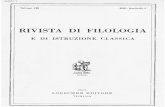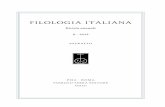Filologia dell'infinitamente piccolo
Transcript of Filologia dell'infinitamente piccolo
Direttori · EditorsSimone Albonico (Lausanne) · Stefano Carrai (Siena)
Vittorio Formentin (Udine) · Paolo Trovato (Ferrara)
*
Comitato di lettura · RefereesGino Belloni (Venezia) · Saverio Bellomo (Venezia)Lucia Bertolini (Chieti) · Guido Capovilla (Padova)
Paolo Cherchi (Chicago) · Claudio Ciociola (Pisa, «Normale»)Luciano Formisano (Bologna) · Giorgio Inglese (Roma, «La Sapienza»)
Guido Lucchini (Pavia) · Livio Petrucci (Pisa)Marco Praloran (Lausanne) · Brian Richardson (Leeds)
Francisco Rico (Barcelona) · Claudio Vela (Cremona-Pavia)Massimo Zaggia (Bergamo) · Tiziano Zanato (Venezia)
*
Redazione · Editorial AssistantFabio Romanini (Milano-Bicocca)
*
Per la migliore riuscita delle pubblicazioni, si invitano gli autori ad attenersi, nelpredisporre i materiali da consegnare alla Redazione ed alla Casa editrice, alle norme
specificate nel volume Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali,Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2004 (ordini a: [email protected]).
Il capitolo Norme redazionali, estratto dalle Regole, cit., è consultabileOnline alla pagina «Pubblicare con noi» di www.libraweb.net.
*
La Accademia editoriale®, Pisa · Roma, pubblica con il marchioFabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma, sia le proprie riviste precedentemente edite con
il marchio Istituti editoriali e poligrafici internazionali®, Pisa · Roma, che i volumidelle proprie collane precedentemente edite con i marchi Edizioni dell’Ateneo®, Roma,
Giardini editori e stampatori in Pisa®, Gruppo editoriale internazionale®, Pisa · Roma,e Istituti editoriali e poligrafici internazionali®, Pisa · Roma.
FILOLOGIA DELL’INFINITAMENTE PICCOLO
Francesco BausiUniversità della Calabria
na decina di anni fa Gennaro Sasso polemizzò contro quei filologi che – di frontealla carenza di moderne edizioni critiche delle opere di Niccolò Machiavelli – guar-
dano con disdegno e diffidenza quanti si ostinino ad applicarsi all’‘interpretazione’ deitesti; e affermò che un simile atteggiamento sarebbe giustificato solo nel caso in cui costoro potessero indicare (nelle edizioni di cui disponiamo) «luoghi sicuramente o probabilmente corrotti, di senso incerto, di poco perspicua intelligenza concettuale», epotessero quindi dimostrare che tali edizioni «non garantiscono quel minimo di certezza obiettiva che è indispensabile perché un’interpretazione del pensiero possa essere tentata».1 Sulla sua scia, Giorgio Inglese ha sostenuto, a proposito del Principe,che il lavoro dei filologi, dal Lisio in poi, si è esaurito nella «messa a fuoco dei dettagli:importanti quanto si vuole, ma sempre dettagli»; ed ha affermato – riprendendo a suavolta una considerazione del Sasso – che «la sostanza dell’opera […] è salva anche nelpeggiore dei manoscritti del Principe, e comunque è ben salva nel testo (bladiano) leggendo il quale, nei secoli dal Cinque all’Ottocento, gli Europei si sono fatti l’idea cheesso è un capolavoro del pensiero politico».2
Non c’è dubbio – posta la questione in tali termini – che la filologia si occupi di «dettagli»; il punto è che, soprattutto, ma non solo, in casi come quelli del Principe e deiDiscorsi sopra la prima deca di Tito Livio, la somma di quelli che, singolarmente conside-rati, sono e restano semplicemente «dettagli», può modificare anche profondamentel’immagine e l’idea (tradizionalmente e spesso acriticamente accettate da secoli) di untesto e del suo autore. Purché, s’intende, filologia non significhi applicazione meccani-ca di regole e di ‘metodi’, ma studio a tutto tondo della tradizione di un’opera, nonchépuntuale commento e acuminata esegesi storico-erudita e linguistica del testo fin nellesue pieghe più minute. Anche Mario Martelli ha sottolineato che, per quanto concernei Discorsi, «al testo fissato da Guido Mazzoni […] non si potranno apportare modifichesostanziali»;3 per poi tuttavia precisare:
Ma un’edizione critica non si esaurisce certo nella semplice recensio delle testimonianze, nella lo-ro classificazione, nella elaborazione di uno stemma codicum, nella conseguente costituzione deltesto, nell’approntamento di quel corredo di apparati filologici e di filologico commento che disolito completa le edizioni critiche di tipo tradizionale. Oggi a un’edizione critica – soprattuttoin un caso come quello delle due più grandi opere di Machiavelli […] – si chiede molto di più. Il
1 Sasso 1997, p. 392.2 Inglese 2000, p. 163 (il contributo dell’Inglese replica a Martelli 1999). Gennaro Sasso, proprio ri-
guardo all’edizione critica del Principe approntata dal medesimo Inglese, aveva affermato che essa «gli ècostata anni di duro lavoro e che non di meno, ora che le sue novità sono sotto gli occhi di tutti, mai loindurrebbe a dire che il testo che leggevamo ieri era tutt’altra cosa da quello pensato nello scrittoio diSant’Andrea in Percussina» (Sasso 1997, p. 455). A conferma di questa sua svalutazione dell’attività filolo-gica, il Sasso (p. 395) cita non a caso il ‘crociano’ saggio di Contini su Come lavorava l’Ariosto (del 1937), incui alla filologia veniva attribuito un valore «pedagogico» nei confronti del momento – a suo avviso benaltrimenti importante e significativo – dell’interpretazione e della «descrizione caratterizzante».
3 Martelli 1997, p. 15 (donde anche il brano che segue).
U
«filologia italiana» · 4 · 2007
còmpito che s’impone oggi a un editore critico dei Discorsi non è solo – né, forse, prevalente-mente – quello di procedere al commento, proprio delle edizioni critiche di tipo tradizionale, in-teso alla giustificazione delle lezioni accolte a testo. Di fronte a un’opera come i Discorsi, pur aste-nendosi da interventi congetturali finalizzati all’emendazione dei vari guasti, còmpito primarioè quello di individuare, circoscrivere, segnalare con strenua attenzione le mende, distinguendo,nei limiti in cui sia possibile farlo, quanto sembra doversi attribuire alla responsabilità dei copi-sti e degli editori e quanto invece allo stato imperfetto in cui l’autore lasciò la sua opera.
È proprio un’operazione di questo tipo che – credo – può consentire alla filologia di sottrarsi a un ruolo servile e a una posizione marginale nei confronti della critica, tor-nando ad agire efficacemente sull’interpretazione dei testi: risultato non da poco, questo, in tempi, come i nostri, caratterizzati da inquietanti e ricorrenti rigurgiti antifi-lologici. Nella fattispecie, riconoscere come machiavelliane – e quindi conservare a testo – tutta una seria di particolarità e di «dettagli» (errori di informazione, citazioni incomplete o approssimative, trascuratezze formali), e al tempo stesso puntualizzare,in sede di commento, certe caratteristiche della lingua di Machiavelli e del suo approc-cio alle fonti storiche, non può restare senza effetto ai fini di correggere l’immagine tra-dizionale tanto dell’opera in questione, quanto del suo autore, vale a dire della sua cul-tura, del suo modo di lavorare, degli obiettivi che egli si prefiggeva componendo iDiscorsi, dello stato in cui essi ci sono giunti. Tutte questioni dalle quali nessun ‘inter-prete’ può prescindere, se intende fondare su basi documentarie minimamente solidele proprie costruzioni critiche.1
Nelle tre schede che seguono mi propongo di illustrare altrettanti esempi di questafilologia dei «dettagli», o, se si vuole, dell’infinitamente piccolo; esempi (desunti da tretesti quattro-cinquecenteschi, latini e volgari, dei quali ho approntato in tempi recentil’edizione critica) a mio avviso paradigmatici di come un apparentemente minimo «det-taglio» testuale evidenziato dallo scavo filologico possa avere ricadute anche rilevantisul piano non solo dell’interpretazione del passo interessato, ma anche, talvolta, del-l’intero testo, nonché – su un altro piano – dell’accertamento della cultura dell’autoree del suo modo di lavorare. Dio è nel particolare; e spesso particolari apparentementemicroscopici – se collocati da un osservatore allenato sotto la lente appropriata – si ri-velano ricchi di preziose informazioni e forniscono elementi oggettivi e certi sui qualiimpostare in modo non arbitrario lo studio di importanti questioni storico-culturali,sottraendole tanto alla superficialità delle impressioni, quanto al condizionamento diformule e luoghi comuni.
1.
Leggiamo i vv. 35-38 dell’Epicedio di Albiera degli Albizzi di Angelo Poliziano, compostonel 1473:
Solverat effusos quoties sine lege capillos,infesta est trepidis visa Diana feris;
sive iterum adductos fulvum collegit in aurum,compta Cytheriaco est pectina visa Venus.2
10 francesco bausi
1 La questione è stata poi ripresa e sviluppata, sempre in relazione a Machiavelli, da Martelli 2001,pp. 212-71.
2 Bausi 2003, p. 52. Questa la traduzione italiana: «Ogni qual volta slegava, sciogliendoli liberamente,i capelli, sembrava Diana che minaccia le fiere impaurite; o se di nuovo, stringendoli, li raccoglieva in unnodo dorato, sembrava Venere col citereo pettine acconciata».
Il componimento è tràdito da tre testimoni tardo-quattrocenteschi, due manoscritti (45C 17 [già 582] della Biblioteca Corsiniana e dell’Accademia dei Lincei di Roma, cc. 9v-14r= C; NN V 7 della Biblioteca dell’Accademia delle Scienze di Torino, cc. 3r-12v = T) e unastampa (Angeli Politiani Omnia opera, Venezia, Aldo Manuzio, 1498, cc. ff vir-gg iv = V).C, T e V rendono testimonianza di tre distinte fasi redazionali dell’epicedio (e parlereiappunto di ‘fasi’ redazionali, non di vere e proprie ‘redazioni’, giacché l’autore sembraessere intervenuto solo qua e là, correggendo certi errori ed eliminando alcune impro-prietà, ma senza procedere a un’autentica ‘riscrittura’ del componimento): C è testimo-ne della prima ‘fase’, T della seconda (che vide l’epicedio ritoccato in un solo punto, on-de correggere una svista prosodica; questa ‘fase’ corrisponde al testo inserito nellaraccolta ‘ufficiale’ di scritti poetici e prosastici messa insieme da Sigismondo della Stufapochi mesi dopo la morte della promessa sposa Albiera per onorarne la memoria),1 e Vdella terza (che coincise con una più accurata revisione dell’elegia). Il testo di quest’ul-tima revisione (che fu evidentemente rinvenuto dai postumi curatori dell’aldina – Pie-tro Crinito e Alessandro Sarti – fra le carte dell’umanista) dovette essere approntato dalPoliziano dopo che il componimento era ormai entrato in T.2 Ebbene, in tutti i testimoniil v. 36 si presenta nella forma sopra citata: «Compta Cytheriaco est pectine visa Venus».
La locuzione Cytheriaco pectine, tuttavia, è poco perspicua, e appare anzi pleonastica,visto che Cytheriacus vale ‘di Citera’, e quindi (Citera essendo, come ognun sa, l’isolagreca celebre in antico per il culto di Afrodite) ‘di Venere’; il v. 36 viene dunque a dire,in sostanza, che Albiera, quando raccoglie i suoi capelli in un nodo dorato, sembra Ve-nere acconciata col pettine di Venere. Qui Poliziano ha senza dubbio in mente un versoovidiano (Met., iv, 311), dove si parla della naiade Salmacide, che «sæpe Cytoriaco deducit pectine crines»; con allusione a Citòro, nome di una città e di un monte dellaPaflagonia (regione dell’Anatolia compresa tra il Ponto e la Bitinia) noti in antico per lefolte foreste di bosso (e dunque Cytoriacus pecten vale ‘pettine di bosso’). Il fatto, però, èche Poliziano doveva leggere questo verso di Ovidio in una forma diversa («sæpeCytheriaco deducit pectine crines»), giacché tanto la stragrande maggioranza dei ma-noscritti delle Metamorfosi, quanto la princeps delle opere ovidiane (Roma, Sweynheyme Pannartz, 1471), riportano appunto la banalizzazione Cytheriaco; e il nome della città edel monte in questione risultano variamente corrotti (Citheron, Citheri, Cyteros, Cythero)anche nelle prime stampe di altre opere latine – come i carmi di Catullo, le Georgiche diVirgilio e la Naturalis historia di Plinio – che di questi luoghi fanno menzione.3
Né poteva soccorrere Poliziano un testo come gli Argonautica di Valerio Flacco, chemenzionano il monte Citòro a v, 105: «Mox etiam Cromnæ iuga pallentemque Cyto-ron» (con allusione alle foreste di bosso che lo caratterizzano: l’aggettivo pallentem valeinfatti ‘giallastro’, come appunto è il legno del bosso). Così nelle edizioni moderne; ma,al solito, codici e stampe antiche riportano una lezione ben diversa. Nei manoscrittifiorentini quattrocenteschi e nella princeps (Bologna 1474) il verso si presenta nel modoseguente: «Mox etiam Cromanæ [vel Cromane] iuga pallentem Cytheron». Non solo:
filologia dell’infinitamente piccolo 11
1 Patetta 1917-1918.2 Per una più dettagliata ricostruzione della storia redazionale dell’epicedio si veda la Nota ai testi in
calce alla mia edizione (Bausi 2003, pp. 107-21).3 Catullo, iv, 11 e 13; Virgilio, Georg., ii, 437; Plinio, Nat. hist., vi, 5-6 e xvi, 71. Anche nell’unico altro
luogo della letteratura latina in cui – stando ai lessici – ricorre l’agg. Cytoriacus (Ovidio, Met., vi, 132), lamaggior parte dei codici legge Cytheriacus.
Cytheron, come attesta l’apparato della più recente edizione critica di Valerio Flacco, èlezione di tutti i manoscritti (e viene pertanto ricondotta all’archetipo); mentre la le-zione buona Cytoron fa la sua comparsa solo con la stampa ripolina del 1480 o ’81, ed erastata restaurata da Bartolomeo Fonzio alcuni anni prima sul manoscritto degli Argo-nautica da lui copiato (attuale Pl. xxxix 36 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Fi-renze), dove l’umanista intervenne per correggere Cromanæ in Cromnam, iuga in iugo,pallentem in pallente e anche Cytheron in Cythoron. Questi interventi, come dimostranol’inchiostro e la grafia, furono però effettuati dal Fonzio successivamente alla trascri-zione del testo, e risaliranno con ogni verosimiglianza ad alcuni anni più tardi, quandol’umanista iniziò il suo pluridecennale e monumentale lavoro ecdotico ed esegetico su-gli Argonautica; lavoro consegnato in gran parte ai ricchissimi marginalia depositati, inun arco di tempo che va dal 1476 al 1504, sull’esemplare della princeps posseduto dallostesso Fonzio e oggi conservato presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze (con la segnatura E.R. 431), dove parimenti, a v, 105, il Fonzio corresse in Cytoron la lezioneCytheron della stampa, rinviando – in una glossa marginale – a Plinio, Pomponio Melae Solino. Il Fonzio, dunque, approda sì alla lezione buona Cytoron, restaurandola sia nelcodice che nell’incunabolo (ed è probabilmente il primo ad arrivarci); ma vi approda sicuramente dopo il 1474, e quindi dopo che Poliziano aveva composto, e riveduto, l’epicedio di Albiera degli Albizi.
Le annotazioni polizianesche al carme iv di Catullo1 dimostrano come in origine(una soscrizione autografa ci informa che il lavoro correttorio ed esegetico sul poeta ve-ronese fu ultimato, nella sua prima fase, il 12 agosto 1473, e proprio questa prima fase ri-specchia dunque quali fossero – riguardo a Cytorus/Cytherus – le conoscenze del Poli-ziano nel periodo in cui egli andava componendo l’epicedio di Albiera) l’umanista fossein effetti convinto che la località ricca di bossi, e nota in antico per la fabbricazione el’esportazione di pettini, fosse l’isola di Citera; e come egli fondasse questa sua ideaesclusivamente sulle testimonianze dello stesso Catullo (dove egli leggeva infatti, al v.11, «Cythereo in iugo»)2 e di Ovidio (Met., iv, 311). In quest’ultimo luogo, come abbia-mo detto, Poliziano leggeva Cytheriaco, e riferiva dunque l’aggettivo all’isola di Citera,non però in quanto isola consacrata a Venere, ma in quanto isola considerata – erro-neamente – ricca di foreste di bossi; e «Cytheriaco pectine» (nell’epicedio di Albiera, v.36) veniva pertanto a significare, per antonomasia, ‘pettine di bosso’. In séguito, la co-noscenza di Probo – attestata da una prima postilla a Georg., ii, 4373 – permise a Poli-ziano di appurare che non di Cythera di trattava, ma di una città del Ponto chiamata Cy-therus; e, in un fase ancora successiva, l’ausilio di Strabone (xii, 3, 10, citato in unaseconda annotazione al medesimo luogo virgiliano, e in una successiva postilla al ca-tulliano carme iv) gli consentì di pervenire finalmente alla lezione buona, Cytorus (cheperò egli continuò a scrivere impropriamente Cythorus), restituendola quindi nei luoghicorrispondenti di Virgilio, Ovidio e Catullo.4
La presenza, al v. 36 dell’epicedio di Albiera, della lezione Cytheriaco (che si configuradunque come un errore d’autore) ci dice almeno due cose. La prima è che le modifiche
12 francesco bausi
1 Le postille a Catullo, ancora inedite, si trovano sull’esemplare della princeps (Venezia, Vindelino daSpira, 1472) posseduto dal Poliziano (attuale incunabolo 50 F 37 della Biblioteca Corsiniana e dell’Acca-demia dei Lincei di Roma). 2 Le edizioni moderne recano «Cytorio in iugo».
3 Le annotazioni alle Georgiche si trovano sull’esemplare della stampa romana del 1471 posseduto dalPoliziano (attuale incunabolo Rés. g. Yc. 236 della Bibliothèque Nationale di Parigi); sono pubblicate inCastano Musicò 1990. 4 Per un più esauriente esame della questione rimando a Bausi 2002.
apportate da Poliziano all’epicedio dopo la sua inclusione in T, e per questo testimo-niate dal solo V, devono comunque risalire a un’epoca piuttosto alta, non lontana dalmomento in cui l’elegia apparve e cominciò a circolare all’interno della silloge stessa;in caso contrario (se cioè Poliziano si fosse applicato alla revisione del componimentoin anni più tardi), la lezione Cytheriaco del v. 36 sarebbe stata infatti corretta, con ogniverosimiglianza, in Cythoriaco. D’altra parte, è logico che Poliziano tornasse sull’epice-dio (soprattutto per emendare alcuni errori prosodici, che probabilmente gli furono se-gnalati dai primi lettori del componimento) a breve distanza dalla sua prima diffusione,onde metterne in circolazione un testo più corretto; mentre stupirebbe – alla luce del-la storia intellettuale dell’umanista – che egli avesse deciso di rimetter mano all’elegianegli anni successivi, quando ormai i suoi interessi culturali si muovevano in direzioneben diversa, e quando l’epicedio (trascorsa l’occasione che lo aveva dettato) aveva per-duto la sua ‘attualità’. La seconda, e più interessante, è che il Poliziano dei primissimianni ’70, nonostante le cure dedicate già allora al testo di Catullo e di Marziale, è appe-na agli albori della sua filologia, come conferma anche il credito concesso (nell’elegiaal Fonzio, anch’essa del 1473, al v. 240) alla tradizione medioevale – generalmente ab-bandonata dagli umanisti – di designare Marziale con l’improprio nomignolo di Cocus.1Il Cytheriaco pectine dell’epicedio di Albiera, insomma, è una piccola ma significativa enon isolata testimonianza dell’ancora incerta e acerba ‘filologia’ del giovane Poliziano,che già in quegli anni cominciava ad applicarsi alla critica testuale, ma era ancora in granparte legato a una cultura ‘umanistica’ di tipo tradizionale, la cultura di un Landino odi un Verino, fondata essenzialmente sui poeti classici latini (Virgilio, Ovidio, Catullo)e poco profonda sui versanti della letteratura greca e della latinità argentea e tarda (set-tori che invece diventeranno centrali, a partire dagli anni ’80, nell’attività filologica e cri-tica polizianesca, e che già risultano sfruttati piuttosto largamente nelle Stanze, com-poste fra 1475 e 1478).
Ad avvertire Poliziano dell’errore in cui stava incorrendo al v. 36 dell’epicedio di Al-biera (sulla base dei testi corrotti di Catullo, di Virgilio, di Ovidio e di Valerio Flacco cuiegli si appoggiava) sarebbero bastati il Plinio della princeps veneziana e Strabone (anchequello latinizzato da Guarino Veronese e Gregorio Tifernate, apparso a stampa fin dal1469, dove ricorre sempre la lezione Cytorus): autori che però, nel 1473, non rientravanoa pieno titolo nell’orizzonte culturale polizianesco (è significativo che i passi pliniani re-lativi al monte e alla città di Citòro non siano mai citati né nelle postille alle Georgiche,né in quelle a Catullo; d’altronde, la prima sistematica recognitio di Plinio fu condottasolo nel 1480, e su un esemplare non della princeps, ma della stampa romana del 1473).2Così come erano ignoti al giovane Poliziano del 1473 altri testi, latini e soprattutto gre-ci, che parimenti gli avrebbero consentito di evitare l’abbaglio: non tanto PomponioMela (Chor., i, 104), Solino (44, 1), Apollonio Rodio (ii, 942) e Stefano di Bisanzio (i qua-li, a proposito del Citòro, non parlano delle foreste di bossi), quanto soprattutto Teo-frasto (Historia plantarum, iii, 15, 5, che troviamo citata per la prima volta nel commen-
filologia dell’infinitamente piccolo 13
1 Bausi 2003, p. 42.2 L’esemplare polizianesco è l’attuale Auct. Q 1 2 della Bodleian Library di Oxford, che reca due
subscriptiones, una datata 15 agosto 1480, l’altra 30 aprile 1490 (Perosa 1955, p. 22; Maïer 1965, pp. 351-52; Fera1995, pp. 442-43; Fera 1996, pp. 203-5). Quanto a Strabone, la Geographia sarà citata spessissimo – sia neltesto greco, sia nella versione latina – nel Commento alle ‘Selve’ di Stazio, steso per il corso universitariodel 1480/1481 (si veda l’Index auctorum in calce all’edizione Cesarini Martinelli 1978); ed excerpta dallaGeographia si trovano anche nello ‘schedario’ de poesi et poetis compilato da Poliziano, probabilmente, nel1479 (Cesarini Martinelli 1985, pp. 471-72).
to ai Fasti di Ovidio, redatto dal Poliziano per il corso del 1481/1482) ed Eustazio di Tes-salonica (glosse all’Iliade, ii, 853).
2.
Tutti conoscono la disputa epistolare che nel 1485 oppose Giovanni Pico della Miran-dola ed Ermolao Barbaro intorno allo stile dei filosofi.1 Alla lettera con cui Pico, il 3 giu-gno, aveva respinto (in modo semiserio e antifrastico) l’accusa di ‘barbarie’ e rozzezzalinguistica e stilistica scagliata dal Barbaro contro i pensatori medievali, l’umanista ve-neziano replicò alcuni mesi più tardi con una non meno elaborata e artificiosa lettera,smontando con le armi della logica e della dialettica le argomentazioni retoriche del Mi-randolano. Qui mi interessa il § 105 dell’epistola del Barbaro:
Quid sit autem maiestas in dicendo, quid veneratio, quid gravitas, quid dignitas, quid sanctitas,quid asperitas, quid squalor, quid horror, percipere non videri, qui sic pronuncient; cuius præ-ceptionis plenos Aristotelis, Theophrasti, Dionysii, Ciceronis, Quintiliani, recentiorum Hermo-genis, Alexandri Minutiani libros esse.2
Questo il testo nell’edizione critica dell’epistolario barbariano curata da Vittore Brancanel 1943,3 che per questa lettera si fonda sul manoscritto 1415 della Biblioteca Statale diLucca (cc. 20r-23v), testimone della seconda e definitiva redazione della lettera;4 edi-zione poi riprodotta (limitatamente a questa epistola) nella silloge dei Prosatori latini delQuattrocento allestita da Eugenio Garin nel 1952.5 Lo stesso Garin annota in quella sedeche il personaggio citato dal Barbaro dopo Ermogene è «Alessandro Minuziano, di SanSevero (Puglie), morto nel 1522», il quale «fu editore, e insegnò a Venezia e a Milano».L’identificazione non è mai stata messa in dubbio, ed è ribadita anche da Letizia Paniz-za in un lavoro recente, dove la studiosa, a proposito del passo ora citato della letteradel Barbaro, osserva tuttavia:
Della dottrina dei genera dicendi, sono pieni i libri di Aristotele, Teofrasto, Dionigi d’Alicarnasso,Cicerone, Quintiliano, e tra i recenti – qui pare che il pappagallo faccia altri spropositi – Ermo-gene ed Alessandro Minuziano, il contemporaneo di Barbaro. Ermogene non è recentior, e Ales-sandro Minuziano non è della stessa pasta dei maestri antichi. Sembra che il Padovano abbia an-che confuso due Alessandri: il primo recentior (Alessandro Minuziano), ma l’altro il più notoAlessandro d’Afrodisia, discepolo di Aristotele e commentatore dei suoi Topici, del quale Barba-ro possedeva il manoscritto. Si tratta, in effetti, di tutti gli autori prediletti da Barbaro; con Ales-sandro d’Afrodisia, sembra che voglia richiamare l’attenzione sull’importanza dei Topici, con icommenti in greco, e non solo in latino.6
La Panizza, dunque, si rende conto del fatto che l’inclusione del Minuziano (editore efilologo contemporaneo del Barbaro, attivo prevalentemente a Milano, curatore di una
14 francesco bausi
1 Edizione e commento in Bausi 1998a.2 «Che cosa sia poi la maestà nell’espressione, cosa la venerabilità, cosa la gravità, cosa la dignità, cosa
la santità, cosa l’austerità, cosa l’asprezza, cosa la rozzezza, non sembrano avere ben chiaro coloro cheparlano in questo modo; eppure, di tali insegnamenti sono pieni i libri di Aristotele, di Teofrasto, di Dionigi, di Cicerone, di Quintiliano, e dei più moderni Ermogene e Alessandro Minuziano».
3 Branca 1943, p. 107.4 Gli altri due testimoni (che trasmettono la redazione originaria, quella effettivamente inviata a Pico)
sono il ms. Capponi 235, parte ii, cc. 2v-7r, della Biblioteca Apostolica Vaticana, e la princeps degli Omniaopera del Poliziano (Venezia, Aldo Manuzio, 1498, cc. m iiii v-m viii r; la lettera del Barbaro, come quellapichiana, è infatti inclusa nel Liber epistolarum polizianeo). 5 Garin 1952, p. 860.
6 Panizza 1996, pp. 303-4.
grande edizione ciceroniana, apparsa però solo nel 1498-1499) in questo elenco di auc-toritates retoriche greco-latine è decisamente impropria (anche se sottolinea che il Mi-nuziano «promuove un Cicerone grande filosofo ed oratore, avendo uno stile perfetta-mente adatto al discorso filosofico»); e ipotizza che quello di Ermolao sia un erroreintenzionale, da lui attribuito all’immaginario filosofo patavino cui l’umanista venezia-no mette in bocca, nella sua epistola, il discorso incaricato di evidenziare la fallacia e l’in-consistenza delle argomentazioni proposte da Pico (che a sua volte le aveva fatte enun-ciare da un immaginario filosofo ‘scolastico’) contro l’uso di uno stile eloquente edelaborato nelle opere filosofiche. Questa tesi – secondo cui, come abbiamo visto, l’im-maginario filosofo padovano (da lei definito anche «scimmia» e «pappagallo», perché ri-peterebbe, senza capirne il significato, termini e concetti desunti da Aristotele e da altriauctores) confonderebbe inoltre Alessandro Minuziano con il maggiore tra i commen-tatori greci di Aristotele, Alessandro di Afrodisia – si accorda con la generale interpre-tazione che la Panizza fornisce della lettera barbariana: secondo la studiosa, infatti, ilBarbaro farebbe in modo che il suo filosofo patavino, «non sapendo niente né di dialet-tica né di retorica né d’Aristotele, incorra inconsapevolmente in sofismi e barbarismi diogni genere», infarcendo il suo discorso di errori marchiani e comici che avrebbero loscopo di mettere in ridicolo i peripatetici dell’Università di Padova, colleghi di Ermolaoe avversari del suo progetto di restituzione del ‘vero’ Aristotele.
In verità, nel passo che qui ci interessa non c’è alcun ‘errore’ del filosofo patavino: l’er-rore è tutto nostro, ossia dei moderni editori dell’epistola. È necessario infatti inserireuna virgola tra Alexandri e Minutiani, giacché il Barbaro non vuole alludere certo adAlessandro Minuziano, come tutti, a partire da Branca, hanno creduto, ma senza dub-bio a due distinti e diversi personaggi, vale a dire Alessandro Sofista e Minuciano, reto-ri greci vissuti tra il ii e il iii secolo d.C., la menzione dei quali è perfettamente con-gruente al contesto. In questo paragrafo si fa riferimento alle teorie relative alle varieforme del discorso, rinviando a un manipolo di auctoritates latine e soprattutto greche,elencate in ordine cronologico: cinque più antiche (Aristotele, Teofrasto, Dionigi di Ali-carnasso, Cicerone, Quintiliano) e tre definite recentiores (Ermogene, Alessandro Sofi-sta e Minuciano). Ora, come detto, Alessandro Sofista e Minuciano sono due retori gre-ci vissuti tra il ii e il iii secolo d.C., dunque contemporanei di Ermogene, e con luiannoverabili fra i recentiores: il primo è autore di un De figuris sensus et dictionis (¶ÂÚd ÙáÓÙɘ ‰È·ÓÔ›·˜ ηd Ùɘ Ϥ͈˜ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ), mentre al secondo si deve un De argumentis(¶ÂÚd ëȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ). Queste operette furono edite solo nel xvi secolo;1 il Barbaro po-teva però leggerle manoscritte (molti codici contenenti testi retorici greci furono por-tati a Venezia da Giano Lascaris e da altri dotti suoi conterranei, e costituirono il fon-damento della grande edizione aldina dei Rhetores Græci apparsa nel 1508-1509, checomprende anche, nel primo volume, il trattato di Alessandro Sofista e – ma solo in par-te – quello di Minuciano), oppure conoscerle attraverso le frequenti citazioni che di es-se si trovano nei commentatori bizantini di Ermogene2 (alla biblioteca di Ermolao ap-parteneva un codice contenente la «Rhetorica Hermogenis cum commentariis»).3 DiAlessandro Sofista e di Minuciano parla anche il lessico Suda (i, p. 104 e iii, p. 398 Adler),dove al secondo sono attribuiti dei Progymnasmata, una Ars rhetorica e alcune orazioni;ma oggi, sulla base della cronologia, si distinguono due retori con questo nome, Mi-nuciano il Vecchio (ii secolo d.C., autore dell’Ars rhetorica) e Minuciano il Giovane (iii
filologia dell’infinitamente piccolo 15
1 Ora si leggono in Walz 1832-1836 (1968), rispettivamente viii, pp. 421-86 e ix, pp. 601-13.2 Walz 1832-1836 (1968), voll. iv-vi, ad ind. 3 Diller 1963, pp. 258 e 261.
secolo d.C., autore del De argumentis). Minuciano, inoltre, è citato dal Trapezunzio nelv libro della sua Rhetorica – opera ben nota a Ermolao, che se ne serve anche in questa stessa epistola a Pico – come un precursore di Ermogene, proprio riguardo alla dottri-na delle formæ dicendi:Nam etsi Hermogenes et clarius et distinctius cæteris omnibus qui ante eum fuerunt de dicendiformis, quas græce ·˜ vocamus, disseruit, a multis tamen ille potuit tam præcepta quamexempla delecta […] colligere. Nam […] Minutianus, quamvis confuse nimis, multa tamen etpræcepta et exempla, partim ab aliis designata, partim sua industria sumpta a clarissimis orato-ribus, illi parata subiecit.1
Quella di Branca, insomma, si configura come una vera e propria facilior: più noto – al-meno a chi si occupa di cose umanistiche e di letteratura quattrocentesca – essendoAlessandro Minuziano rispetto ai retori bizantini Alessandro Sofista e Minuciano, l’edi-tore moderno ha compiuto un’errata identificazione e, banalizzando il testo, ha omes-so l’indispensabile virgola fra Alexandri e Minutiani. Qui la filologia dei «dettagli» e del-l’infinitamente piccolo tocca il suo culmine: una virgola in più o in meno, infatti,determina un mutamento di interpretazione che non riguarda solo il passo in questio-ne, ma investe anche il testo nel suo complesso. Come abbiamo visto, la Panizza si ap-poggia anche a questo luogo per sostenere la sua tesi, secondo la quale il Barbaro fa-rebbe cadere volutamente il suo portavoce in una serie di grossolani strafalcioni, ondedimostrare l’ignoranza dei filosofi dell’università patavina; ma il fatto che in questo pas-so non ci sia alcun errore induce a mettere in dubbio la validità di una simile lettura,che in effetti non trova conferme nel testo, giacché a un esame attento nessuno deglierrori attribuiti dalla Panizza all’immaginario filosofo padovano si rivela tale.2 Anzi, lalettera del Barbaro dimostra una perfetta padronanza dei testi, del pensiero e della ter-minologia aristotelica, in particolare per quanto riguarda la logica e la dialettica; e pa-rimenti esibisce una raffinata elaborazione letteraria, capace com’è di esporre com-plesse argomentazioni tecniche in un latino scorrevole ed elegante, non alieno dapreziosità lessicali e stilistiche.
3.
Il terzo esempio è desunto dal capitolo 10 del primo libro dei machiavelliani Discorsi.Leggiamone i §§ 16-17 secondo il testo critico da me stabilito, nel quale evidenzio colcorsivo il passo su cui verterà la presente scheda:
[16] Consideri ancora, quello che è diventato principe in una republica, quanta laude, poi che Ro-ma fu diventata imperio, meritarono più quegli imperadori che vissero sotto le leggi e come prin-cipi buoni, che quegli che vissero al contrario; e vedrà come a Tito, Nerva, Traiano, Adriano, Anto-nio e Marco non erano necessarii i soldati pretoriani né la moltitudine delle legioni a difendergli, perchéi costumi loro, la benivolenza del popolo, l’amore del senato gli difendeva. [17] Vederà ancora co-me a Gallicola, Nerone, Vitellio, e a tanti altri scelerati imperadori non bastarono gli esercitiorientali e occidentali a salvarli contro a quegli inimici che gli loro rei costumi, la loro malvagiavita aveva loro generati.3
Il passo si presenta in questa veste in tutti e tre i testimoni dell’opera (il manoscritto Har-ley 3533 della British Library di Londra; la princeps romana di Antonio Blado del 1531; la
16 francesco bausi
1 Trapezunzio 1472, cc. 117v-118r; e si veda anche c. 30r.2 Rimando per questo al mio commento all’epistola barbariana (Bausi 1998a, pp. 131-70).3 Bausi 2001, pp. 71-72.
stampa giuntina dello stesso anno), eccezion fatta per minime varianti formali, irrile-vanti ai nostri fini. Nondimeno, tutti gli editori moderni, già prima dell’edizione criticacondotta da Guido Mazzoni nel 1929, correggono Antonio in Antonino,1 considerandoloevidentemente un errore di tradizione, poiché qui in effetti si allude all’imperatore An-tonino Pio. La lezione dei testimoni è però da conservare, giacché Antonino Pio risul-ta designato come Antonio in almeno due testi volgari certamente ben noti a Machia-velli, quali l’abbozzo del primo capitolo del petrarchesco Triumphus Fame (v. 100, quiprobabilmente riecheggiato: «Traiano ed Adrïano, Antonio e Marco») e come il relati-vo Commento di Jacopo di Poggio Bracciolini («Questo Antonio fu quello che fu dectoAntonino Pio»).2 Guido Martellotti osserva a questo proposito che Petrarca, nella redazione definitiva del Triumphus Fame (i, 124: «Helio Adrïano e ’l suo Antonin Pio»),ripristinò – sulla base dell’Historia Augusta – la forma corretta Antonino; e ricorda che laforma Antonius per Antoninus si riscontra anche nel Policraticus di Giovanni di Salisburye, questa volta in riferimento a Marco Aurelio Antonino, nella tradizione manoscrittadella Familiares petrarchesche (vii, 15, 4-5, dove Vittorio Rossi inopportunamente emen-dò Antonium – che però, come sottolinea lo stesso Martellotti, è certo «la scrittura ori-ginaria del Petrarca» – in Antoninum).3
Antonio per Antonino non è dunque un errore di tradizione, ma un errore d’autore(che Machiavelli ha desunto da testi a lui familiari e che riflette le sue letture e le sue co-noscenze), e deve essere pertanto conservato a testo;4 ed è questo, ancora un volta, unodi quei minimi «dettagli» filologici che, come ha scritto Martelli, sono «destinati a re-stare dettagli con la determinante collaborazione di chi non li vuol mettere a frutto».5Il recupero di una lezione come Antonio nel capitolo decimo del primo libro dei Discor-si, infatti, può dirci molto intorno a un tema capitale e dibattutissimo come quello del-la ‘cultura’ di Machiavelli, fornendo un’ulteriore e non trascurabile conferma della suanatura prettamente ‘volgare’, ‘moderna’ e ‘poetica’. È certo significativo, in quest’otti-ca, che, quando Machiavelli deve citare gli imperatori romani saliti al trono per adozio-ne, alla sua memoria non si affaccino gli storici latini, ma un poeta volgare come il Pe-trarca dei Trionfi (opera, com’è noto, assai familiare al segretario fiorentino, e da lui piùvolte citata a memoria nelle lettere),6 dal quale ricava la forma erronea Antonio per An-tonino (Pio); forma che avrebbe potuto agevolmente correggere se solo si fosse ricorda-to di testi come la Historia Augusta (peraltro a lui scarsamente nota e solo occasional-mente utilizzata nei Discorsi) e anche come il primo capitolo della stesura definitiva delTriumphus Fame (qui messo in ombra dall’abbozzo, credo, perché quest’ultimo era sta-to oggetto del commento di Jacopo Bracciolini, un altro testo ben conosciuto da Ma-chiavelli e da lui più volte messo a frutto nei Discorsi).
Gli imperatori ‘buoni’ elencati nel passo in questione di Discorsi, i, 10 costituiscono ineffetti quella che in Petrarca (dove manca il solo Nerva) è definita «la famiglia che pervarco | d’adoptïon al sommo imperio monta» (Triumphus Fame, ia, 98-99); versi così
filologia dell’infinitamente piccolo 17
1 Ignoro chi per primo abbia introdotto la correzione, che, per esempio, già si trova nell’edizione deiDiscorsi di Piergili 1893.
2 Vedi l’edizione parziale compresa in Bausi 1989, pp. 122-49: 143. Per la conoscenza del Commento al‘Trionfo della Fama’ di Jacopo Bracciolini (edito due volte, nel 1475-1478 circa a Roma e nel 1486 a Firen ze)da parte di Machiavelli: Dionisotti 1980, p. 91; Bausi 1989, pp. 83-87, 100, 109-13; Bausi 1998b, pp. 90-93.
3 Martellotti 1949, p. 62.4 D’altronde, negli altri luoghi machiavelliani in cui ricorre il nome Antonino (Discorsi, iii, 6, 85 e 131;
Principe, xix, 27, 40, 50, 53) non si tratta mai di Antonino Pio, ma sempre di Caracalla.5 Martelli 2001, p. 238. 6 Si veda da ultimo Simonetta 2004, pp. 243-51.
chiosati da Jacopo Bracciolini nel suo Commento al ‘Trionfo della Fama’: «Ma ben v’era lafamiglia che non per heredità come molti, non per usurpatione (come Galba, Octone,Vitellio), ma per electione o adoptione era montata a tanto imperio: come Nerva, Tra-iano, Adriano e altri che raconta; de’ quali Nerva, dopo Domitiano, electo dal Senato,fu facto imperadore, huomo temperato e modesto e civile».1 E da testi come questi de-riva sicuramente a Machiavelli anche l’esaltazione della successione adottiva che si leg-ge al § 20 del medesimo capitolo i, 10 dei Discorsi:
Vedrà ancora, per la lezione di questa istoria, come si può ordinare uno regno buono: perché tut-ti gl’imperadori che succederono allo imperio per eredità, eccetto Tito, furono cattivi; quegli cheper adozione, furono tutti buoni, come furo quegli cinque da Nerva a Marco; e come lo impe-rio cadde negli eredi, e’ ritornò nella sua rovina.2
Per la polemica contro la trasmissione ereditaria del potere, alcuni commentatori cita-no Tacito (Hist., i, 16, dove Galba, in occasione dell’adozione di Pisone, condanna il si-stema della successione ereditaria); ma anche in questo caso ritengo che Machiavelli sifondi su Petrarca, il quale nel medesimo abbozzo del primo capitolo del Triumphus Fa-me scrive, a proposito di Marco Aurelio (cui successe l’inetto e corrotto figlio Commo-do), che «facea d’adottar anch’egli il meglio» (v. 101), biasimandolo per non aver adotta-to un degno successore. E si veda anche, nuovamente, il Commento di Jacopo Bracciolini:«felice per certo [scil. Marco Aurelio] se non havessi lasciato herede Lucio AntoninoCommodo, suo figliuolo naturale, il quale […] fu principio della ruina dello imperio ro-mano, però che da quel tempo inanzi cominciorono per successione a sforzarsi di fareciascuno il peggio che potessi, in modo che disfeciono tanto imperio conservato et ac-cresciuto dignissimamente fino al tempo di Antonino philosopho [cioè dello stesso Mar-co Aurelio]».3 La lezione Antonio in Discorsi, i, 10 non è d’altra parte un fenomeno iso-lato: un caso pressoché identico si rintraccia, nella stessa opera, a ii, 4, 30, dove TitoQuinzio Flaminino è chiamato da Machiavelli Flaminio, esattamente come sempre lochiama il Petrarca nei Trionfi (Tr. Fame, i, 74 e ia, 77) e nelle opere latine, e come ricorreancora nel commento di Jacopo Bracciolini;4 anzi, è opportuno conservare a testo lagrafia del manoscritto e della stampa bladiana (Flamminio, contro Flaminio della giunti-na, inopportunamente preferita, per amor di regolarità, da tutti gli editori), che trovapreciso riscontro in Tr. Fame, i, 74 («Tito Flamminio, che con forza vinse») e nella lette-ra di Machiavelli a Francesco Vettori del 20 dicembre 1514, di cui possediamo l’autogra-fo («Tito Flamminio»).5
Insomma, quando Machiavelli evocava questi e altri personaggi dell’antica storia ro-mana, le prime letture che affioravano alla sua memoria erano quelle dei poeti volgari,che tanta parte avevano avuto nella sua formazione culturale e che certo gli erano piùfamiliari degli autori greci e latini; e il caso di Antonio/Antonino è per certi versi simile aquello di Discorsi, iii, 29, dove, onde dimostrare che (come recita il titolo del capitolo)«gli peccati de’ popoli nascono dai principi» e commentare la sentenza di Livio secon-do cui la moltitudine «semper regenti est similis» (v, 28), Machiavelli non cita nemme-no uno dei mille autori antichi, medievali e umanistici che avevano riproposto questo
18 francesco bausi
1 In Bausi 1989, p. 140. 2 Bausi 2001, p. 73. 3 In Bausi 1989, p. 144.4 Si veda ancora Martellotti 1949, p. 62. Per le opere latine, Afr., ii, 135; Fam., i, 2, 27; Rer. mem., ii, 79.
E inoltre il commento del Bracciolini a Tr. Fame, ia, 77: «Tito Quintio Flaminio, figliuolo di Caio Flami-nio, vinto e morto da Hanibale in sul lago di Perugia»; «Flaminio, tornato a Roma, triomphò»; «E que-sto fu l’ultimo acto di Flaminio». 5 Martelli 1971, p. 1187a.
luogo comune1 («quales in republica principes essent, tales reliquos solere esse cives»,aveva scritto ad esempio Cicerone nelle Epist. ad fam., i, 9, citato, fra i tanti, da PoggioBracciolini nel De avaritia),2 ma si limita a riportare due versi tratti dalla Rappresenta-zione di san Giovanni e Paolo di Lorenzo de’ Medici (xcic, 7-8: «E quel che fa ’l signor fan-no poi molti, | Ché nel signor son tutti gli occhi volti»). Versi che cita in modo appros-simativo, e dunque a memoria, a dimostrazione, ancora una volta, del fatto che da testicome questi – poetici, fiorentini e volgari – era soprattutto costituito lo strato più pro-fondo, lo ‘zoccolo duro’ della sua cultura.
filologia dell’infinitamente piccolo 19
1 Peraltro già biblico: «et qualis rector est civitatis, tales et inhabitantes in ea» (Eccli., 10, 2).2 Si veda Martelli 1998, pp. 183-85.
Abbreviazioni bibliograficheBausi 1989 = Francesco Bausi, Politica e cultura nel «Commento al Trionfo della Fama» di Jacopo Brac-
ciolini, «Interpres», 9, pp. 64-149.Bausi 1998a = Ermolao Barbaro, Giovanni Pico della Mirandola, Filosofia o eloquenza?, a cura di
Francesco Bausi, Napoli, Liguori.Bausi 1998b = Francesco Bausi, Machiavelli e la tradizione culturale toscana, in Cultura e scrittura
di Machiavelli, Atti del Convegno di Firenze-Pisa (27-30 ottobre 1997), Roma, Salerno Editrice,pp. 81-115.
Bausi 2001 = Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, a cura di Francesco Bausi, Roma, Salerno Editrice.
Bausi 2002 = Francesco Bausi, ‘Citèro’ o ‘Citòro’? Un errore del giovane Poliziano, «Interpres», 21,pp. 205-25.
Bausi 2003 = Angelo Poliziano, Due poemetti latini. Elegia a Bartolomeo Fonzio, Epicedio di Albieradegli Albizi, a cura di Francesco Bausi, Roma, Salerno Editrice.
Branca 1943 = Ermolao Barbaro, Epistolæ, orationes et carmina, ed. critica a cura di Vittore Bran-ca, 2 voll., Firenze, Bibliopolis.
Castano Musicò 1990 = Angelo Poliziano, Commento inedito alle «Georgiche» di Virgilio, a cura di Livia Castano Musicò, Firenze, Olschki.
Cesarini Martinelli 1978 = Angelo Poliziano, Commento inedito alle «Selve» di Stazio, a cura di LuciaCesarini Martinelli, Firenze, Sansoni.
Cesarini Martinelli 1985 = Lucia Cesarini Martinelli, ‘De poesi et poetis’: uno schedario sconosciutodi Angelo Poliziano, in Tradizione classica e letteratura umanistica. Per Alessandro Perosa, a cura diRoberto Cardini, Lucia Cesarini Martinelli, Eugenio Garin, Giovanni Pascucci, Roma, Bulzo-ni, ii, pp. 455-87.
Diller 1963 = Aubrey Diller, The Library of Francesco and Ermolao Barbaro, imu, 6, pp. 253-62.Dionisotti 1980 = Carlo Dionisotti, Machiavellerie. Storia e fortuna di Machiavelli, Torino, Einaudi.Fera 1995 = Vincenzo Fera, Un laboratorio filologico di fine Quattrocento: la «Naturalis Historia», in
Formative stages of classical traditions: Latin texts from Antiquity to the Renaissance, ed. by Otta-vio Pecere and Michael David Reeve, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo,pp. 435-66.
Fera 1996 = Vincenzo Fera, Poliziano, Ermolao Barbaro e Plinio, in Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro, Atti del Convegno di Studi in occasione del quinto centenario della morte dell’umanista Ermolao (Venezia, 4-6 novembre 1993), a cura di Michela Marangoni e ManlioPastore Stocchi, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, pp. 193-234.
Garin 1952 = Prosatori latini del Quattrocento, a cura di Eugenio Garin, Milano-Napoli, Ricciardi.Inglese 2000 = Giorgio Inglese, Il «Principe» e i filologi, «La Cultura», 38, pp. 161-66.Maïer 1965 = Ida Maïer, Les manuscrits d’Ange Politien. Catalogue descriptif. Avec dix-neuf documents
inédits en appendice, Genève, Droz.Martelli 1971 = Niccolò Machiavelli, Tutte le opere, a cura di Mario Martelli, Firenze, Sansoni.Martelli 1997 = Mario Martelli, Edizione nazionale delle opere di Niccolò Machiavelli, Roma, Salerno
Editrice.Martelli 1998 = Mario Martelli, Machiavelli e gli storici antichi. Osservazioni su alcuni luoghi dei
«Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio», Roma, Salerno Editrice.Martelli 1999 = Mario Martelli, Saggio sul «Principe», Roma, Salerno Editrice.Martelli 2001 = Mario Martelli, I dettagli della filologia, «Interpres», 20, pp. 212-71.Martellotti 1949 = Guido Martellotti, Linee di sviluppo dell’umanesimo petrarchesco, «Studi petrar-
cheschi», ii, pp. 51-80, poi in Martellotti 1983, pp. 110-40.Martellotti 1983 = Guido Martellotti, Scritti petrarcheschi, a cura di Michele Feo e Silvia Rizzo,
Padova, Antenore.Panizza 1996 = Letizia Panizza, Ermolao Barbaro e Pico della Mirandola tra retorica e dialettica: il «De
generi dicendi philosophorum» del 1485, in Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro, pp. 277-330.
20 francesco bausi
Patetta 1917-1918 = Federico Patetta, Una raccolta manoscritta di versi e prose in morte d’Albiera degliAlbizzi, «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», 53, pp. 290-94, 310-28.
Perosa 1955 = Mostra del Poliziano nella Biblioteca Medicea Laurenziana. Manoscritti, libri rari, auto-grafi, documenti, a cura di Alessandro Perosa, Firenze, Sansoni.
Piergili 1893 = Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, commentati da Giu-seppe Piergili, Firenze, Successori Le Monnier.
Sasso 1997 = Gennaro Sasso, Machiavelli e gli antichi e altri saggi, iv, Milano-Napoli, Ricciardi.Simonetta 2004 = Marcello Simonetta, Rinascimento segreto. Il mondo del Segretario da Petrarca a
Machiavelli, Milano, Franco Angeli.Trapezunzio 1472 = Georgii Trapezunzii Rhetoricorum libri quinque, Venezia, Vindelino da Spira,
non ante 1472.Walz 1832-1836 (1968) = Rhetores Græci…, edidit … Christian Walz, Osnabrück, Zeller, 9 voll. (rist.
anast. dell’ed. London-Stuttgart-Tübingen, 1832-1836).
filologia dell’infinitamente piccolo 21
Accademia editoriale®
Casella postale n. 1, Succursale n. 8 · i 56123 PisaTel. +39 050 542332, fax +39 050 574888E-mail: [email protected] · www.libraweb.net
Abbonamenti · SubscriptionsItalia: Euro 95,00 (privati) · Euro 195,00 (enti, con edizione Online)
Abroad: Euro 165,00 (individuals) · Euro 245,00 (Academic Institution, with Online Edition)Prezzo copia singola / Single issue: Euro 300,00
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento sul c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Eurocard, Mastercard, Visa).
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28 · i 56127 PisaUffici di Roma: Via Ruggiero Bonghi 11/b · i 00184 Roma
*
La casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possi-bilità di richiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo al nostro indirizzo. Le informa-zioni custodite dalla casa editrice verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati
nuove nostre proposte (D. Lgs. 196/2003).
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 18 del 26 novembre 2003Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento anche parziale oper estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi messo effettuati, compresi la copia fotostatica,il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc. senza la preventiva autorizzazione della
Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma,un marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2008 by Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma,
un marchio della Accademia editoriale®, Pisa · Roma.
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 1724-6113issn elettronico 1825-1021
SOMMARIO
Francesco Bausi, Filologia dell’infinitamente piccolo 9Marco Berisso, «Clericus clerico lupissimus». Sul testo dell’«Intelligenza» 23Stefano Carrai, Quale lingua per la «Vita nova»? La restituzione formale di un testo
paradigmatico 39Giorgio Inglese, Per lo ‘stemma’ della «Commedia» dantesca. Tentativo di statistica
degli errori significativi 51Paolo Trovato, Postille sulla tradizione della «Commedia» 73Emiliano Bertin, Nuovi argomenti per l’idiografia di un testimone del «Teleutelogio»
di Ubaldo di Bastiano da Gubbio 79Andrea Donnini, Un ‘nuovo’ autografo bembiano (dal Vaticano Lat. 13252) 89Renzo Rabboni, Sul canzoniere «in movimento» di Nicolò Martelli. Dalla forma Mi-
nerbetti (1530) alla forma Salterelli (1547) 103Gabriele Bucchi, La «Guerra de’ topi e de’ ranocchi» attribuita ad Andrea del Sarto:
un falso di Francesco Redi? 127Paola Italia, I tre tempi degli «Idilli» leopardiani (con un’edizione del quaderno na-
poletano) 173Cristina Montagnani, Il viaggio immobile. D’Annunzio e la genesi di «Maia» 215
Indici, a cura di Fabio Romaninii. Indice dei nomi 251ii. Indice dei manoscritti e dei postillati 261
Sigle impiegate in questa rivista 265