Roncaglia e la filologia romanza
Transcript of Roncaglia e la filologia romanza
RonEnro ANroNBrrt
AURELIO RONCAGLIA, LA FILOLOGIA ROMANZA
A dieci anni dalla scomparsa, la figura scientifica e umana di AurelioRoncaglia d non solo ancora vivissima nella memoria degli studiosi e diquanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo o di leggerlo purnon avendolo magari mai incontrato, ma costituisce tuttora una presenza
attiva, un interlocutore autorevole e insieme amichevole e solidale, cui si
rivolge il pensiero di quanti praticano la fllologia e linguistica romaflza ela storia della linguistica e delle letterature romanze, dalle origini ai gior-ni nostri. Lo testimoniano non solo la decisione dell'Accademia di ricor-darlo in questo convegno ma il concorso di presenze e di messaggi, la cuiimponenza d tale e tanta che rende ancor pii difficile il compito di quanti
oggi sono chiamati a parlare. Una ragione fondamentale per un tale concor-so di stima - ma certo non la sola - credo la si possa gii preliminarmenteprovare ad indicare: Roncaglia ha davvero rappresentato per molti decenni,
nella maniera scientificamente piir impegnata e approfondita e nelf impe-gno dialettico pii forte, una vera e propria polaritd positiva d'intendere e
praticare la Filologia romanza, disciplina dai vasti, molteplici e contrastaticonfini spaziali e temporali: dall'Europaromanza alla Americhe, all'Africa,perfino all'Asia; dall'eti tardo-antica all'Umanesimo, alla contemporanei-td. Una disciplina soggetta quindi anch'essa, nel tempo e nello spazio, allepii varie interpretazioni ed esecuzioni teoriche e pratiche, che sempre perb
aspiravano ad una deflnizione e ad un punto di coagulazione, o almeno ad
una polaritd, quella appunto che Roncaglia ha saputo interpretare, per rico-noscimento unanime.
I protocolli retorici di circostanza vorrebbero che liminarmente illustras-si f importanza e la statura scientifica e culturale di Roncaglia, tracciandonela biografia (a cominciare dal folgorante accesso alla Scuola Normale, fa-mosissimo per 1'alto punteggio raggiunto) e il cursus studiorum e honorum,ed elencando magari tutti i grandi e numerosi riconoscimenti internazio-nali, dalle lauree honoris caLtsa, alle presidenze dr numerose e prestigiose
istituzioni e Accademie che 1o hanno visto insieme autorevolissimo mem-
-14-bro e protagonista, dalla societd de linguistique internationale alla unionacad6mique internationale, alla Societd Italiana di Filologia Romanza, chequi sono state rappresentate nel saluto del nostro Presidente e del Presidentedella SIFR, l'associazione italiana dei filologi romanzi. un ricordo parti-colare, in questa nostra sede, merita perb il suo impegno quale segretario epoi presidente dell'Union acaddmique internationale, alla quale ha dedicato,proprio nell'ediflcio di fronte, anni di proficua attivitd, con riconosciuto be-neficio di molte intraprese scientiflche della nostra Accademia e di quelleconsorelle, in Italia e in Europa, a cominciare dal quel Corpus tropatorumcui dedicd attentissime cure a passione.
Sarebbe certamente giusto e doveroso soffermarci su questo aspetto, mail convegno b dedicato innanzitutto a ricordare quel che ad Aurelio Ronca-glia d sempre stato pii e profondamente a cuore, prima di ogni altro ricono-scimento ufficiale o accademico: l'attivitd di ricerca el'avanzamento deglistudi della sua disciplina, la fllologia romanza. Ed al legame fra Roncagliae la fllologia romanza b dedicato il convegno, non solo perchd egli ha rap-presentato una flgura oggi sempre pii rara (ma tale era gid ai tempi del gio-vane Roncaglia, che indagava sulle ragioni storiche del cambiamento), unafigura sempre piir rara di fllologo romanzo attivo sull'intera area neolatina,dal Portogallo, dalla Spagna e dalla Romania atlantica, anzi caruibica, allaRomania e dalla Sicilia a Liegi e al Nord-Europa: per di pii aperto, cul-turalmente e scientificamente, a un'Europa comprensiva di tutta la culturamediterranea, bizantina, araba ed ebrea e a tutta la Slavia. Lo testimoniaeloquentemente gid il programma del convegno con tanti e illustri relatoriche parleranno in modo specifico su tutti, o meglio quasi tltti, gli aspettidell'attiviti scientiflca di Roncaglia, pur se l'assenza del collega Mcilk, acui rivolgiamo i migliori auguri per una pronta guarigione, ci ha privati perora del contributo importante di uno degli interlocutori pli apprezzati dalMaestro.
A spingerci ad anahzzare non solo il rapporto di Roncaglia con la suadisciplina ma ad identificare quasi il suo percorso esistenziale e scientificocon la sua disciplina (Aurelio Roncaglia, la Filologia romanza), ci ha perbindotto non solo quella sua fisionomia complessiva cosi estesa e competentedi studioso, ma la continuiti e centralitd che nella sua opera ha goduto lariflessione sulle origini, 1o sviluppo e il destino futuro della Filologia ro-mafizai un tema presente in alcuni passaggi-chiave della sua ricerca e dellasua carriera e una preoccupazione costante di tutta la sua attivitl scientifica,accademica e politico-culturale.
Quando nel L954, a soli 37 anni, si insediava come ordinario sulla pre-stigiosa cattedra dell'Universith di Pavia, erano appunto le <ragioni ideali>della Filologia romanza che proponeva all'attenzione dei nuovi colleghi e
_ 15 _
degli studenti nella sua prolusion.tt) (gid ricordata da Madeleine Tyssens in
altra occasione(2)), in un momento in cui la sua disciplina sembrava <<attra-
versare un periodo di crisi> nell'ordinamento universitario (non mi produrrb
in facili battute su quel che sarebbe stata la sua reazione nella situazione
odierna):<Come attuare e mantenere l'unitd scientiflca e didattica di una disci-
plina che in linea di diritto aspira ad abbracciare tutto il complesso mondo
culturale delle lingue e delle letterature romarrze, scendendo dai primi docu-
menti linguistici in volgare, anzi dai primi volgarismi attestati negli antichi
scrittori, fino ai testi letterari nostri contempofanei, e spaziando dalle coste
mmene sul Mar Nero a quelle portoghesi sull'Atlantico, ed ancora, oltre
Oceano, fino all'America latina, flno ai dialetti creoli del capo Verde e di
Macao?rr(3).
Se pure quest'ambizione poteva apparire naturale dall'esterno, nei paesi
di lingua non neolatina - soggiungeva forse maliziosamente il giovane Ron-
caglii sottolineando in realti una pratica comune sul piano internazionale -..altrettanto naturale b che in ciascuno dei paesi neolatini almeno 1o studio
della lingua e della letteratura nazionale si distacchi per piD diretto impegno
da quello delle altre>. Tanto naturale che pochi anni dopo un suo ex-docente
alla Normale, Gianfranco Contini, poteva a sua volta constatare - forse per
autoproiezione - che i grandi maestri della Filologia romanza novecentesca
erano stati nella pratica cultori soprattutto o quasi esclusivamente della pro-
pria fllologia nazionale, e tanto naturale che lo stesso Roncaglia riconosce-
ua le ragioni profonde del processo che stava progressivamente riducendo
,.quella larghezza di d'interessi e di preparazione che fu di un Vosslep> e
ch'era allora di uno SPitzer(a).
<Dappertutto la specializzazione si afferma come necessitd, ed b natura-
le, inevitabile, per molti rispetti anche vantaggioso al progresso degli studi,
(1) prolusione a un corso di filologia romanza, in <Aut a.ut>>,2,1954, pp. 93-110. I corsivi
talvolta utilizzati nelle citazioni sono sempre nostri'(2:) Analizzata insieme alla prolusione romana: cf. MaoprolNln TvssBNs, Aurelio Roncaglia
e la cultura europea medievale, in Lo filologia romanza oggi, Atti della Giornata di studio in
onore di Aurelio Roncaglia (Modena 19 ottobre 2OO2), a cura di P. Paradisi e c. Robustelli, Mo-
dena 2004, pp. 41-50.(3) Prolusione a un corso cit., p. 93.(1) E che Roncaglia riconosceva e sottolineava in Giulio Bertoni e Angelo Monteverdi,
quali maestri esemplari della propria tradizione; cosi nel ricordo dedicato ad Angelo Monteverdi'
in cento e Duecento. Nuovi iaggi su lingua e letteratura italiana dei primi secoli,Roma 7971,
p. 311: <Non c'era area dell'Europa neolatina, dal Portogallo alla Rumenia, n6 epoca della sua
itoria, dall,alto medio evo all'eth contemporanea, su cui egli non abbia fermato la sua penetrante
attenzione. Non v'E aspetto della ricerca filologica - dalla linguistica alla letteratura, dalla critica
testuale alla storia della cultura, delf indagine erudita alf interpretazione estetica - che non sia
stato da lui perseguito con uguale sicurezza ed eleganza metodologica>.
-16-che essa affermi le sue esigenze nel campo tanto vasto della nostra materia:
dove tende a sceverare, secondo diversi piani di sfaldatura, nella dimensione
sociale la linguistica dalla critica letteraria, nella dimensione spaziale 1o stu-
dio di ciascuna lingua e letteratura da quello delle altre, inflne nella dimen-
sione cronologica 1o studio del Medio Evo da quello dell'Etd Moderna"(s)'
Ma un conto per Roncaglia era riconoscere prioritd "nazionali" alle fi-
lologie del proprio paese in un ambito romanzo unitario, altra cosa ridurre
tutto a filol,ogia nazionale e ftazionare aprioristicamente la disciplina per
compartimenti stagni; 1i poteva effettivamente annidarsi il pericolo:
<,Lu Fitologia romanza b destinata a ftazionatsi e a risolversi, prima o
poi, senza residuo nelle singole discipline speciali? O conserva di fronte ad
Lsse, in mezzo ad esse, una propria giustificazione e un proprio ambito?>(6)'
A tale domanda aiutavano a rispondere non solo le posizioni pii volte
espresse dai suoi predecessori sulla cattedra romana, e ciob Giulio Bertoni e
Angelo Monteverdi (che al tema aveva anch'egli dedicato, fra l'altro, la sua
proiusione milanese e il completamento delle monumentali Origini di Fran-
cesco Novati), ma anche due Maestri di altra disciplina, Giorgio Pasquali e
Giacomo Devoto: occoreva rivendicare <<contro il dominante "verticalismo
didattico" la feconditd di quel punto di vista "oizzontale", largamente sin-
tetico(7), che appunto la fllologia tomanza E rimasta sola a rappresentare nel
nostro ordinamento universitario. [...] Nella tradizione latina del medio evo
consiste infatti [...] 1'uniti della nostra materia: d quello il solo nucleo intor-
no al quale i dati di una ricerca "orizzontale" possono comporsi a superare
il comparatismo nella storia concreta. E proprio la presenza documentaria
di una tradizione che trascende le possibiliti ricostruttive della comparazio-
ne e largamente attesta spiriti e forme di quella cultura da cui il sorgere
delle letterature nazionali fu preceduto, accompagnato e permeato, pro-
prio tale presenza b fondamento all'originalith ed esemplaritd metodologica
dell'esperienza peculiare al neolatinista, necessariamente filologo di fronte
al puro glottologo indoeuropeista, naturalmente storico di una civiltd uni-
taria di fronte al sociologo studioso di letterature comparate"(8)' Potremmo
aggiungere, comparatista nel senso pit pieno della parola, proprio perchd da
tali presupposti Roncaglia deriva una visione unitaria e insieme sincronica
e diacronica del comparatismo, quella propria tutti i grandi fllologi romanzi
(s) prolusione a Ltn corso cit., p. 94. Il problema, come molti di quelli affrontati nella pro-
lusione pavese, sari ripreso nella prolusione alla cattedra romana, Prospettive della Filologia ro-
*orro,in..Cultura neolatina>>, XVI (1956), pp.1-13, e sp.p. 3 segg', in una situazione gih muta-
ta, con la creazione delle cattedre di Lingua e letteratura latina medievale.(6) Ibid.(7) L,oesigenza di una visione sintetica era ulteriormente riproposta, articolata e arricchita,
in Prospettive della Filologia romanza cit., p. 4 sgg'(8) Prolusione a un corso cit', p. 95.
-: -\
: -. *
_17_
del Novecento; senza pretese egemoniche, come purtroppo si b favoleggiatoper anni, con notevoli danni per la disciplina, ma con la coscienza di unaspecificiti propria e appunto, per ragioni storiche, unica nel panorama disci-plinare delle lingue e letterature moderne:
<Uistanza unitaria della filologiaromanza b dunque legata alla conside-razione del momento medievale come costitutivo fondamentale della nostracivilti. Logico percib che le cosiddette "questioni d'origini" e la fase me-dievale delle nuove letterature occupino il primo posto nella nostra attenzio-ne. come gih l'occuparono presso i nostri predecessorirr(e).
Con quanto immediatamente segue:<<Cid non significa che il filologo romanzo debba limitare la sua attivitd
entro i confini cronologici del medio evo; ma in realtd, anche quando egliesce da quei confini, il riferimento alla comune eredith medievale d quelche distingue la sua visuale da quella dello studioso di letterature compa-raterr(r0). E concetto ribadito anche nella prolusione romanza de|1956, ul-teriormente articolata, a comprendere anche <<quanto si estende ben oltre iconfini del mondo romanzo>>, poich6 <<non la sola civilti neolatina, ma tuttala civiltd europea occidentale ha in essa [sc. l'unith culturale del medio evo]le sue radici vitali, la sua solida base comune>>.
Una storia di "lunga durata" d dunque organica alla stessa natura dellafilologia romanza, pur se essa non pub <pretendere ad un assurdo ruolo disupercattedra: che costringendo, sul piano scientifico, a sintesi inevitabil-mente troppo schematiche o troppo disinvolte, flnirebbe poi, al limite, colridurre il fllologo romanzo al ruolo di brillante genericorr(11). E percib perRoncaglia evidente <<che non risolverebbe affatto questo problema chi, postodi fronte al contrasto d'opinioni dianzi prospettato, credesse di poterlo con-ciliare empiricamente col dire - cosa fln troppo ovvia - che, in fondo, ogniscienza ha i suoi "universalisti" e i suoi specialisti, e che gli uni e gli altripossono benissimo coesistere, ciascuno seguendo la sua vocazione [...]". Inrealti, infatti, <<La necessitd, d'integrare un certo specialismo particolaristi-co con un certo universalismo panromanzo ed europeo d, 1l problema fon-damentale e addirittura costitutivo della nostra disciplina; la dualitd di pro-spettive che ne scaturisce condiziona intrinsecamente ogni aspetto ed ogni
(e) Ibid.; d quanto sottolineava, con evidente empatia, ancora una volta, ne1la personalitidel Maestro Angelo Monteverdi: <AI centro della tematica monteverdiana si colloca dunque ilnucleo stesso della problematica da cui si def,nisce la filologia romanza: il lungo e complesso
travaglio del trapasso dal mondo antico al modemo, il riconoscimento delle basi su cui questo dvenuto costruendosi, delle forze che alla sua formazione hanno variamente concorso, dei valoriche si sono realizzati e che ne hanno configurata dal profondo la struttura spirituale>, in Angelo.llonteverdi cit., p. 316.
(0\ Ibid.tlt\ Prospettive della Filologia romanza cit., p. 8.
momento della nostra attivita. Proprio cib spiega quella ricorrente sensazio-
ne di crisi che ne ha accompagnato 1o sviluppo dopo gf iniziali entusiasmi
romantici, e che ne domina l'attuale struttura nel quadro generale degl'inse-
gnamenti universitari, rendendola cosi elastica, cosi restia a lasciarsi cristal-
iirrur" in un'accezione rigida e univoca, Si tratta d'una crisi non contingen-
te e temporanea, ma permanente e connaturata alla stessa definiZione della
filologia romanza. Frazionamento specialistico ed espansione universalisti-
ca sono due prospettive immanenti alla nostra disciplina, perchd sono in
ogni momenti le conclizioni esistenziali del suo oggetto>>oz)'
LaFilologia romanzarimanda dunque a una "lunga durata" particolare,
quella garantita dai circa mille e pit anni di cultura postclassica comune
" dunqr" da strutture e istituzioni culturali la cui peffnanenza nel tempo
ha formato e forma un nucleo identitario preciso, a condizione di saperne
riconoscere il vero specifico: una civiltd formata dall'incontro e dalf incro-
cio di popolazioni, lingue e culture diverse, anche diversissime, cui il rico-
noscimento di una lingua e di una cultura comune, quella della tradizione
classico-cristiana(13), fornisce per centinaia d'anni l'elemento di coagulo e
reciproco riconoscimento, pur fra tanti conflitti.
Nello stesso anno della prolusione romana (1956) usciva Mimesis' Ilrealismo nella letteratura occiclentale di Erich Auerbach, con quelf introdu-
zione di Roncaglia che ne ha guidato la ricezione italiana e che costituisce
uno dei suoi capolavori critici. Le interrelazioni con le prolusioni romana e
pavense sono molteplici ed evidenti e particolarmente preziose le conver-
genze, essendo Mimesis ancora oggi, con Letteratura europea e Medio Evo
ttzt lbid., pp. 8-9. La risposta - aggiunge nelle conclusioni, p. 13 -: <<non pub essere n6
un,espansione che guardi solo alle ragioni ideali, prescindendo dalle esigenze della specializza'
zione, nd una sfaldatura secondo quel quadro di nazionalith, che rappresenta si la cristallizzazio-
ne di un certo equilibrio, ma non il processo per cui vi si pervenne e non pud essere anticipato'
n6 considerato definitivo, senza cadere in una forma di determinismo naturalistico. La filologia
romafizapub e deve lasciare ad altre discipline tutto cib che si svolge entro questo quadro senza
alterarlo; suo oggetto specifico sard non la statica, ma Ia dinamica di questo equilibrio: anzitutto
dunque il proceiio del suo costituirsi (le cosiddette "origini"), ma poi anche tutti quei movimen-
ti atiraverso i quali esso viene lentamente modificandosi [...]. Se dunque l'oggetto della filologia
romanza E la dinamica di un equilibrio, potremo dire, e non sard un gioco di parole, che la sua
uniti non pud realizzarsi altrimenti che in un equilibrio dinamico: fra studio delle lingue e studio
delle letterature;fraindiizzo naturalistico e indirizzo culturalistico; al limite: fra la prospettiva
del frazionamento e la prospettiva dell'espansione'>>'rr:) C,E un autore mediolatino, fra i tantissimi studiati, amati e citati da Roncaglia, che tor-
na spesso nei suoi lavori dedicati al nostro tema, otfried von weissenburg, poich6, pur animato
da spinte ,.nazionali", tanto da usare letterariamente il proprio volgare, tributava suo malgrado
il pii alto omaggio al latino e al nuovo crogiolo culturale stabilizzato ed esaltato dalla riforma
carolina: <Res mira, tam magnos viros, prudentia deditos, cautela precipuos, agilitate suffultos,
sapientia latos, sanctitate praeclaros, cuncta haec in alienae linguae gloriam transferre et usum
scripturae in propria lingua non habere!>.
:.- - r- -:
-_:---:.
- :>- -
-19-latino di Curtius, una delle due piir importanti trattazioni dedicate alla let-teratura europea intesa come storia di "lunga durata", da Omero a Virginia\\bolf. E all'europeismo fllologico di Auerbach, Roncaglia dedica ovvia-mente attenzione particolare: <Questo "europeismo" fllologico non d un'e-sco_eitazione occasionale e di patata, ma qualcosa d'intimamente connatu-rato alla nostra attivith, perch6 [...] ha una motivazione intema alla logicastessa della nostra disciplina. Se non d una mera espressione geograflca [...]che altro signiflca "Europa" se non una tradizione di civilti comune? E che
altro sono le "origini romanze" se non le origini stesse di questa civilth, leorigini dell'Europa? Non dirb che questa concezione unitaria ed europeistadella fllologia romanza sia generale. Basta che 1o sia tra i pii pensosi e ge-
nerosi: coloro i quali nei loro studi sentono una responsabilitd morale che
impegna la tecnica a non rimanere tale. [...] Presso uno studioso animato daquesto ethos, oltre che fornito di larga preparazione, d naturale che il carat-rere sintetico della nostra disciplina soverchi la spinta alla divisione specia-
listica del lavoro, e che della filologia romar,za non solo si realizzi sul pianotecnico la concezione unitaria, ma s'attui sul piano ideale la concezione piiespansiva: la tendenza a porsi come centro per la comprensione e interpre-tazione storica dello spirito europeorr(14). Roncaglia ne rileva l'estensione, a.,trascendere in qualche modo la stessa nozione tradizionale d"'Europa">>,
cui pure, nota ancora, Auerbach ritorna, usando <il termine di Europo>, ne-
gli Epilegomena(ts) a Mimesis, <pii spesso e volentieri che il termine Occi-dente>>, malgrado stesse probabilmente gih pensando, sull'esempio goethia-no. a una Philologie der WeltliteraturQ6). Ma, soprattutto, Roncaglia coglieil nodo metodologico fondamentale di Mimesis, sottolineando non solo ilproblema del rapporto fra sincronia e diacronia ma quello fra conoscenza
storica e conoscenza strutturale, in un anno, il 1956, in cui le problematichestrutturali erano patrimonio ancora esoterico: <<Esiste, certo, il rischio d'ir-rigidire il discorso critico in astrazioni tipologiche, cosi come esiste, d'altrocanto, l'opposto rischio di disgregare il discorso critico in una contempla-zione d'oggetti irrelati. Proprio nella consapevolezza di questi due pericolisembra a noi di riconoscere il motivo determinante della struttura di Mime-sis, che cerca garanzia contro il secondo nella linea "storica" assunta comeasse della ricerca, e contro il primo nel "metodo dei campioni". E una solu-
(ta) Introduzione a E. Aurnse,at, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino1956. pp. xvr-xvrr.
'15) Epilegomena zu Mimesis, in <Romanische Forschungen>, LXY 1950, pp. 1-18, tr. it. inDa .\fontaigne a Proust. Ricerche sulla storia della cultura francese,MTlano 1913, pp. 233-253.
(16) E. AusnsA.crt, Philologie der Weltliteratur (1952), poi in Gesammelte Aufsiizte zur ro-,,tnrtischen Philologie, Bem und Munchen 1967, tr. it. in S. Francesco Dante Vico, e altri saggi.:i,filologia romanza, Bari 1970, pp. 171-191 (rist., con introduzione di A. Varvaro, Roma 1987).
-20-zione che pud essere discussa, ma che ha il merito d'affrontare in pieno un
problema Lggi fondamentale; quello del rapporto fra conosceflza storica e
conoscenza strutturale, fra conside razione sintetica e considerazione diacro-
nica.Certosilascianosfuggirelapiigenerosaispirazionedellibro,coloroche vi leggono soltanto un-alaccoliu di saggi staccati>(17).
Se rimanessimo ferd soltanto sul terreno metodologico e tralasciassimo
quellopiidirettamerrtestorico,tradiremmoquelchegidnellg54costituivaun altro elemento innovatore dell'analisi di Roncaglia: la capacitd di co-
gliere,nell,interpr"tu,i,,"delleoriginidellelingueeletteraturemoderne,accanto alla continuitd, che le sottrae all'ipoteca ideologic-a romantico-posi-
tivista(r8), anche Ia discontinuiti fra mondo classico e moderno e soprattutto
la ragione profonda di quella discontinuith e di quelle novith che segnano
lafinedelmondoantico,elanascitadelmoderno.RoncagliaEilprimochementre sottolinea con sottigliezza atche psicologica (ma
^storicamente fon-
data,ritengo,sull,acutaeinnovatriceprospettivaStoriograficadelMuratori),una sorta di nazionalismo latente da parte dei romantici francesi e tedeschi'
invaghitidelleovergini"n".gi"deibarbariinvasori>T1111"*'etazioneditale discontinuith, rileva d'altra parte nella <<nostra retorica nazionale>> l',a-
bitudine opposta: <<collocarci coi sentimento dal lato della classicith' quasi
identificando istintivamente noi stessi nell'antica classe colta imperiale"(1e)'.
Nonsolo<<inconsueto>>,percid,comeegliStessoaffermava,ilcollocarsi<<da un altro punto di vista, iociale prima che etnico'' ma effettivamente del
tutto nuovo i, ,r,ini".p. etazione deile Origtni e quindi, come abbiamo visto,
delle tavole costitutive della stessa fllologia romanza' Roncaglia' utilizzando
acutamente le analisi del Rostovzev e dei giovane e coetaneo Sante Mazzari-
no, indica infatti nella chiusura della classe colta romana, <<ne1l'inerte attac-
camento ai propri privilegi>, insomma nelf incapacith della classe dirigente
fomana a rispondere politicamente e culturalmente alla spinta delle masse
non urbaniz ,ur" tu ruiice profonda della discontinuia: <Per questo il medio
evo [...] non d ,"-pii." involuzione del mondo classico>>, dovuta esclusiva-
menteaspinteesterne,<<maevoluzionedinuoveforzesocialidopolafrat-tura col mondo classico>(20), sia dal punto di vista linguistico che culturale'
t-2. ::--\:-
-1-,= -.--
(11) Introduzione cit., pp. xxvll-xxvll'(r8) La contestazione delf interpretazione <romantico-positivisto delle origini e la sua re-
lazioneconlanascitadellafilologiaromanzasonopelRoncagliasemp.repreliminariadognidiscorso sulle Origini o ,oiL moro"gi a fofira.,zat cf. almeno Le origini in storia della Letteratura
italianadiretra da B. c...ti" N. ;up"gno, l. Le origini e il Duecento, Milano 1965, pp' 3-269;
in particolare 3-17.(rs) prolusione a yn corsocit., p. 100. A conferma, basti del resto pensare alla diversa for-
mula con cui vengono moJ"i" a",i"i quel che noi ancora definiamo "invasioni barbariche": per
i tedeschi pit semplicemente "trasmigrazioni di popoli"'
tzo) lfuifl.,p. lQ3.
0
!-li
ra
9:
-2t-Per questo - si scuseri l'inconsuetamente lunga citazione - <La cul-
tura elaborata dalla societh antica, una volta crollata quella societd, orien-nlizzato e segregato quel nucleo piD resistente che in qualche modo pote-va continuarla, efa rimasta come un immenso relitto galleggiante sul mare
tempestoso della societd nuova. Questa era formata non soltanto e neppurprevalentemente da barbari (i quali infatti ne furono assorbiti), ma anche
e soprattutto da quelle masse, specialmente rurali, che la classicitd aveva
lasciato vegetare, partecipi dei suoi fondamenti elementari e generici, ma
estranee alla sua attiva e profonda elaborazione. Tali masse, eterogenee e
prive di proprie tradizioni capaci di significato universale, non potevano non
rifarsi alf ideale di quella cultura, della cui luce era pure filtrato in loro qual-
che barlume, e che sempre sentivano superiore ed esemplare, anche quando
non la comprendevano bene o non la comprendevano pii. Ma, perduta or-
mai ogni possibilith di diretto assorbimento, di graduale trapasso, nemmenopotevano svolgerla mantenendosi sullo stesso piano. Dovevano ritrovame ilsenso in se stesse, svolgendolo da quel piano elementare che era comune
anche a loro, riscoprirlo in quelle tracce e rovine che intorno a loro ne era-
no rimaste, reinterpretarlo in uno sforzo di lenta elevazione, finch6 dal loroseno emergesse una cultura nuova, pari in dignitd all'antico>(21).
E un caposaldo interpretativo che torneri di nuovo nella prolusione ro-mana del 1956, con ulteriori articolazioni, anche diacroniche:
<Percib lo stesso sorgere delle letterature nazionali non tanto rappre-
senta, nelle sue immediate consegueflze, la frattura di un'unitd spirituale,quanto piuttosto un'estensione di tale unitd nella dimensione sociale. Infatti,pur essendo intimamente fecondate dalla cultura dei loro iniziatoi,le nuo-
r,e letterature per la loro veste linguistica facilmente penetrano e presto si
diffondono in ogni strato della societd. Si popolarizzano cosi quelle flguree quei miti, quelle immagini e quelle espressioni dell'onore e dell'eroismoguerriero, del corteggiamento e della dedizione amorosa, che avevano pri-mamente ricevuto vita ed elaborazione in ambienti feudali e cortesi. Epicafeudale, lirica e romanzo cortese riescono in questo modo a creare il senti-
mento popolare europeo, e lo improntano per secoli, depositandovi un patri-
monio comune che sopravviveri anche al successivo differenziarsi delle tra-
dizioni letterarie e al loro cnstallizzarsi come tradizioni nazionali [...1rtzzl.Nella grande trattazione delle Origini del 1965Q3) per la Storia della
letteratura italiana diretta da Emilio Cecchi e Natalino Sapegno, il filo con-
duttore sard dunque e sempre, fin dal primo capitolo e dunque prima ancora
della forte riaffermazione della singolaritd delle origini romanze (cap. II),
2t'lbid..pp.l04-105.(22) Prospettive della Filologia romanza cit., p. 6.{23) Le origini cit., pp. 3-269.
rr-
er
-22-il rapporto fra continuitd e discontinuitd, a partire da quell'analisi storico-
sociale ma declinato sul terreno pii propriamente culturale e letterario nella
dialettica tradizione-innovazione. Roncaglia parte dalf inversione di pre-
stigio determinata dall'avvento del cristianesimo, e quindi dai Padri della
Ch-iesa e dalla fondazione della tradizione classico-cristiana, e ne segue ana-
liticamente gli sviluppi per tutto il Medio Evo sia sul terreno linguistico che
letterario, tracciando cosi impticitamente anche una vera e propria storia del
dotto medievale, nella quale il lettore b portato a riconoscere progressiva-
mente la nascita e il primo sviluppo dell'Europa, della cultura europea e
dei suoi intellettuali. Unu p.orpettiva che sarh poi esplicitamente perseguita
vent,anni dopo, nel 1985, in un capitolo che alle Origini del 1965 possia-
mo considerare come strettamente complementare: il grandioso e minuzioso
saggio sulle corti medievali nel volume della Letteratura italiana Einaudi
dedicato appunto a Il letterato e le istituzioni'. un insieme di dati e inter-
pretazioni d"t trtto nuovo e insuperato, come non superate sono le origini
del 1965, fortunatamente sottratte all'incultura delle grandi case editrici e
dei grandi quotidiani dalla riedizione stampata nel 2006 dalla UTET(24) (1/
corriere della seraaveva eliminato e malamente sostituito il capitol0 in una
ristampa delf intera opera destinata a un vasto pubblico(2s)).
Pensieri certo fondati su fonti e testi e ricerche, ma anche, sarebbe dif-
flcile e perflno antistorico negarlo, sulla sensibilitd politico-culturale nuova
e speciflca di Roncaglia quale intellettuale moderno, osservatore per tutta la
vita attento e partecipe dei processi storico-politici contemporanei e capace
sempre di operare "ongirrrioni
consapevoli fra Passato e Presente(26)' E del
resto non d proprio lui, convinto storicista, che in pi; occasioni ricorda la
famosa proposizione crociana secondo cui ogni storia b storia contempola-
nea?
A conf-ermarcelo sono ancora le conclusioni della prolusione pavese, in
modo del tutto esplicito (e si ricordi la data in cui fu pronunziata, 1954)' e
quanto mai attualipii di cinquant'anni dopo, in questi giorni:
<<Le origini romanze s,identiflcano, in Sostanza, con le origini dell,Eu-
ropa, ossia della civilti moderna; e il fllologo romanzo si trova proprio sul
passaggio obbligato a penetrare, attraverso i documenti della sua formazio-
(24) Au. RoNcecrra, Le origini della lingua e della letteratura italiana, Torino 2006'
rzs) col titolo La letteraturaitaliana, diretta da E. Cecchi e N' Sapegno, in venti volumi
pubblicati settimanalmente ("Iniziative in edicola") dal 2005'(26) Si veda del resto la significativa general\zzazione proposta in Lingue nazionali e koin6
latina,Toino 1988, p. 555: "t.Ll la diglossia non costituisce un fatto eccezionale' Al contrario'
essa pub considerarsi carattere nuto.ule d'ogni societi in cui tra le classi subalteme e i gruppi
detentori del potere (economico e politico) esista (come esisteva nel medio evo' complicato per
di pii da differenze di composizione etnica) uno stacco marcato (quasi castale) e un accentuato
squitibrio di composizione numerica''
t_:
\r- -- -
-, i-*
I"-
aeritaiia-)souditer-
tirti:ie
t Iluna
dif-oVa
alarace
delalaora-
:. inIt. e
'Eu-
r sul
rzio-
-23-ne. questa civiltd nella cui tradizione, nel cui linguaggio ancora viviamo'
[...] i'unitd d'Europa non b un fatto geografico od etnico, n3n d in altre pa-
role un dato di natura; ma neppure d un fantasma astratto. E una complessa
unitd ideale, meglio un processo storico d'unificazione; ed appunto per que-
sto Suo inerire alla libera azione umana rappresenta un "valore" sempre in
gioco. 1...1 Qui i il motivo di un interesse non dilettantesco o accademico,
nn concretamente storico, che dd significato e valore ai nostri studi. Qui la
responsabilitd che impegna la nostra preparaZione tecnica a non rimanere
p t t rame nt e 7 o1"r, (27)
.
Europa dunque, ma non eurocentrismo: Europa come punto d'incrocio
non solo latino-germanico, pur se questo ne costituisce la base pii rilevante.
\Iolto precocemente, dal lg4g?8), inserendosi in un dibattito allora molto
acceso e ancor oggi oggetto di discussione, ma stabilendo da allora un pun-
ro fermo ineludibile nell'interpretaziote delle origini della lirica romanza,
Roncaglia riconosceva con nuovi argomenti in una forma ritmica della tra-
dizione arabo-ispanica, la strofa zagialesca, possibili antecedenti della liri-
ca provenzale, per essele confortato poco dopo dalla sensazionale scoperta
delle kharagiat mozarubiche di Samuel Stern ed Emilio Garcia Gomez' Alla
scoperta dedicava prontamente (1953) una raccolta di testi(2e) e una serie
nutrita di saggi, dal 1950(30) flno agli ultimi anni della sua vita, quale "Pri-
mo capitolo nella storia della lirica europea", come apertamente dichiara iltitolo del lavoro pubblicato nel 1973(31), tesi alla quale convinse anche l'ini-zialmente scettico Angelo Monteverdi.
La tradizione lirica arabo- ed ebraico-ispanica poteva apparentemente
confernare quell'interpretazione "romantico-positivista" delle Origini con-
tro cui i maestri di Roncaglia e lo stesso Roncaglia avevano combattuto e
(21) prolLtsione a un corso cit., p. 108. E alla funzione della fllologiatomanza nella nuova
Europa, che <si avvia a1la non facile saldatura soprannazionale delle proprie strutture economico-
politiche, E dedicata particolare attenzione anche nell'editoiale Continuitii e rinnovamento pte'
messo alla nuova serie di <Cultura neolatina>>, Lll(1992), p' 14, attraversato da nuovi timori sul
destino della disciplina, e ancora in L'Europa e la Filologia romanza' in <Bulletin de la Classe
des Leures et des Sciences Morales et Politiques>, 6e s6rie, IX (1998), pp. 83-94-
eu Laisat estar lo gazel, (Contributo alla discussione sui rapporti fra lo zagial e la ritmica
ronnnza), in <Cultura neolatina>, IX (199), pp.61- 99'es) poesie d'amore spagnole d'ispirazione melica popolaresca. Dalle khetrge mozarabiche
a Lope de Vega,Modena 7953.t3o) Muratori e la tesi araba sulle origini della ritmica romanza, in <Atti della Deputazione
li Storia patria per le antiche province modenesi> VIII (1950), pp' 16-30 e tn Miscellanea mu-
.c;roriana,Atti del Convegno Oi Stuai Storici in onore di L. A. Muratori (Modena, 14-16 aprile
l9:0. Modena 1951, pp. jOO-:f+ e Di unct tradizione lirica pretovatoresca in lingua volgare, in
..Cultura neolatina>, XI (1951)' pp.213-249.
'31) Il primo capitolo nella storia della lirica europea, in Concetto, storia, miti e immagini
.:el .\tedio Evo, a cura di V. Branca, Firenze 1913, pp' 247-268'
rlumi
koind:nrio.Iruppi[Ll per
ltuato
-24-vinto una lunga e dura battaglia storiografica. Roncaglia ne coglie imme-
diatamente le ascendenze in realti colte(32), frutto di quell'incontro fra la
cultura araba e il lato orientale di quella cultura mediterranea che b anch'es-
sa parte ineludibile della storia europea. Non origini popolari dunque della
lirica romanza, ma tradizione colta flltrata nella cultura mediolatina e tro-
badorica dall'anfizona afro-asiatica attraverso la cultura araba ed ebraica di
Spagna.- Anche in questo caso la sua posizione b fondata su dati di fatto desunti
dall'interpretazione storica dei testi, ovvero su una strenua contestualizza-
zione storica, su quel culto fllologico del documento cosi radicato nella tra-
dizione modenese, da Castelvetro a Barbieri, a Muratori, a Bertoni' Invitato
da Diego Carpitella al primo convegno sugli studi etnomusicologici in Ita-
lia, in qualitd sia di filologo che di musicologo, per tradizione famigliare e
p"r ptopti" competenze e passione, Roncaglia precisa ulteriormente la sua
posiiiot e, non pregiudizialmente contraria ad ammettere il ruolo della tra-
dirior" orale in un campo particolare, quello appunto del canto popolare, la
cui storia toccava in parte <<i termini primi del cosiddetto "problema delle
origini", basilare della filologiatomanza al momento del suo costituirsi in
dis-ciplina scientifico-storicar(33). Definita perb l'area dell'etnomusicologia
<come quella che ricopre il "campo di suoni" posto al di fuori dell'esperien-
za culta occidentale euro-centrica>> ne riconosce senza esitazione il ruolo
e la funzione basilare <<per un settore problematico residuo e tuttora irri-
solto: un rincalzo specialistico indispensabile al progredire della fllologia
romanza stessarr(3a). Se infatti era caduto il presupposto ideologico per cui
le ',origini" <<flnivano per 1o smarrirsi nelle nebbie della preistoria etnica e
dell'ispirazione collettiva> e se dai <precedenti supposti 1'attenzione b tor-
nata aile opere esistenti, restituite alla storia del loro tempo>>, non si po-
teva <<tuttavia negare che fossero rimasti dei residui irrisolti, specialmente
concementi certi aspetti della lirica. S'ha un bel ripetere, col Vossler, che ilpit antico trovatore conosciuto, Guglielmo IX d'Aquitania, "non ha biso-
gno di precursori, poichd d egli stesso un precursofe".La formula brillante
non giova a spiegare come e dietro quali impulsi questo "precursore" abbia
ritrovato le condizioni proprie del canto popolare, con la sua nativa uniti
di parola e musica, n6 dov'egli abbia raccolto, sia pure per trattarli da gran
signore, qual era, certi spunti tematici visibilmente tradizionali e di sapore
(32) Confermate anche nella soluzione dell'etimologia del verbo garrire, in 1l verbum dicen-
di .garrire, nelle kharagiat mozarabiche, in Letterature comparate; problemi e metodo. Studi in
onore di E. Paratore, Bologna 1981,4 voll'; III: pp'973-982'(zz) [y1.167n6isologia e filologia romanza, in L'etnomusicologia in ltalia, a cura di D. Carpi-
tella, Palermo 197 5, PP. 51-67; P. 53.(34) lh'd'
-:,s
-: -\,
-:.- i:
l,__-, :
: -..t: f,
e-
Ia
)s-
tla
o-
di
lri'.4-
'a-
rtO
.a-
:eua'a-
lalle
inrian-rlo
ri-
Iia:ui
IC)r-fo-
lteil
,o-
lteria
itd'an
)re
en-
iin
pi-
-2_<-popolaresco, certe formule espressive altrettanto scopertamente riconducibi-li a tecniche d'improvvisazione orale o a schemi memoriali di tipo paremio-
logico>>(3s). Fino a concludere:<<In questo senso, uno storicismo piir aperto alla considerazione di dati
sociologici e strutturali, insomma pii concreto di quello idealistico-indivi-dualista della generazione crociana, viene oggi accorgendosi che una voltaspogliate d'apriorismi ideologici insidiosi quanto inessenziali, anche vec-
chie ricerche di scuola romantico-positivistica, come quelle d'uno Jeanroy
o d'un Men6ndez Pidal, offrono intuizioni ed osservazioni recuperabili: so-
prattutto per quanto riguarda il genere tipico dei canti d'amore in persona didonna (chansons de femme, Frauenlieder, cantigas de amigo) e altri generi
connessi (come, per esempio, le albe)r(36).
Estrema apertura ai dati "sperimentali", potremmo dire, senza apriori-smi, in nome del "vero" e del "certo" vichiano ma soprattutto della tradizio-ne modenese, specialmente muratoriana, flno a Bertoni (b un capitolo fon-damentale della fllologia di Roncaglia, su cui sono in questa sede obbligatoa sorvolare e su cui peraltro gid molto di condivisibile d stato scritto(r7)): fi-lologia e storia costituiscono dunque un binomio inscindibile, per l'accerta-mento dei fatti e dei testi, un'istanza unitaria imprescindibile per l'ecdoticaanche dei testi moderni, cosi legata eppure cosi diversa e particolare rispetto
a quella dei classici.
Quando precedentemente abbiamo citato I'introduzione a Mimesls, non
sarh sfuggito il cenno di Roncaglia alla <<spinta> che in Auerbach avrebbe
potuto soverchiare la <divisione specialistica del lavoro>>. Non credo si pos-
sa assumerla come una critica al grande filologo tedesco, ma certamente
"-ome una precisazione rispetto alle proprie personali propensioni metodo-
logiche, alf interno di quel quadro unitario che Roncaglia ha proposto dellaFilologia romanza come di disciplina "connaturalmente" in crisi fra spinte"sintetiche" e "specialistiche". E in effetti non sarebbe completa I'equiva-lenza propo sla in limine fra Ronca gha e la Filologia romanza se prescindes-
simo dalla sua pratica specialistica, in realtd il terreno su cui piir ha lavora-to: anzi, il suo terreno forse prediletto.
Se E lecito un ricordo personale, quando mi presentd in Biblioteca va-
ticana, al mio primo ingresso in uno dei luoghi mitici della ricerca storica
e filologica, al segretario addetto alle tessere, che si profondeva in grandi
complimenti per le Origini della Garzanti, appena uscite, rispose quasi con
'35) Ibid., p. 56.
'36t lbid., p. 63.':ir gf. F. Mannr, Roncaglia e Muratori, in kt filologia romanza oggi cit., pp. 91 -94; nello
.resso volume d ristampato il saggio di Roncaglia su Ludovico Antonio Muratori e le origini;ell'Europa alle pp. 125-138.
-26-una smorfla, in lui caratteristica, dichiarando che in realti egli preferiva illavoro di scavo, i sondaggi su argomenti speciflci: era quelli i terreni che
egli considerava di vera ricerca. Ne rimasi stupito: pensai che la risposta
fosse dettata da understatement o da un pizzico di snobismo, ma in realtd
nell'affermazione c'era molto di vero e caratteristico della sua personalitl,
sottolineato non per nulla anche nel suo ricordo di Angelo Monteverdi(38):
il piacere del lavoro di scavo e dell'approfondita e individua prospezione ed
interpretazione dei testi, tanto da considerare sempre del tutto inessenziale
la raccolta dei propri scritti (ma un volume dedicato ai saggi sull'epica fran-
cese b proprio da oggi disponibile<:r); e dal non aver quindi mai provveduto
ad uniflcare le proprie edizioni marcabruniane o i saggi di provenzalistica.
Ecdotica ed edizioni costituiscono, come esercizio specialistico privile-
giato, l'altro aspetto fondamentale della filologia romanza (per quanto ov-
viamente non esclusivo), ad eSSa <<connaturato>>, per usare un termine dello
stesso Roncaglia. Per Roncaglia b stato, durante tutta la vita, un assioma
valido tanto nella teoria quanto nella pratica, tanto da far affermare mol-
to recisamente, nella Giornata di Studio modenese del2002, come un dato
emergesse <chiaro e incontrovertibile> dalla bibliografia dei suoi scritti: <il
pr"ru1"r" su tutti gli altri dell'interesse per la critica del testo>>(4o).
Se in ambito antico-francese alla Chanson de Roland dedicd un'edizio-
ne integrale, ancora giovanissimo, nel1947 (ma del versante antico-francese
della sua produzione parlerl con ben altra competenza Madeleine Tyssens),
d certamente alla fllologia provenzale, e in particolare trobadorica, che Ron-
caglia ha dedicato attenzioni particolari e continue (pur se le correzioni al
Mistero provenTale di S. Agnese(a1) costituiscono ancora oggi un passaggio
decisivo per l'edizione del dramma). Fra tutti i trovatori scelse uno dei piD
difficili e lappresentati nella tradizione manoscritta, Marcabruno, pubbli-
cando i componimenti pii ardui e controversi, a tradizione plurima, mentre
di molti altri forniva nei corsi universitari e nelle relative dispense nuove
edizioni provvisorie e nuove soluzioni per passi fino ad allora incompresi.
Le particolari caratteristiche della tradizione di Marcabruno si prestavano in
modo particolare a praticare una rigorosa metodologia neo-lachmanniana,
quella appresa da maestri come Michele Barbi, Giorgio Pasquali, Alfredo
(38) MoNrEvsxot, Cento e Duecento cit., p. 314.(3e) Au. RoNcncrra, Epica francese medievale, a cura di A. Ferrari e M. Tyssens, Roma
2012.(a0) S. Guro.c., Aurelio Roncaglia editore di testi romanzi, in I'a filologia romanza cit., pp.
79-90, p.19.(at) Il mistero provenz.ale di Sant'Agnese, Testi e appunti del corso di Filologia romanza
tenuto dal prof. Aurelio Roncaglia per l'anno accademico 1966-67, Roma 1967, e Appunti per
Ltna nuoya etlizione del mistero provenlale di Sant'Agnese, in Scritti in onore di Luigi Ronga,
Milano-Napoli 1973, pp. 573-591.
: ,:I]
+:-;-\! -
: r--,
:^-:':i
j"
,'a ilche
osta:altd
Llitd,
i 38).
eed{aleian-Jutola.;ile-ov-
lello0ma
no1-
lato: "il
zio-lese:nS),
Lon-
dall-siopiir
rbli-ntrero\:e
resi.
oinana,'edo
-27 -Schiafflni, Angelo Monteverdi, il giovanissimo Gianfranco Contini e tantialtri con cui si trovd giovanissimo in contatto, ma soprattutto, nel caso spe-cifico, i grandi linguisti e provenzalisti tedeschi della prima metd del No-vecento, che avevano collocato all'avanguardia la provenzalistica fra i varirami dell'ecdotica romaflza. Il presupposto ineludibile di un'ecdotica filo-logicamente matura era per Roncaglia la tensione verso la lezione genuinadell'autore, esercizio preliminarmente ed ineludibilmente linguistico(42) e
storico-culturale, particolarmente importante, delicato e complesso per unautore come Marcabruno:
<Si tratta t...1 di ricercare nei documenti e di ricercare in noi stessi ilmaggior numero possibile dei presupposti che furono familiari a quegliascoltatori ed al poeta stesso. Ricerche di lessicologia e fraseologia che ri-vendicano, chiariscono, o anche solo confermano il significato di vocabolied espressioni, rievocazioni di motivi che vivevano nella simbologia bibli-co-esegetica o nella tradizione proverbiale corrente, riferimenti a dati di sto-ria. di geografia e di costume deducibili da fonti coeve, riscontri con passiparalleli di Marcabruno e dei suoi imitatori, permettono [...] di stringere piDdavvicino il testo, e di fornire un'interpretazione piir completa e piir coeren-te di quelle date sinoro>(43).
A tali principi d restato fedele in ogni lavoro, tanto che ancor oggi, mal-grado una recente edizione completa di Marcabruno, preparata in dquipe,i suoi saggi rimangono fondamentali e in realtiL richiamano all'opportuni-ti di riprendere il cammino interrotto (lo conferma giustamente il sito online "Rialto" afflancando all'edizione inglese tutti i contributi marcabrunianipubblicati in edizione definitiva da Roncaglia).
Attento anche alla possibilith della presenza di varianti d'autore (ne ri-levd una presenza sicura proprio in Marcabruno, poi adottata nei manua-li quale caso esemplare), ovvero alla possibiliti pratica di rispondere auno degli argomenti teoricamente pii solidi nella famosa contestazione diBedier al sistema lachmanniano, non ha mai esitato a ricercare anche tra-mite la contaminazione di lezioni (perlomeno in caso di errori evidenti o di5enso mancante(4)), e dunque nel punto piD controverso, oggi, dell'approc-
-:' Alla linguistica Roncaglia dedicd molteplici saggi e lavori, comprese due grammatiche:ioriche. d'oc e d'oil, ancora oggi largamente in uso.
aj' Marcabruno: Al departir del brau tempier (BdT 393, 3), in <Cultura neolatina>, XIIIi953). pp. 5-33; in particolare, p. 6.
r' ..J'ai voulu simplement montrer que pour 6diter convenablement les podmes des trou-:rdours force nous est de combiner les temoignages. C'est en somme la meme thdse que M. Del-r.ruille a soutenu dans sa communication plus gdn6rale sur In philologie mddievale et la critique:t.t:iuelle au Congrds de Quebec (1971). On ne peut pas renoncer i des intervention de critique,-.-mbinatoire et conjecturelle ld oi il s'agit de la substance mAme du texte,pout ne pas courir le:.que de quelque m6lange arbitraire li oir il ne s'agit que de d6tails insignifiants>, in In critique
Loma
. pp.
ranza
i pertnga,
-28-
cio neo- e trans-lachmanniano, quella <genuinith e coraettezza> della lez\o-
ne tramandata, <<in ogni particolare di Sostanza e di formu. L,accertamento
della lezione ,.autentta', costituiva lo scopo della filologia, come affermava
in limine ai Principi e applicazioni di critica testuale$s) e non si stancava
di ripetere, individuando-in tale tensione, come Joseph B6dier, seppure con
metodologia diversa, un dovere etico' lo tft^t:.che aveva riconosciuto in
Auerbach e nell,attitudine necessaria ad ogni filologo. E quanto ribadird an-
coraunavoltaesplicitamentenellg78,avanzandolapropostadiun,edizio-necomplessivadellaliricaprovenzale,rlcorpusTropatorum'apropositodelle particolari problematicire ecdotiche poste dalla tradizione trobadorica:
<<Tout philologue roman conscient de la qualit6 stylistique donc d-e-la
dignitdlittdrairedelalyriquedestroubadours,nepouffajamaissesatisfairede solutions textuelles moins rigoureuses de celles que tout philologue clas-
siqueexigepourlesmonumentsdelalyriqueancienne.M0mesidansnotrecas la tradition est plus mouvante, car la distance qui sdpare les auteurs et
les copistes n,est pa's si grande, et la langue des uns est encore la langue vi-
vante des autres; m6me Ii dun. 1a tradition des chansonniers m6di6vaux des
faits de contamination (}r la limite: des prises de copie d,aprds la rdcitation
orale)ontpusegrefferplusfacilement,aveclaconsdquencedebrouillerl,i-mage formelle du stemma codicum,les exigences primaires et irrenonqables
de la critique textuelle vis-d-vis des troubadours ne diffbrent gudre de t"ll-:t
que tout le monde reconnait valables vis-irvis des podtes grecs et latins>>(a6)'
Anche in tale occasione(a7), riconosceva peraltro, con,apertura preco-
ce(affiancabileaquantocontemporaneamentepfoponevailgrandeamicoD,Arco Silvio Avalle(a8)), la complementarita di un diverso principio' quello
teso a ricostruire la stoiia e il sinso di ogni singolo manoscritto. Era una
posizione che risaliva in parte ad uno dei suoi maestri, Giorgio Pasquali,
quando questi contro Paul Maas sosteneva la necessith di una <storia della
tradizione e critica del testo>. Proprio nella sua scuola, con Anna Ferrari' a
partire dalla filologia lusitana(as),iale inclinazione trovava nuovo impulso e
textuelle et les troubadours (quelques considdrations), in <cultura neolatina> xxxvu (1978)'
pp.201 - 214; P.214.(45)AU.RoNcecr-te,Principieapplicazionidicriticatestuale,Annoaccadem\co|974-,75,
Roma 1975, dispense poi ristampate in volume pii volte'(46) Au. RoNce.cr-rl, La critique textuelle cit" p' 208'
$tt lbid., pp.208-209.r+tlD,A.S.Avelr-r,FenomenologiaecdoticadelMedioevoromanzo(|972),orainD,A.
S. Avalle, ltr doppia urrita. F"ro*rnologia ecdotica e lingua letteraria del Medioevo romanzo,
Firenze 2002, pp. 125-153; La filologia romanza e i coctiii (1991), ora in l'ct doppia veritir cit'
pp'205-2ll' bl canzoniere portoghese della Biblioteca Na-
(49) A. FERRARI, Formazione e struttura a
zionale di Lisbona (cod.. 10991: colocci-Brancuti),Paris,1979; per la definizione di "filologia
- _[.:
..:..1-
i *_"'
*,..':'
I "'1;':
*:: t:
110-
'nto
aVa
raYa
con>inan-
zio-rsito
ica:le lafaire
;las-l0trers et
e vi-i des
ation:rf i-ables
:elles-16)
reco-rrnico
luelloa unaquali,della
rari. aulso e
-29-si veniva deflnendo come <fllologia materiale>>, intendendo con cib ripren-
dere intuizioni del fondatore della scuola romana' Ernesto Monaci, e nel
contempo sottolineare le condizioni speciflche della filologia romanza in
quanto htotogia moderna, come con formula icastica aveva enunciato Gian-
fianco Contini, proprio nell'epicedio di Joseph B6dier:
<<Le sue teorie non fanno che illustrare la libertd dello scriba romanzo'
la sostanziale equivalenza di nuova copia a nuova edizione; ossia in un altro
aspetto, la definizione stessa di filologia romanza>>'
Roncaglia ha sempre affermato l,imprescindibilita, nella critica del
testo, di <<corredare le affetmazioni teoriche e i consigli metodologici con
esempi concreti, tratti dal lavoro critico>>, poich6 <ogni caso costituisce un
probllma a s6, e non esiste un metodo assoluto, buono per tutti i casi' Quel-
1o che chiamiamo metodo E in realtd una somma d'indicazioni estratte da
concfete esperienze storiche, e nello stesso modo - storicamente - s'evolve
e si perfezionarr(50).
Forr"proprioapartiredataliriflessioni'nel1974'chiamatoaespor-re nel xIV congrerro lrrr*ozionale di Linguistica e Filologia romanza la
propria visione generale della critica testuale, in dittico dialettico col gran-
de bddieriano francese F6lix L6coy, ne estraeva la sostanza metodol0gica e
Droponeva quella che a tutt'oggi appare la pii sottile e stimolante esposizio-
ne delle proilematiche teoriche della critica testuale romanza post-lachman-
niana e che varrd quindi ricordare per intero:
<[...] bisogna riconosc"." ton chiatezza e mantenere ben saldo che i
due tipi d'edizione tra i quali oscilla la pratica e disputa la teoria - da un
lato il ricostruttivo, fedele ai principi lachmanniani canonizzati geometrico
,nore dalMaas (o perseguito attraverso procedimenti probabilistici anche di-
rersi da quelli della stJmmat\catradizionale); d'altro lato il documentario'
f,ncorato, secondo l,insegnamento b6dieriano, a un ..manoscritto di base,,,
.-on eventuale estension" d'irt".r"nti restaurativi rigorosamente circoscrit-
ra ai casi in cui risulti indiscutibile l'evidenza interna della comrttela e al-
tresi del modo di sanarla- non rappresentano un'opposizione di metodi in
.-oncorrenza per un medesimo scopo, ma un'alterith di soluzioni pertinenti
a problemi distinti e funzionali a scopi differenti' Attraverso un vaglio ra-
zionale di tutte |e attestazioni in nostro possesso, I'edizione ricostruttiva si
:forza di scoprire e ripercorrere le linee del sistema di collegamento che ha
rrasmesso a noi il testo, nell'ambizione di raggiungere, come oggetto ideale
di conoscen za, 'Ilrlo stato del testo quanto pii possibile conforme a quello
impostato tn partenza dall'emittente d'origine [...]. Ledizione documenta-
:]areriale" R. ANroNr,rr.t, Interpretazione e critica del testo,tn Letteratura italiana' diretta da
.\..LsorRosa,IV.L',interpretazione,TorinolgS5,l4l-243,inparticolarep'207'5o' Principi e applicazioni cit', p' 16'
,1978),
9l+-75,
in D'A.1lmatlzo,
t'r-rri cit.
:eca Na-'n1o1ogia
-30-ria, invece, concentra l'attenzione su una singola stazione ripetitrice, assun-
ta come particolarmente significativa, e mira a riprodurre con fedeltd, nella
sua natura d,oggetto reale d'esperienza, il testo messaggio quale fu recepito
e ritrasmesso nel momento e nell'ambiente determinati che quella stazio-
ne rappresenta, prescindendo dal grado della sua conformith all'originale e
solo iurando qu"llu congruenza interna che l'eliminazione dei pii flagranti
e intollerabili rumori meccanici basta a restaurare [.'.]. ualternativa che si
pone a ogni editore di testi non concerne dunque la metodologia generale,
ia ta fiialitd specifica: non si tratta di scegliere quale procedimento sia in
ogricasodapreferire,macasopercasoqualetestopiilimportipresentare:il rappresentante empincamente dato d'unafase della tradizione, o il capo-
nipi* idealmente ricostruito cli tutta la tradizione"(s1)'
Nella critica trobadorica Marcabruno lappresentava perb, oltre che un
caso ecdotico esemplare, anche un punto di snodo fondamentale per l'inter-
pretazione di tutta L poesia provenzale, gih nella tradizione fllologica otto-
novecentesca.Sin dai primi lavori marcabruniani Roncaglia riconosce l',unith ideo-
logica e culturale della lirica di Marcabruno, un poeta di valore assoluto,
,p""rro accostato a Dante per la forza linguistica e per l',esposizione ideolo-
gica, impegnato in on'urpiu battaglia moralizzaffice e moralistica, fino alla
trivialitlr, contro lafin'aior corteie, in nome di un'altraf n'amor, clericale
e vicina alle posizioni cisterciensi. In interventi successivi dedicati a capire
appunto il dettato originario dell'autore, Roncaglia smonta le interpretazioni
precedenti, ct e propJnevano una doppia immagine di Marcabruno' poichd
non riuscivarro a dar conto di alcuni componimenti apparentemente difformi
dalla linea poetica maggioritaria. rffiancano com_Al nucleo marcabruniano' e in stretta connesslone' sl i
plementarmente molteplici ricerche, in parte pubblicate come saggi auto-
nomi, in parte affidate alle dispense dei corsi universitari, sempre- concepiti
in stretta interconnessione con 1'attivith scientifica. Roncaglia(s2) affronta
cosi,conunaStrategiachealmenoaposterioriappareprogrammatica,purrispondendo talvolti a stimoli contingenti, alcuni punti chiave della storia
della lirica provenzale: il riconoscimento della partecipazione di chr6tien
de Troyes ai dibattito fra Bernart de Ventadorn e Raimbaut d'Aurenga sulla
(51) Irt critica testuale, in XIV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia romanza
(Napoli, 15_20 aprile tsii):, Aui,Napoli--Amsterdam, 1977-t981, 5 votl.; I: 1978, pp. 481-488, e
iarticolarmente i. +SZ. Si tenga presente che negli stessi anni Roncaglia aveva promosso' e pre-
fato, l,edizione fotografica " tl ,tuOio codicologico del grande canzoniere estense: Il canzoniere
provenzale estense,riproJotto per il centenario della nascita di Giulio Bertoni' con introduzione
di D'A. S. Avalle e E. Casamassima, parte I' Modena 1979'
62) Che aveva gid pubblicato una famosa antologia della letteratura d'oc e d'o'il, Le pii
belle pagine delle letterature d'oc e d'oi'l' Milano 1961'
--- n-:-: 1-=
li.l,'--l
-;I---:
.-[ -:"-:-
tun-rellapitozio-Lle e
:anti
re si
rale,
La inrare:
apo-
eunnter-
otto-
deo-
luto,:olo-, allaicaleapire
zionirich6brmi
com-auto-:epitirontaL purstoria
:dtien
sulla
tman:a
J88, e
, e pre-
:oniereluzione
Le pii
- 3l -!-oncezione amorosa, gid individuato dal suo grande Maestro e amico Mau-nce Delbouille (un evento capitale nella storia della lirica provenzale)(s3),
l'edizione e f interpretazione della tenzone fra Uc Catola e Marcabrunosull'ideologia d'amore(s4), la tenzone fra Raimbaut d'Aurenga e Guirautde Bornelh sulla funzione della poesia, la famosa rassegna canonizzante diPeire d'Alvernha (Chantarai d'aquetsz trobadors),la poesia di Bernardo diVentadom(s5), ecc. ecc., sempre con rilevanti accertamenti ecdotici e/o sto-
rico-culturali.Nel 1969, stimolato da un libro di Ulrich Mdlk, Trobar clusQ6) affron-
tava analiticamente, ma sempre a partire dalla specificiti e dalla storicithdei testi, alcuni problemi fondamentali per I'interpretazione della lirica tro-badorica, fino a coinvolgere, in garbata polemica, anche le metodologie er-
meneutiche elaborate da Paul Zumthor e Robert Guiette, convinti assertori
dell'inesistenza di una dimensione ideologica nella poesia trobadorica, con-
cepita come <<una poesia [...] essenzialmente formale, dove "le thdme n'estqu un pretexte [...] Le style est tout, et l'argument id6ologique n'est qu'un
matdriau>(s7). Proprio a partfue dall'interpretazione di un sintagma marca-
t'runiano, trobar naturau, Roncaglia ne indicava 1'estrema pertinenza ideo-
logica e storico-culturale e ne ricostruiva, lungo la tradizione trobadorica, le
.resenze e il senso, disegnando un quadro complessivo nuovo, avvincente e
,'onvincente, sia sul piano storiografico che metodologico, almeno per quan-
:o nguardava le prime tte generazioni poetiche trobadoriche, con rilevanti:icadute anche teoriche. La risposta di Erich Kohler(s8) tentava di riproporreun'immagine di Marcabruno e della storia della lirica provenzale sostanzial-
nente tradizionale, cui Roncaglia replicava con successive conferme(se), fln-
:i' M. Dr,Lsouttta, Les osenhals> littdraires ddsignant Raimbaut d'Orange et la chrono-
::e de ces tdmoignages, in <Cultura neolatina> XVII, pp. 49-73; Av. RoNcacrre, Carestia,inCultura neolatina> XVIII, pp. 121-137.
:t' I-a tenzone fra ugo Catola e Marcabrano, rn Linguistica e flologia. Omaggio a Benve-
- ,:, , Ierracini, Milano 1968, pp. 203-254.:: La generazione trobadorica del 1170, testi e appunti del corso ... a.a.1967-68, Roma
'.;6!'. I trovatori, testi e appunti per il corso a.a. 1969-70, Roma 1970; Lobadol, rn Studi in onore
-: F. Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno, Roma 1984, pp. 655-660; Il trovatore Bernart de'.,,.ittdorn, materiali e appunti per il corso ... a.a. 1984-85, Roma 1985, ecc. oltre a numerosis-
:::r3 recensioni e schede in <Cultura neolatina>>, a volte con rilievi del tutto nuovi e importanti.:5' U. Molr, Trobar clus, trobar leu. Studien zur Dichtungstheorie der trobadors, MiJln-
,:l:n 1968.i-' Au. RoNctcttt, <Trobar clus: discussione aperta, in <Cultura neolatina>, XXIX
.969t. pp.5-51.:s' E. KouLrn, <Trobar clus>: discussione aperta. Marcabru und die beiden <Schulenr, in
Cultura neoaltina>, XXX (1970), pp. 300-314.:e' Riflessi di posizioni cistercensi nella poesia del Xil secolo, in I Cistercensi e il Lazio.
:.::i delle giomate di studio dell'Istituto di storia dell'arte dell'Universitd di Roma (17-21 mag'
:... 1977), Roma, pp. ll-22 (rist. in kt lirica, a c. di L. Formisano, Bologna 1990, pp. 25'7-282).
ch6 Nicolb Pasero(60), con metodologia intertestuale affine a quella dispiega-
ta da Delbouille e Roncaglia nell'accertamento del dibattito ideologico fra
Bernardo, Raimbaut e chidtien, riconosceva nerla pastorella di Marcabruno
un attacco contro Gugliemo IX, confermando non solo l,interpretazione del-
la pastorella gid forni"ta da Roncaglia, ma accertando deflnitivamente il ruo.
loideologicogiocatodaMarcabrunoedallasuapoesianellacostituzionedella tradizione lirica trobadorica. Non trobar clus o trobar leu (o almeno'
non soltanto differenzi azion\ puramente stilistiche) non poesia formale, ma
differenti linee storico-culturali e veri e propri scontri ideologici'
Insomma un mosaico, quello trobadorico costruito da Roncaglia in tanti
anni di strenua attiviti di riclrca, che offre gld r pezzi principali di una nuova
ideale storia della lirica provenzale: per frammenti si, ma in realth per punti
chiave che ind\rrzzano a nuove interpretazioni; qualcosa ancora da fare' Per-
ch6 non ce la offri il suo stesso fondatore? credo che una delle ragioni fon-
damentali, apparentemente contradditoria in uno studioso talvolta cosi auda-
ce nelle proposte ecdotiche e storico-culturali relative a singoli argomenti e
questioni, sia stata proprio la sua Somma prudenza storico-filologica e quella
tensione scientifica tutia volta agli accertamenti specialistici, quelli che ama-
va def,nire i <sondaggi in proflnditil: il grande affresco storico si sareb-
be potuto compoffe "q:"u"Oo
si fossero chiariti i punti ancora problematici'
a cominciare dalla poririon" di quel Jaufre Rudel intorno a cui non a caso
moltissimo pensd e disse ma poco scrisse, perch6 - confldava - non gli era
ancora del tutto chiaro il suo ruolo fra Guglielmo IX e Marcabruno'
Non il rifiuto aprioristico quindi del quadro complessivo: quello I'aveva
gid offerto almeno dre volte, ielle Origini e nelle Corti medievali, ma an'
cora una volta la convinzione che la Filologia fomaflza consiste nella ricer-
ca dell'ottimo punto d'equilibrio fra ricerca specialistica e interpretazione
complessivu ,,in quurto prospettive immanenti alla disciplinu e che cosi
delicato punto d'equilibrio no, b uin"olabile a circostante esterne' a un libro
e a un editore: in qualche modo b immanente alla ricerca stessa nella sua ar-
ticolazione " ua.ieia, quando b vera ricerca. Roncaglia il punto di equilibrio
all,interno della propriaricercalo aveva trovato da tempo nei suoi sondaggi
in profondita e netta straordinaria articolazione e coefenza del suo impegno'
Non avvertiva affatto la necessith di ulteriori esposizioni: dovevano essere
i ricercatori e i lettori, semmai, a rendersene conto, che b proprio cid che
tentiamo ancora di fare con questo convegno'
(60) N. pASERo , pastora contro cavaliere, Marcabruno contro Guglielmo IX' Fenomeni
di intertestualitii in <L,autrier jost'una sebissa> (BdT 2g3,30), in <cultura Neolatina>, XLIII
(1gg3), pp. g_25 (rist. parziale in Il punto su: i trovatori, a cura di M. Mancini. Roma-Bari 1991'
pp. 153-162).



























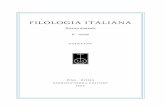


![E]E!DH - RERO DOC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233b14f3cd44b80906ba12/eedh-rero-doc.jpg)










