L'«Occitania poetica genovese» tra storia e filologia
Transcript of L'«Occitania poetica genovese» tra storia e filologia
L’«OCCITANIA POETICA GENOVESE»TRA STORIA E FILOLOGIA*
Tra gli argomenti della medievistica italiana, il rapporto tra il Comune di Genova e la cultura trobadorica è stato oggetto di nume-rosi approfondimenti che hanno sottolineato a più riprese come l’«Occitania poetica genovese» 1 rappresenti un unicum all’interno del panorama italiano, da un lato per l’ospitalità offerta coi suoi domini a diversi trovatori provenzali e, dall’altro, per aver dato i natali al maggior numero tra quelli italiani . Consideratane la natura di fondo, il tema è stato preso in considerazione soprattutto dagli studi letterari: comprendenti anche le diverse edizioni critiche 2, essi si sono concentrati in particolare sulla figura di Lanfranco Cigala (il più prolifico dei Genovesi) 3, sul plurilinguismo di Raimbaut
1 La felice espressione risale a G. FolenA, Tradizione e cultura trobadorica nelle corti e nelle città venete, in Storia della cultura veneta, vol . I, Dalle origini al Trecento, Vicenza 1976, pp . 452-562 (poi in id ., Culture e lingue del Veneto medievale, Padova 1990, pp . 1-137, da cui cito) . Essa si legge a p . 112 ed è stata impiegata a proposito dei rapporti intercorsi tra il trovatore Bartolomeo Zorzi e il Comune ligure, legati essenzialmente ai sette anni di carcere passati a Genova dal mercante di Venezia dal 1266 al 1273 .
2 Si vedano, in ordine di pubblicazione: m. pelAez, Vita e poesie di Bonifazio Calvo, trovatore genovese, Torino 1897 (già in «Giornale storico della letteratura italia-na», XXVIII [1896], pp . 1-44 e XXIX [1897], pp . 318-367); lAnFrAnco ciGAlA, Liriche, a cura di G. tojA, Firenze 1952; F. BrAnciForti, Il canzoniere di Lanfranco Cigala, Firenze 1954; id ., Le rime di Bonifacio Calvo, Catania 1955; luchetto GAttilusio, Liriche . Edizione critica con studio introduttivo, traduzioni dal provenzale, note e glossario a cura di m. Boni, Bologna 1957; W.d. horAn, The Poems of Bonifacio Calvo, Paris-The Hague 1966 . Per le copiose tenzoni dei Genovesi, cfr . ora anche r. hArVey - l. pAterson, The Troubadour Tensos and Partimens. A Critical Edition . In collabora-tion with A . rAdAelli and C . FrAnchi, W . meliGA, G . noto, Z . VerlAto, C . zeni, 3 voll ., Cambridge 2010, in particolare: vol . I, pp . 219-225 (per il testo indicato con la scheda 101,8a = 290,2 da A . Pillet, Bibliographie der Troubadours. Ergänzt, weitergeführt und herausgegeben von H . Carstens, Halle 1933, d’ora in avanti BdT) e 227-236 (BdT 101,11a = 433,1); vol . II, pp . 517-525 (BdT 201,4b = 282,12a) e 851-855 (BdT 258,1a = 282,18a); vol . III, pp . 885-890 (BdT 282,1a = 429,1), 891-900 (BdT 282,1b = 436,1a), 902-912 (BdT 282,14 = 200,1), 1173-1179 (BdT 436,1 = 282,1), 1181-1190 (BdT 436,2 = 13,1), 1191-1194 (BdT 436,3 = 258,1), 1195-1201 (BdT 436,4 = 282,21a), 1203-1208 (BdT 436,5 = 282,21b) .
3 Cfr . G . Bertoni, Due note provenzali, in «Studi medievali», III (1908-1911), pp . 638-672, in particolare pp . 658-672 (II. Sul canzoniere di Lanfranco Cigala); l. sorrento, Intorno alla fortuna del trovatore Lanfranco Cigala, in «Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere - Rendiconti», s . II, LXVII (1934), pp . 681-694, che
* Questo articolo rappresenta una revisione dell’intervento che ho tenuto col medesimo titolo al Circolo Filologico Linguistico Padovano il 6 febbraio 2013 .
6 AlessAndro BAmpA
de Vaqueiras, Bonifacio Calvo e Percivalle Doria 4 e – recentemen-
identifica così i versi già segnalati in id ., Pagina di cultura medievale, in «Aevum», II (1928), pp . 161-190 (entrambi gli articoli sono stati fusi in id ., Medievalia: problemi e studi, Brescia 1943, pp . 228-272); e.G. heAly, Lanfranc Cigala, Poet of the “Dolce Stil Novo” in Provençal, in «Studies in Philology», XLV (1948), pp . 432-444 (l’ipotesi di fondo dell’articolo è stata respinta con forza da BrAnciForti, Il canzoniere cit . con la n . 128 a p . 66, la n . 133 a p . 68, la n . 159 a p . 80, la n . 186 a p . 91, la n . 198 a p . 100: le note – esaustive anche da un punto di vista bibliografico – rendono evidente come, oltre a Healy, l’idea di un contatto tra la maniera di Cigala e quella dello Stilnovo abbia affascinato anche importanti filologi, quali Bertoni, Ugolini e Viscardi); L . sorrento, La spiritualità del trovatore Lanfranco Cigala, in id ., Appunti dei corsi di filologia romanza, Milano 1952, pp . 29-57; K . leWent, Remarks on the Vocabulary of the Italian Troubadour Lanfranc Cigala, in «Studia Neophilologica», XXXII (1960), pp . 310-319; id., On the Text of Lanfranc Cigala’s Poems, in Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti, Palermo 1962, vol . II, pp . 171-192; A .M . Boldorini, Per la biogra-fia del trovatore Lanfranco Cigala, in Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco, Milano 1962, pp . 173-197; R .D . FAce, Lanfranco Cigala of Genoa: the career of a delinquent, in «Medievalia et Humanistica: Studies in Medieval and Renaissance Culture», XV (1963), pp . 77-85 (studio su un possibile cugino omonimo del trovatore, che mette in risalto alcuni documenti sulla sua famiglia); M . peruGi, Lanfranco Cigala nell’epilogo dei “Rerum vulgarium fragmenta”, in «Studi medievali», XXXII (1991), pp . 833-841; id ., Numerologia mariana in due antecedenti del Petrarca: il Canzoniere di Guiraut Riquier e la canzone a Maria di Lanfranco Cigala, in «AnticoModerno», IV (1999), pp . 25-43; m.G. cApusso, Un duello oitaneggiante: lo scambio di sirventesi Lanfranco Cigala-Lantelmo, in Poeti e poesia a Genova (e dintorni) nell’età medievale. Atti del Convegno per Genova capitale della cultura europea 2004, a cura di m. Lecco, Alessandria 2006 (d’ora in avanti citato come Atti Genova 2004), pp . 9-42 (i componi-menti in questione sono Lantelm, qui·us onra ni·us acuoill [BdT 282,13] e Lanfranc, qui·ls vostre fals digz coill [BdT 283,1]) . Per la maggior parte dei testi, si vedano infine le schede di S . centili, in «Repertorio informatizzato dell’antica letteratura trobado-rica e occitana»: 15 .iv .2003 per BdT 282,1 (= 436,1), BdT 282,1a (= 429,1), BdT 282,1b (= 436,1a), BdT 282,2, BdT 282,3, BdT 282,4, BdT 282,5, BdT 282,6, BdT 282,7, BdT 282,8, BdT 282,9, BdT 282,11 e BdT 282,13; 20 .iv .2003 per BdT 282,10; 30 .iv .2003 per BdT 282,12, BdT 282,12a (= 201,4b), BdT 282,14 (= 200,1), BdT 282,16, BdT 282,17, BdT 282,18, BdT 282,18a (= 258,1a), BdT 282,19, BdT 282,20, BdT 282,21a (= 436,4), BdT 282,21b (= 436,5), BdT 282,22, BdT 282,23, BdT 282,24, BdT 282,25 e BdT 282,26 .
4 Per Raimbaut de Vaqueiras, cfr . da ultimi G. cAïti-russo, Appunti per una lettura «malaspiniana» del contrasto bilingue di Rambaldo di Vaqueiras, in Atti Genova 2004 cit ., pp . 189-204 e eAd ., Raimbaut de Vaqueiras, Domna, tant vos ai prejada (BdT 392.7), in «Lecturae tropatorum», II (2009), 21 pp . (da confrontare a livello linguistico con l’edizione offerta da F. sAViotti, Raimbaut de Vaqueiras, Bella tan vos ai pregada, in d. mAntoVAni, Ans am ieu lo chant e∙l ris . Episodi di parodia e satira presso i trovatori, Milano 2008, pp . 139-154) . Per Bonifacio Calvo si vedano m. piccAt, Le «cantigas d’amor» di Bonifacio Calvo, in «Zeitschrift für Romanische Philologie», CV (1989), pp . 161-177, s. mArcenAro, Bonifacio Calvo alla corte di Alfonso X: la rega-lità assente, in «Critica del testo», X/3 (2007), pp . 9-32 e G. tAVAni, Il plurilinguismo poetico e il caso di Bonifacio Calvo (a proposito di Un nou sirventes ses tardar, BdT 101,17), in «Critica del testo», XIII/1 (2010), pp . 17-40 . Infine, per Percivalle Doria,
7L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
te – sul sirventese di Calega Panzano 5, potendo mettere in luce moltissimi dettagli e permettendo la preparazione di diverse visioni d’insieme 6 .
cfr . G. curA curà, Le canzoni di Percivalle Doria. Edizione e commento, in «Filologia italiana», I (2004), pp . 49-59 e c. cAlendA, Percivalle Doria, in I poeti della scuola sici-liana. Edizione promossa dal centro di studi filologici e linguistici siciliani, vol . II, Poeti della corte di Federico II . Edizione critica con commento diretta da c. di GirolAmo, Milano 2008, pp . 751-768 (pp . 751-752 per la biografia, col resoconto della bibliogra-fia precedente; pp . 753-763 per l’edizione e il commento di Come lo giorno quand’è dal maitino; pp . 764-768 per l’edizione e il commento di Amore m’àve priso) .
5 Cfr . l. pAterson, Calega Panzan, Ar es sazos c’om si deu alegrar (BdT 107.1), in «Lecturae tropatorum», V (2012), 24 pp . Sul testo, si veda anche la scheda curata dalla stessa studiosa e da l. BArBieri in «Repertorio informatizzato dell’antica lette-ratura trobadorica e occitana», 5 .i .2013 .
6 Per i trovatori occitanici, possiamo registrare unicamente il contributo di T . leuker, Le poesie “genovesi” di Arnaut de Maruelh, Raimbaut de Vaqueiras e Albertet, in «Medioevo romanzo», XXXVII/2 (2013), pp . 327- 348 . Per i Genovesi, dopo F.l. mAnnucci, Di Lanfranco Cicala e della scuola trovadorica genovese (con ragguagli biografici e documenti inediti), in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», VII (1906), pp . 5-32, risultano decisivi i contributi di G. Bertoni, I trovatori minori di Genova, Dresden 1903 e id ., I trovatori d’Italia. Biografie, testi, traduzioni, note, Modena 1915 (ristampe: Roma 1967 e Genève 1975); dopo gli studi degli anni Venti – con A. restori, I trovatori genovesi, in «Il Comune di Genova», III/8 (1923), pp . 914-917 e c.m. Brunetti, Genova e l’arte dei suoi cavalieri (secolo XIII), Genova 1929 – sono tornati sull’argomento recentemente m. de concA, Genova e Genovesi nelle carte occitaniche, in Atti Genova 2004 cit ., pp . 81-99 e W. meliGA, La tradizione manoscritta dei trovatori genovesi, ibid ., pp . 151-162 . Per quest’ultimo argomento risulta fonda-mentale la parte conservata dal codice di Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, Càmpori γ .N .8 .4: 11, 12, 13, siglato a2 dai provenzalisti (cfr . k. BArtsch, Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur, Elberfeld 1872 e le integrazioni di A. jeAnroy, Bibliographie sommaire des chansonniers provençaux, Paris 1916, BdT, pp . VII-XLIV e della Bibliografia Elettronica dei Trovatori 2.5, a cura di S . Asperti, in rete, aggiornata al 26/09/2012) . Sul codice sono ancora importanti G . Bertoni, Il can-zoniere di Bernart Amoros (Complemento Càmpori), Friburgo 1911 e id ., Il canzoniere provenzale di Bernart Amoros (sezione Riccardiana), Friburgo 1911 . Per quanto con-cerne ancora la tradizione dei testi, ricordo infine un altro lavoro complessivo, quello di F.A. uGolini, La poesia provenzale e l’Italia, Modena 1939 (19492, con revisione, da cui cito), in particolare le pp . XXXIX-XLVII (riprese da luchetto GAttilusio, Liriche cit ., pp . XXX-XXXVII), che correggono, oltre agli altri studi precedenti, soprattutto p. rAjnA, Un frammento di un codice perduto di poesie provenzali, in «Studi di filolo-gia romanza», V (1891), pp . 1-64, in particolare pp . 12-42 per la discussione critica e pp . 45-56 per l’edizione diplomatica dei quattro componimenti traditi da r e assegnati a Lanfranco Cigala, da attribuire invece a Luchetto Gattilusio, ovvero, nell’ordine in cui li riporta il codice: ……………-aigna [A ’n Rizart man que per obra d’aragna], BdT 282,26a (l’incipit e l’intera prima cobla sono sostanzialmente illeggibili, fatto che, per indicare il componimento, costringe a riportare tra [ ] il primo verso della seconda strofa); D’un sirventes m’es granz volontatz preza, BdT 290,1a; Be·m meravilh del mar-ques Moruel, BdT 282,1d; Anc mais nuls hom non trais aital tormen, BdT 282,1c .
8 AlessAndro BAmpA
Ancora oggi, però, sfuggono le cause e le modalità che possono spiegare adeguatamente il fenomeno, in particolare le peculiarità del milieu che favorirono tale fioritura artistica . A livello letterario, la contestualizzazione dei rapporti tra la Repubblica e i trovatori è infatti attualmente rappresentabile da queste pennellate di Bertoni risalenti all’inizio del Novecento:
[l]e ragioni e le cause, onde Genova ebbe ventura di dare al sec . XIII quel ragguardevole numero di poeti provenzali, che tutti sanno, risiedono in gran parte nelle speciali e favorevoli condizioni, in cui Genova veniva posta per effetto della sua situazione geografica, dei suoi possessi e dei frequenti rapporti con la Provenza .A mezzo il secolo XIII, svolgevasi libera e gagliarda la vita pubblica e privata dei Genovesi e la città, già esperta nelle lotte di parte, non s’abbatteva in esse, ché anzi, dotata di virtù di espansione, eserci-tava su tutto il lido un singolare predominio . Né alla sua potenza erasi ormai sottratta la città di Savona, né Ventimiglia, Menton e Monaco eran sfuggite all’avidità della fiorente Repubblica, cui ben anche Nizza era legata con vantaggiosi patti, per quanto non ne fosse rimasta punto scossa la signoria dei conti di Provenza . Con questi Genova ebbe notevoli rapporti, ai quali si intrecciavano le comunicazioni frequenti coi Marchesi di Monferrato, di Malaspina e del Carretto, le cui fiorite corti sonavano di rime e di canti trova-dorici . Né vanno dimenticati gli effetti, che provenivano dal florido commercio genovese, che si diffondeva in gran parte della Francia e in ispecie si stendeva sulla costa . Aveva essa emporio e giurisdi-zione in Narbona; s’accentrava internamente in Montpellier e par-ticolare stanza n’era sulla costa anche Marsiglia, donde i Genovesi dirigevano i loro negozî e la loro navigazione . A ciò si aggiunga che Arles, Avignone e tutte l’altre città più notevoli di Provenza s’erano via via accostate con patti ed alleanze a Genova; né loro conveniva punto rompere l’armonia e l’accordo con quella città potente d’arme e di ricchezze .Tutto ciò contribuiva ad aprir adito in Genova alla poesia proven-zale, la quale doveva trovar quivi luogo sí conveniente al suo fiorire, che ne sorgesse un gruppo di trovatori appartenenti alle più ricche e nobili famiglie genovesi . 7
Tale tentativo d’inquadramento generale della fortuna della liri-ca trobadorica a Genova, rende evidente come l’argomento richieda ulteriori sforzi, per i quali pare assolutamente necessaria l’adozione di una nuova prospettiva metodologica: lo studio dell’«Occitania
7 Bertoni, I trovatori minori cit ., pp . IX-XI .
9L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
poetica genovese», se basato sulle medesime modalità del passato (ovvero esclusivamente sugli strumenti della provenzalistica e della storiografia letteraria italiana del Due-Trecento), potrà continuare ad approfondire solamente gli aspetti più specificamente letterari; come insegna l’esperienza di oltre un secolo di ricerche, difficilmen-te tale metodo potrà spiegare le cause alla base del fenomeno .
Accogliendo l’invito di Bertolucci Pizzorusso, parlando in gene-rale dell’intera situazione italiana nord-occidentale, già in altra sede ho avuto modo di proporre come modello di lavoro per lo studio del tema il già citato saggio di Folena dedicato all’omologa area nord-orientale, soprattutto in virtù dei risultati da esso raggiunti 8 . Il metodo applicato dallo studioso può essere ben esemplificato con la premessa: oltre alla fortuna dell’epica francese, per lo studio della produzione letteraria in lingua d’oc riconducibile al Veneto, essa invita a tenere presente anche
[] le coeve esperienze latine e anche le incipienti tradizioni volgari, dai tentativi plurimi di elaborazione dei dialetti locali nell’orizzonte più largo dell’Italia padana fino alla precoce penetrazione dei pre-stigiosi modelli toscani, prima di lingua poetica, mentre tramon-tava la cultura provenzale e fioriva l’epica romanza francese, poi, nella seconda metà del Trecento, mentre veniva meno ogni influsso letterario francese, anche di prosa artistica . 9
Per comprendere al meglio il suo particolare aspetto trobadori-co, Folena sottolineava così la necessità di uno studio che tenesse conto dell’intera cultura veneta, costantemente presa in considera-
8 A . BAmpA, I trovatori in Liguria e Piemonte: osservazioni di metodo e note bibliografiche, in Lingue, testi, culture: l’eredità di Folena, vent’anni dopo. Atti del XL Convegno Interuniversitario (Bressanone, 12-15 luglio 2012), a cura di I . Paccagnella ed E . Gregori, Padova 2014, pp . 313-329 . Lo studio prende le mosse da V. Bertolucci pizzorusso, Nouvelle géographie de la lyrique occitane entre XIIe et XIIIe siècle. L’Italie Nord-Occidentale, in Scène évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc. Actes du Septième Congrès International de l’Association Internationale d’Études Occitanes. Reggio Calabria-Messina, 7-13 juillet 2002, publiés par R . Castano, S . Guida et F . Latella, Roma 2003 (in seguito citato come Actes septième Congrès A.I.E.O.), pp . 1313-1322 (poi in eAd ., Studi trobadorici, Pisa 2009, pp . 87-94, da cui cito), in parti-colare n . 25, p . 94: «En fait, sur l’expansion de la poésie des troubadours dans l’Italie nord-occidentale nous ne disposons pas encore d’une étude comparable à celle de Folena à l’égard de sa diffusion et de sa réception dans le Nord-Est» . Per un primo inquadramento del tema nord-occidentale, si veda M . Bellotti, L’intertexte italo-occitan dans le Nord-Ouest de l’Italie: quelques pistes de recherche sur la lyrique des troubadours, in «Revue des langues romanes», CIV/1 (2010), pp . 139-152 .
9 FolenA, Tradizione e cultura trobadorica cit ., p . 3 .
10 AlessAndro BAmpA
zione nei suoi molteplici aspetti dal saggio, la cui metodologia di fondo potrebbe allora essere utilizzata per provare a comprendere meglio il fenomeno genovese .
Questa proposta pone in realtà sin da subito un problema, quello relativo alla scarsità degli studi concepiti esclusivamente con l’o-biettivo di offrire una panoramica quanto più esauriente possibile della cultura genovese, o quantomeno ligure, quattro in totale, tutti lontani dall’aver approfondito fino in fondo l’argomento . Procedendo in ordine cronologico troviamo innanzitutto la Storia letteraria della Liguria di Spotorno: pur nella raccolta di dati per il periodo compreso tra il 1100 e il 1300 10, essa appare chiaramente superata dagli studi successivi sui singoli temi, pronti a rilevarne gli errori e a rivederne le conclusioni, nella gran parte dei casi oggi quantomeno da sottoporre a nuove verifiche . Ben più recentemente il lavoro di Risso, pur riportan-do alcuni degli spunti più interessanti delle ricerche precedenti, per la sua esilità non può con ogni evidenza soddisfare tutte le esigenze che una presentazione della cultura genovese medievale richiede 11 . Passando poi al primo volume de La letteratura in genovese di Toso della fine degli anni Novanta, occorre rilevare come la descrizione dell’evoluzione culturale di Genova dal XII al XIII secolo, basata sulla scelta di un ottimo campione dei testi letterari medievali, dei quali vengono sempre messi in rilievo i rapporti più evidenti, abbia spesso lasciato implicitamente al lettore il compito dell’approfondimento dei fenomeni alla base della stessa 12 . Resta la Storia della cultura ligure, curata da Puncuh tra il 2004 e il 2005 13: anche se in quattro volumi, essa offre solo qualche spunto di ordine generale, spesso riassuntivo di monografie del passato . La sua inadeguatezza rispetto ai nostri fini può essere facilmente esemplificata proprio con lo spazio dedicato alla letteratura del Duecento, argomento trattato in una panoramica di venti pagine sui trovatori, su Iacopo da Varagine e sull’Anonimo, peraltro incompiuta e sprovvista di una seppur minima biblio-grafia per l’improvvisa scomparsa dell’autore, l’italianista Croce 14 .
10 G.B. spotorno, Storia letteraria della Liguria, vol . I, Genova 1824, in partico-lare pp . 113-318 .
11 A . risso, Caffaro e la cultura genovese, in Storia illustrata di Genova, I. Genova antica e medievale, a cura di L . Borzani, G . Pistarino, F . Ragazzi, Milano 1993, pp . 161-176 .
12 F. toso, La letteratura in genovese. Ottocento anni di storia, arte, cultura e lingua in Liguria, vol . I, Il medioevo, Recco 1999 .
13 Storia della cultura ligure, a cura da D . Puncuh, 4 voll ., Genova 2004-2005 ( = «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n .s ., XLIV/1-2 e XLV/1-2) .
14 F. croce, La letteratura dal Duecento al Quattrocento, in Storia della cultura
11L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
Ricordando la parzialità alla base delle ricerche destinate esclusiva-mente alla letteratura in lingua latina di Beltrami e Giusti 15, rispetto a tutti questi lavori emerge in sostanza l’obbligo di rivisitare in prima persona le singole attestazioni letterarie più vicine al fenomeno troba-dorico e le relative bibliografie, obbligo che non può non complicare lo studio del tema in esame .
Procedendo con ordine, per predisporre questa analisi culturale occorre innanzitutto individuarne i confini cronologici . Da un lato, si può prendere il periodo compreso tra il 1183 e il 1190, in cui si inserisce la composizione del primo testo trobadorico riferibile al Comune, il contrasto bilingue con la Genovese di Raimbaut de Vaqueiras 16; dall’altro, troviamo l’ultima attestazione di un trovatore genovese, Calega Panzano, ancora vivo nel 1313 17 .
All’interno della produzione letteraria di questo lungo periodo, considerando esclusivamente i risultati già raggiunti dagli studiosi , nella prospettiva che abbiamo assunto risultano di grandissimo interesse i testi di carattere essenzialmente storico, ovvero le fonti dirette della storia di Genova18 . In particolare, andranno considerate le ricerche sugli Annales ianuenses (la cronaca ufficiale del Comune che registra gli avvenimenti dal 1099 al 1293) 19, sulla Chronica civi-
ligure cit ., vol . IV, pp . 5-26 .15 A. BeltrAmi, Gli scrittori latini della Liguria medievale, in «Il Comune di
Genova», III/6 (1923), pp . 648-656; A. Giusti, Lingua e letteratura latine in Liguria, in Storia di Genova dalle origini al tempo nostro, vol . II, Genova nel basso impero e nell’al-to medioevo, a cura dell’Istituto per la Storia di Genova, Milano 1941, pp . 321-349 .
16 Il testo, composto presso la corte dei Malaspina, come testimoniato dalla tornada, è datato all’incirca al 1186 da V. de BArtholomAeis, Poesie provenzali storiche relative all’Italia, 2 voll ., Roma 1931, vol . I, pp . 16-17, intorno al 1190 da j. linskill, The Poems of the Troubadour Raimbaut de Vaqueiras, The Hague 1964, p . 104 e nel periodo compreso tra il 1183 e il 1185 da G. cAïti-russo, Les troubadours et la cour des Malaspina, Montpellier 2005, pp . 26-27 ed eAd ., Appunti per una lettura «malaspi-niana» cit ., pp . 189-194 .
17 Cfr . Bertoni, I trovatori d’Italia cit ., pp . 112-113 .18 Nato con l’obiettivo di indicare i primi strumenti per un approfondimento
dello studio della cultura genovese nel medioevo, l’intervento nel suo prosieguo non toccherà, se non marginalmente, le altre opere letterarie riconducibili a questo milieu («uno dei centri più vivi della cultura duecentesca»: R . Antonelli - S . BiAnchini, Dal clericus al Poeta, in Letteratura italiana, direzione di A . Asor Rosa, vol . II, Produzione e consumo, Torino 1983, pp . 171-227: p . 197) per l’assenza di studi a esse dedicati in grado di fornire ulteriori spunti rispetto alla sola Occitania; una descrizione più dettagliata possibile del contesto genovese imporrà però, ovviamente, anche una loro riconsiderazione .
19 Ancora oggi l’edizione di riferimento è rappresentata dagli Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, 5 voll ., a cura di l.t. BelGrAno (voll . I-II) e C . imperiAle
12 AlessAndro BAmpA
tatis ianuensis di Iacopo da Varagine (che, dalla leggendaria nascita di Genova, arriva agli antefatti della battaglia di Curzola del 1298) 20 e sull’epinicio del notaio Ursone da Sestri, l’Historia de victoria quam Ianuenses habuerunt contra gentes ab imperatore missas (dedicata alla battaglia del 1242 di fronte all’isola del Giglio contro le fila ghibelline) 21 .
Per quanto riguarda gli Annales, è necessario evidenziare come essi assumano il carattere di cronaca ufficiale del Comune nel 1152, quando Caffaro di Rustico da Caschifellone, illustre genovese nato intorno al 1080, presenta la sua opera alla cancelleria del Comune . Da quella data in avanti, a circa un trentennio dai primi passaggi attestatici dei trovatori occitanici per la Repubblica, lo stile anna-listico cambia, assumendo valori più specificamente letterari: con l’ufficializzazione dell’incarico, dalle scarne annotazioni di un appassionato della storia genovese, coinvolto per la sua funzione pubblica in diverse imprese del Comune, si passa a un resoconto dei gesta affidato – dopo la morte del fondatore della storiografia geno-vese – ai professionisti della cancelleria, maggiormente ricercato sotto il punto di vista stilistico attraverso l’impiego della prosa arti-stica mediolatina (con l’utilizzo ad esempio del cursus, dell’inserzio-ne dei versi, di descrizioni sempre più vive e di metafore via via più ardite) . Tale valore letterario è riscontrabile anche nella Chronica di Iacopo da Varagine, composta subito dopo la conclusione degli Annales durante l’ultimo incarico della sua gloriosa carriera eccle-siastica: scritta da un arcivescovo, allora guida spirituale del proprio Comune d’origine, essa non deve essere letta primariamente come attestazione storica, bensì come il testo di un religioso che si rivolge ai suoi fedeli per esaltare Genova ed educare i suoi concittadini, assumendo il ruolo letterario di un vero e proprio speculum .
Di sAnt’AnGelo (voll . II-V), Genova (voll . I-II) e Roma (voll . III-V) 1890 (I), 1901 (II), 1923 (III), 1926 (IV), 1929 (V) . L’opera verrà in seguito citata semplicemente come Annali .
20 Con la revisione di Jacopo da Varagine e la sua Cronaca di Genova: dalle origini al MCCXCVII . Studio introduttivo e testo critico commentato di G. monleone, 3 voll ., Roma 1941, l’edizione più affidabile dell’opera è rappresentata da iAcopo dA VArAGine, Cronaca della città di Genova dalle origini fino al 1297. Testo latino in appendice, introduzione, traduzione e note critiche di s. Bertini Guidetti, Genova 1995 .
21 Per il testo, si veda ursone notAio, Poema della vittoria (Palmaria Portovenere Vernazza Levanto, 1242) . Cura e traduzione con testo a fronte di r. centi, Genova-La Spezia 1993, che riproduce l’edizione offerta da Vittoria de’genovesi sopra l’armata di Federico II . Carme di Ursone, notaio del secolo XIII illustrato e volto in italiano da P .G.B. GrAziAni, Genova 1857 .
13L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
Prima di approfondire il discorso sui due testi e lasciando per un attimo da parte l’epinicio, occorre evidenziare un dato . Anche sulla base di queste rapide descrizioni, appare evidente come, nella Genova del medioevo, emerga subito la presenza di almeno due centri cultu-rali: da un lato, troviamo quello legato al potere laico, incarnato dall’i-stituzione comunale; dall’altro, si segnala quello basato sull’Ordine dei Predicatori, introdotto a Genova durante la fine del secondo decennio del XIII secolo e incentrato – a partire dal 1240 circa – sul convento di San Domenico, che nel 1244 accoglie l’allora giovane Iacopo da Varagine, un ambiente quindi genericamente ecclesiastico . Il discor-so evidentemente non è fine a se stesso: nel trattare dell’«Occitania poetica», ci si deve porre il problema del se e del come il cenacolo rappresentato dai trovatori autoctoni possa essere in relazione con questi due centri, per andare oltre la constatazione dei nobili natali dei trovatori genovesi e, considerate le loro funzioni pubbliche, la supposizione del probabile rapporto diretto col primo, quello laico .
Tale questione è stata affrontata sporadicamente soprattutto dagli storici, in particolare dagli stessi che hanno pubblicato queste stesse cro-nache cittadine tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento mostrando notevole attenzione agli aspetti letterari, fatto che rende i loro lavori imprescindibili per provare ad affrontare attraverso una nuova prospettiva il problema rappresentato dall’«Occitania poetica» .
Scontando consapevolmente un’inversione cronologica, per rendere più agevole il discorso parto dall’edizione della Chronica di Iacopo da Varagine procurata da Monleone . Nel primo volume, dopo un’esaustiva presentazione della figura del Domenicano, viene dedicato un paragrafo proprio a questi due centri di cultura, comin-ciando da quello
[…] di carattere laico, politico e civile, [che] aveva a capo, si può dire, quel maestro Bartolomeo, notaro, grammatico e annalista del Comune, a cui possiamo mettere vicino, da un lato Lanfranco Cigala, rimatore e giureconsulto, insieme con gli altri poeti e trovatori genovesi, compreso, forse, anche il famoso Anonimo; e dall’altro lato il notaro Ursone, scrittore e poeta latino, autore fra l’altro d’un carme sulla vittoria navale ottenuta nel 1242 dalle galee genovesi contro i Pisani e perciò contro il grande nemico di Genova, Federico II . Intorno a questi astri maggiori si aggirava tutto il siste-ma planetario dei notari, un po’ raccoglitori e storici anch’essi, ma soprattutto spesso custodi e spesso artefici del meraviglioso movi-
14 AlessAndro BAmpA
mento commerciale e marittimo dell’antica Repubblica . 22
Permettendo di richiamare anche l’epinicio di Ursone, queste parole delineano un centro ben definito, al quale lo storico ha poi contrapposto quello ecclesiastico, presente a partire dai conventi, in particolare quello della badia dei Cistercensi a Sestri Ponente, quello dei Mortariensi di Paverano e soprattutto quello già ricorda-to dei Predicatori a Genova, tutti luoghi di studio e di produzione manoscritta . Monleone si è ovviamente concentrato sull’ultimo convento citato, dove il da Varagine deve aver conosciuto Giovanni Balbi, l’autore del Catholicon e, forse, considerati i prologhi eruditi di entrambe le loro opere, uno dei possibili ispiratori della Chronica, Iacopo Doria, l’ultimo annalista del Comune, la cui famiglia risiede-va proprio nelle vicinanze del convento domenicano 23 .
Monleone non si è fermato qui . La sua ricerca metodica delle fonti utilizzate da Iacopo, ha infatti permesso di ricostruire il patri-monio librario del polo ecclesiastico, caratterizzato dalla dispo-nibilità di almeno quattro tipologie di testi: alle sacre scritture e alle leggende dei santi si contrappongono i classici latini e (con la mediazione di questi) greci, i testi dei Padri della Chiesa e di altri scrittori dei primi secoli cristiani e del Medioevo e, infine, gli Annales e i documenti genovesi . Sostanzialmente, accanto alle opere propedeutiche a una formazione ecclesiastica, tutte presenti anche nella Legenda, troviamo anche la produzione laica del Comune di Genova 24 .
A queste prime osservazioni sull’ambiente genovese offerte da Monleone, già indicative di un approfondimento della tematica cul-turale, bisogna aggiungere quelle ben più numerose riportate dall’e-dizione di riferimento degli Annales . Per il tema di questo articolo, ci interessano soprattutto le introduzioni al testo dei singoli continua-tori di Caffaro, con le diverse riflessioni sulla stesura della cronache di Oberto Cancelliere, Ottobuono Scriba, Ogerio Pane e Marchisio Scriba (che si succedono l’un l’altro fino al 1225), degli anonimi che proseguono l’opera fino al 1264, dei singoli collegi preposti alla redazione degli eventi fino al 1279 e, infine, di Iacopo Doria, l’ulti-mo continuatore di Caffaro . A livello generale, ad esempio, queste introduzioni sottolineano come lo stile diventi via via sempre più indizio – assieme ai silenzi – della soggiacente pressione politica sul
22 monleone, Jacopo da Varagine e la sua Cronaca cit ., vol . I, pp . 179-180 .23 Cfr . ibid ., vol . I, pp . 180-183 .24 Cfr . ibid ., vol . I, pp . 205-228 .
15L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
resoconto dei fatti, evidente nella drammatizzazione del racconto relativo allo scontro con Federico II e nel progressivo allargamento degli orizzonti della narrazione che, prendendo in considerazione anche eventi che non coinvolgono direttamente Genova, oltre a porre il Comune su un piano che oggi chiameremmo "internaziona-le", rendono gli Annales una testimonianza dell’intera storia europea del XII e XIII secolo 25 . Più in particolare, come ho già anticipato, questo legame col Comune emerge anche dalle ricerche sulla cultura dei singoli annalisti desumibile dalle citazioni e dall’usus scribendi, tema sul quale, ai nostri fini, risultano importanti gli approfondi-menti dedicati al periodo della redazione anonima . La disamina stilistica ha permesso di evidenziare ad esempio che
[…] il complesso degli Annali di questo periodo non è dovuto, […] in particolar modo, a questo o a quell’individuo, ma piuttosto all’opera collettiva di quella cancelleria del comune che in mezzo al continuo succedersi di podestà, ora guelfi, ora ghibellini, al con-tinuo avvicendarsi dei partiti al governo, rappresentava, come la moderna burocrazia, la continuità dell’indirizzo amministrativo, e per qualche riguardo, anche politico .Conviene osservare che questo collegio di scribi del Comune e dei placiti costituiva allora in Genova, come altrove, per esempio alla corte di Federico II, quello che oggi si chiamerebbe un centro intellettuale, perché composto di maestri, di notari, alcuni dei quali erano anche letterati ed eruditi; di persone insomma che ammes-se alla cognizione dei più gelosi affari di Stato, non si limitavano soltanto a redigere gli atti del governo, ma erano spesso chiamate a trattare le questioni più gravi, come segretari di questa o quella legazione, e talvolta anche nella qualità di ambasciatori . 26
Al riguardo occorre rilevare come lo studio di questa partico-lare cultura abbia permesso a Imperiale di Sant’Angelo di inserire all’interno di questa schiera di annalisti anonimi, anche Ursone da Sestri il cui epinicio è stato confrontato coi passi della redazione cronachistica relativa alla vittoria contro Federico II nel 1242, tema
25 Cfr . Annali cit ., vol . III, pp . XXXIV-XLI e vol . IV, pp . VII-XI con, in chiusura, il celebre giudizio del Pertz che, nell’introduzione alla sua edizione, li ha procla-mati «luculentissima Ianuensis gloriae monumenta et qui non Italiae solum, sed et Germaniae nostrae atque Orbis terrarum per saecula XII et XIII historiam multis modis illustrant» (Monumenta Germaniae Historica […] . Edidit G.h. pertz […]. Scriptores, vol . XVIII, Hannoverae MDCCCLXIII, p . 11) .
26 Annali cit ., vol . III, pp . XVII-XVIII .
16 AlessAndro BAmpA
del carme celebrativo 27: il confronto, prescindendo dalla soluzione più o meno definitiva della delicata questione specifica, evidenzia in maniera palese come, da storico, Imperiale di Sant’Angelo si sia dimostrato totalmente disponibile nei confronti delle fonti e delle metodologie letterarie, constatazione che trova conferma nell’edi-zione degli Annales con le note relative a due particolari eventi del 1244 e del 1245, ovvero il bacio del papa genovese Innocenzo IV a Bonifacio II del Monferrato per sancire l’alleanza guelfa con-tro Federico II e il successivo tradimento della stessa da parte di quest’ultimo . I passi degli Annales relativi a questi avvenimenti, infatti, sono stati confrontati puntualmente con Estier mon grat mi fan dir vilanatge, l’invettiva diretta contro Bonifacio II dal trovatore Lanfranco Cigala (BdT 282,6) 28 . Il discorso è il medesimo per la nota al passo dedicato allo scontro tra Carlo d’Angiò e Corradino del 1268, messo a confronto dall’editore con alcuni loci del sirventese di Calega Panzano, da ricondurre al medesimo periodo 29 .
Queste ultime annotazioni evidenziano come l’edizione di riferi-mento degli Annales procurata dagli storici, non solo abbia sempre sottolineato i passi della cronaca che hanno chiamato direttamente in causa i principali trovatori genovesi (in particolare Lanfranco Cigala, Percivalle Doria e Luchetto Gattilusio, i più coinvolti nelle vicende politiche del Comune 30), ma anche come questi si siano avvalsi dei contributi della filologia provenzale allora disponibili, fornendo infine importanti spunti relativi alle condizioni culturali della Genova del Duecento .
In quest’ottica occorre sottolineare anche la riflessione svolta da Imperiale di Sant’Angelo in merito al passaggio dalla redazione
27 Cfr . ibid., vol . III: n . 2, pp . 123-124; n . 4, p . 127; n . 4, p . 128; n . 2, p . 129; n . 1, p . 132 . Sull’epinicio, cfr . anche t. VAllAuri, in Historiae Patriae Monumenta, Torino 1853, Chartarum tomus II, coll . 1741-64 e lo studio di V. ciAn, Un epinicio genovese del Dugento, in Per l’infanzia povera: prose e versi, Genova 1901, pp . 59-74 . Cfr . poi BeltrAmi, Gli scrittori latini cit ., pp . 652-656 e Giusti, Lingua e letteratura latine cit ., pp . 333-335 .
28 Cfr . Annali cit ., vol . III, n . 3, p . 154 e n . 3, pp . 160-161 .29 Cfr . ibid ., vol . IV, n . 3, p . 110 . Errata è invece l’interpretazione offerta poco
oltre, n . 1, p . 115, che propone implicitamente il 1269 come termine post quem per il sirventese, troppo tardo rispetto a quanto evidenziato da tutti gli studi dedicati a esso: cfr . da ultimo pAterson, Calega Panzan cit ., pp . 1-15 .
30 Rinvio all’Indice dei nomi propri e della cose notevoli degli Annali cit ., vol . V, pp . 177-249, da confrontare con quelli posti al termine di ogni volume della loro tra-duzione, ovvero Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori, 9 voll ., a cura di c. roccAtAGliAtA ceccArdi (vol . I) e G. monleone (vol . II-IX), Genova 1923 (I), 1924 (II), 1925 (III), 1928 (IV-V), 1929 (VI-VII), 1930 (VIII-IX) .
17L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
anonima a quella collegiale del periodo 1264-1279, affidata di volta in volta a quattro scrittori . Il cambio è voluto evidentemente dal governo, in questo periodo tornato in mano all’aristocrazia dopo la cacciata del primo capitano del Popolo, Guglielmo Boccanegra: l’in-carico di redigere la cronaca del Comune passa agli esponenti delle classi più agiate, i nobili, evidentemente ritenuti più affidabili nella relazione degli eventi del Comune, immuni com’erano da sentimenti vicini ai populares . Al riguardo, per inquadrare meglio l’«Occitania poetica genovese», paiono importanti le parole dedicate al primo annalista della nuova serie, Lanfranco Pignolo:
[e]gli è […] da considerarsi, per le cariche rivestite […], tra i più autorevoli di quella schiera di giureconsulti della quale fanno parte Ugo Fieschi conte di Lavagna, parente di due pontefici, Innocenzo IV e Adriano V, i celebri trovatori Lanfranco Cicala e Luchetto Gattilusio, capo stipite [sic] dei signori di Metellino e molti altri patrizi i cui nomi ricorrono assai di frequente negli Annali e nei documenti di quell’epoca .Indizio anche questo di un singolar grado di cultura di una classe che in quei tempi teneva il vanto in Italia di aver dato alla gaia scienza il maggior numero di trovatori, - che non reputava incom-patibile con le molteplici cure della navigazione, dei commerci, delle guerre, della politica, l’esercizio di quelle professioni che oggi chiamiamo liberali e che allora molte altre aristocrazie tenevano in disdegno . Non può quindi recar sorpresa che dopo un lungo inter-vallo in cui pareva dimenticata la tradizione di Caffaro, uomo di Stato, e guerriero, il quale aveva dimostrato di saper maneggiare la penna come la spada, altri patrizi riprendessero l’ufficio abbando-nato per tanti anni agli scribi del Comune, dimostrando non solo la volontà ma anche la capacità di esercitarlo . 31
Sull’importanza di queste affermazioni tornerò subito; prima infatti bisogna evidenziare la linearità del ragionamento, che giu-stifica così anche la successiva prosecuzione della redazione degli Annales a cura di Iacopo Doria, componente dell’ultimo collegio incaricato della stesura dell’opera, nominato nel 1280 custode dell’archivio del Comune e, infine, unico cronista – per quanto solo ex post, non essendoci stato alcun incarico ufficiale – del nuovo regime, la diarchia costituita da Oberto Spinola e Oberto Doria, fratello di Iacopo . Anche in questo caso l’introduzione al testo di Imperiale di Sant’Angelo si lascia apprezzare per le considerazioni
31 Annali cit ., vol . IV, pp . LI-LII .
18 AlessAndro BAmpA
sulla cultura genovese, ricordando un trattatello di mascalcia attrib-buito all’ultimo annalista, la Pratica equorum, «strano amalgama di rimedi empirici e di ingenue superstizioni, di cui troviamo, del resto, non pochi esempi fra le carte di mastro Salmone, di Giovanni di Amandolesio e di altri notai genovesi di quel secolo XIII» . Su queste basi secondo lo studioso non sarebbe
[ . . .] improbabile che in un’epoca in cui l’arte della medicina con-tava fra i suoi cultori uomini ragguardevoli nelle professioni legali ed anche personaggi rivestiti di alte dignità ecclesiastiche come il vescovo Teodorico di Cervia, l’arcivescovo genovese Giovanni di Cogorno, ed il canonico Simone da Genova, medico di papa Nicolò IV, e cappellano di Bonifacio VIII, il nostro annalista, che ebbe forse dimestichezza con alcuno di costoro, abbia ceduto al desiderio di mettere in carta quei precetti che, per esperienza pro-pria, o dalle popolari consuetudini aveva raccolto . 32
Con queste ultime frasi, Imperiale di Sant’Angelo è tornato a parlare del centro culturale ecclesiastico, tema approfondito subito dopo ricordando come esso a Genova sia rappresentato, oltre che dal convento di San Domenico, anche da quello dei Frati Minori,
32 Ibid ., vol . V, p . XX . Accettata con queste parole anche da Imperiale di Sant’Angelo, l’attribuzione a Iacopo della Pratica equorum conservata nel ms . lat . VII . 25 (3472) della Biblioteca Marciana di Venezia è stata proposta da i. morelli, Codices manuscripti latini bibliothecae Nanianae a Jacopo Morellio relati. Opuscula inedita accedunt ex iisdem deprompta, Venetiis 1776, p . 73, scheda LXVI, per essere ripresa successivamente da spotorno, Storia letteraria cit ., pp . 142-143 e l.t. BelGrAno, Della vita privata dei genovesi . Seconda edizione accresciuta di moltis-sime notizie, aggiuntevi alcune tavole comparative dei valori monetari genovesi colla odierna moneta italiana compilate da C . desimoni, Genova 18752 (18661, revisione dell’articolo del medesimo anno pubblicato negli «Atti della Società Ligure di Storia Patria», IV, pp . 79-274; ristampe: Roma 1970 e Genova 2003), n . 4, pp . 282-283 . Al riguardo, occorre però segnalare come essa sia stata recentemente messa nuovamen-te in discussione da G. petti BAlBi, Il presente e il senso della storia in Caffaro e nei suoi continuatori, in Il senso della storia nella cultura medievale italiana, 1100-1350. Quattordicesimo Convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d’arte, Pistoia, 14-17 maggio 1993, Pistoia 1995, pp . 31-52, in particolare n . 44, p . 46: il codice contie-ne «la Pratica equorum di Teodorico vescovo di Cervia, seguita da un’altra breve com-posizione dal titolo Pratica equorum. Quedam compilatio Iacobi Auriae, articolata su 59 brevi capitoletti (ff . 31-34) . Sono regole di carattere pratico che prevedono l’uso di mele, aceto, olio, cera, sapone, per curare talune malattie equine . L’unico riferimento interno al Doria è nel capitoletto relativo alla cura della scabbia in cui si asserisce che l’ha provata dominus Iacobus Aurie in quodam equo hispano qui habebat dulcedinem . Sulla base di questa citazione il trattatello viene attribuito al nostro, anche se si pos-sono avanzare, a mio parere, dubbi sulla paternità dell’opera» .
19L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
San Francesco in Castelletto, frequentato da intellettuali di spicco (su tutti, Salimbene de Adam, fra il 1248 e il 1249) . Entrambi sorge-vano a poca distanza dalla casa paterna di Iacopo Doria, fatto che ha permesso all’editore degli Annales di ipotizzare una frequentazione delle loro biblioteche e che quindi giustifica – assieme alla probabile esistenza di un archivio familiare – la ricchezza del proemio intro-duttivo, vicino, come già accennato, a quello di Iacopo da Varagine e caratterizzato, rispetto a quelli dei suoi predecessori, dalla ricerca di notizie sulla nascita di Genova e sulla sua presenza tra le fonti antiche e altomedievali 33 .
Prima di una rapida revisione di quanto appena detto, bisogna ricordare come, anche con Iacopo Doria, l’edizione degli Annales torni ad accennare direttamente all’«Occitania poetica» . La man-canza di un’erudizione che oltrepassi le opere storiografiche e la presenza di diverse locuzioni dialettali nella stesura del cronista hanno infatti permesso a Imperiale di Sant’Angelo di tornare a par-lare, seppur fugacemente, in nota, dei compositori in lingua d’oc, tratteggiando molto rapidamente l’evoluzione della cultura lettera-ria genovese nel corso del Duecento:
[m]entre nella prima metà del secolo XIII i trovatori genovesi rima-vano in provenzale ed il notaio Ursone celebrava una vittoria della flotta genovese in versi latini, in cui ricorrono reminescenze classi-che, ai tempi del nostro annalista, fioriscono invece i canti dialettali dell’Anonimo Genovese, nei quali troviamo i particolari più esatti dei costumi, degli avvenimenti cittadini, delle grandi battaglie nava-li di Laiazzo e di Curzola . 34
Nella sua brevità, questa nota si è spinta ben oltre quanto rico-struito dalla maggioranza delle opere più recenti sulla cultura geno-vese medievale, rendendo palese lo scarto tra gli studi letterari e quelli storici che siamo costretti a registrare in merito: riassumendo quanto emerso dall’analisi delle edizioni delle cronache genovesi, posso infatti dire che, ribadito con Monleone quanto si osserva a una primissima analisi, gli spunti offerti dagli studi di carattere più spiccatamente storico, soprattutto con l’edizione degli Annales, sono già arrivati a toccare un argomento raramente affrontato dalla pro-venzalistica e dalla critica letteraria in generale, ovvero l’ambiente culturale e letterario genovese del Duecento .
33 Cfr . Annali cit ., vol . V, pp . XXXIV-XXXVII .34 Ibid ., vol . V, n . 2, p . XXXVII .
20 AlessAndro BAmpA
Tale constatazione non deve sorprendere: almeno fino alla pubblicazione delle Poesie provenzali storiche relative all’Italia di De Bartholomaeis, storici e filologi hanno lavorato di conserva ma, a partire dagli anni Quaranta del Novecento, gli studiosi di letteratura provenzale hanno progressivamente trascurato l’opera degli storici . Per citare solo un esempio e tornare a quanto lasciato in sospeso, valga quanto osservato da Imperiale di Sant’Angelo in merito alla diversa formazione culturale delle classi sociali cui appartenevano i notai e di quella dei nobili, differenziazione che gli ha permesso di avvicinare i trovatori genovesi, piuttosto che agli altri annalisti, al solo Iacopo Doria: l’argomento necessita con ogni evidenza di nuovi approfondimenti, che dovranno tener conto anche dell’opera dello storico immediatamente successiva alla pubblicazione dell’ultimo volume degli Annales, tornata a più riprese sulla questione cultura-le 35 .
Chiuso il discorso sugli Annales, occorre mettere in rilievo il ruolo ricoperto dalla Società Ligure di Storia Patria in queste par-ticolari tipologie di ricerca, le più proficue per lo studio di questo argomento . Fondata nel 1857 con l’obiettivo di tutelare e far cono-scere la storia e la cultura genovese, essa si caratterizza ancora oggi per l’orientamento filologico-documentario delle sue pubblicazioni e, quindi, delle metodologie di ricerca di diversi suoi associati, soprattutto del passato . Spiccano, tra gli altri, oltre a Desimoni, altro storico attento agli aspetti letterari (penso ad esempio al suo artico-lo sui trovatori nel Monferrato 36), proprio Belgrano e Imperiale di Sant’Angelo, tutti nel corso del tempo suoi presidenti . In generale, si può dire che, proprio per gli obiettivi che si era prefissata, la Società richiedeva necessariamente che i suoi studiosi realizzassero quel connubio tra diverse discipline storiche e storico-letterarie di cui ho cominciato a parlare .
Sulla base di queste considerazioni, esclusi i casi di Bertoni, De Bartholomaeis e Ugolini (le cui opere maggiori sono necessaria-mente anche di carattere storico), non appare allora una semplice coincidenza il fatto che lo studioso che si sia maggiormente avvalso delle ricerche storiche per parlare del rapporto tra il trobadorismo e Genova sia stato il già citato Mannucci, l’allievo del De Lollis che
35 c. imperiAle di sAnt’AnGelo, Jacopo Doria e i suoi annali. Storia di un’aristocra-zia italiana nel Duecento, Venezia 1930 . Si vedano in particolare le pp . 16-24, dedicate unicamente ai trovatori autoctoni .
36 c. desimoni, Il Marchese Bonifazio di Monferrato e i Trovatori provenzali della sua Corte, in «Giornale Ligustico», V (1878), pp . 241-271 .
21L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
più volte collaborò con la stessa Società, pubblicando per la stessa, ad esempio, un articolo sulla vita del Gattilusio, come in precedenza fece anche Belgrano 37 . Probabilmente proprio per questo motivo egli fu l’unico tra i “letterati”, per così dire, ad avvalersi degli Annales per il suo lavoro sui trovatori genovesi . Egli infatti fu l’unico a ricor-dare il seguente resoconto dato dalla stessa cronaca per la festa del 1227, successiva alla vittoria contro la riottosa Ventimiglia:
Reuersus est […] dominus Laçarius Ianuam die veneris quarta iunii cum gaudio et triumpho; qui in signum uictorie et anni felicissimi in festiuitate sue natiuitate beati Iohannis Baptiste, cuius corpus gloriosum in maiori ecclesia recubat Ianuensi prope altare beati Laurentii, post tribunal ipsius ecclesie, in curia domini archiepi-scopi Ianue mirabilem curiam et dignam memoriam celebrauit . In qua curia innumerabilia indumentorum panna a potestate et aliis nobilibus et honorabilibus uiris fuerunt ioculatoribus, qui de Lonbardia, Prouincia et Tuscia et aliis partibus ad ipsam curiam conuenerant, laudabiliter errogata, et conuiuia magna facta et cete-ra que infra scriptis carminibus continentur:
Omne genus ludi Iani fuit urbe repertumper te, Laçari, tunc quia tempus erat .Implebant pueri totam concentibus urbem,uno psaltabant tunc uetuleque pede .Tunc ueluti iuuenum mores iustique gerebant,audax in ludis queque puella fuit .Et sonipes multo fessus sudore madebat,currebant equites urbis ad omne latus urbis .Tanti discursus et ludicra tanta fuerunt,urbe quod in nulla tanta fuisse reor .Adde quod expensis largos superabat auarus,pauper ad obsequium quisque paratus erat .Uxor zelotipi secure cuncta gerebat,verberibus prauis nulla cohacta fuit .De dominabus porticus omnis densa manebat,res quoque que nimium digna fauore fuit . 38
Per l’occasione, dunque il podestà fece accorrere nel Comune anche diversi giullari, circostanza che solo Mannucci sottolineò,
37 F.l. mAnnucci, Per la biografia di Luchetto Gattilusi trovadore genovese, in «Giornale Storico Letterario della Liguria», IV (1903), pp . 455-459; l.t. BelGrAno, Luchetto Gattilusio, in «Giornale Ligustico», IX (1882), pp . 3-13 .
38 Annali cit ., vol . III, p . 26 .
22 AlessAndro BAmpA
rendendola uno dei cardini principali della sua ipotesi sull’impossi-bilità di un apprendimento della lingua d’oc da parte dei trovatori nella loro città . La narrazione di questo evento nella cronaca, infatti, rappresenta per lo studioso un «segno evidente» di come Genova, al tempo, non dovesse essere così frequentata dai trovatori: Mannucci considera l’avvenimento in questione come un’eccezione e basa anche su di esso la tesi di un apprendimento del provenzale da parte dei trovatori genovesi extra mœnia, durante i loro molteplici incari-chi all’estero, nella Francia meridionale, facilmente documentabili già all’epoca 39 .
Quest’intuizione generale sulla formazione trobadorica dei geno-vesi, all’epoca rappresentò una novità e successivamente fu ripresa soprattutto per Cigala, ad esempio da Ugolini 40; nessuno però prese più in considerazione il punto di partenza di Mannucci, appunto la festa del 1227, oggi completamente dimenticata dai provenzalisti: al riguardo, al di là della questione specifica, comunque delicata 41, non ho registrato né interventi favorevoli né contrari all’interpreta-zione del passo degli Annales .
Rispetto a questo tema, centrale nel discorso relativo alla forma-zione dell’occitania autoctona, altri dati storici meritano di essere presi in considerazione . Penso in particolare alla rilevante ospita-lità offerta dal Comune agli artigiani e agli eretici occitani, indice della possibilità da parte dei Genovesi di ascoltare la lingua troba-dorica nelle proprie terre . L’argomento è stato messo in luce dal lavoro di Lopez sui lanaioli, l’arte in corso di formazione agli inizi del XIII secolo soprattutto su impulso degli stranieri costretti all’e-silio dalle loro terre di origine anche a causa delle persecuzioni reli-giose, lavoro che rinvia a quello della fine dell’Ottocento di Boffito,
39 Cfr . mAnnucci, Di Lanfranco Cicala cit ., pp . 11-15 (con citazione a p . 8) .40 uGolini, La poesia provenzale cit ., pp . XL-XLI: «Era figlio di Guglielmo
Cicala, nobile cittadino, che aveva ricoperto cariche nella repubblica . E tradizionali rimangono nella famiglia le designazioni ad uffici pubblici o a rappresentare Genova in missioni di carattere diplomatico . Così troviamo Lanfranco, ambasciatore e nego-ziatore in nome del Comune insieme a un altro Lanfranco della famiglia Malocello il 22 luglio 1241 ad Aix presso Raimondo Berengario IV, conte di Provenza . E lì, forse, avrà aggiunto corde all’arco del diplomatico la conoscenza scaltrita della lingua e dei modi sottili del trovare» .
41 Sul punto mi pare necessario sottolineare come il passo non faccia rife-rimenti espliciti a composizioni riconducibili all’arte trobadorica, fatto che a mio modo di vedere non permette di individuare questi ioculatores con i trovatori e che, di conseguenza, rende molto difficile condividere l’interpretazione del passo data da Mannucci . Resta tuttavia la menzione della Provincia tra le regioni di provenienza dei giullari convenuti alla festa .
23L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
che ha ricordato la permanenza dell’eresia albigese nel Comune attraverso due documenti del 1221 e del 1278 42 . Per evidenziare il continuum di tale permanenza, mi basterà qui ricordare quanto rilevato dallo stesso Boffito e riportato dagli Annales per il 1253 e il 1256, con i passi relativi rispettivamente alla notizia della pena dell’esilio comminata a un eretico e della scomunica del Comune richiesta da parte del frate francescano Anselmo per la mancata pro-mulgazione di leggi contro l’eresia albigese, imposta nel 1252 dalla bolla pontificia di Innocenzo IV, nota col suo incipit come l’Ad extir-panda 43: questi fatti, come si può facilmente intuire, non possono indebolire l’opinione di una formazione trobadorica dei Genovesi fuori dal Comune, certamente basata su solide fondamenta, consi-derati gli incarichi all’estero individuati per quasi tutti i componenti della schiera; tuttavia, sempre per rimanere nell’ottica della descri-zione dell’«Occitania poetica», dimostrando comunque l’ininterrotta presenza provenzale a Genova durante il massimo periodo della sua fioritura trobadorica, non fanno altro che confermare l’importanza del ritorno allo studio dei dati offerti dagli storici 44 .
Chiudo qui il caso rappresentato da Mannucci e mi avvio verso la conclusione che, rimanendo al rapporto tra storia e filologia, è dedicata agli altri spunti utili per la delineazione generale della cul-tura genovese . L’apertura delle metodologie della prima disciplina
42 r.s. lopez, Le origini dell’arte della lana, in id ., Studi sull’economia genovese nel Medio Evo, Torino 1936, pp . 63-204; G. BoFFito, Albigesi a Genova nel secolo XIII, in «Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino», XXXII (1896), pp . 161-170 .
43 Cfr . nell’ordine Annali cit ., vol . IV, pp . 10-11 («In ipso anno magister Lucas per fratres Predicatores de heresi condempnatus, de ciuitate aufugit et bona ipsius iuxta formam constitutionum confiscata fuerunt et destructa») e 23-24 («In ipso anno frater Anselmus ordinis fratrum Predicatorum a Sede Apostolica in Ytalia deputatus ad hereticos sequendos, in potestatem, consiliarios, excomunicationis in ciuitatem et suburbia, auctoritate qua fongebatur, sententiam promulgauit, eo quod ad ipsius mandata constitutiones edite contra hereticos in statutariis comunis Ianue prout uolebat non ponebantur . Fueruntque missi ambaxatores […] ad Sedem Apostolicam; […] ibique obtinuerunt […] quod sententia lata per ipsum fratrem usque ad festum Pasce suspenderetur sub hac condicione ut si infra illud tempus constitutiones in capitulis Ianue ponerentur, uiribus sententia carere deberet; et si non paterentur, deberet suas uires habere; et positis infra dictum tempus constitutionibus in libro capitolorum Ianue, sententia ex precepto papali uiribus caruit et effectu») .
44 Sul tema si veda ora anche M . roqueBert, L’émigration languedocienne en Italie padane au cours du XIIIe siècle, in I trovatori nel Veneto e a Venezia. Atti del Convegno Internazionale, Venezia, 28-31 ottobre 2004, a cura di G . Lachin, presenta-zione di F . zambon, Roma-Padova 2008 (in seguito Atti Venezia 2004), pp . 77-95, che ricorda anche come Genova rappresenti l’unica città ligure ad accogliere i chierici e i fedeli catari .
24 AlessAndro BAmpA
a quelle della seconda evidenziata a partire dall’edizione dei testi storiografici genovesi non deve essere considerata esaurita con la prima metà del Novecento, avendo trovato una degna prosecutri-ce in Giovanna Petti Balbi, già nominata in precedenza 45, autrice di diversi studi fondati su questa linea di ricerca, come il primo articolo che accese i riflettori sulla circolazione dei manoscritti a Genova attraverso lo studio dei cartulari notarili, seguito, un anno dopo, dalla ricostruzione del sistema scolastico della regione e, nel 1982, da una raccolta di interventi dedicati al centro culturale laico, tra i quali bisogna ricordare la panoramica sulla storiografia fino al Quattrocento, che ha approfondito le ricerche sulla cultura dei singoli annalisti 46 .
Culmine di questi studi è Società e cultura a Genova tra Due e Trecento, intervento del 1984 volto ad approfondire l’evoluzione cul-turale verso la fine del XIII secolo, con la constatazione dell’apertura alle influenze della corte papale del genovese Adriano V e a quelle della monarchia francese, influenze acuite dalla crisi successiva alla fine del primo doppio Capitanato . La studiosa ha sottolineato infatti come, con la conseguente instabilità politica, venisse meno il legame diretto tra la cancelleria e la cultura, che accolse così gli influssi e i gusti esterni all’ambiente comunale, dando impulso in particolare alle curiosità scientifiche di Galvano di Levanto (legato, col Liber sancti passagii, anche alla Francia di Filippo il Bello) e, soprattutto, di Simone da Genova e di Ruffino, fino ad arrivare, col Trecento, a uno dei maestri di Boccaccio, Andalò del Negro, tutti intellettuali in stretto contatto con l’ambiente ecclesiastico genovese, soprattutto coi conventi domenicani e francescani, propugnatori evidentemente anche di questo tipo di interessi letterari 47 .
45 Cfr . supra, n . 32 .46 Il riferimento va a: G. petti BAlBi, Il libro nella società genovese del secolo XIII,
in «La Bibliofilia», LXXX (1978), pp . 1-45; eAd ., L’insegnamento nella Liguria medie-vale. Scuole, maestri, libri, Genova 1979; eAd ., La storiografia genovese fino al secolo XV, in eAd ., Caffaro e la cronachistica genovese, Genova 1982, pp . 11-99 (già in Studi sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90° anniversario dell’Istituto Storico Italiano [1883-1973], Roma 1974, pp . 763-850) . Tale panoramica, insieme all’opera appena citata sull’istruzione ligure, è alla base delle monografie curate dalla stessa studiosa per la Storia della cultura ligure curata da Puncuh (eAd ., La scuola medievale, in Storia della cultura ligure cit ., vol . III, pp . 5-46; eAd ., La cultura storica in età medievale, ibid ., vol . IV, pp . 147-190) .
47 eAd ., Società e cultura a Genova tra Due e Trecento, in Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria, Genova 1984 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n . s ., XXIV), pp . 121-149 (poi in eAd ., Una città e il suo mare. Genova nel medioevo, Bologna 1991, pp . 264-
25L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
Rispetto a quanto appena detto, occorre sottolineare come, nella sostanza, con queste considerazioni ci troviamo di fronte agli stessi ragionamenti, maggiormente approfonditi, alla base dell’ipotesi sostenuta da Imperiale di Sant’Angelo sulla formazione della classe di Iacopo Doria, oltre che al chiarimento definitivo del passaggio di testimone dal centro culturale laico a quello ecclesiastico, eviden-ziato dai singoli fenomeni letterari . Emblematico appare l’ultimo caso da ricordare, quello – finora lasciato in disparte – dell’Anoni-mo Genovese che, per il suo legame con la congregazione di Santa Caterina di Alessandria, rappresenta un’altra conferma del pano-rama tratteggiato, cui ancora una volta il Mannucci ha dato il suo non piccolo contributo, mettendo in rilievo la laicità della stessa congregazione e sottolineando i legami del poeta anche col potere comunale, deducibili dai suoi incarichi accennati da alcune poesie e in parte riconducibili a una formazione notarile 48 . In sostanza, con i suoi studi Petti Balbi ha dimostrato il cambiamento dei gusti culturali della Genova di fine secolo: l’attività intellettuale, slegatasi dal rapporto diretto con la Repubblica, lascia spazio alla produzione volgare e alla fruizione delle opere didattico-allegoriche, ma anche all’interesse verso testi d’argomento più evasivo, come dimostrato dalla circolazione manoscritta desumibile a partire dai registri nota-rili, che testimoniano diversi casi di cessioni di libri de romanciis o romanciorum, «dizione con cui viene genericamente indicata la produzione romanza in versi» 49 .
Prima di concludere, colgo quest’ultimo spunto per allargare il discorso a discipline quali la codicologia e la storia della miniatura che, a proposito dei centri culturali, hanno consentito ai filologi, pressoché indipendentemente dai lavori degli storici, di giungere all’approfondimento dell’attività domenicana . Mi sto riferendo allo studio di uno scriptorium genovese vicino ai Frati Predicatori
285, da cui cito) . L’articolo è poi ripreso da eAd ., Potere, società e cultura a Genova nel medioevo, in «Cultura e scuola», XCIV (1985), pp . 107-112 (poi in eAd ., Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale, Firenze 2007, pp . 217-224) .
48 Cfr . F.l. mAnnucci, L’Anonimo genovese e la sua raccolta di rime (sec. XIII-XIV). Con appendice di rime latine inedite e tre facsimili, Genova 1904, in particolare pp . 14-57 . L’edizione di riferimento oggi è rappresentata da Anonimo GenoVese, Rime e ritmi latini . Edizione critica a cura di J . NicolAs, Bologna 1994 (che, alle pp . IX e CXVIII e con la n . ai vv . 1-2 della poesia 133, rubricata «De quodam avaro», a p . 356, ha identificato il poeta con un cittadino genovese di nome Luchetto) .
49 petti BAlBi, Il libro nella società genovese cit ., p . 13 . Cfr . in particolare i docu-menti numero 14 (p . 33), 28 (p . 37), 47-49 (pp . 43-44) .
26 AlessAndro BAmpA
condotto da Avril e Gousset sulla base dell’analisi della decorazio-ne di alcuni codici contenenti opere di argomento storico, sacro, medico e – per ricollegarci a quanto affermato da Petti Balbi – in antico francese 50 . Partendo soprattutto da queste considerazioni, i filologi – cominciando con Benedetti, passando per Bertolucci Pizzorusso e arrivando a Cigni 51 – hanno poi evidenziato a partire dagli anni Novanta il ruolo nella compilazione di alcuni tra questi codici di diversi Pisani catturati dopo la celeberrima battaglia della Meloria del 1284, in particolare di alcuni notai che si sono prodigati in questo lavoro seriale (stiamo parlando di oltre una trentina di manoscritti) lasciandoci il loro nome e la testimonianza della loro prigionia nei colofoni . Per usare le parole di Cigni, su questo tema specifico bisogna notare «il prevalere, da una parte, della commit-tenza fratesca, con particolare risalto dell’ordine dei Domenicani attivo fra Genova e la Toscana; dall’altra il retroterra professionale notarile dei copisti» 52 .
Al riguardo, segnalo solo tre punti: anzitutto, come ricordato sempre da Cigni 53, quest’ultimo aspetto era già stato evidenziato in
50 F. AVril - m.t. Gousset, Manuscrits enluminés d’origine italienne, vol . II, XIIIe siècle, avec la collaboration de C . rABel, Paris 1984, pp . 23-53 . Lo studio dello scrip-torium è stato poi approfondito dalla sola Gousset quattro anni dopo: m.t. Gousset, Étude de la décoration filigranée et reconstitution des ateliers: le cas de Gênes à la fin du XIIIe siècle, in «Arte medievale», s . II, II/1 (1988), pp . 121-152 .
51 r. Benedetti, «Qua fa’ un santo e un cavaliere…». Aspetti codicologici e note per il miniatore, in La grant Queste del Saint Graal. La grande Ricerca del Santo Graal. Versione inedita della fine del XIII secolo del ms. Udine, Biblioteca arcivescovile, 177, Udine 1990, pp . 31-47; V. Bertolucci pizzorusso, Testi e immagini nei codici attribui-bili all’area pisano-genovese alla fine del Duecento, in Pisa e il Mediterraneo. Catalogo della mostra, Milano 2003, pp . 197-201 . Tra i numerosi studi prodotti sul tema da Cigni, richiamo qui unicamente quelli di carattere generale: F. ciGni, Manoscritti di prose cortesi compilati in Italia (secc. XIII-XIV): stato della questione e prospettive di ricerca, in La filologia romanza e i codici, a cura di S . Guida e F . Latella, Messina 1993, vol . II, pp . 419-441; id ., Copisti prigionieri (Genova, fine sec. XIII), in Studi di filologia romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, a cura di P .G . Beltrami, M .G . Capusso, F . Cigni, S . Vatteroni, Pisa 2006, vol . I, pp . 425-439; id ., Manuscrits en français, ita-lien, et latin entre la Toscane et la Ligurie à la fin du XIIIe siècle: implications codico-logiques, linguistiques, et évolution des genres narratifs, in Medieval Multilingualism. The Francophone World and its Neighbours, edited by C . Kleinhenz and K . Busby, Thurnout 2010, pp . 187-217 .
52 id ., Copisti prigionieri cit ., pp . 426-427 . Dopo l’impulso dei filologi, l’argomen-to è stato affrontato nuovamente anche dagli storici della miniatura: cfr . da ultimo l’articolo di F. FABBri, Romanzi cortesi e prosa didattica a Genova alla fine del Duecento fra interscambi, coesistenze e nuove prospettive, in «Studi di Storia dell’Arte», XXIII (2012), pp . 9-32, segnalatomi dallo stesso Cigni, che qui ringrazio .
53 ciGni, Manoscritti di prose cortesi cit ., n . 19, p . 429 .
27L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
precedenza, tra gli altri studiosi, proprio da Petti Balbi, che già all’e-poca di Società e cultura a Genova tra Due e Trecento, in nota, aveva richiamato uno di questi colofoni 54, avendo dimostrato in sostanza la possibilità d’individuare l’atelier; in secondo luogo, se si considera all’interno di questo gruppo individuato dai ricercatori francesi la presenza di manoscritti contenenti opere come lo Speculum regum di Goffredo da Viterbo, l’evoluzione dei gusti culturali genovesi trat-teggiata da Petti Balbi per la fine del XIII secolo e comprendente anche l’interesse per la medicina trova delle conferme anche al di fuori delle sole ricerche d’archivio effettuate dalla studiosa 55; infine, bisogna rilevare come, per un ulteriore approfondimento della que-stione codicologica e la possibile attribuzione di altri manoscritti a questo particolare centro, ancora oggi risulterebbero decisivi gli studi di carattere storico, in particolare le analisi di Belgrano sul cosiddetto «codice autentico» degli Annales – il manoscritto latino 10136 della BnF 56 – e quelle di Monleone presentate nel primo volume dell’edizione della Chronica di Iacopo da Varagine su alcuni dei codici più importanti che tramandano l’opera, accostabili pro-prio per le loro decorazioni – come ha notato lo stesso studioso – al testimone principe della cronaca genovese 57, analisi utilizzate non a caso da Avril e Gousset 58 .
Rispetto a quanto detto finora, mi pare evidente la centralità di
54 petti BAlBi, Società e cultura a Genova cit ., n . 47, pp . 275-276 .55 Faccio riferimento al codice latino 4896 della BnF, recensito alle pp . 32-33
(scheda 30) da AVril - Gousset, Manuscrits enluminés cit . Per una panoramica dello studio della scienza medica nella Genova del Duecento rinvio a l. BAlletto, Medici e farmaci, scongiuri ed incantesimi nel medioevo genovese, in Saggi e Documenti. VI, Genova 1985; per un’analisi delle miniature di alcuni dei codici genovesi dedicati a tale disciplina (tra i quali spicca il manoscritto 78 C 15 del Kupferstischkabinett di Berlino, Lo libro de le mariscalcie dei cavalli, volgarizzamento in pisano dell’opera di Giordano di Ruffo che permette di richiamare il caso relativo alla Pratica equorum attribuibile forse a Iacopo Doria), cfr . F. VolperA, Medicina e miniatura. Codici geno-vesi di età gotica, in «Studi di Storia dell’Arte», XVII (2006), pp . 9-22 .
56 Cfr . Annali cit ., vol . I, pp . XXII-XXXVI, cui vanno affiancate le pp . XXXVII-LV, dedicate alla sua copia, il codice dell’Archivio di Stato di Genova, Sezione mano-scritti, Manoscritti restituiti dalla Francia, 3 (già Parigi, Bibliothèque du Ministère des Affaires Étrangères, Fonds Génois, 2) . Decisivo per questo contributo, come ha riconosciuto lo stesso Belgrano (ibid ., p . XXI), è stato il lavoro di un allora giovane De Lollis .
57 Cfr . Jacopo da Varagine e la sua Cronaca cit ., vol . I, pp . 355-396 .58 Cfr . AVril - Gousset, Manuscrits enluminés cit ., pp . 29 (scheda 24, per il codi-
ce degli Annales, punto di partenza dell’analisi dell’atelier per la certezza della loca-lizzazione e della datazione) e 31 (scheda 27, per il latino 4931 della BnF, cc . 1-116v, ricordato da Jacopo da Varagine e la sua Cronaca cit ., vol . I, pp . 360-365) .
28 AlessAndro BAmpA
un dato specifico: se in passato gli studi più generalmente letterari si fossero maggiormente avvalsi dei lavori approntati dagli storici, la ricerca relativa alla cultura genovese, comprensiva anche del partico-lare aspetto offerto da quella in lingua occitanica, avrebbe permesso di risparmiare diverse energie e sarebbe giunta, già da diversi anni, a risultati che oggi, sul tema, ancora mancano . Credo infatti che si possa affermare che i principali strumenti per analizzare il panorama culturale della Genova del Duecento siano già stati forniti proprio dagli studiosi della sua storia, come del resto aveva già rilevato, sep-pur implicitamente, Lecco, curatrice del recente volume relativo al Congresso sulla letteratura medievale di Genova che, nella premessa, ha sottolineato come esso si fosse concentrato «su argomenti rimasti quasi intoccati dopo gli studi ottocenteschi e primo-novecenteschi» 59 .
Come facilmente intuibile, la situazione che ho cercato di descri-vere e la conseguente esigenza di nuove analisi di carattere multidi-sciplinare va certamente al di là di questo singolo caso, soprattutto per le discipline umanistiche dedicate agli studi sul Medioevo . Occorre però sottolineare come, per la provenzalistica, questa stes-sa specifica necessità fosse già stata evidenziata ormai trent’anni fa da Barbero nelle prime pagine del suo articolo sul rapporto tra i trovatori e il Monferrato in cui, descrivendo lo status quæstionis pre-cedente al suo intervento, si rilevava che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento,
[l]’incontro fra storici e filologi doveva dare alla ricerca sui mar-chesi di Monferrato un impulso che, tramontata quella stagione nei rivolgimenti della guerra mondiale e del primo dopoguerra, non sarebbe mai più stato eguagliato .
Barbero infatti sottolineava come, per il periodo successivo, gli studi dedicati al tema si fossero caratterizzati essenzialmente per
[…] un’aporia: tra una solida tradizione di studi letterari, che trop-po raramente si è posta il problema della realtà cui rimandano i suoi testi, accettandoli nel migliore dei casi come testimonianze «oggettive», ed una storiografia che le cautele metodologiche rischiano di isterilire nel rifiuto di ogni possibile nesso tra fonti letterarie e concreta realtà . 60
59 M . lecco, Premessa a Atti Genova 2004 cit ., pp . 7-8: p . 7 .60 A. BArBero, La corte dei marchesi di Monferrato allo specchio della poesia
trobadorica. Ambizioni signorili e ideologia cavalleresca fra XII e XIII secolo, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXI (1983), pp . 641-703 . Le citazioni
29L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
Queste affermazioni generali, cui va però sottratta la critica rivolta agli storici, mi paiono utilizzabili anche per il caso relativo all’«Occitania poetica genovese»: la filologia necessita evidentemente di una revisione degli studi prodotti nel corso di oltre un secolo dalla storia 61 .
Facendo un ultimo passo in avanti, bisogna rilevare però come occorrano anche nuove ricerche d’archivio: al di là del recupero degli studi di carattere storico, sarà solo col loro approfondimento che si potrà inquadrare al meglio la cultura trobadorica genovese, studiandone più a fondo gli aspetti più interessanti, come quelli che ora, per concludere, elenco rapidamente .
Il primo, anche dal punto di vista cronologico, mi pare senza dubbio quello relativo ai possibili soggiorni in ambienti ricondu-cibili a Genova da parte di Raimbaut de Vaqueiras e Peire Vidal, argomento in nessun modo chiarito definitivamente 62 e che richie-de, a un livello più generale, uno studio maggiormente approfondito del rapporto tra il Comune e i trovatori occitanici, tema lasciato in disparte da pressoché tutti gli studiosi nonostante la sua impor-tanza, evidente se si considera l’assenza nel Comune di un centro
sono rispettivamente alle pp . 644 e 649 .61 Rispetto alle ricerche ricordate fin qui (che rappresentano una recensio solo
parziale dei lavori che dovrebbero essere richiamati), aggiungo le nuove traduzioni degli Annales condotte fino alla redazione di Marchisio Scriba e accompagnate da interessanti saggi introduttivi, con indicazioni approfondite e aggiornate della biblio-grafia pregressa . Cfr ., in ordine di pubblicazione: cAFFAro, La liberazione delle città d’Oriente . Traduzione e note di M . MontAnAri, introduzione di G . AndennA, Genova 2001; Gli Annali di Caffaro (1099-1163), a cura di G . AirAldi, traduzione e note di M . MontesAno, Genova 2002; cAFFAro, Storia della presa di Almeria e Tortosa (1147-1149), a cura di M . MontesAno, Genova 2002; Gli Annali di Oberto Cancelliere (1164-1173), a cura di G . Airaldi, traduzione e note di M . MAcconi, Genova 2004; Gli Annali di Ottobono Scriba (1174-1196) e Gli Annali di Ogerio Pane (1197-1219) e di Marchisio Scriba (1220-1224), entrambi a cura di m. MontesAno e A . MusArrA, traduzione e note dello stesso Musarra, Genova 2010 . Per il polo ecclesiastico e in particolare per la Chronica di Iacopo da Varagine ricordo poi l’introduzione a iAcopo dA VArAGine, Cronaca della città di Genova cit ., pp . 9-74 e s. Bertini Guidetti, Potere e propaganda a Genova nel Duecento, Genova 1998 .
62 Cfr ., per il primo, gli studi citati supra, n . 16, in particolare la biografia rico-struita da linskill, The Poems of the Troubadour cit ., pp . 3-37 e, per il secondo, F. torrAcA, Pietro Vidal in Italia, in «Atti della R . Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli», n .s ., IV (1915), pp . 213-250 (poi in id ., Studi di storia letteraria, Firenze 1923, pp . 65-107), J .M . BrincAt, Le poesie “maltesi” di Peire Vidal (1204-5), in «Melita historica», VII (1976), pp . 65-89 e V. FrAser, Les Pérégrinations de Peire Vidal: ses séjours en Italie et l’évolution de son œuvre poétique, in Actes septième Congrès A.I.E.O. cit ., vol . I, pp . 315-323 .
30 AlessAndro BAmpA
culturale come quello rappresentato dalle corti (fondamentali, come è noto, per la cultura medievale, in particolare per quella troba-dorica) e collegabile a quello relativo al canone dei soli Genovesi, a oggi solo abbozzato: si impone nella sostanza una descrizione maggiormente dettagliata della presenza dei dictatores in lingua d’oc nella Repubblica che permetta di verificare in seguito se, tra i modelli degli autoctoni, siano reperibili i medesimi trovatori che vi soggiornarono più o meno lungamente . Tale discorso coinvolge con ogni evidenza anche uno fra i primi trovatori italiani, il bolo-gnese Rambertino Buvalelli: considerando la vicinanza delle prime attestazioni biografiche di Lanfranco Cigala e, soprattutto, del ghibellino Percivalle Doria al suo triennio da podestà nel Comune (riconducibile al 1218-1220, successivo quindi all’esperienza estense e, di conseguenza, alla sua formazione trobadorica) 63, almeno per l’assenza di argumenta contrari che esulino da quelli ex silentio, l’ipotesi appare quantomeno riproponibile 64 e, ove trovasse fonda-menta più solide, confermerebbe ulteriormente lo stretto legame tra la classe borghese operante a Genova e l’arte trobadorica .
Trattando in generale dei trovatori genovesi, urge poi uno stu-dio dei legami biografici tra i diversi componenti della scuola, che potenzialmente potrebbe aiutare a inquadrare meglio quelli lette-rari, a partire dagli appellativi utilizzati nelle copiose tenzoni che ci sono rimaste 65 . Accanto a questo approfondimento, servirebbe
63 Per il Bolognese, cfr . rAmBertino BuVAlelli, Le poesie . Edizione critica con introduzione, traduzione, note e glossario a cura di e. Melli, Bologna 1978, pp . 51-56 per l’incarico di podestà e pp . 61-84 per il legame – anche poetico – con la corte estense . Per Cigala, la cui prima attestazione notarile è del 1235, quando peraltro era già iudex (cfr . mAnnucci, Di Lanfranco Cicala cit ., n . 1, p . 15), occorre ricordare che Hom que domna se feigna (BdT 282,11) potrebbe essere datato al 1226-1228 (cfr . la scheda di centili indicata supra, n . 3) . Percivalle Doria invece fu con certezza podestà di Asti nel 1228 (cfr . Bertoni, I trovatori d’Italia cit ., p . 90) . Per questo tipo di ricerche bisogna comunque ricordare i problemi di omonimia, esemplificabili proprio con la famiglia genovese dei Doria, come dimostra ad esempio restori, I trovatori genovesi cit ., p . 915: «[È] difficile, scendendo a discorrere dei vari poeti, discernere e fissare le linee della loro personalità e i fatti della loro vita . Quasi tutti son di famiglie note e numerose, divise in varii rami, in cui i nomi si ripetono con una frequenza imbaraz-zante: a metà del secolo troviamo in Genova tracce di quattro Percivalle Doria; pochi anni dopo, alla battaglia della Meloria (1284), presero parte sei Percivalle Doria» . Sulla questione specifica, cfr . A. Ferretto, Documenti intorno ai trovatori Percivalle e Simone Doria, Torino 1907 (già in «Studi medievali», I [1904-1905], pp . 126-151 e II [1906-1907], pp . 113-140, 274-285) .
64 Cfr . ad esempio restori, I trovatori genovesi cit . p . 915 .65 Al riguardo si segnala solo uno spunto offerto dalla polemica di fine
Ottocento tra Schultz-Gora e Desimoni e relativo all’atto, disperso, citato dallo sto-
31L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
poi una prosecuzione per il XIII secolo del lavoro di Pistarino sui rapporti commerciali tra Genova e la Francia meridionale, per veri-ficare ulteriormente la tesi dell’apprendistato trobadorico fuori dal Comune e per chiarire i rapporti diretti dei Genovesi con i trovatori occitanici 66 . Per restare alla metodologia di ricerca finora invocata da questo elenco, considerata la formazione giuridica di molti di loro (presupposta sulla base degli incarichi pubblici ricoperti nel corso della loro vita), un ritorno alle ricerche d’archivio potrebbe poi forse chiudere definitivamente la questione relativa agli Studia che li accolsero . Il discorso risulterebbe interessante soprattutto per Cigala, da sempre ricondotto a Bologna pur senza prove effettive: se confermata e accompagnata da ulteriori dati, la circostanza permet-terebbe forse di riaprire la discussione relativa ai rapporti tra questo trovatore e la pressoché coeva nascita dello Stilnovo, con tutte le conseguenze del caso 67 .
rico e provenzalista vissuto tra il XVI e il XVII secolo, César de Nostredame, che vedeva tra i testimoni della ratifica dell’8 agosto 1262 dei patti con Carlo d’Angiò Luchetto Gattilusio, Percivalle e Simone Doria, Luca Grimaldi e Giacomo Grillo, ovvero alcuni fra i principali trovatori genovesi: cfr . o. schultz-GorA, Zu den genue-sischen Trobadors, in «Zeitschrift für romanische Philologie», IX (1885), pp . 406-407 e c. desimoni, Il marchese Guglielmo il Vecchio e la sua famiglia secondo gli studi recenti, con una appendice sui trovatori genovesi, in «Giornale Ligustico», XIII (1886), pp . 321-356, in particolare n . 1, p . 348 . La circostanza è stata segnalata da Boni in luchetto GAttilusio, Liriche cit ., n . 27, p . XV .
66 Cfr . G. pistArino, Genova e l’Occitania nel secolo XII, in Atti del I° congresso storico Liguria-Provenza. Ventimiglia-Bordighera, 2-5 ottobre 1964, Bordighera-Aix-Marseille 1966, pp . 64-130 (poi rielaborato col titolo Genova e l’Occitania in id ., La Capitale del Mediterraneo: Genova nel Medioevo, Bordighera 1993, pp . 183-248) . Per i rapporti tra trovatori genovesi e occitanici, occorre ricordare in primis il caso di Percivalle Doria, su cui cfr . da ultimo G . lArGhi, Poesia, politica e podestà in Provenza, in Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII . Atti del Convegno internazionale (Messina, 24-26 maggio 2007), a cura di R . Castano, F . Latella e T . Sorrenti, Roma 2007, pp . 397-411, p . 410: «al seguito dell’ambasciatore di Federico II, Galeazzo di Gurzan», Percivalle «tra marzo e giugno 1233 [presenziò] alla stesura di documenti assieme a Falquet de Romans, Ricau de Tarascona, Bertran de Lamanon, Bertran Folco d’Avignone, Raimbaut de Beljoc e Sordello da Goito» . Sullo stesso tema è da evidenziare come Lanfranco Cigala, oltre che con Bertran d’Alamanon (per la missione diplomatica del 1241 conclusa dal patto del 22 luglio, in cui compare tra i testimoni del conte di Provenza questo stesso trovatore), è stato ritenuto in contatto con Guilhem de Montanhagol, identificato in via molto dubitativa col Guilhem della tenzone Lafranc, digatz vostre semblan (BdT 201,4b = 282,12a) per le suggestioni pre-stilnovistiche di entrambi (cfr . in merito la bibliografia citata da cApusso, Un duello oitaneggiante cit ., n . 14, p . 14) .
67 «Se si potesse riconoscere con sicurezza in Bologna la città ove Lanfranco poté compiere i suoi studi giuridici per divenire iudex e iurisperitus, molte cose appa-
32 AlessAndro BAmpA
Con quest’ultimo esempio siamo scesi all’interno di questa parti-colare cerchia trobadorica . Parlando del ghibellino Percivalle Doria, ci si troverebbe sul terreno dei rapporti tra i Genovesi e la corte di Manfredi mentre, contemporaneamente, si potrebbe ulteriormente descrivere il fenomeno del plurilinguismo poetico . Esso, alla base a livello generale della produzione dei trovatori italiani, risulta caratteristico soprattutto del caso rappresentato da Bonifacio Calvo, ospite della corte di Castiglia per un periodo di tempo ancora impre-cisamente collocato tra il 1251 e il 1266 68, argomento che, se appro-
rirebbero chiare, e certe ipotesi oggi troppo scarsamente concretabili troverebbero una lucida conferma»: uGolini, La poesia provenzale cit ., n . 2, p . XLIII . Fatte salve nuove scoperte, ricordando anche le coincidenze metriche tra il corpus cigaliano e quello di Giacomo da Lentini messe in risalto da r. Antonelli, L’invenzione del sonetto, in Miscellanea di Studi in onore di Aurelio Roncaglia, Modena 1989, vol . I, pp . 35-75 (già in «Cultura Neolatina», XLVII [1987], pp . 19-59), sul tema specifico, allo stato attuale degli studi, più che a influenze dirette, mi parrebbe in ogni caso più semplice pensare a convergenze dettate dalle mutazioni culturali del periodo, recepite e rielaborate in diversi milieux italiani pressoché contemporaneamente con modalità in alcuni casi avvicinabili, ma sostanzialmente in maniera indipendente .
68 Il terminus ante quem è dato dalla composizione da Ges non m’es greu s’eu non sui ren prezatz (BdT 101,7), il sirventese, databile al più presto al 1266, che provocò la risposta dello Zorzi, Mout fort me sui d’un chan meravillatz (BdT 74,10) e che rappresenta – al di là forse dello scambio di tenzoni con Gattilusio (Luchetz, se·us platz mais amar finamen, BdT 101,8a = 290,2) e Scotto (Scotz, qals mais vos plazeria, BdT 101,11a = 433,1), testi per i quali è impossibile proporre una datazione – l’unica attestazione del ritorno a Genova del trovatore (cfr . BrAnciForti, Le rime cit ., pp . 36-43) . Ancora più dubbio appare il terminus post quem, rappresentato dall’inizio dell’ambasciata genovese presso Ferdinando III, preparata dal Comune nel 1249 («[P]lacuit tunc sapientibus Ianue ut ad ipsum regem [Ferdinando III] legati miterentur, causa componendi cum eo qualiter negociatores Ianue illuc et ad alias terras regni sui quas habebat et in posterum haberet accedere deberent et quod et quantum pro drictu et exaccionibus soluere deberent, et postularent a rege contratam siue locum in ipsa civitate, in quam haberent negociatores Ianue fondicum, domos, ecclesiam et furnum sicut in pluribus ciuitatibus habent et habere consueuerunt»: Annali cit ., vol . III, p . 183) e affidata a Nicolò Calvo nel 1251 («que quidem conuentio postera com-pleta fuit per uirum nobilem Nicolaum Caluum, qui ad ipsum regem pro ipso facto in legatione trasmissus»: ibid ., vol . III, p . 185): pur nella mancanza di documenti d’archivio, questi è stato individuato dagli studiosi con un parente del trovatore per la vicinanza cronologica della stessa ambasciata con i testi riconducibili alla corte di Alfonso X e databili con assoluta certezza al periodo compreso tra il 1252 e il 1254, ovvero Mout a que sovinenza (BdT 101,9), En luec de verianz floritz (BdT 101,4), il già ricordato discordo plurilingue Un nou sirventes ses tardar (BdT 101,17) e Enquer cab sai chanz e solatz (BdT 101,5) . Tale ipotesi presuppone che, assieme a Nicolò, o comunque poco dopo, abbia lasciato Genova anche Bonifacio (per queste conside-razioni, cfr . BrAnciForti, Le rime cit ., pp . 7-29; per una proposta più dettagliata della cronologia delle poesie composte dal trovatore all’inizio del soggiorno presso la corte
33L’«Occitania pOetica genOvese» tra stOria e fiLOLOgia
fondito adeguatamente, potrebbe chiarire meglio il suo particolare gusto poetico, giustificando così con prove anche documentali la sua diversità rispetto a quello dei suoi concittadini, che si palesa anche ad un confronto solo superficiale dei diversi canzonieri 69 .
Per lo scambio di sirventesi, Calvo ci porta al veneziano Bartolomeo Zorzi che, da un lato, considerato quanto detto a pro-posito dell’atelier ricondotto all’ambiente domenicano, ripropone il tema relativo al ruolo delle carceri genovesi nella sua formazione occitanica 70 e, dall’altro, conducendoci verso la conclusione del XIII secolo, suggerisce un approfondimento delle influenze trobadoriche sull’Anonimo Genovese . Su quest’ultimo argomento, considerato il rapporto certo tra Quan be me sui apessatz di Falquet de Romans (BdT 156,10) e Montá viá ò visto scrito (già segnalato da Lega e ripreso da Roncaglia 71), risultano importanti gli spunti offerti da Allegretti che, allargando il discorso al legame tra il plazer di Pistoleta Ar’agues yeu mil marcx de fin argen (BdT 372,3) e Pusor viá son apensao e segnalando la vicinanza tra le redazioni dei medesi-mi due testi trobadorici traditi dal manoscritto Y e la loro versione offerta dall’Anonimo 72, imporrebbero agli studiosi nuovi sforzi sul
di Alfonso X, cfr . c. AlVAr, La poesía trovadoresca en España y Portugal, Madrid 1977, pp . 181-194) e V . BeltrAn, Los trovadores en las cortes de Castilla y León: Bonifaci Calvo y Airas Moniz d’Asme, «Cultura Neolatina», 45 (1985), pp . 45-57 .
69 Brunetti, Genova e l’arte dei suoi cavalieri cit ., a p . 56, rispetto agli altri tro-vatori autoctoni, arriva a definirlo «lo spaesato» .
70 Sul punto cfr . G. peron, «Sitot m’estauc en cadena»: le prigioni di Bertolome Zorzi, in Le loro prigioni: scritture dal carcere. Atti del Colloquio internaziona-le (Verona, 25-28 maggio 2005), a cura di A .M . Babbi e T . Zanon, Verona 2007, pp . 61-96 .
71 Cfr . G. leGA, recensione a mAnnucci, L’Anonimo genovese e la sua raccolta cit ., in «Giornale storico della letteratura italiana», LI (1908), pp . 282-306, in particolare alle pp . 303-306, volte a contrastare l’opinione dell’allievo del De Lollis espressa alle pp . 67-71, secondo la quale il componimento (edito in Anonimo GenoVese, Rime e ritmi latini cit ., pp . 402-405), nonostante la celebre rubrica che lo introduce («De quodam provinciali translato in lingua nostra»), non rappresenterebbe affatto una traduzione: Lega è stato il primo a individuare il testo-base, proponendo un confron-to sinottico dei due componimenti, poi ripreso da A. roncAGliA, De quibusdam provin-cialibus translatis in lingua nostra, in Letteratura e critica. Studi in onore di Natalino Sapegno, vol . II, Roma 1975, pp . 1-36, con le conclusioni sull’operazione letteraria alle pp . 23-24 .
72 p. AlleGretti, Modelli provenzali dell’Anonimo Genovese, «Medioevo roman-zo», XXII/1 (1998), pp . 3-15 . Tale studio è stato in seguito ripreso con una prospettiva più ampia da eAd ., Cordinate [sic] occitaniche dell’Anonimo Genovese, «Letteratura italiana antica», XIII (2012), pp . 115-128 . Il secondo testo di Luchetto è edito in Anonimo GenoVese, Rime e ritmi latini cit ., alle pp . 388-390 .
34 AlessAndro BAmpA
tema, anche per ciò che riguarda le ricerche sull’eventuale circola-zione di canzonieri di lirica occitanica nel Comune, studio, quest’ul-timo, certamente importante, considerando che – come ha sottoli-neato Lachin – «[n]on ci si è mai posti il problema dell’assenza di antologie trobadoriche provenienti dall’area piemontese e ligure» 73 .
Allargando ulteriormente gli orizzonti, il caso genovese impone di riconsiderare anche la presenza trobadorica nell’intera area che si affaccia grosso modo sul Mar Ligure, altro argomento che ancora oggi rimane in secondo piano: scendendo da Nord a Sud, troviamo innanzitutto la produzione letteraria riconducibile alle corti e ai Comuni piemontesi e liguri divenuta oggetto di studio solo recen-temente 74; attraverso la Lunigiana arriviamo poi alle attestazioni toscane, come per esempio la Doctrina d’acort di Terramagnino da Pisa, opera che – per la sua natura didattica, vicina a quella del Donat proensal – dovrebbe essere considerata all’interno di una pro-spettiva totalmente nuova, quella offerta dalle relazioni tra questa stessa area occidentale e quella veneta, possibili forse per i rapporti che entrambe possono aver avuto per il tramite di Bologna 75 .
AlessAndro BAmpA
73 G. lAchin, Introduzione. Il primo canzoniere, in Atti Venezia 2004 cit ., pp . XIII-CV: n . 114, p . CII . Sul tema confronta però ora F. ciGni, Due nuove acquisizioni all’atelier pisano-genovese: il Régime du corps laurenziano e il canzoniere provenzale p (Gaucelm Faidit); con un’ipotesi sul copista Nerius Sanpantis, in «Studi mediola-tini e volgari», LIX (2013), pp . 107-125, studio che, attribuendo fin dal titolo allo scriptorium più volte ricordato il canzoniere trobadorico p (Perpignan, Bibliothèque Municipale, 128), prelude necessariamente a nuovi orizzonti .
74 Su questo punto specifico, cfr . la bibliografia indicata supra, n . 8 .75 Su Terramagnino e la Doctrina d’acort (composta forse in Sardegna, isola
sempre al centro degli scontri tra Genova e Pisa nel corso del XII-XIII secolo), cfr . la bibliografia indicata da ultima da e. Wilson poe, “Cantairitz e trobairitz”. A forgotten attestation of Old Provençal “Trobairitz”, in «Romanische Forschungen», CXIV (2002), pp . 206-215, n . 6, p . 207 . Per le relazioni tra le due aree, basterà ricordare come uno dei due committenti del Donat sia Corrado da Sterleto, funzionario di Federico II e «dedicatario di Se de voi, donna, gente, canzone che apre il corpus della lirica amo-rosa di Guittone nel fondamentale codice Laurenziano Rediano 9 e nel suo affine Riccardiano 2533»: se si considera che anche l’altro committente dell’opera, Giacomo da Morra, è stato un luogotenente della corte imperiale, si capisce come «alla diret-trice Veneto-Sicilia si aggiung[a] l’importante diramazione verso la Toscana di Guittone» (l. lAzzerini, Letteratura medievale in lingua d’oc, Modena 2001, p . 170) .































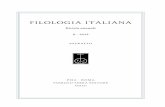


![Filologia dei testi a stampa, Cagliari, CUEC, 2008 [pdf integrale del volume]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324f849c9c7f5721c01d64a/filologia-dei-testi-a-stampa-cagliari-cuec-2008-pdf-integrale-del-volume.jpg)
















