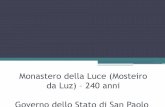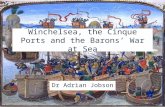‘La poetica dell’epica sacra tra Cinque e Seicento in Italia’, The Italianist, 35 (2015), pp....
Transcript of ‘La poetica dell’epica sacra tra Cinque e Seicento in Italia’, The Italianist, 35 (2015), pp....
LA POETICA DELL’EPICA SACRATRA CINQUEE SEICENTO IN ITALIA*
MARCO FAINI
University of Cambridge, UK
Over the course of sixteenth century and in the early seventeenth century, aremarkable number of biblical poems were written in Italy. Their authorsattempted to outdo classical authors by replacing, within the highest literary genre(e.g. epic), the false pagan divinities with the authentic Christian God. Along withthese attempts came an extremely interesting, and thus far neglected, reflection onthe specific features and problems raised by biblical epic. By resorting to a varietyof sources (poetical treatises, letters, discourses) I deal in this article with suchissues as the problem of matching poetry and sacred history; the difficulty ofdealing with supernatural events and representing the invisible; the role of allegoryand of the so-called meraviglioso. These are some of the most relevant poeticproblems connected to biblical epic, which were also discussed at length outsideItaly during the seventeenth and eighteenth centuries. Finally, I deal with theincreasing relevance of the allegorical meaning attached to these poems and to theconsequent devaluation of the importance of ‘action’, arguing that this eventuallycontributed to the exhaustion of the Western tradition of epic, helping to pave theway for the new genre of the novel.
KEYWORDS: biblical poems, Cinquecento, meraviglioso, allegory, epic
Tra i fenomeni letterari di piu lunga durata nell’Europa moderna il tentativo difondare un’epica cristiana paragonabile ai modelli antichi e uno dei piuinteressanti e, relativamente al caso italiano, tra i meno studiati. Si tratta di unalacuna che richiede di essere colmata perche l’epica cristiana fu un genereampiamente diffuso in Europa fino almeno al principio del XIX secolo e mi pareinnegabile che l’esempio italiano abbia esercitato una duratura influenza anche inGermania, Francia, Inghilterra.1 Per poema epico cristiano mi riferisco ad opere diargomento rigorosamente biblico (non dunque la Gerusalemme liberata e laConquistata) che non si esauriscano in parafrasi o agiografie in versi del testo sacroma siano fornite di alcuni, se non tutti, gli elementi strutturali che contra-ddistinguono l’epica. Cosı delimitato il campo di ricerca, si deve constatarel’assenza di un’opera che possa svolgere funzione di modello e soddisfi talirequisiti. L’epica cristiana non e un genere riconoscibile, come ha mostrato MarioChiesa.2 Ne, del resto, si trovano chiare e sistematiche indicazioni circa l’epicacristiana nei trattati di poetica cinque o secenteschi, molto probabilmente percheessa era sentita come una specie del genere del poema eroico. Eppure, l’epica
The Italianist, 35. 1, 27–60, February 2015
# Italian Studies at the Universities of Cambridge,
Leeds and Reading 2015 DOI: 10.1179/0261434014Z.000000000106
cristiana presenta alcuni problemi specifici che non possono essere ridotti a quellipeculiari al poema epico o eroico. In questo contributo, provero a fornire unarassegna di tali problemi, esaminando alcuni passi nei quali e possibile cogliere untentativo di elaborazione di una poetica dell’epica sacra nel periodo compreso tragli anni Quaranta del Cinquecento e gli anni Cinquanta del Seicento. Affronteroalcuni punti teorici come il tema della variazione dell’ordine delle storie sacre,della possibilita di ampliarle e mutarle, del rapporto tra poesia e storia, del ruolodel meraviglioso e dell’allegoria.
In secondo luogo, cerchero di mostrare come, nel tentativo di trovare soluzioniai particolari problemi posti da questo genere, l’epica biblica percorra stradespesso di grande originalita e susciti questioni circa alcuni concetti chiave dellapoetica occidentale come quelli di ‘meraviglioso’, ‘verosimile’ e ‘allegoria’, suiquali ci si interroghera perlomeno fino all’eta romantica. Proprio l’epica sacra,pero, contribuisce ad esaurire la tradizione epica: non casualmente, l’ultimogrande poema epico europeo e il Paradise Lost di Milton. Il sempre minor spazioriservato all’azione e l’approfondimento delle dinamiche psicologiche, seppursotto forma allegorico-religiosa, fece sı che l’epica cristiana contribuisse a spostaresempre piu l’attenzione verso l’universo interiore dell’uomo.
Infine, in questo contributo intendo far emergere come la Controriforma, lungidall’essere una fase di stagnazione e involuzione, sia stata invece un momento didecisivo ripensamento dei generi letterari, ampiamente sperimentale e foriero dinuovi risultati in generi gia ampiamente praticati.3 La rinnovata attenzione neiconfronti dell’uso del sacro determina il rinnovamento della tragedia, del poemaepico e della retorica. La materia avventurosa e cavalleresca, quella erotica e quellameravigliosa, esposte al contatto con la materia sacra, si rigenerano esopravvivono, al pari della materia lirica. In questo senso, non ritengo azzardatoaffermare che l’epica biblica abbia giocato un ruolo decisivo nella transizionedall’epica tradizionale alle moderne forme del romanzo.
Ho deciso di affrontare in questa sede la questione dal lato puramente teorico,avendo gia avuto modo di offrire abbondante esemplificazione in altri contributi.4
LO SGUARDO DEL CENSORE
Accennavo ad un aspetto costruttivo della Controriforma e al contributo offerto,se non alla nascita di nuovi generi, perlomeno all’affermazione, in formerinnovate, di alcuni di essi. Il poema sacro puo sicuramente rientrare in questatipologia di opere; se nella prima meta del Cinquecento troviamo un numerorelativamente esiguo di poemi (intendo di opere che presentino una strutturanarrativa sufficientemente complessa per giustificare l’impiego di questo termine),la loro presenza si infittisce nella seconda meta del secolo, e si moltiplica nelsuccessivo, anche grazie ad una sostanziale equiparazione del poema sacro alpoema eroico. Comunque, che il poema sacro fosse un genere tutto sommatocoerente con i programmi post-tridentini, possiamo verificarlo anche conside-randone le sorti inquisitoriali. Tra gli autori di poemi sacri, Teofilo Folengo eall’indice del 1596 per le Macaronee, ma non per La umanita del figliuolo di Dio,certamente non priva di spunti sospetti (ne tantomeno per la Palermitana, allorainedita). Il Sannazaro figura all’indice per la produzione epigrammatica latina mail De partu virginis non e condannato;5 parimenti, non compaiono all’indice, salvo
28 MARCO FAINI
errore, autori di poemi sacri come Erasmo da Valvasone e Benedetto dell’Uva, cosıcome il Tasso. Estendendo la ricerca ad altri autori di poemi sacri cercheremmoinvano Scipione Capece il cui De vate maximo sfugge le maglie censorie malgradol’autore non fosse esente da propensioni eterodosse. All’indice troviamo invece unvescovo, Marco Girolamo Vida, incluso nell’Indice spagnolo nel 1559 e poi nel1583: ‘Christiados Hieronymi Vidae, en romance o en otra qualquier lenguavulgar’; assieme se ne condannava la versione spagnola di Juan Martın Cordero(Anvers, Martinus Nutius, 1554);6 ma la Christias e ignorata nell’Indice romanodel 1590 che su quest’ultimo si modella.7 Ne troviamo notizie relative agli autoridi nostro interesse in quel formidabile manuale di expurgatio che e l’Indicislibrorum expurgandorum di Giovanni Maria Brisighella.8 Non intendo dilungarmisu queste notizie, del resto facilmente reperibili grazie alla pubblicazione degliIndici e ad una bibliografia ormai copiosa sulla censura libraria in eta moderna.Si dovra invece assumere come un dato di fatto che, come ha scritto Ugo Rozzo, ‘insede di contenuti si puntava ad eliminare tutto cio che compromettesse in qualchemodo il buon nome e l’immagine del mondo religioso nelle sue varie componenti,istituzioni, riti e valori’.9 Si capisce quindi che, salvo sporadiche eccezioni, i poemisacri si collocassero al di fuori del campo degli interessi inquisitoriali. Noncostituivano trattazioni teologiche; non erano versificazioni della Scrittura chepotessero rientrare nel novero dei volgarizzamenti biblici; meno che meno eranostorie profane che potessero contenere spunti licenziosi o satirici (come prescrittodalla regola VII delle istruzioni di Clemente VIII).10 Al contrario, si trattava diopere che programmaticamente si proponevano di celebrare la religione e,addirittura, di sostituire nel genere piu alto di poesia i temi — e piu tardi anche lalingua — pagani con i corrispettivi cristiani. Tutt’al piu, si sara fatta attenzione ache in essi non si riscontrasse violazione delle norme individuate nell’Indice diClemente VIII sul tema De correctione librorum, evitando che in essi siannidassero, inavvertite, ‘Propositiones hereticae […] scandalosae, piarum auriumoffensivae, temerariae, et schismaticae, seditiosae, blasphemae’ (‘Proposizioniereticali […] scandalose, offensive degli orecchi pii, temerarie e scismatiche,sediziose, blasfeme’); o che in essi non comparisssero ‘profanae etiam novitatesvocum ab haereticis excogitata’ (‘Novita profane di espressioni formulate daglieretici’), ‘verba dubia et ambigua’ (‘parole dubbie ed ambigue’), ‘verba SacraeScripturae non fideliter prolata, vel e pravis haereticorum versionibus deprompta’(‘espressioni della Sacra Scrittura rese non fedelmente, oppure tratte dalle malvagieversioni degli eretici’), ‘verba Scripturae Sacrae, quaecunque ad profanum usumimpie accomodantur’ (‘parole di ogni genere della Sacra Scrittura adoperateempiamente per scopi profani’), ‘omnia, quae superstitiones, sortilegia, acdivinationes sapiunt’ (‘tutto cio che sia in odore di superstizione, incanti edivinazione’).11
Ma non solo l’Inquisizione non condanno queste opere: esse vennero addiritturaapprovate esplicitamente. Se nell’Indice del 1596 venivano tollerate le versifica-zioni bibliche antecedenti il 1515, nel 1601 proprio il Brisighella faceva notare cheanche dopo quella data vari episodi della Scrittura sacra erano stati oggetto dinarrazione poetica, citando in particolare il Sannazaro e il Vida. Pur condividendoil divieto di pubblicazione di opere nelle quali venisse proposto letteralmente iltesto sacro, Brisighella riteneva opportuno consentire la pubblicazione di storie‘paraphrastice […] et variis Poetarum coloribus ampliata’ (‘in modo parafrastico e
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 29
ornate con i diversi colori dei poeti’). In seguito alle sue pressioni, nella riunionedei cardinali dell’Indice del 15 dicembre 1601 si decise di accettare opere che ‘exSacra Scriptura et eius partibus diversas hystorias aut materias assumant prosubiecto poematis, quas ex aliis etiam authoribus colligunt et diversis poetarumcoloribus ornant et paraphrastice pertractant’ (‘assumono come materia di poemistorie tratte dalla Sacra Scrittura o dalle sue parti le quali siano pero tratte ancheda altri autori, le ornano con i colori poetici e le trattano in forma di parafrasi’).12
Analoga impressione di tolleranza nei confronti del genere si ricava leggendo laBibliotheca selecta di Antonio Possevino. Nel libro XVII il capitolo XXV si occupaDe ipsa Epopaeia, deque Epicis Poematibus sacris. Possevino dimostra il suoapprezzamento per il genere:
Porro si in hanc nostram aetatem respicimus, inter Epica poemata vel sacra,
vel de rebus honestissimis, nemo spernenda duxerit, quae Actius Syncerus
Sannazarius de Partu Virginis, Hieronymus Vida sua Christeide, Petrus Angelius
sua Syriade, Franciscus Bencius noster suo poemate quinque Martyrum
scripsere. Quae si alii attentent nova parturitione parere, intelligent quanti
Poetae fuerint hi quos nominamus. Ac a Sannazario quidem paucissimis demptis
(quae voces illas Ethnicorum Poetarum sapiunt) Divinum habemus poema, ut
merito Belisarius Aquaviva, Neritinorum Dux, eidem scribens dixerit cum
orationis splendore contendere brevitatem, cum rotunditate ornatum, cum fluxu
carminum pulchritudinem; atque ita demum omnia numeris, et sententiarum
gravitate mandata videri, ut ad cuiusvis scriptoris antiquissimi candidissimique
laudem accedant. In Hieronymo autem Vida scio quid desiderantur: at materia,
quam tractandam susceperat, Ethnicas poematum et fabularum leges non
admisit. In Petri Angelii Syriade castitas, numerus, amplitudo rerum (licet iam
senescentis viri) ac pleraque alia sunt admiranda […].13
(‘Certamente se guardiamo a questa nostra eta, tra i poemi epici o sacri, o che
trattino di cose piu che oneste, nessuno riterra siano da disprezzare le cose che
scrisse Azio Sincero Sannazaro nel De partu Virginis, Girolamo Vida nella sua
Cristiade, Pietro Angeli nella sua Syriade e il nostro Francesco Benci nel suo
poema De quinque martyribus. Cose tali che, se altri tentassero di dare alla luce
con nuovi parti, capirebbero che grandi poeti sono questi che abbiamo nominati.
E dal Sannazaro — fatta eccezione per pochissime cose (quelle espressioni che
risentono dei poeti pagani) — abbiamo un poema divino, tanto che giustamente
Belisario Acquaviva, duca di Nardo, scrivendogli disse che la brevitas
contendeva con lo splendore del discorso, l’ornato con lo stile pieno e rotondo,
la bellezza con la scorrevolezza dei versi; e cosı appunto ogni cosa sembra legata
ai versi e alla gravita delle sentenze che possono eguagliare le lodi che spettano a
qualunque antichissimo e piu chiaro poeta. So cio che si rimpiange in Marco
Girolamo Vida: ma nella materia che aveva scelto di trattare non accolse le
maniere dei poemi e delle favole dei pagani. Nella Syriade di Pietro Angeli la
verecondia, l’armonia, l’ampiezza delle vicende (sebbene da parte di un uomo
ormai anziano) e molte altre cose sono da ammirare.’)
Possevino appare di ampie vedute anche nel capitolo XXIX Elenchus aliquodPoetarum, qui vel de rebus Sacris, vel certe haud obscoenis scripserunt quive derecto Poeseos usu egerunt. L’elenco include i maggiori poeti neolatini italiani ma
30 MARCO FAINI
non esclude scrittori in volgare, come il Folengo, di cui si ricorda La umanita delFigliuolo di Dio (senza alcun avvertimento circa eventuali cautele da adottare nellalettura) o Capoleone Ghelfucci del quale viene citato il Rosario ‘etruscis rythmiselegantissime, et summa pietate conscriptum’ (‘scritto in modo assai elegante e consomma pieta in rime toscane’).14
‘OGNI COSA IN GLORIA DI DIO E AMMISSA’. O NO? L’ORDINE DELLA STORIA
A partire dalla fine del Quattrocento si cominciano a scrivere in Italia numerosipoemi, principalmente latini, di taglio epico e centrati sulla vita di Cristo o dellaVergine: Macario Muzio, Battista Spagnoli, Girolamo Delle Valli sono alcuni tragli autori di questi poemetti. Da questi tentativi scaturisce una tradizione di epicasacra latina che culmina nei due capolavori di Jacopo Sannazaro e MarcoGirolamo Vida: il De partu virginis (1521) e la Christias (1535).15 L’esigenza diunire epica e messaggio cristiano era del resto evidente fin dalla pratica, ricostruitada Craig Kallendorf, di leggere Virgilio in chiave moralizzata, ampiamente diffusanella Venezia del primo Cinquecento.16 Il poema sacro e solo una delle forme che ilgenere del poema eroico assume nel corso del Cinquecento e, come tale, entra nellacomplessa riflessione sul poema che si svolge negli anni Quaranta e Cinquanta.Alcuni dei poemi sacri piu noti vengono elaborati precedentemente a talidiscussioni, ma certamente le strade del poema sacro e di quello eroico siintrecciano sempre piu, fino a sovrapporsi nel corso del Seicento, quando non einfrequente trovare sui frontespizi indicazioni come ‘‘poema sacro ed eroico’’. Nonintendo naturalmente ripercorrere qui la storia dell’elaborazione del poema eroico,che e stata oggetto di numerosi studi, alcuni dei quali recenti ed esaurienti.17 Milimito a raccogliere un’osservazione di Luciana Borsetto per cui il desiderio ditrovare una nuova forma di narrativa eroica che sostituisse le ‘‘fole’’ dei romanzi,cioe il modello ariostesco, con una narrazione di imprese eroiche, reali e sacrecomincia ad avvertirsi in seguito alla vittoria di Tunisi del 1535.18 Alcuni deipoemi e poemetti dedicati all’impresa di Carlo V indicano programmaticamente,nella propositio, il desiderio di cantare tale autentica e sacra impresa; e, potreiaggiungere, tale istanza si ritrova anche nella lirica, ad esempio in VeronicaGambara che nel sonetto Cantin le ninfe co’ soavi accenti prega ‘accio che senzadanno e vada e torni | questo non fabuloso o finto Giove’.19
La meta degli anni Trenta puo essere considerata un momento di maturazionedell’esigenza di una nuova poesia, in cui il vero — un vero connotato in sensocristiano — prende a farsi strada. Non casualmente, si intraprende allora ancheun’embrionale riflessione su come le forme letterarie possano adattarsi alla materiasacra, sia nel campo della poesia, come nell’interessante introduzione che Folengoscrive per la sua Umanita del Figliuolo di Dio, sia in prosa. Pietro Aretino, conl’abituale chiarezza, espone rischi e pregi della scrittura sacra in due lettere scrittenel 1540, all’indomani della pubblicazione della Vita della Vergine (1539). Meritaqui riportarne alcuni passi perche certe indicazioni di fondo si ritroveranno negliscritti di coloro che si cimentano col poema sacro. Scrivendo a Girolamo Verallo,legato apostolico, dice Aretino:
E perche ogni cosa pensata, detta, e scritta in lode del Signore e autentica, tutto il
mio sforzo e suto in estollere le azzioni, le bellezze, e le virtu di nostra Donna con
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 31
ogni sorte di parole atte a ringrandire il religioso de le meditazioni mie. E non e
dubbio che le menzogne poetiche diventano evangeli allora che posto da parte il
celebrar le chiome, gli occhi, la bocca, e il viso di questa e di quella, si rivolgono
a cantar di colei che e rifugio de le speranze nostre, e beati gli inchiostri, beate le
penne, beate le carte che si spendano, si affaticano, e si spiegano ne i pregi di
Maria.20
La lettera e datata 25 novembre 1540; il giorno dopo Aretino scrive al marchesedel Vasto, alla cui moglie, Maria d’Aragona, l’opera e dedicata:
Onde se voi non trovate la virtu mia ne la prova che una volta vi sete messo a
farne, de la grandezza che io ho trovata la liberalita vostra ne la esperienza che
sempre ne feci, datene la colpa ad Alfonso d’Avalos, il quale ha voluto che io
formi un libro intero d’una leggenda che non empie un foglio mezzo; tal ch’io
vorrei che la sterilita di cotale istoria fusse stata imposta a lo studio di qualunche
si voglia. Io non dico cio per quel che altri si crede che mi abbia saper piu de gli
altri, ma per quel che gli altri stimano d’intender piu di me. Che potria mai fare
lo stupendo artificio del divin Buonarruoti nel dipignere in poco spazio un
concistoro apostolico, non gli essendo lecito di vestire lo assiso Pontefice, ne i
sedenti cardinali d’altro che di rosso e di pavonazzo. Ecco lo scriver mio sempre
ne l’ire, ne le minaccie, ne le prigioni, ne gli spaventi, ne i supplizii, e ne le morti,
si sostien quasi tutto in sul dosso de la invenzione; peroche oltre che, l’opera, che
in se stessa e poca, sarebbe nulla senza lo aiuto che io le ho dato meditando.21
E significativa la fiducia, che ritorna in entrambe le lettere, nel potere dellaletteratura di servire ad esaltazione di Dio, sı che tutto cio che sia scritto in suoonore e verita, sacralizzato dalla natura stesso del suo oggetto. Tuttavia, giaemerge il problema per cui le ‘‘leggende’’ cristiane offrono poco spazioall’immaginazione: la lettera delle Scritture e spesso troppo scarna. Solo ilvirtuosismo dello scrittore puo riscattarla attraverso un’immaginazione che, seancora non si costituisce come ‘‘meraviglioso cristiano’’, pure sembra gia guardarein quella direzione. Certo siamo in una fase in cui ‘ogni cosa che risulta in gloria diDio e ammissa’, ma lo snodo problematico e prima di tutto questo.
La partita del poema sacro si presenta nel Cinquecento come decisiva in unprocesso di evoluzione e progressivo svincolamento dall’eredita classica. I rischiconnessi all’epica cristiana erano molti, ma valeva la pena correrli perche, forse perla prima volta in essa avrebbe potuto ricomporsi il dissidio tra poesia e verita cheaffliggeva i commentatori della Poetica aristotelica. Ancora alla fine del XVIIIsecolo, Carlo Ercolani, traduttore di Milton, scriveva entusiasticamente pre-sentando la propria versione della Cristiade del Vida: ‘La Verita istessa supremaforma il soggetto dell’opera […]. Io adunque pensai che presentando alla mianazione nella sua propria favella un’opera cosı interessante, gli avrei donato unode’ principali poemi che abbia composto l’ingegno umano; ed in questi tempi dirivolta e d’insubordinazione avrei cercato di tener lontano da noi per mezzo dellospirito evangelico, cosparso delle dolcezze poetiche, il fanatismo che serpeggia pertutta l’Europa’.22 I tempi ‘‘d’insubordinazione’’ erano quelli successivi allaRivoluzione — siamo nel 1792 — ed Ercolani proponeva all’Europa un poemaepico cristiano come mezzo per ritrovare la perduta armonia. Tentativo patetico,
32 MARCO FAINI
forse, ma, a mio modo di vedere, estremo vestigio di un sogno di unita dellacristianita, di un sentimento di appartenenza ad una tradizione comune che l’eposbiblico avrebbe dovuto sancire.
Eppure questo genere potenzialmente vincente non seppe quasi mai venire acapo di alcune difficolta. Un primo ordine di problemi e legato alla dispositio:anche ammettendo che si possa scrivere un poema di religione, questo obblighera arispettare l’ordine della storia sacra? La questione era ben presente agli scrittoriancor prima che l’assidua esegesi aristotelica imponesse la scelta tra storia e poesia.L’impaccio e segnalato dal Sannazaro in una lettera del marzo 1521 al Seripando,dalla quale emerge in controluce l’imbarazzo nell’applicare il modello epico allamateria evangelica. Il passo e famoso ma e opportuno ricordarlo: ‘io ad mio poterenon mi era scostato de l’evangelio. […] Anchora che la materia sia di cose sacre,havendole io, cosı come ho possuto, scripte in verso, o bene o male che siano dette,la compositione, il modo et lo ordine son puro di poema’.23 Poco piu tardi,Folengo sottolineava, nella prefazione all’Umanita del Figliuolo di Dio, analoghedifficolta, risolte tuttavia con maggior disinvoltura: ‘non mi pare disdica pero, sealcuno devoto Bernardo, mettasi a scegliere da la ordinata evangelica istoria o gestio documenti del nostro Salvatore, formandone un nuovo ordine con devotodiscorso di piu imaginate cose’.24 In questo campo, sembra che Vida si siaaggiudicato la palma della migliore riuscita. Secondo Ercolani, il Vida aveva sceltoun eroe famoso, anzi, il piu famoso, del quale aveva cantato l’azione piugrandiosa, la Passione, circoscritta ma sufficientemente estesa, giacche il poetaepico non deve narrare per intero il suo soggetto ma deve piuttosto lasciarne inombra le parti meno significative, richiamandole in scorcio. Allo stesso tempo,pero, Vida aveva saputo complicare piacevolmente la vicenda, cosı da tenere illettore avvinto alla narrazione dell’evento principale pur divertendolo ‘col piacerche nascer suole dalla varieta’.25 Per conseguire questa varieta, Vida mise a fruttola propria inventiva sia nell’inserire episodi totalmente nuovi, sia nell’ampliarequelli tramandati dalla Scrittura con sviluppi in essa taciuti. Questa insolita abilitanel gestire l’intreccio era stata del resto gia riconosciuta al Vida da Lilio GregorioGiraldi che nel De poetis nostrorum temporum (1551) aveva osservato che ‘il suoanimo poetico, ha come principale qualita […] una certa eccellente e mirabileabilita nel disporre e nell’abbellire stilisticamente gli argomenti’.26
Ma in generale era la questione stessa della liceita dell’inserzione del sacro nelpoema ad essere in questione. Indubbiamente, il tema dell’originaria contiguita trasacro e poesia e attestato nelle poetiche cinquecentesche, anche nella declinazionedi un rapporto tra sacro e poema eroico. Su di esso Vida aveva speso alcuneconsiderazioni, nella sua Arte poetica, la quale, pur circolando manoscritta gia nel1516, venne perfezionata proprio tra il 1520 ed il 1527; in essa aveva scritto:
Iamque adeo in primis ne te non carminis unum
Praetereat genus esse, licet celebranda reperti
Ad sacra sint tantum versus laudesve deorum
Dicendas, ne relligio sine honore iaceret.27
Imprima adunque gia non ti s’asconda
Non esser una sol sorte di versi
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 33
Quantunque a celebrar sian sol trovati
I sacri culti e de gli dei le lodi.
Tuttavia, in seguito i poeti si dedicarono ad altri generi di poesia, sebbene ‘nullume numero carmen praestantius omni | quam quo post divos heroum facta recensent’(‘Ma non e verso alcun piu celebrato | tra i tanti, qual sia quel con cui gli fatti |Cantan d’alteri Heroi doppo i Divini’),28 anche in virtu del fatto che gli eroi stessidiscendono dagli dei. Analoghe riflessioni erano state svolte dal Sannazaroquando, nella gia citata lettera al Seripando, osservava, a proposito di Giuseppedefinito heros (in II, 292) che ‘li antiqui si gloriavano esser figli de li dii et sichiamavano heroi; in summa volea dire grande homo. […] Chi fu piu grande cheDavid, re et propheta? Se fusse stato greco, saria dio o heroe’.29 Il rapporto tramodello eroico e materia sacra, chiaro dal punto di vista teorico, si complicava almomento delle concrete scelte poetiche. La continuita tra dei ed eroi, accettabilenell’ottica greca, diveniva molto piu problematica, anche per una questione didecoro, in prospettiva cristiana. Scrive Giovan Battista Giraldi Cinzio nei Discorsiintorno al comporre dei romanzi (1554):
Ma questo [fare intervenire la divinita nella vicenda sc.] non e lecito a poeta che
scriva romanzi di cose christiane. Perche la maesta del nostro Iddio et de’ suoi
ministri non consente che gli chiamiamo et che gli trapponiamo nelle nostre ire,
nelle nostre guerre, et facciamo che favoriscano quello et conducano quell’altro
a morte.30
Nello stesso anno, Alessandro Lionardi, nei Dialogi della inventione poeticadedica alcune brevi riflessioni al soprannaturale nei poemi. L’orizzonte pero eancora quello classico: si spiega che ‘il poeta viene in un certo modo ad imitare lecose sopranaturali facendo parlar Dei’; ma cio, secondo un atteggiamento diffuso,e pienamente accettabile se si applica la corretta esegesi: ‘si possono etiandio cotaliimitationi o fintioni poetiche all’astrologia, alla morale & all’istoria ridurre’.31 Ilpoema eroico e ancora pienamente inserito nella tradizione antica: non si parla dialcuna riforma in senso cristiano, se non nella forma di una lettura allegorica. Dalpunto di vista poetico, tre sono gli avvertimenti che Lionardi offre a chi vogliaintramettere il soprannaturale:
Et qui tre cose si deono avvertire, l’una e che l’imitatione sopra naturale si dee
con naturali accidenti rappresentare, altrimente ella non potrebbe essere dal
senso compresa. L’altra e che tale fine bisogna che habbia la favola, quale e il
termine della finta & narrata attione […]. La terza e, che si puo dare ad una sola
favola diverse interpretationi, cioe diversi sensi come istorico, naturale &
morale.32
La riflessione sull’elemento divino e quindi tutta condotta, e non e un caso isolatonelle poetiche cinquecentesche, sugli esempi pagani di Omero e Virgilio, come seancora fosse possibile fare ricorso alle ‘‘favole’’ antiche trasportate al morale,secondo modalita in fondo non dissimili da quelle messe in opera da Ripa oCartari. Ed e gia posto il fondamentale problema di come i sensi possano rendere ilsoprannaturale.
34 MARCO FAINI
LA MACCHINA DEL POEMA. QUALE MERAVIGLIOSO?
Molto piu significative ed articolate le riflessioni che nello stesso anno il Pignaaffida al suo trattato su I romanzi. Qui le questioni affrontate riguardano gliaspetti strutturali della narrazione e i luoghi topici dell’istituto epico-romanzescocome ad esempio l’invocazione:
Il romanze disagiosamente invochera, percioche nelle favolose materie chiamare
il Nostro Signore o riducersi a’ santi sarebbe piu tosto eresia che religione.
Rifuggere ad Apollo e al coro delle Muse del tutto non converra, conciosia cosa
che solo tra gentili simili deita son accettate; ma pure fingendosi che qualunque
buono spirito, da che alla poesia incitati siamo, Apollo sia o il coro delle Muse, e
questo e quello non per vana superstizione ma per dinotar questo divino furore
ci valeranno.33
Le altre considerazioni riguardano principalmente la ‘machina’, cioe l’interventodella divinita per sciogliere i nodi problematici della vicenda; elemento canonicodell’epica che trasferito in ambito cristiano da adito a qualche difficolta:
Ma come faranno i nostri che scrivendo di cose di cristiani l’idolatria fuggir
debbono? Evvi pur troppo il rimedio percioche e de’ superi e de gli inferi serviti si
sono nella loro maniera molto largamente: col paradiso convengono eremiti,
santi, angeli, con l’inferno demonii, maghi, streghe; e dall’uno lato ne risultano
orazioni, benedizioni e inspirazioni, e dall’altro incantesimi, nigromanzie e
fature.34
Di queste ultime sono responsabili le fate, cosı riguadagnate al campo del mirabilecristiano. Secondo Pigna e bene tuttavia servirsi con discrezione di tali interventi etanto maggiore sara il merito del poeta quanto piu la vicenda si dipanera senza farricorso agli dei. Non da ultimo, Pigna si pone anche il problema del mutatoorizzonte d’attesa del pubblico, osservando acutamente che
chi questa poesia tralascia per trattar le favole de gli antichi, a gran rischio si
pone di non far cosa che a questi tempi stimata non sia, essendo che a Giove e a’
suoi compagni e a Plutone e al rimanente della sua schiera piu divozione non
s’ha, e non par piu che le cose impossibili per loro possibili divenir possano.35
A fronte del rischio di introdurre Dio nei poemi, alcuni autori sembrano preferire ilricorso alle divinita pagane; cosı ancora Giraldi Cinzio nella lettera sulla poesiaepica indirizzata a Bernardo Tasso (datata 10 ottobre 1557):
Egli e vero che per la qualita della materia mi e mancato quello che conosco
essere stato di grande aiuto agli antichi et a’ nostri parimente, cioe la religione
loro, introdutta a’ lor tempi ne’ lor poemi. Il che mi avenuto per non patire
questa eta la religione di que’ tempi ne’ quali Ercole fiorı, perche la maesta del
vero Iddio che (merce della bonta divina) noi adoriamo non patisce di essere
trapposta tra le favole degli scrittori.36
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 35
Non potendo pero eludere la questione del meraviglioso, Giraldi Cinzio ha decisodi utilizzare
Le forze delle deita che dagli scrittori di quella superstiziosa religione a que’
tempi furono usate; non passando nell’indurre la meraviglia i termini che al
nume di questo o di quello favoloso iddio die’ la superstizione et il
consentimento degli antichi i quali non conobbero il vero Iddio.37
Si tratta forse dell’unico spunto relativo al tema religioso in quel lungo e fecondoscambio di lettere tra Giraldi Cinzio e Bernardo Tasso che attraversa il secondovolume delle Lettere di quest’ultimo e in cui si discute, rispettivamente, dell’Ercolee dell’Amadigi. Il programma di Giraldi Cinzio e antitetico a quello che pochi annidopo proporra Minturno nella Poetica, in cui si contiene gia in nuce una teoria delmeraviglioso cristiano:
Che altro della diversa religione, e della varieta de’ costumi, se non che, come
che la poesia s’adatta, & acconci a’ suoi tempi, non pero dalla regola sua si
diparte? Movea l’antica gl’Iddij cosı i Celesti, come gl’Infernali, e terreni. La
moderna ha gli Angioli, & i Santi del Cielo, & un solo Iddio, & in terra i
Religiosi, & i Romiti. Havea quella gli oracoli, e le sibylle. Questa ha i
negromanti, e le maghe. Quella l’incantatrici, quali furono Circe e Calysso.
Questa le fate. In quella i messaggeri di Giove eran Mercurio, & Iride. In questa
alcun degli Angioli da Dio si manda.38
Tuttavia non si avverte, in questo programma di aggiornamento del poema, lacapacita di tematizzare un genere nuovo (ne mi sembra di scorgere riferimenti allarelazione tra poema eroico e materia sacra nella minuziosa trattazione ad essoriservata nel libro II del De poeta). Il contesto e ancora quello della polemica traromanzi e poema, e non mi sembra emerga ancora la coscienza dell’epica sacracome genere a se: la religione, rigorosamente cristiana, e un elemento tra gli altri,indispensabile alla riuscita del poema eroico. Interessante notare l’estensione delmeraviglioso che include negromanti, fate, maghe e religiosi, tutti soggetti la cuitrattazione in clima di Controriforma era tutt’altro che agevole. Viene da pensareal meraviglioso ‘‘nordico’’ scelto da Bernardo Tasso nel Floridante, quasi a volerprevenire, attraverso una forte dislocazione spazio-temporale, imbarazzi nell’usodi simile materia.
LE IMPERVIE MERAVIGLIE DELLA RELIGIONE
Certamente pero e a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta che il poema non puopiu essere se non cristiano. La parabola di Francesco Bolognetti e esemplare: dalCostante, del quale e stata osservata la ‘impalcatura ideologica, politico-religiosa,decisamente controriformistica’ e l’evidente ‘recupero di istanze schiettamentetridentine entro le strutture narrative ed ideologiche del poema eroico’,39 allaChristiana vittoria maritima dedicata alla vittoria di Lepanto, alla Vita di SanThomaso d’Aquino.40 Bisogna aggiungere che lo scontro tra Cristiani e Turchi e ilsuo enorme impatto sull’immaginario collettivo si interseca con la storia delpoema sacro e non sara un caso che il tema della battaglia celeste attraversi alcuni
36 MARCO FAINI
poemi eroici scritti in questo periodo o addirittura ne divenga l’oggetto; e cosı inparte dell’iconografia lepantina, in cui si affaccia un nuovo meraviglioso cristianonel quale gioca un ruolo di spicco l’arcangelo Michele.41
Indubbiamente il nodo che si stringe tra poema, religione ed elaborazione di unrinnovato ‘‘meraviglioso’’ e sempre piu stretto; ed evidentemente, gli ultimi dueelementi sono sempre piu strettamente, ma anche problematicamente, intrecciati.La meraviglia non si oppone al fine didattico ed educativo, ma lo rafforza.42 Avevascritto Girolamo Muzio nella sua Arte poetica (1551) che ‘la poesia, che senzameraviglia | non puo lode acquistar, non sta contenta | ai semplici ritratti’;43 cioe,la poesia non deve raccontare le cose come sono accadute ma come avrebberodovuto accadere. Analogamente, la poesia non puo prescindere dalla religione ‘cheil poema e divin, ne senza i dei | poetar si conviene’;44 ma il soggetto da trattaresara da individuarsi nella materia guerresca che in Italia non ha ancora trovatocantori adeguati (con un singolare riecheggiamento di un identico giudiziodantesco nel De vulgari eloquentia).45 Il programma di Muzio prevedeva insommaun poema eroico nel quale abbiano spazio la meraviglia e la religione. A volerguardare indietro, la possibilita di un meraviglioso cristiano era gia forse presentea Pontano, se nell’Actius scriveva da un lato che ‘non verbis modo magnificis, sedrebus quoque et inventis excellenter et expressis admiratio a poetis quaeritur’ (‘sicerca dai poeti l’admiratio non soltanto tramite le parole, ma anche tramite le coseeccellentemente trovate ed espresse’),46 dall’altro che la poesia ‘princeps de Deo etdisseruit et eius laudes cecinit, instituitque sacra, unde primi poetae sacerdotesvocati’ (‘dapprima tratto di Dio e canto le sue lodi e fisso le cose sacre, cosı che iprimi poeti furono chiamati sacerdoti’):47 e anche se lo scopo della poesia non eimmediatamente ed esclusivamente religioso, tuttavia essendo il suo finel’admiratio e la sua origine sacra, credo si possa pensare ad una giustificazionein sede teorica per la creazione di un meraviglioso sacro (non mi pare che Pontanoparli ancora di religione cristiana).48
Circa il fatto che religione cristiana e meraviglia possano procedere di conserva emolto scettico Jacopo Mazzoni che condanna, se non il genere del poema sacro,perlomeno i suoi esponenti di maggior spicco. Nella sua Difesa di Dante introducela categoria di ‘‘impossibile credibile’’ (cfr. il cap. VI della III parte Che cosa sial’impossibile credibile, e che il Poeta puo non solamente finger da se tuttal’inventione della favola intiera: ma anchora alterare, e falseggiare le favole, lehistorie narrate da altri, e per qual cagione). Stabilendo i limiti dell’intervento deipoeti nelle ‘‘storie’’ con alterazioni (Mazzoni dispone una griglia di 34 modalita), ilcesenate individua due modalita fondamentali di poesia: la poesia greca,fantastica, e quella ebraica, icastica. Entrambe si ricollegano ad un diversoatteggiamento verso la storia; cosı, mentre i Greci non prestarono molta attenzionealle proprie storie, di cui esistono diverse e contrastanti versioni che autorizzano leliberta poetiche, gli Ebrei furono sempre scrupolosi raccoglitori del propriopassato. Ragione per cui, dichiara Mazzoni,
Io non posso lodare ne il Sannazaro, ne il Vida, ne altri poeti simili, i quali con
tutto, c’habbiano preso soggetto da’ sacri libri, e per conseguente inalterabile per
le ragioni sopradette, vi hanno pero voluto giungere (e certo troppo arditamente)
molte phantasie.49
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 37
Dichiarazione di certo molto piu interessante del successivo monito a nonmischiare la materia sacra con le favole dei gentili, mitigato pero dalriconoscimento che sia i poeti cristiani antichi, sia i Padri ammisero il ricorso aibuoni autori pagani, e dal riconoscimento che gli stessi autori in precedenzacensurati, trattarono tuttavia la materia in modo pio.50
GLI ANGELI INCARNATI. RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE
Spunti di interesse provengono anche dalla dedicatoria dal poeta friulano Erasmodi Valvasone premessa all’Angeleida, un poema stampato nel 1590 nel quale sidescrive la battaglia tra l’arcangelo Michele e gli angeli ribelli guidati da Lucifero.La materia sacra va giustificata, e lo si fa col criterio della verita: ‘Il soggetto per sestesso e assai acconcio alle regole poetiche, poi che egli e preso da istoria vera manon pero nota, se non nel suo universale, ned e stata trattata da altri poeti, se nonsı come s’e detto da’ Greci e da’ Latini sotto nome di Giganti’.51 Il criterio e sempreduplice: quello di aderenza alla verita, e, dall’altro lato, quello di agire negli spazilasciati liberi dal testo sacro, riorganizzando, ampliando, dettagliando nel rispettodel verosimile e del decoro. E cio attraverso una sostituzione della materia paganacon un perfetto equivalente cristiano, che comporta pero scrupoli dottrinali: ‘iosento alcuni avermi di gia opposto ch’io con poco giudizio abbia ragionato cosımaterialmente come ho fatto de gli angeli’.52 E allora occorre subito un’autoa-pologia, articolata in tre punti, di cui interessa l’ultimo, che chiama in causal’abusato ut pictura poesis: ‘essendo la poesia facolta imitante come ancor lapittura, ella e necessitata delle cose che tratta far un idolo o vogliam dire unaimagine che possa esser oggetto de’ sensi umani, e cio non si puo fare se non concose sensibili’.53 Di fatti, se parlasse di questi soggetti secondo la dottrinateologica, il poeta ‘verrebbe appresso i non dotti a non essere inteso, ed appresso idotti a non esser poeta, poi che allora non imiterebbe’.54 Le esigenze sono quindiquella, tassiana, di salvaguardare l’equilibrio tra poesia e storia, e quella didatticae controriformistica di indirizzarsi anche ad un pubblico di non dotti, e di farlograzie al potenziale visivo della poesia, ribadito anche piu sotto allorche si ricordache ‘e permesso anco a’ pittori di pigner gli angeli buoni di corpo tutti risplendentie belli, ed i cativi all’incontro, della piu spaventevol forma che imaginar sifanno’.55 L’epica cristiana, dunque, in eta di Controriforma, deve possedere unforte impatto, e un potenziale visivo forte e percepibile. Tutta la discussione sulmeraviglioso, con i relativi dubbi che abbiamo visto affiorare in luoghi e tempidiversi sulle capacita di attrattiva della religione, si gioca su questo puntofondamentale: che non e letterario, o non interamente. Alcuni dei punti discussi daValvasone, e particolarmente quello della possibilita/necessita di rappresentaresotto spoglie sensibili le forze spirituali sono poi ripresi da Scipione di Manzano(1560–1596) nel suo Discorso sopra l’Angeleida. Manzano, autore a sua volta diun poema eroico intitolato Il Dandolo, sulla vita del doge Enrico Dandolo,patrocinatore della quarta Crociata, ricostruisce un ideale percorso di auctoritatesche trova in Vida (nel V libro della Cristiade) e in Trissino i suoi ideali antecedentie loda il tentativo di Valvasone di unire poesia icastica e fantastica cosı che‘accoppiando il fantastico col similitudinario, e la favola […] un perfettissimomisto del verisimile con l’impossibile’.56 In un tentativo genealogico impostato suun fitto ricorso ad autori tardoantichi ed umanistici (il De civitate dei, il De
38 MARCO FAINI
misteriis di Giamblico, il commento ficiniano al Simposio), afferma l’originariasomiglianza tra eroi ed angeli, essendo i primi identificabili, alla luce dellatradizione ricordata, come demoni. E quindi perfettamente legittimo inserire entitasovrannaturali e rivestirne le parvenze di panni sensibili: le Scritture sono ricche diesempi in tal senso. Interessante semmai l’idea del mascheramento: Manzanoriattiva, per giustificare le scelte del Valvasone, alcuni spunti derivanti dallatradizione umanistica della prisca theologia secondo cui in tempi e culture diverseil soprannaturale si e sempre svelato ammantandosi di parvenze sensibili checompete all’uomo decifrare come nel caso, esemplare, dei geroglifici. Pienamentegiustificato quindi il ricorso al meraviglioso cristiano da parte del Valvasone, masempre nel rispetto del vincolo allegorico: ‘ne sarebbe gia mai stata concessa a iPoeti l’incredibilita, se non fosse stata l’Allegoria, nel cui senso havessero passatoquesti compensando il mancamento dell’incredibilita, seguire il credibile, peraccrescimento del maraviglioso’.57
LUCI, OMBRE E METAMORFOSI
Rendere visibile l’invisibile e dunque il problema principale di questo genere dinarrativa; nascondere svelando, rivelare nascondendo. Un andamento ossimorico eparadossale, certamente in buona parte consonante con la cultura tardo-cinquecentesca e barocca. Un andamento che impone il ricorso all’allegoria,figura che per eccellenza realizza la coincidenza tra nascondimento e svelamento. Ilpoema sacro richiede programmaticamente una sorta di correzione prospettica,poiche il senso letterale non coincide mai con il senso profondo; e naturalmente lastratificazione semantica puo essere assai elaborata.
La componente visuale implicita in ogni discorso allegorico e mirabilmenteespressa in una pagina di uno dei Discorsi morali sopra la tavola di Cebete tebanodi Agostino Mascardi (1590–1640), il terzo, intitolato Dell’uso e dell’utilita dellefavole nelle cose spettanti alla Religione ed al costume. Il discorso esemplifica lanecessarieta e l’onnipervasivita della favola; in tutte le religioni la verita e stataadombrata da favole e ciascuna disciplina del sapere se ne serve. La favola con lasua dialettica di simulazione e svelamento diviene una sorta di legge universale chetrova applicazione nella politica58 ma che diviene un paradigma di lettura delmondo tutto.59 La favole, e dunque l’allegoria, hanno a che fare con la prospettiva:
E, Signori, l’humano intendimento di tal natura, che le cose piu malagevoli solo
per la difficolta piu curiosamente rintraccia, e de’ beni di questo mondo in
maggior pregio si tengono quelli, che da i meno sono partecipati. Trovansi certe
figure, che se da lontano le miri, par che l’artefice habbia in esse consumato
l’ingegno, tanto son belle; ma se s’avvicinano all’occhio, perdono di vaghezza,
perche alcuni tratti di pennello paion da huomo grosso, se non son posti nella
proportionata distanza.60
Qualcosa di simile accade con la religione:
S’addimestica troppo l’occhio con gli oggetti, che di continuo gli sono opposti. I
sacri horrori, la religiosa caligine un non so che di misterioso barlume, un certo
dubbioso confin di notte, e di giorno non e credibile quanto di riverenza ne gli
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 39
animi de gli adoratori producono; perche sı come l’oscurita de’ colori vale ad
unir la forza dell’occhio, cosı il velo de gli oggetti intelligibili il vigor
dell’intendimento inforza. E vaglia il vero, Signori. Chi piu della Religione
Christiana professa di caminar al buio? Stassene Dio sepolto ne’ lucidissimi
abissi di lume inaccessibile, e tutto che si dica haver poste per nascondiglio le
tenebre, non e pero, ch’egli non habiti una gran luce; la quale essendo a gli occhi
nostri oggetto troppo sfrenato, percio co ’l nome di tenebre s’addimanda.61
La religione e intimamente ossimorica, luminosa tenebra, con linguaggio ricco divenature mistiche e, assieme, pittoriche. Non stupisce allora che proprio ladialettica luce/tenebra diventi materiale costruttivo di questi poemi: la cuiprossimita alla pittura coeva, in termini di correzione prospettica e giochiluministici, e evidente.
Il quinto discorso delle Prose morali dello stesso Mascardi reca un titolocurioso: Delle contese degli Angioli, cosı buoni come rei, e del Geniopredominante nomato. Nato da uno spunto attuale (‘Il suon dell’armi, cheusciendo da provincie straniere viene a ferir gli orecchi all’Italia’),62 il discorsoriflette sui due episodi biblici nei quali si raffigurano angeli intenti a guerreggiare:quello della Caduta e la battaglia di Gabriele contro il re di Persia, narratirispettivamente nell’Apocalissi e nel Libro di Daniele. La riflessione, dapprimaaccentrata sulle conseguenze della guerre sulle lettere, talvolta positive, talaltrasconvolgenti, vira poi in chiave metafisico-morale. La guerra ha avutocominciamento in cielo e due sono le battaglie angeliche che la Scrittura tramanda:quella di Lucifero contro il Creatore e quella di Gabriele contro il re di Persia(riportate rispettivamente nell’Apocalissi e nel Libro di Daniele). Nella descrizionedella battaglia Mascardi e attratto dagli effetti metamorfici che essa produce; egioca sull’ambiguita di Lucifero e sulla sua natura tra fisica di stella e spirituale; dinuovo gli effetti di luce ed ombra diventano essenziali alla raffigurazionedell’indicibile evento. L’esposizione della battaglia e sapientemente costruita;dapprima essa viene enunciata sinteticamente con ampio ricorso ad elementiluministici:
quel Lucifero che sorgeva la mattina, o come legge l’hebreo, ch’era figlio
dell’alba: quel che portava in fronte quasi aurora prescente lo splendor della
gratia: quel che scorgeva per le doti della natura lampi, e baleni; quel che
illustrato da tanti doni celesti prometteva un giorno eterno di gloria di Lucifero
precursore del lume, cangiato in hespero foriero dell’ombre: d’Angiol di luce in
principe delle tenebre, vinto nell’abbattimento dal valor di Michiele fu cacciato
vergognosamente dal campo.63
Quindi, il racconto prosegue con l’esposizione della superbia di Lucifero, condottasulla falsariga della narrazione di un intrigo di corte, nel quale il ribelle ha il ruolodi ‘Cortigiano per la buona fortuna divenuto insolente’.64 Alla superbia Micheleoppone l’ubbidienza, l’umilta, la fede. La battaglia viene risolta in poche righe,mentre cio che sembra affascinare l’immaginazione di Mascardi e la caduta e isorprendenti effetti di metamorfosi che ne derivarono:
40 MARCO FAINI
Lucifero e nome di Stella, che composta di materia celeste, riman pura del
mescolamento delle cose sottolunari; il Dragone e una impressione meteo-
rologica che nella parte elementare formandosi dall’impurita de’ vapori
contaminata, rattiene un incerto e spaventevole splendore; prima di prender
l’armi Lucifero fu stella pura, che dal Sole della divina gratia beveva una
sincerissima luce, con cui i doni naturali abbelliva; ma nel cader dal Cielo parve
un volante Dragone, poiche rimanendo eclissato nella parte, che riguarda la
gratia, mantenne un debole barlume nelle doti della natura; il qual pero,
infettato dalla malitia, ha sembiante minaccioso, & horrendo.65
Mi sembra affascinante questa descrizione della caduta: ma soprattuttoparadigmatica di un modo di procedere che cerca di rendere conto dell’inafferra-bile natura degli angeli, sostanze spirituali che secondo un continuum di arduadescrizione, hanno pero anche sostanza materiale, al punto che esito della caduta euna mutazione del cielo stesso:
dal comandamento divino fu questo gran padiglione del mondo tutto di stelle
d’oro ricamato e trapunto; ma nominatamente con l’artificio della sua mano, per
memoria d’un gran fatto, ci trasse in luce la costellatione del Dragone, o del
Serpente […]. E queste sono le metamorfosi derivanti dalla prima guerra degli
Angioli.66
L’interesse del racconto risiede in questa attenzione alla metamorfosi, allecontinuita e fratture tra piano spirituale e materiale, all’ambiguita che si stabiliscenella costellazione del dragone che e assieme reale e simbolica in virtu del‘sembiante minaccioso, & horrendo’ che questa assume quasi a monitodell’accaduto: la stessa natura ambigua del poema sacro.
Il poema sacro dunque — ed e una sua peculiare caratteristica — ha unastruttura intimamente visiva, legata al suo continuo alludere a qualcosa d’altro,qualcosa di nascosto che viene ricoperto per essere svelato, posto in unaprospettiva obliqua, deformante, quasi anamorfica.
I ‘LUMINOSI ABISSI’ DI SANTA PELAGIA
La tendenza, particolarmente evidente, del poema sacro a privilegiare soluzioniallegoriche, e, attraverso l’uso dell’ossimoro, dei traslati e delle metaforeluministiche, a dar voce a vicende che spesso offrivano scarso spazio all’azione,si presta bene ad essere esemplificata ricorrendo al poemetto del bresciano LucilloMartinengo, Vita di Santa Pelagia, piu volte edito tra il 1590 e il 1592,accompagnato da un corteggio di sonetti ad opera, tra gli altri, di Antonio BeffaNegrini, Gregorio Comanini, Malatesta Porta e Bartolomeo Tortelletti, in cui saraforse da riconoscere il Tortoletti di cui si parlera piu sotto. Qui mi pare evidentecome il poema sacro riduca lo spazio diegetico sostituendolo con un’impalpabile efittissima trama metaforica, di notazioni sottili e sfuggenti che con un ornatosovrabbondante e calcolatissimo accompagnano la vicenda principale, in questocaso molto lineare. Sogni, visioni ed ecfrasi scandiscono la narrazione nel corsodella quale spesso i confini tra realta ed illusione sono incerti; la metafora del velo eimpiegata sovente ad indicare una verita resa opaca dallo sviamento morale della
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 41
protagonista. Il conflitto tra bene e male e quasi sempre reso attraverso metaforeluministiche semplici ma fortemente rilevate che determinano un andamento quasiossessivo della narrazione. Si prenda a campione il sogno allegorico di Pelagia nelcanto II, nel quale l’eroina vede la propria anima in forma di colomba dapprimanera e quindi candida. Qui lo statuto dell’immagine e fortemente equivoco: ‘Fupuro sogno, o pur sott’ombra il vero? […] o qualche imaginato mio pensiero? […]O finto mostro ingannatore, e vero, / Et amator de l’ombre oscure?’67 E di nuovol’immagine del velo che impedisce l’accesso alla luce e replicata nel lamento diPelagia:
Qual nebbia, ahi, spessa m’imbruniva il core?
Lo cinsce del suo horror, m’ingombro ’l lume?
Torbida faccia di confuso errore
[…]
Et non vedea, cieca, il celeste lume?
Horrida notte il petto, abisso oscuro
M’involse, ahi quanto a rimembrarlo e duro!68
Il poema si configura anche come progressiva ascesi verso la luce, come suggerisceuna serie di calibratissime opposizioni e parallelismi. Se oscuro e il velo che offuscala mente, per contrasto e contrappasso, una volta iniziato il percorso penitenziale, icapelli aurei ‘di color fosco il copre benda schietta’ e le bianche carni ‘nero, e vilpanno l’orna, e le diletta’.69 La narrazione procede attraverso opposizionistrutturali che danno vita a protratti campi metaforici: luce ed ombra ma ancheacqua e fuoco. Anzi, la metafora marina viene utilizzata con gusto concettoso apartire dal bisticcio ‘‘pelago/Pelagia’’ a simboleggiare il mare del peccato:
D’un pelago Pelagia, c’hor m’aveggio
Nel fondo immersa d’aspro error mortale,
A te ricorro, e ale secure sponde
Trammi, che puoi, pria che m’affoghin l’onde.
Per l’infinito Mar d’errori l’onda
Senza il tuo aiuto il mio pensier trasporta
[…]
Spera d’haver da te l’aura feconda
E di fuggir il gran naufragio accorta.70
Si tratta di metafore ovvie ma che si complicano attraverso elaborate similitudiniesplorando il tema dell’acqua, anche nella forma delle lacrime di penitenza, equello del fuoco. Martinengo imposta infatti la propria poetica sulla coesistenza diopposte qualificazioni nello stesso oggetto: cosı si avra un’acqua di vita e una cheannega, un ardore di carita e un fuoco che consuma nel peccato, cosı tutta unaserie di concetti sulla morte vivificante espressi nel canto quinto. Qui Pelagiariflette sulla pieta divina: essa ‘che sol pieta compose / ove la vita, per dar vitamuore’,
Tra acute spine, acuta spina ascose
Ove la Morte nel suo proprio horrore
42 MARCO FAINI
Punta, in un punto uccise, e ancisa giacque
Morendo a lo spirar la vita nacque.
Un mistero che porta ad interrogarsi ulteriormente:
Come la Morte, che la vita sperde
La vita uccide, e ne la vita muore?
E come, chi da vita vita perde
E de la morte il cinge forza, e horrore?71
La dimensione teologica e quindi ben presente in tutta l’opera che si configura, nonsolo allegoricamente, come un cammino lontano dalle tenebre del mondo e versola luce, la quale scandisce il significato iniziatico del percorso di conversione dellasanta che, ovviamente, comincia di notte. Un’oscurita metaforica che vieneraddoppiata dal velo delle ‘innocenti frodi’ di Pelagia che nasconde la sua naturafemminile sotto abiti maschili. Questo cammino si conclude idealmente nel cantoquarto allorche Pelagia e ammessa alla contemplazione, sotto forma di visione, delParadiso, in una sezione dell’opera straordinariamente contesta di immaginiluminose. Sicuramente il modello dantesco agisce fortemente, trovando il suoculmine nella descrizione del mistero trinitario; si tratta di alcune ottave che forsemerita riportare per intero:
Qui scorge con tre lumi in una luce
La diva mente, e primo, e sommo Nume;
Vita, luce, e color, ch’arde, e riluce,
Splendido Spirto, puro foco, e lume;
Com’egli avviva, illustra, orna, e produce
Come si sparga, si diffonda, e allume
In vari gradi le celesti menti
Vinca ogni senso, e le ragion lucenti
Come la luce ancor parte, e dissolve
Il puro, da l’impuro, e dal difforme;
Penetra l’allumato, e ’n se s’involve
Ne con quel mesce le sue illustri forme.
Come il calor, ov’ a infiammar si volve
Passa, e si mesce con sue nobil orme;
Scevra e da noi la luce, in noi se sparse
Il raggio, ed e il calor con se n’arse.
Fonte di vita, ch’ogni ben diffonde
Luce, e splendor, da cui fulgor lampeggia;
Mente e, che splende, e che scienza infonde
Ne gli spirti de la celeste Reggia;
Luminoso discorso ne le monde
Menti de la diletta humana greggia;
Color belta, che ’n corpi puri splende;
Virtu ch’a generar l’opaco prende.
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 43
Come prima ne’ lumi suoi supremi,
Quasi in christalli a splender ei si degni
Per essi poi trapassi a li piu estremi
Lucidi, e primi mezi a humani ingegni
Come la luce varij, e cresca, e scemi
Ne gli inferiori, o meno, o ver piu degni.72
Il passo restituisce l’immagine di un universo concepito come progressivaemanazione di luce da parte della divinita: la complessa rete di metafore luminoseindica come l’essenza profonda del reale possa essere letta come mescolanza di luceed opacita e, in linea assoluta, cio pare perfettamente consonante con la poeticaallegorica peculiare al poema sacro. Tutto partecipa della luce della verita, copertapero dal velo delle apparenze sensibili: cio accade nel mondo naturale e nel piccolomondo artificiale del poema, nel quale il lettore e chiamato a sollevare da se questovelo.
E BUONO CIO CHE PIACE. LA POESIA E LA STORIA
Il poema sacro conduce anche ad un punto di rottura l’opposizione tassiana trapoesia e storia. In merito, si possono leggere alcune lettere del benedettino AngeloGrillo (1557–1629), noto per la sua amicizia con Torquato Tasso e per unaraccolta di rime sacre intitolata Pietosi affetti (1594). In queste lettere siimpartiscono alcuni consigli ad Alessandro de’ Nobili e a fra Matteo da Stiacirca la composizione di due poemi di argomento sacro. Il primo aveva scelto dicelebrare i santi dell’anno secondo l’esempio dei Fasti ovidiani. La materia,secondo Grillo, e impegnativa e rischia di risultare non eccessivamente gradevole:
tuttoche la materia non sia atta a ricever quella piu eccellente forma […] essendo
nondimeno pia, & della Christiana religione, non posso se non approvarla […].
Et benche l’epico debba in ogni sua parte cercare il verisimile, & nel poema, di
cui si tratta, sia necessario cercare solamente il vero, sendo mera historia, &
veneranda, quantunque non di quelle tanto sacre, & di fondamento alla nostra
fede, che non potesse ricever qualche alteratione, & violarsi dalla sua pura verita
senza biasimo: non resta pero, che dalla moltiplicita delle attioni non si possa far
sorger molto il dilettevole: benche anco in questo sia imperfettion d’arte,
dovendo l’attione esser una: ma forse una si potrebbe intendere in quanto
all’atto beatifico.73
Poche righe nelle quali compaiono tutti i nodi problematici: il rapporto tra vero everosimile, e tra rispetto del vero e diletto oltre all’onnipresente preoccupazionecirca l’unita dell’azione. Semmai interessa l’idea che esista una gradazione dellestorie sacre, alcune delle quali tollerano un maggior grado di liberta poetica: e ilcaso delle storie dei santi che non implicano verita dogmatiche. Resta pero laconsapevolezza che ad una civilta educata a certi valori estetici non e piu possibilepresentare modelli agiografici nella loro nudita: occorre cercare una forma che,salvaguardando la santita e il decoro della materia, possa fornire il necessariopiacere al lettore. Ecco allora i consigli del benedettino (e si presti attenzione allacura con cui viene enfatizzato il potenziale visivo):
44 MARCO FAINI
Potra altresı con varie conversioni, hora a Dio, hora a’ Tiranni, hora a’ ministri
di morte, hora a’ tormenti, & hora a se stessa accrescer molto piu il mirabile, il
quale non solamente sara accompagnato dal verisimile, ma dal vero, con
l’occasione di tanti veri miracoli, et della vera Deita, et con l’intervento de’
Demoni, molto piu dico, che non si legge ne’ poemi de’ gentili, con la lor torma
di falsi numi. Et l’andar descrivendo la visione beatifica, il fruire amando, &
l’amar fruendo, la felicita dell’intelletto per la volonta, et della volonta per
l’intelletto, toccar qualche cosa della Citta Celeste derivata da’ fonti del grande
Aeropagita. Vestire Angioli di sottil corpo, et sopporli al senso visivo, ornarli di
fulminea spada et cingerli d’armi adamantine, farli balenar per l’aria vestiti
d’aria: tutte queste cose senza partirsi dalla verita dell’historia potran recar
molta lode al Poeta, massime in tanti nobili, & vari avvenimenti. Mi resterebbe
alcun dubio, come potransi acconciamente innestare gli episodi non otiosi, &
ben tessuti, con tutto il contesto principale […].74
Il passo risente dell’influenza tassiana, ma e significativo il tentativo di rovesciarel’assunto per cui l’epica cristiana sarebbe in partenza impossibile per via delvincolo troppo stretto con la storia. Al contrario, qui il diletto viene ritrovato nelcuore stesso della storia: un diletto che e al contempo vero, e quindi superiore aquello che e dato ritrovare nei poemi degli antichi. In germe, un’avvisaglia dellacelebre querelle des Anciens et des Modernes, fondata sul ricorso al meravigliosocristiano, ma anche su un compiaciuto gusto visivo fatto di luce, colore eleggerezza, velocita. Nuovi valori che impongono nuove sfide al poeta cristiano,nel tentativo di rappresentare l’invisibile, l’etereo, il non terreno.
Molto interessanti anche le osservazioni che padre Grillo rivolge a Matteo daStia impegnato nella stesura di un poema su san Francesco. Ancora una volta, ilpunto di partenza e la difficolta di adattare alle esigenze della poesia una storiasacra:
Et gia quel brieve saggio, che mi ha mandato del suo poema, mi assicura di farmi
vedere il suo purgato Francesco trionfante nelle delitie del suo nobil Parnaso, &
non vile, & malamente stimmatizzato fra l’indegnita, & le brutture di Musa
plebea, com’io l’ho talhora veduto non senza mio sdegno. Segua dunque
allegramente, che se ben la materia non e per se stessa del tutto idonea a ricever
quella pur eccellente forma di poesia, che puo far glorioso il Poeta, per esser pura
historia, & che non patisce cosı di leggieri alteratione, essendo assai nota, e tutto
il giorno fra le bocche, & le mani degli huomini, V.T. nondimeno l’arricchira di
tante gioie di poetico lume, che ad ogni modo la rendera pretiosa, & mirabile.75
Malgrado l’appartenenza alla congregazione cassinese, Angelo Grillo tenta diconciliare le esigenze della poesia con quelle della fede e della scrupolosaosservanza dell’ortodossia. Che cio non implichi ipso facto una rinuncia alleprime, lo testimonia questo passaggio tratto da un’altra lettera allo stesso frateMatteo nella quale Grillo esprime il proprio giudizio circa i rapporti tra laLiberata e la Conquistata:
Diro ben, che ’l Tasso per mio parere acquista tanto di artificio nella Gierusalem
Conquistata quanto nella Liberata avanza di vaghezza, & di ornamenti, & cio
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 45
che in quelle cose, le quali appartengono all’unita, & all’essenza della Poesia
s’e voluto piu ristringere in questo secondo poema all’essempio di Homero, &
di Vergilio, benche nel primo non si allontanasse da’ precetti Aristotelici. Ha
attaccato meglio le materie l’una con l’altra; che alcune parevano legate
solamente dal tempo, & dall’instante, assai debol legame, & piu da Romanzo,
che da poema Eroico. Accompagna piu la poesia co i passi dell’historia. Ha
rimediato in alcun luogo, dove l’attion principale sta troppo sospesa. Ha avuto
piu mira, che la sua scena epica non rimanga vota […]. Dimostra maggiore
unita d’attione, & d’agente; benche neanco di questo potesse esser ripreso
nell’altro. […]. Ha levato a bello studio le bellezze soverchie […]. Queste, &
altre perfettioni di arte parmi di havere scorte nella Gierusalem Conquistata;
percio giudicola io poema piu buono, sı come l’altro stimo piu bello. Benche
non ostante tutto cio, che si e tocco, se migliori hanno a giudicarsi que’ poemi
che piu piacciono, & piu son letti da tutti universalmente, […] che, sicome la
Gierusalem Liberata e piu bella della Conquistata, cosı anco sia la piu
buona.76
Avvicinandosi alla fine del secolo si infittiscono i precetti rivolti agli autori dipoesia sacra, in un processo di accentramento e controllo di questa multiformeproduzione che giunge ad un esito sistematico nella Poetica sacra di GiovanniCiampoli. Comune a queste riflessioni e la posizione antiaristotelica.77 SecondoFrancesco Patrizi (1529–1597), i poemi sacri appartengono non solo alla categoriadei poemi morali ma anche a quella dei poemi storici: e qui la polemica e non solocontro Castelvetro ma anche contro Tasso (siamo nel 1588). I poemi sacri (osemisacri giusta le categorie di Patrizi) ‘dal regno di poesia […] sbanditi’ viandranno invece riammessi
se bene non con favole, ma con finzioni belle, e varie, e grandi, e con
oscuramenti quasi del vero, e con velamenti, e con figurazioni, e trasmutazioni,
per poco in altra specie de’ fatti veri hanno in ogni parte la loro istoria distinta, e
del mirabile vestita, e fatta risplendere hanno.78
Alla base di queste convinzioni vi e una teoria della poesia fondata su un dupliceprincipio: innanzitutto che ‘forma di vera poesia e il mirabile’;79 quindi che eperfettamente ammissibile che la storia divenga oggetto di poesia, sulla scorta diaffermazioni autorizzanti provenienti da Platone e dallo stesso Aristotele. Nellamisura in cui puo produrre il mirabile (puo cioe creare una tensione traconoscenza ed ignoranza, credibile ed incredibile) tutto puo cadere entro ilcampo del poetabile e della poesia. Cio che conferisce lo statuto di poetico adun’opera non e in effetti il contenuto quanto l’applicazione ad esso delle setteproprieta universali della poesia (individuate nel libro secondo della Decamirabile, dedicato alle Proprieta poetiche regolate). Il mirabile e, attraverso diesso, la meraviglia, e non la verita costituiscono la forma essenziale e il fine dellapoesia; cio tuttavia deve accadere sempre nel quadro della dialettica traincredibile e credibile dalla quale sola si genera il mirabile, che un ricorsoall’incredibile conduce, come nel caso di Luciano o Rabelais, fuori del campodella poesia.80
46 MARCO FAINI
PERCHE CANTARE DI ORFEO? LE PIE MUSE BARBERINIANE
Ho insistito sull’assenza di un’organica riflessione sul poema sacro: altrettantodoveroso e pero segnalare come tra gli ultimi anni del XVI e i primi decenni delXVII secolo si sperimentino, da piu parti, tentativi di poetica sacra.
Il nuovo modello di poema eroico e, lo si e visto, cristiano; per questo motivo,poiche ha saputo aggiungere ‘la perfezione della virtu Cristiana’ alle qualitaeroiche classiche, Tasso ha creato in Goffredo l’‘idea di perfetto capitano, ed eroe’.Cosı il gesuita Paolo Beni (1552–1625) nella sua Comparazione di Omero,Virgilio e Torquato.81 Piu avanti, lo stesso Beni spende alcune riflessioni pertinentialla nostra materia, perche rispondendo alle obiezioni di coloro che opinavano cheper unita d’azione Aristotele intendesse la rappresentazione di un solo eroe,risponde
che percio di solitario cavaliere, il quale con verita abbia fatto molte cose e
maravigliose imprese, e degne di eroica tromba, resterebbe solamente alcun
essempio sacro, o pur anco di alcuno, il qual non senza particolar soprumano
ajuto abbia fatto le sue imprese; sicche non occorrendo di cio profano essempio,
che vero ed atto sia, chiunque prendesse a far eroico poema di cavaliere, il qual
del tutto solitario avesse fatto eroica prodezza, ed azione, sarebbe astretto a
finger il tutto, senza punto fondarsi sull’istoria. Oltreche in un poema di
cavaliero ed eroe di tale e tanta solitudine, la favola riuscirebbe facilmente senza
varieta, ed arida oltramodo.82
Per Beni si puo dare poema eroico di sola materia profana: la religione cristiana nee necessario complemento, ma non puo costituirne assolutamente la materia.Attraverso la duplice interdizione religiosa e narrativa, relativa alla materia sacra eall’eroe unico, si escludono i numerosi poemi agiografici oltre a quelli relativi allavita di Cristo o della Vergine. Mi sembra da sottolineare come il motivo religiosonon sia esclusivo nel determinare le remore o la rimozione della materia sacra dalnovero dei soggetti poetabili; piuttosto, esso e spesso accompagnato, se nonsostituito, dalla preoccupazione letteraria relativa al predominio del meravigliosoo all’eventuale aridita della narrazione.
Molto diversa la posizione, pochi anni dopo, di Tommaso Campanella che nellasua Poetica latina (siamo attorno al 1613), pur muovendo da un’analogaintenzione polemica in chiave antiaristotelica (per cui la distanza dalle normearistoteliche di Urbano VIII sembra essere il suo maggior merito),83 approda adesiti opposti. Il quadro teorico di Campanella e naturalmente molto complesso e lariflessione poetica e affiancata a quella relativa al bene. In estrema sintesi, laconcezione del poeta come ‘magister et dux populorum’ (‘maestro e guida dellegenti’)84 implica che questi abbia di mira il bene della comunita, e che non si diapoesia se non con un fine educativo. Proprio perche il poeta non e tale se la suaopera non e di giovamento alla Res publica (un giovamento che, si badi, non puoprescindere dalla meraviglia che mette in opera la forza magica della parolapoetica), e poiche l’autentica religione e il piu saldo fondamento di uno statovirtuoso, la poesia sacra deve tenere il primo posto.85 Il legame che unisce la poesiae la religione deve essere quantomai sorvegliato, se proprio dalla poesia sembraaver tratto la sua prima origine l’eresia: ‘ex cantilenis incepit haeresis Germanica,
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 47
& Gallicana: & Comediis & Tragediis nutritur’ (‘dalle rime ebbe inizio l’eresiatedesca e francese, e si nutre di commedie e di tragedie’).86 La poesia puo perolegittimamente estendersi alle cose sacre. L’arte infatti consiste nell’imitazionedella natura, e l’imitazione produce piacere. Bene e piacere si fondono nellanozione di conservazione: il piacere e il sentimento del bene e il bene e cio che ciconserva, cosı che il piacere e ‘sensus conservationis’ (‘il sentimento dellaconservazione’).87 Ma, poiche la nostra conservazione avviene anche in Dio,anche la materia divina puo essere oggetto di poesia. Cade cosı la pregiudizialearistotelica che la poesia non debba occuparsi del vero; l’argomentazione diCampanella condotta dapprima sul filo dell’ironia paradossale verte proprio sullapoesia cristiana. Petrarca avra certo errato nel chiamare poeti Iovenco e Aratore,Vida non era dotto ne lo erano gli antichi autori di inni sacri, superati pero dalBarberini: unici tra i poeti saranno gli autori di romanzi cavallereschi come ilMeschino, la Tavola rotonda e innumerevoli altri.88
Le cautele cui si e fatto cenno vanno moltiplicate quando si debbano introdurrepotenze soprannaturali, procedendo attraverso distinzioni e avvertimenti indis-pensabili al momento di trattare di sostanze spirituali che richiedono rigoreteologico: ‘haec autem non fabulose, sed secundum Theologiam describat: uthomines admirentur, terreantur, discant’ (‘queste cose tuttavia non descriva inmodo favoloso, ma secondo la teologia, cosı gli uomini ne siano ammirati, siatterriscano, imparino’).89
In ambito romano, pur nella temperie classicistica barberiniana, si tenta di darvita ad una poesia integralmente cristiana, con punte polemiche nei confronti dellatradizione classica, come nel carmen dello stesso Maffeo Barberini Poesis probis etpiis ornata documentis primaevo decori restituenda aperto da una domandafulminante: ‘Orphea cur canimus penetrantem ad Tartara, victor | Si spoliansErebum Christus ad astra redit?’ (‘Perche cantiamo di Orfeo che entro vincitore nelTartaro, se spogliando l’Erebo Cristo fece ritorno al cielo?’).90
Nel 1617 il gesuita Famiano Strada (1572–1649), professore di retorica alCollegio romano, da alle stampe le sue Prolusiones Academicae, delle quali ciinteressa particolarmente la quinta del primo libro intitolata An ex rebus sacrisidonea commentationibus poeticis argumenta provenient aeque ac ex profanis.L’autore si propone di dimostrare come la materia sacra sia piu che adatta adivenire oggetto di poesia, malgrado i dubbi che molti agitano sulla sua effettivacapacita di suscitare interesse presso il pubblico perche i suoi argomenti sarebbero‘frigidiora […] ac tristiora’ (‘piu freddi e piu tristi’) e meno capaci di suscitare imoti dell’animo che quelli profani che solleticano la lascivia e la volutta ‘interarma et amorum’ (‘tra le armi e gli amori’).91
Ad un secolo pressoche esatto dalla pubblicazione del primo Furioso, il binomioda esorcizzare e ancora quello di armi e amori. Certamente il modello cavallerescoe principalmente il nemico con cui confrontarsi giacche, nel clima del classicismobarberiniano, l’eredita classica puo essere ampiamente riguadagnata allacristianita. Nella prospettiva di Strada si puo infatti scorgere un significatoallegorico celato dietro le favole pagane, un significato che rimanda alle veritacristiane.92 Anzi, questa lettura allegorica richiesta dai testi antichi si salda conl’autentica e profonda essenza dell’arte poetica che consiste nel ‘facere ac fingere’(‘fare e fingere’): e quest’ultima a sua volta si puo compiere appieno solo nella
48 MARCO FAINI
poesia cristiana, nella quale le cose divine si presentano vestite di similitudini esimboli affinche vengano colte dai nostri sensi.93
Non solo la poesia cristiana e superiore alle altre forme (ed appare chiaro che ciocui Strada si riferisce qui e il poema) per quanto concerne il grado di poeticita; maanche perche il suo meraviglioso pare preferibile a quello pagano fondato su ideeinverosimili e spesso ‘inhonesta, nefanda, sacrilega’ (‘disoneste, esecrabili,sacrileghe’).94
‘UN NUOVO SENTIERO DI POETARE’. LA SCOPOFILIA DELLE PASSIONI
La prolusione di Strada precede di un solo anno un altro importante testo,significativo per quanto breve: il Discorso intorno all’onesta della poesia che ilbolognese Girolamo Preti (1582–1626) premette all’edizione del 1618 de LeLagrime di Maria Vergine del suo concittadino Ridolfo Campeggi (1565–1624).95
La questione del poema sacro e impostata a partire da un confronto tra Antichi eModerni:
Percioche egli era cosa desiderabile a tutti gli animi ch’han zelo di pieta, e a tutti
gl’ingegni ch’han gusto di poesia che ormai comparir si vedesse un’opera poetica
la qual non vaneggiasse fra le lascivie e fra gli amori. […] La qual cosa detta non
e per riprender le fatiche de’ nostri poeti, ma per deplorare la disavventura della
nostra poesia, la qual per altro e giunta ad un segno tanto sublime, che non solo
e fatta riguardevole fra l’altre poesie delle lingue viventi, ma potrebbe
peravventura ancor contendere coll’antica poesia delle lingue migliori.
Insomma, ai Moderni manca ancora la prova decisiva per superare gli Antichi: ilpoema. Ma il poema non potra che essere cristiano, se la poesia, che deve essereutile alla comunita, intende farlo secondo la Legge piu alta ed in accordo alla suastessa natura ‘non sol pudica, ma celeste e santa’. La materia amorosa puo esseresalvata ma a patto di essere riconvertita in chiave spirituale: Preti ricorre qui almito delle due Veneri. La prospettiva e proprio quella di una poesia sapienziale:una poesia teologica espressa da una nuova forma di poema altrettanto dilettevole:
Che se mirano gli scrittori allo scopo del diletto, egli e per mia fe un’empieta il
dire che le materie sante al diletto proporzionate non sieno […]. Ma se volessimo
ancor concedere che le cose sacre fosser piu malagevoli al dilettare che
l’amorose, per questo appunto un ingegno nobile ed elevato ritirar si dovrebbe in
disparte dagl’ingegni volgari, e non andarsene per la via calpestata degli amori,
ma dovrebbe ritrovarsi un nuovo sentiero di poetare il quale fosse da pochi
calcato e conosciuto.
Il poema sacro si pone come nuovo genere e spazio ancora aperto all’invenzione enon gravato da modelli. Ma al di sotto dell’excusatio non petita circa la suppostascarsa ‘‘dilettanza’’ della materia sacra mi sembra di dover cogliere laconsapevolezza lucida che invece proprio qui sta il problema; problema urgenteal punto di dover trovare ‘un nuovo sentiero di poetare’; un genere, una formapoetica non codificata dagli Antichi, dunque. Quale sia questa forma ci vienespiegato piu sotto:
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 49
Il presente poema sara stimato […] glorioso, avendo egli conseguito quel fine che
fino a quest’ora e paruto al mondo tanto malagevole, cioe di congiugnere il
diletto poetico al giovamento spirituale. Imperoche alla morte di Cristo, la qual
contiene i piu alti misteri della Fede santa, egli ha tanto felicemente unita la
sublimita dello stile, la nobilta de’ concetti, e la tenerezza degli affetti […]. Al
rimanente, se il lettore fosse vago di maggior numero di episodi all’usanza degli
altri poeti, l’autore non si difendera colla dottrina del Maestro, il qual vuole che i
poemi abbondanti d’episodi sieno i peggiori; ma dira che sı come questo poema e
diverso dagli altri nella materia, cosı non sarebbe disdicevole ch’egli fosse
alquanto diverso anche nella forma: e l’aggirarsi con digressioni era cosa
pericolosa in un soggetto dov’era necessario fermarsi non solamente sul
verisimile, ma sul vero, ed usar le sovverchie liberta de’ poeti non era
convenevole alla riverenza che si dee alla maesta d’una materia sacrosanta: ed
insomma e stato costretto l’autore a far un misto non meno malagevole che
nobile, cioe formare una poetica teologica, ed una teologica poesia.
Passano trent’anni esatti, siamo nel 1648, e Bartolomeo Tortoletti (1560 ca.-1648), che ha scritto una Giuditta vittoriosa (Roma: Ludovico Grignani) dimostrache il ‘‘misto malagevole’’ malagevole lo e per davvero; e che i problemi, magaririsolti narrativamente, richiedono ancora apologie minute. Perche non vi e dubbioche ‘ne maggior virtu, ne piu sicuro giovamento da huomo Cristiano, che nellematerie Sacre puo ritrovarsi’ cosı che il nostro ha ‘aderito volentieri a quei Poeti,che con piu sano intendimento a subbietti di pieta si sono applicati’;96 non vi edubbio che questi poeti siano stati eccellenti e costituiscano una tradizioneautorizzante che ha insegnato a trattare poeticamente il testo sacro, ma lequestioni sono sempre delicate. Storia o poesia? Vero o verosimile? E ilmeraviglioso? Gli episodi? Le alterazioni? Ecco allora che e opportuno specificare,distinguere, circostanziare, anatomizzare:
Diranno per avventura, che le Istorie sacre sono venerande, ma non alterabili,
com’e necessario nell’Epopea. Io nondimeno concedo, che non siano capaci
d’alteratione ne gli accidenti, senza pregiudicio del vero […]. Si raccordino, ch’io
do un poema, non un’Istoria; Se vogliono la serie del fatto di Giuditta, come
Istorica narratione, ella e reggistrata nella sacra Bibbia, come ogn’un sa. Ma
questa non si dice, se non quanto basta all’Istoria, non gia quanto basta alla
Poesia. Per tanto mi e stato lecito valermi del verisimile, e second’esso specificar
molte cose, che nella storia o sono in compendio, o non necessarie, come le
rassegne de gli eserciti, le missioni, i viaggi, i paesi, l’ambascierie, i ragionamenti,
le battaglie, le morti, & altre particolarita solite d’occorrere nelle guerre, et
attioni grandi. Mi e parimenti stato lecito di mutar l’ordine del racconto […]. Et
inoltre finger Episodi per lo piu in persona di gentili, si come probabilmente
poteano succedere; poiche questi ritrovamenti alla verita della sacra Istoria nulla
repugnano […]. E in questo segno ferisce quello, che io dico nel principio, et
invocatine del Poema, che molte particolarita sono al buio, perche l’Istoria non e
tenuta di venire all’individuo di tutte le cose, si come pare, che sia tenuta la
Poesia.97
50 MARCO FAINI
Bisogna insomma cautelarsi di fronte ad un pubblico di censori occulti ma occhiutiche oppongono, contrastano, eccepiscono: quegli stessi che lo stesso Tortolettiaveva rappresentato sarcasticamente nel 1628 nella sua Iuditha vindicata:‘quaestionem profecto arduam, ac fore inextricabilem deinceps nacti sumus, quaeiam eruditorum omnium defatigavit, ac prope exhausit ingenia […] videtur multisex historia, praesertim sacra, conflari possis neutiquam posse’ (‘abbiamo quindiincontrato una questione di certo ardua e quasi inestricabile che gia avevaaffaticato, se non quasi esaurito, gli ingegni di tutti i sapienti: sembra a molti chel’istoria, soprattutto sacra, non possa essere per nulla arricchita’).98 Ma la poesiarivendica il suo spazio accanto alla storia: anzi, con inversione prospettica, allapoesia viene assegnato il dominio non piu dell’universale, ma del particolare,dell’individuo, cio che la storia non sa, non dice, non ricorda. Ma la vera questionedel poema sacro, che mi sembra di poter cogliere con chiarezza da questo brevescritto, e un’altra. E vero che il meraviglioso cristiano e stato a questa datacodificato, ma il meraviglioso cristiano non si limita, come si e ampiamente visto,ad una sostituzione della mitologia pagana con piu o meno efficaci equivalenti.Esso richiede un ulteriore scivolamento: il meraviglioso cristiano indica in realtasempre le forze interne all’uomo, rende visibile la psicomachia tra bene e male cheinveste le facolta interiori. Esso si accompagna e richiede una lettura allegoricagenerale (‘nella Poesia non si deve far capitale solamente della superficie […] ma[…] penetrar nel midollo de sentimenti reconditi, et allegorici’)99 e particolare:‘Betulia dunque dinota l’anima nostra assediata’; ‘Giuditta s’interpreta per lavolonta humana’.100 Il punto critico e questo: da un lato il racconto significa ormaiqualcosa di ulteriore; dall’altro, cio che esso significa non ha ancora un nome, nepuo essere di per se oggetto di letteratura; sotto la superficie comincia a farsi stradala percezione dei conflitti dell’io. Lo scopo e la grande difficolta del poema sacromi sembra diventato quello di esprimere le complesse pulsioni psicologichedell’individuo presentandole nella forma di uno scontro tra le opposte forze offertedal meraviglioso cristiano. In altri termini, come e stato notato a proposito diMilton,101 l’azione ha valore principalmente per il suo significato allegorico chenon designa piu pero soltanto forze religiose ma anche tensioni morali cheappartengono all’universo psicologico-passionale. La funzione di compromessodel meraviglioso cristiano ha il compito di rendere visibile, secondo una modalitafortemente polarizzata, la psicomachia soggiacente il poema sacro. La logica diTortoletti e semplice e fondata su un assunto evidente: ‘Gia e noto, che laprovidenza di Dio governa, e modera tutte le cose […]; e parimenti manifesto, cheil nemico infernale non cessa di perseguitare il genere humano’.102 Da qui, la fonteprincipale del meraviglioso e degli episodi:
Come vogliamo dunque noi […] che ben, e vagamente apparisca o l’assistenza
della divina providenza, o la persecutione, e machine del demonio, se non
introduciamo i concilii in Cielo, e nell’inferno, le missioni de gli Angioli, e de i
Demoni, le prosopopee, e finte persone per esprimere l’inspirationi, gli spettri, i
prestigi, e le magie per rappresentare le tentationi, & altre somiglianti cose, che
non cadono sotto la vista?103
Fornire uno sbocco a questa ossessione scopofila e l’impasse del poema sacro;vedere quello che la storia non mostra; rendere quello che sfugge alla vista; le
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 51
forze, le tensioni che devono prendere forma umana. Il poema sacro rivolge losguardo all’interno: il mondo non vale per se, le vicende narrative non significanoper se, ma rimandano ad un senso allegorico che sospinge, a sua volta, a cio cheaccade in interiore homine.
‘STUPOR NON PERDI, E VERITA GUADAGNI’. LA SVOLTA DEL XVII SECOLO
Attorno agli anni Quaranta del secolo si compone insomma la frattura netta edevidente che fino ad allora si registrava tra la cospicua produzione di poemi epoemetti sacri ed un’elaborazione poetica che affannosamente cercava di forniresoluzioni alle difficolta che la doppia ortodossia — aristotelica e cattolica —produceva. Non a caso si stampano allora due opere che programmaticamentemettono a tema la relazione tra sacro e poetica: la Poetica sacra di GiovanniCiampoli e la Poetica ecclesiastica e civile del frate Celso Zani, pubblicata diseguito alla sua Retorica ecclesiastica e civile. Quest’ultima e di fatto un minutorendiconto dell’esegesi cinquecentesca della Poetica aristotelica, con particolareattenzione a Tasso, Mazzoni e Patrizi. Tuttavia, proprio nelle prime pagine deltrattato troviamo una dichiarazione assai pertinente al dibattitto che qui si cerca diricostruire. Stabilito che la poesia puo essere anche imitazione di azione divina,Zani, con l’autorita di Agostino e Vida, afferma che la poesia ebbe origine dallareligione e che quindi i primi poeti furono teologi. Di conseguenza, pur con tutte lecautele ed il discernimento del caso, si puo affermare senz’altro che
Nell’Imitazione, ed espressione di queste azioni divini [sic], e sopranaturali,
come anche nell’Imitazione, ed espressioni [sic] di azioni della Scrittura sacra,
che per fede si credono, e lecito, salva sempre la sostanza, e la verita del fatto,
aggiungere, e fingere quelle cose, che non ripugnano a essa verita, e sostanza, e
delle quali con pia meditazione, si puo pensare, che necessariamente o
verisimilmente succedessero o potessero succedere.104
Si tratta di estendere all’epopea il precetto agostiniano (De civitate Dei, XIII, 21)per cui, tenendo ferma la verita della storia sacra, si possano su di essa elaborareriflessioni e meditazioni spirituali. Segue una rassegna di esempi, per la veritapiuttosto eterogenea e desultoria, di coloro che seppere mettere in pratica taleprecetto: tra di loro, Vida e, in precedenza, Sedulio e Apollinare.105
All’ambito barberiniano va invece assegnata la Poetica sacra del Ciampoli(1589–1643), allievo di Galileo Galilei e membro dell’Accademia dei Lincei: diessa esistono due versioni (entrambe stampate nel 1648, rispettivamente a Roma eBologna: quest’ultima e piu ricca di circa cento versi). L’operetta, in forma didialogo tra la Poesia e la Devozione, si propone l’apparentemente impossibileconciliazione tra le due, di fatto pero possibile dall’esempio di due autorita: Dantee Urbano VIII.106 Ancora una volta il problema e quello da un lato dellosganciamento rispetto all’eredita classica, dall’altro quello della possibilita dellamateria cristiana di suscitare meraviglia (‘al mio spirto altero | Povero appar dimeraviglia il vero’).107 Tuttavia, la Poesia afferma di essere disposta a seguire laDevozione se questa le sapra donare un nuovo meraviglioso (‘Ma se in Parnasoinsegni | Che i prodigij non falsi Iddio produce’).108
52 MARCO FAINI
Segue una rassegna, simile ad altre di cui si e gia fatta menzione, nella quale simostra la sovrapponibilita tra molti dei piu famosi luoghi del meraviglioso classicocon analoghi cristiani, cosı che la Devozione puo concludere trionfante che ‘stupornon perdi, e Verita guadagni | E vestir ancor puoi pompe inventrici’.109 Ilprogramma annunciato dalla Devozione, e fatto proprio da una titubante Poesia(‘Ma temo troppo, temo | Che gl’Intelletti humani | Da me non allontani | Questorigore estremo’),110 e pero abbastanza moderato. Ciampoli non intende rifiutare inblocco la tradizione classica, ormai parte del comune patrimonio culturale: gli deigreci possono essere nominati senza assegnare loro effettiva esistenza, errore nelquale incappo Sannazaro nel De partu virginis.111
Poesia e Devozione sono dunque pienamente conciliabili anche alla luce di unaconcezione del vero che prevede una sorta di necessaria menzogna; se bisognaammettere che ‘non quel, che ver non e, sempre e bugia’, bisogna d’altro cantoconstatare che, non avendo l’intelletto umano forza sufficiente per penetrare isegreti divini ‘dunque o sepolti dentro al silentio eterno | de i secoli infiniti | Staranquei sacri arcani | O di fregi non suoi fian rivestiti’.112 I risultati del Ciampoli nonsono forse strabilianti a livello teorico, ma hanno il merito di esprimere in versipiacevoli un programma di riforma spirituale della poesia che, evidentemente, allasoglia degli anni Quaranta, era ancora di la da venire o, forse, era ancora in cercadi modelli.
Ancora nel 1662, nel Trattato dello stile, Sforza Pallavicino (1607–1667) siinterroga sulla liceita e sull’opportunita poetica dell’introduzione dei miracoli, cioedel meraviglioso, per negare che attraverso di essi avvenga una saldatura diverisimile e meraviglioso:
Adunque si vuol considerare che la potenza divina o l’angelica inverso di se non
rende i miracoli verisimili, sapendo noi che l’una e l’altra gli fe’ di rado: e percio
ne habbiamo stupore quando succedono. Quindi e che l’ordire la favola con tal
arte onde nasca per verisimile conseguenza che la divinita vi si voglia mescolare,
o farvi o lasciarvi mescolare i buoni o i rei Spiriti con effetti miracolosi, e fattura
di sottilissimo studio, mirabile a fingersi.113
Qui, come in altri autori considerati, si affaccia l’idea che il meraviglioso siafattura interamente poetica: il discorso e riportato, dopo lungo giro, su un pianoesclusivamente letterario. Ad essere in gioco non e la liceita del meravigliosocristiano ma la sua efficacia letteraria e il suo rapporto con il verisimile. A produrreil meraviglioso dovra essere il meccanismo interno della favola, quasi che lameraviglia fosse il lato nascosto dell’ordinario, e non un aggiunto esterno.
Piu o meno nello stesso torno d’anni troviamo traccia di una riflessione sullascrittura sacra estesa ad ambiti diversi da quelli del poema qui considerati, sia chetrovi compiuta formulazione, sia che resti sul piano di dichiarazioni program-matiche frammentarie e disperse.114 Un esempio cronologicamente vicino e ladiscussione nata tra Ferrante Pallavicino e Giovan Francesco Loredan, e gliammonimenti rivolti dal primo in una lettera del 24 novembre 1639 all’autoredell’Adamo:
La descrizione inoltre, non alterata, o deve essere pura e nuda con sembianze di
semplici narrative, overo intrecciata con vaghezze ch’allettino nella varieta e
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 53
nella tessitura. Il primo modo […] contradice alle proibizioni che vietano la
traduzione della Bibbia per non tramandarla a notizia degl’ignoranti. […] Il
secondo nemmeno s’esclude da que’ biasimi che puo meritare la variazione di
sensi che devono riverirsi, e con irrefragabile puntualita conservarsi nel loro
natıo decoro. […] Sono istorie nelle quali l’aggiunto di sacre intima obligazione
di maturar ogni pensiero, di bilanciare ogni carattere, accio che non segua il
misto vietato di cose vane nonche profane.115
Argomenti gravi a chi si accingeva, o si era gia prodotto, in quell’esercizio che e ilromanzo sacro, e di fronte alle quali appaiono rischiose le repliche indirizzate allostesso Loredan da Tomaso Tomasi:
E chi non giudichera pien di fallacia quel discorso in cui si fa prova di persuadere
che sia da sfuggirsi la tessitura d’Istoria sacra perche in essa non puo sodisfarsi la
fantasia col ritrovamento di nuove invenzioni, perche ella intima obligazione di
maturare ogni pensiero, di bilanciare ogni carattere, perche non ammette al suo
adornamento spirito che, sebbene ha del vivace, tiene dell’inverisimile: vaghezza
che, seppure ha dello spiritoso, ha anche del leggiero; detto il quale, ancorche
brillante, e vano? Quasi che l’arte istorica non imponga questi medesimi precetti
a chiunque spiega un’istoria, o sia in Sacra od in profana materia, e quasi che,
tolto l’addito d’inventare sul verisimile, ch’e proprio di chi tesse poemi o
romanzi, non resti aperto un nobil campo ad uno scrittore d’istoria d’adornare il
suo componimento con l’eloquenza dello stile, con l’artifizio delle concioni, con
la vaghezza delle descrizioni, con lo spirito delle sentenze, con la moralita de’
documenti, con la prudenza de’ giudizii, con la vivacita de’ concetti, con la
varieta delle figure, e con cento, e mill’altri ornamenti, che non possono non
piacere, anche in questo secolo, a chi non ha corrotto affatto il gusto nel diletto
delle vanita.116
C’e molto in questa pagina, a partire da quello che Fabrizio Antonini ha definito‘assioma storiografico’ cioe l’assunto comune a storiografia sacra e romanzo sacro,un assunto su cui si basa la fondamentale analogia dei due generi, loschiacciamento, per un breve periodo, della distanza tradizionale tra l’uno el’altro. Riduzione, questa, resa possibile dalla peculiare natura della storia sacra, diper se misteriosa, al punto di poter essere ‘fonte, quindi, di concetti, arguzie, nuoviaccostamenti e manipolazioni del tessuto narrativo’,117 di quella gamma, cioe, diinterventi che, con torrentizia eloquenza, Tomasi affastella senza riuscire a celarele difficolta strutturali dei romanzi sacri. Se questo spinge la storia verso ilromanzo, l’esigenza di verosimiglianza imposta dalla materia sacra avvicina questoa quella. C’e, anche, mi sembra, nelle parole del pesarese la tendenza a convergereverso una linea di compromesso tra le opposte poetiche del docere e del delectare,perseguita contemporaneamente a Genova, dal Brignole Sale nella Maddalena (incui si e ravvisata ‘l’idea di una rinnovata funzione del linguaggio, la cui preziositanon si esaurisce nel balenio dell’acutezza ma si serve della meraviglia che essasuscita con una finalita morale’),118 e a Venezia, nell’ambito stesso dell’Accademiadegli Incogniti.119
54 MARCO FAINI
CONCLUSIONE
Credo che l’epica cristiana, per tutte le aporie e le difficolta mostrate in questepagine, non si sia mai costituita come genere riconoscibile e, malgrado alcunirisultati di apprezzabile valore, non abbia mai prodotto un’opera che potesse porsicome modello.
Allo stesso tempo, essa ha contribuito ad alimentare il dibattitto poetico e adapprofondirne alcuni cardini, come i concetti di ‘allegoria’, ‘verosimile’,‘meraviglioso’ e il fondamentale rapporto tra storia e poesia. Non e per casodunque che il dibattito sull’epica sacra e ancora vitale nell’Europa romantica, adesempio nelle pagine del Genie du Christianisme di Chateaubriand (e, in Italia, inpagine di Monti, Di Breme, Leopardi, Manzoni), allorche, con la nascita dellapoetica romantica prima e del romanzo storico, tutte queste questioni tornano diestrema attualita.
Ritengo dunque che l’epica cristiana, genere che si afferma in Italia prima e piuautorevolmente che altrove, abbia giocato un ruolo decisivo e seminale, anche neisuoi esiti controriformati, nella transizione verso le forme letterarie dellamodernita.
NOTES
* Tutte le traduzioni dei passi latini, dovenon altrimenti specificato, sono mie.
1 Si veda Marco Faini, ‘‘‘HeroicMartyrdom Unsung’’. The Tradition ofChristian Epic in Renaissance Italy andthe European Context’, WolfenbuttelerRenaissance Mitteilungen, 32 (2008–2010), pp. 135–52.
2 Mario Chiesa, ‘Poemi biblici fraQuattro e Cinquecento’, Giornale stor-ico della Letteratura italiana, 179(2002), pp. 161–92.
3 Virginia Cox, The Prodigious Muse.Women’s Writing in Counter-Reforma-tion Italy (Baltimore: The Johns Hop-kins University Press, 2011), pp. 32–45.
4 ‘La figura di David nei poemi bibliciitaliani tra Cinque e Settecento’, in Lafigure de David entre profane et sacredans l’Europe des XVIe-XVIIe siecles,Actes du Colloque, Tours, Centred’Etudes de la Renaissance-UniversiteFrancois Rabelais, 25–27 mai 2011,publie par Elise Boillet-Sonia Cavi-cchioli (Geneve, Droz, 2015), pp.363–408; ‘La tradizione del poemasacro nel Cinquecento’, in La Bibbianella letteratura italiana, diretta daPietro Gibellini, Brescia, Morcelliana,
vol. V, Dal Medioevo al Rinascimento, acura di GraziaMelli eMarialuigia Sipione(Brescia: Morcelliana, 2013), pp. 591–608; ‘Riscrivere e moralizzare i Fasti nelCinquecento. Una scheda per i FastorumSacrorum Libri di Ambrogio Fracco’, ResPublica Litterarum, 33–34 (2010–2011),pp. 176–84; ‘Le ‘‘sacrosante Muse diGiordano’’. La riflessione sul poema sacronella prima meta del Cinquecento’, inAutorita, modelli e antimodelli fraRiforma e Controriforma, Urbino-Sasso-corvaro, 9–11 novembre 2006, a curaAntonio Corsaro, Harald Hendrix, PaoloProcaccioli (Manziana: Vecchiarelli,2007), pp. 243–65.
5 Ma incluso in un parere inviato da uncensore anonimo al cardinale Sirleto econtenuto nel ms. Vat. Lat. 6149, cc.141r–146v e 148r–150r; su cui si vedaGigliola Fragnito, ‘L’ultima visione: ilcongedo di Pietro Bembo’, in Eadem,In museo e in villa. Saggi sul Rinas-cimento perduto (Venezia: Arsenale,1988), pp. 29–64 (pp. 48–49).
6 Index des livres interdits, Directeur J.M. De Bujanda, vol. V: Index del’Inquisition Espagnole, 1551, 1554,1559, par J. M. De Bujanda, avec
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 55
l’assistance de Rene Davignon et ElaStanek (Geneve: Droz, 1984), pp. 470–71: vol. VI: Index de l’Inquisitionespagnole, 1583, 1584, par J. M. DeBujanda, avec l’assistance de Rene Da-vignon, Ela Stanek, Marcella Richter,ibid., 1993, pp. 577–78.
7 Cfr. ibid., vol. IX: Index de Rome,1590, 1593, 1596. Avec etude desindex de Parme 1580 et Munich 1582,par J. M. De Bujanda et alii, avecl’assistance de Rene Davignon, ElaStanek, Marcella Richter, ibid., 1994,p. 319.
8 Indicis librorum expurgandorum […] perFr. Io. Maria Brasichellen Sacri PalatiiApostolici Magistrum in unum corpusredactus, & publicae commoditati aeditus(Romae: ex Typographia R. Cam. Apost.,1607).
9 Ugo Rozzo, ‘L’espurgazione dei testiletterari nell’Italia del secondoCinquecento’, in La censura librarianell’Europa del secolo XVI, ConvegnoInternazionale di Studi, Cividale delFriuli 9–10 Novembre 1995, a cura diUgo Rozzo (Udine: Forum, 1997), pp.219–71 (p. 256).
10 Index librorum prohibitorum […](Romae: apud Impressores Camerales,1596), c. c1r.
11 Ibid., c. d2r–v.12 I documenti in questione, provenienti
dall’Archivio del Sant’Uffizio di Roma,Indice, vol. I/1 sono trascritti inGigliola Fragnito, La Bibbia al rogo.La censura ecclesiastica e i volgarizza-menti della Scrittura (1471–1605)(Bologna: Il Mulino, 1997), p. 207, macfr. le pp. 199–216. Interessante laricostruzione proposta secondo cui, die-tro le pressioni del Brisighella, ci fosserole insistenze di Cinzio Aldobrandini che,in possesso del Mondo creato tassiano,allora parzialmente inedito, premevaaffinche la pubblicazione di poemi sacrinon venisse interdetta.
13 Antonii Possevini Mantuani, Societati IesuBibliotheca selecta […] (Venetiis: apudAltobellum Salicatum, 1603), t. II, p. 509.Su quest’edizione cfr. Luigi Balsamo,Antonio Possevino S.I. bibliografo della
controriforma e diffusione della sua operain area anglicana (Firenze: Olschki, 2006),pp. 88–91 e, sul libro XVII, pp. 84–87.
14 Possevino, Bibliotheca selecta, p. 522.15 Sulla tradizione antecedente si veda
Mario A. Di Cesare, Vida’s Christiadand Vergilian Epic (New York andLondon: Columbia University Press,1964), pp. 219–20 e 281.
16 Craig Kallendorf, Virgil and the Mythof Venice: Books and Readers in theItalian Renaissance (Oxford: Claren-don Press, 1999); Id., ‘From Virgil toVida: The Poeta Theologus in ItalianRenaissance Commentary’, Journal ofthe History of Ideas, 56 (1995), pp. 41–62.
17 Ad esempio Stefano Jossa, La fonda-zione di un genere. Il poema eroico traAriosto e Tasso (Roma: Carocci, 2002).
18 Tenendo presente anche gli sviluppisuccessivi scrive la studiosa che ‘sitrattava anche di contrapporre allaperniciosa inutilita degli avventurosi elascivi racconti della tradizione roman-zesca, l’utilita di una narrazione digesta moralisticamente orientata, tri-dentinamente incentrata sull’esalta-zione di eroi, volta a rappresentare iltrionfo della fede di Cristo e la dignitadell’impero nel forte richiamo teologicoalla crociata e all’apocalittico conflittotra bene e male che la sottendeva’,Luciana Borsetto, ‘‘‘Prendi l’armeMichel!’’. Figura e scrittura della guerraguerreggiata nei poemi degli angeliribelli del secondo Cinquecento’, inL’actualite et sa mise en ecriture dansl’Italie des XVe–XVIe siecles, Actes duColloque international, Paris, 21–22octobre 2002, reunis et presentes parDanielle Boillet et Corinne Lucas(Paris: Universite Paris III SorbonneNouvelle, 2005), pp. 173–89 (p. 174).
19 Veronica Gambara, Le rime, a cura diAlan Bullock (Firenze: Olschki, Perth:Department of Italian/Tthe Universityof W. Australia, 1995), p. 107.
20 Pietro Aretino, Lettere, a cura di PaoloProcaccioli, II (Roma: Salerno Editrice,1998), p. 236.
21 Ibid., pp. 237–38.
56 MARCO FAINI
22 Carlo Ercolani, La Cristiade del Vidarecata in ottava rima e in XXIV cantidivisa (Macerata: Bartolommeo Capi-tani, 1792), pp. XXI–XXII.
23 Jacopo Sannazaro, De partu virginis, acura di Charles Fantazzi e AlessandroPerosa (Firenze: Olschki, 1988), p. 88;si vedano in proposito le considerazionidi Guido Baldassarri, ‘‘‘Il modo e loordine di poema’’. Il Sannazaro, i‘‘romanzi’’, la Liberata’, in Culturameridionale e letteratura italiana. Imodelli narrativi nell’eta moderna,Atti dell’XI Congresso dell’Associa-zione Internazionale per gli Studi diLingua e Letteratura Italiana, Napoli-Castel dell’Ovo, 14–18 aprile 1982,Salerno-Lancusi 16 aprile 1982, a curadi Pompeo Giannantonio (Napoli:Loffredo, 1985), pp. 107–17.
24 Teofilo Folengo La Umanita delFigliuolo di Dio, a cura di SimonaGatti Ravedati (Alessandria: EdizioniDell’Orso, 2000), pp. 132–33.
25 Ercolani, La Cristiade del Vida, p. XXV.26 ‘Vastus illi animus poeticus, praecipua
eius […] virtus excellens acmira quaedamin poeticis materiis disponendis ilustran-disque felicitas’, cfr. Lilio GregorioGiraldi da Ferrara,Due dialoghi sui poetidei nostri tempi, a cura di ClaudiaPandolfi, presentazione di WalterMoretti (Ferrara: Corbo, 1999), pp. 92–95.
27 Marco Girolamo Vida, L’arte poetica,introduzione, testo, traduzione e notea cura di Raffaele Girardi (Bari:Adriatica, 1982), p. 72. Si veda perol’obiezione di Giulio Cesare Scaligero,Poetices libri septem […], (s.l. [Lyon]:apud Antonium Vincentium, 1561), p.310: ‘Non vera dixit, ubi ait versus adsacra deorum tantum inventos, nam inagresti vita apud Pastores extitisseversus primos diximus in nostro histor-ico’ (‘Non disse il vero dove disse che iversi furono inventati per celebrare lasacralita degli dei: infatti, abbiamodetto nel nostro libro storico come iprimi versi si trovassero presso i pastoriche conducevano vita agreste’).
28 Vida, L’arte poetica, p. 72. Le tradu-zioni dei due passi del Vida sono tratteda Poetica del diviniss. Poeta MarcoHieronymo Vida d’heroici latini in versitoschi sciolti trapportata da M. NicoloMutoni (Venezia: Andrea Arrivabene,1550 ca.), cc. A6v e A7r.
29 Sannazaro, De partu virginis, p. 104.La scelta doveva sembrare impegnativase Giovanni Giolito nel suo volgarizza-mento traduce ‘heros’ con ‘buonuomo’, cfr. Jacopo Sannazaro, De partuvirginis. Il parto della Vergine volgar-izzamento di Giovanni Giolito de’Ferrari (1588) a fronte, a cura diStefano Prandi (Roma: Citta nuova,2001), pp. 156–57.
30 Giovanni Battista Giraldi Cinthio,Discorsi intorno al comporre de’romanzi, in Id., Discorsi intorno alcomporre, a cura di Susanna Villari(Messina: Centro interdipartimentale diStudi umanistici, 2002), pp. 3–204 (p.81).
31 Lionardi, Discorsi, p. 83.32 Ibid., p. 84.33 Giovanni Battista Pigna, I romanzi,
edizione critica a cura di SalvatoreRitrovato (Bologna: Commissione peri Testi di Lingua, 1997), p. 86.
34 Ibid., p. 43.35 Ibid., p. 45. Sulle differenze di atteggia-
mento di Giraldi e Pigna nei confrontidella ‘macchina’ e sul passaggio tra ilpoema eroico e il poema cristiano (siintenda: il poema eroico cristiano, nonil poema biblico), si vedano le pagine diJossa, La fondazione di un genere, part.il cap. III.
36 Giraldi Cinzio, Discorsi intorno alcomporre, p. 464.
37 Ibid., p. 465. Si veda Donatella Rasi,‘Breve ricognizione di un carteggiocinquecentesco: Bernardo Tasso e G.B.Giraldi’, Studi tassiani, 28 (1980), pp.5–24.
38 Antonio Minturno, L’arte poetica (perGio. Andrea Valvassori, 1564, col.:Venetia: per Gio. Andrea Valvassori,1563 [ed. an.: Munchen: Wilhelm FinkVerlag, 1971]), p. 31.
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 57
39 Albert N. Mancini, ‘Funzione e tatticadel meraviglioso nel Costante diFrancesco Bolognetti’, in Studies in theItalian Renaissance. Essays in Memoryof Arnolfo B. Ferruolo, ed. by GianPaolo Biasin, Albert N. Mancini andNicholas J. Perella (Napoli: SocietaEditrice Napoletana, 1985), pp. 181–207 (pp. 184 e 187).
40 Sulla quale cfr. Albert N. Mancini, ‘Dal‘‘romanzo’’ all’epopea agiografica nel-l’eta della Controriforma: La Vita disan Thomaso d’Aquino di FrancescoBolognetti’, Rivista di Studi Italiani, 3(1985), pp. 11–43.
41 Seguo qui Cecilia Gibellini, L’immaginedi Lepanto. La celebrazione della vit-toria nella letteratura e nell’arte venezi-ana (Venezia: Marsilio, 2008), p. 99.
42 Fino alla formulazione tassiana ‘diremodunque che ’l poema eroico sia imita-zione d’azione illustre, grande e per-fetta, fatta narrando con altissimoverso, affine di muovere gli animi conla maraviglia e di giovare in questaguisa’; Torquato Tasso, Discorsi delpoema eroico, in Id., Discorsi dell’artepoetica e del poema eroico, a cura diLuigi Poma (Bari: Laterza, 1964), pp.59–259 (p. 74).
43 Girolamo Muzio, Dell’arte poetica, inTrattati di poetica e di retorica delCinquecento, a cura di BernardWeinberg (Bari: Laterza, 1970), II, pp.165–209 (p. 185).
44 Ibid., p. 188.45 Ibid., p. 175.46 Giovanni Pontano, Actius, in Id.,
Dialoge, ubersetz von HermannKiefer, unter Mitarbeit von Hannah B.Gerl Falkowitz und Klaus Thieme(Munchen: Wilhelm Fink Verlag,1984), pp. 279–511 (p. 502).
47 Ibid., p. 510.48 Sul ruolo di Pontano nell’elaborazione
della categoria poetica di admiratio cfr.Tobias Leuker, ‘Dall’‘‘admiratio’’ alla‘‘meraviglia’’. Su Marino lettore deitrattati di poetica’, in Autorita, modellie antimodelli fra Riforma e Controri-forma, Atti del Convegno di Urbino-Sassocorvaro, 9–11 novembre 2006, a
cura di Antonio Corsaro, HaraldHendrix, Paolo Procaccioli (Manziana:Vecchiarelli, 2007), pp. 77–87.
49 [Iacopo Mazzoni], Della difesa dellaComedia di Dante (Cesena: Barto-lomeo Raverij, 1587), p. 414.
50 ‘E certo, se bene io lodo, che lo scrittoreChristiano si guardi a piu potere insoggetto religioso di scegliere favole,essempij, e modi di dire proprij de’Gentili contenenti dishonesta, o che peraltro sieno contra i buoni costumi, senon solo per biasmarli, e per vituperarli:tuttavia io non so, come si potessegiustamente riprendere s’egli con favolehoneste nel sentimento letterale, &molto utili nell’allegorico, e con historied’essempij virtuosi, volesse incitare, espronare i lettori a viver bene, e beata-mente’, ibid., p. 615. L’impossibilecredibile e luogo diffuso nelle poetichecinquecentesche, secondo l’assunto percui ‘tutte le cose insieme deono esserecorrispondenti, & piu tosto impossibili,& verisimili, che possibili, et nonverisimili’; qui da Alessandro Lionardi,Dialogi della inventione poetica(Venetia: Plinio Pietrasanta, 1554 [ed.an.: Munchen: Wilhelm Fink Verlag,1970]), p. 67.
51 Erasmo di Valvasone, Angeleida, a curadi Luciana Borsetto (Alessandria:Edizioni dell’Orso, 2005), pp. 75–76.
52 Ibid., p. 76.53 Ibid.54 Ibid., p. 77.55 Ibid., p. 78.56 Scipione Manzano, Discorso sopra
l’Angeleida poema heroico dell’illustresig. Erasmo de i signori di Valvasone(Venetia: Iacomo Antonio Somascho,1595), p. 17.
57 Ibid., p. 57. Il senso allegorico com-plessivo dell’Angeleida sarebbe rappre-sentare e celebrare l’umilta (Michele)che sconfiggendo la superbia (Lucifero)si apre la strada alla contemplazionedivina.
58 Cfr. Agostino Mascardi, Discorsi mor-ali […] su la Tavola di Cebete tebano(Venetia: Baba, 1660), p. 46.
59 Ibid., pp. 52–53.
58 MARCO FAINI
60 Ibid., p. 44.61 Ibid., pp. 44–45.62 Agostino Mascardi, Prose vulgari
(Venetia: Baba, 1660), p. 79.63 Ibid., p. 82.64 Ibid., p. 83.65 Ibid., pp. 84–85.66 Ibid., p. 86.67 Vita di Santa Pelagia detta Margherita
ridotta in ottava rima dall’IllustreSig. Don Lucillo Martinenghi […](Brescia: Appresso Pietro Maria Mar-chetti, 1592), p. 24. Sul poema si vedaElisabetta Selmi, ‘‘‘Inchiostri purgati’’ eil ‘‘Parnaso in pulpito’’ (Memoria eriscrittura tassiana nell’epica sacra delSeicento)’, in Dopo Tasso. Percorsi delpoema eroico, Atti del Convegno diStudi, Urbino, 15–16 giugno 2004, acura di Guido Arbizzoni, Marco Faini,Tiziana Mattioli (Roma–Padova: An-tenore, 2005), pp. 423–75 (pp. 455–61).
68 Martinengo, Vita di Santa Pelagia, p.249.
69 Ibid., p. 54.70 Ibid., p. 58.71 Ibid., p. 94.72 Ibid., pp. 77–78.73 Angelo Grillo, Lettere (Venetia:
Bernardo Giunta, Gio. Battista Ciotti,& Compagni, 1608), p. 527. Sul Grillosi veda Francesco Ferretti, Le muse delCalvario: Angelo Grillo e la poesia deibenedettini cassinesi (Bologna: IlMulino, 2012).
74 Grillo, Lettere, p. 528.75 Ibid., pp. 530–31.76 Ibid., pp. 538–39; cfr. Mario Costanzo,
‘Per una tipologia dell’’eroe’ cristiano.Le Giornate soriane di LudovicoAgostini (1536–1612)’, in Id., I segnidel silenzio e altri studi sulle poetiche el’iconografia letteraria del Manierismoe del Barocco (Roma: Bulzoni, 1983),pp. 65–81.
77 Si veda Erminia Ardissino, Poetichesacre tra Cinquecento e Seicento, inPoesia e retorica del sacro tra Cinquee Seicento, Poesia e retorica del Sacrotra Cinque e Seicento, a cura di Ermi-nia Ardissino ed Elisabetta Selmi
(Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2009),pp. 367–81.
78 Francesco Patrizi da Cherso, Dellapoetica, edizione critica a cura diDanilo Aguzzi Barbagli, III (Firenze:Istituto Nazionale di Studi sulRinascimento, 1971), pp. 437 e 444.
79 Ibid., p. 443.80 Ibid., vol. II, p. 309.81 Cito da Paolo Beni, Comparazione di
Omero, Virgilio e Torquato, in Operedi Torquato Tasso, VI (Firenze: Tartini,e Franchi, 1724), pp. 366 e 379.
82 Ibid., p. 388.83 Tommaso Campanella, Rationalis
Philosophiae pars quarta videlicet:Poeticorum liber unus (Parisiis: apudIoannem Du Bray 1638), p. 168. Siveda almeno Lina Bolzoni, ‘La poeticalatina di T. Campanella’, Giornalestorico della Letteratura italiana, 149(1972), pp. 481–521.
84 Campanella, Poeticorum liber unus, p.149.
85 Ibid., p. 160.86 Ibid., p. 149.87 Ibid., p. 96.88 Ibid., p. 121.89 Ibid., p. 191.90 Maffeo Barberini, Poemata (Romae:
Ex Typographia Ludovici Grignani,1643), p. 3. Si veda Giovanni Baffetti,Poesia e poetica sacra nel circolobarberiniano, in Rime sacre traCinquecento e Seicento, a cura diMaria Luisa Doglio e Carlo Delcorno(Bologna: Il Mulino, 2007), pp. 187–203.
91 Famiano Strada, Eloquentia bipartita(Colonia Agrippinae: apud IoannemKinchium, 1638), pp. 176–77.
92 Ibid., p. 177.93 Ibid., pp. 182–83.94 Ibid., p. 190.95 Il Discorso e stato pubblicato a cura di
Domenico Chiodo nel periodico on-lineLo Stracciafoglio, da cui cito; lo si leggeall’indirizzo web www.edres.it|gpreti.html.
96 L’apologia di Tortoletti e pubblicata coltitolo Apparato al poema eroico dellaGiuditta vittoriosa in Lorenzo Carpane,
LA POETICA DELL’EPICA SACRA TRA CINQUE E SEICENTO IN ITALIA 59
Da Giuditta a Giuditta. L’epopea del-l’eroina sacra nel Barocco (Alessandria:Edizioni dell’Orso, 2006), pp. 121–25(p. 121). Sul tema di Giuditta si vedaPaola Cosentino, Le virtu di Giuditta. Iltema della ‘‘mulier fortis’’ nella letter-atura del Cinquecento e del Seicento(Roma: Aracne, 2012).
97 Tortoletti, Apparato, p. 122.98 Bartolomeo Tortoletti, Iuditha vindex
et vindicata (Romae: typis Vaticanis,1628), p. 252.
99 Tortoletti, Apparato, p. 122.100Ibid., p. 123.101Judith A. Kates, Tasso and Milton. The
Problem of Christian Epic (Lewisburg:Bucknell University Press, London andToronto: Associated University Press,1983).
102Tortoletti, Apparato, p. 124.103Ibid.104Celso Zani, Poetica ecclesiastica e civile
(Roma: Lodovico Grignani, 1643), p.13.
105Ibid.106Giovanni Ciampoli, Poetica sacra, in
Id., Rime (Roma: appresso gli Heredidel Corbelletti, 1648), pp. 235–350(pp. 243–44 e 245).
107Ibid., pp. 247 e 271.108Ibid., p. 272.109Ibid., p. 275.110Ibid., p. 283.111Ibid., pp. 286–87.112Ibid., pp. 318 e 319.113Sforza Pallavicino, Trattato dello stile e
del dialogo (Roma: Mascardi, 1662), p.300. Le idee in proposito sono discusseda Eraldo Bellini, ‘Scrittura letteraria e
scrittura filosofica in Sforza Pallavi-cino’, in Claudio Scarpati ed EraldoBellini, Il vero e il falso dei poeti.Tasso, Tesauro, Pallavicino, Muratori(Milano: Vita & Pensiero, 1990), pp.73–189 (pp. 138–40).
114Riprendo la distinzione con cui si apreil saggio di Pierantonio Frare, ‘Poetichedel barocco’, in I capricci di Proteo.Percorsi e linguaggi del Barocco, Attidel Convegno, Lecce, 23–26 ottobre2000 (Roma: Salerno Editrice, 2002),pp. 41–70; si veda anche dello stesso ‘Ilmito nella trattatistica e nella narrativadel Seicento. Metamorfosi vs conver-sione’, Istituto lombardo. Accademiadi Scienze e Lettere. Rendiconti. Classedi Lettere e Scienze morali e storiche,137 (2003), pp. 381–405.
115La lettera, come la successiva delTomasi, si legge in Fabrizio Antonini,‘La polemica sui romanzi religiosi: unalettera da Parigi di Ferrante Pallavi-cino’, Studi secenteschi, 31 (1990), pp.29–85 (p. 72).
116Antonini, La polemica, p. 81.117Ibid., p. 46.118Elisabetta De Troja, La maraviglia de
la santita. Significati e strutture delromanzo religioso barocco (Padova:Liviana, 1980), p. 9.
119Sulla quale cfr. almeno Monica Miato,L’Accademia degli Incogniti di GiovanFrancesco Loredan, Venezia (1630–1661) (Firenze: Olschki, 1998);Edward Muir, Guerre culturali.Libertinismo e religione alla fine delRinascimento (Roma–Bari: Laterza,2008).
NOTES ON CONTRIBUTOR
Marco Faini is a Postdoctoral Research Associate at the University of Cambridge (UK),working on the ‘Domestic Devotions’ project. He holds a Laurea from the University ofPavia and a PhD from the University of Urbino ‘Carlo Bo’. He has held postdoctoralfellowships at Italian and German institutions. His research interests cover heroic andmock-heroic poetry, macaronic and comic literature, the European tradition of impreseliterature, and biblical epic.Correspondence to: Marco Faini. Email: [email protected]
60 MARCO FAINI