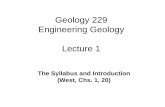“Cartografie Dantesche: Mappando Malebolge.” Critica del Testo: Dante, oggi. XIV/2, (2011):...
Transcript of “Cartografie Dantesche: Mappando Malebolge.” Critica del Testo: Dante, oggi. XIV/2, (2011):...
Critica del testoXIV / 2, 2011
Dante, oggi / 2
a cura di
Roberto AntonelliAnnalisa Landolfi
Arianna Punzi
viella
© Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali,“Sapienza” Università di RomaISSN 1127-1140 ISBN 978-88-8334-638-5Rivista quadrimestrale, anno XIV n. 2, 2011Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 125/2000 del 10/03/2000
Sito internet: http://w3.uniroma1.it/studieuropei/[email protected]
Direzione: R. Antonelli, F. Beggiato, P. Boitani, C. Bologna, N. von PrellwitzDirettore responsabile: Roberto AntonelliQuesta rivista è finanziata da “Sapienza” Università di Roma
Viellalibreria editricevia delle Alpi, 32 – I-00198 ROMAtel. 06 84 17 758 – fax 06 85 35 39 60www.viella.it – [email protected]
Questioni
Arianna Punzi«Animos movere»: la lingua delle invettive nella Commedia 11
Rachel JacoffDante and Rome 43
Olivia HolmesSex and the City of God 67
Rodney LokajDante’s Comic Reappraisal of Petrine Primacy 109
Lorenzo MaininiSchermi e specchi: intorno a Vita nova 2, 6-9 e ad altre visioni dantesche 147
Justin SteinbergArbitrium: Judicial Discretion and Poetic License in De vulgari eloquentia and Purgatorio 27 179
Giovannella DesideriDi Pluto e di Fortuna: topica e microcircolarità significative 199
Theodore J. Cachey JrCartografie dantesche: mappando Malebolge 229
Silvano PelosoDante, Iacomo della Lana e il canto 26 dell’Inferno: a proposito di Ulisse e degli estremi limiti dell’ecumene 261
Claudia VillaLa fine della storia o la storia senza fine: Ulisse fra Dante e Pascoli 277
Ronald L. MartinezAnna and the Angels Sing Osanna: Palm Sunday and the Cristo-rhyme in Dante’s Purgatorio and Paradiso 293
Paolo Cherchi, Selene SarteschiIl cielo del Sole. Per una lettura della Commedia a “lunghe campate” 311
Giuseppe MazzottaMusica e storia nel Paradiso 15-17 333
Gioia ParadisiIcone nella parola: il «volume» «legato con amore» (Pd 33, 86) 349
Mira Mocan«Lucem demonstrat umbra». La serie rimica ombra : adombra e il lessico artistico fra Dante e Petrarca 389
Valentina AtturoIl Paradiso dei sensi. Per una metaforologia sinestetica in Dante 425
Gaia GubbiniRadix amoris: Agostino, Dante e Petrarca (con Bernardo di Ventadorn) 465
Silvia ConteLa ricezione del mito di Filomela e Procne nella Commedia: “Dante filologo” a confronto con Virgilio e Ovidio e un’eco petrarchesca 483
Leonardo CapezzoneIntorno alla rimozione delle fonti arabe dalla storia della cultura medievale europea, e sul silenzio di Dante 523
Immagini
Lucia Battaglia RicciLa tradizione figurata della Commedia. Appunti per una storia 547
Claudia Cieri ViaLa Commedia di Dante in immagine nell’arte del Rinascimento 581
Silvia De SantisWilliam Blake e la Commedia dantesca 613
Ilaria SchiaffiniLa Divina Commedia di Salvador Dalí: una storia italiana 643
Claudio ZambianchiDalla Divina Commedia Alinari all’Inferno di Rauschenberg. Qualche aspetto dell’illustrazione novecentesca di Dante 675
Carla SubriziIl corpo, il dettaglio, gli spazi in Reading Dante di Joan Jonas 695
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Theodore J. Cachey Jr
Cartografie dantesche: mappando Malebolge*
Chi insegna regolarmente l’Inferno di Dante e, del resto, la maggior parte dei lettori della Commedia, avrà dimestichezza con il puzzle della topografia di Malebolge che è l’oggetto di questo mio saggio. L’ottavo cerchio di Dante, in cui è punita la semplice frode, è composto da dieci bolge o male-bolge appunto, che il poeta descrive in tredici canti. (Più di un terzo dell’Inferno è dedicato a Malebolge, vale a dire, all’ottavo cerchio sono dedicati di gran lunga più canti che a qualunque altro dei nove cerchi). Ma perché, vorrebbero sape-re i lettori curiosi, tredici e non dieci canti, che avrebbero corrisposto al numero dei gironi e perciò sarebbero stati conformi a quello che Dante ha altrove definito «lo perfetto numero» (Vita Nuova XXIX 1)? Perché certe categorie di frode sono trattate in uno stesso canto, mentre altre in due canti diversi; e perché nel XVIII canto dell’Infer-no, il primo di Malebolge, sono punite due classi di frode?
Senza dubbio, attraverso queste incongruenze Dante estende al lettore un invito esplicito ad investigare il significato più profondo della relazione tra topografia testuale e fisica nell’ottavo cerchio. Ep-pure gli studiosi che hanno scritto di Malebolge hanno generalmente evitato di discutere questo aspetto. L’ormai classico Interpretazione di Malebolge (1961) di Edoardo Sanguineti1, ad esempio, contestava la distinzione tra poesia e struttura non poetica che Benedetto Croce aveva tracciato in La poesia di Dante (1921)2, dimostrando il valore
* Questo saggio è la versione italiana del mio articolo Cartographic Dante, apparso nella rivista «Italica», 87 (2010), 3.
1. E. Sanguineti, Interpretazione di Malebolge, Firenze 1961.2. B. Croce, La poesia di Dante, Bari 1921.
Theodore J. Cachey Jr230
poetico della struttura del poema. Ma quello studio trascurava persino di riconoscere la questione della relazione tra topografia testuale e ter-ritoriale in Malebolge. Penso sia giusto dire che i dantisti degli ultimi sette secoli hanno prevalentemente evitato la questione, con l’ecce-zione degna di nota e relativamente recente di James Nohrnberg, che in una serie di saggi notevoli ha caratterizzato Malebolge come un parodico milieu paradisiaco, scoprendovi una prefigurazione infernale e un’immagine parodistica dei dieci cieli del Paradiso3.
Allo stesso tempo, insegnando Dante, il mio personale approc-cio è stato fino a poco tempo fa lo stesso di quello della maggior parte dei dantisti, sebbene ogni anno io abbia segnalato il problema per grandi linee agli studenti, mappando la proporzione tra i canti e le bolge dell’ottavo cerchio (si veda in appendice lo schema dei can-ti di Malebolge in rapporto alle bolge). Ma il problema di mappare l’Inferno di Dante e le Malebolge è più di una semplice sfida peda-gogica. Infatti la cartografia infernale non è, come è stata di solito considerata, semplicemente un anacronistico sebbene inizialmente illustre approccio critico inventato dai rappresentanti dell’umane-simo volgare del Quattrocento fiorentino, caduto in seguito irrime-diabilmente nel discredito degli studiosi, e praticato oggi in maniera anodina dai moderni curatori che cercano di offrire un aiuto visivo ai lettori4. Piuttosto, vorrei suggerire che un impulso cartografico abbia
3. Tra gli altri si veda Z. G. Baranski, The ‘Marvelous’ and the ‘Comic’: To-ward a Reading of Inferno XVI, in «Lectura Dantis: A Forum for Dante Research and Interpretation», 7 (1990), pp. 72-95, il quale ha sollevato il problema topo-grafico della relazione tra le interruzioni dei canti e il territorio fittizio nei canti di Malebolge; comunque, il significato della struttura estesa da canto a canto è rimasto ai margini, con l’eccezione degli studi di Nohrnberg (più recentemente, J. Nohrnberg, The Love that Moves the Sun and Other Stars in Dante’s Hell, in Sparks and Seeds: Essays in Honor of John Freccero: Medieval Literature and its Afterlife. Essays in Honor of John Freccero, a c. di D. E. Stewart e A. Cornish, introd. di G. Mazzotta, Turnhout 2000, pp. 87-118, p. 89). Ma si veda anche J. Ferrante, Male-bolge (Inf. XVIII-XXX) as the Key to the Structure of Dante’s Inferno, in «Romance Philology», 20 (1966), pp. 455-466. La lettura cartografica, topografica e terrestre sviluppata in queste pagine si propone come complementare a quella di Nohrnberg. Per un resoconto dei precedenti tentativi di descrivere la struttura etica di Malebol-ge si veda P. Mazzamuto, Malebolge, in Enciclopedia dantesca, a c. di U. Bosco, 6 voll., Roma 1970-1978, III, pp. 787-789.
4. Questo è di fatto il resoconto della mappatura dantesca dato da John Kleiner nel suo illuminante volume, J. Kleiner, Mismapping the Underworld: Daring and
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 231
profondamente stimolato in primo luogo l’immaginazione di Dante, e che abbia trovato espressione in tutto il poema, a cominciare dal primo incontro di Virgilio col pellegrino nel prologo, in cui il poeta latino offre una sorta di itinerario del viaggio oltremondano che sta per cominciare in implicito contrasto con la selva non mappata:
e trarrotti di qui per loco etterno;ove udirai le disperate strida,
vedrai li antichi spiriti dolenti, ch’a la seconda morte ciascun grida;
e vederai color che son contenti nel foco (…)
(If 1, 114-119)5
Voglio proprio cominciare col proporre che la cartografia infer-nale fu stabilita come approccio interpretativo al poema autorizzato niente meno che dall’autorità dello stesso Dante, nel momento in cui Virgilio dota il pellegrino di una mappa o di un itinerario verbale dell’Inferno in Inferno 11. La lezione della guida nella “sala del map-pamondo” di Inferno 11 ha una potenziale rilevanza, vorrei suggerire, per la discussione corrente tra gli storici, i geografi e gli studiosi della cultura a proposito dei confini epistemologici della cartografia. Tanto più che oggi ci troviamo in una situazione non dissimile da quella del pellegrino nell’Inferno, avendo riconosciuto i limiti della carto-grafia come strumento di navigazione della labirintica realtà di un mondo contemporaneo che sfida la “ragion cartografica” del periodo moderno. Allo stesso modo, la realtà dell’Inferno dà prova di essere
Error in Dante’s Comedy, Stanford 1994, al quale ritornerò più avanti. Lo studio di Kleiner è alla base della recente discussione di Ricardo Padrón sul mappare Dante. Padrón considera le mappe quattrocentesche dell’architetto Antonio Manetti (1423-1497) e tratta il moderno fenomeno della mappatura di mondi immaginari. Si veda R. Padrón, Mapping Imaginary Worlds. Maps. Finding our Place in the World, a c. di J. R. Ackerman e R. Karrow Jr., Chicago-London 2007, pp. 255-287. Per gli studi di Manetti e le mappe basate sugli stessi, che furono pubblicati per la prima volta in un’appendice all’edizione del 1506 della Commedia di Dante di Girolamo Be-nivieni (Giunti, Firenze), si veda T. Cachey, L. Jordan, Renaissance Dante in Print (1472-1629): Dante’s Hell, http://www.italnet.nd.edu/Dante/text/Hell.html 2009.
5. Tutte le citazioni dall’Inferno sono prese da Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a c. di G. Petrocchi, Edizione Nazionale a c. della Società Dantesca Italiana, Milano 1966-1967.
Theodore J. Cachey Jr232
al di là della comprensione della mappatura filosofica “razionalista” dell’Inferno di Virgilio in Inferno 11. Inoltre, nella transizione dalla proiezione cartografica razionalista “a volo d’uccello” del trattato lin-guistico di Dante, il De vulgari eloquentia, all’altamente soggettiva e autobiograficamente radicata mappatura dell’Italia che caratterizza i tredici canti di Malebolge della Commedia, il poeta anticipa aspetti del salto da un paradigma cartografico moderno (all’interno del quale le mappature rinascimentali dell’Inferno di Dante ispirate a Tolomeo furono sviluppate inizialmente) ad una prospettiva post-moderna6. Per questa ragione l’attuale ricerca sulle relazioni tra cartografia moder-na e post-moderna dovrebbe comprendere una rinnovata attenzione all’impulso alla descrizione geografica in Dante e al suo sviluppo, a partire dal problema della mappatura dell’Inferno di Dante.
1. Cartografia ermeneutica
La mia caratterizzazione della mappatura di Virgilio dell’In-ferno come inadeguata si ispira in parte ad una recente lectura di Inferno 11 di Zygmunt Baranski, che ha sottolineato i limiti del-la preliminare cartografia dell’Inferno di Virgilio, sostenendo che Dante poeta in questo canto stia ponendo come questione essenziale la limitata capacità delle epistemologie razionaliste sia pagane che cristiane di capire il male7. Ma anche gli studiosi che prendessero la
6. Farinelli, in F. Farinelli, L’immagine dell’Italia, in Geografia politica delle regioni italiane, a c. di P. Coppola, Torino 1997, pp. 33-59, legge il De vulgari elo-quentia come un precursore dell’«ethos cartografico» della modernità. Per Farinel-li, Dante nell’ideale del volgare illustre adombra una prospettiva politica nazionale eretta sulle fondamenta della ragione (costituendo una prospettiva a volo d’uccello sulla penisola concepita come unità territoriale, sebbene non ancora la prospettiva moderna nazionale e zenitale di un Tasso, sopra Gerusalemme, o di un Manzoni, sopra il lago di Como). Per un resoconto del fondamentale mutamento nella storia della cartografia e dello spazio che ci lascia oggi nella necessità di «modelli per la più accurata descrizione delle nuove non euclidee e invisibili linee che dividono gli uomini fra loro» (ivi, pp. 58-59), si veda Id., Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Torino 2003, in particolare, il capitolo intitolato Critica della ragione cartografica (in part. pp. 200-201).
7. Si veda Z. G. Baranski, “Canto XI.” Lectura Dantis Turicensis: Inferno, a c. di G. Güntert e M. Picone, Firenze 2000, pp. 151-163 (in part. p. 159): «Piutto-sto che chiarire l’organizzazione dell’Inferno, Virgilio mette in evidenza la propria
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 233
spiegazione di Virgilio alla lettera, come Marc Cogan, autore di The Design in the Wax8, il tentativo più recente di spiegare la struttura morale ed etica dell’intero poema, riconosceranno che al momento di spiegare le divisioni e l’ordinamento di Malebolge, la presenta-zione di Virgilio in Inferno 11 è, come minimo, incompleta, e anche l’ordine è sbagliato:
Questo modo di retro par ch’incidapur lo vinco d’amor che fa natura;onde nel cerchio secondo s’annida
ipocresia, lusinghe e chi affattura,falsità, ladroneccio e simonia,ruffian, baratti e simile lordura.
(If 11, 55-60)
Come hanno notato gli studiosi, l’ordinamento dei peccati di Malebolge offerto da Virgilio in questo passo di Inferno 11 non cor-risponde alla reale struttura delle bolge, e la loro disposizione sem-bra essere piuttosto casuale. (Benvenuto da Imola fu forse il primo commentatore a segnalarlo quando osservò: «[…] et vide quod autor non servavit ordinem in numerando dictas species fraudium»). So-prattutto degni di nota sono i peccati e i peccatori assenti dalla lista data da Virgilio: niente meno che i consiglieri fraudolenti, compresi Ulisse e Guido da Montefeltro, rispettivamente di Inferno 26 e 27, e i seminatori di discordia, compreso Bertran de Born di Inferno 289. Mazzoni, per citare solo un critico moderno di questa crux, si rifiutò
limitatezza intellettuale, culturale e religiosa. E non unicamente la propria, ma pure quella di tutto il suo mondo e di tutti coloro, pagani e cristiani, che pongono una fiducia eccessiva in epistemologie razionali».
8. M. Cogan, The Design in the Wax. The Structure of the Divine Comedy and its Meaning, Notre Dame-London 1999.
9. Baranski, in Baranski, “Canto XI” cit., include questo passo di Inferno 11 nella sua discussione degli «errori di omissione» della guida, leggendo la sua lacu-na, come il fatto che Virgilio non includa il peccato di eresia nella sua mappa, come un’espressione dell’incapacità del poeta pagano di apprezzare la fede cristiana: «In effetti, tutta la descrizione di Virgilio dell’ottavo cerchio è insoddisfacente: l’ordine in cui le colpe sono presentate non segue l’ordine reale di queste (vv. 57-60); inoltre il poeta latino, accomunando gli abitanti dell’ottava e della nona bolgia nell’etichet-ta generalizzante di ‘simile lordura’ (v. 60), dimentica di notare il fatto, tuttaltro che banale, che Malebolge si divide in dieci parti – cioè che la struttura rivela la mano
Theodore J. Cachey Jr234
di credere che Dante avesse pensato di coprire questi peccati e questi peccatori con la frettolosa locuzione alla fine del verso 60, «simile lordura», e rigettò la possibilità che la lacuna fosse stata il risultato di una mancanza di progetto da parte del poeta10. In ogni caso, prefe-risco non soffermarmi sul problema esegetico presentato da questo passo11. Invece, per il momento propongo di prendere lo schizzo di Malebolge di Virgilio semplicemente come l’invito di Dante a noi lettori ad investigare a fondo sulla questione e crearci le nostre pro-prie mappe. Si può dimostrare che questo è l’effetto del racconto di Virgilio della geografia di Malebolge sul pellegrino Dante, che tempesta la guida di domande che lo portino a chiarire la più ampia divisione aristotelica di alto e basso Inferno secondo la distinzione medievale tra appetito concupiscente (alto Inferno) e appetiti ira-scibili e intellettuali (basso Inferno) e di dissertare sull’usura come peccato contro natura. Il tentativo di mappatura da parte di Virgilio ha lo stesso effetto su Dante poeta se prendiamo, come penso che
dell’artista divino, dato che secondo la numerologia cristiana, il dieci era simbolo della perfezione di Dio» (p. 159).
10. In F. Mazzoni, Canto XI dell’Inferno, in AA. VV., Lectura Dantis Ne-apolitana, I: Inferno, Napoli 1986, pp.167-209, Mazzoni aveva già notato il fat-to che l’ordine dei peccati di Malebolge presentato da Virgilio in Inferno 11 non corrisponde alla struttura e alle collocazioni reali e invece appare ai versi 57-60 «completamente casuale»; infatti «ipocresia, lusinghe e chi affattura» del v. 58 cor-risponde nell’ordine di fatto ai canti 21, 18, 20; «falsità, ladroneccio e simonia» del v. 59 a 29, 24-25, 19; «ruffian, baratti e simile lordura» del v. 60 ai canti 18 e 21. In alcuni casi la lista di Inferno 11 crea dei doppioni, come nel caso dei ruffiani e dei lusingatori che, come è stato notato in precedenza, sono puniti insieme nel canto 18 ma qui si trovano separati al verso 58 e al verso 60.
11. Alcuni commentatori accettano che l’espressione generica «simile lordura» si riferisca ai consiglieri fraudolenti e ai seminatori di discordia. Più recentemente Nicola Fosca (2003-2006, Original publication […] by the Dartmouth Dante Project, 2003) in modo avventato asserisce che «La simile lordura si riferisce ad altre due categorie di fraudolenti contro chi non si fida: i consiglieri di frode (8ª bolgia; canti XXVI e XXVII) ed i seminatori di discordie (9ª bolgia; c. XXVIII)». L’approccio esemplificato da Fosca, che è caratteristico di una parte significativa della tradizione dei commenti, ha l’effetto di trascurare un significativo problema critico e interpretati-vo. Al contrario, Hollander pone almeno la questione nel suo commento: «Qui Dante per qualche ragione (per tenere i suoi lettori attenti?) permette a Virgilio di enumerare i peccati in un ordine incomprensibile, persino omettendone due», (traduzione mia). Tutti i commentatori sono citati dai testi dei loro commenti disponibili attraverso il Dartmouth Dante Project, http://dante.dartmouth.edu/commentaries.php.
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 235
dobbiamo prendere, la grande apertura cartografica ai canti di Ma-lebolge all’inizio del XVIII canto («Luogo è in inferno detto Male-bolge»), come la sua risposta al provvisorio ed incompleto racconto di Virgilio nel canto 1112.
Quindi sia che si opti per la lettura decostruzionista di Baranski della mappa di Virgilio in Inferno 11, sia che si scelga la più diret-ta interpretazione medievale aristotelica di Cogan, il risultato più importante del tentativo di Virgilio di descrivere la struttura etica dell’Inferno è quello di stabilire una cartografia infernale, e in parti-colare, di mappare Malebolge come un problema interpretativo sia per Dante poeta (che ha il compito di disegnare la sua propria mappa di Malebolge al suo ritorno dal viaggio) sia per il lettore al quale è imposto di intraprendere la sua propria mappatura. Del resto, come afferma succintamente Cogan all’inizio del suo capitolo sull’Infer-no, «[t]he moral significance of the physical structure of Hell is itself an explicit subject of the narrative of the poem»13. L’interpretazione della struttura richiede una forma di mappatura ermeneutica che Vir-gilio modella, sebbene in modo imperfetto, per il lettore del poema in Inferno 11.
Tuttavia, la mappatura da parte del lettore dell’Inferno di Dante è complicata in modo considerevole dal fatto che, a differenza del pellegrino e della sua guida, il lettore non ha direttamente di fronte la realtà fisica dell’Inferno ma la rappresentazione che il poeta ne dà. Lo spazio del poema si è frapposto tra il lettore e la realtà dell’In-ferno. La mappatura dell’Inferno di Dante, pertanto, deve essere in-trapresa a diversi livelli. Primo, la rappresentazione nel poema della topografia fisica dell’Inferno (i suoi fiumi, le pianure, i deserti, i col-li, i ponti, le fosse, le mura della città, le torri, e così via), e niente-
12. In J. Nohrnberg, The descent of Geryon: the moral system of Inferno XVI-XXXI, in «Dante Studies», 114 (1996), pp. 129-187 (in part. p. 154), Nohrnberg ha recentemente proposto una soluzione ingegnosa. Secondo lui il passo anticipa la sequenza della sezione di Malebolge in cui si alternano i canti dai numeri pari, dedicati ai peccati contro la verità di rappresentazione (2, 4, 6, 8, 10), ai canti dai numeri dispari, dedicati ai crimini contro l’integrità degli accordi e dei vincoli (1, 3, 5, 7, 9): «Virgilio ci può aiutare a indovinare questo schema, in Inferno 11, 58-60, quando enumera otto delle frodi nel seguente ordine ritmico: 6, 2, 4, 10, 7, 3, 1, 5» (traduzione mia).
13. Cogan, The Design cit., p. 1.
Theodore J. Cachey Jr236
meno che la rappresentazione nel poema della realtà geo-fisica fuori del testo (del mondo mediterraneo, in particolare dell’Italia, dei suoi mari, delle montagne, delle coste, dei colli, delle pianure, dei fiumi e delle città) invitano ad una descrizione interpretativa. Forse più si-gnificativamente da un punto di vista meta-poetico, lo spazio stesso della rappresentazione è suscettibile di una mappatura interpretati-va. Mappare l’intersezione tra spazio testuale (cioè tra lo spazio del-la rappresentazione) e spazio rappresentato (e cioè lo spazio fisico dell’Inferno ma anche gli spazi fisici al di fuori del poema ai quali si fa riferimento) fornisce un’immagine più completa del terreno etico del poema. In questo articolo propongo di affrontare il problema della mappatura dell’Inferno di Dante tenendo a mente tutti e tre i livelli, ed enfatizzando il terzo nel caso di Malebolge. Perché qui, nel regno del mostro metaletterario Gerione, troviamo un maggior grado di complessità rispetto all’ordinamento dei peccati, che si ac-compagna ad un maggior livello di sofisticazione meta-poetica. In-fatti, la proporzione topografica tra lo spazio della rappresentazione e lo spazio rappresentato, cioè la relazione tra i tredici canti e le dieci bolge, getta luce sulla questione della verità del poema di Dante e dei suoi legami con la creazione di Dio e la Sua giustizia.
2. Mappare l’Italia nell’Inferno: «Di quella umile Italia (…)»
Prima di provare a descrivere Malebolge, voglio illustrare in termini più generali ciò che si potrebbe provvisoriamente chiama-re (con un cenno al geografo Franco Farinelli) l’ethos cartografi-co di Dante, nella speranza di fornire una premessa a future analisi della scrittura cartografica di Dante nell’Inferno e attraverso tutto il poema. Per cominciare, l’intertesto virgiliano di If 1, 106-108, che è parte della profezia di Dante della futura salvazione dell’Italia da parte del veltro che dovrebbe nascere tra feltro e feltro (o tra Feltro e Feltro)14, non è stata pienamente spiegata dalla tradizione esegetica:
14. Nella sua nota a questo passo, Hollander afferma che, in disaccordo con il testo di Petrocchi, scriverebbe i due nomi Feltro e Feltro con la maiuscola perché essi indicherebbero nomi di luoghi nel nord Italia. La persona che Dante avrebbe in mente sarebbe quindi Cangrande della Scala, il giovane generale degli eserciti di Verona, al tempo in cui Dante visitò la città per la prima volta intorno al 1304.
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 237
Di quella umile Italia fia saluteper cui morì la vergine Cammilla,Eurialo e Turno e Niso di ferute.
(If 1, 106-108)
L’eco di Dante di Eneide III, 522-523, «cum procul obscuros col-lis humilemque videmus / Italiam» suggerisce che l’Italia è intravista qui all’inizio del poema dalla prospettiva di una nave che arrivi per la prima volta alle spiagge della penisola. Dante assume qui il ruolo di un nuovo Enea o di un Colombo ante litteram. Di conseguenza, è nel nuovo mondo del poema che egli si cimenterà nella ri-mappatura dell’Italia, dopo l’esperimento cartografico interrotto del suo trattato linguistico, il De vulgari eloquentia15. Infatti spiegare la parola umile, come è di solito interpretata, come riferita semplicemente allo stato abietto dell’Italia significa perdere la risonanza geografica dell’agget-tivo all’interno dello specifico contesto retorico della Comedìa cri-stiana di Dante. Infatti, «umile Italia» (l’Italia che si trova in basso) descrive un programma poetico che Dante sviluppa sia cartografica-mente sia retoricamente nella rappresentazione dell’Italia e di luoghi italiani nel poema. In altre parole, Dante sacralizza l’Italia territo-rialmente in senso cristiano per mezzo del poema. Pertanto, non solo Troiani e Latini, ma implicitamente tutti i Guelfi e i Ghibellini d’Italia, sono reinterpretati come martiri italiani dalla prospettiva della storia salvifica che ha mutato il suo centro geografico dalla Terra Santa alla penisola italiana. Per Dante, in continuità con la poetica biblica del sermo humilis che informava la sua epica cristiana, le umili, basse co-ste d’Italia, non meno che l’umile mangiatoia a Betlemme, si ergono a testimoni dell’Incarnazione e della promessa della redenzione finale16. Di conseguenza, come ogni lingua e stile sono degni di essere registrati
15. Si veda C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Torino 1951, p. 36, per il quale Dante: «(…) ormai solo e “lungi dal lito” (…) muove alla scoperta di un mondo nuovo. Questo mondo è anche l’Italia: geograficamente la stessa del De Vulgari (…) ma non più soltanto l’Italia aristocratica e curiale cui potevasi accedere per la via del linguaggio e dello stile tragico, proposti nel De Vulgari, bensì l’umile e vasta Italia cui appella la ‘cantilena’ della Commedia».
16. Sul sermo humilis scritturale come fonte della poetica di Dante, si veda il classico saggio di E. Auerbach, Neue Dantestudien : Sacrae scripturae sermo humilis. Figura. Franz von Assisi in der Komödie, Istanbul 1944.
Theodore J. Cachey Jr238
dal poema, così ogni luogo ha il diritto di essere incluso nel poema in-terpretato come una mappa. Parole che il De vulgari eloquentia evita-va, come introcque in posizione rimica nell’ultimo verso di If 20 (130: «Sì mi parlava, ed andavamo introcque»), fanno la loro apparizione, allo stesso modo che umili luoghi come Gaville, che come introcque è messo in evidenza in un’analoga maniera, ostentata dall’essere posto nell’ultimo verso di If 25 (151: «l’altr’era quel che tu, Gaville, pia-gni»). La menzione dell’umile villaggio toscano è giustapposta niente meno che al colle Aventino nello stesso canto di Malebolge: «Lo mio maestro disse: “Questi è Caco, / che, sotto ’l sasso di Monte Aventino, / di sangue fece spesse volte laco.”» (If 25, 25-27), e quindi coincide con uno dei più importanti temi epico-geografici dell’Inferno, l’intrec-cio secondario del poema Ercole-Dante-Gerione17.
L’unione di contrastanti referenti geografici allude alla miscela retorica di stile alto e basso che è l’impronta caratteristica dei can-ti di Malebolge. Un criterio geo-retorico, per esempio, informa la giustapposizione nel primo dei canti di Malebolge (Inferno 18) tra l’Egeo di Giasone e le salse della Bologna di Venedico18, un contra-sto che prefigura quello tra l’eroico periplo del Mediterraneo di Ulis-se in Inferno 26 e la domestica corografia italiana della Romagna evocata nell’espisodio di Guido da Montefeltro di Inferno 27.
Generalmente parlando, una dimensione cartografica italiana dell’Inferno di Dante strutturalmente significativa è stata trascurata dagli studi danteschi perché non è stata riconosciuta la natura siste-matica del dispiegarsi delle similitudini corografiche e delle descri-
17. Per l’aspetto geografico dell’intreccio Ercole-Dante-Gerione nell’Inferno, si veda T. Cachey, Dante’s Journey Between Truth and Fiction: Geryon Revisited, in Dante da Firenze all’aldilà, Atti del terzo Seminario dantesco internazionale (Firenze, 9-11 giugno 2000), a c. di M. Picone, Firenze 2001, pp. 75-92.
18. If 18, 49-51: «se le fazion che porti non son false, / Venedico se’ tu Cac-cianemico. / Ma che ti mena a sì pungenti salse?». Dante gioca sul toponimo salse che contribuisce alla generale patina di dialetto bolognese del canto (sipa del verso 61 è antico dialetto bolognese per sì). Benvenuto da Imola, qui citato dal commento di Singleton, notò per primo: «volo te scire, quod Salse est quidam locus Bononiae concavus et declivus extra civitatem post et prope sanctam Mariam in Monte, in quem solebant abiici corpora desperatorum, foeneratorum, et aliorum infamatorum. Unde aliquando audivi pueros Bononiae dicentes unum alteri ad improperium: Tuus pater fuit proiectus ad Salsas. Ad propositum ergo autor vult dicere: Quid ducit te ad vallem tam infamem, sicut est vallis Salsarum apud patriam tuam?».
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 239
zioni dell’Italia. Per cominciare, appena oltrepassata la porta dell’In-ferno, Dante descrive le tombe degli Epicurei con una similitudine che paragona il loro cimitero ai cimiteri che si trovano vicino Pola e vicino Arles, in altre parole, rispettivamente ai confini di nord-est e di nord-ovest dell’Italia:
Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,sì com’ a Pola, presso del Carnaroch’ Italia chiude e suoi termini bagna,
fanno i sepulcri tutt’ il loco varo,così facevan quivi d’ogne parte,salvo che ’l modo v’ era più amaro.
(If 9, 112-114)
Marcando le frontiere settentrionali d’Italia in questa maniera, Dante stabilisce un orientamento diverso per la mappa d’Italia del poema in contrasto con quella del De vulgari eloquentia. Nel trattato linguistico la penisola era descritta come estesa da ovest a est («vi-delicet usque ad promontorium illud Ytalie qua sinus Adriatici maris incipit, et Siciliam»)19, in linea con le rappresentazioni cartografiche antiche e medievali del Mediterraneo; da cui anche la designazione convenzionale dell’Adriatico e del Tirreno come rispettivamente i mari alto e basso. Comunque Dante nella Commedia cambia l’orien-tamento della penisola da est-ovest a nord-sud cosicché, entrando nel basso Inferno, noi lettori ci troviamo a varcare i confini d’Italia da nord e diretti verso sud. In questo modo Dante pone la carta geo-grafica d’Italia e la carta geografica dell’Inferno, il cui principale
19. I confini d’Italia descritti nel De vulgari eloquentia (I, viii, 6) hanno un orientamento diverso rispetto a quelli descritti in If 9, 112-114, se si accetta il giudi-zio espresso da Mengaldo nel suo commento a questo passo controverso: «Istorum vero proferentes oc meridionalis Europe tenent partem occidentalem a Ianuensium finibus incipientes. Qui autem si dicunt a predictis finibus orientalem tenent, vide-licet usque ad promuntorium illud Ytalie qua sinus Adriatici maris incipit, et Sici-liam». Mengaldo, in D. Alighieri, De vulgari eloquentia a c. di P. V. Mengaldo (in Id., Opere minori, 2 voll., Milano-Napoli 1979, II, p. 68, n. 1), nota che delle varie identificazioni proposte per promuntorium illud … incipit, quella di Istria e speci-ficamente di Capo Promontorio (Andriani, Revelli, Vinay) è inaccettabile. Rimane il dubbio se Dante si riferisca qui alla Calabria meridionale (Catona? cfr. Pd 8, 62), che era l’opinione di Casella, il quale seguiva il commento di Giuliani, o a Capo d’Otranto, come sostenevano Magnaghi e Marigo.
Theodore J. Cachey Jr240
orientamento etico è definito dalla regola che quanto più si scende tanto peggiori sono il peccato e la pena, in generale allineamento.
Infatti, l’evocazione dei confini d’Italia alle porte di Dite è par-te di un sistema di corrispondenze cartografiche che emerge pro-gressivamente nelle similitudini che si susseguono dai cerchi della violenza, che segnano rispettivamente l’ingresso e l’uscita da quel territorio. La prima di queste è l’unica similitudine che ricorre nei quasi due canti di spazio testuale che la separano dalla similitudine di Pola e di Arles in If 9, 112-117, e che pertanto costituiscono la più lunga porzione di testo tra similitudini nell’intero poema20. Il cammino alpestre che il pellegrino e la guida incontrano all’inizio di Inferno 12, che segna la vera e propria entrata al settimo cerchio, è descritto come segue:
Era lo loco ov’ a scender la rivavenimmo, alpestro e, per quel che v’er’ anco,tal, ch’ogne vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fiancodi qua da Trento l’Adice percosse,o per tremoto o per sostegno manco, che da cima del monte, onde si mosse,al piano è sì la roccia discoscesa,ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse: cotal di quel burrato era la scesa;e ’n su la punta de la rotta laccal’infamïa di Creti era distesa
che fu concetta ne la falsa vacca.(If 12, 1-13)
Nei versi 4-6 Dante si riferisce alla cosiddetta slavina di Mar-co, un’immensa frana tra le città di Marco e Mori, tre miglia sotto Rovereto, sulla riva sinistra del fiume Adige. La tradizione esege-tica si biforca tra attribuire il passo a una fonte geografica libresca (Alberto Magno) e l’osservazione diretta del sito da parte di Dante,
20. Hollander nota nel suo commento che lo spazio tra If 9, 112-114 e If 12, 1-10 rappresenta «il più lungo intervallo tra similitudini nel poema eccetto per quel-lo tra Paradiso VI.1 e VIII.15 (a meno di voler contare il breve paragone in Par. VII. 8-9 come una similitudine)» (traduzione mia).
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 241
come se le due possibilità si escludessero a vicenda21. Di fatto, la conoscenza di Dante dell’Italia nelle sue caratteristiche fisiche de-rivava sia dai libri che dall’esperienza, e l’autorità delle sue descri-zioni dell’Italia, nella loro miscela di fonti testuali e osservazione empirica, può essere considerata moderna proprio perché si basa su questa combinazione.
Inoltre, se anche da una parte siamo abituati a pensare all’esilio come fondativo per la svolta poetica di Dante nel poema, d’altra par-te le implicazioni specificamente geografiche della “vita di Dante” e il ruolo della geografia nella costruzione della sua autorità letteraria rappresentano questioni cruciali non molto sviluppate dalla critica. Che Dante stesso considerasse questa dimensione della sua autorità culturale come vitale è evidente da un’opera tarda, la Questio de aqua et terra, scritta implicitamente in difesa della sostanza geo-fisica del poema allo stesso tempo in cui egli era impegnato a finire il Paradiso22.
Lo scenario settentrionale alpino della prima similitudine all’ini-zio del basso Inferno trova il suo appropriato complemento in una seconda similitudine più giù nella cartografia del poema. Ricorre in-fatti alla fine del cerchio della violenza nella cruciale transizione tra violenza e frode, e come preludio all’incontro con il mostro Gerione in Inferno 16:
Io lo seguiva, e poco eravam iti,che ’l suon de l’acqua n’era sì vicino,che per parlar saremmo a pena uditi.
21. Tipicamente, la tradizione esegetica fa notare in connessione con questo passo che Dante spesso utilizza elementi di paesaggio terrestre «per dare concretez-za realistica alla storia» (nelle parole di Nicola Fosca), così ignorando la possibilità che tali similitudini possano essere parte di una più ampia intenzione strutturale.
22. Sulla Questio de Aqua et Terra, si veda J. Freccero, Satan’s Fall and the Quaestio de aqua et terra, in «Italica», 38 (1961), pp. 99-115; e più recentemente F. Mazzoni, Dante “misuratore di mondi”, in Dante e la scienza, a c. di P. Boyde e V. Russo, Ravenna 1995, pp. 25-53, e Z. G. Baranski, I segni della creazione: il mistero della Questio de aqua et terra, in Id., Dante e i segni. Saggi per una storia intellettuale di Dante Alighieri, Napoli 2000, pp. 199-219, p. 159 (una versione precedente di questo studio è apparsa come Id., The mystery of Dante’s “Questio de aqua et terra”, in In amicizia. Essays in Honour of Giulio Lepschy, a c. di Z. G. Baranski e L. Pertile, Supplement to «The Italianist», 17 [1997], pp. 146-164).
Theodore J. Cachey Jr242
Come quel fiume c’ ha proprio camminoprima dal Monte Viso ’nver’ levante,da la sinistra costa d’Apennino,
che si chiama Acquacheta suso, avanteche si divalli giù nel basso letto,e a Forlì di quel nome è vacante,
rimbomba là sovra San Benedettode l’Alpe per cadere ad una scesaove dovea per mille esser recetto;
così, giù d’una ripa discoscesa,trovammo risonar quell’ acqua tinta,sì che ’n poc’ ora avria l’orecchia offesa.
(If 16, 91-105)
Questa similitudine segnala la transizione dal cerchio della vio-lenza, che finisce con una scogliera ripida su cui il Flegetonte forma una cascata, ai cerchi della frode. La cascata è appropriatamente pa-ragonata all’Acquacheta-Montone in piena torrenziale e in partico-lare alle cascate del Montone vicine al monastero di San Benedetto in Alpe. Dopo aver incontrato all’inizio del settimo cerchio una si-militudine che alludeva alla violenza tellurica di un terremoto o di una frana sulle Alpi, qui alla fine del settimo cerchio, la violenta pie-na di un fiume sugli Appennini serve da veicolo appropriato per una similitudine che segna i confini tra due diverse regioni dell’Inferno. Soffermandosi in particolare sul frastuono delle acque scroscianti, come notano Durling e Martinez23 (al seguito di Vellutello), Dan-te implicitamente suggerisce un paragone con le cateratte del Nilo, che, secondo il Somnium Scipionis (5. 3), rendono gli abitanti di quei luoghi sordi, e il cui suono Macrobio paragonò negativamente (Commentarii 2. 4. 14) alla musica delle sfere24.
23. D. Alighieri, The Divine Comedy of Dante Alighieri. Inferno, a c. di R. M. Durling e R. D. Martinez, 3 voll., New York-Oxford 1996, I, p. 257.
24. Anche per Nohrnberg, in J. Nohrnberg, Canto XVIII. Introduction to Malebolge, in Lectura Dantis: Inferno, a c. di A. Mandelbaum, A. Oldcorn e C. Ross, Berkeley 1999, pp. 238-261 (in particolare p. 242), l’allusione sarebbe un’al-lusione negativa e parodica alla musica delle sfere discussa da Macrobio. La con-nessione col Somnium Scipionis di Cicerone notata da Durling e Martinez nel loro commento, Alighieri, The Divine Comedy cit., p. 257, era stata osservata per la prima volta da Alessandro Vellutello (1544), If 16, 100-105: «Onde dicono, che
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 243
Tuttavia, il carattere geo-cartografico messo ostentatamente in evidenza non è stato molto apprezzato da una tradizione esegetica che ha ignorato la funzione strutturale del passo. Sapegno lo consi-derava «troppo lungo», mentre Bosco e Reggio trovavano che «gli incisi che vogliono essere precisazione geografica, (…) indubbia-mente appesantiscono, e un po’ intralciano il corso del pensiero», Momigliano criticò la pesantezza del lungo «periodo appesantito dalle inutili determinazioni geografiche delle prime due terzine». Mestica lamentò che la similitudine «è un po’ troppo particolareggia-ta; ma Dante molto si compiace e spesso s’indugia nella descrizione dei luoghi da lui veduti col metterne in evidenza le particolarità ad essi attinenti, anche se non sono in istretta relazione col soggetto principale». Di fatto la rappresentazione geografica dell’Italia di Dante, nella sua sintetica descrizione dei sistemi montuosi e idro-grafici dell’Italia del centro-nord, qui va al di là delle descrizioni cartografiche e geografiche che ci sono giunte da quell’epoca25. Il fatto è che manca davvero una fonte letteraria o, che io sappia, una mappa che possa essere indicata come fonte di Dante. La similitudi-ne cattura implicitamente l’intera valle del Po in una rimarchevole prospettiva cartografica a volo d’uccello a partire dalle sorgenti del Po in Piemonte (Monte Veso, v. 95). Identifica il primo dei fiumi sul lato sinistro degli Appennini che non fluisce nel Po e quindi segna un preciso confine geo-fisico26. Inoltre, la similitudine è perfettamen-
gli habitatori vicino alle catarate del Nilo, per lo troppo eccessivo suono, che fa nel cader d’altissimo monte, assordano. Et questo afferma Marco Tullio, in quel de somnio Scipionis, ove dice “Sicut in illis ubi Nilus ab illa, quae Catapulta nomina-tur, praecipitat ex altissimis montibus, ea gens, quae illum locum accolit, propter magnitudinem sonitus sensu audiendi caret [Cic. De re pub. 6.19]”».
25. Singleton nota: «Il fiume al quale si riferisce Dante è il Montone, che nasce come torrente negli Appennini orientali, a circa sei miglia dal monastero be-nedettino di San Benedetto dell’Alpe, vicino al quale si unisce ai torrenti di Ac-quacheta e Riodestro. A Forlì e Ravenna si unisce ad altri due corsi d’acqua, ed entra nell’Adriatico sopra Sant’Apollinare. Al tempo di Dante il Montone sfociava nell’Adriatico sotto il Po ed era quindi il primo fiume dopo il Po che, nascendo sul versante orientale degli Appennini, fluiva nel mare (tutti gli altri fluivano nel Po)» (traduzione mia).
26. Dante anticipa la vista dall’alto di una Google Map. Si veda http://en.wikipedia.org/wiki/Montone_River. Si noti la parallela inclusione del Po nella successiva similitudine di Marcabò in If 28, 73-75: «rimembriti di Pier da Medi-
Theodore J. Cachey Jr244
te funzionale da un punto di vista strutturale, tematico e narrativo. Come notò Benvenuto da Imola, i cambiamenti di nome dello stesso fiume che Dante descrive (da Acquacheta a Montone) trovano corri-spondenza nei cambiamenti di nome del fiume infernale, e anticipa-no il cambiamento di nome che il fiume Flegetonte subirà diventan-do il Cocito quando raggiungerà il fondo dell’Inferno.
Ma perché Dante, potrebbe chiedersi il lettore, introduce simili-tudini corografiche in senso strutturale e cartografico solo a comin-ciare dai cerchi della violenza? Tenendo a mente la generale strut-tura etica del poema secondo la quale scendere è andare di male in peggio, il significato polemico della corrispondenza che Dante trac-cia tra la mappa d’Italia e il più basso Inferno è evidente. Inoltre, nei termini di quella stessa struttura etica, ci si potrebbe bene aspettare che i peccati dell’appetito concupiscente fossero meno differenziati in termini geografici e linguistici rispetto ai peccati del basso Infer-no, perché i primi rappresentano l’espressione degli aspetti più bassi della natura umana. Dante sembra voler dire che mentre l’espressio-ne dell’appetito concupiscente, cioè la ricerca di cibo e sesso e di altri beni come se fossero cibo e sesso, rappresenta una disposizione peccaminosa che si trova senza distinzione in tutto il genere umano, gli italiani si distinguono particolarmente per i peccati di violenza e specialmente di frode. Di conseguenza, quando il ritratto antro-pologico dantesco del peccato sale lungo la catena dell’essere, cioè quando scendiamo più in basso nell’Inferno, l’Italia e i suoi spazi (e le sue lingue) diventano cruciali.
Da un punto di vista geo-cartografico, si può tracciare un’affasci-nante analogia tra la transizione dall’alto al basso Inferno e la transi-zione tra i capitoli biblici e i capitoli italiani del De vulgari eloquentia, la prima importante incursione di Dante nel genere della scrittura car-tografica. Esiste un abbozzo di analogia strutturale tra la parte superio-re dell’Inferno e quei capitoli che Dante dedica alla discussione geo-cartografica della linguistica biblica (I i-ix), in particolare alla storia di Babele, i quali offrono le premesse strutturali e storiche alla tratta-zione della situazione linguistica italiana che emerge alla fine come
cina, / se mai torni a veder lo dolce piano / che da Vercelli a Marcabò dichina». Si veda anche I. Baldelli, Lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina: Inferno XXVIII, 74-75, in «Lettere Italiane», 47 (1995), pp. 193-202.
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 245
l’argomento specifico del trattato27. Infatti, le caratteristiche istintuali e intellettuali carenti dei peccati dell’appetito concupiscente puniti nella parte superiore dell’Inferno corrispondono eticamente all’universale stato di confusione che inizialmente derivò da Babele. Questa fase è cronologicamente, spazialmente ed eticamente antecedente alla situa-zione linguistica italiana dal punto di vista razionale e scientifico del trattato. La differenziazione delle lingue d’Italia pertanto corrisponde ad un più alto livello di sviluppo umano, le cui elaborazioni lingui-stiche e intellettuali peccaminose sono esplorate rispettivamente nei capitoli xi-xv del trattato e nel settimo e ottavo cerchio dell’Inferno.
Nella transizione dal trattato al poema, la tassonomia scientifica e razionale del trattato subisce una traduzione etica. Si può dire che l’Inferno rimappi il De vulgari eloquentia in senso morale-allegorico. L’ingresso al basso Inferno corrisponde al punto del trattato in cui l’Italia diventa il centro e il soggetto della descrizione cartografica; di conseguenza Malebolge si rivelerà come la regione del poema dove il dialogo tra il De vulgari eloquentia e l’Inferno è più intenso, e raggiunge una sorta di crescendo. Dante esplora diverse mappature dell’Italia nei due testi: potremmo dire che la mappatura cartografica-
27. La mia proposta trova supporto nel lavoro di studiosi che si sono concentra-ti sulla relazione tra la Babele biblica e quella dell’Inferno di Dante. In particolare, il saggio di Baranski del 1989, Z. G. Baranski, Divine, Human and Animal Languages in Dante: Notes on De Vulgari Eloquentia I i-ix and the Bible, in «Transactions of the Philological Society», 87 (1989), 2, pp. 205-231, ha importanti implicazioni per la riscrittura cartografica del De vulgari eloquentia che ho sviluppato qui come una chiave di lettura del poema. Secondo Baranski Babele «ha un’influenza importante sulla percezione artistica di Dante del suo primo regno oltremondano» e «il suo Inferno è presentato come un mondo senza senso di confuse voci balbettanti» sin dal principio. Più in particolare, Baranski nota che «L’equazione tra la confusione di lingue nella “valle” del Senaar e il “ ’ntrono (…) d’infiniti guai” della “valle do-lorosa” di Dante (If IV 8-9) è più evidente in Inferno III-VII (p. 278)», e che «Dopo questa infernale confusio linguarum, dal canto VIII in poi, si può dire che un certo silenzio scenda sull’Inferno di Dante», (traduzione mia). La confusio linguarum del-la parte superiore dell’Inferno corrisponde allo stato etico relativamente non evolu-to dei peccatori lì puniti, dove i rumori che giungono alle orecchie del pellegrino appartengono, come mostra Baranski, alla categoria semiotica dei segni “naturali” che, secondo Jan Pinborg «sono comuni a tutti gli uomini e non dipendono da alcuna convenzione. Generalmente, sono paragonati ai versi di animali che sono pertanto inclusi nella stessa categoria», J. Pinborg, Medieval Semantics, a c. di S. Ebbesen, London 1984, p. 407 (traduzione mia).
Theodore J. Cachey Jr246
mente “realistica” dell’Italia che caratterizza quei capitoli del trattato dedicati alla ricerca del “volgare illustre” (De vulgari eloquentia xi-xv) è caleidoscopicamente riconfigurata nella rappresentazione poeti-ca del viaggio del pellegrino attraverso l’ottavo cerchio. Nel viaggio toscano-centrico di Malebolge, il poeta esplorerà ed esprimerà i con-torni più soggettivi della sua mentale mappa d’Italia.
Ma la più ampia, più istituzionale ri-mappatura d’Italia del poe-ma, cominciata appena al di là delle porte del basso Inferno e con-tinuata nel settimo cerchio, è completata solo nell’ottavo cerchio. Questo accade specificamente all’inizio di Inferno 28, dove l’Italia del sud è associata all’Italia alpina e appenninica a turno messe in risalto dalle similitudini del settimo cerchio:
Chi poria mai pur con parole scioltedicer del sangue e de le piaghe a pienoch’i’ ora vidi, per narrar più volte?
Ogne lingua per certo verria menoper lo nostro sermone e per la mentec’hanno a tanto comprender poco seno.
S’el s’aunasse ancor tutta la genteche già, in su la fortunata terradi Puglia, fu del suo sangue dolente
per li Troiani e per la lunga guerrache de l’anella fé sì alte spoglie,come Livïo scrive, che non erra,
con quella che sentio di colpi doglieper contastare a Ruberto Guiscardo;e l’altra il cui ossame ancor s’accoglie
a Ceperan, là dove fu bugiardociascun Pugliese, e là da Tagliacozzo,dove sanz’ arme vinse il vecchio Alardo;
e qual forato suo membro e qual mozzomostrasse, d’aequar sarebbe nullail modo de la nona bolgia sozzo.
(If 28, 1-21)
Mentre le similitudini del settimo cerchio sono basate rispetti-vamente su frane rovinose sulle Alpi e fiumi straripanti negli Appen-nini, qui le pianure della Puglia (che metonimicamente indica tutto
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 247
il sud Italia) assistono come testimoni silenziosi ad una carneficina caratteristicamente umana, un cambiamento di prospettiva dalla na-tura alla cultura coerente con la transizione dalla violenza alla frode in quanto riflette la maggiore umanità del peccato dei fraudolenti se-minatori di discordia. Persino l’ipotetica forma della similitudine è coerente con il più alto livello di complessità intellettuale e retorica caratteristica dei canti di Malebolge. Si può dire che questa ipote-tica similitudine epica in apertura di Inferno 28 rappresenti la meta all’interno del contesto dell’Inferno per il tema della sacra umile Italia annunciato in Inferno 1 dalla tragica evocazione dei martiri virgiliani d’Italia: «per cui morì la vergine Cammilla, / Eurialo e Turno e Niso di ferute» (If 1, 107-108).
Ma è necessario fare ancora una precisazione prima di tornare ad affrontare il problema di mappare Malebolge, che era il nostro punto di partenza. I luoghi italiani descritti nel settimo cerchio, bisogne-rebbe ricordare, erano tutti evocati nel contesto delle similitudini. Al contrario, i maggiori passi italiani corografici di Malebolge – che in-cludono il territorio alpino intorno a Mantova minutamente descritto da Virgilio in If 20, 61-87 e il riconoscimento geo-politico della con-temporanea Romagna appenninica riportato dal pellegrino a Guido da Montefeltro in If 27, 25-54 – presentano descrizioni dettagliate del mondo geo-fisico soprastante, al di fuori del poema. Il racconto dantesco della fondazione di Mantova, che Dante mette in bocca a Virgilio e che include una descrizione geo-storica dettagliata di una parte dell’Italia alpina, è costruito al fine di sostenere la pretesa ve-rità della Commedia in contrasto con il racconto della fondazione di Mantova dato nella tragedia di Virgilio che Dante qui corregge28. Il livello di elaborazione e complessità culturale e geografica che ca-ratterizza questi esempi di scrittura coro-cartografica di Malebolge è molto maggiore di quello che abbiamo incontrato precedentemente, sia in termini di sostanza dei passi che del modo in cui questi sono collegati alla struttura ideologica del poema. Questa dimensione dal valore aggiunto caratterizza anche la dettagliata descriptio corogra-
28. Dante attribuisce alla sua guida in Inferno 20 un racconto della fondazio-ne di Mantova che è incoerente con quello che il poeta Virgilio aveva presentato nell’Eneide (X 198-200). Si veda R. Hollander, The Tragedy of Divination in Infer-no XX, in Id., Studies in Dante, Ravenna 1980, pp. 131-218.
Theodore J. Cachey Jr248
fica della Romagna in Inferno 27, dove Dante poeta, in una sorta di pre-figurazione di Machiavelli, offre in un tour de force una revi-sione geo-politica del contemporaneo stato di Romagna. Infatti, se la scrittura cartografica di Inferno 20 ha la sua fonte nel sottogenere epico del racconto geografico della fondazione di città e territori, la scrittura geo-politica di Dante in Inferno 27 anticipa invece le scrit-ture politiche moderne di un Machiavelli nei suoi dispacci ai Dieci di Firenze a proposito dei movimenti di Cesare Borgia in Romagna, o persino lo stesso Principe, dove il principe deve «in questo porre grandissima cura», cioè nell’«imparare la natura de’ siti, e conoscere come surgono e’ monti, come imboccano le valle, come iaciono e’ piani, e intendere la natura de’ fiumi e de’ paduli» (Capitolo XIV: Quod principem deceat circa militiam)29.
Entrambi i maggiori passi cartografici di Malebolge, sebbene apparentemente tangenziali rispetto alla maggiore linea dell’argo-mento del poema, sono di fatto strategicamente collocati nelle bolge dedicate rispettivamente ai falsi profeti e ai consiglieri fraudolenti, bolge che implicano più direttamente i rischi che Dante poeta cor-reva in primo luogo nello scrivere il poema. In entrambi i conte-sti lo sfoggio di conoscenza e persuasività di Dante, come autorità carto-geografica, serve implicitamente a reiterare la buona fede del proprio stato morale e delle proprie intenzioni, e la verità del poema in netto contrasto con l’ambiente infernale fraudolento dell’ottavo cerchio. Se un aspetto caratteristico della letteratura epica da Gil-gamesh a Omero a Virgilio a Melville è l’autorità in questioni ge-ografiche, la necessità di fondare il poema sulla realtà geo-fisica di questo mondo era forse ancora più grande per Dante, il quale si era impegnato a rappresentare ai suoi lettori niente meno che i tre regni oltremondani30.
29. Niccolò Machiavelli, Il Principe, a c. di G. Inglese, Torino 1995, capitolo XIV.
30. Per una prospettiva antropologica sui legami tra geografia, viaggio e auto-rità culturale, si veda l’ormai classico studio di M. W. Helm, Ulysses’ Sail. An Eth-nographic Odyssey of Power, Knowledge and Geographical Distance, Princeton 1988. Per esempi di un approccio geografico alla letteratura si veda W. Herendeen, From Landscape to Literature. The River and the Myth of Geography, Pittsburgh 1986, e J. Romm, The Edges of the Earth in Ancient Thought. Geography, Explo-ration and Fiction, Princeton 1994. Per un’ancor utile ricognizione bibliografica
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 249
Generalmente parlando, il modo in cui le descrizioni degli spa-zi dell’Inferno e le descrizioni dello spazio al di fuori del poema si rinforzano a vicenda a sostegno della pretesa di verità del poema raggiunge nuovi livelli di complicazione nell’ottavo cerchio. Ce lo dovremmo aspettare, dati, da un lato, la natura intellettuale del pec-cato di frode e dall’altro la natura non fraudolenta della finzione del poema, il suo status di «non falso errore»31. La composizione del poema come un territorio fisico o un vero spazio emerge come una preoccupazione primaria del poeta in Malebolge e diventa esplicita, per esempio, nello straordinario exordium di Inferno 20: «Di nova pena mi conven far versi / e dar materia al ventesimo canto / della prima canzon, ch’è de’ sommersi» (If 20, 1-3), che è, come ha notato Teodolinda Barolini, il «solo luogo nel poema dove Dante esplicita il numero di un canto»32. Di conseguenza, la questione dei criteri che guidano la proporzione che il poeta stabilisce tra le dieci bolge dello spazio fisico di Malebolge e i tredici canti che Dante compone per descrivere quello spazio non può essere tralasciata.
3. Mappando Malebolge
Nella parte finale di questo saggio, propongo una tabella preli-minare della topografia dell’ottavo cerchio, e suggerisco come po-
si veda F. Lando, Fact and Fiction. Geography and Literature. A Bibliographic Survey, in «GeoJournal» 38 (1996), 1, pp. 3-18.
31. Si vedano T. Barolini, Detheologizing Dante: For a ‘New Formalism’ in Dante Studies, in «Quaderni d’Italianistica: Official Journal of the Canadian Society for Italian Studies», 10 (1989), 1-2, pp. 35-53, e The Undivine Comedy: Detheologiz-ing Dante, Princeton 1992, e C. Moevs, God’s Feet and Hands (Paradiso 4.40-48): Non-duality and Non-false Errors, in «Modern Language Notes», 114 (1999), 1, pp. 1-13, sul poema di Dante come «non-false error». Per Moevs «La revisione della Barolini della formula di Singleton è esatta: “la Commedia è un non falso errore, non una finzione che finge di essere vera ma una finzione che È vera “ (p. 13). Questo è il modo in cui Dante intende il suo poema. Ed è anche il modo in cui egli intende – e questo è il punto fondamentale – tutta la realtà fisica: una forma contingente che maschera l’atto di essere in cui essa sola e interamente consiste. È anche la natura della Scrittura, che deve comunicare l’esperienza di non-contingente coscienza di sé (“verità”) attraverso contingenze spazio-temporali (…)», p. 8, (traduzione mia).
32. T. Barolini, Canto XX: True and False See-ers, in Lectura Dantis: Inferno cit., pp. 275-286 (in part. p. 276).
Theodore J. Cachey Jr250
trebbe essere utilizzata per intraprendere letture più dettagliate della mappa mentale d’Italia del poeta. L’anomalia di Inferno 18, come abbiamo notato all’inizio, segnala che la mancanza di corrisponden-za tra le dieci bolge della topografia di Malebolge e i tredici canti della sua descriptio poetica (Inferno 18-30) è di natura program-matica. Mappando l’alternanza di canti che trattano di una bolgia, con quelli che trattano di due bolge, emergono vari modelli e si può distinguere una struttura o un piano architettonico per Malebolge nella sua interezza:
I-II III IV V VI VII VIII IX X
2 1 1 1 1 1 1 1 1
– – – – – – – – –
1 1 1 2 1 2 2 1 2
18 19 20 21 23 24 26 28 29
22 25 27 30
Vi sono almeno due modelli ai quali presterei attenzione. Prima di tutto c’è la divisione dei tredici canti in due segmenti di cinque e otto canti ciascuno, che corrispondono rispettivamente alle prime cinque e alle seconde cinque bolge di Malebolge. In altre parole, i primi cinque canti (18, 19, 20, 21, 22) coprono cinque bolge o la metà di Malebolge in termini di territorio, mentre ci vogliono otto canti (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) per coprire le rimanenti bolge dell’ottavo cerchio. In secondo luogo, c’è una simmetria quasi chia-smica nell’alternanza tra bolge di cui si tratta in un canto e bolge di cui si tratta in due canti. La proporzione di due a uno dell’anomalo Inferno 18, che tratta sia dei seduttori che dei lusingatori, è rovescia-ta dalla proporzione di uno a due di Inferno 29 e 30, che trattano dei falsari. Il rovesciamento di proporzioni che incornicia l’intera strut-tura è ricapitolato nel rovesciamento di proporzioni nei segmenti che coprono rispettivamente le bolge III-V e VII-IX. Nel primo tro-viamo due bolge di Malebolge (simoniaci e indovini) trattate ciascu-
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 251
na in un canto (19 e 20), seguite da una bolgia (quella dei barattieri) trattata in due canti (21 e 22). Dopo una bolgia (VI, ipocriti) trattata in un canto (24), lo stesso modello è ripetuto nel segmento succes-sivo, ma seguendo un ordine inverso: una bolgia (ladri) è svolta in due canti (24 e 25). Questa è seguita da una bolgia (consiglieri frau-dolenti) trattata in due canti (26 e 27), e una terza bolgia (seminatori di discordia) è coperta in un canto (28). Questo modello ai due lati del canto 23, insieme al rovesciamento di proporzione che inquadra l’ottavo cerchio ai due estremi, converge attorno al canto centrale degli ipocriti, al quale ritornerò.
Ma prima, voglio evidenziare la generale struttura di 5+8 = 13 canti e le considerevoli implicazioni metaletterarie di quella pro-porzione. Perché la proporzione di 5 / 8 nella struttura dei tredici canti di Malebolge non è mai stata notata prima, per quanto ne so. Pertanto la corrispondenza tra questa struttura e quella che i Gre-ci chiamarono la sezione o proporzione aurea, conosciuta anche come proporzione estrema e media non è stata precedentemente considerata e valutata per le sue implicazioni critiche. Questa pro-porzione si ottiene dividendo una linea in modo tale che la parte più piccola sta a quella più grande come la più grande sta all’in-tero. La condizione si applica alla proporzione che costituisce la struttura dei canti di Malebolge dal momento che 5 sta a 8 (appros-simativamente) come 8 sta a 13. Inoltre, 5, 8 e 13 sono numeri che ricorrono in quella che è conosciuta come la sequenza di Fibonac-ci, che prende il nome dal matematico medievale Leonardo da Pisa (conosciuto anche come Fibonacci, da figlio di Bonacci) il quale al principio del XIII secolo aveva presentato la prima sequenza di numeri ricorsivi conosciuta in Europa33.
33. I matematici ci informano che la sequenza di proporzioni dei numeri con-secutivi di Fibonacci (1/1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13….) si avvicina ad un sin-golo numero reale al quale i termini della sequenza si avvicinano sempre di più, in modo arbitrario. Gli antichi Greci chiamarono questo numero sezione aurea che è di solito indicata dalla lettera greca φ (phi) e a volte dalla lettera µ (mi). Credevano che la proporzione phi fosse la più gradevole ed esteticamente perfetta, e la loro arte, la scultura e l’architettura ne facevano uso. Per una recente rassegna della questione si veda V. Hösle, Did the Greeks Deliberately Use the Golden Ratio in An Artwork?, in «Parola del passato. Rivista di studi antichi», 362-363 (2008), pp. 415-426, il quale sostiene l’uso intenzionale della sezione aurea da parte dei Greci. Si veda
Theodore J. Cachey Jr252
L’ordinamento dantesco dei canti di Malebolge secondo la pro-porzione della sezione aurea è ispirato dallo stesso tipo di poetica geometrica che motivava l’uso di varie approssimazioni di π nel di-segno complessivo del poema. Infatti, Thomas Elwood Hart ha con-vincentemente svelato l’uso dantesco di corrispondenze o modelli relativi alle costanti geometriche come π nel posizionamento di certi passi, parole e rime34. Le sue scoperte ci incoraggiano ad avanzare l’ipotesi che preoccupazioni geometriche, come quelle a livello del-la macro struttura del poema, informino anche la struttura del trat-
anche M. Livio, The Golden Ratio. The Story of Phi, the World’s Most Astonishing Number, New York 2002. Secondo Joseph e Frances Gies, i biografi di Leonardo da Pisa, gli architetti ancora oggi «spesso approssimano la proporzione a 5/8 (0.625) - essendo 5 e 8 due numeri della sequenza di Fibonacci», in J. e F. Gies, Leonard of Pisa and the New Mathematics of the Middle Ages, New York 1969. Per Fibonacci, si vedano Leonardo Fibonacci. Matematica e società nel Mediterraneo nel seco-lo XIII, Atti del Convegno internazionale di studi (Pisa-Firenze, 20-23 novembre 2002), in «Bollettino di Storia delle scienze matematiche», 23 (2003), 2 (prima parte) e 24 (2004), 1 (seconda parte), e P. Hemenway, Divine proportion: Phi in art, nature, and science, New York 2005. Se Dante conoscesse o meno il lavoro matematico di Fibonacci è argomento controverso. Maracchia, in S. Maracchia, Dante e la matematica, in «Archimede», 31 (1979), pp. 195-208, è convinto che lo conoscesse, mentre Hart è più scettico e sostiene che non abbiamo prove di questo. Nondimeno, nei suoi fondamentali studi che illustrano in modo convincente l’uso che Dante fece di π nel suo disegno del poema, Hart trovò alcuni valori di π utiliz-zati da Dante nel posizionamento secondo proporzione di alcuni passi, che potrebbe riflettere la conoscenza di Dante della Practica geometriae di Fibonacci, per cui si veda T. E. Hart, “Per Misurar Lo Cerchio” (Par. XXXIII 134) and Archimedes’ De Mensura Circuli: Some Thoughts on Approximations to the Value of π, in Dante e la scienza cit., pp. 265-335 (in particolare pp. 286-289).
34. Hart offre osservazioni generali riguardanti l’estetica della strutturazione numerica e geometrica nelle arti nel periodo medievale, osservando che: «La pre-senza di (in parte geometrica) proporzionalità che governa sia apertamente che meno apertamente contesti ‘geometrici’ nella Commedia indica che Dante emulava la ‘geo-metria e la logica eterna della creazione’ tra le altre cose utilizzando le dimensioni fisiche del suo testo come una sorta di sintassi per metafore strutturali, cioè, come un mezzo per dire una cosa in altri termini giustapponendo entrambi i termini struttu-ralmente in modelli proporzionali. Come risultato, le ‘linee’ o ‘vettori’ del suo dise-gno potrebbero servire quasi come una specie di commento dell’autore al poema, al punto di essere fattori fondamentali nella genesi del poema», T. E. Hart, Geometric Metaphor and Proportional Design in Dante’s Commedia, in The Divine Comedy and the Encyclopedia of the Arts and Sciences, a c. di G. Di Scipio e A. Scaglione, Amsterdam-Philadelpia 1988, pp. 95-146 (in part. p. 129, traduzione mia).
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 253
tamento poetico di Malebolge, in modo tale da implicare più ampie questioni di poetica, incluse la relazione putativa del poema con la giustizia divina e la sua pretesa di verità. Infatti, nella composizione del suo poema, Dante aveva cercato di imitare il divino geometra: «(…) “Colui che volse il sesto / a lo stremo del mondo, e dentro ad esso / distinse tanto occulto e manifesto» (Pd 19, 40-42). L’assetto proporzionale dei canti di Malebolge, come le approssimazioni di π nello stabilire i confini del poema e la disposizione dei luoghi al suo interno, riflettono l’imitazione che Dante fece dell’arte di Dio, la geometria, nella costruzione del poema. I criteri artistici che gui-dano la costruzione degli spazi testuali del poema, sono informati da concezioni geometriche, la quadratura del cerchio e la sezione aurea (phi) che alludono da una parte ai parametri ineffabili della creazio-ne di Dio e dall’altra al carattere impenetrabile della Sua giustizia35.
In verità, si trova che il numero e le misurazioni matematiche hanno implicazioni diverse per l’interpretazione di Malebolge, che dipendono dal tipo di cartografia ermeneutica applicato alla loro analisi. È dunque essenziale tenere a mente la distinzione che ab-biamo tracciato qui tra lo spazio fisico fittizio dell’Inferno e il te-sto stesso come costruzione spaziale. Le circonferenze del nono e decimo cerchio di 22 e 11 miglia ad esempio, come registrato in If 29, 7-9 e If 30, 82-87 ispirò i cartografi del Rinascimento a ten-tare di mappare «il sito, la misura, e le dimensioni» dell’Inferno. E tuttavia tali tentativi si sono rivelati assolutamente incongrui e inutili allo scopo, come ha dimostrato John Kleiner36. Hart, d’altro
35. Il legame fondamentale tra la geometria e la giustizia divina nella mente di Dante era originariamente derivato dal fatto che, come scrive Giuseppe Mazzotta, «come la geometria, la giustizia non è né casuale, né vulnerabile ai capricci caotici e alle incoerenze dell’opinione. Come la geometria, che è basata sulla legge dell’in-ferenza, secondo cui un punto nello spazio comporta altri punti, la giustizia unisce l’anima individuale alla città e all’interezza del cosmo», in G. Mazzotta, Dante’s Vision and the Circle of Knowledge, Princeton 1993, p. 87 (traduzione mia).
36. In un penetrante capitolo, Mismapping the Underworld, dal volume epo-nimo, Kleiner nota che l’enfasi sulla misurazione aumenta quanto più discendiamo nell’Inferno, in particolare negli ultimi sei canti. Kleiner si concentra su due passi in cui parlano Virgilio e Maestro Adamo, rispettivamente nei canti 29 e 30, in cui sono date le misure precise della nona e della decima bolgia. Apprendiamo da Virgilio, in If 29, 9-10, che la nona bolgia ha una circonferenza di 22 miglia, mentre in If 30, 84-87 veniamo a sapere che la decima e ultima bolgia ha una circonferenza di
Theodore J. Cachey Jr254
canto, ha provato che le stesse due misurazioni da Inferno 29 e 30, che Kleiner ha trovato erronee e incoerenti, sono situate all’interno della topografia testuale del poema secondo una proporzione che è precisamente calibrata rispetto al principio e alla fine del poema e al principio e alla fine rispettivamente del Purgatorio e del Paradiso37.
Incongrui ed erronei allo scopo di tracciare una mappa rinascimen-tale dell’Inferno di Dante, i passi dei canti 29 e 30 sono nondimeno accurati per calcolare le misure della stessa Commedia. Servono a segnare i confini geometricamente proporzionali dello spazio testua-
undici miglia e un diametro di un miglio e mezzo. Kleiner discute come i cartografi rinascimentali dell’Inferno di Dante usarono queste misurazioni per estrapolarne il sito, la misura e le dimensioni, e mostra in modo convincente che, di fatto, l’uso di queste misure a questo scopo è piuttosto assurdo e conduce a impossibili incon-gruità così come le altre misurazioni fornite da Dante circa la misura dei giganti e di Lucifero, compresi i calcoli che egli ci invita ad estrapolare e che riguardano l’altezza di Nembrot che sarebbe basata sulla misura della «pina di San Pietro». La conclusione di Kleiner, oltre a mostrare perché «la cartografia dantesca rimanga oggi una disciplina profondamente screditata» è che «le misurazioni dell’Inferno producono solo una parvenza di ordine». Kleiner propone tre possibilità d’inter-pretazione a proposito di queste misure e preferisce l’ultima delle tre. Queste sono: a. che dando misure erronee Dante esprima dubbi a proposito della giustizia divi-na, o b. che le misure erronee riflettano una prospettiva infernale, o c. che Dante stia parodiando le sue stesse pretese di giudicare i suoi simili. Kleiner arriva alla conclusione che Dante ha un certo gusto per l’autocritica: «Nominare quelli che saranno dannati e quantificare le loro ‘giuste’ punizioni per tutta l’eternità significa avvicinarsi simultaneamente alla frode [Maestro Adamo] e alla hybris [Nembrot]», in Kleiner, Mismapping the Underworld cit., p. 55 (traduzione mia).
37. In “Per Misurar lo Cerchio” cit., pp. 282-283, e in Figure 3A e 3B, Hart dimostra proporzionalità e omologia nella disposizione dei due passi che indicano le dimensioni della nona e della decima bolgia: «Il posizionamento dei due termini numerici, relativi ai limiti delle tre cantiche, è conforme alle proporzioni dei due cerchi concentrici con le circonferenze (approssimativamente) di ventidue e undici ‘miglia’, come segue: se il cerchio più largo ha le dimensioni di circonferenza + diametro = 14233 (il totale dei versi nella Commedia corrispondente a 29.000 ‘mi-glia’ [circonferenza + diametro della bolgia 9] nella Figura 3A), il cerchio più pic-colo ha, rispetto al numero intero più vicino, una circonferenza di 5398 ‘versi’ (cor-rispondente quasi a 11.000 ‘miglia’ [circonferenza della bolgia 10] in Figura 3 A) e un raggio di 859 ‘versi’ (859 è anche la distanza tra i due cerchi, corrispondente a 1.750 ‘miglia’ [raggio della bolgia 10] in Figura 3A», (traduzione mia). Hart scopre che ci sono di conseguenza 859 versi tra la posizione della prima misurazione in Inferno 29 e la fine dell’Inferno e l’inizio del Purgatorio e ci sono 5398 versi tra la seconda misurazione in Inferno 30 e la fine del Purgatorio e l’inizio del Paradiso.
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 255
le del poema, e pertanto servono ad autorizzare quello spazio come costitutivo di un “artefatto” divinamente imitativo e ispirato. Dante reitera nella sua poetica geometrica in Malebolge la stessa afferma-zione già fatta nel rivendicare la verità del poema in congiunzione con l’apparizione del suo ostentatamente fittizio simbolo di frode, il mostro Gerione, un’invenzione esemplare dell’arte di Dante, che è “quasi nepote” di quella di Dio (If 11, 105). Se ad un certo livel-lo il poema deve essere considerato come una finzione, nondimeno esso rappresenta un «non falso errore» e una più alta dimensione di verità. Proprio come il fittizio Gerione è un prodotto meraviglio-so dell’invenzione divinamente ispirata e quindi fondamentalmente vera di Dante, il poema stesso, come spazio testuale, è autorizzato dalla sua poetica geometrica, compresa la disposizione di passi a seconda delle varie approssimazioni di π e la struttura 5+8 = 13 che Dante poeta dà a Malebolge.
Da un lato, la struttura espressa dalla proporzione di 5 / 8 dei 13 canti di Malebolge ha l’effetto metaletterario di segnalare che una proporzione geometrica ineffabile ispira il trattamento poetico delle dieci bolge; d’altro canto l’ordinamento “a griglia” dell’ottavo cerchio che abbiamo mappato prima serve allo scopo più pratico di ordinare lo spazio fisico dell’Inferno (e lo spazio fuori dell’Inferno) secondo un sistema di simmetrie e antinomie che sostengono una lettura etica del testo. Ma il valore ermeneutico di queste strutture per l’interpretazione del testo non è stato pienamente sviluppato, dal momento che la struttura stessa non è stata riconosciuta come un sistema topografico. In questo contesto, possiamo solo suggerire in termini generali come potrebbe essere intrapresa una lettura di Ma-lebolge attraverso la lente della cartografia ermeneutica.
Come notato prima, la proporzione tra le bolge e i canti è rove-sciata tra il trattamento delle bolge III (simoniaci), IV (falsi profe-ti), e V (barattieri) e quello delle bolge VII (ladri), VIII (consiglieri fraudolenti), e IX (seminatori di discordia). Vale a dire, due diversi canti sono dedicati rispettivamente alla simonia e alla falsa profezia e due insieme alla baratteria, mentre due canti sono dedicati rispetti-vamente al furto e al consiglio fraudolento, e solo uno ai seminatori di discordia. Questa struttura invita il lettore a considerare i modi in cui la simonia corrisponde al furto, la falsa profezia al consiglio fraudolento, e la baratteria al seminare discordia. Ad un livello la
Theodore J. Cachey Jr256
corrispondenza è relativamente sicura. La simonia è connessa al fur-to perché entrambi consistono nell’appropriazione indebita di beni o proprietà. La falsa profezia corrisponde al consiglio fraudolento perché entrambi sono considerati peccati della lingua e della reto-rica. La baratteria come il seminare discordia insidia i vincoli della comunità. Giù è peggio secondo il sistema etico geografico dell’In-ferno. Quindi il furto è più condannabile della simonia e il consiglio fraudolento della falsa profezia e il seminare discordia più della ba-ratteria. L’ordinamento dei 13 canti in questi segmenti paralleli e tut-tavia contrastanti ai due lati di Inferno 23 pertanto serve a sollevare questioni etiche di interpretazione che potrebbero non essere venute in mente al lettore se non fossero state segnalate in questo modo. Infatti questa sequenza di contrasti nelle categorie di frode non è evidente se si collegano semplicemente le prime cinque bolge alle seconde cinque. Lo schema complica al livello topografico del trat-tamento poetico delle bolge la divisione etica pari-dispari tra peccati di rappresentazione (bolge pari: 2, 4, 6, 8, 10) e peccati contro i patti (bolge dispari: 1, 3, 5, 7, 9) scoperta da James Nohrnberg.
Infatti, il canto 23, dedicato agli ipocriti, spicca come centrale all’interno della struttura. Da un punto di vista tematico la centralità dell’ipocrisia deriva dal fatto che l’ipocrisia è presente come una caratteristica che definisce tutti i peccati di frode puniti in Malebol-ge, vale a dire che l’ipocrisia è intrinseca alla frode come peccato dell’intelletto e cattivo uso della ragione. Non è possibile commet-tere frode, per definizione, senza esserne coscienti e pertanto non si può commettere alcuna forma di frode senza essere, al fondo, ipo-criti. La centralità dell’ipocrisia spiega la presenza di Caifa (If 23, 111-126) e il ruolo senza precedenti della ruina creata dal terremoto alla morte di Cristo a questo punto al livello del racconto (If 23, 137). L’enfasi strutturale sul canto dedicato all’ipocrisia e sulle sue risonanze cristologiche rinforza anche e coincide con un’asserzione, da parte di Dante, di autorità e buona fede come poeta-profeta. La rivendicazione di un’autorità etica della sua visione poetica è di con-seguenza evocata al cuore della frode da un punto di vista concettua-le attraverso uno dei più potenti e risonanti riferimenti autobiografici di Dante alla sua stessa storicità nel poema. Perché è precisamente in questo canto che egli informa il Frate Gaudente Catalano che ha riconosciuto l’origine toscana del pellegrino dal suo accento, che «I’
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 257
fui nato e cresciuto / sovra ’l bel fiume d’Arno alla gran villa, / e son col corpo ch’i’ ho sempre avuto» (If 23, 94-96). In un recente contri-buto intitolato Dante’s Poetics of Births and Foundations, Giusep-pe Mazzotta ha argomentato che per Dante «ogni evento di nascita è significativo perché altera la rete di relazioni esistenti e cambia ognuno di noi in un agente potenzialmente storico capace di volere e dare forma ad entrambi il passato (…) e il futuro» e che la teoria di Dante del futuro «dipende dal più naturale e comune evento di tutti: il nascere»38. Chi può dubitare che tra tante nascite e fondazioni registrate nel poema la nascita del poeta stesso sia registrata qui per sottolineare lo stato privilegiato dello stesso Dante, la radicale origi-nalità della sua poesia e la sua ambizione di dare forma al futuro?
La firma cartografica che Dante applica qui alla sua self-made map (per usare un’espressione di Tom Conley)39 è centrale all’interno di una schiera di passi corograficamente auto-referenziali che caratte-rizza i canti di Malebolge. Questi sono cartograficamente disposti in modo tale da asserire effettivamente e rinforzare l’integrità e probità della storia personale di Dante in contrasto con il contesto di frode e con i peccatori fraudolenti che egli incontra nell’ottavo cerchio. Per-tanto troviamo che il peccato specifico degli ipocriti Frati Gaudenti più o meno coincideva con il tempo della nascita di Dante. Catalano e Loderingo nel 1265 e 1267 avevano insieme la carica di podestà a Bo-logna e nel 1266 a Firenze. Nel 1266 i due, dopo la sconfitta di Man-fredi a Benevento, ipocritamente e con fraudolenza avevano favorito i Guelfi vittoriosi quando sarebbe stato loro dovere rimanere super par-tes. La loro condotta invece aveva portato direttamente all’esilio e alle espropriazioni delle proprietà dei Ghibellini fiorentini. La coincidenza tra la firma cartografica di Dante e gli atti di ipocrisia politica, che era-no stati l’inizio della serie di eventi politici che avrebbero condizio-nato l’esistenza di Dante e che infine l’avrebbero condotto all’esilio, rappresenta il punto centrale dal quale emana, attraverso Malebolge e oltre, l’autobiografia cartografica o la mappa mentale d’Italia tosca-
38. G. Mazzotta, Dante’s Poetics of Births and Foundations, in Dante. A Cri-tical Reappraisal, a c. di U. Falkeid, Oslo 2008, pp. 7-26 (in part. p. 13 e p. 23, traduzione mia).
39. T. Conley, The Self-Made Map: Cartographic Writing in Early Modern France, Minneapolis 1996.
Theodore J. Cachey Jr258
nocentrica del poeta. Partendo da ovest dai Guelfi Neri barattieri di Lucca, questa comprende la Pistoia di Vanni Fucci, la stessa Firenze (e Prato), la Toscana sud-occidentale della Siena di Griffolino e il settore nord-orientale del Casentino di Mastro Adamo, e infine si estende, ol-tre i confini di Malebolge, ad abbracciare la Pisa di Ugolino e persino le isole dell’arcipelago toscano che sono evocate in una culminante fioritura cartografica da incubo che coinvolge l’intera penisola nel suo profetico furore apocalittico:
Ahi Pisa, vituperio de le gentidel bel paese là dove ’l sì suona,poi che i vicini a te punir son lenti,
muovasi la Capraia e la Gorgona,e faccian siepe ad Arno in su la foce,sì ch’elli annieghi in te ogne persona!
(If 33, 79-84)
Il viaggio cartografico di Dante in Malebolge non è pertanto in alcun modo neutralmente geografico o turistico nella sua ispirazione. In netto contrasto con il paradigma cartografico che aveva informato il De vulgari eloquentia, che aveva aspirato alla prospettiva di una verticalità e “oggettività” razionalista, il viaggio di Dante attraverso Malebolge è invece distinto dalla sua soggettività non apologetica. Nella transizione dal De vulgari eloquentia alla Commedia, Dante arrivò ad accettare e ad abbracciare pienamente la marginalità della sua situazione politica da un punto di vista cartografico. La nuova forma di scrittura cartografica che egli impiega nel poema rappre-senta un mezzo importante per compiere la rigenerazione dell’Italia. Egli lo utilizza in uno sforzo poetico per rappresentare lo stato etico della penisola dal suo punto di vista. In questo senso i canti di Male-bolge rappresentano la riscrittura da parte di Dante della spedizione di caccia attraverso l’Italia che egli aveva intrapreso nel trattato lin-guistico in cerca della pantera del volgare illustre. Nel poema egli lascia da parte ogni rimpianto circa la mancanza di una curia e / o aula centrale e tutta la nostalgia per Federico II40. Allo stesso tempo
40. Per una lettura similmente “de-territorializzata” del De vulgari eloquen-tia, si veda il capitolo di Justin Steinberg sul De vulgari eloquentia, A terrigenis mediocribus, in J. Steinberg, Accounting for Dante. Urban Readers and Writers
Critica del testo, XIV / 2, 2011
Cartografie dantesche: mappando Malebolge 259
egli mette da parte ogni aspirazione ad un’autorità cartografica di per sé basata su un potere politico umano esterno e la rimpiazza con la sua soggettiva mappa mentale d’Italia, utilizzata come strumento di un argomento poetico potentemente persuasivo. In questo, Dante prefigura la transizione nella storia della cartografia dalla pretesa di oggettività rinascimentale ad un paradigma cartografico post-mo-derno descritto da Denis Wood in The Power of Maps: «Una volta che la mappa è accettata per la rappresentazione parziale che di fatto è, una volta che la sua contingenza storica è pienamente riconosciu-ta, non è più necessario mascherarla. Liberata da questo peso della dissimulazione (…) la mappa potrà assumere il suo carattere più vero, quello di uno strumento per (…) organizzare dati, quello di uno strumento per ragionare su informazioni quantitative, quello di uno strumento per l’argomentazione persuasiva»41.
Ma c’è un’importante differenza tra la scardinata soggettività post-moderna e la soggettività tardo-medievale di Dante e della sua cartografia, che è in definitiva autorizzata dai suoi legami con la geometria di Dio. La firma di Dante sulla carta geografica in questo senso serve a situarlo attraverso lo spazio (o gli spazi) del poema geometricamente e pertanto in relazione alla storia della salvezza. In questo senso, il poema deve essere compreso come un sistema glo-bale, o piuttosto come un sistema di posizionamento cosmico, i cui tracciati cartografici Dante-centrici si ramificano attraverso la prima cantica così come attraverso i regni di Purgatorio e Paradiso.
in Medieval Italy, Notre Dame-London 2007, p. 122: «Il contrasto tra spazio e luogo nella discussione della stanza di canzone fornisce anche un’illustrazione finale della tensione tra autorità poetica e storia nel De vulgari. Attraverso una teoria poetica basata sullo spazio microcosmico, l’esiliato Dante tenta di rifare se stesso, di rinascere poeticamente al di fuori delle sue reali condizioni storiche» (traduzione mia).
41. D. Wood, The Power of Maps, New York-London 1992, p. 182 (corsivo mio).
Theodore J. Cachey Jr260
Appendice: bolge/canti di Malebolge
I bolgia Ruffiani / Seduttori Canto 18
II bolgia Lusingatori
III bolgia Simoniaci / Mercanti di uffici sacri Canto 19
IV bolgia Indovini Canto 20
V bolgia Barattieri / Mercanti di pubblici uffici Canto 21
Canto 22
VI bolgia Ipocriti Canto 23
VII bolgia Ladri Canto 24
Canto 25
VIII bolgia Consiglieri fraudolenti Canto 26
Canto 27
IX bolgia Scismatici / Seminatori di discordia Canto 28
X bolgia Falsari Canto 29
Canto 30