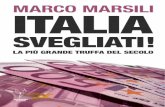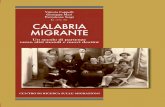ItalIa sveglIatI! - la più grande truffa del secolo - Zenodo
L’ascesa del romanzo (XVII-XVIII secolo), Einaudi 2011
Transcript of L’ascesa del romanzo (XVII-XVIII secolo), Einaudi 2011
Se in un accesso di nostalgia teorica misurassimo la pro-duzione romanzesca italiana sei-settecentesca secondo i para-metri definiti dal giovane György Lukács nella sua impareg-giabile, benché fallace, Teoria del romanzo (1920); se lo se-guissimo nella sua insistita propensione a concepire il roman-zo come un duello tra l’Io e una realtà divenuta sempre piùangusta, ostile e disorganica; se potessimo ancora credere nel-la sua struggente identificazione del personaggio romanzescocon «l’itinerario dell’individuo problematico che viene a sestesso, la via che dal torpido irretimento nella realtà che sem-plicemente è, eterogenea e priva di senso per l’individuo, con-duce alla compiuta e lucida conoscenza di sé»: ebbene, se lofacessimo, il presente contributo potrebbe concludersi qui.Poiché nessun testo della tradizione italiana sei-settecentescasarebbe arruolabile in questa colossale, hegeliana storia delloSpirito Assoluto: dove la parte del personaggio romanzesco èalternativamente quella di chi viene a patti con la realtà ri-nunciando a una parte di sé nel corso di una narrazione reali-stico-oggettiva, oppure quella di chi fa di sé un santuario, este-tizza la vita stessa e dà le dimissioni dalla realtà.
Non andrebbe meglio se facessimo nostri altri e più avan-zati paradigmi teorici, ad esempio l’idea che il romanzo siaconsanguineo al concetto di possibilità (Hans Blumenberg). Ilvero imbarazzo è costituito però da una considerazione qua-litativa dei testi italiani in prospettiva comparata con le altretradizioni europee. Tralasciando il Seicento, secolo di incuba-zione generalizzata del romanzo, vediamo che mentre nel xviiisecolo l’Italia annovera Pietro Chiari, in Francia spiccano tragli altri Marivaux, Prévost, Diderot, Laclos; a fronte del nostroAntonio Piazza, l’Inghilterra esordisce con Defoe, Richard-son, Swift e Fielding, per poi lasciare il passo a Sterne; e men-tre in Italia si delibano le Avventure di Saffo, poetessa di Miti-lene (1782) di Alessandro Verri, in cui si narra l’infelice inna-moramento (eterosessuale) della poetessa greca, in Germaniaha ormai già fatto scuola il Werther goethiano.
Dopo l’aurea stagione cinquecentesca, l’Italia ha per l’ul-tima volta il primato nel settore della haute couture letterarianegli anni venti e trenta del Seicento, quando GiambattistaMarino trionfa a Parigi con l’Adone e Giambattista Basile – unaltro napoletano – pubblica una raccolta di fiabe che resteràa lungo, almeno sino ai romantici tedeschi, un architesto im-
pareggiabile. Se non c’è dunque nulla di singolare nella me-diocrità della produzione romanzesca italiana, essa nondime-no si rivela quantitativamente cospicua e, tra alti e bassi, ab-bastanza continuativa nell’arco dei due secoli, accanto alle tra-duzioni dalle principali lingue europee.
Nel Seicento le prose narrative che si susseguono a buonritmo, alimentando un flusso policentrico (se la leadership edi-toriale è sempre e comunque da riconoscersi a Venezia, spic-ca la presenza di Bologna al secondo posto per quantità di ti-toli stampati), sono dei paleosauri la cui principale caratteri-stica è mescolare in modo tendenzialmente coeso elementimorfologici della tradizione epico-eroica (personaggi di illustrelignaggio, ambientazioni cortigiane, arcature temporali piut-tosto estese, adozione di strategie retoriche monolinguistica-mente tarate sui codici alti) e della tradizione cavalleresca,quale era stata teorizzata a partire da Giovan Battista Giral-di Cinzio nel Cinquecento: forte incidenza dell’elemento av-venturoso-evenemenziale, adozione dell’entrelacement per con-sentire un maggiore stivaggio di eventi nel testo, coinvolgi-mento del destinatario nella struttura narrativa grazie alla ma-nipolazione del tempo del discorso narrativo in forma di sus-pense, ricorso massiccio al tema del travestimento dei perso-naggi e correlativa presenza di scene di riconoscimento.
In Francia e in Germania si sviluppa soprattutto una lineadi romanzo eroicomico e di costume – a puro titolo di esem-pio ricordiamo il Romanzo comico di Scarron (1651-57), il Ro-manzo borghese di Furetière (1666) e il Simplicissumus di Grim-melshausen (1669) – che continua la tradizione picaresca delsecolo precedente, mettendo satiricamente in scena il mondocorrotto degli appaltatori e dei giudici, le flâneries delle com-pagnie teatrali di provincia, l’ambiente carcerario e le scorri-bande dei briganti. Viceversa, in Italia per tutto il secolo sisusseguono ponderosi romanzi di ambientazione fittizia, incui la geografia è spesso favolosamente orientale o epico-clas-sica e dove i personaggi sono cavalieri immacolati che paionorecitare sempre in playback: estranei a ciò che vivono, prote-si unicamente all’espletamento del Programma Narrativo dicui sono meri esecutori, per confermare i valori della cristia-nità e del lignaggio nobiliare.
Indipendentemente da qualsiasi orientamento teorico, og-gi sappiamo con certezza che il romanzo – il cosiddetto novel –
La nascita del romanzo italiano (xxvviiii e xxvviiiiii secolo)
Bologna(96)
Bracciano (3)
Bergamo(1)
Cesena(1)
Cesena
Udine(1)
Siena(1)
Siena
Torino(1) Parma
(1)
Fermo (1)
Chieti(1)
L’Aquila(1)
Viterbo(1)
Palermo(1)
Ragusa(1)
Foligno(1)
(3) (3)
Velletri(2)
Messina(3)
Lucca(3)
Camerino(3)Perugia
(2)
Macerata (11)
Pesaro (1)
Perugia
Brescia(4)
Ferrara(6)
Verona(3)
Villafranca(7)
Firenze(7)
Cremona(2)
Piacenza(4)
Genova(21)
Pavia(3)
Treviso(3)
Venezia(479)
Modena(2)
Modena
Padova(14)
Napoli(24)
Roma(40)
Milano(52)
Milano
Città straniere (31)
Venezia
100 0 80
55,4%
11,1%
6%
4,6%
2,8%
2,4%
3,6%
14,1%
604020
Bologna
Milano
Roma
Napoli
Genova
Città straniere
Altre italiane
Secolo XVII. Pubblicazioni nelle città italiane
Figura 1. Romanzi pubblicati nelle città italiane del Seicento. Percentuali calcolate su un totale di 852 pubblicazioni di cui si conosce il luogodi stampa.
Città straniere (25)
Secolo XVIII. Romanzi pubblicati nelle città italiane
Bassano(1)
Poschiavo(1)
Carpi(1)
Guastalla(1)
Bergamo(2)
Bologna(2)
Brescia(6)
Cremona(1)
Novara(1)
Vercelli(1)
Firenze(11)
Genova(9)
L’Aquila(1)
Livorno(1)
Lucca(1)
Pisa(1)
Milano(14)
Napoli(59)
Padova(7)
Parma(29)
Pavia(1) Piacenza
(1)
Roma(12)
Siena(3)
Torino(4)
Treviso(1)
Venezia(413)
Verona(2)
100 0 80
67,5%
9,6%
4,7%
2,3%
2%
4,1%
9,8%
604020
Venezia
Napoli
Parma
Milano
Roma
Città straniere
Altre italiane
Figura 2. Romanzi pubblicati nelle città italiane del Settecento. Percentuali calcolate su un totale di 612 pubblicazioni di cui è noto il luogodi stampa.
prende forma all’inizio del Settecento grazie alla frizione traun intreccio gestito da un individuo e un intreccio ammini-strato dal contesto storico-sociale (famiglia, istituzioni pub-bliche, tribunali, ecc.), mostrandoci le trasformazioni che ilcontesto provoca sull’interiorità dell’individuo. Non si dà ro-manzo senza l’intersecarsi elicoidale di questo double plot: aciò si avvicinava ingenuamente la narrativa picaresca (dovecomportamenti illeciti e identità del picaro erano il prodottomonogenetico dell’ambiente circostante, ma dove al tempostesso questo induceva la fuoriuscita del picaro dal quadro so-ciale), e a ciò tendevano i romanzi comici francesi, mettendosempre più a fuoco il setting romanzesco (per la prima volta,nei testi di Furetière ogni accadimento viene ambientato inuna topografia urbana reale, dove strade e piazze hanno no-mi e cognomi riconoscibili). In Italia, nessun double plot, nes-suna interazione biunivoca tra individuo e contesto; né si rie-scono a rilevare differenze strutturali nella galassia classico-eroico-galante costituita fra gli altri da Giovan Francesco Bion-di con i suoi romanzi ciclici L’Eromena (1624), La Donzella de-sterrada (1627), Il Coralbo (1632); o dagli accademici Incogni-ti Francesco Pona (La Messalina, 1627) e Pace Pasini (Histo-ria del Cavalier Perduto, 1644); da Bernardo Morando con lasua mediocre Rosalinda (1662) o dall’illeggibile Giovanni Am-brosio Marini (Il Calloandro fedele, 1664).
Certo, chi come Lucinda Spera ha studiato di recente ilromanzo tardo-secentesco ha convintamente dimostrato co-me non solo le manifatture narrative non chiudano i battentipoco dopo la metà del secolo – come ancora Martino Capuc-ci sosteneva nel 1974 –, ma che vi sia una marcata attenzio-ne agli scenari della storia e dei costumi contemporanei nei ro-manzi italiani dove, a partire dalla trilogia di Girolamo Bru-soni, il confronto con le altre tradizioni narrative europee sem-bra essere più attivo. Tuttavia, basta aprire a caso una paginadella Peota smarrita di Brusoni (1662) per comprendere chenella topografia reale dell’entroterra veneziano si muovonointricate vicende di travestimenti e agnizioni in nulla diverseda quelle della linea eroico-galante di inizio Seicento. Mancasempre il double plot. Manca il gioco di rifocalizzazioni inte-riori e di discontinue correnti volizionali attraverso cui l’Io diun personaggio trova il proprio destino mediante una catenacausale di conflitti, atti mancati, omissioni, sconfitte e vittorie.
La morfologia del romanzo italiano del Seicento, d’al-tronde, parla chiaro. In genere si tratta di testi eterodiegeti-ci, ossia con un narratore esterno all’intreccio ma fortementeintrusivo nei modi del commento gnomico o dell’interferen-za sapienziale: un narratore che rivolge rimproveri o esorta-zioni al personaggio e che ne considera il valore mettendoloantagonisticamente a confronto con altri eroi della tradizioneepica classica. Con due conseguenze.
Da un lato, l’esternalizzazione del narratore ha effetti diconsolidamento circa la credibilità dell’autore – il cui nome ap-pare infatti nei frontespizi a chiare lettere dopo il titolo, spes-so senza una diminuzione del corpo tipografico, come accadràinvece nel Settecento – e circa il grado di autenticità della nar-
razione. Come ha dimostrato Lubomìr Dole∆el, l’estraneità delnarratore alla scena narrata presuppone l’esistenza di due attidiscorsivi: quello autoriale, autonomo e fondativo, e quello deipersonaggi, dipendente dal primo e spesso fallace, corrotto daipregiudizi e dalle anguste focalizzazioni di chi, al contrario delnarratore onnisciente, può sapere solo quello che vede.
Dall’altro lato, è vero che un modello di eterodiegesi in-trusiva come quello secentesco non mette solo l’autore in po-sizione di superiorità rispetto al personaggio, ma anche il let-tore. Si prenda ad esempio una situazione che di rado latitanel romanzo secentesco (la si trova ad esempio nel Cretideo diGiovan Battista Manzini, 1637, o nelle Gare de’ disperati di Gio-vanni Ambrosio Marini, 1644): il personaggio di genere ma-schile X si innamora del personaggio di genere femminile Y,concupita incestuosamente dal proprio padre e dunque co-stretta a una fuga precipitosa travestita da uomo per evitaredi essere riconosciuta; X parte alla sua ricerca e quando a uncerto punto inizia un duello con un cavaliere il cui volto è co-perto da un elmo, si rende conto che il suo antagonista è ladonna che ama. Poiché in questi casi il narratore eterodiege-tico (esterno alla scena narrativa) e intradiegetico (in grado dileggere passioni e pensieri dei personaggi) preavverte dei tra-vestimenti in corso il lettore, dando a quest’ultimo una supe-riorità epistemica sui personaggi, non può certo essere la sus-pense a favorire o giustificare o sostenere piacevolmente l’at-to di lettura. Conoscendo in anticipo gli accadimenti futuri,il destinatario della narrazione partecipa meno alle emozionidel personaggio che non alla situazione drammatica da lui vis-suta, e la passione più marcata di questo lettore è allora il con-trasto che si viene a creare tra la consapevolezza di una minac-cia e l’impossibilità di un intervento attivo finalizzato a scon-giurarla. Meglio ancora: al di qua dei confini del mondo fin-zionale, il lettore degusta la superiore, elegante frustrazionedi un sapere cui non può far seguito alcun fare, mentre nel pe-rimetro del mondo finzionale i personaggi sono ciechi, suddi-ti di un Caso apparente che, dopo molte diversioni, li condu-ce al compimento di un giusto destino.
Nei romanzi del Seicento tutto si gioca dunque sulla di-sparità tra la scena romanzesca e la consapevolezza che di es-sa ne hanno i lettori. L’arcatura temporale degli intrecci è sem-pre congrua, coprendo preferibilmente la durata di alcuni me-si; gli spazi sono tanto dilatati – le coste del Mediterraneo, ipaesi europei, il Medio Oriente – quanto il ruolino di marciadei protagonisti è, e resterà nel secolo successivo, davvero im-pressionante; i personaggi sono degli attanti, cioè esecutoricoatti di un destino prescritto, e non attori, individui che ap-prendono dall’esperienza a riconfigurare le proprie volizionie i propri stati emozionali; il discorso narrativo procede se-condo velocità alterne, facendo seguire puntualmente ai som-mari (fulminee sintesi degli accadimenti) scene in cui tutto èrallentato, mostrato in piano-sequenza da un narratore che os-serva l’evento e insieme lo commenta in tono elativo e sa-pienziale. Quanto alla suspense, essa è inibita dalla scelta stes-sa dell’eterodiegesi intrusiva che tutti gli autori italiani adot-
4 L’età di Roma
tano. Insomma: per un lettore del terzo millennio, una disa-strosa voragine di noia.
Un solo assaggio di questo disastro: i Giuochi di Fortunadi Luca Assarino (1655) si aprono con l’omicidio cruento del-la moglie da parte del re dei Medi, Astiage, il quale l’aveva in-giustamente sospettata di avere una relazione adultera con unpaggio di nome Clorinante, che in realtà non è un paggio mala figlia sotto mentite spoglie dell’imperatore delle Indie; d’al-tro canto Astiage apprende da un oracolo che è destinato amorire per mano di un nipote, e dunque decide di uccidereanche Mandane, l’unica, amata figlia avuta dalla moglie de-funta. Fermiamoci qui: siamo solo all’incipit di un romanzofluviale articolato in cinque libri, dove i personaggi vagano tral’Egitto e l’Arabia, l’Armenia e il Mediterraneo, e in cui il nar-ratore eterodiegetico tiene il fiato sul collo del personaggio elo esorta a continuare nel suo cammino aneddotico, ricordan-dogli di volta in volta – a tutto beneficio del lettore – le tra-versie già narrate nelle pagine precedenti. Così, mentre un cer-to Moraspe che si scoprirà chiamarsi Idraspe ed essere l’ere-de al trono delle Indie attraversa faticosamente un deserto vi-cino al mar Caspio e dispera di trovare salvezza, oppresso dal-la sete e dalle tempeste di sabbia che «suoffocano il fiato», ec-co come lo videoriprende il narratore: «Moraspe, è giunto iltempo che tu rammentando tra te medesimo i deliziosi pas-seggi di Lippomara, i soavi conviti d’Almerinda, le ricchezze,la libertà e ’l comando che avevi in Farace tuo castello, con-
traponga quelle beatitudini a queste sciagure, e che consideriche l’uomo, che altro al fine non è che un giuoco di Fortuna,non è mai sicuro d’aver un continuato tenor di vita».
Il romanzo del Settecento riparte di qui, prendendo mol-to sul serio la preoccupazione di questo narratore circa l’in-stabilità dei tenori di vita, perché i grandi mutamenti storico-sociali in corso – costituzione di manifatture industriali, for-mazione di centri metropolitani, avvio della classificazione delprestigio sociale in base al censo e non alla nascita – hanno re-so il futuro degli individui sempre più difficilmente configu-rabile e sempre meno simile a quello dei loro padri. Dov’è ilturning point? Negli intrecci narrativi settecenteschi si co-mincia ad assistere al precario equilibrio tra l’individuo e ilcontesto storico, in modo che l’impulso ad agire e ciò che difatto accade derivino da un negoziato tra il primo e il secon-do. Contrariamente all’eroe dell’epos, privo di dimensioni la-tenti o virtuali, i personaggi romanzeschi sperimentano ora ildivergere dei valori dai fatti trovandosi sospesi tra le cause ei fini, la realtà della storia e l’utopia del desiderio.
Dotato di un’energica volizione che propizia il futuro, ilpersonaggio settecentesco ci appare all’inizio del testo comecolui che si distacca dalla cieca rotazione delle cose: è a tuttii fini un individuo – non un tipo – che si dà consapevolmentedelle determinazioni, è l’uomo della mancanza preliminare dileggi, che rifiuta di omologare l’essere all’azione, come avve-niva nei romanzi eroici del Seicento, e che si mostra infedele
La nascita del romanzo italiano (xvii e xviii secolo) 5
0
40
20
60
80
100
120
160
140
180
9 9
30
190 193
150
113
74
38 35
7 6
1422
29
90
149
85
136
71
20016
01-10
1611
-20
1621
-30
1631
-40
1641
-50
1651
-60
1661
-70
1671
-80
1681
-9016
91-17
00
1701
-10
1711
-20
1721
-30
1731
-40
1741
-50
1751
-60
1761
-70
1771
-80
1781
-9017
91-18
00
Secoli XVII-XVII. Pubblicazioni dei romanzi per decenni
Figura 3. Romanzi pubblicati in Italia nei secoli xvii e xviii, per decenni. Edizioni di cui è nota la data di stampa: 841 (xvii sec.) e 609 (xviiisec.).
persino a se stesso. Risultato di un intermedio congiungersidel furfante picaresco (trickster), che si adeguava a ogni circo-stanza, e del cavaliere epico, che non ripudiava mai i principîmorali della sua missione, il nuovo personaggio è sia parteci-pe sia osservatore del mondo, proprio perché muove dall’ideadi una tabula rasa da assoggettare a un processo di matura-zione, cioè dalla certezza che non esistano principî antecedentiall’esperienza.
Significativa la biografia di tale personaggio. In genere,nelle sezioni iniziali del testo egli ha l’impressione di sentirsiconfiscato e prigioniero di qualcosa o qualcuno. Occupa il tem-po leggendo romanzi, osservando da luoghi di provincia la mo-bilità sociale in ambiente urbano, oppure entrando a far par-te di ceti professionali emarginati, ad esempio quello degli at-tori: spesso ritratto nei romanzi di Chiari e di Piazza così co-me, nella letteratura tedesca, in quelli di Goethe. Per rinasce-re in uno spazio e in un tempo più prossimi ai suoi desideri, ilpersonaggio romanzesco sembra quasi anelare al naufragio, enel carcere familiare – tanto più duro per i personaggi fem-
minili –, dinanzi alle prescrizioni pedagogiche delle figure pa-terne, reagisce allestendo scenari immaginari.
Una prova del mutamento radicale risiede nell’abbando-no della posizione eterodiegetica del narratore. Un abbandonopressoché totale. A dominare nel Settecento è infatti il model-lo dell’omodiegesi: dove sono i personaggi stessi a raccontar-si, siano essi protagonisti, comprimari o semplici testimonioculari. Che sia epistolare o autobiografica, l’istanza narrati-va omodiegetica tende a coincidere con la vicenda narrata e aradicarvisi in una suggestiva simulazione di verità. Nota bene:se sul piano dell’enunciato narrativo troviamo personaggi for-temente transitivi, oberati di scopi da raggiungere, preda diuna sorta di dromofilia che talvolta fa loro percorrere l’inte-ro pianeta (come nel caso dei Viaggi di Enrico Wanton di Zac-caria Seriman o dell’Uomo d’un altro mondo di Chiari), sem-bra che alla fine il loro solo interesse sia allestire una rappre-sentazione verbale delle proprie avventure. Si ha spesso l’im-pressione che la realtà incuta ormai nei narratori – e insiemea essi, nei lettori – un terrore regressivo, e che l’unico strumen-
6 L’età di Roma
Figura 4. Un frontespizio in cui il protagonista del romanzo è indi-cato quale autore dell’opera.
Figura 5. Un esempio di antiporta: La vedova di quattro mariti di Pie-tro Chiari (1771).
to per addomesticare un mondo della vita reale in costantemutamento consista nell’allestirne una rappresentazione ri-veduta e corretta: come è stato detto, per empatia etimologi-ca il novel addomestica il novum.
Ma non deve stupire che i personaggi romanzeschi tra-scorrano il tempo scrivendo o scoprano al termine della lororudimentale Bildung una vocazione di memorialisti, poiché ilSettecento costituisce il secolo in cui la stipulazione dei pattinarrativi è più incessante e multiforme, ed è in essi che si con-densano le tensioni psichiche degli scrittori. Dal momento chestanno confezionando la realtà, gli autori di romanzi devonoelaborare dei codici di intercettazione e criptare le finzioni. Ilsistema settecentesco dei generi letterari ha inventato – comeè noto – l’autobiografia in quanto genere predisposto ad ac-cogliere ritratti di individui. Ma romanzo e autobiografia set-tecenteschi sono davvero due generi letterari differenti, se èvero che non solo i romanzi simulano la forma delle autobio-grafie reali, ma queste ultime si avvalgono di una sintassi ro-manzesca (è il caso, studiatissimo, dei Mémoires goldoniani)?
Di grande interesse si rivela l’elevato numero di fronte-spizi in cui autore del romanzo appare il personaggio, mentrel’autore implicito viene citato nelle vesti di editor, tradutto-re, narratario o mero tramite materiale tra il personaggio e lostampatore (fig. 4), in un gioco di paternità negate e masche-ramenti di cui Pietro Chiari si rivela maestro, come mostranoquesti pochi esempi: La filosofessa italiana, o sia le Avventuredella Marchesa N.N., scritte da lei medesima e pubblicate dal-l’Abate Chiari (1753); La ballerina onorata, o sia memorie d’u-na figlia naturale del Duca N.V. scritte da lei medesima (1754);L’uomo d’un altro mondo o sia memorie d’un solitario senza no-me, scritte da lui medesimo in due linguaggi, chinese e persiano,e pubblicate nella nostra lingua dall’abate Pietro Chiari (1760);La vedova di quattro mariti ossia memorie della Baronessa N.N.e pubblicate dall’abate Pietro Chiari (Venezia 1771).
Ecco come l’editor Pietro Chiari stabilisce un patto nar-rativo con il lettore all’inizio di La bella pellegrina, o sia me-morie di una dama Moscovita, scritte da lei medesima (1761):«Alla mia Viaggiatrice assai conosciuta per le lettere, che nepubblicai l’anno scorso son io debitore di queste Memorie, chesottometto presentemente agli occhi del pubblico. Ella me leinviò dalla Germania, dove allora trovavasi col titolo di BellaPellegrina, che portano in fronte, assicurandomi nella letterasua, che contenevano esse le avventure assai strane d’una gio-vane dama moscovita da lei conosciuta alla Corte di N. N.[…]. Trovandole io esposte in una lingua di cui non avevo mol-ta esperienza, mi convenne faticar molto per ben intenderle,e quasi da capo a fondo tornare ad iscriverle alla foggia mia,perché dessero a chi leggeva qualche diletto».
Altrettanto numerosi sono i personaggi che, in luogo di li-mitarsi a una rappresentazione di se stessi al termine delle av-venture di cui fanno parola, eleggono a componente essenzialedella loro vita la riproduzione esteticamente controllata dellarealtà: come il protagonista dei Viaggi di Enrico Wanton diZaccaria Seriman e quello dell’Uomo d’un altro mondo di Chia-
ri, i quali scrivono le loro memorie giorno per giorno, simul-taneamente alle vicende narrate nel testo.
Certo, va rimarcato il deficit qualitativo del romanzo ita-liano del Settecento rispetto ad altri paesi europei, i cui best-seller vengono peraltro tradotti tempestivamente in lingua ita-liana, spesso attraverso la mediazione francese: un deficit so-vente dovuto a un eccessivo rispetto della tradizione, o allasottovalutazione delle difficoltà morfologiche intrinseche a ungenere letterario ritenuto dai più, in Italia, di scarso valore esenza futuro. Si pensi che per ideare l’intreccio del suo ro-manzo Il poeta, o sia le avventure di D. Oliviero de Vega, poetaspagnolo, scritte da lui medesimo (1756), Chiari riprende duetesti teatrali di Edme Boursault (Ésope à la ville ed Ésope à lacour, rispettivamente del 1690 e 1701, tradotti in Italia daGasparo Gozzi) e tre commedie, rispettivamente di GirolamoBaruffaldi senior (Il poeta), Luisa Bergalli (Le avventure del poe-ta, 1730), Carlo Goldoni (Il poeta fanatico, 1750). Il peso del-la tradizione in questi casi appare assai nocivo, ed è l’interte-stualità a frenare l’ingresso della vita reale nei territori dellafinzione.
Secondo le figure 6 e 7, la produzione a stampa dei ro-manzi italiani e delle traduzioni di romanzi europei nel Sei eSettecento disegna un andamento sinusoidale, che riflette as-sai bene i fattori condizionanti che accomunano il xvii e ilxviii secolo. In particolare, nel Seicento furono 132 i roman-zi tradotti da altre lingue, mentre nel Settecento furono 295.
Si osservi ora la figura 3, che ripartisce per campate de-cennali le edizioni dei romanzi italiani, tra prime edizioni eristampe. Nei primi trent’anni del Seicento la stampa dei ro-manzi appare quasi irrilevante, in coincidenza forse con le on-date di peste causate dalla guerra di successione di Mantovatra il 1629 e il 1630: dal 1621 al 1630 la percentuale della pro-duzione romanzesca è pari al 3,6% (dato calcolato sul totaledegli 841 romanzi del Seicento di cui si conosce la data distampa: 24 sono senza data). Così avviene anche nella fles-sione che salda i due secoli: in costante discesa dal picco piùalto, registrato tra il 1641-50 (con il 22,9%, 193 opere sul to-tale), le edizioni si fermano al 4,5 e al 4,2% negli ultimi ven-t’anni, per crollare all’1,1 e all’1,0% dal 1701 al 1720. Una ti-
La nascita del romanzo italiano (xvii e xviii secolo) 7
XVII secolo
XVIII secolo
1000 80604020
Italiani Tradotti
84,7% 15,3%
52,7% 47,3%
Figura 6. Percentuali dei romanzi italiani e dei romanzi tradotti (secc.xvii-xviii).
mida ripresa comincia subito dopo, per riaffermarsi nella se-conda metà del Settecento: quando il picco più alto si registratra il 1761 e il 1770 con il 24,5% delle pubblicazioni (149 edi-zioni), calcolate sul totale dei romanzi del Settecento di cui siconosce la data di stampa (609 su un totale di 624: 15 titolisono senza data).
Questi dati fanno riferimento al numero di romanzi stam-pati nel corso dei due secoli considerando sia le prime edizio-ni sia le ristampe, mentre un conteggio delle sole novità edi-toriali rivela come, se nel Seicento i romanzi pubblicati sono289, nel Settecento essi salgono a 324. Da un’analisi sinotti-ca della produzione dei due secoli emerge comunque una sen-sibile diminuzione del numero delle edizioni di titoli roman-zeschi nel Settecento rispetto al secolo precedente (624 con-tro le 865 del Seicento), così come il Settecento si dimostrameno variegato dal punto di vista autoriale (fig. 8): il solo Pie-tro Chiari con 144 titoli occupa il 43,8% del totale, AntonioPiazza il 31,3%, mentre agli altri autori resta appena il24,9%. Al contrario, se nel Seicento l’autore maggioritario èFerrante Pallavicino (11,5%), a risultare complessivamentedominante è il team costituito dall’Accademia veneziana de-gli Incogniti (fig. 9).
Nel xviii secolo aumenta invece il peso delle traduzioni,nel tentativo di mantenere la penisola al passo con l’Europa(fig. 7): se nel Seicento solo il 15,3% della produzione roman-
zesca che appare in lingua italiana è costituito da traduzio-ni, nel Settecento la percentuale si triplica, raggiungendo il47,3%. Altrettanto diversa appare la suddivisione delle tra-duzioni in base alla lingua di partenza, poiché se nel Settecen-to domina il francese (79,9%, pari a 238 titoli), nel Seicentola medesima lingua (55,3%) viene affiancata dallo spagnolo,che con 25 titoli supera nettamente l’inglese (9,8%, 13 tito-li) (fig. 10). Oltre a ovvie ragioni politiche, l’incidenza dellospagnolo nel xvii secolo si deve all’ampia circolazione dellaletteratura picaresca in Italia: caso significativo è la riscritturadel Lazarillo (1554) sotto forma di avventura in terra italiana aopera di Pompeo Vizzani (Le disgrazie di Bartolino della Zena,1597), mentre nel 1606 esce la traduzione della Vita del Picarodi Alemán, nel 1622 quella del Lazarillo e una traduzione a ope-ra di Lorenzo Franciosini del Quijote di Cervantes (L’inge-gnoso cittadino don Chisciotte della Mancia). Né va dimentica-ta la fortuna di un testo niente affatto picaresco, ma dai toniegualmente antifrastici come il Bertoldo di Giulio Cesare Cro-ce. L’immediata circolazione in Italia di queste opere fonda-tive del romanzo europeo incide senza dubbio, sia pure con ra-gionevole lentezza, sulla scelta dei titoli, dei soggetti e dei pro-tagonisti della nascente prosa romanzesca italiana.
La ben nota supremazia editoriale veneziana nei due se-coli in esame si legge chiaramente nelle figure 1 e 2, in baseai quali Venezia passa dal 55,4% (479 titoli) nel Seicento sul
8 L’età di Roma
0
40
5 5 514
4 412
18 1820
60
80
100
120
140
160
180
200
Italiani Tradotti
Secoli XVII-XVIII. Romanzi italiani + romanzi tradotti
1601
-10
1611
-20
1621
-30
1631
-40
1641
-50
1651
-60
1661
-70
1671
-80
1681
-9016
91-17
00
1701
-10
1711
-20
1721
-30
1731
-40
1741
-50
1751
-60
1761
-70
1771
-80
1781
-9017
91-18
00
169
21
125
25
95
61
13
31 32
73
1 1 06 6
50
40
105
44
57
28
6670
37 34
177
16 167
22
Figura 7. Numero di romanzi italiani e di romanzi tradotti in italiano, per decenni (secc. xvii-xviii).
totale delle edizioni al 67,5% (413 titoli) nel Settecento. Manon mancano sorprese: nel panorama editoriale secentesco, eproprio negli anni di fondazione della prosa romanzesca ita-liana, Bologna si rivela ad esempio un caso interessante: conl’11,1%, pari a 96 romanzi, ben superiore al lavoro compiu-to dai torchi milanesi (6,0%). In sincronica aderenza al mo-vimento generale del secolo, sia Bologna sia Venezia cono-scono un incremento della produzione subito dopo il 1630, an-no della peste ma anche data di fondazione dell’Accademia ve-neziana degli Incogniti (fig. 11). Per Venezia il decennio 1631-1640 (che assieme a quello compreso tra il 1651 e il 1660 rap-presenta il picco della produzione) segna una netta ripresa,passando dal 5,3% (25 edizioni) al 20,1% (95 edizioni). Quan-to a Bologna, essa è quasi assente come centro di produzioneromanzesca fino al 1630, quando emerge d’improvviso con 29edizioni (31,2% nel decennio 1631-40); il dato si consolidanel decennio successivo (1641-50), ma è già la fine di un mo-mento assai favorevole, poiché un crollo verticale si può leg-gere nei decenni successivi alla metà del secolo (solo 15 edi-zioni tra il 1651 e il 1670).
Come spiegare la momentanea, apicale fioritura della pro-duzione romanzesca a Bologna? Innanzitutto grazie all’impe-gno dello stampatore Giacomo Monti, curioso di fatti strava-ganti e notizie sorprendenti, che tra il 1637 e il 1640 immet-te sul mercato ben 11 edizioni, tutte significative per il con-solidarsi di una tradizione narrativa: nel 1637 escono dai suoitorchi la princeps del Cretideo di Manzini, una nuova versionedella Stratonica di Assarino e l’Erotea di Francesco Bogliano;nel 1640 è la volta dell’Almerinda di Assarino. Giacomo Mon-ti era destinato ad aprire una strada che verrà in seguito atti-vamente percorsa.
Lo storico Mario Infelise ha efficacemente dimostrato co-me l’antica figura del libraio-stampatore vada scomparendonel corso del Settecento, per una serie complessa di moti-vazioni. Poiché l’evolversi del gusto e della società, il progressoscientifico e il mutamento della composizione sociologica delpubblico tendono sempre più a favorire le aziende dotate dimaggiore elasticità e meglio adattabili tanto ai momenti di cri-si quanto alle rapide espansioni, una tipografia dotata di mol-ti torchi rischiava di subire un tracollo improvviso, dovendofare i conti con la sovrabbondanza di manodopera e non riu-scendo ad assorbire la congiuntura negativa perché lontana,in fondo, dal comprendere le incognite del mercato. Al con-trario i librai, che orientavano o comunque intuivano il trendin corso e il polimorfismo di una domanda sempre più porta-ta a scegliere prodotti editoriali in grado di costituire un pas-satempo, si limitavano a ordinare la stampa dei propri libri aquelle tipografie che in numero crescente vivevano su com-missione.
Così, passando dal Sei al Settecento si assiste a un am-pliarsi progressivo della forbice tra libraio-editore e stampa-tore: le relazioni tra Giambattista Pasquali e Goldoni, tra gliAlbrizzi e Giovanni Battista Piazzetta, tra Antonio Zatta eGasparo Gozzi testimoniano di una sorta di sinergia intellet-
La nascita del romanzo italiano (xvii e xviii secolo) 9
Secolo XVIII. Romanzi di Pietro Chiari e Antonio Piazza
Chiari43,8%
Piazza31,3%
Altri autori24,9%
Figura 8. I romanzi di Pietro Chiari e Antonio Piazza: percentualedelle edizioni sul totale delle 329 edizioni di romanzi italiani pubbli-cate nel Settecento.
Loredano5%
Pace Pasini 0,1%
Pona 2,2%
Secolo XVII. Produzione romanzesca dell’Accademia degli Incogniti
Altri romanzieri
italiani66,8%
Pallavicino11,5%
Assarino8,3%
Biondi6%
Figura 9. Produzione romanzesca dell’Accademia veneziana degli In-cogniti (xvii sec.).
Francese55,3%
Francese79,9%
Spagnolo18,9%
Spagnolo 5,4%Inglese9,8%
Inglese 6,4%Latino9,8%
Latino 1,3%
Greco6,1%
Greco 4,4% Russo 0,3%
Tedesco 2,3%
Figura 10. Lingue di origine dei romanzi tradotti in italiano (xviisec.).
tuale senza precedenti. Intorno al 1765, a Venezia ben settetra i quindici più attivi professionisti matricolati sono esclu-sivamente librai – tra questi Antonio Graziosi, Paolo Colom-bani e Tommaso Bettinelli – attenti alla produzione di benieditoriali effimeri quali gazzette e romanzi. Anche l’identitàdei punti-vendita si adegua a questo multiforme processo diristrutturazione. Denominate sempre più spesso «librerie ve-nali» per distinguerle dalle librerie pubbliche o biblioteche, sitratta di botteghe che manifestano una duplice tendenza: daun lato cercano di espropriare la parte retrostante a uso di ma-gazzino, mentre nel passato accadeva di frequente che vi fos-se ospitata una piccola stamperia; dall’altro si indirizzanoesclusivamente allo smercio dei libri e delle calcografie, men-tre ancora nel Seicento vi si potevano trovare manufatti di di-versa area merceologica: quaderni, moduli amministrativi, in-chiostro, ceralacca, calendari, lunari.
Inoltre, va tenuto conto del fatto che in genere il costo diun libro rappresentava la quarta parte del suo prezzo di ven-dita al pubblico, ed evidentemente questo surplus del 75% nonandava a vantaggio dello stampatore: tanto più quando que-st’ultimo (era il caso della maggior parte dei tipografi) agivasu commissione e richiesta di un libraio. C’era poi l’andamentociclico del mercato, con le sue crisi ricorrenti: la più grave del-le quali colpì l’editoria veneziana tra gli anni sessanta e set-tanta del Settecento, proprio quando il numero di edizioni di
romanzi mandati a stampa si innalza vertiginosamente. In que-sta situazione sopravvive soltanto chi – come i Remondini diBassano – riesce a intercettare i gusti di un nuovo pubblicodesideroso di opere utili o, al contrario, solum dilettevoli abasso costo. Ciò spiega il rimpicciolirsi progressivo dei for-mati rispetto al Seicento (quando i romanzi venivano editi neiformati in-quarto o in-ottavo) e il sempre minore ricorso a eso-si apparati calcografico-illustrativi, a raffinati capilettera o afinalini rococò con tanto di putti in tripudio arcadico.
Se dalla valutazione quantitativa si passa a una conside-razione del peritesto (per Gérard Genette, il «peritesto» è unacategoria spaziale, aderente al testo e in grado di presentarlo,comprendente titoli, dediche, epigrafi ma anche il lay-out delfrontespizio) dei romanzi pubblicati nell’arco dei due secoli,i dati su cui riflettere sono di estremo interesse. A dare ascol-to al Carlo Denina della Bibliopea o sia l’arte di compor libri(1776), la fatturazione del titolo di un testo sarebbe ad esem-pio cruciale non solo per orientare l’orizzonte d’attesa dei let-tori, ma anche per scongiurare una crisi di mercato la quale,endemica a Venezia dopo la metà del Settecento, si manife-stava con sensibile evidenza in tutta la penisola: per Denina,si dovrebbe sempre concepire il frontespizio dei libri secondoun funzionalismo tendente a elidere gli elementi inutili e or-namentali, così da concentrarsi su quelli meglio in grado di in-fluenzare l’interesse dei lettori.
10 L’età di Roma
0
20
41
6
0
10
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Venezia Bologna
Secoli XVII-XVIII. Pubblicazioni a Venezia e a Bologna per decennio
1601
-10
1611
-20
1621
-30
1631
-40
1641
-50
1651
-60
1661
-70
1671
-80
1681
-9016
91-17
00
1701
-10
1711
-20
1721
-30
1731
-40
1741
-50
1751
-60
1761
-70
1771
-80
1781
-9017
91-18
00
25
0 0
95
29
95
7
78
8
34
14
30
1
61
1
92
1
27
0
5
0
5
0
10
0
17
0
23
0
46
0
45
0
100
79
33
Figura 11. Numero di edizioni pubblicate a Venezia e a Bologna, per decenni (secc. xvii-xviii).
Il titolo, in questo senso, ha un ruolo «deittico» che De-nina – molto prima delle rigorose osservazioni di Genette sulperitesto – ci chiede di non sottovalutare. Esso è il «somma-rio de’ sommari», l’indice dell’indice, il geno-testo, il nucleogenerativo dell’insieme-libro che può trarre ispirazione fon-damentalmente da quattro «luoghi o fonti»: il genere disci-plinare (per esempio Della Rettorica), un accadimento in gra-do di formattare il testo (per esempio La cena de’ savi e deipno-sofisti), il o i protagonisti (per esempio Il Cretideo), infine unelemento metaforico, ciò che obbliga il titolo a sdoppiarsi inemblema e motto esplicativo, in figura e commento. È una clas-sificazione operativa, uno strumento interpretativo che il let-tore non deve lasciarsi sfuggire e che può aiutare la distribu-zione del libro: «non vi è libraio sì ignorante e sì goffo chenon sia in questa parte de’ titoli capace di correggere, e d’i-struire gli autori. Leggendo i loro cataloghi, e guardando i bre-vi, o cartuccie, che appongono a’ libri nei loro magazzini, noipossiamo esser convinti, che i titoli de’ libri si debbono poterridurre a due parole, e con due o tre parole, compresovi il no-me dell’autore, potersi citare da chi che sia».
Come stavano realmente le cose? Una sola citazione pre-levata dalla Commediante in fortuna, o sia Memorie di MadamaN.N. scritte da Lei medesima (1755) di Pietro Chiari ci parladi una situazione assai degradata, in cui l’ottica funzionalista diDenina viene spesso sostituita da un orientamento inutilmenteestetizzante: «L’ideare il titolo e l’argomento d’un libro nonè si facile come qualcuno lo crede, ma il trattarlo poi degna-mente con soddisfazione di tutto è così malagevole e arduoche ci sono riusciti pochissimi. È pieno il Mondo di libri, ilcui titolo non è punto dissimile dalle insegne delle osterie chelevar si ponno e sostituirne un’altra a capriccio; perocché vo-lendo alloggiare colà nulla si trova alla fine di quanto pro-mettono. Ho conosciuto degli Autori più bravi nell’adattarei titoli all’Opere loro che non sono que’ ciabattini medesimidei quali vuole adattarsi ad ogni piede una scarpa. Quante co-se promette un magnifico frontespizio, di cui leggendo e ri-leggendo un intero volume non si trova poi sillaba. Quantifanno i libri come si fanno in Arsenale le Navi, che quandosono finite soltanto, e direi quasi pronte alla vela, si pensa qualnome si possa alle medesime imporsi, perché sono distinte dal-l’altre».
Nella nostra analisi quantitativa dei titoli dei romanzi sei-settecenteschi abbiamo tenuto conto della categorizzazione diDenina, ritoccandola alla luce delle tassonomie approntate daGenette. In questo senso, diciamo innanzitutto che se nelleopere del Settecento prevale una titolazione costituita da piùsegmenti (ad esempio Avventure di Stefanello Gonzales, so-prannominato il garzone di buon genio - Storia galante scritta dal-l’autore del Gil-Blas e tradotta dalla lingua francese, 1754), mol-ti titoli di romanzi secenteschi presentano invece una formauninominale (La Stratonica, 1633; La Taliclea, 1636; La Bersa-bee, 1639). Quanto ai sottotitoli, talvolta veri e propri secon-di titoli, essi si legano al titolo per coordinazione attraversol’uso di congiunzioni inclusive quali «o», «ossia» e «ovvero»,
che assumono coerentemente un valore esplicativo in relazio-ne ai contenuti del romanzo (ad esempio Il filosofo veneziano,o sia la vita di Venanzio, 1770), salvo eccezioni incoerenti co-me La Farfalla, ossia la Commediante convertita (1797).
Oltre a contribuire alla tematizzazione semantica del ti-tolo, i secondi titoli possono fornire indicazioni riguardanti lasuddivisione dell’opera (L’Eromena, divisa in sei libri, 1637),il numero dell’edizione (Gil-Blas di Santillano, storia galante,quinta edizione, 1755), eventuali annessioni testuali (Amelia,aggiuntovi Il Mennone e I due consolati del Sg. di Voltaire, eL’avventura singolare del Sg. Ab. Prevost, 1782) o revisioni (LaCantatrice per disgrazia, con nuove e copiose aggiunte dell’auto-re, 1754), ma possono altresì contenere informazioni sull’au-tore (Gli Incas, ovvero la Distruzione dell’Impero del Perù, ope-ra scritta sull’idioma francese dal sig. Marmontel storiografo diFrancia, dell’Accademia dei Quaranta, e recata nell’italiano daLodovico Antonio Loschi, 1785), includere una dedica (Il Prin-cipe Lacchè, dedicato a Sua Eccellenza il Signor Co. Bortolo Mar-tinengo, 1751) o contrassegnare un atto traduttivo (Avventu-re di Lillo cagnuolo bolognese, storia critica e galante tradotta dal-l’inglese, 1760).
Nel sottotitolo – che può seguire il titolo o in rari casi ilsecondo titolo, ed è separato da essi mediante un punto – com-pare spesso un indicatore metafinzionale la cui funzione è diesplicitare il genere diegetico del testo (fig. 12). Nei corporasei-settecenteschi presi in esame è stata osservata l’occorren-za di marche metafinzionali quali istoria/historia/storia, me-morie, lettere, racconto, novella, romanzo, che tuttavia com-paiono spesso anche nei titoli o nei secondi titoli (ad esempioHistoria egittia e persica, 1685; Il falso Rabbino, ossia le avven-ture del conte Vaxere, romanzo curioso tradotto dal francese,1760; Le due gemelle. Memorie scritte dall’una di loro, e pub-blicate dall’abate Pietro Chiari, 1777) (figg. 13 e 14).
Attraverso questi contrassegni, nel Settecento si proponeal lettore un patto finzionale in relazione all’autenticazione deicontenuti e allo statuto epistemico del mondo allestito: mec-canismo che può essere rafforzato attraverso ulteriori deter-minazioni (memorie di, storia scritta da), ma sempre in linea
La nascita del romanzo italiano (xvii e xviii secolo) 11
1000 80604020
Nessuna marca metafinzionale Presenza di marca metafinzionale
87,7% 12,3%
42,1% 57,9%
XVII secolo
XVIII secolo
Figura 12. Presenza o assenza di marche metafinzionali nei titoli(secc. xvii e xviii).
12 L’età di Roma
0
60
30
90
120
150
180
210
270
240
750
770N ess
u na
m ar ca
m et af i n
z i on a
le
Istor
i a
Hi st
ori a
S tor
i a
Mem
ori e
L et t e
r e
R acc
ont o
N ovell
a
R om an
z o
263
761
152
89
138
4
29
3 4521
2
17
1
XVIII secolo
XVII secolo
Figura 13. Tipologie delle marche metafinzionali nei titoli (secc. xvii e xviii).
0
20
1 0 00 1 0
11
1
11
0 0
8
0 0
9
30
33
0
10
30
40
50
70
60
Historia / Istoria / Storia Memorie
Secoli XVII-XVII. Occorrenza nei titoli delle marche metafinzionali “historia”/“istoria”/ “storia” e della marca metafinzionale “memorie”
1601
-10
1611
-20
1621
-30
1631
-40
1641
-50
1651
-60
1661
-70
1671
-80
1681
-9016
91-17
00
1701
-10
1711
-20
1721
-30
1731
-40
1741
-50
1751
-60
1761
-70
1771
-80
1781
-9017
91-18
00
6 5
02 1 10
13
31
20
32
53
26
18
37
25
12
6
1
53
Figura 14. Occorrenza nei titoli delle marche metafinzionali «memorie» e «historia»/«istoria»/ «storia» (secc. xvii-xviii).
con la forma omodiegetica predominante nel secolo dei Lumi.In alcuni casi, all’interno di uno stesso titolo sono addirittu-ra presenti più indicatori metafinzionali (ad esempio La Nuo-va Ernestina, storia francese, o siano Memorie scritte dal Contedella Rochelle, 1778). L’autore può dunque comparire nel ti-tolo dichiarandosi come tale, può celarsi fingendo di coinci-dere con un personaggio della storia o apparire come falso tra-duttore, perché anche questi meccanismi, in quanto pratichenarrative, sono funzionali all’allestimento dello storyworld (fig.15). Quando l’autore si finge personaggio della storia, comeaccade spesso nei romanzi di Piazza e Chiari, vengono usateformule quali «memorie scritte da lei medesima» o «avven-ture narrate da lei medesima» (ad esempio nel romanzo di An-tonio Piazza, L’Innocente perseguitata, ovvero Vita e avventuredi M. Virginia de Rosis, scritte da lei medesima, 1768).
Gli autori non mancano neppure di giocare con l’atto bat-tesimale costituito dall’assegnazione del titolo, come quandoAntonio Piazza scrive nell’Avviso ai lettori che l’autore, «av-visato il Pubblico che mancò la promessa sua di dare alle stam-pe La povertà contenta perocché seppe mentr’appunto comin-ciava a por mano in un tale argomento, esservi un’Opera delcelebre P. Bartoli che porta un frontespizio uguale, onde perevitare una confusione di titoli, che meritata gli avrebbe qual-che riprensione, abbandonò l’idea conceputa e compilò in po-chissimo tempo l’Operetta presente», cioè La Moglie senza ma-rito ovvero Memorie d’una dama italiana scritte da Lei medesi-ma (1766): il punto è che non esiste alcuna opera del Bartolicon questo titolo…
È certo che la suspension of disbelief assume un andamen-to crescente man mano che si passa dal Sei al Settecento, quan-do gli artifici di autenticazione dominano i frontespizi dei ro-manzi: se nella produzione del Seicento le marche metafin-zionali che circoscrivono il campo del racconto veridico (co-me «historia», «memorie», «lettere») si attestano all’11,3%,e sono inoltre esigui i riferimenti al genere (solo cinque titoliriportano la parola «racconto», due «novella» e uno solo laparola «romanzo»), la percentuale di tali marche si amplia inmodo considerevole nel secolo successivo, quando la cosid-detta rivoluzione della lettura suggerisce agli autori di far le-va sull’esemplarità storica dei romanzi per restituire ai letto-ri l’impressione di leggere resoconti di vite realmente vissute.Così, i contrassegni metafinzionali nel Settecento salgono al51,1%, e il solo indicatore «istoria»/«historia»/«storia» oc-cupa il 24,4% del totale.
La poetica narrativa umanistica incide in modo conside-revole sulla scelta degli argomenti, sulle introduzioni teoricheautoriali presenti nei romanzi (spesso in forma di dedica) maanche sui titoli. Secondo un orientamento ormai consolidatonei secoli precedenti – dalla celebre riscrittura in latino da par-te di Francesco Petrarca di una novella decameroniana alle va-rie rielaborazioni di storie antiche e moderne che accomuna-no la produzione narrativa umanistica fino alle novelle cin-quecentesche di Matteo Bandello – il racconto di finzione de-ve essere esemplare e deve al contempo dilettare, ma piacevo-
lezza e divertimento della finzione romanzesca soggiaccionoalla prima finalità narrativa, che è innanzitutto pedagogica emorale. L’importanza di tale assioma agisce anche nella codi-ficazione del romanzo italiano, come dimostra l’ampio ricor-so ad argomenti storici che risultano tanto più esemplari e con-vincenti in quanto realmente accaduti: per questo l’allusionealla veridicità del romanzo, anche quando essa viene palesa-mente tradita nel racconto finzionale, è costante in quasi tut-te le narrazioni romanzesche sei-settecentesche.
I titoli dei romanzi di questi due secoli marcano peraltrouna differenza rispetto alla coeva letteratura di consumo bas-so – come le gazzette – che negli stessi anni viene stampataper divulgare notizie sensazionali o fatti di cronaca ricorren-do nei frontespizi a una titolazione lunga, quasi un sommarioche viene pensato e adattato alla pagina per stupire il lettore.Al contrario, i romanzi hanno titoli più lineari: nel Seicentoevocano spesso la classicità attraverso i nomi di personaggi chevengono coniati in modo fantasioso su base etimologica conuno sguardo all’immaginario epico-cavalleresco medievale e ri-nascimentale (Cretideo, Coralbo, Cordimarte), mentre i titolisettecenteschi si orientano verso nomi più comuni, legati allasocietà contemporanea.
Non bisogna dimenticare che sin dalle origini della nostraletteratura in prosa è il protagonista a strutturare il titolo del-le narrazioni: così per il Filocolo (1336-38) di Giovanni Boc-caccio, dove Florio assume il nome di Filocolo, che nell’im-perfetta conoscenza del greco doveva significare per Boccac-cio «fatica d’amore». Non molto diversamente si comporta-no i titoli dei principali romanzi secenteschi: il Cretideo (1637)di Manzini ricorda la nascita del protagonista a Creta; il Co-ralbo (1632) di Biondi mette in evidenza il candido, nobilecuore del cavaliere arabo; il Calloandro fedele (1640) di Mari-ni è coniato grazie all’amalgama di due parole greche cheesprimono la bellezza maschile del protagonista; il Cordimarte(1660) di Giuseppe Artale indica il coraggio del protagonista.Evidentemente, l’idea di ancorare i titoli a una tradizione let-teraria classica si genera dalla necessità di fondare le nuoveprose romanzesche entro l’alveo di una letteratura colta o uma-nistica, anche per meglio prendere le distanze da una produ-zione di nuovo conio ma di consumo, che si andava forman-do in agglomerati testuali di varia natura (racconti in prosa ein versi, notizie, ragguagli) ma uniti dalla comune finalità dioffrire novità e fatti sorprendenti (come la nascita di bambi-ni deformi o eventi delittuosi). La prosa romanzesca del Sei-cento si colloca sin dalle sue origini come alternativa alla mol-teplicità di notizie e avvenimenti di una letteratura di consu-mo che si innesta, a propria volta per progressiva dissoluzio-ne della macrostruttura di grandi raccolte quali il Novellino,sulla vivace tradizione europea della narratio brevis (soprat-tutto novelle e fiabe). Il romanzo è insomma una risposta al-la dissoluzione della micronarrativa d’invenzione, e insieme iltentativo di continuare i grandi modelli classici.
Per quanto riguarda l’analisi della titolazione da un pun-to di vista semantico, abbiamo distinto i titoli in attanziali,
La nascita del romanzo italiano (xvii e xviii secolo) 13
evemenenziali, spaziali e temporali a seconda che il focus siacostituito dai personaggi, dagli eventi, dai luoghi o da un seg-mento cronologico presente nei romanzi (fig. 16). Più preci-samente, sono stati classificati come attanziali i titoli costi-tuiti da un nome (La Stratonica, 1633), spesso accompagnatoda un aggettivo o da lemmi che lo specificano, quali la prove-nienza di un personaggio, il suo titolo nobiliare o il suo statod’animo (ad esempio L’ingegnoso cittadino don Chisciotte del-la Mancia, 1677, e il Socrate delirante, 1781). Poiché la nozio-ne di «attante», elaborata originariamente da Algirdas J. Grei-mas nel 1979, comprende non solo attori umani ma oggetti,
animali e persino concetti astratti, vanno considerati attan-ziali anche titoli quali La Gondola a tre remi (1657) e Il car-rozzino alla moda (1658).
Nella categoria evemenenziale rientrano i titoli focalizza-ti sull’ordine degli avvenimenti che si succedono nel raccon-to (Le Avventure di Telemaco figlio d’Ulisse, 1785), ma è pos-sibile ricondurre a questa categoria anche quelli che racchiu-dono in sé l’azione in potenza presentando una chiara aspet-tualizzazione terminativa o durativa dell’evento (Il matrimo-nio per forza, 1754; L’amore ammogliato, 1724; o Il regno di Ero-de l’Ascalita, 1680). La crescita percentuale dei titoli che fo-calizzano un accadimento man mano che dal Seicento si pas-sa al Settecento e infine al romanzo del xix secolo – da unostudio dedicato da Margherita Di Fazio al romanzo storico,appare come i titoli attanziali continuino a decrescere rispet-to a quelli evenemenziali, pur restando maggioritari, anchenella prima metà dell’Ottocento – si spiega da un lato con ilruolo sempre maggiore del contesto storico-sociale nel deter-minare l’identità dei personaggi (ruolo che diventerà con il na-turalismo addirittura imperialistico, tanto da trasformare gliindividui da agenti a pazienti, da personaggi che desideranoagire a vittime di eventi che possono solo subire passivamen-te), dall’altro con il grado progressivamente più elevato di coe-sione dell’intreccio romanzesco: una macchina evenemenzia-le che esclude qualsiasi elemento frammentario, o digressivo,o dannoso per la tenuta crono-causale della storia narrata.
Quanto alle titolazioni di tipo cronotopico, soltanto tra iromanzi del Settecento sono stati rintracciati titoli spaziali (adesempio Il tempio di Gnido, 1766; Il Monte di Aretea, 1793; Le
14 L’età di Roma
1000 80604020
Attanziali
Evemenenziali
Spaziali
Temporali
Altro
XVIII secolo
73,8% 22,4%
63% 32,1%
XVII secolo
Figura 16. Percentuali delle titolazioni dal punto di vista semantico(secc. xvii-xviii).
0
20
10
3
0 0 0
3
0 0 0
4
1 0 0
5
02
0
11
26
8
4
14
4 5
1
6
32
2 1
2624
9
2
9
56
26
32
0 0 0
30
40
50
60
70
1701
- 10
1791
- 1800
1711
- 20
1721
- 30
1731
- 40
1741
- 50
1751
- 60
1761
- 70
1771
- 80
1781
- 90
Secolo XVIII
Autore Personaggio
Editor Falso traduttore
Figura 15. Le qualifiche con le quali gli autori menzionano se stessi nei titoli dei romanzi (xviii sec.).
isole della fortuna, 1774) e temporali (Le notti romane al sepol-cro degli Scipioni, 1792), mentre se si guarda ai sottotitoli leindicazioni spazio-temporali ricorrono spesso in entrambi isecoli (ad esempio Giornale dell’accaduto nella torre del Tem-pio durante la prigionia di Luigi XVI di Francia, pubblicato infrancese dal signor Clery, di lui cameriere, e recato fedelmente initaliano da N.N., 1799; La Rossane, romanzo storico in cui sifanno conoscere di passaggio le vicende politiche che accadderoin Italia ed in Germania sotto l’Imperatore Federico I chiamatoBarbarossa, 1791).
Infine, il corredo iconografico dei romanzi. Mentre nelleedizioni del Seicento l’antiporta precede solitamente il fron-tespizio nel recto del primo foglio, nelle edizioni del Settecen-to l’illustrazione, ricavata da una tavola incisa in rame, si tro-va sempre più spesso a riscontro del frontespizio, quasi a pre-annunciare eventi, situazioni e dinamiche narrative di rilievo(fig. 5). In particolare, nelle edizioni dei romanzi di Chiari ePiazza l’antiporta sembra acquistare un valore prolettico. È ilcaso ad esempio de La cantatrice per disgrazia di Pietro Chiari(1755): la protagonista Giustina viene ritratta nel momento incui scopre nella caverna un misterioso cadavere con una borsapiena di monete d’oro, fortunato ritrovamento che le consen-tirà di proseguire la fuga dalla famiglia e che viene raccontatonell’articolo v, dal titolo: «Un caso terribile avvenutomi nellagrotta, che mi consola invece di funestarmi». Duellanti che sisfidano in un bosco con la città sullo sfondo promettono le giu-ste emozioni ai lettori che aspettano, anzi «bramano», un nuo-vo romanzo di Chiari (L’amante incognita, 1765). Nell’antiportadella Moglie senza marito di Antonio Piazza (1766) una donnafugge a cavallo, inseguita da un uomo con le mani alzate: un fer-mo immagine notturno in cui lo spazio prospettico della fugasi contrappone al palazzo-prigione, mentre la curvatura di unalbero e alcune nubi sollecitano la sensazione di una notte agi-tata dal vento. Anche in questo caso l’illustrazione costituiscela prolessi di un capitolo importante del romanzo (articolo viii)in cui l’eroina riesce a liberarsi dall’abbraccio sgradito di unuomo «con mille furie in seno, col veleno sui labbri e colle mem-bra agitate dall’estrema ira».
Al centro di una elegante camera borghese, ricca di drap-pi e ritratti, una donna con kimono e cappello cinese viene cir-condata dalle effusioni di un tipico giovane borghese europeodel Settecento con parrucca e redingote: è l’antiporta che an-ticipa le avventure della Cinese in Europa di Chiari (1778),mentre un’indagine di costume si trova nell’ accuratissimo ri-tratto del prussiano Barone di Trenck (1754), verosimilmentesempre di Chiari: «un buon soldato» che non «era altresì indebito d’esser bravo scrittore». Lo stampatore avvisa che «civolea persona più di lui esperimentata nel mestiere dello scri-vere», mentre lascia a un esperto lettore il compito di scopri-
re chi sia il trascrittore di queste memorie militari e amorose:«la penna che ha faticato in queste memorie è facile da rile-varsi quando esse attentamente si paragonino con altre opereromanzesche uscite in questi tempi».
stefano calabrese, antonella de blasioed elisabetta menetti
c. denina, Bibliopea o sia l’arte di compor libri, Fratelli Reynolds, To-rino 1776 (rist. anastatica Mucchi, Modena 1994); a. n. mancini, Ilromanzo del Seicento. Saggio bibliografico, in «Studi secenteschi», XI(1970), pp. 205-74; XII (1971), pp. 443-98; m. fuiano, Aspetti dellacultura e dell’editoria napoletana del Settecento, in «Archivio Storicoper le province napoletane», 3ª serie, XCI (1974), n. 12, pp. 257-79;f. barberi, L’antiporta nei libri italiani del Seicento, in «Accademiee biblioteche d’Italia», L (1982), n. 4-5, pp. 347-54; id., Il frontespi-zio nel libro italiano del Seicento, in «La Bibliofilia», LXXXV (1983),n. 1, pp. 49-72; l. balsamo, Produzione e circolazione libraria in Emi-lia nel secolo xviii, in r. cremante e w. tega (a cura di), Scienza e let-teratura nella cultura italiana del Settecento, il Mulino, Bologna 1984;f. barberi, Profilo storico del libro, Gela, Roma 1985; g. genette,Soglie. I dintorni del testo (1987), Einaudi, Torino 1989; a. postiglio-la (a cura di), Libro, editoria, cultura nel Settecento italiano, s.e. [maCopisteria Goliardica], Roma 1988; m. infelise, L’editoria venezia-na nel ’700, Angeli, Milano 1989; f. barberi, Il libro italiano del Sei-cento. Aggiornamento della bibliografia dei tipografi, editori e librai aRoma nel Seicento, a cura di L. Baldacchini, Vecchiarelli, Roma 1990;g. marchesi, Romanzieri e romanzi del Settecento, introduzione a cu-ra di L. Toschi (Un secolo di romanzo), con una Rassegna bibliograficasul romanzo del ’700 a cura di M. Gori, Vecchiarelli, Manziana 1991(facsimile della 1ª ed., Istituto italiano d’arti grafiche, Bergamo 1903);m. gori, Il romanzo italiano del Seicento. Rassegna bibliografica, in «Larassegna della letteratura italiana», XCVII (1993), n. 3, pp. 94-178;m. di fazio, Dal titolo all’indice. Forme di presentazione del testo lette-rario, Pratiche, Parma 1994; r. chartier (a cura di), Histoires de la lec-ture. Un bilan des recherches, Imec, Paris 1995; l. clerici, Best-Sellerdel Settecento. I romanzi di Pietro Chiari, in «ACME», XLVIII (1995),n. 2, pp. 73-102; m. infelise, L’utile e il piacevole. Alla ricerca dei let-tori italiani del secondo ’700, in m. g. tavoni e f. waquet (a cura di),Gli spazi del libro nell’Europa del xviii secolo, Pàtron, Bologna 1997,pp. 113-26; m. capucci, La prosa narrativa, memorialistica e di viaggio:avventurieri e poligrafi, letterati, critici, polemisti, Salerno, Roma 1998;c. a. madrignani, All’origine del romanzo in Italia. Il “celebre AbateChiari”, Liguori, Napoli 2000; l. spera, Il romanzo italiano del tardoSeicento, La Nuova Italia, Firenze 2000; a. m. morace, Il prisma del-l’apparenza. La narrativa di Antonio Piazza, Liguori, Napoli 2002; c. a.madrignani, Introduzione a p. chiari, La Filosofessa Italiana, Manni,Lecce 2004, pp. 5-14; m. santoro e m. g. tavoni (a cura di), I dintor-ni del testo. Approcci alle periferie del libro, Edizioni dell’Ateneo, Ro-ma 2005; a. natale, Gli specchi della paura. Il sensazionale e il prodigio-so nella letteratura di consumo (secoli xvii-xviii), Carocci, Roma 2008;http://www.sbn.it (Sistema Bibliotecario Nazionale); http://marcia-na.venezia.sbn.it (Biblioteca Nazionale Marciana); http://catalo-gue.bnf.fr (Bibliothèque Nationale de France).
La nascita del romanzo italiano (xvii e xviii secolo) 15