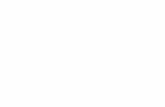TESI DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI PROCESSI INDUSTRIALI E DEI MATERIALI PANNELLI FOTOVOLTAICI
La terza ondata - processi di democratizzazione nel XX secolo
Transcript of La terza ondata - processi di democratizzazione nel XX secolo
Università degli studi di Cagliari Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea Magistrale “Governance e sistema globale”
La terza ondata. Processi di democratizzazione alla fine del XX secolo.
Saggio di Politica Comparata
Docente: Gabriella Lamonica
Focus: 4° Ondata di Democratizzazione
Sonia Marouani 50094
Cosa ci vuole dire Huntington nel suo articolo: “Democracy Third wave”? Innanzitutto per comprendere al meglio il processo di terza democratizzazione dobbiamo descrivere brevemente le prime due ondate, definire il concetto di democratizzazione, e perché furono chiamate ondate. Samuel Huntington definisce ondate di democratizzazione il passaggio di alcuni paesi da regimi autoritari a regimi democratici che furono numericamente superiori a quelli che fecero il contrario, siccome le prime due ondate furono seguite da ondate di riflusso o contro-ondate, il nome era azzeccato, perché come le onde lambisce il bagnasciuga e poi torna indietro. In base a questo concetto, in virtù del fatto che la sua analisi è relativa al XX secolo egli ha suddiviso il fenomeno così: Prima ondata di democratizzazione (lunga) 1820-1926 Prima ondata di riflusso 1922-1942 Seconda ondata di democratizzazione (corta) 1943-1962 Seconda ondata di riflusso 1958-1975 Terza ondata di democratizzazione 1974- in corso Approfondiamo meglio questa periodizzazione, nel suo articolo pubblicato nel Journal of Democracy, analizza come introduzione le prime due ondate, la prima definita lunga ondata inizia nel 1820 quando il suffragio universale maschile ottenuto negli Stati Uniti diede quell’input che serviva per iniziare il processo, durò fino al 1926 creando 29 nuove democrazie, tuttavia nel 1922 in Italia stava cominciando un periodo storico difficile, che noi conosciamo come Regime Fascista. Il potere che Mussolini applicò con il pugno di ferro diede il via ad una contro-ondata che ridusse le democrazie recentemente conquistate a 12, dopo la vittoria degli alleati nella seconda guerra mondiale, nel 1943-1945 iniziò la seconda ondata di democratizzazione detta corta perché terminò tra il 1958 e il 1962 dando il via alla seconda ondata di riflusso che ridusse le democrazie dalle 36 conquistate a 30 rimaste, nel 1974 arriviamo finalmente all’oggetto della nostra analisi ovvero la terza ondata di democratizzazione, nel periodo in cui Huntington scriveva non erano successi molti degli eventi che noi conosciamo bene, quindi dovremmo almeno per ora attenerci solo al suo punto di vista, verso la fine avremo tutti gli elementi per approfondire meglio a questione. Nel suo articolo afferma che della terza ondata sappiamo poco se non l’inizio e i paesi coinvolti finora, siamo negli anni ’90 del XX secolo, non possiamo quindi prevedere se ci sarà un’altra ondata di riflusso o se le democrazie conquistate rimarranno tali, per questo Huntington è riuscito a creare un elenco di fattori che hanno permesso la transizione democratica, li riporterò integralmente:
1. I profondi problemi di legittimazione dei regimi autoritari in un mondo dove i valori democratici sono largamente accettati, che porta alla conseguente dipendenza di questi regimi a performance di successo che non riescono però a mantenere a causa del fallimento e della stagnazione economica dovuta anche al clientelismo.
2. La crescita economica globale senza precedenti del 1960 che alzò gli standard di vita, aumentò l’istruzione e espanse enormemente la classe media in molti paesi.
3. Il cambiamento radicale della dottrina e delle attività della Ciesa Cattolica, espresse nel Concilio vaticano II del 1963-1965 e la loro conseguente trasformazione delle chiese cattoliche da difensori dello status quo ad avversari dell’autoritarismo.
4. Cambiamenti nelle politiche degli attori esterni, come l’Unione Europea, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica.
5. L’effetto “Snowballing” ovvero l’effetto dimostrativo delle prime transizioni della terza ondata per stimolare uno sforzo ulteriore per fornire modelli democratici. Inteso anche come metafora della palla di neve che da piccola rotolando nella discesa diventa sempre più grande.
L’autore inizia con l’analisi degli ultimi tre fattori proponendosi di ritornare in seguito sui primi due. Possiamo notare una correlazione storica tra il mondo cristiano occidentale e la democrazia, infatti verso la fine degli anni ’70 la maggior parte dei paesi protestanti era diventata democratica, qui
possiamo notare un sottinteso riguardo parti del mondo con altre religioni come Islam e Confucianesimo ad esempio, approfondiremo questo tema più avanti. Il ruolo delle forze esterne è sicuramente segnato dalle tre superpotenze dell’epoca: L’UE ebbe un ruolo chiave nella democratizzazione dell’Europa sud-occidentale, infatti per garantire la stabilità economia dell’Unione era necessario che i suoi membri avessero un regime democratico, per questo Spagna, Portogallo e Grecia dovettero fare delle modifiche prima di entrare a pieno titolo nell’UE. L’URRS invece ha un ruolo nel senso della possibile fine del suo impero comunista, ovvero, ricordiamoci che siamo nel 1990, poco prima della sua definitiva caduta, se appunto dovesse ritirarsi dai giochi, ridurrebbe il suo controllo sui paesi baltici, quelle che verranno conosciute come ex province sovietiche, avrebbero una reale speranza di diventare democratiche ed in più se la futura repubblica russa dovesse accettare la democrazia come modello, sarebbe la vittoria più grande dopo la fine della II guerra mondiale. Infine gli Stati Uniti, essi avevano il ruolo primario di diffusori del modello democratico nel mondo negli anni compresi tra il 1970 e il 1980, cosa succederebbe però se la forza e la credibilità della potenza americana diminuisse? Ricordiamo alcuni eventi che hanno messo a rischio la sua immagine in questi anni: -La guerra del Vietnam, che si avviava alla fine e anche se nel 1973 ritireranno le truppe dal territorio, facendola diventare una guerra solo vietnamita, era la più grande vergogna della politica statunitense. -Nel 1974 si dimette il Presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon in seguito allo scandalo Watergate che prese il nome dal Watergate Complex, il complesso edilizio di Washington che ospita il Watergate Hotel, l'albergo in cui furono effettuate le intercettazioni che diedero il via allo scandalo. -La presa dell’ambasciata americana in Iran nel 1979, subito dopo la rivoluzione Khomeinista, che nessuno aveva previsto, ma che col senno di poi era inevitabile, con la detenzione per oltre un anno di centinaia di ostaggi. -Nel 1984 scoppia lo scandalo Irangate che fa traballare la presidenza Reagan: nonostante l'embargo totale, armamenti sarebbero stati venduti all'Iran con la complicità di alti esponenti politici americani. È abbastanza chiaro quindi il perché l’autore affermi che l’immagine e la credibilità statunitense sia traballante, lo definisce “American Decline” probabilmente per fare il verso al concetto di “American Dream”. In effetti se il mondo iniziasse a vedere la realtà interna americana contrassegnata da stagnazione politica, inefficienza economica e caos sociale, il suo fallimento generale porterebbe ad un fallimento del concetto stesso di democrazia che tenta di esportare e conseguentemente ad una diminuzione della forza mondiale che sostiene la democratizzazione.
Il concetto di Snowballing che abbiamo introdotto prima diventa evidente negli anni ’90 in Bulgaria, Romania, Yugoslavia, Mongolia, Nepal, e Albania, coinvolge anche movimenti liberali in alcuni paesi arabi e africani. I sollevamenti nell’Europa dell’est, le cosiddette rivoluzioni colorate, appellativo attribuito dai media internazionali e dai soggetti coinvolti a una serie di
movimenti simili e correlati tra di loro che si sono sviluppati principalmente in alcuni stati post-sovietici, hanno alimentato la richiesta di cambiamento nel mondo arabo, e portato alcuni leaders, soprattutto del Maghreb ad aprire di più al dissenso politico.
A questo punto avendo chiarito i precedenti punti possiamo porci una domanda: ci può essere una terza ondata di riflusso? Nel 1990 ad esempio abbiamo gli esempi del Sudan e della Nigeria che sono tornati al regime autoritario. Se prima l’autore ha elencato i fattori necessari alla democratizzazione, ora elenca quali sono i fattori che potrebbe al contrario portare ad un percorso inverso della terza ondata d democratizzazione:
1. La debolezza dei valori democratici all’interno delle èlite al governo e del pubblico. 2. Crisi economiche gravi che possono intensificare i conflitti sociali e mettere in luce la
popolarità delle soluzioni che possono essere imposte solo da un governo autoritario. 3. Polarizzazione sociale e politica, spesso prodotta da governi di sinistra che in questo modo
cercano di introdurre grandi riforme economico-sociali. 4. La determinazione della borghesia conservatrice e dei gruppi elitari di escludere dal potere
gruppi populisti e di sinistra. 5. La crisi dell’ordine e della legge risultato del terrorismo o movimenti di insorti. 6. Intervento e conquista del potere da un movimento non democratico 7. “Reverse snowballing” in riferimento al fenomeno descritto n precedenza, in questo caso
innescato da collassi di democrazie in altri paesi. La maggioranza di questi stati che hanno subito una transizione dalla democrazia all’autoritarismo, sono stati vittima di un colpo di stato militare che prendeva il posto di governanti legittimamente eletti, oppure gli stessi governanti incentrando tutti i poteri nelle loro mani creavano forme di presidenzialismo assoluto o di dispotismo presidenziale, solitamente dichiarando nel primo caso la legge marziale e nel secondo caso lo stato di emergenza, che sospendeva diritti civili e politici. Non bisogna dimenticare che anche nel caso di un regime autoritario che vuole conquistare altri territori oltre i suoi confini, vedi il modello tedesco e quello giapponese durante la seconda guerra mondiale, il cosiddetto Liebensraum o spazio vitale, può scatenare altre derive autoritarie in altri paesi democratici o in via di democratizzazione. Ma quali sono gli ostacoli alla democratizzazione?
L’autore analizza le categorie che possono essere ostacoli o opportunità per la democratizzazione, sostenendo in primo luogo che in quei paesi che mancavano di democrazia si verificava spesso una sovrapposizione di questi fattori geo-culturali:
1. Regimi nazionali di stampo Marxista-Leninista dove i maggiori movimenti di liberalizzazione avvennero negli anni ’80, inclusa l’URSS, e movimenti democratici esistevano in molte delle repubbliche.
2. L’Africa subsahariana he con qualche eccezione rimase in mano a dittatori che crearono dispotismi personali, regimi militari, governo a partito unico, oppure una commistione di questi tre come metodo di governo.
3. Paesi islamici dal Marocco all’Indonesia con l’eccezione di Turchia e forse il Pakistan hanno governi non democratici.
4. Paesi dell’Asia orientale che da Burma al sud-est asiatico, dalla Cina alla Corea del nord, hanno regimi comunisti, dittature militari, dispotismi personali e due semi-democrazie, Thailandia e Malaysia.
Da questo possiamo ricavare la risposta alla nostra domanda, ovvero che gli ostacoli, almeno per questi paesi sopracitati sono di natura culturale, politica, ed economica, o meglio l’autoritarismo resta l’ostacolo maggiore per i paesi con scarsa esperienza democratica, anche la poca serietà e attaccamento ai valori democratici dei leader porta al fallimento della democratizzazione e anche quando ci provano lo fanno a denti stretti, perché stanno rinunciando a parte del loro potere. Abbiamo detto che la cultura è determinante nel percorso di democratizzazione, opinione condivisa anche da Larry Diamond, che distingue tra paesi musulmani e paesi arabi, sostenendo che questi ultimi hanno un grado di libertà bassissimo, mentre nei paesi a maggioranza musulmana ma non arabi si riscontrano diritti civili e politici. Infatti più la cultura in questione è restrittiva e nega l’accesso dei valori democratici all’interno della società più sarà difficile per essa fiorire in questo contesto, spesso più il concetto democratico è ritenuto giusto per l’occidente più per converso è ritenuto sbagliato per l’oriente. Le due culture che più spesso vengono citate in questo contesto sono Confucianesimo e Islam, in particolare l’autore evidenzia 3 questioni per comprendere che ostacoli possono porre:
1. In che misura i valori confuciani e islamici sono ostili all’ideale democratico? 2. Se lo sono in che misura hanno ostacolato il progresso della democrazia? 3. Se lo hanno fatto in che misura lo faranno in futuro?
Il Confucianesimo: non si ha nessun dubbio sul fatto che sia una religione pregnante su tutti i livelli della vita e che sia antidemocratica, l’unico pregio è che nella distribuzione delle cariche in Cina soprattutto si usa il criterio meritocratico e non basato sul nepotismo, che però non determina la democrazia, infatti questi paesi tradizionalmente confuciani non hanno esperienza di diritti civili, quei pochi esistenti sono creati dallo stato, e di norma si preferisce l’armonia e la cooperazione al disaccordo e competizione, il mantenimento dell’ordine e il rispetto della gerarchia sono essenziali per questo tipo di società, il conflitto in generale non è accettato, e soprattutto lo stato tende ad amalgamarsi con il cittadino, delegittimando qualsiasi istituzione sociale autonoma, rendendola inutile. Gli unici due paesi ad aver sperimentato la democrazia dagli anni ’90 sono il Giappone e le Filippine, in entrambi i casi il risultato della presenza americana, nel caso filippino, la maggioranza è cattolica, mentre in Giappone il confucianesimo è mescolato alle tradizioni locali e quindi meno restrittivo, ecco perché la democratizzazione ha potuto funzionare. L’Islam: è una religione complessa, che non abbraccia solo la parte spirituale della vita del credente, ma in teoria la impregna tutta, infatti al suo interno troviamo elementi di diritto, di società e anche di politica, infatti per alcuni versi è antidemocratico per altri non lo è affatto. L’unico fulgido esempio di democrazia riuscita, almeno fino a pochi anni fa, era la Turchia, che con la fine dell’Impero Ottomano e l’arrivo di Mustafa Kemal (Ataturk), si proiettò verso l’occidente ed il suo modello democratico, rifiutando ogni concetto si stato islamico, cercò di fondare un potente stato moderno, occidentale e secolarizzato, un successo quasi completo se non fosse per gli sporadici interventi militari. Paradossalmente anche il Pakistan ha provato la via della democrazia, ma al contrario della Turchia ha avuto un governo militare con sporadiche elezioni. Quali sono i limiti degli ostacoli derivanti dalla cultura?
Effettivamente abbiamo visto le caratteristiche di queste due culture millenarie, ma l’autore ci tiene a sottolineare il fatto che adesso si dice che sono antidemocratiche, come poco tempo fa si diceva anche del cattolicesimo, che poi fu segnato da tantissime transizioni democratiche, in secondo luogo bisogna comprendere che il Confucianesimo e l’Islam sono culture complesse e ricche e hanno anche loro alcuni elementi compatibili con la democrazia, così come il cattolicesimo ha elementi chiaramente anti democratici, in terzo luogo non dobbiamo ragionar come se queste religioni e le relative società siano immobili e stagnanti, anzi al contrario sono in continuo movimento, lo approfondiremo meglio dopo nel caso studio, e quindi quello che valeva qualche generazione fa non vale più ora; in sostanza l’autore non vuole chiudere a chiave la porta per questi paesi, ma al contrario vuole lasciare uno spiraglio, perché secondo lui c’è speranza. Per concludere la sua analisi Huntington vuole analizzare la correlazione tra benessere economico e democrazia, infatti secondo lui la correlazione esiste, la maggior parte dei paesi democratici sono anche ricchi o perlomeno benestanti. La sua teoria è che nei paesi ricchi la democrazia è già solida, nei paesi poveri non è consigliabile, e nei paesi medi si tratta di un area grigia di transizione, che molto probabilmente approderanno in una nuova realtà democratica, anche in questo caso però l’autore non chiude la porta ma lascia uno spiraglio di salvezza, ovvero se i paesi poveri riusciranno a risollevarsi abbastanza da entrare nello strato di transizione, saranno già salvi. In conclusione troviamo delle previsioni sul futuro, passa dalla possibilità di una terza ondata di riflusso che potrebbe portare parecchie derive autoritarie ad una quarta ondata di democratizzazione prevista per il XXI secolo che sarà condotta principalmente da due fattori, sviluppo economico e leader politici, comunque smorza le speranze dicendo di procedere con cautela per due ragioni: la prima è il ruolo che avranno i paesi dell’Africa, che sono definiti paesi in via di sviluppo molto in ritardo, in secondo luogo, anche se era una visione distopica per l’epoca, l’ipotesi che degli autoritarismi nascano anche in società altamente tecnologizzate e ricche è possibile, ma nel caso queste realtà non si materializzassero, il tempo è dalla parte della democrazia che piano piano sostituirà tutti i regimi autoritari con quelli democratici.
Approfondimento: La Quarta Ondata di Democratizzazione? In un intervista fatta al Professor Grilli di Cortona docente di scienza politica nella facoltà di Roma tre, si evidenzia che si tende a definire i recenti moti del 2011-2013 come possibile candidato all’etichetta di Quarta ondata di Democratizzazione. Alla fine del suo articolo Huntington aveva predetto un evento simile per il nostro secolo, e sembrerebbe essere avvenuto, o perlomeno la volontà era di democratizzare i paesi delle cosiddette Primavere Arabe che dalla Tunisia passando per l’Egitto e la Libia sono arrivate fino in Siria, con piccoli sommovimenti anche negli altri paesi del Medio Oriente. Nella domanda riguardante le peculiarità del mondo arabo-musulmano in relazione alla democrazia il professor Grilli pone l’accento sulla mancanza di classi medie responsabilizzate nella gestione delle risorse pubbliche, in velato accenno al clientelismo, a cui va
aggiunta una serie di fattori, ad esempio la mancanza di esperienza democratica, in quanto questi paesi sono tutti reduci prima dalla longa manus dell’impero ottomano e poi dai colonialismi occidentali che solo recentemente ha concesso loro l’indipendenza, a partire dalla metà del ‘900, continuando però ad esercitare il controllo in maniera differente, il cosiddetto colonialismo economico. Un altro fattore importante è relativo al concetto di rentier state, ovvero un’eccessiva dipendenza dello stato dagli idrocarburi che si forniscono ricchezza ma che viene iniquamente ridistribuita tra le classi medio alte, per assicurarsi fedeltà e lasciando il resto della società, spesso la maggioranza, in una situazione economicamente insoddisfacente. Altro fattore è sicuramente, e soprattutto dal settembre 2001 a questa parte, il ruolo della religione in chiave integralista e terroristica che non permette alla democrazia di fare il suo corso, per non citare poi il ruolo ambiguo degli apparati militari. Perché proprio questi paesi sono definiti come protagonisti della quarta ondata? Perché per dirla con Huntington, nelle altre ondate erano i grandi assenti, realtà considerate immobili ed immutabili, che invece con queste rivolte nella migliore delle ipotesi hanno eliminato il problema e sono ben instradati sulla via democratica, come la Tunisia, e nella peggiore hanno mescolato le carte in tavola cadendo prima nella guerra civile e poi nelle grinfie dello Stato Islamico, come la Siria, in ogni modo però hanno movimentato la situazione. Una definizione ad hoc era stata elaborata per descrivere questi regimi, “regimi ibridi”, ovvero autoritarismi particolari, con caratteristiche inedite capaci di conservarsi e consolidarsi nel tempo. Tali regimi consentono forme di competizione politica e perfino l’indizione sistematica di elezioni, senza per questo trasformarsi in democrazie, è tutto finto a vantaggio di chi dall’occidente osserva e inneggia queste democrazie consolidate in Medio Oriente. In questi regimi, proprio le procedure democratiche possono costituire lo strumento principale per ottenere ed esercitare piena autorità politica, ma la violazione di tali regole e l’adattamento delle stesse da parte di chi governa ai propri interessi, infrange gli standard minimi richiesti a sistemi anche solo parzialmente liberi. La definizione minima di democrazia1 non è quindi rispettata. La manipolazione delle procedure e dei risultati delle elezioni rappresenta lo strumento privilegiato di sovversione dei contenuti democratici di tali regimi. In conclusione possiamo dire che nonostante sia passato qualche anno dall’esplosione di queste rivolte ancora non abbiamo i dati necessari per affermare se si tratta o no di una quarta ondata, e se sì se ci sarà anche una quarta ondata di riflusso, quello che è certo è che la carte in tavola sono sicuramente cambiate e che anche i giocatori giocano con regole ed interessi diversi rispetto alle altre ondate.
1 Sono democratici quei regimi che presentano • Suffragio universale maschile e femminile • Elezioni libere competitive, ricorrenti e corrette • Pluralismo partitico • Diverse e alternative fonti di informazione • Incertezza decisionale e certezza procedurale • Bilanciamento di principi diversi (e in tensione) • Accordo e dissenso • Maggioranza e minoranza • Rappresentanza ed efficacia decisionale
Bibliografia:
-Huntington Samuel P., Democracy’s third wave, in Journal of democracy 2 n° 2 1991
-Huntington Samuel P., La terza ondata. Processi di democratizzazione nel XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1991
-Diamond Larry, Consolidating the third wave of democracy, J.H. university press, Baltimore and London, 1997
- Seymour Martin Lipset, Jason M. Lakin, The Democratic Century, University of Oklahoma Press, 2004