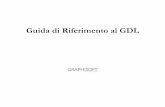Modellazione Statistica per l'Ottimizzazione di Sistemi Energetici
Informazione statistica e processi decisionali pubblici: un quadro di riferimento
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Informazione statistica e processi decisionali pubblici: un quadro di riferimento
1
1
QUADERNO N. 145
Luigi Riva Marco Trentini
Informazione statistica e processi decisionali pubblici: un quadro di riferimento
RAPPORTI DI RICERCA
DEL DIPARTIMENTO METODI QUANTITATIVI
Brescia, 1998
5
5
1. Premessa 7 2. Il nuovo ordinamento degli Enti locali 13 3. La riforma della statistica 19 4. Conoscere per deliberare 25 5. Statistica e processo decisionale: il quadro concettuale 31 6. Statistica e processo decisionale: i modelli interpretativi 37 7. Riferimenti bibliografici 47 8. Riferimenti normativi 55
9
9
L'Ufficio di statistica del Comune di Brescia ha svolto, nel corso
degli ultimi dieci anni, accanto alle originarie funzioni di Ufficio
periferico dell'ISTAT (con il conseguente carico di varie attività di
rilevazione, controllo e registrazione dei dati) alcune funzioni di
preminente interesse per l'Amministrazione locale.
Si pensi, solo a titolo esemplificativo, alla produzione di
documentazione statistica per la collettività locale, alla rilevazione delle
opinioni dei cittadini su temi di interesse dell'Amministrazione e, infine,
alla partecipazione, come fornitore di informazioni, a commissioni per la
predisposizione di documenti di programmazione.
L'attività dell'Ufficio si è venuta precisando ed arricchendo nel
tempo, anche a seguito di alcuni provvedimenti legislativi, determinando
lo sviluppo di tre diverse “anime” caratterizzate da funzioni distinte:
- funzioni proprie dell'anima istituzionale che consiste
nell'assicurare continuità, tempestività e qualità alle
rilevazioni programmate dal SISTAN e dal Comune;
10
10
- funzioni proprie dell'anima specialistica nella produzione
dell'informazione e nella ricerca a supporto delle esigenze
dell’Amministrazione;
- funzioni proprie dell'azione di consulenza tecnico-
metodologica al servizio di altri uffici dell'Ente, soprattutto
per quanto riguarda i sistemi informativi ed informatici,
l'informazione statistica, i modelli organizzativi ed i modelli
di ricerca, l’addestramento l’aggiornamento e la
professionalizzazione del personale nel campo della gestione
integrata delle informazioni.
L'Amministrazione ha seguito e assecondato l'evoluzione
dell'Ufficio riconoscendone il preminente ruolo di staff, alle dirette
dipendenze del Sindaco, e l'autonomia con il passaggio successivo a
Settore.
Proprio quest'ultimo atto, nonché l'insediamento della nuova
Amministrazione, è l'occasione per una riflessione più organica sulle
relazioni tra informazione statistica e processi decisionali pubblici, tema
basilare per il lavoro dell'Ufficio.
L'analisi della normativa, generale e specifica, costituisce il punto
di partenza obbligato.
Nella prima parte della nota, al punto 2, si ripercorrono le tappe
della riforma degli enti locali mettendo l'accento sui principi guida
contenuti nella legislazione.
Successivamente, al punto 3, vengono precisati i criteri che hanno
ispirato l'organizzazione del SISTAN e le tendenza di base dello sviluppo
della statistica ufficiale dei prossimi anni, così come delineati dagli
organismi centrali del SISTAN (ISTAT e Comitato di Indirizzo e
Coordinamento dell'Informazione Statistica) nei documenti ufficiali:
programmi statistici nazionali, direttive e Conferenza Nazionale di
Statistica.
Ovviamente la presentazione rispecchia marcatamente
l'interpretazione data dall'Ufficio all'insieme delle disposizioni prodotte a
livello ufficiale.
11
11
In questo quadro viene assegnato un ruolo chiave al collegamento
tra processo decisionale pubblico ed informazione statistica, nel senso
che le informazioni statistiche costituiscono il naturale supporto dei
processi decisionali in ambito pubblico.
Questo tema viene introdotto nel punto 4, mentre nel punto 5 viene
illustrato il quadro concettuale all'interno del quale si colloca il ruolo
della statistica rispetto ai processi decisionali.
Nel punto 6 si discute, scendendo nel dettaglio, sui principi cui
attenersi nella predisposizione dei modelli interpretativi e decisionali
della realtà; solo la specificazione di tali modelli consente, infatti, di
stabilire quali informazioni siano coerentemente, necessarie.
La trattazione segue con l'illustrazione di un esempio relativo al
Comune, ottenuto seguendo le funzioni dell'ente così come tracciate dalla
normativa sull'ordinamento delle autonomie locali, secondo la
tripartizione in settori organici di intervento relativi ai servizi sociali, allo
sviluppo economico ed al territorio.
Chiudono la nota alcuni riferimenti bibliografici, punto 7, e
normativi, punto 8.
Infine, la nota consiste, sostanzialmente, in una revisione (a cura di
L. R.) di un precedente lavoro: Comune di Brescia, Settore Statistica,
“Informazione statistica e processi decisionali pubblici: un quadro di
riferimento”, Brescia, 25 novembre 1994 (redatto da M. T.).
15
15
L'assetto istituzionale e operativo del Comune è stato
profondamente rinnovato negli ultimi anni a partire dall'approvazione
delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e sul procedimento
amministrativo1.
La legislazione emanata successivamente alle due fonti ricordate
non ha fatto altro che specificare, integrare ed approfondire concetti già
presenti, in nuce, nelle leggi citate2.
I (principali) principi guida dell'azione dell'Amministrazione, come
risultano dalla normativa, si possono così riassumere:
1) centralità dell'utenza
1 Si tratta delle ben note L. 142/90 e L. 241/90. A queste norme aggiungiamo una illustre
precedente, vale a dire la meno nota legge sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme (L. 15 del 4.1.1968), più nota come Legge
sull'autocertificazione ed infine i codici ed i regolamenti emanati durante la presenza di Cassese
quale Ministro per la funzione pubblica.
2 Si pensi a solo titolo esemplificativo alle leggi "finanziarie" approvate sotto i Governi Amato e
Ciampi, nonché ai recenti interventi sulla finanza pubblica del Governo Berlusconi.
16
16
Le funzioni generali attribuite al Comune, e le stesse modalità
partecipative con cui deve avvenire la cura degli interessi e lo
sviluppo della comunità locale, portano alla ovvia
conclusione che quello dei cittadini, nella veste di utenti dei
servizi comunali3, debba costituire il punto di vista attraverso
cui organizzare le attività4. In altri termini l'attività del
Comune deve essere finalizzata al soddisfacimento dei
bisogni della collettività e non, per esempio, alla produzione
arbitraria di pratiche;
2) partecipazione dei cittadini
Il nuovo ordinamento delle autonomie locali, e lo stesso
Statuto comunale, valorizzano il ruolo partecipativo dei
cittadini, singoli e variamente associati, all'Amministrazione
locale5. La partecipazione popolare è espressamente richiesta
nell'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche
soggettive, comprendendo, con ciò, la predisposizione di
documenti ufficiali quali, ad esempio, i piani di natura
programmatoria6;
3) orientamento economico dell'attività
Il Comune è, per sua natura, produttore ed erogatore di beni,
servizi ed informazioni7. Queste attività sono il frutto di un
vero e proprio processo produttivo nel quale alcuni input, il
personale, le risorse di capitale e le informazioni, vengono
trasformati in output, beni, servizi o informazioni. 3 Nella veste di utenti, si diceva, ma anche nella veste di finanziatori dei servizi, di controllori, cioè
di soggetti verso cui è orientata l'attività dell'ente.
4 Nell'ovvio significato che l'attività della struttura operativa dell'ente, articolata in settori e servizi,
deve essere orientata alla fornitura di servizi ai cittadini e non, invece, alla propria sopravvivenza,
ma anche nel significato, meno ovvio, di orientare la scelta delle priorità e quindi l'attribuzione delle
risorse.
5 Si veda l'intero capo III della L. 142/90 ed in particolare l'art. 6 commi 1 e 2.
6 Si pensi al Piano regolatore generale, al Piano commerciale, al Piano urbano del traffico e così
via.
7 Queste ultime sono prodotte, principalmente, rielaborando altre informazioni.
17
17
Questo processo è economico in quanto avviene in condizioni
di risorse scarse da ripartire nella realizzazione di una
pluralità di obiettivi8.
Seguendo questo schema il primo problema che si pone
riguarda l'efficacia del processo produttivo, cioè il perché si
fanno le cose, per usare una battuta. Solo dopo aver chiarito
questo primo aspetto l'attenzione va posta sull'ottimizzazione
nell'uso delle risorse, vale a dire sull'efficienza9;
4) trasparenza delle procedure
La produzione ed erogazione, proprio per il carattere pubblico
dell'attività del comune, viene sottoposta dalla legge a regole
ben precise che si possono riassumere con il termine di
trasparenza. Approfondendo il ragionamento si può affermare
che il carattere pubblico dell'attività svolta dal Comune è
determinato sì dalle finalità, ma altresì dai mezzi utilizzati per
conseguirle10.
Il rispetto dei principi elencati significa, tra l'altro, porre al centro
dell'attenzione delle amministrazioni locali la tematica della qualità dei
servizi pubblici, che altro non è se non la capacità di soddisfare le
esigenze espresse o implicite degli utenti, nel rispetto delle regole
generali di trasparenza dei processi decisionali e di partecipazione,
8 L'orientamento economico non è solo un criterio derivato dalla letteratura economica aziendale,
ma è contenuto pienamente nei principi di professionalità e responsabilità richiesti per
l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Principi, questi, che integrano e completano quei criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità parimenti richiesti all'organizzazione delle attività. Si veda
l'art. 51, comma 1, del Capo XIII, Uffici e personale, della L. 142/90.
9 Porsi i problemi in quest'ordine, prima l'efficacia e quindi l'efficienza, consente di rimettere l'azione
pubblica con i piedi per terra. Un esempio potrà chiarire la sostanziale diversità dei punti di vista. Si
pensi, per esempio, alla produzione di certificati. Ragionare in termini di efficienza significa porsi il
problema di produrli a minor costo, ragionare in termini di efficacia significa chiedersi se servono
veramente.
10 Citiamo, un po' alla rinfusa, i principi che la legge stabilisce debbano guidare l'attività
amministrativa: economicità, efficacia, pubblicità, certezza dell'inizio e del termine dei
provvedimenti, motivazione dei procedimenti, responsabilità del procedimento, partecipazione,
semplificazione ecc.
18
18
avendo in mente l'economicità dell'attività pubblica, quindi l'efficacia e
l'efficienza nella gestione delle risorse raccolte dalla collettività locale11.
11 Si vedano, a titolo esemplificativo, le norme UNI ISO 9004-2, relative agli Elementi di gestione
della qualità e del sistema qualità, Guida per i servizi.
21
21
Parallelamente al riassetto dell'ordinamento delle autonomie locali
venivano emanate le norme di istituzione del SISTAN12.
I principi stabiliti nella normativa, che hanno trovato applicazione
all'interno dei documenti di programmazione, come il Programma
statistico nazionale, possono essere ricordati brevemente.
1) le informazioni statistiche come bene pubblico
Le informazioni statistiche sono un vero e proprio bene
pubblico. Sono raccolte attraverso un canale pubblico, il
SISTAN con le sue varie articolazioni, e costituiscono un
patrimonio della collettività. Il possesso di informazioni
statistiche costituisce un vantaggio competitivo per il
sistema sociale ed economico del paese.
2) la statistica come supporto per le decisioni pubbliche
12 Si veda il repertorio delle norme che definiscono la struttura e le funzioni degli uffici di statistica,
in M. Palamenghi, La legislazione in materia statistica, Comune di Brescia, 1993.
22
22
Le informazioni statistiche sono destinate a soddisfare, in
primo luogo, la domanda di informazioni espressa dalle
amministrazioni produttrici di dati per far fronte alle proprie
esigenze operative. Ovvero, usando una felice espressione di
L. Einaudi, "conoscere per deliberare".
3) la statistica per il controllo delle attività delle
amministrazioni
I decisori, siano essi politici o dirigenti, in relazione
all'ambito di competenza13, non sono gli unici destinatari
delle informazioni statistiche. Per sostanziare i principi di
partecipazione e trasparenza delle procedure amministrative,
è necessario che i destinatari degli interventi14, possiedano gli
strumenti conoscitivi, anche quantitativi, per esercitare il
controllo sostanziale sulle attività svolte.
Parafrasando l'espressione einaudiana: "conoscere per
controllare".
4) il mercato dell'informazione statistica
L'informazione statistica prodotta dalle componenti del
SISTAN risponde non solo alle esigenze informative interne
alle amministrazioni stesse, ma è in grado di soddisfare il
fabbisogno espresso da soggetti esterni: le famiglie, le
imprese e istituzioni per far ricorso all'usuale tripartizione.
La fornitura di informazioni statistiche a soggetti esterni
implica la creazione di un vero e proprio mercato
dell'informazione, con operatori che esprimono una domanda
ed operatori che offrono informazioni e servizi.
13 Secondo la L. 142/90 la componente politica , in sintesi, ha compiti di indirizzo politico-
amministrativo mentre la dirigenza ha compiti di gestione.
14 Identificheremo spesso, nel prosieguo, i soggetti che interagiscono nel sistema economico e
sociale distinguendo tra famiglie, imprese e istituzioni. Per quanto riguarda le famiglie non vi sono
particolari osservazioni da fare se non per ribadire il carattere economico di alcune delle attività
svolte da esse: si pensi all'offerta di lavoro, o al consumo, solo per citare i primi che vengono in
mente. Ugualmente per le imprese. Parlando di istituzioni faremo riferimento ad un concetto ampio
che comprende le attività delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni private.
23
23
Poiché i dati statistici prodotti dal SISTAN sono comunque
beni pubblici, scaturiscono alcune conseguenze che è
opportuno analizzare rapidamente.
a) La diffusione delle informazioni deve rispondere a precisi
requisiti di tutela della privacy dei fornitori di
informazioni, tanto più se si pensa che, nel caso degli
archivi amministrativi, non esiste consenso all'utilizzo dei
dati forniti. La tutela del segreto statistico è condizione
essenziale per garantire tutti i soggetti coinvolti a partire
dalle famiglie e dalle imprese.
b) I dati diventano informazioni se incorporano il valore
aggiunto costituito, in primo luogo, dai modelli
interpretativi della realtà ed in secondo luogo dai servizi di
elaborazione dei dati15.
La valorizzazione dei dati comporta, ovviamente, dei costi
per il produttore ed andrebbe adeguatamente compensata,
fissando un vero e proprio tariffario.
c) La capacità di affrontare il mercato significa altresì
necessità di individuare esattamente le esigenze
informative, espresse o potenziali16, dei vari operatori17.
Perché questi principi vengano realizzati è necessario che il
produttore di informazioni dia ampie garanzie, nel proprio modo di
procedere, di imparzialità, obiettività ed inattaccabilità sul piano del
metodo. 15 La differenza tra statistici ed informatici può essere colta proprio in relazione a questi due aspetti
essendo i secondi i semplici gestori delle basi di dati, mentre i primi gli utilizzatori; con un ovvio
primato degli statistici rispetto agli informatici. Questi concetti sono contenuti anche nella normativa
che prevede l'istituzione dell'Autorità per l'informatica pubblica.
16 Tenere in considerazione anche le esigenze potenziali della domanda trova la sua ragione
d'essere, oltre che in un criterio generale relativo alla qualità dei servizi (in altre parole si tratta di
"fare l'interesse del cliente"), in una considerazione di carattere etico . La domanda che si ha di
fronte è, spesso, costituita da soggetti che non sempre possiedono una visione globale e coerente
delle alternative da considerare per la soluzione dei problemi. Dare sostanza al principio della
partecipazione significa, anche, consentire il superamento di questo gap.
17 Vale a dire il target per usare un termine che, essendo di moda, è ampiamente abusato.
24
24
Di seguito svilupperemo, separatamente, i temi trattati in
precedenza con particolare attenzione alle modalità con cui
l'informazione statistica entra nel processo decisionale.
Questo punto rappresenta la novità più rilevante che la normativa in
vigore ha stabilito.
Gli altri aspetti, come l'uso delle informazioni per il controllo18, e
l'orientamento alla domanda nella produzione delle statistiche, non
richiedono particolari commenti.
18 O per il rendiconto, per usare un termine carico di significati.
27
27
Potrebbe sembrare banale affermare che il processo decisionale
nell'ambito pubblico deve tenere conto di obiettivi generali e specifici che
riguardando la rappresentanza, gli interessi e lo sviluppo delle comunità
locali.
Questa affermazione acquista un senso meno banale se viene
inquadrata all'interno dei principi generali già ricordati in premessa, ed in
particolare quando si convenga sul carattere economico dell'attività del
Comune.
Parlando di processo decisionale, relativamente ad aziende
pubbliche, si è tentati di compiere paragoni tra le modalità con cui
vengono prese le decisione nel pubblico e nel privato.
I motivi sono molteplici.
Esiste, in primo luogo, una riflessione nella letteratura economica
aziendale piuttosto ampia e consolidata, ed inoltre, ed è il secondo
aspetto, è ormai un luogo comune ritenere più efficienti i processi
decisionali nell'ambito privato.
28
28
Per procedere occorre avere in mente che la distinzione
fondamentale tra i due ambiti, pubblico e privato, si colloca nelle
differenti caratteristiche che assume il processo decisionale in relazione,
anche ma non solo, ai differenti obiettivi.
Nell'ambito privato, per esempio, l'obiettivo, almeno quello di
breve periodo, è sufficientemente chiaro19 e noto a tutti, ed esiste, nelle
situazioni normali, una linearità dei comportamenti in funzione del
raggiungimento dell'obiettivo20.
Nell'ambito pubblico la situazione appare più complessa potendosi
distinguere due livelli.
Il primo attiene alla chiarezza e condivisione degli obiettivi, mentre
il secondo riguarda, più propriamente, la linearità dei processi
decisionali21.
Quanto agli obiettivi si è già ricordato, più volte, la centralità
dell'utenza e gli altri aspetti collegati, tanto che riteniamo sia superfluo
approfondire l'argomento ancora una volta. In una battuta: l'informazione
statistica consente la partecipazione alle scelte anche nel duplice
significato del consenso informato alle scelte stesse e del concorso alla
predisposizione di proposte di soluzione dei problemi.
Il problema della linearità dei processi decisionali rimanda invece
ai mezzi da usarsi per raggiungere gli obiettivi.
A questo proposito è necessario ribadire che fini e mezzi,
nell'azione pubblica, non possono essere disgiunti, come può avvenire
nell'impresa privata.
Anzi, è proprio il dibattito sui mezzi utilizzabili nell'azione
pubblica che consente di delineare con chiarezza gli obiettivi che si
vogliono perseguire.
19 E' il profitto, o la redditività del capitale investito ...; dipende dai punti di vista.
20 E' spesso sufficiente il controllo di una sola leva interna, finanziaria, produttiva ecc. per garantire
il raggiungimento degli obiettivi. In questi contesti la linearità del processo decisionale è facilmente
raggiungibile.
21 Si rammenti che nel pubblico contano sì i fini, ma anche i “mezzi” e i “modi”.
29
29
Il processo decisionale pubblico deve perciò possedere requisiti di
trasparenza e partecipazione, da cui la necessità di un approccio razionale
alle decisioni.
In altri termini solo la trasparenza su tutti gli elementi che hanno
condotto alla decisione22 costituisce una garanzia per i cittadini, i quali
sono in grado di valutare appieno le direzioni e gli effetti delle differenti
scelte politiche.
La componente burocratica ha il compito di prospettare le
alternative praticabili, sulla base di criteri generali che rimandano ai
principi normativi23 ed alle competenze tecniche proprie24.
La componente politica ha, invece, il compito di definire gli
indirizzi politico-amministrativi e scegliere le alternative che meglio
rispondono alle esigenze attuali e future della comunità.
Una caratteristica saliente del processo decisionale pubblico, così
come delineato, è data dalla necessità della burocrazia di operare sotto i
molteplici vincoli derivanti da un sistema normativo in cui non sempre è
definito un insieme coerente di principi cui attenersi nelle situazioni
concrete25. La soluzione del dilemma, ed il ripristino della linearità dei
processi decisionali, passa, quindi, attraverso la ricostruzione di un
22 In altri termini possiamo parlare di elencazione completa delle regole del gioco a cui ci si è
attenuti.
23 Il termine di principi normativi è volutamente generico ricomprendendo tutto quanto costituisce la
guida all'operare della Pubblica Amministrazione. In primo piano vi è la Costituzione della
Repubblica, quindi vengono le Leggi dello Stato e quelle Regionali e lo Statuto comunale. Nel
"quadro normativo", così come inteso, si colloca pure il programma della Giunta municipale, che è
il documento che contiene gli indirizzi politico-amministrativi che l'Amministrazione intende
perseguire.
24 E' qui che entrano le conoscenze degli strumenti teorici forniti dalla letteratura tecnica, ad
esempio dalle tecniche aziendali, finanziarie, economiche, matematiche ecc.
25 Un esempio potrà chiarire il concetto. Si pensi al principio del diritto al lavoro e all'analogo
principio della tutela dell'ambiente naturale, nel caso in cui non vi sia nessuna priorità di legge e vi
sia una impresa inquinante. Un insieme coerente di principi sarebbe quello che stabilisce priorità
all'occupazione. Il dilemma di prima sarebbe già risolto: l'impresa potrebbe continuare a produrre
inquinando il meno possibile. Spetta alla politica dirimere la questione, dal momento che si è di
fronte ad una scelta tra due principi altrettanto legittimi.
30
30
sistema coerente di principi, cosa ottenibile attraverso la fissazione di una
gerarchia degli stessi26.
Affronteremo di seguito tre aspetti del problema articolando, con
un certo grado di dettaglio, il ruolo dell'informazione statistica nei
processi decisionali pubblici.
Nella prima parte, relativa al quadro concettuale, verranno
evidenziati i livelli dell'attività politica e le soluzioni informative; nella
seconda parte si discuterà dei principi cui ancorare i modelli interpretativi
che sono l'elemento che costituisce la griglia necessaria per poter
procedere alle elaborazioni statistiche.
Infine, nella terza parte, viene proposto un quadro d'insieme per il
Comune, ottenuto articolando e specificando i principi di costruzione dei
modelli interpretativi per i settori organici di intervento dell'ente previsti
dalla L. 142/90, vale a dire servizi sociali, sviluppo economico e tutela
del territorio.
26 E' questo un ambito tipico in cui, fatte salve le riserve di legge, si può esercitare l'autonomia
delle amministrazioni locali. In particolare lo Statuto comunale è il documento in cui trovano spazio
le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente.
33
33
L’informazione statistica gioca un ruolo centrale nei processi
decisionali pubblici, perché la sua funzione consiste nel fornire il
supporto, prevalentemente, quantitativo alle decisioni.
E' chiaro che ciò può accadere solo se si verifica uno stretto
collegamento tra decisori e produttori di informazioni; la conoscenza dei
modelli interpretativi e decisionali della realtà è una condizione
essenziale per consentire la produzione di informazioni puntuali e
coerenti.
Spesso si assiste invece a decisioni prese non tanto in assenza di
informazioni statistiche27, ma in presenza di dati che non sono
minimamente collegati all'articolazione del processo decisionale.
L'esame dei livelli in cui si caratterizza l'attività della componente
politica è perciò preliminare ad ogni altro aspetto. Nel prosieguo
27 Questa pratica, deplorata, per motivi ovvi, dagli statistici, è del tutto legittima, poiché seguire
metodi razionali nei processi decisionali non assicura la bontà dei risultati, anche se assicura la
trasparenza delle procedure, cioè delle regole del gioco.
34
34
considereremo tre livelli dell'attività in relazione a tre orizzonti temporali
di riferimento.
1) Il medio periodo: il futuro.
Esistono molteplici attività delle Amministrazioni pubbliche
che richiedono, per loro natura, tempi lunghi di progettazione
ed esecuzione28, e, maggiore è il tempo, maggiore è
l'incertezza e quindi il rischio connesso alle decisioni.
Conoscere il futuro è sicuramente impossibile; è percorribile,
invece, la via di prefigurare le alternative possibili,
evidenziare le leve che i decisori hanno a disposizione e
presentare le conseguenze delle differenti scelte di intervento.
Dal punto di vista statistico lo strumento tipico per affrontare
problemi di questa natura consiste nella costruzione di
scenari.
Si tratta di un'area in cui gli elementi qualitativi sono
preponderanti rispetto agli elementi quantitativi, o, in altri
termini, in cui contano più le direzioni di tendenza, o i segni
di certi fenomeni, che i valori puntuali che verranno
effettivamente raggiunti29.
Un esempio potrà chiarire i punti del ragionamento.
Le previsioni della popolazione nel medio periodo, 30 anni,
possono costituire una parte dello scenario relativo
all'evoluzione del sistema sociale ed economico locale e
consentono di stimare la domanda potenziale dei servizi
pubblici.
Lo scenario socio-demografico ha lo scopo di fornire
informazioni circa le direzioni dei fenomeni (in crescita o in
contrazione), la cadenza temporale ed, eventuali, inversioni di
tendenza degli stessi.
28 Si pensi, solo per esemplificare, al progetto di realizzazione della metropolitana leggera.
29 E' l'ambito tipico della raccolta ed esame a tavolino delle informazioni, o della raccolta di opinioni
di osservatori qualificati, i ben noti testimoni privilegiati.
35
35
2) Il breve periodo: la legislatura.
L'arco temporale di breve periodo può essere
convenzionalmente fissato in quattro anni, cioè nel periodo
della durata in carica degli organi istituzionali dell'Ente
(Sindaco, Giunta, Consiglio).
In un arco temporale così corto può essere avviata la
riprogettazione dei servizi lungo le direttrici che emergono
dagli scenari di medio periodo, ricorrendo anche allo
strumento dei bilanci pluriennali.
E' questo l'ambito di applicazione dei modelli (aziendali,
economici, ..., sociologici) di interpretazione della realtà.
Le necessità statistiche afferenti questi modelli possono
essere soddisfatte attraverso stime dei parametri caratteristici
dei modelli stessi, vale a dire stime effettuate su informazioni
aggregate ricavabili dall'evoluzione storica del fenomeno, da
esperienze già vissute da altre realtà analoghe, o da
esperienze già vissute dagli "innovatori".
Riprendendo l'esempio delle previsioni demografiche, nel
breve periodo è possibile passare a stimare, sulla base dei dati
recuperabili dai sistemi informativi interni, i tassi di ricorso ai
servizi pubblici, magari specifici per tipologia di utente.
Informazioni di questa natura consentono di passare dalla
stima della domanda potenziale alla stima e specificazione
della domanda effettiva.
3) Il brevissimo periodo: le attività d'esercizio.
Una volta fissato lo scenario di riferimento, quindi la
direzione, nonché la progettazione della qualità e della
quantità dei servizi, rimane la fase, di brevissimo periodo,
collegata alla gestione delle attività correnti.
Le necessità informative fanno riferimento alle tecniche che
consentono l'allocazione ottimale di risorse scarse a fronte di
una pluralità di obiettivi, quindi agli strumenti concettuali
36
36
forniti dall'analisi economica, dalla ricerca operativa, dalle
tecniche aziendali e così via.
La statistica consente, con i propri strumenti di analisi, la
stima dei parametri guida della gestione, nonché li
“controllo” della gestione stessa.
La base dei dati è fornita dal sistema informativo aziendale,
da cui originano i dati gestionali, purché siano soddisfatte
alcune condizioni generali che riguardano, in sintesi, i
requisiti di unicità dell'archivio, unicità del modello di
organizzazione dei dati, ed unicità dello strumento di
elaborazione30.
Per riprendere l'esempio che ha guidato l'esposizione negli
ultimi punti, le informazioni necessarie per il livello
gestionale non coinvolgono le stime della domanda, ma
piuttosto devono essere finalizzate alla gestione ed al
miglioramento della qualità dei servizi erogati. Ciò può
avvenire, ad esempio, attraverso la valutazione dell'efficacia
dell'intervento effettuato dalle strutture pubbliche su un
determinato utente31.
Questo richiede, tra l'altro, che il sistema informativo
consenta, in ogni momento e senza ambiguità, di ricostruire
l'intera gamma di interventi e servizi che hanno come
destinatario quel certo utente.
30 In altri termini che non esistano ridondanze o duplicazioni nei dati, nei modelli concettuali e negli
strumenti di trattamento delle informazioni.
31 Per usare una terminologia traslata si può parlare di “ritorno dell'investimento” rispetto
all'obiettivo fissato. L'obiettivo non sarà, ovviamente, monetario, ma sarà nel miglioramento,
tamponamento o contenimento delle condizioni sociali, sanitarie, ecc. della popolazione.
39
39
Forse può sembrare paradossale l'affermazione che i dati statistici
non hanno un particolare valore in sé e per sé. A ben vedere si può
convenire che un'informazione statistica non collegata ad alcun modello
interpretativo e decisionale della realtà risulta del tutto priva di valore
operativo.
La conseguenza di ciò è che i produttori di informazioni statistiche
si devono collocare in stretto contatto con i decisori, siano essi politici o
tecnici.
In effetti è solo dopo aver definito il modello di riferimento32 che
intervengono i produttori di informazioni che provvedono alla
specificazione dei dati necessari per quantificare i vari parametri, alla
32 Il modello di interpretazione non è altro che una descrizione della realtà nella quale vengono
messi in evidenza gli agenti che possono intervenire, i vincoli sotto cui devono operare, le relazioni
tra gli agenti che si ritengono rilevanti e le forze che portano al movimento.
40
40
raccolta dei dati ed infine alle elaborazioni utilizzando le metodologie
statistiche33.
Il problema di fondo per chi si occupa di fornire informazioni non è
tanto nella scelta del modello cui ispirarsi34, quanto piuttosto, in assenza
di indicazioni puntuali, nella definizione dei principi cui attenersi nella
predisposizione dei modelli interpretativi.
Su questo punto discuteremo nel prosieguo.
La definizione dei modelli interpretativi e decisionali, così come
l'ambito della scelta esulano dalle competenze strette dell'Ufficio di
statistica.
Il compito di chi fornisce le informazioni, nel rispetto delle regole
generali esposte in precedenza, deve essere limitato alla sola valutazione
della coerenza interna del modello o dei modelli prescelti dai decisori ed
alla scelta delle informazioni congruenti con i modelli stessi.
E' quindi possibile che si sottopongano a quantificazione e
valutazione modelli anche tra loro conflittuali.
Qualora i modelli non vengano esplicitati l'Ufficio, con la sua
professionalità e con eventuali supporti esterni35, può scegliere propri
modelli.
Ovviamente, vista la delicatezza della materia, l'Ufficio dovrà
attenersi a precise regole di comportamento nella scelta dei principi
necessari per definire i modelli interpretativi e decisionali da utilizzare.
Due sono le direzioni che possono essere seguite senza correre il
rischio, presente quando si tratta di effettuare scelte sostanziali, di "essere
di parte" nel senso deteriore del termine.
33 Gli statistici, per usare un altro linguaggio, si occupano della identificazione delle variabili rilevanti
per il problema in questione, definizione della matrice dei dati, della misurazione delle stesse,
costruzione della matrice dei dati, fino alle elaborazioni sulla matrice medesima.
34 Per esemplificare nell'ambito economico è possibile rifarsi a modelli liberisti o statalisti; entrambi
per poter diventare strumenti di azione richiedono informazioni, magari sui medesimi aspetti del
sistema economico.
35 Questo che stiamo descrivendo è l'ambito nel quale possono trovare collocazione le consulenze
esterne di natura specialistica.
41
41
Una prima direzione consiste nel seguire, quali principi ispiratori
dei modelli, principi comuni e quindi condivisi da tutti.
E' il caso, per esemplificare, dei fondamenti costituzionali, vale a
dire delle regole della convivenza civile.
Una seconda direzione consiste nello scegliere principi
scientificamente validi, cioè principi che le diverse discipline hanno
sviluppato ed affinato nel corso del tempo.
E' il caso dei modelli dell'analisi economica o sociologica tanto per
fare un esempio.
Gli argomenti sviluppati fino a questo punto sono volutamente
generici e possono essere specificati per le varie amministrazioni avendo
in mente compiti e funzioni dei singoli enti.
L'esempio del Comune potrà servire a chiarire meglio i concetti
precedenti.
I principi stabiliti dalla normativa possono costituire la trama del
disegno, con riferimento, in particolare, all'autonomia dell'ente locale.
L'autonomia locale si sostanzia nella attribuzione ai comuni delle
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale.
Nella legislazione recente vengono individuati tre settori organici di
intervento relativi ai servizi sociali, cioè alla popolazione, allo sviluppo
economico, quindi alla capacità del sistema economico di soddisfare le
esigenze della popolazione, ed al territorio, nel senso della compatibilità
dello sviluppo economico e sociale con l'ambiente.
Questa tripartizione può essere ripresa allo scopo di mettere in
evidenza i principi comuni che possono ispirare l'Ufficio nella sua
attività.
Esamineremo separatamente i tre livelli.
1) L'informazione sulle famiglie-abitazioni
Al centro dell'attenzione viene posta la famiglia per almeno
due ordini di ragioni:
42
42
- la famiglia è il soggetto sociale elementare cui deve essere
indirizzata l'attività dell'ente36;
- è all'interno della famiglia che prendono corpo alcune
fondamentali decisioni che coinvolgono direttamente
l'erogazione di servizi pubblici37.
Accanto alla famiglia si colloca l'abitazione, cioè il luogo in
cui la famiglia svolge buona parte delle proprie attività
fondamentali.
I problemi relativi all'ambito delle famiglie possono essere
sinteticamente ricondotti, per usare una battuta, alle
problematiche connesse all'eterogeneità dei gruppi sociali che
vivono sul territorio.
Eterogeneità è volutamente un termine generico che consente
di comprendere, logicamente, anche situazioni estremamente
differenziate: dai problemi relativi al benessere, e quindi alla
povertà, fino all'immigrazione straniera.
Nel trattare le tematiche connesse alla famiglia, ci si ispira a
tre principi:
- diffondere il benessere e la qualità della vita;
- tutelare la convivenza civile;
- valorizzare il senso di appartenenza ad una comunità.
Si tratta di principi estremamente generali, ma non per questo
generici, dal momento che consentono di guidare le scelte
operative ed informative.
Il principio della valorizzazione del senso di appartenenza fa
riferimento alla costruzione, o ricostruzione, di un tessuto
sociale equilibrato e quindi più solido.
Il principio di benessere fa riferimento alle modalità di
ripartizione delle risorse tra gruppi della popolazione. Non vi
sono particolari riflessioni da aggiungere essendo un tema 36 E' la già citata centralità dell'utenza.
37 E' solo il caso di citare di sfuggita, e senza essere esaustivi, le decisioni in materia di assistenza,
educazione , mobilità, sanità e così via.
43
43
ampiamente dibattuto nella letteratura sociale, economica e
politica.
Il principio di convivenza civile, infine, fa riferimento
all'equilibrio che deve sussistere in tutte le comunità tra diritti
individuali e regole di vita comune.
Un esempio potrà chiarire il concetto.
L'integrazione degli stranieri di recente immigrazione
costituisce per il Comune un obiettivo generale in relazione ai
principi appena esposti.
L'Ufficio di statistica produrrà le informazioni necessarie per
identificare e quantificare gli elementi che costituiscono un
ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo. Si tratta allora di
fornire informazioni, per esempio, sull'abitazione, sugli
aspetti dell'istruzione, ma anche, per esempio, sulle
condizioni igienico-sanitarie della popolazione straniera.
2) L'informazione sulle imprese-aziende
L'attività dell'ente ha lo scopo di favorire lo sviluppo
economico nel senso della capacità del sistema economico di
soddisfare le esigenze della popolazione con i vincoli imposti
dal sistema sociale ed ambientale.
Una corretta impostazione dell'analisi richiede di porre
l'attenzione sull'anello terminale del sistema economico, vale
a dire sui singoli operatori economici e sulle attività da essi
svolte, in altri termini principalmente sul binomio impresa-
azienda38.
L'interesse del Comune è verso quegli elementi che, in
prospettiva, possono costituire punti di difficoltà per il
sistema delle imprese. I termini sono volutamente generici
poiché si vogliono ricomprendere tutte le fasi dei processi
38 Le imprese non sono gli unici soggetti economici, accanto ad esse operano anche le famiglie,
nella veste di consumatori finali, di beni e servizi, di centro di offerta di lavoro, e di centro di
produzione, e le istituzioni, pubbliche e private.
44
44
produttivi: reperimento delle materie prime, domanda e
offerta di lavoro, ..., fino alla commercializzazione dei
prodotti.
Nel trattare le tematiche connesse all'impresa, ci si può
ispirare a vari principi riconducibili alla necessità di:
- consentire lo sviluppo di attività produttive compatibili con
le esigenze sociali;
- rispettare le compatibilità ambientali;
- garantire il corretto funzionamento dei mercati.
Il primo principio fa riferimento alla necessità che il sistema
produttivo soddisfi, principalmente, le esigenze della
comunità locale.
Il secondo principio fa riferimento alla necessità di bilanciare
le esigenze produttive con quelle ambientali con riferimento
al prelievo di risorse effettuato sull'ambiente e all'immissione
di prodotti nell'ambiente sotto forma di rifiuti ed
inquinamento.
Il terzo principio fa riferimento alla garanzia di efficienza dei
mercati per quanto attiene alla parità di condizioni tra tutti gli
operatori economici, e quindi, in ultima analisi, al
soddisfacimento delle esigenze dei destinatari dei beni e
servizi prodotti.
Un esempio potrà chiarire i concetti espressi in precedenza.
Il sistema del commercio si sta rapidamente evolvendo sulla
base di dinamiche interne collegate alla nascita di nuove
tipologie distributive, i discount in primo luogo.
E' interesse della collettività locale che tale trasformazione
avvenga in modo tale da garantire, tra l'altro, che tutte le zone
della città, quartieri "ricchi" e "poveri", e tutte le fasce di
mercato, "giovani" ed "anziani", possano avere facile accesso
alla distribuzione.
L'Ufficio di statistica fornirà, tra l'altro, le informazioni
necessarie, per esempio, per quantificare e qualificare gli
effetti dell'innovazione del settore commerciale sul sistema
45
45
sociale ed economico, cioè gli elementi guida per la
programmazione nel settore.
3) L'informazione sul territorio
Il terzo ambito di intervento riguarda gli effetti delle attività
umane sul territorio.
Tutte le attività umane di produzione, ma anche di consumo,
generano effetti che vengono scaricati sull'ambiente naturale.
Nella definizione dei principi ci atterremo all'ampio
riconoscimento39 che ricevono le necessità di:
- tutelare il paesaggio, intendendo con ciò la difesa della
biosfera;
- garantire uno sviluppo sostenibile40;
- tutelare la diversità biologica41.
Per quanto riguarda i primi due punti, essendo giunti
all'attenzione di esperti e cittadini da molti anni ed essendo
ampiamente dibattuti, non vi sono particolari riflessioni da
svolgere.
La tutela della diversità biologica merita invece una battuta.
L'eterogeneità in ambito ambientale è legata alla capacità dei
viventi, umani ed animali, di adattarsi all'evoluzione
dell'ecosistema, ed è legata, quindi, alla garanzia di
sopravvivenza delle diverse specie.
39 Si pensi, ad esempio, alla recente Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di
Rio de Janeiro, o alle disposizioni di provenienza comunitaria sulle tematiche dello sviluppo
sostenibile.
40 Si veda ad esempio il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'Agenda XXI
adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, approvato dal CIPE nella
seduta del 28 dicembre 1993.
41 Nella convenzione sulla biodiversità approvata dalla Conferenza citata, e ratificata nel febbraio
1994 dal Presidente della Repubblica, si sottolinea, nel preambolo, il valore intrinseco della
diversità biologica e del valore della diversità nei suoi componenti ecologici, genetici, sociali,
economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici.
46
46
L'applicazione di questi principi consente di valutare ogni
attività umana nella prospettiva dell'impatto, desiderato o
indesiderato, che può avere sull'ambiente naturale.
Un esempio potrà chiarire, anche in questo caso, i concetti.
Si pensi, tanto per fare un esempio, agli effetti inquinanti
delle attività produttive, come le tintorie, le carrozzerie ecc.
In queste situazioni può risultare conveniente per la
collettività comprare un rifiuto tossico piuttosto che
sopportare il rischio che si disperda o che si mescoli con altri.
Per ogni attività è possibile definire un bilancio, anche
monetario, tra costi e benefici in relazione all'ambiente,
all'occupazione, o in altri termine alla pluralità di aspetti del
fenomeno.
Le informazioni che verranno fornite possono consentire la
definizione, per ognuna delle attività, del grado di
compatibilità con l'ambiente, giungendo fino a quantificare i
costi delle differenti alternative che ha l'amministrazione
pubblica. Alternative che vanno dalla continuazione delle
attività così come sono svolte, fino alla chiusura della stesse,
o alla rilocalizzazione.
La tripartizione seguita costituisce sicuramente una semplificazione
rispetto alla complessità della realtà sociale ed economica. Basti pensare
ad aspetti quali la mobilità che coinvolgono le persone in quanto soggetti
che si spostano, ma coinvolgono le attività economiche, ed ai pesanti
costi che si scaricano sul territorio quando la mobilità si manifesta.
49
49
AA.VV., "Statistica e processi decisionali nella pubblica
amministrazione", Atti del Seminario di studio di Bressanone, 12-13
settembre 1988, Padova, CLEUP editore, 1989
AA.VV., "Segreto Statistico. Esigenze conoscitive e tutela della privacy",
Atti del Convegno USCI, Lucca, 1990
R. N. Anthony, D. W. Young, "Controllo di gestione per gli enti pubblici
e le organizzazioni non profit", McGraw-Hill, Milano, 1992
G. Bellitti, R. Tomei, "Il censimento demografico. Lineamenti giuridici e
organizzativi", Ordinamento e amministrazione, Quaderni di ricerca,
ISTAT, 1/1992
G. Bellitti, R. Tomei, "L'accesso ai dati statistici", Ordinamento e
amministrazione, Quaderni di ricerca, ISTAT, 2/1992
50
50
S. Borra, F. Crescenzi, "La tutela della riservatezza dei dati demografic:
proposte e problemi aperti", Metodologia e informatica, Quaderni di
ricerca, ISTAT, 1/1993
V. Buzzi Donato, "Statistica ed enti locali", Informatica ed enti locali, n.
1, Gen-Mar 1989
G. Casati, “La misurazione e la valutazione dei risultati nei servizi
pubblici”, Azienda pubblica, 1992
V. Castellano, "... ma l'università statale non è anch'essa un servizio?",
Statistica, anno LIII, n. 2, 1993
R. Cavallo Perin, “Comuni e province nella gestione dei servizi
pubblici” , Jovene, Napoli, 1993
B. Colombo, "Considerazioni 'laiche' su alcuni interventi di 'chierici'",
Statistica, n. 1, 1991
Comune di Brescia, Servizio Statistica, "Il Servizio Statistica del Comune
di Brescia nel quinquennio 1986-1990", agosto 1990
Comune di Brescia, Servizio Statistica, "Proposta per il Programma
statistico comunale per il triennio 1995-1997", febbraio 1994
Comune di Brescia, Servizio Statistica, "Relazione annuale per l'anno
1993", febbraio 1994
Comune di Brescia, Settore Statistica, "L'attività del Settore Statistica dal
1990 al 1993", marzo 1994
A. Cortese, "Il quadro evolutivo delle statistiche demografiche, sociali e
ambientali negli anni '80", Interventi e relazioni, ISTAT, 1993
51
51
F. De Sandre, U. Trivellato, R. Capocaccia, "Sull'accesso ai dati statistici
elementari", Bollettino della Società Italiana di Statistica, n. 19-20,
Settembre 1990
J. Delors, "Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da
percorrere per entrare nel XXI secolo. Libro bianco", Commissione delle
Comunità Europee, Milano, Saggiatore, 1994
Dipartimento per la Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, "Carta dei servizi pubblici. Proposta e materiali di studio",
Quaderni del Dipartimento, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
Roma, 1993
F. Endrici, "La riorganizzazione della statistica pubblica: il governo del
sistema", Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1990, 1902 ss.
P. Garonna, "La statistica nel processo di integrazione economica
europea", Atti della XXXVII Riunione Scientifica della SIS, 6-8 aprile
1994
P. Garonna, "Statistical 'decentramento' in Italy: Significance and
Implication", SISTAN, ISTAT, Quaderni di Ricerca, Interventi e
relazioni, 1993
G. Gasbarri, "Il microcosmo territorio: un laboratorio per l'informatica
evolutiva", Inchiesta, gennaio-marzo 1990
E. Giovannini, "L'informazione statistica per le decisioni: alcune linee
generali e un esempio illustrativo", ISTAT, Quaderni di ricerca, 1994
M. Godet, “Crise de la prèvision. Essor de la perspective”, Presses
Universitaires de France, Paris, 1972
52
52
L. Guerra, "La riorganizzazione della statistica pubblica: il Sistema
Statistico Nazionale", Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1990
ISTAT, "Atti del Convegno sull'informazione statistica e i processi
decisionali", Annali di Statistica, Serie IX, vol. 7, ISTA, Roma
M. La Rosa, E. Minardi, A. Montanari, “I servizi sociali tra
programmazione e partecipazione”, F. Angeli, Milano, 1977
L. Luini, "Economia dell'informazione. Mercato, tecnologia,
organizzazione", La Nuova Italia Scientifica, Firenze, 1994
G. Marbach, C. Mazziotta, A. Rizzi, "Le previsioni. Fondamenti logici e
basi statistiche", Etaslibri, Milano, 1991
A. Martelli, "Analisi strategica mediante scenari. Dal macro al
microambiente: teorie e metodi", Etaslibri, Milano, 1992
F. Martufi, “Pianificazione territoriale e pianificazione dei servizi” ,
Edizioni delle autonomie, Roma, 1993
G. Muraro, Economia dell'informazione ed economia pubblica, Il
Mulino, Bologna, 1992
A. M. Okun, Eguaglianza ed efficienza, Liguori, napoli, 1990
M. Palamenghi, La legislazione in materia statistica, SISTAN, Comune
di Brescia, Servizio Statistica, Rapporto tecnico n. 4, Brescia, 1993
A. Predetti, L'informazione economica di base, Milano, Giuffrè editore,
1983
A. Predetti, "Il nuovo ordinamento statistico nazionale è al nastro di
partenza", Rivista milanese di economia, n. 32, 1990
53
53
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica, "Carta dei servizi pubblici. Proposta e materiali di studio.",
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica, "Tecniche per la misurazione dei costi e del rendimento nelle
oubbliche amministrazioni", Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, 1994
G. M. Rey, "Informazione statistica e decisione pubblica", Interventi e
relazioni, Quaderni di ricerca, ISTAT, 1992
G. M. Rey , "Il Sistema Statistico Nazionale", Interventi e relazioni,
Quaderni di ricerca, ISTAT, 1992
A. Righi, V. Terra Abrami, "Verso lo sfruttamento integrato delle
indagini e delle rilevazioni a fini demografici", Famiglie e società,
Quaderni di ricerca, ISTAT, 1/1993
A. Sen, La diseguaglianza, Il Mulino, Bologna, 1994
C. L. Schultze, L'uso pubblico dell'interesse privato, Guerini e Associati,
Milano, 1993
M. Trentini, "Riflessioni sulle conseguenze delle recenti disposizioni di
legge sul sistema informativo del Comune", Comune di Brescia, Servizio
Statistica, Pro memoria 1/94, Brescia, 1994
S. Vianelli, "Sulla statistica sociale", Statistica, anno LIII, n. 1, 1993
V. Visco Comandini, M. Volpe, “Efficienza e produttività dei servizi
pubblici. Il caso dei comuni italiani”, F. Angeli, Milano, 1986
54
54
A. Zuliani, “Presentazione della sessione specializzata ‘Metodi statistici
di valutazione dell’attività della Pubblica Amministrazione’”, Atti della
XXXIII Sessione Scientifica della Società Italiana di Statistica, 1986
A. Zuliani, "Informazione statistica, decisioni, comportamenti",
Relazione del Presidente dell'ISTAT alla seconda conferenza nazionale
di statistica, Roma, 15-17 novembre 1994, stesura provvisoria
L. Worral, “Urban demographic information systems”, in: P. Congdon, P.
Batey (Editors), “Advances in regional demography”, Belhaven Press,
London, 1989
57
57
8.1 Normativa di riferimento generale
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, Decreto 31 marzo 1994 del Ministro per la funzione
pubblica
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, Carta dei servizi
pubblici, 28 gennaio 1994
Nuove norme sulle opere pubbliche, cosiddetta "Legge Merloni" sugli
appalti, gennaio 1994.
Norme attuative della Legge 15 gennaio 1968 n. 15, con particolare
riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive, 21 gennaio 1994.
58
58
Interventi correttivi di finanza pubblica, L. 24 dicembre 1993, n. 547, e
regolamento del Ministro del Bilancio sull'applicazione dell'art. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 1994), 22 dicembre 1993.
Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23
ottobre 1989, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale, e
circolari collegate, novembre dicembre 1993.
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art
2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, Decreto Legislativo n. 29, 3
febbraio 1993.
Decreto interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro del
Tesoro 28 maggio 1993 sulla definizione dei servizi locali indispensabili.
Finanziaria 1993, Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Statuto del Comune di Brescia.
Ordinamento delle autonomie locali, Legge 8 giugno 1990, n. 142,
aggiornata e coordinata con la Legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione
diretta dei Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio
comunale e del Consiglio provinciale.
59
59
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione delle firme, Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
8.2 Normativa statistica
Norme generali
Legge 23 dicembre 1992, n. 498
Interventi urgenti in materia di finanza pubblica
DPR 2 aprile 1992, DPR 10 aprile 1992
Approvazione del Programma statistico nazionale per gli anni 1992-1994
e approvazione dell'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma
statistico nazionale 1992-1994, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti
privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti.
DPCM 29 ottobre 1991, Individuazione degli enti e delle amministrazioni
pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico
nazionale (SISTAN).
Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
Statistica, ai sensi dell'articolo 24 della L. 23 agosto 1988, n.400.
60
60
Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei MinistriDirettive del
Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'informazione Statistica
Direttiva N. 1
Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione, deliberazione del
15 ottobre 1991
Direttiva N. 2
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
statistica dei comuni, deliberazione del 15 ottobre 1991
Direttiva N. 3
Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nell'ambito del
Sistema statistico nazionale, deliberazione del 15 ottobre 1991
Direttiva N. 4
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
deliberazione del 15 ottobre 1991
Direttiva N. 5
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture, deliberazione del 15
ottobre 1991
Direttiva N. 6
Disposizione per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
statistica delle province, deliberazione del 18 dicembre 1991
Direttiva N. 7
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre