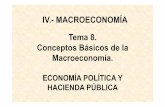i cristiani e la giustizia penale: principi e prassi (IV-VI secolo d.C.) forthcoming
La cristianizzazione fra IV e V secolo
Transcript of La cristianizzazione fra IV e V secolo
X.1. Cristo e gli Evangelisti sulla misticabarca, frammento di sarcofago,325-350 d.C., Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano
“La Chiesa è simile alla nave di un mer-cante: sotto la guida del Signore, essen-done nocchieri gli apostoli, spirando loSpirito Santo, la Chiesa con la predica-zione della parola, corre per il mondointero, mentre ha con sé un inestimabilevalore, con il quale ha comprato tutto ilgenere umano, anzi il mondo intero: ilprezzo è il sangue di Cristo”.Cromazio, Trattato 42,5
X.2.a-c. Trichora degli Apostoli, capitelli,prima metà del V secolo d.C.,Portogruaro, Museo NazionaleConcordiese
“Ci felicitiamo della vostra fede, Con-cordiesi, perché avete superato chi vidava l’esempio: avete, infatti, comincia-to più tardi di noi Aquileiesi la costruzio-ne, ma avete terminato prima… Noi,Aquileiesi, abbiamo ricevuto da voi,Concordiesi, le reliquie dei Santi, voiavete ricevuto da noi lo zelo della devo-zione e lì emulazione nella fede”.Cromazio, Sermone 26, per la dedicazio-ne della cattedrale degli Apostoli
Catalogo
X.1.
X.2.b.X.2.a. X.2.c.
452
453
X.3. Eva, prima metà del IV secolod.C., Altino, Museo ArcheologicoNazionale
X.4.a-b. Frammenti di pergula,VIII secolo d.C., Altino, MuseoArcheologico Nazionale
X.5. Pilastrino di recinzione,V-VI secolo d.C., Zuglio, Museo Civico
X.6. Pilastrino di recinzione, VI secolod.C., Zuglio, Museo Civico
La cristianizzazione fra iv e v secolo
X.4.a.
X.4.b.
X.5. X.6.
X.3.
454 Catalogo
X.7. Mosaico a girandola, dalla primapseudobasilica di Parenzo, fine del IVsecolo d.C., Porec (Parenzo),Museo della Cattedrale
X.8.a-b. Mosaici con iscrizioni offerenti,fine del IV secolo d.C., Porec(Parenzo), Museo della Cattedrale
“Recarono al santo padre Filippo (abatedel monastero di Gerusalemme) quellevenerande reliquie (di Giovanni il Batti-sta). Egli inviò le reliquie di quella vitti-ma innocente ad Atanasio di Alessan-dria, il più autorevole dei vescovi, e siservì dell’opera del diacono Giuliano,che in seguito divenne vescovo della cit-tà di Parenzo”. Rufino, Storia della Chiesa II, 28
1. Emblema centrale con cantharose l’epigrafe degli offerenti: Lupicinuse Pascasia, Clamosus - magister puerorume Successa, Felicissimus
X.8.a.
X.8.b.
X.7.
La cristianizzazione fra IV e V secolo
X.9.a-f. Reliquiario: Cristo con gli Apostoli, inizi del V secolo d.C.,Vienna, Kunsthistoriches Museum
“Molti sono invero i meriti degli Apo-stoli, le cui reliquie sono qui presenti. Sìla voce degli Apostoli si è diffusa in ognidove, non solo quando, ancora rivestitidella loro carne, predicavano il Cristo almondo, ma anche oggi e ogni giorno essasi espande”.Cromazio, Sermone 26,2
X.9.b.
X.9.c. X.9.d.
X.9.a.
X.9.e. X.9.f.
455
Catalogo
X.10. Cristogramma, fine IV secolo d.C.,Celje, Museo Provinciale
X.11. Cristogramma con delfini,fine del IV secolo d.C., Celje Museo Provinciale
X.12. Cristogramma per asta, secondametà del IV secolo d.C., Celje,collezione privata
XI.13. Specchio, inizio del V secolo d.C.,Lubiana, Museo Nazionale della Slovenia
X.14.a-b. Lamine di rivestimento,seconda metà del IV – V secolo d.C.,Lubiana, Museo Nazionale della Slovenia
X.15. Incensiere, V secolo d.C.,Lubiana, Museo Nazionale della Slovenia
X.16. Pendente d’oro con crocemonogrammatica, V secolo d.C.,Lubiana, Museo Nazionale della Slovenia
X.17. Fibula di Drnovo, seconda metàdel IV secolo d.C., Lubiana, MuseoNazionale della Slovenia
X.10. X.11.
X.13.
X.13.X.12.
456
Catalogo
X.19. Candeliere a due luci, IV secolod.C., Vienna, Kunsthistoriches Museum
X.18. Candeliere a una luce, IV secolod.C., Vienna, Kunsthistoriches Museum
X.22. Fibbia a croce, seconda metà del VI secolo d.C., Klagenfurt,Landesmuseum Kärnten
X.19.
X.18.
X.22.
458
459La cristianizzazione fra IV e V secolo
X.21.a-b. Urna e reliquario, dal V al XIIsecolo d.C., Villach, Stadtmuseum
La diffusione della venerazione verso itre fratelli martiri Canziani si estese benoltre il patriarcato di Aquileia. Ne fa fede anche l’omelia pronunciata il30 maggio dal vescovo di Torino Massi-mo: “Oggi è il giorno in cui nacquero alcielo i beatissimi Canzio, Canziano eCanzianilla”.
X.21.a.
X.21.b.
Catalogo
X.20. Colonnina di recinzione,IV-V secolo d.C., Ptuj, Museo Provinciale
X.20.
X.23. Colonnina di recinzione, V-VIsecolo d.C., Klagenfurt, Landesmuseumfür Kärtnen.
X.24. Colonnina direcinzione,V-VI secolo d.C., Klagenfurt,Landesmuseum für Kärtnen
460
X.23. X.24.
461
X.25. Gru che cattura una lucertola,V secolo d.C., Klagenfurt,Landesmuseum für Kärtnen
La cristianizzazione fra iv e v secolo
X.25.
463La cristianizzazione fra IV e V secolo
X.1. Cristo e gli Evangelisti sulla misticabarca
325-350 d.C. circa Frammento di sarcofago, marmobianco, 20 × 46 × 7,5 cmProvenienza: sconosciuta; quindi a Spoleto, località Apostoli,riutilizzato quale elemento murario;acquistato da G.B. de Rossi e donato infine al Museo PioCristiano da Natalia Ferraioli de Rossi nel 1931Collocazione: Città del Vaticano,Musei Vaticani, Museo PioCristiano, inv. n. 31594
Questo piccolo frammento delcoperchio di un perduto sarcofago,d’inizio IV secolo, si ricollega alleraffigurazioni marine frequenti nel-l’arte greco-romana, e spesso utilizza-te nella decorazione dei sarcofagi. Visi riconosce un’imbarcazione dallaprua slanciata e basso scafo, guidatada un nocchiero dalla folta chioma ericco abito, mentre tre rematoricoperti dal solo perizoma ne seguonogli ordini. La nave si muove su unmare mosso da onde, mentre a destrasi vede a malapena la superstite por-zione del basamento di un faro. Iscri-zioni poste a mo’ di didascalia a fian-co delle figure ne chiariscono l’iden-tità: il nocchiero a destra è Iesus,Gesù – di cui s’intuiva l’iconografiadel volto apollineo, per quanto par-zialmente sberciato – e i rematorisono invece, procedendo verso sini-stra, Marcus, Lucas e [Io]annes, inomi di tre degli evangelisti, chefanno ipotizzare coerentemente,oltre la frattura, la presenza del quar-to evangelista Matteo.La generica nave che appare su tantisarcofagi e iscrizioni riceve dunque,su questo frammento, la sua più veraidentità: essa è, infatti, la Chiesa, laquale, come la barca della tempestasedata (cfr. Mt 8, 23-27 e paralleli),“sul mare del mondo è scossa dalleonde delle persecuzioni e delle ten-tazioni, mentre il Signore nella suapazienza sembra dormire, fino almomento ultimo in cui, svegliatodalla preghiera dei santi, egli padro-neggia il mondo e ridona la pace aisuoi” (Tertulliano, De Baptismo, 12,8). Nella lettera indirizzata a Giaco-mo, all’inizio delle sue Homiliæ (1,14), anche l’autore delle pseudo-cle-mentine afferma che “il corpo interodella Chiesa somiglia a una grandenave, che trasporta in una violentatempesta uomini di provenienze lon-tane”. Egli precisa anche che di que-sta nave Cristo è il pilota – comeproprio il nostro frammento fa benvedere –, il vescovo è la vedetta,mentre i diaconi, i presbiteri e i cate-chisti sono i rematori. Anche Ippoli-to di Roma riprende (De antichristo,
59) la stessa analogia, ribadendo che“il mare è il mondo; la Chiesa, comeuna nave, è scossa dai flutti, ma nonsommersa: ha infatti con sé un pilo-ta esperto, il Cristo”, mentre “hacome timone i due Testamenti”.Altri Padri della Chiesa sottolinea-no il significato delle varie parti diquesta nave, in particolare riferen-dosi all’albero maestro, che simbo-leggia nella sua forma la Croce, tut-tavia qui ci preme sottolineare ilriferimento alle Scritture propostoda Ippolito e l’importanza data daClemente, nella composizione del-l’equipaggio della nave, ai catechi-sti: questi infatti istruiscono i fedelinella fede, e primariamente sullaScrittura e i Vangeli, e sono dei veriprotagonisti nell’opera di diffusionee comprensione del “lieto annun-cio” della salvezza. Gli evangelistiche sospingono la barca guidata daCristo, non possono infatti che rife-rirsi all’invito che Gesù rivolge aisuoi al termine del racconto evan-gelico: “Andate in tutto il mondo epredicate il Vangelo a ogni creatura.Chi crederà e sarà battezzato saràsalvo” (Mc 16, 15); “Andate dun-que e ammaestrate tutte le nazioni,battezzandole nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt28, 19).La barca condotta dagli evangelistie guidata da Cristo al porto della sal-vezza è dunque, in conclusione,un’immagine efficace dell’inarresta-bile diffusione del messaggio cristia-no (il kérygma, con parola greca), diquell’euanghélion, lieto annuncio,che, accolto, conduce alla salvezza(il battesimo, come ingresso nellavita nuova), e che, grazie alla capil-lare diffusione dei testi evangelici, siè propagato – proprio attraverso levie del mare – sulle rive del mondoantico.
U. Utro
Bibliografia:CIL XI, 4965; ILCV 1965a; ICI VI, 82;de Rossi 1871, pp. 127-129, tav. 7,1;Garrucci 1879, p. 138, tav. 395,6; Wil-pert 1929, pp. 157-158, fig. 52; Wilpert1938, pp. 128-132; Stuhlfauth 1942, p.123, n. 36; Deichmann 1967, p. 89, n.134, tav. 32; Spinola, in Donati 1996, p.222, n. 71; Lega, Mazzoleni, in Di Stefa-no Manzella 1997, p. 303, n. 3.8.4.;Utro, in Bisconti, Gentili 2007, pp. 148-149, n. 23; Utro, in AA.VV. 2008, p.351, n. 112.
X.2. Trichora degli Apostoli
Prima metà V secolo d.C.
a. Marmo, 19 × 25,3 cm; Ø 15,6 cm(base), inv. IG 10293b. Pietra tenera, ricomposto da dueparti, 22,5 × 29,30 cm; Ø 20 cm
(base), inv. IG 10294 +10298c. Pietra tenera, 23,8 × 27 cm; Ø 17 cm (base)
Provenienza: Concordia Sagittaria,fuori originario contesto, estrattidall’inserimento in una muratura Collocazione: magazzino di VillaSoranzo (Concordia Sagittaria).Museo Nazionale Concordiese
Questi tre capitelli sono un campio-ne degli altri (più o meno in statoframmentario e ancora da restauraree risarcire) che ragionevolmentepossono essere riferiti, per le dimen-sioni e per il numero, alle ottocolonne che costituiscono i supportidell’ambiente a tre navatelle edifica-to quale ampliamento antistanteall’originaria trichora dedicata agliApostoli, sul lato destro della basili-ca di Concordia. Ciascun capitello sviluppa, secondouna propria soluzione formale, trat-tata in superficie con squisito calli-grafismo scultoreo e conforme acaratteri di elegante varietà, quelloche è il medesimo motivo decorativofitomorfo, riferibile chiaramente alloro comune prototipo, cioè il capi-tello corinzio di tipo “teodosiano”. Ilcriterio informatore del loro stileappare quello di una semplificazioneriduttiva degli stilemi propri delnaturalismo tipico del prototipostesso. L’abaco appare qui ripropostoin forma piena, vibrante per le sca-nalature orizzontali e decorato alcentro da una rosellina o da dischet-to, secondo una variante estrosità;gigliati caulìcoli (primo e secondocapitello), oppure calligrafiche seg-mentazioni (terzo capitello) emergo-no direttamente dalla base del capi-tello, a suggerire gli elementi vegeta-li intercalati alle foglie lisce o varia-mente segmentate, che avvolgono edelineano la sagoma a cespo delcapitello.La serie di questi capitelli concordie-si si propone, pertanto, quale nuovoapporto – cui sembrano, per ora, esse-re carenti adeguati confronti (quan-tunque il motivo dei caulicoli sia rap-portabile al capitello aquileiese ditipo ionico d’età cromaziana) – adaccrescere le tipologie nel panoramascultoreo locale del maturo V secolo.1
S. Piussi
1 I capitelli sono stati segnalati dal dotto-re Luca Villa.
BibliografiaInediti.
X.3.Eva
Prima metà del IV secolo d.C.Vetro blu con figure dorate, Ø 1,9 cm
Provenienza: generica, AltinoCollocazione: Altino, MuseoArcheologico Nazionale, inv. AL. 12000
Piccolo frammento circolare di vetrodi colore blu con figure dorate. Ladecorazione consta di un cerchioall’interno del quale è una figurafemminile nuda in atteggiamentopudico, probabilmente Eva, stantetra due alberi frondosi. In origine ilmanufatto apparteneva verosimil-mente a una coppa vitrea a meda-glioni, una tipologia che imitavacoppe in metallo prezioso decorateda gemme. La figura femminile delframmento altinate fu probabilmen-te estrapolata da una composizionefigurata più complessa costituita dal-le due figure di Adamo ed Eva ai latidell’albero del Bene e del Male, unmodello attestato oltre che su altrivetri dorati coevi, nelle pitture dellecatacombe, su sarcofagi, bassorilievie avori. La coppa da cui fu ricavato il fram-mento è una produzione della primametà del IV secolo.Il ritaglio attorno alla fascetta doratacircolare è invece spia di un probabi-le riuso del singolo frammento comecastone, forse come gemma di unoggetto di ornamento personale.
E. Possenti
BibliografiaBetti 2004, pp. 46-49.
X.4.Frammento di pergula
VIII secolo d.C.Calcare, 19 × 87 cm × 13 cmProvenienza: generica dal territorio altinateCollocazione: Altino, MuseoArcheologico Nazionale, inv. AL. 11534
Porzione sinistra di un architrave dipergula decorata, nella parte supe-riore, da una fascia con cani cor-renti e ricciolo rivolto verso sini-stra; in quella inferiore da un’iscri-zione lacunosa, delimitata sul fon-do da una semplice linea incisaorizzontale. Del testo, fortementeconsunto nella porzione destra èleggibile la frase, purtroppo incom-pleta e solo in parte traducibile:“(chrismòn) Om(ne)s hic aspicien-tes pro honore beat[? b?p—-]”(“?tutti quelli che pregano qui perl’onore della beata ….?”)Un altro lacerto di iscrizione, analo-gamente molto rovinato, è inciso sullato contiguo del medesimo fram-mento. Nel testo, originariamentepiù lungo e parimenti traducibilesolo in parte, si legge “† Post obi-tu(m) ambor(um) ce..p..oe [—-]”(“dopo la morte dei due…”).
Vista la posizione piuttosto inusualeè possibile che quest’ultima iscrizio-ne sia il frutto di un riuso con funzio-ne commemorativa dell’architrave,in ogni caso, visto il tipo di caratteriutilizzati, di poco successivo al pre-cedente.La lavorazione delle superfici in cal-care è abbastanza regolare. Il manu-fatto presenta inoltre notevoli trac-ce di esposizione all’acqua, fenome-no che ha comportato, all’estremitàdestra della superficie decorata acani correnti e sull’altro lato iscrit-to, una scomparsa quasi totale deltesto epigrafico. La decorazione acani correnti è inoltre fortementeconsunta, probabilmente in seguitoad un’abrasione continua e prolun-gata della superficie, forse in segui-to ad un utilizzo del frammentocome soglia.Il motivo del cane corrente è moltocomune, seppure frequentementeassociato ad una fascia inferiore amatassina;1 la semplicità e le dimen-sioni dell’elemento decorativo sug-geriscono una datazione che, purnon escludendo gli inizi del IX seco-lo, può essere anticipata all’VIIIsecolo, analogamente ad alcuniframmenti di provenienza lagunare,oggi al museo di Torcello,2 o pado-vana.3 Il frammento torcellano offreun buon riscontro anche per l’impo-stazione complessiva dell’architra-ve; come nel reperto altinate èinfatti decorato nella parte superio-re da una fascia a cani correnti, inquella inferiore da un’iscrizionecontornata su tre lati da semplicilinee incise.Una datazione più puntuale, circo-scrivibile alla metà dell’VIII secolo,è suggerita dai caratteri epigraficidelle iscrizioni (ex inf. Flavia DeRubeis).
E. Possenti
1 Cfr. Lusuardi Siena, 1997, pp. 171-173.2 Polacco 1976, p. 54.3 Sannazaro 1989, p. 224.
BibliografiaInedito.
X.5. Pilastrino di recinzione
V-VI secolo d.C.33 × 16 × 21, 6 cmProvenienza: Zuglio, scavi dellabasilica urbana di Iulium CarnicumCollocazione: Zuglio, Museo Civico,inv. n. 378938
Il piastrino con attacco di colonni-na proviene dalla basilica urbanafaceva parte della recinzione del-l’area dell’altare e del presbiterio. Èdecorato conforme al modo tradi-zionale proprio di tali elementiarchitettonici: semplice calligrafi-
smo floreale a palmetta di stile geo-metrizzante.1
Prezioso perché unica testimonianzarimasta dell’arredo liturgico dellabasilica cattedrale di Iulium Carni-cum, cui era annesso il battistero. Ilprimo vescovo, di cui si ha memoriaepigrafica, morì nel 490, dopo alme-no dieci anni di episcopato, confer-mando la fondazione della Chiesanel municipium romano alpino alme-no al V secolo.2
S. Piussi
1 Museo archeologico Iulium Carnicum20052.2 Cuscito 1976, pp. 337-338; Su IuliumCarnicum, cfr: Studi Tolmezzini 1981.
X.6.Pilastrino di recinzione
VI secolo d.C.Calcare grigio, 26,5 × 16,6 × 8 cmProvenienza: Zuglio, scavi di SanPietro, aula ecclesialeCollocazione: Zuglio, Museo Civico,inv. n. 379369
Il pilastrino di recinzione dell’areadell’altare e presbiterio è decoratocon cantaro e il motivo della vite.Proviene dagli scavi condotti neglianni ottanta all’interno della pievedi San Pietro sul colle di Zuglio, chesovrasta l’antica città romana. L’au-la ecclesiale, dalle ridotte dimensio-ni, era absidata. Il pilastrino testi-monia della presenza cristiana sullarocca, da dove proviene anche l’epi-grafe del vescovo Ianuarius.1
S. Piussi
1 Museo archeologico Iulium Carnicum2005.2
2 G. Cuscito 1976, pp. 337-338; Su IuliumCarnicum, cfr: Studi Tolmezzini 1981.
X.7. Mosaico a girandola
Fine del IV secolo d.C.Mosaico su supporto, 69 × 98 × 6 cmProvenienza: Parenzo, scavi dellaprima pseudobasilicaCollocazione: Porec (Parenzo),Museo della Cattedrale, s.n. inv.
Questo frammento dal motivo “agirandola” è parte del pavimentomusivo della prima basilica, cheappare decorato essenzialmente dascomparti quadrotti puramente geo-metrici, tra i quali però, oltre alleepigrafi degli offerenti, sono statiponderatamente campiti il bel moti-vo del cantharos fiorito nello scom-parto centrale e, nell’area orientale,quello con l’immagine del pesce,dalla indubbia evocazione simbolicaal nome del Cristo.
I. Matejcic
X.8. Mosaico con iscrizione di offerente
Fine del IV secolo d.C.Mosaico su supporto, 117 × 112 × 4 cmProvenienza: Parenzo, scavi della prima pseudobasilicaCollocazione: Porec (Parenzo),Museo della Cattedrale, s.n. inv.
“cuius num|en d(ominu)s nuvet| provoto s|uo f(e)c(it) p(e)d(es)XIII.”“Colui il cui nome il Signore cono-sce, fece realizzare per suo voto 13piedi (di mosaico)”.
Interessante è il particolare dellavocale o in nomen e in novit scritta u,che riflette il timbro fonetico scuro echiuso proprio dell’idioletto parenti-no. Un sentimento di umiltà ha sug-gerito all’offerente di non rivelare ilproprio nome. È questa una delle epigrafi musive diofferenti inserite nel pavimento del-la prima basilica cattedrale. Similiiscrizioni testimoniano della tradi-zione, tipica dei cristiani della Vene-zia e Istria, di voler lasciare il lororicordo insieme a quello dell’offertadevoluta per edificare e abbellirel’edificio ecclesiale.
I. Matejcic
X.9. Reliquiario: Cristo con gli Apostoli
Inizi del V secolo d.C.Argento, altezza 12,3 cm; 119,4 gProvenienza: rinvenuto nel 1860 a Pula (Pola, Croazia)Collocazione: Vienna,Kunsthistorisches Museum,Antikensammlung, inv. n. VII 760
Il contenitore esagonale (pisside) èrealizzato da lamine d’argento conornamenti molto accurati con la tec-nica del cesello. Il suo coperchiolavorato separatamente si congiungedal basso in alto in una sovrastantepiastrina. Il fondo originario inseritoè andato perso.Il prezioso recipiente è stato trovatonel 1860 in un cantiere per la costru-zione di una cisterna nella piazzaduomo di Pola insieme con un reli-quiario d’oro (inv. n. VII 761) e conaltri, oggi perduti, reliquiari e prezio-si in una cassetta d’argento. Questoera riposto in due cassette di pietrainfilate una nell’altra, sistemate nel-la fossa delle reliquie entro l’areadell’altare nell’antica aula ecclesialedegli inizi V secolo, che in seguito fuconosciuta come chiesa dell’aposto-lo Tommaso, prima di essere distrut-ta nei primi anni del XIX secolo.La decorazione si addice alla formadel recipiente: nella parte inferioresono rappresentate figure intere, inquella superiore i busti. Si tratta del-
le rappresentazioni convenzionali diCristo e degli apostoli nel consuetoportamento e nella gestualità; sonovestiti con la tunica e il pallio. Cri-sto è raffigurato giovane; ha capellilunghi con la scriminatura centrale.Con la mano sinistra regge il libroaperto, la mano destra è sollevatanel tradizionale gesto di redenzione.Degli Apostoli solo Pietro e Paolosono facilmente identificabili. Sonorivolti verso Cristo, mentre le altrefigure sono state mostrate approssi-mativamente di fronte. Pietro portacapelli corti e folti, e ha una barbaaltrettanto folta; Paolo ha la frontecalva, la barba lunga e appuntita.Come riferimento iconografico larappresentazione figurativa ha ungrande respiro, mostrando l’omaggiodegli Apostoli verso Cristo maestro;simili composizioni si trovano nellepitture delle chiese e nei mosaici. Lostile delle figure ricorda con le suemovenze, la morbidezza lineare del-l’arte teodosiana. La probabilità cheil recipiente sia stato fabbricato inuna bottega settentrionale dimostranella forma e nel contenuto che larappresentazione inizialmente nonera stata creata per essere utilizzatacome reliquiario, bensì per un altrouso nell’ambito ecclesiastico.
M. Laubenberger
BibliografiaStutzinger 1983, pp. 571-573, n. 172;Cuscito 2000a, pp. 60-61, n. IV.19; Lau-benberger 2005, p. 230, n. 102; Spier2007, p. 251, n. 74.
X.10. Cristogramma
Fine IV secolo d.C.Bronzo, Ø 25,4 cm; 28,8 × 0,73 cmProvenienza: rinvenimentooccasionale dal colle Vipota sopraPecovnik, presso CeljeCollocazione: Celje, MuseoProvinciale, inv. n. 2129
Il cristogramma è stato rinvenutonelle vicinanze dell’abitato d’alturatardoantico (nella stessa zona sonostati rinvenuti altri due cristogram-mi nn. cat. 11-12). È un disco circolare in bronzo, conganci per l’attacco della catena, si pre-senta come un disco traforato. Lungoil bordo esterno mostra una decorazio-ne composta da una serie di perline eda sei coppie di piccoli fori posiziona-ti tra di loro in modo uniforme. Ilmonogramma di Cristo è compostodalle lettere greche “C” (chi) e “R”(ro) finemente elaborate; la lettera roè riconoscibile dalla presenza dellacoda (cauda) nella parte destra dellalettera. Nella parte interna è presentel’ideogramma di Cristo formato dallaprima e dall’ultima lettera dell’alfabe-to greco, “A” (alfa) e “W” (omega).
464 Catalogo
465La cristianizzazione fra IV e V secolo
Il monogramma di Cristo è un tipicosimbolo grafico del periodo storicoche sant’Agostino definiva christianatempora. Allora, i cristogrammi ditipo costantineo venivano fabbricatispesso in bronzo e, dopo la fine delIV secolo, venivano posizionatisoprattutto sulle tombe e sui sarcofa-gi. Dalla metà del IV secolo, i cristo-grammi presentavano anche le lette-re “A” e “W” che, in base al Vangelosecondo Giovanni (1.8 e 21.6),venivano interpretate come simbolodell’annuncio che Cristo è l’inizio ela fine di tutto.1
T. Knific
BibliografiaCiglenecki 1993, p. 213, ss. 1, 5.
X.11. Cristogramma con delfini
Fine del IV secolo d.C.Bronzo, Ø 25,2 cm (ricostruito)Provenienza: Vipota sopra Pecovnikpresso Celje, SloveniaCollocazione: Celje, MuseoProvinciale, inv. n. 2130
Si tratta di un rinvenimento occa-sionale avvenuto nelle vicinanzedell’abitato d’altura tardoantico(nella stessa zona sono stati rinvenu-ti altri due cristogrammi, catt. X.10-11.). Del cristogramma si sono con-servati: alcuni frammenti del cer-chio; tre elementi a botte e tre “aesse“ della catena; frammenti dellelettere “C” e “A”, mentre la lettera“W” è conservata interamente; dueasticelle e parte di una terza a formadi pesce. Solo in base al confrontocon il primo cristogramma (cat.X.10.) è stato possibile dare una for-ma logica a questi frammenti ericomporli. L’attendibilità della rico-struzione proposta è stata conferma-ta da alcuni frammenti che appar-tengono ad altri tre singoli cristo-grammi rinvenuti successivamente;allo stato odierno delle ricerchesono a Vipota presenti frammenti dicinque singoli cristogrammi conanaloghe caratteristiche.1
Le differenze tra i singoli cristogram-mi sono minime: fondamentalmentesi tratta di un cristogramma massiccioche veniva appeso al soffitto tramiteuna catena che passava attraverso ilgancio superiore, mentre dal laccioinferiore scendeva un’altra catenache tratteneva un lume; lungo il bor-do, decorato da una serie di perline,vi erano applicate sei asticelle a for-ma di pesce, probabilmente si trattadella stilizzazione di un delfino. Inbase alla grandezza dei cristogrammi èpossibile supporre che appartenesseroa una struttura di culto importante;probabilmente sono stati portati aVipota dalla vicina Celeia (Celje)dove sono stati riconosciuti i resti di
una basilica e di un battistero databi-li al periodo del primo cristianesimo.2
T. Knific
1 Ciglenecki 2003, 12, 13, figg. 3-5.2 Pubblicato da: Ciglenecki 1993, pp.213-214, s. 3, 4, 6-8; Ciglenecki 1993,pp. 213-221; Ciglenecki 2001, pp. 18-19,tav. 31.
X.12.Cristogramma per asta
Seconda metà del IV secolo d.C.Bronzo, Ø 9,8 cm; 14,05 × 0,4 cm Provenienza: Vipota sopra Pecovnikpresso Celje, Slovenia;rinvenimento occasionale avvenutonelle vicinanze dell’abitato d’alturatardoantico (nella stessa zona sonostati rinvenuti altri due cristogrammicatt. X.10-11.) Collocazione: Celje, collezioneprivata
Cristogramma fuso in bronzo diaspetto massiccio con doppio laccionella parte inferiore e gancio inquella superiore. Dal punto di vistafunzionale, si tratta probabilmentedell’elemento di una catena. Ilmonogramma è composto dalle let-tere greche “C” (chi) e “R” (ro). Leasticelle delle lettere sono forate ecreano un effetto di trasparenza (unaspecie di opus interrasile). La partefrontale presenta su tutta la superfi-cie una decorazione incisa compostada cerchielli concentrici e singolicon un puntino al centro.In Slovenia è stato rinvenuto un altonumero di cristogrammi databili allaprima età cristiana: i due esemplaridi Ragoznica presso Ptuj facevanoparte di un candelabro votivo (catt.X.18-19.); i due cristogrammi diVipota appartenevano probabilmen-te a grandi lumi; a Emona (Lubiana)apparteneva un cristogramma auto-nomo ottenuto con tecnica di fusio-ne;1 nella grotta Tominceva jamapresso Skocjan è stata rinvenuta unaguarnizione a forma di cristogrammacon le lettere “A” e “W”.2
T. Knific
1 Dostal 1914, p. 189.2 Knific, Sagadin 1991, p. 28, s. 67.
BibliografiaInedito.
XI.13. Specchio
Seconda metà del IV – inizio Vsecolo d.C.Bronzo, Ø 15,5 cm; 0,2 cm (spess.) Provenienza: Lubiana, scavi dellanecropoli settentrionaleCollocazione: Lubiana, MuseoNazionale della Slovenia, inv. R 5953
Proviene dagli scavi di Lubiana,rinvenuto nella tomba a inumazio-ne n. 679 della necropoli settentrio-nale della città (fanno parte delcorredo funerario anche i seguentioggetti: moneta non identificabile,lampada a olio, fondo di una botti-glietta e chiavistello in bronzo diuna serratura). La parte frontale dello specchio cir-colare è in lega di bronzo chiara. Èfinemente levigata, mentre quelladorsale è meno liscia; presso i cerchie le croci in rilievo sono visibilitracce di fusione. Le asticelle dellecroci presentano una sezione a T ela loro forma imita quella dello stru-mento di tortura al quale venivanolegati gli schiavi (patibulum). L’ele-mento decorativo dominante è lacroce: la più grande è circondata daun anello con decorazione a lineette– il che sottolinea la sua posizionecentrale –, mentre le rimanenti tre,più piccole e posizionate simmetri-camente lungo il bordo dello spec-chio, sono circondate da due cerchiconcentrici. Le croci più piccole,inoltre, formano con una quarta –immaginaria – un quadrato. Ladecorazione rappresenta senza dub-bio quattro simboli fondamentalisovratemporali: centro, cerchio,croce e quadrato.1
Il cristianesimo aveva a Emona radi-ci molto profonde già nel periodotardoromano; san Girolamo tenevanegli anni tra il 376 e il 377 una fit-ta corrispondenza con le vergini delluogo e il fratello Antonio; nellaseconda metà del IV secolo, l’anticobagno pubblico fu trasformato incentro di culto del primo cristianesi-mo; nel secondo decennio del Vsecolo vi fu aggiunto un battisterocon pavimentazione a mosaico.2
T. Knific
1 Chevalier, Gheerbrant 1994, pp. 173,195, 248, 912.2 Plesnicar 1983.
BibliografiaPubblicato da: Petru 1972, 65; t. 46: 6;Knific, Sagadin 1991, 74, cat. 67.
X.14. Lamine di rivestimento
Seconda metà del IV – V secolod.C.10 × 7,2 cm e 12 × 7,25 cmProvenienza: Sentjurski hrib sopraTrzisce, SloveniaCollocazione: Lubiana, MuseoNazionale della Slovenia, invv. S 2500, S 2501
Sono rinvenimenti occasionaliavvenuti nelle vicinanze dell’abitatod’altura tardoantico non ancoraindagato archeologicamente (nellastessa zona sono stati rinvenuti un
pendente in oro e un incensiere, nn.cat. X.16. e X.15.). Le guarnizioni presentano una deco-razione composta da una serie dibugnette scolpite lungo i bordi. Poi-ché la loro altezza è uguale, è possibi-le presumere che facessero parte diuno stesso oggetto. Sulla prima èvisibile una croce monogrammata(crux monogrammatica) con le lettere“A” e “W”, delineata da una serie dibugnette all’interno di un cerchio;negli angoli sono siconoscibili deifori utilizzati per l’applicazione. Lecroci monogrammate con le letterealfa e omega sono spesso impressesulla ceramica fine africana databilealla seconda metà del V secolo e laprima del VI.1
La seconda guarnizione, invece, èdivisa dalla decorazione a bugnettein tre parti: la parte superiore pre-senta una vite con grappoli d’uva,mentre le due inferiori la scritta“votvm posvit”. La vite (Vitis vinife-ra) è uno dei simboli biblici più vivi,poiché rappresenta il rapporto traDio e i credenti; durante la prima etàcristiana, il grappolo d’uva venivaspesso raffigurato sulle strutture inpietra delle chiese, come per esem-pio sulla colonna del coro a Ptuj(cat. X.10).2 Per quanto riguarda lascritta votiva, i confronti di riferi-mento sul territorio sloveno si trova-no su due candelabri rinvenuti aRagoznica presso Ptuj, datati al IVsecolo; le scritte votive di questi ulti-mi presentano – differentemente daquella della guarnizione – anche inomi dei propri donatori.3
T. Knific
1 Hayes 1972, pp. 273-274, figg. 54: a-c,55: f; Wamser 2004, p. 254, n. 375.2 Knific, Sagadin 1991, 55, n. 17.3 Ibidem, 48, nn. 1 in 2.
BibliografiaPubblicato da: Bitenc, Knific 2001, 19,cat. 34.
X.15.Incensiere
V secolo d.C.Bronzo, altezza 13,8 cm; Ø 8 cm (magg.) Provenienza: Sentjurski hrib sopraTrzisce, SloveniaCollocazione: Lubiana, MuseoNazionale della Slovenia, inv. S 2560
Il suo rinvenimento è stato occasio-nale nelle vicinanze dell’abitatod’altura tardoantico (nella stessazona sono stati rinvenuti il pendentein oro e le due guarnizioni in laminadi bronzo, catt. X.16., X.14.). Nellaparte superiore dell’incensiere di for-ma ovale, in bronzo bianco, compo-sto da due parti, sono presenti treaperture simili a una lettera V rove-
sciata. Nel punto di contatto tra ledue parti si sono conservate traccedei cardini e delle manigliette per lachiusura. Sulla punta della partesuperiore è presente un gancetto condue frammenti “a esse“ di un filo dibronzo, mentre sul fondo della parteinferiore si scorge un buchino dovesi trovava l’attacco del piede dell’in-censiere. L’incensiere di Sentjurskihrib è correttamente paragonato aun esemplare ovale su piede compo-sto da due parti in argento datato alperiodo copto (probabilmente risaleal V secolo), che fa parte della colle-zione egizia del Museo Louvre.1
L’incensiere (incensorium) è unoggetto liturgico; l’uso dell’incensonei territori orientali è stato intro-dotto durante i riti cristiani attornoall’anno 400. Il fumo dell’incensosimbolizza l’innalzarsi al cielo dellepreghiere.
T. Knific
1 Bénazeth 1992, 96, p. 26, n. E 11705.
BibliografiaPubblicato da: Bitenc, Knific 2001, 20,cat. 35; Knific 2006, 113, Fig. 85: 1.
X.16. Pendente d’oro con crocemonogrammatica
V secolo d.C.Oro, altezza 1,75 cm; Ø 1,46 cm Provenienza:Sentjurski hrib sopraTrzisce, SloveniaCollocazione: Lubiana, MuseoNazionale della Slovenia, inv. S 2686
Il pendente è stato rinvenuto a Sen-tjurski hrib sopra Trzisce, Slovenia.Si tratta di un rinvenimento occa-sionale nelle vicinanze dell’abitatod’altura tardoantico non ancoraindagato archeologicamente (nellastessa zona sono stati rinvenuti l’in-censiere e le due guarnizioni inlamina di bronzo, catt. X.15.,X.14.). Presenta una croce mono-grafata all’interno del cerchio. Nelpunto in cui si intersecano le asti-celle è visibile una rondella. Il pen-dente è elaborato in filigrana e agranulazione, mentre il gancetto èformato da un filo costolato in lami-na d’oro. La croce monogrammata(crux monogrammatica), formata dal-la croce latina e dalla lettera greca“R” (ro), rappresenta un simbolofigurativo molto diffuso nel periodotardoantico; la croce bordata da unaserie di “perline” era spesso rappre-sentata dalle applicazioni dei vasi invetro,1 oppure autonomamente, maanche come pendente.2
T. Knific
1 Whitehouse 2001, pp. 235-236, nn.818-820.
2 Wamser 2004, pp. 128, 323, nn. 164,620.
BibliografiaPubblicato da: Bitenc, Knific 2001, 19,cat. 33.
X.17. Fibula di Drnovo
Seconda metà del IV secolo d.C.Bronzo dorato, 4,7 × 7,8 × 6,1 cmProvenienza: necropoli a Drnovopresso Krsko Collocazione: Lubiana, MuseoNazionale della Slovenia, inv. R 89
È stata rinvenuta in una necropoli aDrnovo presso Krsko (Neviodunum),Slovenia – informazioni dettagliateriguardo il rinvenimento non sononote. La fibula “a balestra” è in bron-zo dorato con bottoni a forma dicipolla. L’arco e il piede della fibulapresentano una decorazione effetua-ta in tecnica a niello con otto bustiin cornici quadre e campi geometri-ci tra esse. Nella parte finale dell’in-serto semicircolare per l’ago è incisoun cristogramma composto dalle let-tere greche “C” (chi) e “R” (ro); sitratta delle prime due lettere delnome di Gesù Cristo (L’Unto) ingreco (Crist’j).Le fibule con bottoni a forma dicipolla rappresentano una delle tipo-logie di fibule più diffuse in età tardo-romana; i proprietari di questi oggettidi lusso erano probabilmente alti uffi-ciali dello stato e comandanti del-l’esercito (per esempio, il dittico diStilicone). La fibula di Drnovo appar-tiene alla tipologia delle fibule deco-rate con busti (tipo Keller/Pröttel 5ovvero tipo Swift 5i). Di questa tipo-logia ci sono noti 46 esemplari rinve-nuti soprattutto nel territorio tra l’In-ghilterra, lungo il limes reno-danubia-no, e il Mar Nero; tra questi sono pre-senti nove fibule con cristogramma.1
T. Knific
1 Kaufmann-Hainimann 2003, pp. 145-160, fig. 161.
BibliografiaPubblicato da: Knific, Sagadin 1991, 71,cat. 61; Kaufmann-Hainimann 2003a,309, n. F 17, fig. 283.
X.18. Candeliere a una luce
IV secolo d.C. Bronzo, ferro, argento; dimensionisenza supporto: altezza 13 cm; Ø 6 cm(disco); distanza tra i petali 14,2 cmProvenienza: rinvenuto nel 1858 a Ragosnitz-Rogoznica presso Ptuj(Poetovio) in SloveniaCollocazione: Vienna,Kunsthistoriches MuseumAntikensammlung, inv. n. VI 727
È uno dei due candelieri con cristo-gramma in bronzo fuso frammentatiche furono accidentalmente rinve-nuti. Sono attualmente collocati sumoderni supporti, con parti di colle-gamento in piombo. Entrambi i candelieri hanno comeparte centrale un disco con cristo-gramma, lungo la cui circonferenzasul verso corre un’iscrizione votiva.Il porta candela ha la forma di unfiore a cinque petali, con perno diferro al centro. Poiché questi esem-plari sono documenti finora comeunici nel loro genere, non è determi-nabile la loro integrazione. Rimaneimprecisata la loro destinazione:devozionale, tombale, liturgica.Questa è la parte sommitale del can-delabro “a una luce”, mancante didue petali che è connessa da un glo-bo al sottostante cristogramma. Ildisco è decorato da quattro globulinel prolungamento dei bracci dellacroce, decorati da quadratini incisi;nella loro convergenza è inciso unornato circolare. Lungo la circonferenza è incisal’iscrizione: “votum Pusinnio posuit”(“Pusinnione ha posto in voto”). Sulretro del cristogramma una piccolabarra in ferro collega il portacandelaa cinque petali.
M. Laubenberger
BibliografiaDeringer 1965, p. 139, tav. XVI; Noll1974, pp. 33-34, nn. B.9, B.10; Korosec1980, pp. 55-61; Knific, Sagadin 1991:1,2, p. 48; Vomer, Gojkovic-Kolar 1993,p. 26; Bratoz, Knific 2005a, p.137.
X.19. Candeliere a due luci
IV secolo d. C. Bronzo, ferro, argento, dimensionisenza supporto: h 10 cm; Ø 8 cm (disco); distanza tra i bracci 14,9 cmProvenienza: rinvenuto nel 1858 a Ragosnitz-Rogoznica presso Ptuj(Poetovio) in SloveniaCollocazione: Vienna,Kunsthistoriches MuseumAntikensammlung, inv. n. 728
È la parte sommitale del secondocandelabro “a due luci” che sonocollegate lateralmente al disco concristogramma da due bracci e sorret-te da una mano. Ciascun portacan-dela ha la forma di una corolla a cin-que petali. Nel fiore di sinistra man-cano due petali; nel fiore di destra suun petalo appuntito è conservatauna decorazione a forma di goccia. Ildisco con il cristogramma è ornatosopra la “R” da due sfere ornamenta-li d’argento i bracci della “C” porta-no segni di martellature. L’iscrizionelatina votiva con caratteri incisi cor-re sul bordo esterno; è proposta l’in-
tegrazione di quattro lettere: “Inti-mius Maximilianu[s fra]tres Crispinoposuerunt” (“I fratelli Intimio e Mas-similiano hanno posto a Crispino”).Isolati sono i ritrovamenti di fram-menti di lucerne simili candelieri,come quello di Lauriacum (Enns),Norico, Museo di Lauriacum (inv. n.VI 328).
M. Laubenberger
BibliografiaDeringer 1965, p. 139, tav. XVI; Noll1974, pp. 33-34, nn. B.9, B.10; Korosec1980, pp. 55-61; Knific, Sagadin 1991:1,2, p. 48; Vomer, Gojkovic-Kolar 1993,p. 26; Bratoz, Knific 2005a, p.137.
X.20. Colonnina di recinzione
IV-V secolo d.C.Marmo, 50 × 31 × 26 cmProvenienza: rinvenimentoaccidentale nel 1936Collocazione: Ptuj, MuseoProvinciale, inv. RL 428
Il frammento è una parte dellacolonnina reggi balaustra di unachiesa sconosciuta nel territoriodella romana Poetovio. Il marmo èscolpito con volute di vite con grap-polo, che fuoriescono da un granvaso; sulla sommità una colombaregge la croce.
S. Piussi
BibliografiaKnific, Sagadin 1991: 17, p. 55.
X.21. Urna e reliquiario
Datazione problematica: dal V al XII secolo d.C.Marmo, cassa: 26 × 35 × 25 cm;coperchio: 8 × 36 × 24 cm; cassettadi avorio: 8 × 16,5 8 × 8 cmProvenienza: 1928, ritrovamentocasuale a Mesner sul Kanzianiberg Collocazione: Villacco,Stadtmuseum, inv. AR/325
Nel 1928 durante i lavori di ristrut-turazione nella cantina di una casaprivata a Mesner sul Kanzianiberg(Monte dei Canziani) vicino a Vil-lacco, fu scoperta questa cassa dimarmo con coperchio. All’interno sitrovavano resti di questa cassetta inavorio col coperchio a forma di tet-to. Sul suo contenuto nulla si sa.Mancano riferimenti ad una chiesapaleocristiana; la chiesa attualmenteesistente è documentata per la primavolta nel 1301. Il reliquiario potreb-be essere appartenuto alla dotazionedi una costruzione sepolcrale; nellesue immediate vicinanze fu scopertauna tomba con lastra di pietra del V-VI secolo. Mancano riferimenti aduna chiesa paleocristiana; la chiesa
466 Catalogo
467La cristianizzazione fra IV e V secolo
attualmente esistente è documenta-ta per la prima volta nel 1301. È sta-ta avanzata l’ipotesi di un lavorosiculo-arabo del XII secolo: questospiegherebbe più facilmente il ritro-vamento. H. Fillitz esprime dubbisulla datazione tardoantica della cas-setta di avorio e la reputa un lavorosiculo-arabo del XII secolo. Se ilrecipiente fosse effettivamente delmedioevo, le circostanze del ritrova-mento lo spiegherebbero più facil-mente. Il reliquiario potrebbe esserestato sotterrato nella casa Mesnerdurante le incursioni dei turchi deltardo XV secolo ed essere statodimenticato nel nascondiglio.Il nome stesso del luogo da cui pro-viene è però valido indizio per rico-noscervi una traslazione delle reli-quie dei Martiri Canziani nella valledella Gail.
K. Karpf
BibliografiaFillitz, Pippal 1987, pp. 237 e ss.; Glaser1997, p. 125.
X.22. Fibbia a croce
Seconda metà del VI secolo d.C.Bronzo, 5,7 × 3 × 0,7 cm Provenienza: St. Peter im Holz, area cimiteriale della chiesaextraurbana di TeurniaCollocazione: Klagenfurt,Landesmuseum Kärnten, inv. Aust. 7/25
La fibbia di cintura in bronzo pro-viene dall’area occidentale delcimitero nella chiesa di Teurnia:nell’anno 1910 è stata rinvenutanella sepoltura a. La staffa ha la for-ma di una croce e il cerchio ha inci-si cinque occhi. Fibbie del tipo conpiccole partizioni sono principal-mente in territorio di cultura bizan-tina e appartengono alla secondametà del VI secolo. Questo esem-plare documenta del tempo dellamomentanea riconquista giustinia-nea del Noricum, oppure si riferiscealla frequentazione di Teurnia in etàostrogota.
F. Glaser
BibliografiaIbler 1991.
X.23. Colonnina di recinzione
V-VI secolo d.C.Marmo frammentato, 67,5 × 11 cmProvenienza: St. Peter im Holz, areacimiteriale della chiesa episcopaledi TeurniaCollocazione: St. Peter im Holz(Carinzia), Römermuseum Teurnia;prestito del Landesmuseum fürKärtnen, inv. Aust. 7/23
Questa colonnina, proveniente dallabalaustra a delimitazione dell’areadell’altare, è documento della chiesacattedrale della città di Teurnia cheebbe due fasi costruttive riferibili laprima al V la seconda al VI secolo.
F. Glaser
X.24. Colonnina di recinzione
V-VI secolo d. C.Marmo frammentato, 80 × 11 cmProvenienza: St. Peter im Holz, areacimiteriale della chiesa extraurbanadi TeurniaCollocazione: St. Peter im Holz(Carinzia), Römermuseum Teurnia;prestito del Landesmuseum fürKärtnen, inv. Aust. 7/26
Questa colonnina faceva parte dellarecinzione della balaustra a delimita-zione dell’area presbiterale dellachiesa a aula extraurbana, dalla pla-nimetria cruciforme, che aveva desti-nazione cimiteriale.
F. Glaser
X.25. Gru che cattura una lucertola
V secolo d.C.Mosaico, particolare, 113 × 142 cmProvenienza: St. Peter im Holz,chiesa extraurbana di TeurniaCollocazione: in situ, St. Peter imHolz (Carinzia), RömermuseumTeurnia; prestito delArchäeologisches MuseumLandesmuseum für Kärtnen
È riprodotto uno dei dodici riquadridel pavimento – integro – a mosaicodella cappella meridionale dellachiesa cimiteriale fuori le mura diTeurnia, l’ultima capitale del Nori-cum mediterraneo. L’iscrizione nelmosaico menziona il nome deldonatore: il comandante (dux) virspectabilis Ursus (“Ursus, comandan-te, uomo di rango senatorio”). Dif-ferenti sono le decorazioni deiriquadri che a campiture coloristi-che aggiungono simboli del reperto-rio cristiano. La gru che ha cattura-to la lucertola nel becco è l’unicaimmagine zoomorfica. È possibiletrovare un rimando allegorico, con-frontando il significato che ne dà ilPhysiologus greco: Cristo (la cico-gna) libera dalle tenebre e restitui-sce alla luce lìumanità gravata dalpeccato (la lucertola).Una covergenza tra avvenimentistorici locali e lo stile iconograficofanno propendere per una datazionedi V secolo. Teurnia col il suo vesco-vo Paulinus è ricordata nella vita diSeverino (Eugippio, Vita di san Seve-rino), il santo monaco latino che sulfinire del V secolo guidò i romaninell’esodo dal Norico verso l’Italia.
Due basiliche sono state scoperte aTeurnia: quella episcopale sul colle equella funeraria a valle. Teurnia fudistrutta nel 610.
F. Glaser
BibliografiaGlaser 2000b, p. 132: IX. 4
X.26.Volatile palustre
V-VI secoloMosaico, particolare, 119 × 131 cm Provenienza: dall’edificio ecclesiale(A) sul colle GlobasnitzCollocazione: Hemmaberg, prestitodel Archäeologisches MuseumLandesmuseum für Kärtnen
È una porzione del pavimento amosaico dell’edificio ecclesiale (A)sul colle Globasnitz. La composizio-ne a cerchi tra loro connessi, è deco-rata da immagini campite all’inter-no; esempio ne è questo volatile. Ilmonte Hemmaberg servì comepostazione di difesa per gli abitantidell’antica Virunum, dove furonocostruiti numerosi edifici sia abitati-vi sia ecclesiali. Le geometrie com-positive e l’evanescente naturalismostilistico apparentano questo mosai-co ad affini composizioni di Grado,Santa Maria delle Grazie.Per la destinazione di tali chiese èstato proposto un duplice loro utiliz-zo liturgico: una parte per gli ariani eun’altra parte per i cattolici romani,come era usanza durante il regnoostogoto.
F. Glaser
BibliografiaGlaser 2000b, p. 133: IX 5; Glaser 2008,pp. 385-387.