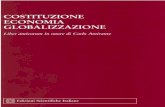La città fedelissima. Savona e il governo genovese fra XVI e XVIII secolo
Transcript of La città fedelissima. Savona e il governo genovese fra XVI e XVIII secolo
Giovanni Assereto
La città fedelissima Savona e il governo genovese
fra XVI e XVIII secolo
Edizione fuori commercio realizzata per conto della
Cassa di Risparmio di SavonaGruppo Banca Carige
Referenze fotografiche
Le fotografie pubblicate nel libro sono di:
- Studio Fulvio Rosso di Calice Ligure(nn. 1, da 3 a 29, da 14 a 19, da 26 a 29, da 34 a 38, da 44 a 47, da 50 a 55, da 74 a 77)
- Archivio di Stato di Genova (nn. 48, 56, 57, 66, 70)
- Comune di Genova, Archivio fotografico Beni Culturali (nn. 20, 21, 22)
- Comune di Genova, Settore Biblioteche, Biblioteca Berio (nn. 58, 62, 63, 64, 65, 72, 73)
- Service Historique de la Défense/Département Marine, Château de Vincennes BP 166 00468 Armées (n. 68)
- Pontificia Università Gregoriana (n. 71)
Immagine di copertina: Frontespizio del «Registro dei decreti» (Archivio di Stato di Savona, Comune 1,209)
Autorizzazioni alla pubblicazione di immagini:
- Archivio di Stato di Savona MBAC (–AS) –SV Prot. n. 1532. Class. 28.13.05 data: 19/06/2007
- Comune di Genova, Settore Biblioteche, Biblioteca Berio,Sezione di Conservazione Prot. n. 724809 data: 26/06/2007
- Archivio di Stato di Genova MBAC (–AS) –GE Prot. n. 3894. Class. 28.28.00 data: 25/06/2007
- Archivio della Pontificia Università Gregoriana aut. del 10/07/2007
- Service Historique de la Défense/Département Marine,Château de Vincennes BP 166 00468 Armées, Devis n. 12327 data: 18/07/2007
- A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona, Prot. 1810 data: 26 luglio 2007
Proprietà letteraria riservata 2007 Daner Elio Ferraris Editore srl - Giovanni Assereto
Progetto editorialeDaner Elio Ferraris Editore srlVia Amendola 13, 17100 Savonawww.daner.orge-mail: [email protected]
Edizione fuori commercio realizzata per conto della Cassa di Risparmio di Savona
Stampa Coop Tipograf - Corso Viglienzoni 78r - 17100 Savona
RingraziamentiL’Editore ringrazia Luca Bochicchio per la preziosa collaborazione alla ricerca iconografica.
Tutti gli aventi diritto citati per la gentile concessione alla riproduzione delle immagini contenute inquesta pubblicazione.
Resta a disposizione di eventuali altri che, involontariamente, non fossero stati citati, reperiti o indi-viduati.
Un particolare ringraziamento a:Don Giovanni Farris per le immagini tratte dalla Biblioteca del Seminario Vescovile di Savona;Luigi Albezzano per le immagini di Villa Faraggiana di Albissola M.; Pio Vintera per le immagini di Villa Cambiaso di Savona.
7
Presentazione di Franco Bartolini .................................................... Pag. 9
Abbreviazioni................................................................................... » 11
Cap. 1 Una leggenda nera e qualche luogo comune.................... » 15
Cap. 2 “Gloriosa libertà” e “rivalità secolare”? ............................. » 25
Cap. 3 Il 1528, annus terribilis:premesse, eventi, conseguenze ........................................ » 39
Cap. 4 Comparazioni.................................................................. » 57
Cap. 5 Sottomissione, autonomia, consenso ............................... » 67
Cap. 6 Sovrano tutore e comunità pupilla ................................. » 97
Cap. 7 Fare fortuna nel «secolo dei genovesi» ............................ » 109
Cap. 8 L’esproprio della memoria .............................................. » 121
Cap. 9 Gli artigli del fisco .......................................................... » 135
Cap. 10 Distruggere e costruire ................................................... » 153
Cap. 11 Ostacoli e incentivi all’economia .................................... » 171
Cap. 12 La fortezza e le soldatesche ............................................. » 193
Cap. 13 Una storia economica da fare ......................................... » 205
Indice dei nomi ............................................................................... » 219
Indice
8
Prima Sezione
I Savona sottomessa da Andrea Doria nel 1528 .................... Pag. I
II I decreti del Senato di Genova regolano la vita di Savona .. » II
III La città continua a reggersi in base ai propri statuti e
le vengono concessi privilegi e autonomie .......................... » IV
IV Savona conserva e regola le proprie “arti” ........................... » VII
V I Governatori e i Commissari della fortezza sono
scelti tra i nobili genovesi più illustri ................................. » X
VI Il Santuario, centro di potere e luogo-simbolo della
collaborazione tra Genova e Savona ................................... » XII
Seconda Sezione
VII Il Bosco di Savona.............................................................. » XVII
VIII I ricchi patrizi savonesi e alcune grandi famiglie genovesi
costruiscono sontuosi palazzi e splendide ville suburbane... » XIX
IX La difficile conservazione della memoria storica ................. » XXX
X Cooperazione e adulazione................................................. » XXXI
Terza Sezione
XI La fortezza del Priamàr, irrinunciabile apparato di difesa
e simbolo di oppressione .................................................... » XXXIII
XII Una politica che contempla poche infrastrutture................ » XXXV
XIII Immagini della città e del suo territorio ............................. » XXXIX
XIV La Chiesa savonese retta da vescovi genovesi ...................... » XLVI
Indice iconografico
9
Libro di piacevole lettura, ricco di notizie curiose e impensate, note e nonnote, sempre comunque documentate. Tutto qui? Direi di no.
Infatti: chi lo ha scritto non è certo un ricercatore di curiosità e piacevolezzeda conversazione. Chi lo presenta è un’istituzione di cui si può dir tutto quelche si vuole, ma non certo che sia un qualcosa di irrilevante per la vita di que-sta città.
Il libro è stato pensato e voluto come “storia” ossia come sforzo di capire, didarsi conto, di inquadrare il frammento, anche il più piccolo, in un quadrogenerale, in un significato. Vuole essere uno stimolo alla riflessione basata sullaconoscenza e volta all’azione.
Nell’ultima pagina salta fuori, quasi per inciso, quella che è la vera molla dacui è scaturita la ricerca; il lettore avveduto e pensoso non avrà certo bisogno diarrivare fino in fondo per capire; ritengo tuttavia più significativo di ogni miodiscorso, anticiparne due righe: «viene quasi la tentazione di paragonare laSavona settecentesca a quella degli ultimi decenni del Novecento, che dopo la rapi-da deindustrializzazione ha conservato ottimi livelli di vita, ma al prezzo di uncomplessivo immobilismo, di un ripiegamento demografico, di una perdita di pro-spettive soprattutto per i più giovani».
Franco BartoliniPresidente
Cassa di Risparmio di Savona SpA
Presentazione
11
AMSSSP «Atti e memorie della Società savonese di storia patria»
ASCG Archivio storico del Comune di Genova
ASG Archivio di Stato di Genova
ASLSP «Atti della Società ligure di storia patria»
ASS Archivio di Stato di Savona
Abbreviazioni
Nel 1849 Tommaso Torteroli, sacerdote e bibliotecario civico, pubblicò unaStoria del Comune di Savona che, pur essendo opera modesta, riscosse tra i savo-nesi colti un certo successo, destinato tra l’altro a durare nel tempo, come dimo-stra la ristampa anastatica proposta nel 1977 dall’editore Forni1. L’autore,infiammato di ideali risorgimentali, dedicava il proprio volume alla primaamministrazione comunale “democratica”, cioè eletta col suffragio dei cittadini,e auspicava la nascita di una nazione italiana «libera, alta e possente».Ammiratore di Sismondi e della sua Storia delle repubbliche italiane del medioe-vo, Torteroli celebrava i fasti del comune savonese fra XI e XVI secolo, un’epo-ca sana, gagliarda, prospera, dopo la quale per la sua piccola patria e per l’Italiac’erano stati solo declino materiale, snervamento morale, sudditanza allo stra-niero. Per Savona il tornante decisivo era stato il 1528, quando Genova l’avevasottomessa con la forza. Da allora «la ragguardevolissima terra […] ridotta apodesteria genovese, perduto ogni rigoglio, s’incamminò a passi grandi e velocia miserabilissimo stato» e «parve una tomba». La popolazione, nel giro di unsecolo, sarebbe scesa da 36.000 a 8.000 abitanti, «per la maggior parte poveri edesolati uomini, e ciò per mancamento di ogni ragion di commercio, per esse-re lasciati senza una strada al mondo, divisi da tutti i circostanti paesi»: cosic-ché «Savona fu misera e grama sempre […] per oltre due secoli e mezzo»2.Mentre la penisola intera si apprestava a entrare in una lunga fase di decaden-za, la città suddita perdeva ogni speranza, ogni ragione di essere, non valevaneppure più la pena di farne la storia – e infatti la narrazione di Torteroli si arre-stava appunto al 1528. Solo a partire dal 1805 l’Impero napoleonico le avreb-be dato un effimero «accrescimento», in attesa che il 1848 e la rinascita dellanazione italiana la ridestassero a nuova vita.
Nello schema che abbiamo qui riassunto non c’è molto di inconsueto. Si puòdire che quasi tutta la storiografia italiana, tra la metà dell’Ottocento e la secon-da Guerra Mondiale, ha seguito una traccia analoga. In particolare ha visto nellafase comunale un momento tutto progressivo e positivo: sulla scorta appuntodi Sismondi e di Cattaneo – ha scritto Giorgio Chittolini – «le libere istituzio-ni municipali continuarono a essere considerate come il modello e il simbolo diuna felicissima condizione civile e politica […] che la società italiana non avreb-
15
1 T. TORTEROLI, Storia del Comune di Savona, Savona, Tip. Felice Rossi, 1849; e Bologna, Forni, 1977. SulTorteroli (1810-1868), oltre al vecchio articolo di G. ROSSI, Savona e i suoi scrittori di storia, «Archivio storicoitaliano», 1878, pp. 418-428 (dove della sua Storia si dice: «più che libro storico si può appellare pagina di sde-gnosa polemica contro Genova»), si veda M. VIOLA, Tommaso Torteroli erudito savonese del XIX secolo, AMSS-SP, n. s., vol. XLIII, 2007, pp. 341-375.
2 T. TORTEROLI, op. cit., pp. 372-380.
Capitolo 1
Una leggenda nera e qualche luogo comune
Capitolo 1
be più saputo raggiungere»3. Sono stati il basso medioevo e il Rinascimento adattirare a lungo l’attenzione degli studiosi, mentre i secoli seguenti destavanominore interesse, e ancora nel 1974, in un’opera pur d’avanguardia come laStoria d’Italia Einaudi, si poteva definire il Seicento «un secolo senza politica»4.A maggior ragione questo paradigma è stato applicato ai centri minori, quellivia via sottomessi da altri più forti (Venezia, Milano, Firenze) ed entrati a farparte di formazioni statali più ampie, cosicché sino a non molto tempo fa le sto-rie di tutte le città italiane che non erano divenute capitali di uno Stato regio-nale si arrestavano in pratica al momento della sottomissione, della perdita del-l’antica libertas. Ma nelle pagine di Torteroli si delineava forse un tratto origi-nale: nella storia di Savona la sottomissione del 1528 appariva così violenta edrammatica da riverberarsi profondamente su tutte le vicende precedenti: larivalità con Genova, o per meglio dire la prepotenza e la malvagità dei genove-si, diventavano la principale chiave di lettura non solo dei duecentosettantaanni che avevano seguito quella data fatidica, ma anche dei quattro secoli chel’avevano preceduta. Da allora la storiografia savonese – che non sempre ha bril-lato per qualità – ha ripetuto molte volte gli stessi giudizi e replicato all’infini-to gli stessi anatemi contro la potente vicina.
Pochi anni dopo Torteroli, Nicolò Cesare Garoni – portavoce dell’intelli-ghenzia savonese del tempo – scriveva che «la storia della città e del comune diSavona […] è una lotta interminabile contro Genova, […] è uno sforzo ostina-to e impotente per isciogliersi dalle intollerabili pastoie» con cui questa la tienelegata e la sfrutta, una serie di ribellioni fallite, al termine delle quali ecco laSuperba «sfogare l’ira sua, fulminar le sue vendette sulle pietre della città, diroc-car le mura, mozzar le torri, empiere i fossi»5. Nel 1891, tracciando un quadrodel ponente ligure nel medioevo, Andrea Calenda di Tavani sostiene: «La dife-sa della propria indipendenza rimpetto a Genova ed il contrasto lungo, tenaceal dominio della rivale dai primi tempi fino al decimosesto secolo formano, puòdirsi, il vero ritratto storico di Savona»6. All’inizio del Novecento AgostinoBruno, uno dei più prolifici storici locali, nella sua opera maggiore ripete imedesimi concetti, e inoltre distribuisce i propri interessi in proporzioni che siritroveranno pressoché identiche nelle opere di altri autori: delle 253 pagine delvolume, 120 le dedica all’età del libero comune sino al 1528, solo 20 ai secoliXVI-XVIII, il resto all’«età francese» e all’Ottocento7. È, per così dire, il pianodi lavoro cui si atterranno anche i due maggiori protagonisti della storiografiasavonese nella prima metà del XX secolo, Filippo Noberasco e Italo Scovazzi, iquali – facendo anch’essi della rivalità con Genova il filo conduttore di tutta la
16
3 G. CHITTOLINI, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, Torino,Einaudi, 1979, pp. 3-4.
4 C. VIVANTI, La storia politica e sociale. Dall’avvento delle signorie all’Italia spagnola, in Storia d’Italia, vol. 2,Dalla caduta dell’Impero romano al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1974, pp. 275-427 (in particolare pp. 423-427).
5 N. C. GARONI, Guida storica economica ed artistica della città di Savona compilata coi documenti degli archivimunicipali, Savona, G. Sambolino, 1874, pp. 164-165.
6 A. CALENDA DI TAVANI, Patrizi e popolani del medio evo nella Liguria occidentale, Trani, V. Vecchi, 1891-92, pp.170-171.
7 A. BRUNO, Storia di Savona dalle origini ai nostri giorni, Savona, Tip. Bertolotto, 1901.
Una leggenda nera e qualche luogo comune
storia di Savona – si affaticheranno soprattutto sul medioevo, e in subordinesugli anni napoleonici e risorgimentali, ignorando quasi completamente ilperiodo intermedio, quello che va dal 1528 al 17978.
L’insistenza sulla “eterna rivalità” – che spesso è stata segnalata addirittura apartire dalle guerre puniche! – è il tratto tipico di altri studiosi: «le lotte traGenova e Savona costituiscono il motivo principale della storia del comunesavonese», scriveva sbrigativamente nel 1942 – in un saggio peraltro di grandefinezza analitica – il giovane Carlo Russo9. Più recentemente, in un articolodedicato alla costruzione della fortezza sul Priamàr, Rinaldo Massucco si lascia-va andare a un durissimo j’accuse contro le ininterrotte sopraffazioni genovesi apartire almeno dagli inizi del XII secolo10. E nel bel volume del 1982 dedicatoproprio al Priamàr dallo stesso Massucco – unitamente a Marco Ricchebono,Magda Tassinari e Carlo Varaldo – ancora una volta la storia di Savona lungotutto il medioevo veniva considerata «essenzialmente lo scontro fra due cittàconcorrenti, due grandi porti dell’alto Tirreno con simili e nello stesso tempoopposti interessi, che, troppo vicini per poter tranquillamente coesistere, devo-no necessariamente combattersi fino al definitivo prevalere dell’uno sull’al-tro»11. Sempre nel 1982 Nello Cerisola nella sua corposa Storia di Savona, dopoaver affermato in sede di prefazione che non intendeva uniformarsi «all’abusa-ta, classica storiografia municipale che […] faceva leva […] sull’antagonismosecolare con Genova» e dopo aver deprecato «i deleteri campanilismi del passa-to, che non sono più delle nostre generazioni», ricostruiva poi le vicende dimezzo millennio proprio intorno alla «acerba rivalità fra i due popoli di Savonae di Genova […] che per molti secoli li mantenne sul piede di guerra sciupan-do in una stolta lotta fratricida preziose energie che avrebbero certo potuto tro-vare più proficui impieghi a vantaggio di entrambi»; e non perdeva occasioneper sottolineare come la causa prima di questa rivalità fosse la continua volontàoppressiva dei genovesi, perché «la lotta fu sempre a senso unico e cioè diGenova contro Savona»12.
Nel frattempo, però, maturavano concezioni diverse. Fin dal 1888 PaoloBoselli, un personaggio che tra le molte doti possedeva anche notevole acumestorico, aveva messo in guardia contro quelle eccessive semplificazioni, invitan-do a porre domande nuove, ad allargare la visuale ben oltre le mura cittadine e
17
8 La bibliografia di Noberasco e Scovazzi è ricchissima di titoli (se ne può trovare un elenco abbastanza com-pleto in N. CERISOLA, Storia di Savona, Savona, Editrice Liguria, 1982, pp. 933-937 e 950-952), ma qui basti ricor-dare la loro Storia di Savona, 3 voll., Savona, Società savonese di storia patria, 1926-1928, che significativamente siarresta al 1528; o la nuova edizione che ne è stata proposta cinquant’anni dopo (Storia di Savona: vicende di unavita bimilleniaria, 2 voll., Savona, Sabatelli, 1976), annettendovi altri scritti che, appunto, riguardano quasi soltan-to l’età napoleonica e il Risorgimento, mentre il capitolo Savona dopo la catastrofe nei secoli XVI, XVII e XVIII con-sta solo di una ventina di pagine.
9 C. RUSSO, L’arbitrato di Giulio II nella secolare lotta tra Genova e Savona, AMSSSP, vol. XXIV, 1942, pp.3-30 (qui p. 5).
10 R. MASSUCCO, L’estremo tentativo di salvare il quartiere del Priamàr, AMSSSP, n. s., vol. IV, 1970-71, pp.309-313.
11 R. MASSUCCO, M. RICCHEBONO, M. TASSINARI, C. VARALDO, Il Priamàr prima pietra della storia bimil-lenaria di Savona, Savona, Sabatelli, 1982, p. 31.
12 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., pp. 6, 44, 238 e passim.
Capitolo 1
a lasciar perdere «le patriottiche ire del Torteroli»13; ma era rimasto inascoltato.Molto più tardi, tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento, erano statialcuni importanti studiosi genovesi (Vito Vitale, Geo Pistarino, Dino Puncuh)a sottolineare che non si poteva ridurre una vicenda complessa e di respirointernazionale come quella della Savona medievale a un lungo, monocorde con-flitto con Genova; e le loro critiche vennero accolte e tradotte in proficui pro-grammi di lavoro da diversi ricercatori più giovani, a cominciare da CarloVaraldo il quale già a partire dal 1975 rilevava che l’insistenza sull’antagonismocon Genova quale unica chiave interpretativa aveva appiattito e impoverito ilquadro storico, facendo tra l’altro dimenticare che la città non era affatto unarealtà univoca tutta tesa all’eterna lotta con la rivale, ma era un intrico di fazio-ni politiche e di gruppi sociali in contrasto tra loro e legati in varie forme allefazioni e ai gruppi genovesi14. Successivamente Varaldo è tornato a più ripresesull’argomento, da un lato ribadendo il suo distacco da quella «vecchia storio-grafia savonese», localistica e di basso profilo, che aveva «colto delle vicendedella città la sola tematica del conflitto con Genova, esaurendo praticamente inuna funzione “in negativo” […] una storia ben più vitale e articolata»; e d’altrolato fornendo con le sue ricerche un affresco ampio e dettagliato di Savona nelQuattrocento dal punto di vista sia delle articolazioni politico-sociali, sia delleattività manifatturiere e del grande commercio internazionale15.
Analogamente Angelo Nicolini, rifiutando la «visione vetero-campanilistica»che riduceva tutto al «ruolo oppressore esercitato da Genova», ha ripercorso inalcuni intelligenti articoli la vita economica della Savona medievale, il grandeventaglio dei suoi traffici marittimi dai Paesi Bassi alla Crimea, gli intrecci com-plessi e non necessariamente antagonistici con Genova stessa16. E GiulioFiaschini, in un saggio di grande intelligenza, ha mostrato come il rapporto chelegava le due città rivali fosse ben più complesso di quanto credevano i vecchistorici locali, e come per comprenderlo occorresse allargare di molto lo sguardoal di là dell’orizzonte cittadino o regionale17: cosa che recentemente ha cercatodi fare a più riprese, a nostro avviso con esiti eccellenti, Riccardo Musso18.
18
13 P. BOSELLI, Discorso per l’inaugurazione della Società Storica Savonese, Savona, Tip. D. Bertolotto, 1888,p. 25.
14 C. VARALDO, La topografia urbana di Savona nel tardo medioevo, Bordighera, Istituto internazionale distudi liguri, 1975, p. 12.
15 C. VARALDO, Savona nel secondo Quattrocento. Aspetti di vita economica e sociale, in Savona nelQuattrocento e l’istituzione del Monte di pietà, Savona, Cassa di Risparmio di Savona, 1980, pp. 9-163 (la cita-zione qui sopra è a p. 9); ID., Appunti sui ceti dirigenti nella Savona del secondo Quattrocento, in La storia deiGenovesi, vol. III, Genova, Associazione nobiliare ligure, 1983, pp. 131-141.
16 A. NICOLINI, Viaggi e commerci nella Savona medioevale, «Rivista ingauna e intemelia», n. s., XLII-XLIII,1987-88, pp. 97-112; ID., La gestione del porto di Savona fra Tre e Quattrocento, AMSSSP, n. s., vol. XXXVII, 2001,pp. 5-57.
17 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore tra medioevo ed età moderna, in La Madonna di Savonaa cura di S. RIOLFO MARENGO, Savona, Cassa di risparmio di Savona, 1985, pp. 49-78.
18 R. MUSSO, Ceto dirigente, fazioni ed istituzioni comunali della Savona rinascimentale, in Giovanni AgostinoAbate. Una fonte per la storia di Savona nel XVI secolo. Studi in occasione del quinto centenario della nascita (1495-1995) a cura di C. PAOLOCCI E F. MOLTENI, Genova, Associazione Amici della Biblioteca Franzoniana, 1995,pp. 7-50; ID., Lo “Stato cappellazzo”. Genova tra Adorno e Fregoso (1436-1464), in «Studi di storia medioevalee diplomatica», 17, 1998, pp. 223-286; ID., “Viva el Duca et lo Sancto Padre”. Savona al tempo degli Sforza e diSisto IV, AMSSSP, n. s., vol. XXXVII, 2001, pp. 59-153.
Il risultato è che oggi tutte le tradizionali storie di Savona – ivi compresaquella benemerita miniera di notizie politico-diplomatiche che è l’opera diNoberasco e Scovazzi – risultano agli occhi dello studioso, ma anche del letto-re attento di “memorie patrie”, insopportabilmente parziali, ottuse, datate. Ilquadro della città medievale si è arricchito, mentre gli stereotipi si sono logora-ti e frantumati, come cercheremo di mostrare, almeno per accenni, nel capito-lo seguente. Quel che però non è cambiato, salvo rare eccezioni, sono le cono-scenze e i giudizi relativi all’età successiva, ai due secoli e mezzo abbondantiseguiti al 1528.
Cominciamo dai giudizi, e per farlo apriamo una cronaca savonese delSeicento, il cosiddetto “manoscritto Pavese”, cui un anonimo postillatore otto-centesco ha aggiunto qualche commento definendo i secoli XVII e XVIII l’e-poca «in cui Savona per la perduta libertà non poteva avere più storia», perché«la terra era spopolata misera e grama per volere della prepotenza e del vandali-smo genovese», sotto la cui dominazione la città «si poteva chiamare la terra deimorti»19: una decadenza totale fino all’annichilamento, dunque, tanto da con-figurarsi come una sorta di interruzione del divenire storico. Ebbene, esageran-do un poco potremmo dire che a tutt’oggi, per quanto riguarda la storia diSavona durante l’età moderna, non siamo andati molto al di là delle parole del-l’anonimo, o di quelle usate sul finire del secolo XIX dal canonico AndreaAstengo – editore di un’altra e ben più corposa cronaca seicentesca, quella diGian Vincenzo Verzellino – là dove sostiene che Savona, dopo il 1528, era«caduta in basso per la perdita di ogni sua libertà, per l’abrogazione di tutti isuoi privilegi, per la rovina del suo porto e per la distruzione della massimaparte delle sue case»20. Mentre proprio all’aprirsi del secolo XX Agostino Brunoscriveva: «caduto il Comune […], Savona non rimase che una città di conqui-sta, all’arbitrio assoluto di Genova», una «Cartagine ligure» ridotta a fantasma,in cui era «spenta ogni vitalità», in cui sopravvivevano solo «desolazione eabbandono»21.
Da allora ogni intervento in materia ha rappresentato una variazione su que-sto tema, magari con qualche bel tocco di colore e un’intonazione manzoniana,come in questo passo di Paolo Boselli:
Nel secolo XVII, di piacevole a Savona non era rimasta che l’aria. Muti gli affarinel nostro abbandonato Rialto. Era spettacolo la nobiltà pelata fra i tributi, la qualeintanto poneva ogni ora in forza del giuoco le doti delle mogli e delle madri. Lagente di villa, fosco lo sguardo, traeva in terra gli aratri miseramente logorati e veniamanco per fame. I giusdicenti [genovesi] smungevano i poveri. Era tale tormento,tale solitudine, che agli spiriti generosi pareva impossibile poterla sostenere22.
19
19 Cronaca savonese dal 1600 al 1675 (m. s. di G. B. Pavese) a cura di G. FARRIS, Savona, Sabatelli, 1999, p.42.
20 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona cura-te e documentate dal canonico arciprete A. ASTENGO, Savona, D. Bertolotto, 1885-1891, vol. II, p. VII.
21 A. BRUNO, Storia di Savona cit., p. 123.22 P. BOSELLI, L’esposizione savonese del 1897, in Esposizione agricola, industriale, artistica e didattica promos-
sa dalla Società economica di Savona, 1897, Savona, Tip. Ferretti, 1898.
Una leggenda nera e qualche luogo comune
Capitolo 1
Ripercorrendo le storie locali si trova infatti sempre il medesimo topos, dallaversione per così dire classica di Noberasco e Scovazzi («la vita savonese intristi-va nella uggiosa uniformità della miseria e del torpore. […] La sventurata cittàsi andava rapidamente spopolando. […] Precipitosa fu la decadenza delle arti.[…] Un cumulo d’altre disavventure si abbatté sull’infelice città»23), a quella diVittorio e Poggio Poggi («il periodo della dominazione genovese è il più tristeper Savona che aveva visto svanire tutti i suoi rigogliosi traffici, tutte le sue ric-chezze, tutte le sue glorie», rimanendo «misera, senza speranza alcuna»24); daCarlo Varaldo (che parla di una città privata col suo porto di ogni prosperità edi ogni forza di attrazione, «schiacciata da inasprimenti fiscali sempre più pesan-ti», «fossilizzata per quasi tre secoli» in una crisi senza sbocchi25) a Nello Cerisola(secondo il quale dopo il 1528 inizia un lungo «dopoguerra che doveva duraresino alla fine del Settecento», «anni di miserie e di persecuzioni» durante i quali«la città si spense e cominciò a vegetare […], i commerci si ridussero spavento-samente, […] e le manifatture si ridussero in maniera drastica»26).
Se ci si chiede su quali conoscenze e su quali basi documentarie poggino que-sti giudizi, la risposta è presto data: soprattutto sulla cronaca cinquecentesca diAgostino Abate27, poi su alcuni passi di quelle seicentesche del Verzellino e diAntonio Maria de’ Monti28, sulle note di viaggiatori come Montesquieu, pocoteneri verso la Repubblica di Genova e abbastanza inclini a parlarne malecomunque29, infine su qualche supplica (il cui incipit non manca mai di lamen-tare lo stato di miseria e desolazione) inoltrata dall’amministrazione savonesedell’epoca, la quale poneva ogni cura, rivolgendosi al governo genovese, neldipingere a tinte fosche la situazione della città per motivare le proprie richie-ste di sgravi fiscali, di contributi per opere pubbliche, di provvedimenti a favo-re dell’economia locale. La documentazione è così ristretta perché, come si èvisto, per molto tempo della storia di Savona nell’età moderna nessuno si èoccupato e nessuno ha ritenuto che valesse la pena di occuparsi. Per convincer-sene basta consultare alla voce «Savona, storia» il vecchio catalogo a soggettodella locale biblioteca civica: pur essendo fatto con molta cura, per tutto ilperiodo 1529-1797 non contiene quasi nessuna scheda. D’altronde quando,nel 1928, alcuni tra i più prestigiosi studiosi di storia ligure dedicarono un volu-me “savonese” al vecchio Paolo Boselli, riuscirono a coprire con i loro saggi un
20
23 F. NOBERASCO-I. SCOVAZZI, Storia di Savona. Vicende di una vita bimillenaria cit., vol. II, pp. 25-27.24 V. POGGI-P. POGGI, Cronotassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il Comune di Savona
dalle origini alla perdita della sua autonomia, parte VI, AMSSSP, vol. XXI, 1940, pp. 3-155 (in particolare pp.129-130).
25 M. RICCHEBONO-C. VARALDO, Savona, Genova, Sagep, 1982, pp. 81-82.26 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., p. 241.27 A. ABATE, Cronache savonesi dal 1500 al 1570 accresciute di documenti inediti, pubblicate e annotate da
G. ASSERETO, Savona, Tip. Bertolotto, 1897.28 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit.; A. M. DE’ MONTI, Compendio di memorie historiche della
città di Savona e delle memorie d’huomini illustri savonesi, Roma, Stamperia di Marc’Antonio e Orazio Campana,1697.
29 C.-L. DE MONTESQUIEU, Viaggio in Italia a cura di G. MACCHIA e M. COLESANTI, Roma-Bari, Laterza,1995, pp. 103-104; G. ASSERETO, Viaggiatori francesi a Genova tra Seicento e Settecento: pregiudizi e stereotipi,«Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”», vol. LXX, 2000, pp. 3-12.
Una leggenda nera e qualche luogo comune
arco cronologico vastissimo, nel quale però veniva saltato a piè pari appuntoquel periodo, perché su di esso non c’era nulla da dire30. E da allora la situazio-ne non è molto cambiata, a parte pochissime eccezioni di cui parleremo inseguito.
Ricordavamo più sopra che la storiografia italiana aveva a lungo riservatoun’attenzione molto debole all’età post-rinascimentale, quella delle «preponde-ranze straniere», per usare un’espressione cara agli storici attivi nel primoNovecento; e quel relativo disinteresse aveva una sua logica nel quadro di studisoprattutto politico-diplomatici. A proposito della realtà locale, ancora Boselliaveva scritto con qualche ragione che, dopo il 1528, «il periodo dell’assolutodominio di Genova […] era stato per Savona periodo di annali amministrativie di rassegne economiche anziché di vera storia politica»31. Ma in decenni piùrecenti, quando gli storici italiani coltivavano sempre più spesso e con frutticopiosi il terreno della storia economica e sociale, quel rifiuto di prendere inconsiderazione i “secoli bui” della città non aveva più ragione di essere, era nul-l’altro che un ritardo culturale, spiegabile probabilmente con un accanito pro-vincialismo.
Come che sia, la ricostruzione della storia di Savona nell’età moderna è anco-ra quasi tutta da fare, e il poco che ne sappiamo si riduce a una sbrigativa histo-ria calamitatum in cui Genova, la «Dominante», fa più che mai la parte del vil-lain. Per lo studioso che voglia affrontare seriamente questo periodo si aprequindi un campo molto vasto, anche perché il materiale disponibile negli archi-vi di Savona, di Genova e in altri ancora è fin troppo abbondante. Quasi inevi-tabilmente, il primo compito interessante che si presenta – e che cercheremo diaffrontare in questo libro – è proprio la verifica di quella leggenda nera, di quelluogo comune che fa coincidere l’ostinata oppressione genovese e la cupa deca-denza savonese. Di fronte ai luoghi comuni, la tentazione è spesso quella didemolirli e rovesciarli, ma nel nostro caso sarebbe certamente una sciocchezza.Anche sulla base delle poche conoscenze di partenza, i sintomi di decadenza edi oppressione sono difficilmente negabili, e un “revisionismo” preconcetto,oltre ad essere disonesto, produrrebbe bugie dalle gambe corte.
Quel che vale la pena di fare è semmai entrare nel concreto: accumularealmeno qualche dato su quella decadenza; verificare i modi e la misura in cui siè realizzata quell’oppressione; ascoltare le ragioni dei vincitori accanto a quelledei vinti; analizzare le forme di convivenza e di accordo che certo non sonomancate, nell’arco di quasi tre secoli, tra la città dominante e quella suddita;studiare l’articolazione della società cittadina, partendo dall’ipotesi verosimileche crisi economica e sudditanza politica non sono mai uguali per tutti, che inqualunque situazione, anche la più sfavorevole, c’è sempre qualcuno che soffremeno di altri, si ritaglia posizioni privilegiate o addirittura si avvantaggia. Sitratta inoltre di riflettere sul fatto che il rapporto di potere e di sfruttamento
21
30 Savona nella storia e nell’arte. Scritti offerti a Paolo Boselli, Genova, Tip. Artigianelli, 1928.31 P. BOSELLI, Discorso per l’inaugurazione cit., p. 26.
Capitolo 1
instauratosi tra Genova e Savona non rappresenta certo un unicum, bensì unfatto comune – sia pure con molte varianti – a buona parte dell’Italia centro-settentrionale fra Quattrocento e Settecento.
Perché l’impresa abbia un senso, bisogna uscire dall’ambito della vecchia sto-riografia “municipalistica” la quale, chiusa in un orizzonte limitato e animata dauna «incontenibile pietas loci», si rifiuta di cercare connessioni con realtà piùampie, di assumere una dimensione comparativa, di guardare le ragioni altrui,e ritiene che la piccola patria oggetto della sua ricerca sia per così dire l’ombe-lico del mondo e la misura di tutte le cose: insomma, la storia locale nella peg-giore accezione del termine, il cui connotato negativo non riguarda tanto «lalimitatezza del campo di ricerca», che è del tutto legittima, quanto «l’angustiadi orizzonte critico»32. Una storia locale che, per redimersi da questi peccati,deve appunto chiedersi cosa succede contemporaneamente altrove, tenere d’oc-chio una cronologia e un panorama più ampi, il rapporto con lo Stato nel suocomplesso, il contesto internazionale e così via; una storia locale che, a diffe-renza di quanto pensano gli studiosi dilettanti, non è «una cosa che sanno faretutti», e non ha nulla a che vedere con la «pura celebrazione localistica»33.
Ma questi, si dirà, sono problemi che riguardano una ristretta cerchia diintellettuali e di eruditi, topi di biblioteca o razzolatori di carte d’archivio. Einvece no, perché la storia – a tutti i livelli – non è mai una disciplina platoni-ca e inoffensiva, come hanno sempre saputo fin da tempi lontani gli Stati e leChiese che ne controllavano la produzione e la diffusione, e come ci hannoinsegnato tutti i regimi liberticidi del XX secolo che ad essa hanno prestato lamassima attenzione, fino al punto di riscriverla radicalmente col mutare dellecircostanze e delle esigenze del potere. Nella piccola patria di cui ci occupiamoi problemi sono certamente più banali e modesti, ma anche qui la storia espli-ca le sue funzioni politiche, specie se si considera ciò che potremmo definireuna communis opinio, un senso comune storiografico, una vulgata, una sensibi-lità collettiva. In genere gli storici non amano occuparsi di tali vulgate, a menoche esse non riguardino temi scottanti come il fascismo, la shoah, o simili; mafanno male e fanno torto al loro lavoro, perché con i luoghi comuni, con le“verità” diffuse bisogna invece fare i conti, se la storiografia vuole avere una fun-zione che non sia unicamente quella di consumare i cervelli degli accademici odi produrre elucubrazioni comprensibili solo agli accademici stessi, se non vuoleabdicare al compito di informare correttamente un pubblico più vasto.
Scendendo dal piano dei problemi generali a quello della realtà locale e deitemi affrontati in questo libro, va detto chiaro che persiste nella communis opi-nio dei savonesi sia l’idea che «Genova matrigna» porti le colpe di quasi tutti imali che per secoli hanno afflitto la loro città, sia la convinzione che a tutt’og-gi la malevolenza genovese non abbia cessato di agire e continui a produrre
22
32 Riprendo qui le considerazioni di G. TOCCI, Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospet-tive di ricerca, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1997, pp. 18-22.
33 G. RICUPERATI, In margine a “Rivoluzione e reazione fra Liguria e Piemonte (1796-1799)”, «Rivista stori-ca italiana», CXVI, 2004, pp. 1114-1128 (in particolare pp. 1114-1119).
Una leggenda nera e qualche luogo comune
effetti negativi. Si può naturalmente far conto che questi sentimenti non esi-stano, ignorarli rivendicando all’analisi storica una sorta di superiore indiffe-renza, rivolgersi a interlocutori non toccati da simili pregiudizi. Ma sarebbeipocrisia: se mai queste pagine avranno qualche lettore, è probabile che si trat-ti per lo più di savonesi o comunque di liguri, non immuni da quelle idéesreçues. Idee che nel tempo hanno influito sui comportamenti collettivi e suglischieramenti politici, hanno determinato scelte economiche. A chi scrive è capi-tato, anni fa, di far la storia dell’Istituto che edita questo volume, la Cassa dirisparmio di Savona, e di scoprire quanto, negli anni venti del Novecento, aves-se pesato il sentimento antigenovese nel determinare l’ostinata difesa dell’auto-nomia di questa banca rispetto alla consorella di Genova34; e ogni savonese saquanto lo stesso sentimento abbia contribuito a rendere lungo e tormentato, inanni più recenti, l’iter attraverso il quale la seconda è giunta a controllare laprima. Ma sono innumerevoli le occasioni in cui – quando a livello regionale enazionale si trattava di prendere decisioni relative a Savona e riguardanti la poli-tica industriale, la costruzione di infrastrutture, la spartizione di finanziamenti– il revanscismo (o il vittimismo) savonese nei confronti della Superba è torna-to a farsi sentire, a torto o a ragione.
Una volta riconosciuto che il problema esiste, bisognerebbe tuttavia analiz-zarne la genesi e gli sviluppi. Quando, come, perché e tra chi si diffonde quel-la robusta, durevole avversione per Genova di cui stiamo parlando? L’indagineesula dai compiti che qui ci siamo prefissi, e certo richiederebbe uno studioapprofondito dei ceti dirigenti e degli intellettuali locali, specie tra la metàdell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ma non solo. Perché l’origine è lonta-na, tanto è vero che nel 1797, appena caduta la repubblica oligarchica e instau-rato un regime democratico o “giacobino” come allora si diceva, i maggiorentisavonesi si erano affrettati – con un accanimento ben superiore a quanto fosserichiesto dall’opportunità politica del momento – a levare accuse roventi con-tro «la tirannia aristocratica», «l’infernale politica», la «mano di ferro» del vec-chio governo genovese, e a ricordare tutti i mali che la città ne aveva sofferto: lademolizione «a spese de’ proprietari», negli anni quaranta del Cinquecento, delsuo quartiere più antico e prestigioso per innalzare al posto di esso una grandefortezza; la devastazione del porto, un tempo «accessibile ad ogni sorta di basti-menti»; una pressione fiscale insopportabile; la paralisi del commercio e dellemanifatture; e, più in generale, «la degradazione in cui si aveva cura di tenercisempre umiliati»35. Erano lagnanze che avevano certo dei fondamenti oggettivi,ma c’è da pensare che ancor più rilevante fosse l’aspetto soggettivo di quell’av-versione per il passato dominio, visto quanto poi accadde tra il 1805 e il 1814,allorché la Liguria entrò a far parte dell’Impero francese. Il ceto dirigente savo-nese mostrò per il regime napoleonico un favore che può in parte spiegarsi con
23
34 G. ASSERETO, Cassa di risparmio di Savona (1840-1990). Centocinquant’anni di storia, Savona, Cassa dirisparmio di Savona, 1991, pp. 282-285.
35 Tale il testo dell’arringa letta dalla deputazione savonese giunta a Genova per felicitare il nuovo governoprovvisorio della Repubblica Ligure («Gazzetta nazionale della Liguria», 24 giugno 1797).
Capitolo 1
l’orgoglio di vedere la propria città elevata a capoluogo di dipartimento e ono-rata dalla presenza di un grande funzionario come il prefetto Gilbert Chabrolde Volvic, il quale concepiva per essa progetti di rilievo, ma ancor più si giusti-fica con il forte rancore antigenovese di quel ceto. Perché gli anni francesi furo-no un periodo di profonda crisi economica, di blocco del commercio maritti-mo, di guerre continue che si portavano via la gioventù più vigorosa, e solo unlivore profondo verso il padrone antico poteva indurre ad amare o quantome-no a tollerare benevolmente il padrone nuovo.
Nel corso dell’Ottocento, e poi ancora nel secolo seguente, l’età napoleonicafu mitizzata dalla cultura locale e venne a costituire l’elemento positivo di unbipolarismo in cui la dominazione genovese rappresentava la negatività assolu-ta. Quell’età ricevette e riceve tuttora grande attenzione da parte degli studiosidi storia patria, ma per lo più in forme acritiche, che ne danno per scontato ilruolo progressivo e costruttivo. Cosicché di quelle due epoche – i “secoli geno-vesi” e gli “anni francesi” – si è finito con l’avere conoscenze quantitativamentediverse, poverissime in un caso e ricche nell’altro, ma ugualmente viziate da pre-giudizi che in un certo senso si puntellano a vicenda.
Non è questa – torniamo a dire – la sede per ricostruire esattamente i per-corsi di quei pregiudizi speculari e per chiarire tutte le ragioni della loro longe-vità, ma almeno un paio di elementi vanno segnalati. Il primo riguarda la pecu-liarità savonese rispetto ad altre analoghe situazioni: fra il XIV e il XVI secolo– ne riparleremo in un capitolo successivo – furono molte le città italiane a per-dere la loro libertas per opera di una vicina più potente, e per alcune di loro lasottomissione avvenne in forme violente, che lasciarono strascichi di rancore;ma in nessun caso, neppure in quelli più emblematici di Pisa e di Siena nei con-fronti di Firenze, tale rancore si protrasse così a lungo nella coscienza cittadina.Il secondo concerne un atteggiamento che Genova – a differenza di altri capo-luoghi regionali – ha spesso tenuto nel corso dell’Ottocento e del Novecento,sfruttando il proprio maggior peso economico, demografico, culturale, politicoper imporre alle città minori della Liguria, e in primo luogo a Savona, scelteegoistiche in tema di infrastrutture portuali, ferroviarie e stradali, o di politicaindustriale. Tanto da far sospettare che i savonesi, quando ancora oggi sembra-no rimuginare sul vulnus del 1528 o sugli atti d’imperio che nel Sei-Settecentola Serenissima Repubblica compiva nei loro confronti, in realtà siano mossi daeventi assai più vicini nel tempo.
24
Oltre a leggere – lo abbiamo visto nel primo capitolo – il medioevo savone-se come uno scontro infinito contro Genova e contro la sua volontà di prevari-cazione, la storiografia locale ha quasi sempre ritenuto che la conquista violen-ta, nel 1528, ad opera di Andrea Doria determinasse per Savona la finis liberta-tis, il tramonto irreversibile delle libere istituzioni comunali, la tragica perditadi un’indipendenza che durava dai tempi lontani in cui la città si era affrancatadal dominio dei suoi signori feudali, i marchesi Aleramici. A partire da quel-l’anno, essa sarebbe stata mantenuta in una condizione che qualcuno non haesitato a definire «semicoloniale»1. Il 1528 segnerebbe dunque una cesura nettatra «i secoli della libera repubblica marinara» e quelli del totale vassallaggio neiconfronti di Genova2.
Queste affermazioni sono entrambe false, in modo per così dire speculare:perché da una lato una libera e indipendente Respublica Saonensis non era maiesistita, e d’altro lato, come vedremo in uno dei prossimi capitoli, tra il 1528 eil 1797 non si realizzò affatto un «dominio diretto» di Genova con conseguen-te perdita di ogni «libertà», privilegio o diritto particolare da parte di Savona.Per il periodo medievale, sarebbe bene ricordare anzitutto che concetti comeindipendenza e sovranità hanno scarso significato quando si tratta di comuni, inparticolare quelli di minore entità: il comune, più che un istituto di diritto pub-blico, era un gruppo di potere, «un partito organizzato», una fazione dotatadella capacità militare di «occupare la città» e distruggere o contenere le fazioniavverse. Queste ultime, dal canto loro, si appoggiavano spesso a città rivali, e sevenivano costrette all’esilio non esitavano ad allearsi con i nemici esterni e aprendere le armi contro la loro stessa patria3. In secondo luogo i rapporti tracomuni non somigliavano certo a quelli tra gli odierni Stati sovrani, erano piut-tosto pattuizioni di carattere privatistico, in cui era normale che la parte piùdebole finisse per subordinarsi a quella più forte, mettendosi in qualche misu-ra al suo servizio e sotto la sua protezione. Prevalentemente attraverso patti diquesto tipo («convenzioni» o «capitolazioni», come allora si diceva) si sonovenute formando le strutture territoriali più ampie, alcune sino alla dimensio-ne regionale, nell’Italia centrosettentrionale. La storia politica in quest’area èsoprattutto una storia di accordi e di contrattazioni: «per molte città l’esigenzadi una robusta rete di alleanze cresce al punto di trasformarsi nella accettazionedi un vincolo stabile di dipendenza». Qui non si realizza – a differenza della
25
1 Si veda ad esempio G. B. N. BESIO, Savona. Il centro storico, Genova, Siag-Valenti, 1980, p. 30.2 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., p. 6.3 G. CHITTOLINI, La formazione dello Stato regionale cit., pp. 6-9; e, per il caso savonese, C. RUSSO,
L’arbitrato di Giulio II cit., pp. 6-8..
Capitolo 2
“Gloriosa libertà” e “rivalità secolare”?
Svizzera – un sistema federativo, bensì la prevalenza di pochi comuni su altri,ma sempre nel quadro di una «progressiva articolazione di particolarismi»: unassetto scarsamente uniforme, basato sul riconoscimento di autonomie e privi-legi locali, molto labile e precario ai nostri occhi, eppure capace di durare persecoli4.
Genova offre un esempio particolarmente chiaro di queste costruzioni realiz-zate pezzo per pezzo e caso per caso. Nel XII secolo ha avviato un processo diespansione territoriale che nel 1162 ha ottenuto un importante riconoscimen-to formale: una costituzione imperiale di FedericoBarbarossa – ribadita daEnrico VI nel 1191 e da Federico II nel 1220 – che in forma di concessione feu-dale la dichiara signora di entrambe le Riviere. Da allora ha accelerato l’azionedi egemonia territoriale sulla Liguria, apparentemente conclusa verso la fine delXIII secolo; ma si tratta in realtà di un mosaico molto fragile, costituito da ele-menti disparati (comuni con gradi diversi di autonomia, signorie ecclesiastiche,feudi, castelli), messo insieme «con l’uso della guerra e della diplomazia», e for-malizzato «con strumenti giuridici scelti volta a volta». Al suo interno ci sonocomunità come Noli che, in cambio di un’indiscussa fedeltà, mantengono unaquasi totale autonomia e uno status di potenza alleata; città più importanti eriottose che Genova non priva di alcune prerogative di potere, ma le costringea sottoscrivere patti onerosi e a scegliere il loro Podestà fra i cittadini genovesi;borghi di minore entità, specie nella Riviera di Levante, sottomessi in misuraassai più ampia5. Le prime due categorie rappresentano le cosiddette «terre con-venzionate», la terza le «terre proprie», in cui è il diritto genovese a valere in totoo in gran parte.
Savona, al pari di Albenga e Ventimiglia, appartiene al secondo gruppo e findal 1153 – cioè prima ancora di ottenere formalmente dai propri marchesiun’autonomia comunale che peraltro verrà conquistata proprio all’ombra dellapotenza genovese – ha siglato con Genova un trattato che ne limita l’autono-mia: è tenuta a fornire aiuto militare per mare e per terra, a pagare le collectae,e le sue navi non possono oltrepassare la Sardegna e Barcellona se non fannoscalo a Genova all’andata e al ritorno. L’asimmetria dei diritti e dei poteri è evi-dente, e non lo si può ritenere un patto stipulato liberamente: uno storicomolto campanilista non esita a definirlo «atto di sottomissione senza alcunacontropartita» e pieno di «condizioni odiose», ma con ciò riconosce che, di fattoe di diritto, già da questo momento l’eventuale indipendenza di Savona non èche parziale6.
La «convenzione» del 1153 viene rinnovata nel 1181 e poi nel 1202 «conimpegno speciale di far guerra viva contro chi che sia ad ogni ordine del gover-no di Genova, e con promessa di farne giurare l’osservanza ogni anno dal loro
26
4 G. CHITTOLINI, Introduzione a La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimentoa cura di ID., Bologna, Il Mulino, 1979, p. 28.
5 V. PIERGIOVANNI, I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio, ASLSP, vol. XCVIII, 1984, fasc. II, pp. 427-449; R. PAVONI, Liguria medievale. Da provincia romana a Stato regionale, Genova, Ecig, 1992, pp. 251-256.
6 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., pp. 42-44
Capitolo 2
Podestà e Consoli, et ogni quinquennio da ogni persona del popolo da 15 sinoin 70 anni»7. Ma i rapporti fra le due città non sempre sono pacifici. Savonacerca a più riprese di ottenere diplomi imperiali, come quelli di Ottone IV nel1209 e di Federico II nel 1222, che le garantiscano franchigie e maggiori auto-nomie nei confronti di Genova; o passa a forme di aperta ribellione, come quel-la del 1226-27, conclusa con una severa punizione da parte del Podestà geno-vese il quale ordina che vengano atterrate le mura, «distrutto il molo, ingom-brato il porto e nel sito più elevato fabbricata una fortezza ad infrenare l’auda-cia dei popoli soggetti»8: un’anticipazione molto precisa di quanto accadrà altrevolte in seguito, sino all’epilogo del 1528. Tra un atto di insubordinazione e l’al-tro, tuttavia, nuove pattuizioni intervengono a fissare sempre meglio i rapportidi sudditanza. Tra le più importanti c’è la cosiddetta convenzione di Varazze del19 febbraio 1251, ratificata dal papa genovese Innocenzo IV (SinibaldoFieschi), in cui – secondo un autore molto attento ai temi giuridici – si stabili-sce tra Genova e Savona «un rapporto di protettorato», restando alla prima delledue città il pieno controllo dello ius belli e della legislazione9. In base a tale con-venzione i savonesi si impegnano a combattere per mare et per terram agli ordi-ni di Genova, a contribuire all’armamento delle sue flotte, ad accettare le pacida essa concluse, a consegnare fortezze e castelli (ciò che equivale a rinunciare auna politica estera autonoma e ad accettare la subalternità militare), a rispetta-re gli obblighi e i divieti da essa imposti, a non dare asilo a persone o fazioni daessa banditi, a transitare con le proprie navi per il porto genovese e pagarvi idiritti sulle merci importate, a scegliersi un Podestà che sia cittadino genovese.In cambio Genova riconosce a Savona piena giurisdizione sul proprio territorioe il diritto di riscuotervi ogni genere di imposte tranne la gabella del sale, mono-polio genovese su entrambe le Riviere; inoltre si impegna a considerare gliuomini di Savona come cittadini genovesi e a trattarli dovunque come tali,facendoli partecipi dei medesimi diritti e privilegi10.
Le clausole del 1251 restano sostanzialmente valide per due secoli, talvoltacon nuove concessioni, talaltra con qualche ulteriore restrizione (nel 1347, adesempio, «l’obbligo di dare totalmente la città di Savona in forza dellaRepubblica per reggerla e governarla, […] in essecuzione del che costumò ilPodestà di prestare verso la Repubblica il giuramento di ubbidienza»11), il tuttoinframmezzato ancora da ribellioni come quella del 1440, quando i savonesi –dopo aver «essercitato il navigare vietato loro» ed essersi rifiutati «di pagare idritti» – «havean radunato truppe di soldati con alquante galere» e «posto pre-sidio ne’ luoghi forti», e il governo genovese aveva ordinato «che si facessero
27
7 ASG, Archivio segreto, 361, n. 57.8 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., pp. 66-67.9 C. RUSSO, L’arbitrato di Giulio II cit., pp. 13-14.10 I Registri della Catena del Comune di Savona, Registro II, parte I, AMSSSP, n. s., vol. XXII, 1987, pp. 72-
86; V. PIERGIOVANNI, I rapporti giuridici cit., p. 436; R. MUSSO, Ceto dirigente cit., pp. 14-15: a tutto que-st’ultimo saggio, documentato e intelligente, si rimanda per un’analisi puntuale dei rapporti giuridici fra le duecittà nel basso medioevo e nel Rinascimento.
11 ASG, Archivio segreto, 361, n. 57.
“Gloriosa libertà” e “rivalità secolare”?
condurre a Genova centocinquanta di quei cittadini che poteano essere piùsospetti, che a tutti gli altri si togliessero le armi, che si distruggesse il mole chefa porto, si atterrassero le muraglie della città e si privassero quegli abitanti delbeneficio di qualunque convenzione»12. Allora la repressione fu probabilmenteancora più dura di quanto poi sarebbe avvenuto nel 1528: saccheggi, distruzio-ni sistematiche delle opere portuali e degli apparati di difesa (questi ultimi sosti-tuiti da punti forti presidiati dai genovesi), la bocca del porto ostruita conl’affondamento di navi cariche di pietre, ma soprattutto la riduzione della cittàa «mera suddita», con l’abrogazione degli statuti municipali e l’applicazione diquelli di Genova, e la soppressione dell’ufficio del Podestà, sostituito da unGovernatore direttamente nominato dal Doge13.
Questa altalena di sottomissioni, velleità indipendentiste e rivolte ritma a talpunto le vicende dei secoli XII-XV che è stato poi ovvio, per una storiografiamolto “municipalista” e interessata prevalentemente ai fatti politico-diplomati-ci, ridurre ad essa gran parte della storia cittadina – come si è detto nel capito-lo precedente – e quel che è peggio travisarne spesso il significato. A fineSeicento il cronista savonese Agostino Maria de’ Monti, certo per piaggeria neiconfronti dei padroni di allora, ricorda con toni idilliaci la convenzione del1153: «bisognosa […] di potenza vicina che la proteggesse in ogni turbationeche potesse patire d’insulto nemico», a Savona «riusciva decoroso vivere sotto ilpatrocinio di una Repubblica così agguerrita e potente nelle sue armate, con cuisi rendeva formidabile a tutto il Mediterraneo». Si era trattato, per il Monti, diun evento felice grazie al quale «questa mia patria […] fu la prima città dellaLiguria che volontaria si sottopose al governo di Genova», «la prima gioia ches’incastrò nella sua corona», e «dié sì bell’esempio ad Albenga e Noli et altre cittàd’unirsi a questo Serenissimo Stato»14. Ma prima di lui un altro importante cro-nista, il Verzellino, assai prudente ma meno incline all’ossequio verso i gover-nanti dell’epoca, ha scritto che con la convenzione del 1153 «i savonesi s’aggre-garono alla protezione dei signori genovesi, e furon da essi fatti cittadini diGenova sotto de’quali, così nelle parti di qua dal mare come nelle parti al di là,conseguirono onori, comodi ed utilità»15. Ha fatto un po’ di confusione con ledate (in realtà, e lui stesso lo riconosce più innanzi, è nel 1251 che i savonesiottengono per la prima volta una sorta di cittadinanza genovese16), ma ha cen-trato il nocciolo della questione. Perché la pretesa eterna rivalità, l’inimiciziasecolare fra le due città, la prevaricazione continua della più forte sulla piùdebole, sono favole che solo una cultura storiografica intrisa di campanilismoha potuto creare, divulgare, amplificare.
28
12 Ibidem.13R. MUSSO, “Viva el Duca et lo Sancto Padre” cit., p. 64.14 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 45 e pp. iniziali non numerate.15 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. I, p. 186.16 Ivi, p. 209.
Capitolo 2
La cità di Saona […] – ricordava intorno al 1570 il cronista Agostino Abate – èsituata apreso a la inclita e nobile cità de Genoa a 30 migia, e per esere così apresoa una tanto grande e famoza e rica cità dicemo che più volte questa cità de Saonaesere stata in controversia con la inclita cità de Genoa per causa che la cità de Saonaavìa porto […]. E per avere porto le nave con le loro mercancìe intravano in Saonae danificavano molto li comerchi e gabele de […] Genoa, tal menti che […] sem-per antiqua mente la cità de Genoa ha avuto in odio questo fare porto in Saona eper questa causa più volte la cità de Saona è stata danificata con mano armata da lisignori genoezi17.
Abate scrive avendo ancora negli occhi – evento traumatico della sua gio-ventù – le demolizioni portuali del 1528 e le decisioni genovesi degli anniimmediatamente successivi, che tendevano a impedire la resurrezione delloscalo savonese. Perciò è indotto a generalizzare, ed estende a un periodo pluri-secolare un atteggiamento che viceversa è relativamente episodico.Intendiamoci: è vero che quando Genova intraprende un abbozzo di unifica-zione politica della Liguria tra i suoi obiettivi c’è anche «l’instaurazione di unasupremazia economica attraverso la subordinazione delle marinerie locali,soprattutto nel Ponente, ove i porti di Savona, Noli, Albenga e Ventimigliapotevano divenire pericolosi concorrenti»18. Ma questa spiegazione non va for-zata oltre un certo limite: se Genova ha sottomesso facilmente e rapidamente laRiviera di Levante, mentre quella di Ponente – dove fin da tempi coevi all’ascesadel comune genovese si sono sviluppate città più forti e riottose – ha offertomaggiore resistenza, ciò è dipeso anche dal fatto che la Riviera di Levante è benpiù essenziale a Genova per il controllo del Tirreno nei confronti di Pisa e perl’accesso alle colonie del Levante, mentre il Ponente ha una minore importan-za strategica, tanto da passare in secondo piano anche rispetto all’Oltregiogo, ilcui possesso è fondamentale per garantire la facilità dei traffici con il retroterralombardo e monferrino19.
Sulla sempiterna rivalità portuale e commerciale hanno naturalmente insisti-to numerosi storici locali, da Boselli (secondo cui «il sistema della dominazionegenovese sopra tutte le terre liguri volle spenta [in esse] ogni scintilla di libertà,d’energia, d’operosità»20) a Cerisola, che sui contrasti relativi al porto ha cen-trato buona parte della sua interpretazione della storia savonese21. Ma la realtàè diversa: come ha spiegato Gabriella Airaldi, «tra tutte le forze liguri, certa-
29
17 A. ABATE, Cronache savonesi cit., pp. 268-269; anche nel Seicento, d’altronde, il Monti scriverà a propo-sito di Savona che il porto «fu origine del suo ingrandimento e rovina», per aver determinato lo sviluppo dellacittà e quindi attirato l’invidia e le ire dei genovesi (A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 53).
18 R. PAVONI, Liguria medievale cit., p. 251.19 G. AIRALDI, Genova e la Liguria nel medioevo, in A. M. NADA PATRONE-G. AIRALDI, Comuni e signorie
nell’Italia settentrionale: il Piemonte e la Liguria, Torino, Utet, 1986 (Storia d’Italia diretta da G. GALASSO, vol.V), pp. 363-547, in particolare pp. 436-438.
20 P. BOSELLI, Discorso per l’inaugurazione cit., p. 23.21 Si veda, oltre alla più volte citata Storia di Savona, N. CERISOLA, Storia del porto di Savona, Genova,
Editrice Liguria, 1968, passim; e anche F. NOBERASCO, Il porto di Savona nella storia, AMSSSP, vol. III, 1920,pp. 83-112.
“Gloriosa libertà” e “rivalità secolare”?
mente Savona rappresenta, per tutto l’arco dell’età medievale, il gran baluardooppositivo a Genova», e tuttavia «la sua storia […] può e deve esser letta nonsempre in contrasto con quella genovese, come dimostra il fenomeno dell’e-spansione commerciale svolta spesso in raccordo con la città principale»22.Persino due vestali del “patriottismo municipale” come Filippo Noberasco eItalo Scovazzi sono costretti a riconoscere che Savona sfruttava la propria sud-ditanza a Genova «per ottenere agevolazioni commerciali, […] per averne unaprotezione sicura, larga, feconda»23. Già sul finire dell’XI secolo alcuni savone-si partecipano con profitto, al fianco dei genovesi, alla prima Crociata; e l’e-spansione marittima dei centri costieri della Liguria, specialmente Savona eNoli, viene inizialmente stimolata e favorita da Genova, tanto che il legame conquest’ultima è decisivo per garantire l’inserimento dei savonesi nel grande com-mercio mediterraneo, in direzione del Levante e della Sicilia. Proprio in questaprospettiva si comprende appieno il significato delle convenzioni del 1153 che– come si è visto – costringono le navi savonesi dirette oltre la Sardegna eBarcellona a fare scalo a Genova per sdoganarvi il carico: questa imposizione,dato il modesto grado di sviluppo raggiunto dal commercio della città minore,non solo non è onerosa, ma consente ai mercanti savonesi di trovare più facil-mente sulla piazza genovese soci e finanziatori per i loro traffici oltremare24.
Gli orizzonti commerciali del Comune savonese, insomma, sono «ristretti ocomunque organizzati nella sfera del fiscalismo genovese, ma anche spalancatidal diritto di esibire una cittadinanza che equivale ad un lasciapassare su tutti imari conosciuti». Nelle piazze del Mediterraneo in cui sono presenti, i savone-si si proclamano cives Ianue o tutt’al più «genovesi cittadini di Savona», e in que-sta veste «dalla prima crociata in poi, sino alla conquista di Chio, essi parteci-pano ai benefici del trionfante espansionismo genovese»25. «A chiunque scorrauno qualsiasi degli indici delle edizioni di atti notarili rogati a Chio o a Caffa[…] risulta evidente come Savona si sia sempre mossa in sostanziale sintoniacon Genova, tanto che si può ben dire che fra le due città vi sia stata una verae propria “simbiosi” economica»26. Oltretutto, finché quell’economia si man-tiene florida, finché il bottino da spartire è ricco, le clausole che determinano lasottomissione dei savonesi restano valide più sul piano teorico e formale che suquello pratico ed effettivo. Gli obblighi militari sono spesso simbolici, le guar-nigioni genovesi presenti a Savona sono esigue, il carico fiscale è irrisorio, lanorma che prescrive di eleggere come Podestà un cittadino di Genova lascia tut-tavia alla città minore la libera scelta della persona, cosicché il gioco delle allean-ze di fazione o della contiguità degli interessi mercantili consente di nominarepersonaggi graditi all’establishment locale.
30
22 G. AIRALDI, Genova e la Liguria cit., p. 444.23 F. NOBERASCO-I. SCOVAZZI, Storia di Savona cit., vol. II, pp. 236-237.24 R. PAVONI, Savona alle origini del comune, AMSSSP, vol. XXX, 1994, pp. 93-136 (in particolare pp. 108-
110).25 A. NICOLINI, Viaggi e commerci cit., p. 98.26 R. MUSSO, “Viva el Duca et lo Sancto Padre” cit., p. 61.
Capitolo 2
Le cose in parte cambiano a partire dalla metà del Trecento, quando si ridu-cono le opportunità economiche dei genovesi; e ancor più nella prima metà delQuattrocento, allorché il commercio e la navigazione savonesi conoscono ungrande sviluppo, specie in direzione dell’Atlantico. Il porto di Savona diventaallora «scalo fisso sulla rotta fra Genova e le Fiandre, e a partire almeno dal 1426le stesse navi savonesi la percorrono in maniera regolare» trasportando un’im-portante materia prima, il guado del Monferrato usato come tintura per i tes-suti. Ma non meno importanti sono i rapporti commerciali, alimentati dallemanifatture cittadine, col Regno di Aragona, con Napoli e la Sicilia, con Chioe il Levante in genere. Questo apogeo dell’economia savonese ne aumenta lecapacità concorrenziali e induce Genova a pretendere un rispetto molto piùrigoroso degli obblighi fiscali e delle restrizioni commerciali, e infine ad attua-re nel 1440 quella dura rappresaglia nei confronti di Savona alla quale già abbia-mo fatto cenno. Ma a questo punto ciò che conta, al di là dei rapporti e dei con-trasti fra le due città liguri, è l’emergere sulla scena internazionale di nuovi pro-tagonisti sempre più agguerriti: catalani, baschi, galiziani, francesi, veneziani,fiorentini. Va poi sottolineato il fatto che, anche nel momento di maggiore rigo-glio e di maggiore estensione marittima, il commercio savonese non è riuscitoad ancorarsi a un vasto retroterra: i traffici con il Milanese, l’Alessandrino e ilMonferrato restano in mano ai genovesi; gli stessi rapporti politici che a parti-re dal 1353, con la breve signoria di Giovanni Visconti, sino al 1488-1499 conquella di Ludovico il Moro si instaurano fra Milano e Genova rispecchianol’importanza di queste direttrici mercantili. La vicinanza tra i due empori ligu-ri è tale che Savona, pur avendo sperato a varie riprese di ritagliarsi un ruolo pri-mario, è stata costretta ad accettarne uno subalterno. Nell’Adriatico la piccolaRagusa, abbastanza distante da Venezia e abbastanza prossima all’ImperoOttomano, potrà giocare con successo una partita ben più ambiziosa.
Nella seconda metà del XV secolo, «Savona ripiega progressivamente la suapolitica marittima verso il piccolo cabotaggio tirrenico, trovandosi ormai esclu-sa dalle principali rotte navali tra oriente e occidente»27. Ciò non le impediscedi vivere ancora una stagione florida, fondata sull’incremento di quelle mani-fatture, in particolare la concia delle pelli e la tessitura della lana, che assorbo-no parte della forza lavoro precedentemente impiegata nel commercio maritti-mo, e sempre basata sugli stretti legami economici con Genova. «Si tratta […]quasi di un’osmosi – è stato scritto sulla base di un attento spoglio di atti nota-rili – fra le due classi mercantili che, indifferentemente, prendono parte a spe-dizioni nell’una e nell’altra città: capitalisti genovesi che impiegano i loro fondisu navi savonesi, come savonesi che affidano loro mercanzie ad imbarcazioniarmate in Genova»28. Questi legami spiegano perché Savona da un lato cerchiperiodicamente di affrancarsi in modo subdolo o violento dalla sudditanza neiconfronti di Genova («in sostanza i savonesi pretendevano di poter godere tutti
31
27 A. NICOLINI, Viaggi e commerci cit., pp. 105-109.28 C. VARALDO, Savona nel secondo Quattrocento cit., pp. 12-17, 43-68 e passim.
“Gloriosa libertà” e “rivalità secolare”?
i vantaggi della cittadinanza genovese – navigare con la bandiera di San Giorgio;protezione diplomatica e, se era necessario, militare; agevolazioni commerciali– senza rinunciare in alcun modo alla propria libertà»29), ma d’altro lato nongiunga mai a forme di definitiva ribellione, neppure quando la situazione inter-nazionale – con le contrapposte pretese di signorie forestiere sulla Superba,quelle del duca di Milano o del re di Francia – consentirebbe uno sganciamen-to netto dalla potente vicina. La città, per così dire, gioca di sponda con i nemi-ci o con i temporanei signori di Genova, per ottenere da quest’ultima condi-zioni più favorevoli e maggiori margini di autonomia30; ma poi la segue nellerivolte contro quegli stessi signori, ben consapevole che i vantaggi del dominiogenovese sono superiori agli svantaggi, che i savonesi non possono «stare senzaGenoa per li traffichi et comertii hanno insieme», che esiste «uno medesimosangue cum zenoesi»31.
Questa comunanza di interessi, tuttavia, non è un dato che riguardi in modoindifferenziato tutta la popolazione di Savona e di Genova. Per quanto possaapparire lapalissiano, occorre ricordare – in tempi nei quali Marx è diventato unautore obsoleto e proscritto – che entro uno stesso corpo politico, entro unastessa comunità coesistono, se non delle classi sociali, quantomeno dei gruppiportatori di interessi diversi e contrapposti. Ma senza scomodare Marx e la lottadi classe, è difficile dimenticare che le città italiane del basso medioevo e delRinascimento sono società estremamente turbolente, suddivise in “parti”,“colori”, fazioni e clan in continuo conflitto fra loro e alla continua ricerca dialleanze con fazioni e potentati esterni: una realtà che – absit iniuria – somigliapiù alla lotta senza quartiere fra cosche mafiose che alla ben regolata contesa(diplomatica, ma anche bellica) fra le varie potenze cui ci abituerà l’Europa apartire dalla pace di Westfalia, o meglio ancora dal XVIII secolo.
Leggere lo scontro fra città nel Tre-Quattrocento come un conflitto fra corpipolitici compatti e coesi è un imperdonabile peccato di anacronismo proprioperché – se n’è già fatto cenno – i comuni, le respublicae e le signorie dell’epo-ca sono aggregati precari di interessi particolari e hanno ben poco a che fare congli Stati contemporanei, nei quali vale il principio che gli inglesi esprimono coldetto right or wrong, my country: il patriottismo che nei momenti cruciali faaggio su ogni divisione di classe e di partito, spingendo tutti i cittadini a bat-tersi uniti contro un nemico comune. Più di sessant’anni fa qualcuno ha acuta-mente rilevato il carattere popolare del conflitto fra Savona e Genova, il fattoche esso metteva in causa interessi diffusi, non coincidenti con quelli dellaristretta élite di potere. «Le contese con Genova furono richieste dal popolosavonese, piuttosto che preparate dai magistrati del Comune»; costoro, anzi,«furono spesso freno moderatore alla spinta della massa», e se non si tenesseconto di questo fatto, la storia politica della città «sarebbe incomprensibile nella
32
29 C. RUSSO, L’arbitrato di Giulio II cit., p. 85.30 M. RICCHEBONO-C. VARALDO, Savona cit., p. 77.31 R. MUSSO, “Viva el Duca et lo Sancto Padre” cit., pp. 62-63.
Capitolo 2
sua illogicità». I magistrati e i personaggi più influenti furono costretti dallaspinta popolare a contestare e rinnegare quelle convenzioni che viceversa sareb-be stato loro interesse «proclamare toto corde», perché in esse trovavano un tor-naconto economico e una garanzia di stabilità politica32. D’altronde, a proposi-to del fatidico 1528, già il vecchio Torteroli aveva osservato che i più inclini allasottomissione a Genova erano stati i patrizi, e i più decisi a resistere i popola-ri33. Non siamo in grado di giudicare fino a che punto l’interpretazione sia cor-retta, ma certo essa segnala un problema, indica che non si può non tenereconto, nell’analizzare i conflitti tra le due città, delle articolazioni politico-eco-nomiche in esse presenti.
Genova è forse la città italiana in cui, fra basso medioevo e primoCinquecento, la conflittualità politica e la violenza faziosa hanno raggiunto ilpiù alto livello; e Savona, così strettamente legata ai destini della Superba, hacontinuamente risentito di questa situazione. In parte se ne è avvantaggiata,perché talora le lotte intestine hanno talmente indebolito o paralizzato la suapotente vicina da consentirle margini di manovra molto ampi, ma in parte neè rimasta coinvolta, cosicché vi si sono sempre ripercossi i conflitti in corso frale grandi famiglie che a Genova si contendono il potere. Ciò è particolarmenteevidente nei quasi due secoli – tra la metà del Trecento e i primi tre decenni delCinquecento – in cui Genova è sottoposta alternativamente alle signorie fore-stiere dei re di Francia e dei duchi di Milano, ed è teatro dello scontro fra i grup-pi facenti capo ai due grandi clan “popolari” degli Adorno e dei Fregoso. Se èproprio in questa lunga fase che la rivalità fra le due città liguri appare più aspra,con la dura spedizione punitiva del 1440 e poi con gli interventi ravvicinati einfine “risolutivi” del terzo decennio del Cinquecento, sarebbe un grave erroredi prospettiva considerare tale rivalità come una partita con due soli conten-denti compattamente schierati su fronti contrapposti. I protagonisti viceversasono molti, in Italia e fuori d’Italia, il campo di battaglia è vasto, le forze ingioco combattono su numerosi fronti e le alleanze mutano frequentemente.
Di volta in volta i Visconti, gli Sforza e i sovrani francesi si inseriscono inquel contrasto e se ne servono per rafforzare la loro presenza in Liguria34. Cosìi duchi milanesi non esitano a concedere a Savona – nel 1421 e nel 1464 – lostatus di «terra separata» direttamente sottoposta alla loro sovranità e sganciatada ogni sudditanza rispetto a Genova, a confermarle i suoi statuti e i suoi pri-vilegi, a lasciarle spazi di autonomia superiori a quelli garantiti dalle conven-zioni con Genova stessa. Gian Galeazzo Sforza arriva a fare di Savona la piùimportante piazzaforte milanese nella Riviera di Ponente e a rintuzzare le pre-tese fiscali del Banco di San Giorgio. Il ceto dirigente savonese e soprattutto i
33
32 C. RUSSO, L’arbitrato di Giulio II cit., pp. 120-121.33 T. TORTEROLI, Storia del Comune di Savona cit., p. 370; cfr. anche C. BITOSSI, Il governo genovese e Savona
nell’età di Chiabrera. Appunti di ricerca, in La scelta della misura. Gabriello Chiabrera: l’altro fuoco del barocco ita-liano a cura di F. BIANCHI e P. RUSSO, Genova, Costa & Nolan, 1993, pp. 75-103 (in particolare p. 80).
34 Su questi temi, che qui vengono trattati solo in forma riassuntiva, si rinvia alle ottime analisi di RiccardoMusso (Ceto dirigente cit., pp. 16- 26; “Viva el Duca et lo Sancto Padre” cit., pp. 66-153), delle quali ci siamoampiamente serviti.
“Gloriosa libertà” e “rivalità secolare”?
nobiles gliene sono grati, ma restano legati a quelle consorterie genovesi(Adorno e Fregoso, Doria e Spinola) con le quali hanno in comune interessieconomici e politici. Dal canto loro queste fazioni – e in particolare le primedue, che si contendono il dogato – considerano Savona un’importante posta ingioco.
In un generale quadro di spartizione e quasi di privatizzazione del territorioligure da parte di questi gruppi in conflitto, Savona rappresenta per moltidecenni «una vera e propria signoria semi-autonoma, controllata direttamentedal Doge o da un suo stretto parente», secondo una prassi già inaugurata nel1340 da Simon Boccanegra: dal 1416, a parte gli intermezzi delle dominazionimilanesi o francesi, il governo di Savona «fu quasi sempre tenuto da Adorni eFregosi, con la netta prevalenza per questi ultimi. Savona divenne infatti ogget-to di scambio tra i vari capi delle due fazioni al potere, quasi un premio perricompensare quelli tra loro che accettavano di sostenere il Doge in carica»35.Dal 1447, col dogato di Giano Fregoso, Savona è più che mai controllata dallafamiglia al potere (prima sotto Tommaso, poi sotto Gian Galeazzo Fregoso)anziché dal governo di Genova: nel 1448 l’umanista Giacomo Bracelli, nellaDescriptio da lui inviata al geografo Flavio Biondo e da costui inserita nel volu-me Italia illustrata del 1453, scrive che la città, «nobile e famosa per lo concor-so di molti popoli da li quali è frequentata», è posseduta da «Tomaso Fregososingolare huomo e letterato […] che con somma lode è due volte stato duca diGenova»36. E se non si trasforma in un potentato indipendente è perché solouna parte della nobiltà si mostra fautrice di questi governatori-signori, mentremercanti e artigiani restano fedeli al governo genovese. Nel 1488, quandoGenova torna sotto il duca milanese Ludovico il Moro che caccia i Fregoso, saràpoi un Adorno a insignorirsi di Savona. E dopo la dominazione francese del1499-1512 toccherà nuovamente ai Fregoso, nel 1512-1522, a parte un breveintermezzo adornesco.
A questa dialettica giocata tra le fazioni genovesi e le signorie forestiere cor-risponde una non meno complessa conflittualità interna al Comune di Savona.Da tempo immemorabile vi esiste una generica partizione – e una rivalità – franobiles, facenti capo alla piazza della Maddalena, e populares che hanno il lorocentro nella piazza del Brandale. Lo scontro tra i due gruppi ha un suo momen-to topico nel primo Trecento, ma si ricompone con la redazione degli Statutaantiquissima civitatis Saone (1345), una normativa di compromesso grazie allaquale la situazione interna si fa via via meno critica, mentre le differenze fra idue schieramenti tendono a stemperarsi ma anche a complicarsi. La polaritànobili-popolari, e la correlativa contrapposizione tra le “parti” guelfa e ghibelli-na, lasciano il passo a una suddivisione più articolata in cui compaiono nobili,mercatores e notarii non nobiles, artigiani, tutti «a loro volta ripartiti fra le “com-
34
35 R. MUSSO, Ceto dirigente cit., pp. 18-23.36 La conoscenza del territorio ligure fra medio evo ed età moderna a cura di M. QUAINI, Genova, Sagep, 1981,
p. 66.
Capitolo 2
pagne” di piazza del Brandale e piazza della Maddalena»37. Gli Statuta politica del 1404 (che formalizzano la suddivisione dell’oligarchia
comunale nei tre «ordini» dei nobili, mercanti e artigiani, destinati a chiudersie a cristallizzarsi a cavallo fra Quattro e Cinquecento), e poi le tensioni di ini-zio Quattrocento con la conseguente pacificazione del 1415, renderanno evi-dente che non si tratta più di uno scontro tra nobili e popolari arroccati cia-scuno nella sua “piazza”, ma che ogni piazza ha una propria articolazione inter-na, appunto tra nobiles, mercatores e artifices.
Le antiche, classiche divisioni politiche paiono ormai quasi del tutto superate.La formazione di nuove, rapide fortune e i nuovi legami che vengono ad istituirsifra i casati più prestigiosi e ricchi, indipendentemente dal loro originario colorepolitico, favoriscono la creazione di quella composita ed eterogenea aristocraziamercantile che si pone al vertice della scala sociale. È questo il vero cardine delladirigenza cittadina, per il quale gli scontri dialettici di tipo politico nascono daragioni di scelte economiche e commerciali. Schierarsi a favore della dominazionedel duca di Milano o del re di Francia […] vuole dire privilegiare più una politicadi penetrazione commerciale che un’altra, con tutti i risvolti economici che taliscelte comportano sugli interessi e la prosperità di una famiglia38.
E le famiglie più dinamiche – i Becalla, i Bresciano, i Catullo, i Cerrato, iFerrero, i Gavotti, i Grasso, i Pavese, i Pozzobonello, i Sansone, i Viale – sonoquelle particolarmente interessate ai circuiti “occidentali”, ai nuovi mercati incui si intensifica l’iniziativa genovese man mano che le opportunità nelle colo-nie del Levante si vanno riducendo: Napoli, la Provenza, ma ancor più laSpagna, le Fiandre, l’Inghilterra. Ovvio, dunque, che tutti costoro si disponga-no in schieramenti facenti capo alle fazioni genovesi degli Spinola o dei Doria,degli Adorno o dei Fregoso.
In questo quasi inestricabile groviglio di “partiti” e conflitti, due aspetti cipare che vadano isolati e sottolineati: in primo luogo, lo ribadiamo, si deve con-statare che non esiste un fronte netto al di qua e al di là del quale combatta cia-scuno dei due Comuni; in secondo luogo, però, bisogna anche riconoscere chela presenza accanto a Genova di un’altra città popolosa, ricca, intraprendente,dinamica, dotata di buon porto e di ragguardevoli fortificazioni costituisce unfattore di instabilità permanente. Ancora una volta è stato Paolo Boselli a porreil problema in termini corretti, scrivendo che Savona rappresentava per Genovaun elemento di debolezza «perché asilo de’ suoi fuorusciti e focolare delle lorocospirazioni», oltreché «sede prediletta delle estere influenze a Genova ostili, estanza acconcia ai nemici che le movessero guerra»39. Se Genova nella pubblici-stica politica rinascimentale verrà spesso definita, con trasparente gioco di paro-
35
37 C. VARALDO, Appunti sui ceti dirigenti cit., pp. 131-141; e, per un’accurata disamina della dinamica trafazioni a Savona, R. MUSSO, Ceto dirigente cit., pp. 28-39.
38 C. VARALDO, Appunti sui ceti dirigenti cit., p. 136.39 P. BOSELLI, Discorso per l’inaugurazione cit., p. 23.
“Gloriosa libertà” e “rivalità secolare”?
le, Ianua Italie, Savona tra la fine del Trecento e l’inizio del Cinquecento svol-ge spesso la funzione di “porta della Liguria”, rappresenta cioè «il costante rife-rimento strategico per ogni operazione, diplomatica o militare, rivolta all’as-soggettamento di Genova»40. Giocano in tal senso, oltre alla posizione geogra-fica e alla consistenza economica della città che ne fanno un’ideale testa diponte, il “revanscismo” sempre presente in una parte del ceto dirigente savone-se, il quale aspira a maggiori libertates municipali, a uno sviluppo commercialeautonomo, a un controllo sul territorio circostante che non sia contrastato dallepretese egemoniche di Genova su comunità anche vicinissime come Vado oQuiliano, addirittura alla conquista di un ampio retroterra nel Monferrato e nelPiemonte che dia ben altro impulso ai commerci marittimi e alla produzionemanifatturiera.
Un documento ufficiale indirizzato nel 1465 dal Comune genovese aFrancesco Sforza arriva a ipotizzare che Savona possa un giorno trasformarsi inuna seconda Genova, altrettanto potente. È più che altro un argomento retori-co, ma indubbiamente a quel tempo la situazione dell’Italia – e in particolaredella Liguria – è assai fluida, la mappa politica della penisola è ancora in granparte da disegnare, ogni protagonista anche piccolo può giocare una forte postaai tavoli della diplomazia, della guerra, delle alleanze fra le potenze italiane edeuropee. La stessa dinamica faziosa che – come s’è visto – a Savona dà vita quasia delle signorie separate per gli Adorno o i Fregoso può essere gravida di sviluppiimprevedibili. Nel 1488 Ludovico il Moro, chiamato a far da arbitro tra lefazioni e a garantire a Genova un assetto stabile, sembra propendere per unadivisione della Liguria in due distinte aree d’influenza, cioè «dar Savona con laRiviera di Ponente agli Adorni» e lasciare Genova ai Fregoso41.
La proposta è assai più strumentale che realistica: benché in passato moltistorici locali abbiano celebrato le magnifiche sorti della Savona quattrocentesca,a quest’epoca Genova è – dal punto di vista economico, politico e militare –una realtà incomparabilmente superiore. Savona ha avuto forse la possibilità diritagliarsi per il futuro una più o meno duratura sopravvivenza autonoma al paridi Modena, Lucca o Ferrara, città peraltro molto più ricche di lei; ma non certola forza di competere su un piano di parità con Genova e meno che mai di sosti-tuirsi ad essa nel controllo della Liguria, così come nessuna città del Veneto(eppure ce n’erano di potenti, a cominciare da Padova o Verona) ha mai potu-to aspirare a un’egemonia regionale in alternativa a Venezia, né alcuna città dellaToscana, neppure la ricchissima e splendida Siena, ha potuto scalzare il prima-to di Firenze.
È vero tuttavia che, a partire dagli anni settanta del Quattrocento, la condi-zione di Savona subisce delle importanti modifiche grazie all’elezione, in rapi-da successione, dei due papi Della Rovere, Sisto IV (1471-1484) e Giulio II(1503-1513). Nel giro di pochi decenni dalla famiglia dei due pontefici e da
36
40 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., p. 52.41 A. GIUSTINIANI, Annali della Repubblica di Genova illustrati con note del Prof. cav. G. B. Spotorno, Genova,
Canepa, 1854, vol. II, p. 552.
Capitolo 2
molte casate ad essi collegate – siano esse di modesto livello o di antica nobiltà– escono una dozzina di cardinali e oltre venti vescovi, mentre molti personag-gi ricevono cospicui benefici ecclesiastici o cariche civili nello Stato dellaChiesa42; e per altri savonesi di quelle stesse parentele si aprono importantioccasioni di affari e di lauti guadagni nella Roma rinascimentale, crocevia diformidabili flussi finanziari e mercantili. Il ceto dirigente locale si trova improv-visamente sbalzato su una scena più vasta, la città si popola di artisti e letterati,il Comune si accorge di poter contare sull’appoggio del papato, tanto da chie-dere nel 1505 a Giulio II di essere liberato dalle convenzioni concluse conGenova e da ottenere successivamente dalla Sacra Rota una sentenza favorevo-le in tal senso43.
Il peso specifico di Savona, di conseguenza, aumenta; e cresce del pari la suapericolosità politica per Genova, specie dal momento in cui – sul finire del seco-lo XV – la calata di Carlo VIII e l’avvio delle “guerre d’Italia” complicano enor-memente il quadro internazionale e rendono tanto più necessario per i piccolipotentati della penisola darsi un assetto politico-territoriale più stabile. Comeabbiamo già avuto modo di dire, Savona in linea di massima ha rappresentatoper Genova più un partner economico che un temibile concorrente commer-ciale; di modo che, quando tensioni o aperte rotture si sono manifestate fra ledue città, esse hanno avuto soprattutto natura politica, e solo dal punto di vistapolitico la città minore – a causa degli interventi esterni cui si è fatto cenno –ha rappresentato un pericolo per la maggiore. Tale pericolo, pur avendo indot-to molte volte Genova a rappresaglie e interventi punitivi, non l’ha mai spintaa perseguire l’annientamento di Savona, di cui pure era materialmente capace,proprio perché la sussistenza della piazza mercantile savonese le tornava utile.Semmai si è limitata, con un’azione continua e di lungo periodo, a eroderne lasovranità sul territorio circostante. Fin dal XIII secolo ha cercato di impadro-nirsi di Quiliano e ha ottenuto per Noli dignità di città e sede vescovile; poi nelcorso del Trecento ha sottratto Albisola, Celle e Varazze alla giurisdizione savo-nese facendone una podesteria genovese; in tal modo ha rinserrato Savona «inun ristretto ambito territoriale fra Albisola, Quiliano, Segno e il capo diVado»44: ne ha fatto cioè una città pressoché priva di contado, e già questo soloelemento basterebbe a dimostrare un assunto dal quale siamo partiti in questocapitolo, cioè che la sua pretesa indipendenza è insussistente, perché nel pano-rama italiano del basso medioevo non c’è civitas davvero libera che non possie-da un proprio ampio comitatus.
Se solo all’aprirsi del Cinquecento, cioè proprio quando Genova sta ormaicompiendo la metamorfosi da potenza mercantile e marittima a grande piazza
37
42 C. VARALDO, Savona nel secondo Quattrocento cit., p. 41.43 E. PANDIANI, Controversie tra Genova e Savona durante il pontificato di Giulio II, in Savona nella storia e
nell’arte cit., pp. 167-202; C. RUSSO, L’arbitrato di Giulio II citato.44 R. PAVONI, L’organizzazione del territorio nel Savonese: secoli X-XII, in Le strutture del territorio fra Piemonte
e Liguria dal X al XVIII secolo a cura di A. CROSETTI, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed arti-stici della provincia di Cuneo, 1992, pp. 65-119; Repertorio degli statuti della Liguria (sec. XII-XVIII) a cura diR. SAVELLI, Genova, Società ligure di storia patria, 2003, pp. 81-82.
“Gloriosa libertà” e “rivalità secolare”?
Capitolo 2
finanziaria, il livello della violenza contro Savona tende ad aumentare, non èdunque la rivalità economica il movente, bensì un gioco politico estremamen-te complesso, cui prenderanno parte alcuni tra i principali attori della scenaeuropea.
38
L’annalista genovese Jacopo Bonfadio, aprendo la sua narrazione degli even-ti cinquecenteschi, scrive: «Fra questo tempo i savonesi, già prima adheriti a’genovesi, sopportando mal volontieri di rimaner all’imperio di quelli soggetti etributarij, come è costume di molti che malagevolmente possono sofferire laloro buona fortuna, molto più alla scoperta e con maggior ardire cominciaronoa machinar quello che prima, vanamente però, havevano più volte tentato».Bonfadio si riferisce all’anno 1528, ma le sue affermazioni potrebbero applicar-si tali e quali a tante altre vicende dei secoli più lontani, quando i cittadini diSavona avevano inutilmente cercato di ridurre o addirittura annullare la propriadipendenza dai genovesi, mentre questi ultimi li avevano «sempre con piacevo-lissime parole ripresi et amichevolmente avisati che desistessero da così fattaimpresa, e star volessero in quello di che per antichissima conventione s’eranocontentati»1. Sappiamo che non sempre le cose erano procedute in modo cosìidilliaco come l’annalista vuole farci credere, che le rappresaglie per castigare etenere a freno la città riottosa erano state talora molto violente; è vero tuttaviache le punizioni non si erano mai spinte oltre un certo limite, le controversieerano state infine risolte con nuove pattuizioni, sentenze, arbitrati, dopo i qualiSavona aveva potuto riprendere energia e riavviare le proprie fortune economi-che, in attesa che il gioco degli interessi e delle fazioni riaccendesse le tensioni.
Una storia ciclica e ripetitiva, insomma, che però all’inizio del Cinquecentopresenta connotati di originalità: «molto più alla scoperta e con maggior ardi-re» i savonesi avrebbero preso a «macchinare». La materia del contendere èapparentemente sempre la stessa: «la ripugnanza di pagar certe gabelle dovuteper dritto de’ commerci», il desiderio di ottenere piena libertà di navigazione,magari la volontà di sottrarsi al monopolio genovese del sale2. Non è neppurnuovo il fatto che i savonesi «entrarono in speranza certa di poter conseguire dalre [di Francia] ciò che desideravano»3, poiché sappiamo come anche in passatole «esterne dominazioni» avessero suscitato mosse e speranze di quel tipo. Quelche è davvero cambiato è invece il quadro internazionale: il sovrano sul quale isavonesi ora fanno conto non è il pur temibile re Luigi XI che all’inizio delQuattrocento si è insignorito del Genovesato, e neppure quel Carlo VIII chenel 1494 ha compiuto una fulminea incursione fino al regno di Napoli desti-nata, lo sappiamo col senno di poi, ad aprire la fase delle «guerre horrende de
39
1 J. BONFADIO, Gli annali di Genova dall’1528 [sic] che ricuperò la libertà, fino al 1550 divisi in cinque libri.Nuovamente tradotti in lingua italiana, et di una tavola copiosissima accresciuti da Bartolomeo Paschetti medico etfilosofo, Genova, Girolamo Bartoli, 1586, pp. 5v-6r.
2 ASG, Archivio segreto, 361, n. 57.3 J. BONFADIO, Gli annali di Genova cit., p. 6v.
Capitolo 3
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
Italia» come le chiamerà Guicciardini, ma apparsa sul momento niente più diun colpo di mano piuttosto avventato. Si tratta invece di Luigi XII, monarcaabile, astuto, determinato, che nel 1498, al momento della sua ascesa al tronodi Francia, si è proclamato anche re delle due Sicilie e duca di Milano; e che nel1499 è sceso in Italia con solide alleanze e con piani di conquista nient’affattofumosi. La sua spedizione ha davvero sconvolto il precario equilibrio politico-diplomatico-militare su cui la penisola s’era retta nei cinquant’anni successivialla pace di Lodi del 1454. E nel 1502, rottosi l’effimero accordo fra Luigi eFerdinando il Cattolico per la spartizione del regno di Napoli, diverrà a tuttichiaro che la partita italiana riguarda ormai non solo e non tanto gli staterellidella penisola, quanto le due grandi potenze europee, la Spagna e la Francia.
«Savona – scrivono Scovazzi e Noberasco nella loro Storia – si affrettò adaccordarsi col potente re di Francia, ispirata […] dal palese desiderio di preve-nir Genova, di acquistar grazie e favori, a danno della Metropoli, presso ilnuovo dominatore, e di crearsi l’ambita posizione di dipendenza da un solopadrone, rompendo i vincoli, subiti per forza e non riconosciuti mai, con loStato genovese»4. Luigi XII entra a Milano, suo obiettivo strategico primario, il6 ottobre 1499 e subito il Comune savonese gli spedisce tre ambasciatori perannunciare che la città gli ha giurato fedeltà e intende mettersi sotto la sua pro-tezione, ma chiede in cambio una serie interminabile di garanzie, il rispetto dimille privilegi, l’autonomia più completa da Genova5. Quest’ultima invece èstata colta alla sprovvista: la presa di Milano, liberandola dalla soggezione sfor-zesca, l’ha indotta per un attimo a meditare una restaurazione repubblicana, esolo il 26 ottobre, con una propria ambasceria nella capitale lombarda, haannunciato di volersi sottomettere a re Luigi, peraltro chiedendo che venganointegralmente mantenute in vigore le convenzioni con Savona. Il re si barca-mena, risponde che non concederà nulla in prejuditium CommunitatisIanuensis, ma assicura i savonesi che – qualora insorgano controversie tra le duecittà – se ne farà arbitro imparziale, justitiam faciet. «Ciascuno tornava sulle sueposizioni, dunque; almeno all’apparenza. In realtà qualcosa era mutato per sem-pre, da quando il confronto era stato spostato su un campo d’azione le cuicoordinate sfuggivano ormai ad entrambi i contendenti»6.
Da allora gli eventi si susseguono a un ritmo rapido7. Ludovico il Moro tornapochi mesi dopo a Milano e subito Genova ne approfitta per ribellarsi ai fran-cesi, mentre Savona resta loro fedele. Ma il Moro viene presto sconfitto, laSuperba è ripresa e nuovamente costretta alla sudditanza verso Luigi XII; men-tre quest’ultimo concepisce il piano di utilizzare Savona come piazzaforte «pertener a freno l’infida Repubblica», e infatti vi realizza opere innovative di forti-ficazione che ne fanno un caposaldo dell’apparato strategico francese. Avendo a
40
4 I. SCOVAZZI-F. NOBERSASCO, Storia di Savona cit., vol. III, p. 5.5 Ivi, pp. 5-8.6 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., pp. 58-59.7 Se ne possono seguire i dettagli nell’opera di Scovazzi e Noberasco (vol. III, pp. 5-116), o vederne un’a-
nalisi più rapida ma anche assai più acuta nel citato saggio di Fiaschini, pp. 58-72.
Capitolo 3
disposizione un padrone e protettore così potente, non c’è da stupirsi che i savo-nesi, o quantomeno la fazione prevalente in quel momento, cerchino di rivolger-si direttamente a lui per far valere quei diritti e privilegi che in passato hannoinvano rivendicato facendosi concedere qualche diploma imperiale che regolar-mente, data la debolezza e la lontananza del Cesare di turno, restava lettera morta.Tanto più favorevole deve sembrare l’occasione quando nel 1503 il savoneseGiuliano Della Rovere – salutato subito come defensor civitatis – diventa papaGiulio II, e quando un anno dopo egli stringe alleanza proprio con Luigi XII.
Viceversa la preoccupazione di Genova è grande, tanto da indurla nel 1504a proclamare contro Savona una sorta di embargo, vietando a ogni suddito e cit-tadino di trafficare con essa «sub pena de perdere lo commertio suo». Ne segueda parte savonese – vi abbiamo già accennato nel capitolo precedente – larichiesta di un arbitrato internazionale affidato alternativamente al pontefice eal re di Francia: una vicenda che si trascina fino al 1512 senza risultati concre-ti, tanto più che la nascita della Lega Santa nel 1511, promossa dal papa con-tro i francesi, ha messo l’uno contro l’altro i due presunti protettori. Certo, daRoma sono venute sentenze favorevoli a Savona che ne hanno sancito una largaindipendenza; ma infine non si sono dimostrate più efficaci dei vecchi diplomiimperiali, e il sovrano francese – il quale non può scontrarsi apertamente congli interessi genovesi – ne ha tenuto ben poco conto.
Nel 1512 i francesi vengono cacciati da Genova, l’anno dopo OttavianoFregoso ne diventa Doge con l’appoggio della Spagna e del papa, che però nonè più il savonese Giulio II ma il fiorentino Leone X de’ Medici. Savona a que-sto punto ha perso ogni speranza di ottenere o recuperare una propria “libertà”e deve impegnarsi con nuovi patti, firmati il 23 agosto 1515, al rispetto delleconvenzioni con Genova rinunciando ad appellarsi a qualunque autorità ester-na8. Contemporaneamente il successore di Luigi XII, Francesco I di Valois, èsceso a sua volta in Italia: Ottaviano Fregoso si accorda subito con lui abban-donando l’alleanza ispano-pontificia, e pochi mesi dopo – giuratagli fedeltà –lascia la dignità dogale e assume la carica di Governatore di Genova in nomedel re Cristianissimo. La dominazione francese sulla Liguria – sia pure mediatadalla presenza, appunto, di un Governatore genovese – è destinata a durare finoal 1522, e durante tale periodo Genova manifesta per la compattezza territoria-le del proprio Stato una attenzione nuova, testimoniata sia dagli sforzi per otte-nere il pieno controllo di luoghi strategici dell’Oltregiogo come Ovada e Gavi,sia da una particolare sensibilità per la questione di Savona, al punto che que-sti temi costituiscono forse il principale motivo di tensione con la Francia, pocoincline a soddisfare le aspirazioni genovesi9.
Questa nuova attenzione si spiega innanzitutto con l’accelerazione che all’i-
41
8 E. PANDIANI, Controversie cit., pp. 198-201.9 A. PACINI, I presupposti politici del «secolo dei genovesi»: la riforma del 1528, ASLSP, vol. CIV, 1990, pp.
80-84. Questo importante saggio di Pacini, e ancor più il suo ricchissimo volume La Genova di Andrea Dorianell’Impero di CarloV (Firenze, Olschki, 1999), sono testi fondamentali per ricostruire le vicende genovesi (enon solo!) nella prima metà del Cinquecento. Ad essi, perciò, faremo spesso riferimento nel corso di questocapitolo, anche al di là di quanto via via segnalato nelle note.
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
Capitolo 3
nizio del XVI secolo, dopo lo scoppio delle guerre d’Italia, ha assunto la com-petizione violenta fra corpi politici grandi e piccoli: una competizione che,avendo tra le principali poste in gioco lo Stato di Milano cui da sempre sonolegati i destini di Genova, pone anche quest’ultima al centro dei conflitti. È unalotta per la sopravvivenza, nel corso della quale molti Stati italiani verranno tra-volti: il ducato di Milano e i regni di Napoli e Sicilia perderanno la loro indi-pendenza per divenire infine possedimenti spagnoli; la repubblica fiorentinadovrà trasformarsi in un principato; Siena verrà conquistata dai fiorentini; lostesso ducato di Savoia-Piemonte rischierà di sparire dalla carta politica.Genova invece ne uscirà avendo garantita – anzi, rifondata in forme ben piùsolide che in passato – la propria indipendenza, sia pure nel quadro del “siste-ma spagnolo”; e ciò che più conta acquisendo all’interno dell’impero facentecapo a Madrid una posizione assolutamente privilegiata, con il suo ceto diri-gente che detiene quasi il monopolio dei prestiti alla corona di Spagna e deibuoni affari con i territori che da essa dipendono.
Col senno di poi, l’alleanza spagnola appare del tutto ovvia: Genova risulteràfondamentale per la vittoria finale della Spagna e di Carlo V grazie sia all’ap-porto dei suoi capitali, sia alla forza marittima garantita dalle galere di AndreaDoria; e in cambio ne trarrà tutti i vantaggi suddetti. Nei primi tre decenni delXVI secolo, tuttavia, il finale della pièce non è affatto scontato: perché non èfacile prevedere quale delle due grandi potenze in lotta avrà la meglio, perchémolti genovesi hanno forti interessi commerciali in Francia, e perché le lotte difazione entro la città sono violentissime. Ma c’è un quadro strategico comples-sivo che permette di capire le ragioni della decisiva scelta di campo, e chesoprattutto – dal nostro punto di vista – consente di situare in modo correttola vicenda di Savona. Se guardiamo ai rapporti di Genova con Francia e Spagnanel primo Cinquecento, ci accorgiamo di una differenza sostanziale: quando lacittà accetta l’egemonia della prima, essa diventa suddita dei sovrani francesi, liriconosce come signori, rinuncia al proprio Doge in cambio di un Governatoreche comanda in nome di Sua Maestà Cristianissima; viceversa con la Spagna deire Cattolici, e poi dell’imperatore Carlo V, Genova stringe patti che ne fannoun’alleata e che le consentono di mantenere intatto il proprio assetto repubbli-cano. Inoltre la Francia – al contrario della potenza iberica – vuole in vari modiingerirsi nell’assetto territoriale della Liguria, ne infeuda alcune porzioni sot-traendole al controllo genovese, e in particolare – si è detto – utilizza Savonacome piazzaforte e antemurale. Infine, ed è una differenza non da poco, men-tre Luigi XII e Francesco I pretendono da Genova, in quanto suddita, aiutifinanziari sotto forma di tributi, Carlo V ben presto capirà che il modo miglio-re per ottenere denaro dai patrizi-banchieri della Superba consiste nella stipuladi contatti di prestito, quegli asientos dai quali – fra il terzo decennio delCinquecento e la metà del Seicento – essi ricaveranno guadagni colossali10.
42
10 A. PACINI, I presupposti politici cit., pp. 143-144. Un’analisi di lungo periodo della dominazione francesea Genova ha sottolineato lo sforzo continuo messo in atto dai re cristianissimi – mediante la produzione di
Il 27 aprile 1522 Francesco I viene sconfitto alla Bicocca, presso Milano, ilche permette ad Antoniotto Adorno di assumere il titolo di Doge in unaRepubblica formalmente restaurata, che ha tra i principali impegni quello diriprendere il pieno controllo su Savona, dove naturalmente il gioco delle fazio-ni ha riportato al potere il locale «partito adorno». Sul piano degli atti formaliil governo genovese emana il 29 giugno 1523 una sentenza in base alla quale isavonesi, accusati di essersi sottratti al rispetto delle convenzioni, vengono pri-vati del beneficio di queste ultime (dovranno «remanere et esse meros subditosexcelsi Communis Ianue») e condannati a subire le pene previste per la viola-zione dei patti, cioè – come al solito – la distruzione delle opere portuali(«diruendam esse molem seu modulum et implendum et devastandum portumdicte civitatis Saone»)11. La sentenza non viene eseguita perché la guerra conti-nua ad infuriare, e tocca Savona con una breve riconquista francese e lo scop-pio di una grave pestilenza. Ma nel 1525 la durissima sconfitta di Francesco I aPavia costringe i francesi ad abbandonare il ponente ligure, cosicché Genovapuò ora dar seguito alle minacce.
Nel marzo di quell’anno l’Officium Saone – la speciale magistratura genoveseincaricata dei problematici rapporti con la vicina città – invia a Savona quattrocommissari per ispezionare le opere portuali e stabilire quanta parte distrugger-ne allo scopo di ottenere la loro «total devastatione»12. Questi propositi inquie-tano l’ambasciatore imperiale Lope de Soria, il quale il 5 aprile ne informa CarloV: «Sahona […] es tierra de importancia», ma i genovesi vogliono che «los deSahona» non riconoscano altra autorità superiore se non Genova, mentre i savo-nesi chiederebbero quantomeno il diritto di appellarsi ad un’autorità superiore –in questo caso appunto l’imperatore. La controversia rischia di “destabilizzare” –diremmo oggi – un’area strategicamente cruciale, perciò il de Soria torna pocodopo a consigliare che Carlo V scriva a entrambe le parti per ordinare «que dies-sen fin a las dichas diferencias, porque con ellas se destruie Sahona y no gananada Genova», senza contare che Savona è «tierra de Imperio», quindi i genove-si non possono pretendere di aver su di essa piena sovranità13.
Uno dei più stretti collaboratori dell’imperatore, il marchese di Pescara, nel-l’autunno del 1525 giunge a diffidare il Doge e gli Anziani di Genova dal pren-dere un’iniziativa ostile nei confronti di Savona, ma senza risultato. Il de Soria,informandone Carlo V, fa presente che tale iniziativa non solo non è «confor-me a justicia», ma è strategicamente pericolosa perché il porto di Savona puòessere molto utile agli ispano-imperiali. Infine, però, la sua conclusione è illu-minante: se Genova vuole procedere alla rappresaglia, bisogna lasciarla fare, per-ché «ella es la cabeça y la que […] serve a Vuestra Magestad». È Genova che
43
nuove leggi e la creazione di nuove magistrature – per fare della Liguria un possedimento stabile della corona.Si voleva cioè colpire l’autonomia della legislazione e della giurisdizione locale, per ridurre Genova a «simpleville de France et [...] considérer les génois non pas comme citoyens de leur commune, mais comme sujets duroi» (F. LÉVY, Gênes ville de France? Aspects juridiques de la domination française à Gênes, ASLSP, vol. CXXI,2007, fasc. I, pp. 329-356).
11 ASG, Archivio segreto, 361, n. 57.12 ASG, Manoscritti, 652, cc. 1594-1596.13 A. PACINI, I presupposti politici cit., p. 241.
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
appoggia la causa imperiale e la finanzia: perciò, fintanto che tiene fede agliimpegni, può regolarsi come meglio crede per risolvere i problemi territorialiinterni14. Così ai primi di novembre giunge a Savona il commissario genoveseBartolomeo Spinola «con forte mano de soldati e guastatori a profondare sullebocche di questo porto tre grosse navi ripiene e lavorate tutte al di dentro diforte muro». Pochi giorni dopo un altro commissario, Geronimo Adorno,«occupate tutte le case del molo, fatti sloggiar gl’habitanti, attese a far dirocca-re quella mole o sia argine del porto, e con le sue rovine e col cumulo d’altrematerie a diseccar l’acque», rendendo lo scalo savonese «inhabile a riceverevascelli d’alto bordo» e capace solo di dare asilo nella darsena alle «navi sottili»,ossia alle galere15. Fernando Marín, commissario dell’esercito spagnolo, ha insi-nuato a Carlo V che la rappresaglia abbia anche altri scopi: se un domaniGenova intendesse «mudar estado», cioè rovesciare le alleanze, l’armata impe-riale non potrebbe più far conto su Savona per tenere la Liguria16. Ha perfetta-mente ragione a pensare che ormai la controversia tra le due città trascenda lapolitica interna, ma per il resto sbaglia le previsioni, come dimostreranno gliesempi dei due anni successivi.
Il 22 maggio 1526 si forma, contro l’imperatore, la lega di Cognac che uni-sce alla Francia i principali Stati italiani: tra le clausole si contempla cheFrancesco I possa riacquistare su Genova «quella superiorità che vi soleva avereper il passato»17. Subito Savona si consegna ai francesi, i quali – occupate leRiviere – stringono d’assedio Genova che si ritrova ben presto in condizionidisperate. È allora che in quest’ultima città riprendono con vigore i propositi,già delineati qualche anno prima, di giungere a una profonda riforma politica:l’«unione», cioè un governo senza fazioni, ma anche senza divisione tra cetidiversi, tra nobiles e populares, in cui tutte le famiglie maggiori costituiscano ununicus ordo e abbiano pari diritto di accedere alle cariche. Ma il buon esito del-l’unione ha una condizione irrinunciabile, cioè la “riconquista” di Savona, chenon deve essere più una posta nel gioco tra le fazioni adorna e fregosa, né tan-tomeno un’arma con cui le potenze straniere possano minacciare a loro piaci-mento l’integrità di Genova. E la minaccia è soprattutto francese: sia perché orasono le truppe e le navi di re Francesco I che assediano Genova, sia perché il suopiano, più ancora che in passato, mira a rafforzare Savona, a costituire in essa«un polo economico e strategico autonomo nel ponente ligure, prevedendo checiò avrebbe portato, presto o tardi, alla caduta della stessa Genova». Il quadro,a questo punto, è chiarissimo: per la sicurezza di Genova è indispensabile la sot-tomissione di Savona, la quale può essere ottenuta solo con l’appoggio militaredegli ispano-imperiali. Gli obiettivi finali, per i genovesi più illuminati, sono lacostruzione in Liguria di uno Stato territoriale compatto – almeno per quanto
44
14 Ivi, pp. 241-243.15 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 167.16 A. PACINI, I presupposti politici cit., pp. 243-244.17 F. GUICCIARDINI, Storia d’Italia, Torino, Einaudi, 1971, p. 1719.
Capitolo 3
lo consente l’evoluzione statuale dell’Europa di allora – nonché il raggiungi-mento di una ragionevole indipendenza e di una relativa neutralità, perché laRepubblica smetta di essere in continuazione un campo di battaglia e una postain gioco fra le grandi potenze.
La guerra, però, volge a favore di Francesco I e il 22 agosto 1527, con l’arri-vo a Genova di Teodoro Trivulzio che vi assume la carica di Governatore innome del re di Francia, prende avvio l’ultima dominazione francese della città.Al suo interno, tuttavia, gli accordi per giungere a quell’«unione» di cui si èdetto procedono, e nell’aprile 1528 i Dodici riformatori, una magistratura adhoc, emanano nuove leggi in tal senso, benché il Trivulzio e il suo governo dif-fidino di un mutamento che di fatto mira, compattando il ceto dirigente geno-vese, «a ottenere che se reduca questa città a uso de republica», cioè a garantir-le un’autonomia incompatibile con la signoria francese, la quale proprio sulcontrasto delle fazioni fonda la propria ragione d’essere.
Guardando le vicende dal punto di vista savonese, è importante sottolinearecome i Dodici riformatori traggano origine da una «balìa», una commissione diotto membri eletti il 6 settembre 1527 dal Comune di Genova «con il compi-to di fare tutto il possibile per ottenere dai francesi la restituzione di Savona, ecome il 20 dicembre siano stati aggiunti quattro membri a tale magistratura, aquel punto definita esplicitamente pro unione facienda»18. Non si potrebbeesprimere in modo più chiaro, dunque, il fatto che tra i presupposti fonda-mentali dell’«unione» i governanti genovesi pongono – come recita un docu-mento di quei giorni – la «reintegratione de le membra nostre», il pieno con-trollo sul territorio ligure e in particolare sulla piazzaforte savonese. Se la rifon-dazione dello Stato genovese vuole avere qualche speranza di successo, nonbasta che dentro le mura i cittadini sottoscrivano un nuovo patto, ma è indi-spensabile che sia definita una volta per tutte la questione dell’effettiva sovra-nità sulle Riviere e sul cuneo di terre che, oltre Appennino, si estende in dire-zione della pianura padana. Proprio in quei giorni, però, il comportamento diFrancesco I rende evidente la sua volontà di non restituire Savona ai genovesi,anzi di favorirla, proteggerne i traffici, garantirne l’autonomia, infine metterla«al centro di un progetto politico mirante a spezzare l’unità della Liguria»19.D’altronde che ha fatto il re di Francia non appena Savona stessa è tornata nellesue mani? Ha cominciato subito a ripararne e rinnovarne le fortificazioni,ristrutturando la cinta muraria, elevando baluardi e bastioni, armandola dibuona artiglieria, sgombrando il porto20. Per Genova – se ne vede bene l’eco intutti i suoi storici e cronisti che hanno trattato la vicenda, dal Giustiniani alSalvago al Casoni – ciò rappresenta una minaccia gravissima dal punto di vistadegli interessi commerciali e fiscali, ma ancor più di quelli politici, perché vani-fica la speranza di poter sussistere come Stato indipendente21.
45
18 A. PACINI, I presupposti politici cit., p. 281.19 Ivi, p. 286.20 A. ABATE, Cronache savonesi cit., pp. 74-87; I. SCOVAZZI-F. NOBERASCO, Storia di Savona cit., vol. III, pp.
102-104; G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., pp. 69-70.21 A. PACINI, I presupposti politici cit., pp. 285-291.
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
È a questo punto che entra in scena il personaggio di Andrea Doria, unpotente signore della guerra che con la sua flotta privata di galere può far pen-dere da una parte o dall’altra la superiorità navale nel Mediterraneo. Fin dal1525 Carlo V ha cercato di assicurarsene i servigi, ma Doria – pur consapevo-le della necessità di mettere fine alla lotta tra fazioni e di rafforzare la strutturapolitica genovese, obiettivi cui l’imperatore potrebbe contribuire – ha finito peraccordarsi con Francesco I e per partecipare con lui alla presa di Genova. Oraperò la situazione lo preoccupa, tanto da indurlo – il 6 aprile 1528 – a scrivereal re e a rimproverarlo per la sua condotta riguardo a Savona: gli ricorda che datempo immemorabile essa è stata soggetta a Genova, che il popolo genovese malsopporterebbe un cambiamento in questa materia, che l’indipendenza savonesecomporterebbe la perdita di importanti proventi fiscali su cui fa conto il Bancodi San Giorgio per distribuire gli interessi sui suoi «luoghi» – i titoli del debitopubblico – ai quali moltissimi genovesi sono interessati22.
Gli argomenti sono validi, ma soprattutto è forte la posizione di chi li sostie-ne, tanto è vero che il re, con un decreto emanato da Parigi il primo luglio1528, nella sua qualità di signore di Genova restituisce ai genovesi «la città diSavona con le sue dipendenze e magazzini» a condizione che «i savonesi nonsiano molestati per multe od altri motivi e che non siano demoliti il molo, ilporto e tutte le altre opere di difesa»23. In passato una soluzione del genereavrebbe posto fine, almeno per un certo tempo, alle controversie fra le due città,e ne sarebbe scaturita un’ennesima replica delle conventiones: è accaduto cosìsolo due anni prima, nel marzo 1526, con quei «capituli» che ancora una voltaGenova ha concesso per «clemenza e pietà», e che sono stati più duri rispetto alpassato (in essi si specifica «che la Repubblica hebbe et ha la superiorità e tota-le giurisditione nelli huomini e città di Savona e tutto il suo distretto», e che isavonesi, in caso di mancato rispetto di quegli accordi, devono considerarsi«ipso iure cascati dal loro benefitio» per «restare meri suditi della Repubblica»),ma hanno anche confermato diversi privilegi della città soggetta, a cominciareda una larga autonomia fiscale24. Ora però i nodi stanno venendo al pettine. Leleggi elaborate nell’aprile dai Dodici riformatori e poi votate dagli Anziani diGenova hanno sancito l’unificazione dei cives in un unico ordine di governo,ma non hanno potuto toccare il tema dell’indipendenza e della sovranità, per-ché il monarca francese e il suo Governatore non intendono prestare orecchioa simili rivendicazioni: tanto è vero che Francesco I, nel momento stesso in cuirestituisce Savona, ordina al suo rappresentante in loco di rafforzarne ulterior-mente le difese.
Diventa allora decisiva la scelta di campo da parte di Andrea Doria, che nel-
46
22 Ivi, pp. 293-294.23 ASG, Archivio segreto, 2780; P. LISCIANDRELLI, Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova
(958-1797), ASLSP, LXXV, 1960, p. 192.24 ASG, Archivio segreto, 294; Concessioni, decreti et ordini della città di Savona concessi dalla Serenissima
Repubblica di Genova, Genova, Giuseppe Pavoni, 1610, pp. 1-30.
Capitolo 3
l’agosto 1528 sottoscrive con Carlo V un asiento – un contratto con cui glimette a disposizione la propria flotta – e vi fa includere alcune clausole, tipichepiù di un trattato fra potenze che di un accordo privato, con le quali viene sta-bilito che Genova «sia posta in libertà soa, et remessa a vivere in forma de repu-blica et reintegrata de tutto il suo Dominio et specialmente della terra deSavona»25. A questi eventi Francesco Guicciardini, nella sua Storia d’Italia, hadato il giusto rilievo: «il Doria – scrive – s’affaticava molto col re che Savonafusse rimessa nella antica subiezione de’ genovesi»; infatti «avendo il re smem-brato la città di Savona da’ genovesi, si dubitava che, voltandosi infra non moltotempo, per il favore del re e per la opportunità del sito, a Savona la maggiorparte del commercio e delle mercatanzie, e quivi facendo scala l’armate regie,quivi fabricandosi i legni per lui, Genova non si spogliasse di frequenza d’abi-tatori e di ricchezze». E aggiunge icasticamente che gli obiettivi del Doria sono«la libertà di Genova sotto la protezione di Cesare, la suggezione di Savona a’genovesi»26.
Il 12 settembre 1528, con un colpo di mano, Doria libera Genova dai fran-cesi, ponendo le premesse per la sua lunga signoria di fatto sulla città. Ed entroottobre promuove il completamento dell’«unione», dando sanzione a quellariforma nel governo della città (anzi, della Excellentissima Respublica, come daadesso si chiamerà, finché nel 1580 l’imperatore Rodolfo II le concederà il dirit-to di fregiarsi del titolo di Serenissima) che andrà poi sotto il suo nome, anchese ad essa si stava lavorando da diversi anni. Di lì a un mese – a conferma delnesso inscindibile tra «unione», alleanza imperiale e questione savonese – l’am-miraglio decide di affermare una volta per tutte la sovranità genovese su Savona.
L’urgenza e la risolutezza dell’intervento – è stato scritto con esatta comprensio-ne delle vicende – si spiegano con la rinnovata concezione del Dominio (e delmodo di governarlo) che si affermò a Genova come una rivoluzione rispetto aimetodi della politica tradizionale. L’esigenza inderogabile di conseguire un’organi-ca compattezza territoriale non consentiva più di praticare le solite soluzioni com-promissorie che, preservando le strutture della città rivale, ne lasciavano sussistereintatte […] le capacità di reazione ed offesa. Contro i savonesi, in questa occasio-ne, fu avventata una vera e propria campagna militare, studiata e guidata diretta-mente da Andrea Doria e dai suoi più vicini collaboratori; e condotta con lo spiri-to e i mezzi idonei a sospingere la conquista armata fino a ridurre i vinti alla tota-le discrezione dei vincitori27.
Savona viene investita da quattromila fanti, di fronte ai quali il Governatorefrancese Gian Francesco Solaro conte di Moretta, a ciò incoraggiato dai mag-giorenti locali, pensa bene di capitolare stabilendo con Filippino Doria che
47
25 C. BORNATE, I negoziati per attirare Andrea d’Oria al servizio di Carlo V, «Giornale storico e letterario dellaLiguria», XVIII, 1942, pp. 51-75 (in particolare pp. 74-75); V. DE CADENAS Y VINCENT, El protectorado deCarlos V en Génova. La “condotta” de Andrea Doria, Madrid, Hidalguía, 1977, pp. 85-88.
26 F. GUICCIARDINI, Storia d’Italia cit., p. 1912 e 1956.27 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., p. 72.
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
«venendo la cità nel dominio de li […] signori genoesi la conserveranno cumogni sua parte integra e illesa nel stato e grado nel qual [si trova] al presente, ené li permeterano ruine aut dano alcuno, né li citadini beni o persone loro have-rano distorbo aut lexione in modo alcuno, né intrometerano gente alcuna in lapredicta cità salvo per guardia necessaria di essa»28. Ma dopo che il Moretta, il29 ottobre, ha consegnato le chiavi della città «ad Andrea Doria, al conteFilippino Fiesco et al conte Filippino Doria che a nome della Republica ne pre-sero il possesso»29, si scatena la violenza degli assalitori: viene infatti deciso chesiano «le mura di Savona tutte ruinate, i nuovi bastioni e tutte le fortificationispianate, le fosse della città empiute, il porto chiuso»30. Un tradimento – si diràda parte savonese – e una vendetta rabbiosa; ma certo non ingiustificata. C’è incorso una guerra generale, non limitata a Savona, e nella stessa Genova resisteasserragliato nel Castelletto un presidio francese. Le «ruine» allora non hannosemplicemente lo scopo di punire la città ribelle, ma anche quello di tutelarsida un ritorno dei nemici (la Francia e i suoi alleati della seconda Lega santa) chesulle installazioni savonesi potrebbero far conto. D’altronde lo stesso Castellettogenovese, appena conquistato, verrà immediatamente raso al suolo.
A Savona l’opera di distruzione, tuttavia, procede con una sistematicità sco-nosciuta in passato: Genova invia uno dietro l’altro diversi commissari incari-cati di sovrintendere alle demolizioni e di accertarsi che siano radicali.Un’istruzione redatta il 13 dicembre 1528 per due di costoro, ad esempio, èmeticolosissima nel prescrivere che «la ruina de quelli propugnacoli et fortessenove» – cioè le fortificazioni allestite dai francesi – e «la ruina de le mura vechieverso la marina» siano eseguite a regola d’arte, ma soprattutto che venga total-mente distrutto il molo «de forma che si accomodi col guastamento et riempi-mento del porto qual vogliamo che del tuto resti guasto et ruinato»; e perchéciò avvenga più rapidamente si dispone che «ogni barca [che] vene in quelloloco porti una barchata de le ruine fatte in el dicto porto»31. È una vicenda,quella delle devastazioni del 1528, che in tutte le storie savonesi costituisce l’ul-timo atto del lungo dramma in cui viene messa in scena la perfidia genovese, altermine del quale non può che calare il sipario. Ma se si osservano gli eventi consguardo più pacato e insieme meno miope si può cogliere la presenza di altriprotagonisti e di altri scenari, si può comprendere meglio sia la logica comples-siva di quella violenza, sia le conseguenze che ne derivano, non tutte necessa-riamente negative.
Che nel 1528 la “catastrofe” savonese non sia un fatto ristretto al duello trale due città, che si inquadri entro la grande storia italiana ed europea, che solo
48
28 A. BRUNO, Storia di Savona cit., p. 115.29 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 168.30 J. BONFADIO, Gli annali di Genova cit., p.18v.31 ASG, Camera del governo, 6 (ringrazio Riccardo Dellepiane che gentilmente mi ha dato copia di questo
documento). Sulle distruzioni operate allora a Savona la fonte più pittoresca, sempre citata in tutte le storielocali, resta la cronaca dell’Abate (A. ABATE, Cronache savonesi cit., pp. 99-101).
Capitolo 3
all’interno di questa sia comprensibile, dovrebbe essere chiaro alla luce di quan-to si è detto finora. Lo hanno ben capito alcuni dei principali testimoni dell’e-poca, dal già citato Guicciardini a Paolo Giovio a Marin Sanuto32, per non par-lare dei maggiori annalisti genovesi. L’ha intuito persino il modesto cronistaMonti: Carlo V – scrive – ha dato il suo assenso alla sottomissione e alla “puni-zione” di Savona da parte dei genovesi «per tranquillar il loro Stato e le cosed’Italia»33. In realtà la Repubblica di Genova, per assestarsi del tutto, impie-gherà ancora mezzo secolo, fino a quelle Leges novae del 1576 scaturite da unultimo sussulto di lotte intestine, sia pure in un contesto totalmente diverso34.Ma la riforma “doriana”, con le sue nuove istituzioni di governo e il nuovoassetto territoriale dato alla Liguria (si ricordi che, non appena presa Savona,Genova ottiene anche la cessione di altri luoghi strategici come Gavi, Novi eOvada) rappresenta comunque un punto di partenza imprescindibile, da cui lastoria genovese si dipana per duecentosettanta anni con una continuità e unastabilità mai conosciute in precedenza.
Anche le «cose d’Italia» vedranno ancora trent’anni di sommovimenti e guer-re, ma si fisseranno infine in quella pax hispanica (alla cui realizzazione il con-tributo finanziario e strategico di Genova risulterà essenziale) destinata anch’es-sa a durare molto, in forme non così deleterie come ha creduto un tempo la sto-riografia di stampo risorgimentale o nazionalista35. Nel corso di questo lungoperiodo – lo abbiamo detto – Genova avrà indipendenza, neutralità, pace e ric-chezza: dalla Spagna otterrà guadagni cospicui, tutela diplomatica, protezionemilitare, laddove una considerevole parte della penisola verrà dalla stessa Spagnafiscalmente spremuta e coinvolta in vario modo nelle sue interminabili guerre.Se sarà appunto Genova, in quanto città Dominante e in quanto sede di ungrande emporio e di immensi capitali, a sfruttare al meglio la collocazione nelsistema spagnolo e i vantaggi che ne derivano, di alcuni benefici profitteràanche il suo Dominio, compresa Savona. Ciò vale, ne riparleremo più avanti,per il regime fiscale; ma anche – ed è una valutazione che molti savonesi hannopotuto fare subito, già all’indomani della “catastrofe” – per la pacificazione
49
32 P. GIOVIO, Historiarum sui temporis a cura di D. VISCONTI, t. II, p. I (Opera, t. IV), Roma, IstitutoPoligrafico dello Stato, 1964, p. 82; M. SANUTO, I diarii, t. XLIX, Venezia, R. Deputazione veneta di storiapatria, 1897, col. 98-100 e 207-214.
33 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 11 (il corsivo è nostro).34 G. DORIA, Un quadriennio critico: 1575-1578. Contrasti e nuovi orientamenti nella società genovese nel qua-
dro della crisi finanziaria spagnola, in Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a FrancoBorlandi, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 377-394 (ora in G. DORIA, Nobiltà e investimenti a Genova in etàmoderna, Genova, Istituto di Storia economica, 1995, pp. 157-174); R. SAVELLI, La repubblica oligarchica.Legislazione e ceti a Genova nel Cinquecento, Milano, Giuffré, 1981.
35 La revisione dei giudizi sulla dominazione spagnola in Italia conta ormai una bibliografia vastissima, el’intervento di studiosi di grande prestigio come Giuseppe Galasso, Domenico Sella, Aurelio Musi, GianvittorioSignorotto e altri. Per un quadro aggiornato su questo tema rinvio a: Nel sistema imperiale: l’Italia spagnola acura di A. MUSI, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1994; A. MUSI, L’Italia dei viceré. Integrazione e resistenzanel sistema imperiale spagnolo, Cava de’ Tirreni, Avagliano Editore, 2000 (specie le pp. 11-21 e 59-77); Alle ori-gini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana a cura di A. MUSI, Milano, Guerini e Associati, 2003 (inparticolare i saggi di A. Musi, G. Signorotto e C. Mozzarelli).
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
interna ed esterna. Uno studioso del tutto alieno da ubbie di tipo campanilistico lo ha scritto in
maniera molto chiara: «C’è nel 1528 la fine di un lungo periodo di scorreriealterne e successive di contrastanti eserciti e bande armate, con l’inizio di unperiodo di pace che per la cinquecentesca gente di Savona – o quantomeno,aggiungiamo noi, per una parte cospicua della popolazione – non è una depre-cabile pace dei vinti, ma molto più realisticamente ed umanamente una pacemilitare pura e semplice: è una sequenza di anni successivi senza guerre e mortie paure sulla porta di casa»36. È una constatazione quasi banale, e tuttavia “scan-dalosa” rispetto alla vecchia storiografia locale, benché questa avesse già tutti glielementi per avanzarla a sua volta: chi scorra i capitoli dell’opus maius di quellastoriografia, la Storia di Savona di Scovazzi e Noberasco, vi trova – specie per idecenni che precedono l’annus terribilis – una tale sequela di fatti d’arme, asse-di, colpi di mano, lotte intestine da fare intuire quanto una pacificazione, siapure attuata con mezzi violenti e deprecabili, potesse essere desiderabile permolti. E riguardo ai mezzi violenti, oltre a ricordare – vi torneremo tra poco –che essi non rappresentano certo un’esclusiva dei genovesi, va aggiunto che aquella violenza partecipano alcuni comprimari sulla cui presenza è bene riflet-tere.
Come riferiscono le cronache di Antonio Barberino e di Agostino Abate, lamanodopera per realizzare le demolizioni del 1528 viene reclutata nelle vicinecomunità di Varazze, Albisola, Stella, Vado, Quiliano, Noli e nelle “ville” circo-stanti: accorrono molti uomini, allettati come è ovvio dalla possibilità di gua-dagnarsi la paga di qualche giornata, i quali però mettono nell’opera di distru-zione un entusiasmo e un accanimento tali («gran impeto e crudeltà a ruinareche proprio pareano cani arabiati», riferisce il Barberino) da far pensare che ilsalario non sia la loro unica motivazione, ma che vi siano vecchi rancori e ini-micizie da sfogare37. È anche questa una lunga storia di tensioni, dispute o vererivolte che hanno contrapposto al Comune savonese gli abitanti dei centriminori, dei borghi, delle ville: una conflittualità quotidiana e diffusa – ne siamobene informati relativamente ai casi di Quiliano38 – che ora esplode grazie all’i-stigazione genovese, ma che non è stata inventata da Genova, anzi negli annisuccessivi sarà da questa regolata e contenuta, secondo una strategia politica cheintende presentare la Dominante quale arbitro imparziale dei contrasti fra lecomunità.
Se l’esito finale della lotta tra Genova e Savona trascende di molto il quadrolocale e si inserisce nella logica delle guerre d’Italia, del conflitto franco-asbur-gico, della evoluzione statuale cinquecentesca, va detto nel contempo che in uncerto senso solo nel 1528, per la prima volta dopo molto tempo, lo scontro
50
36 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero e il suo palazzo, Savona, Camera di commercio, 1990, p. 14.37 I. SCOVAZZI-F. NOBERASCO, Storia di Savona cit., vol. III, pp. 127-128.38 G. MALANDRA, Storia di Quiliano, AMSSSP, n. s., vol. I, 1967, pp. 101-190 (in particolare pp. 162-163).
Capitolo 3
avviene davvero tra due città schierate in formazione abbastanza compatta l’unacontro l’altra. Nella lunga fase delle lotte di fazione, degli scontri tra i capipo-polo Adorno e Fregoso (i «cappellazzi», come li definisce il lessico dell’epoca),la contrapposizione – già abbiamo avuto modo di osservarlo – solo in apparen-za ha riguardato i due Comuni come entità distinte. In realtà li ha attraversati,cosicché le rappresaglie genovesi, disposte dal vincitore di turno della contesafaziosa, di solito hanno mirato a colpire non tanto la città nel suo insieme quan-to il “partito” soccombente39: anche se la natura esatta di questa lotta tra fazio-ni nel contesto savonese non è chiara, e forse non lo sarà mai, perché per com-prenderla occorrerebbe un’analisi socioeconomica tanto approfondita quantodifficile da realizzare. Ma nel 1528 anche questo scenario è cambiato: Genovaha realizzato quella «unione» che ha abolito formalmente – ma in parte anchesostanzialmente, nell’effettivo esercizio delle cariche – la divisione in “partiti” ela spaccatura tra nobiles e populares; ed è riuscita altresì a comporre il contrastodi interessi fra chi per motivi economici guarda favorevolmente alla Francia (peresempio i produttori di manufatti, con in testa i «seatieri») e chi per le stesseragioni propende per la Spagna (i mercanti-banchieri). È una forza armata uni-taria, espressione di un corpo politico coerente, quella che si presenta davantialle mura di Savona per chiudere i conti.
Anche la città assalita appare forse meno divisa di una volta, visto che il suoceto dirigente poco più di un anno prima ha cercato di realizzare una riformaanaloga a quella contemporaneamente dibattuta a Genova, allo scopo di porta-re «bona unione et sancta concordia» fra i cittadini, superando la contrapposi-zione fra le «piazze»40. Ci sono insomma, anche in sede locale, nuove regole delgioco che impediranno quella replica infinita dello stesso copione (l’alternanzatra accordi e ribellioni che è anche, in senso pregnante, un gioco delle “parti”)andata in scena nei secoli precedenti. Questa volta la repressione genovese nonè la faida di un clan o la vendetta di una cosca; è l’atto d’imperio di uno Statoche intende sancire la propria sovranità e affermare, sia pure ancora in formaembrionale, il principio del “monopolio della forza”.
A noi che guardiamo le cose dalla distanza di quasi cinquecento anni tuttociò può apparire abbastanza chiaro, ma forse non altrettanto lo era per chi vive-va quegli eventi. È anzi naturale che per gli uomini del tempo l’episodio del1528 si inscrivesse in un continuum secolare e venisse interpretato secondoparametri tradizionali – mentre è forse meno naturale che la vulgata storiogra-fica locale abbia ripetuto pedissequamente quella interpretazione. Da una partee dall’altra del fronte, ad esempio, si tiravano in ballo i vecchi argomenti: la riva-lità commerciale (che oltretutto, lo abbiamo visto, non era mai stata così nettada non lasciare spazio a forme di ampia collaborazione e integrazione), e soprat-tutto le ragioni fiscali. Nei documenti genovesi degli anni venti delCinquecento non si fa che insistere sui problemi dei dazi, dei «comerchi» e del
51
39 Questa dialettica è bene analizzata in R. MUSSO, Ceto dirigente cit., pp. 18-39.40 Ivi, p. 27.
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
monopolio del sale: tanto è vero che spesso nel dibattito su Savona intervengo-no in prima persona i Protettori di San Giorgio, interessati a non perdere gliintroiti che i traffici savonesi possono garantire. Sono problemi seri, reali,nient’affatto da sottovalutare, specie nel quadro di uno Stato come quello geno-vese, con bilanci pubblici molto ristretti e un equilibrio sempre difficile tra leuscite e le poche entrate disponibili. Ma certamente nella crisi del 1525-1528passano in secondo piano, come dimostra il particolare accanimento sulle opereportuali.
I rappresentanti di Savona, recatisi a Genova per implorare misericordiadopo le prime demolizioni del 1525, hanno puntato proprio sugli interessi diquel governo e di quel fisco: «il privarci del porto, della navigazione, del traffi-co», hanno detto, non può che «ferir questo Stato», sottraendogli quegli introi-ti che proprio dal commercio si ricavano41. Ma i loro argomenti non serviran-no a evitare la devastazione del ’28, segno che altro è l’obiettivo, altra la causa.L’annalista Filippo Casoni, che ci ha lasciato un bel resoconto del dibattitoseguito alla sottomissione di Savona, attribuisce al patrizio Giambattista Fornarila proposta, addirittura, di «togliere di mezzo la città» e deportarne gli abitanti(«mandarli ad abitare divisi in altre terre di Liguria, o trasportarli in diversecolonie a popolare la Corsica»); e a un altro patrizio, Agostino Pallavicino, il piùmite proposito – che verrà di fatto attuato – di accanirsi principalmente controle opere portuali: «tolto a’ savonesi il porto, e per questo mezzo impedita lorola navigazione e levato il comerzio, verrà Savona a diminuirsi da se stessa dipopolo e di ricchezze, e però a perdere quelle forze, le quali potessero alzare glianimi degli abitanti, e tirarli a disegni alla pubblica quiete perniciosi»42. Non sipotrebbe esprimere meglio la logica di quegli interventi: l’attacco all’economiasavonese mira non tanto a eliminare un concorrente commerciale, quanto adeprimere un potenziale polo di resistenza politica, e solo entro questi limiti l’a-zione del governo avrà motivo di continuare o meno negli anni successivi.
Peraltro quella resistenza – lo ripetiamo – da tempo non ha nulla a che farecon la pretesa indipendenza savonese, con uno status di libero comune o diautonoma repubblica marinara, cioè con quei falsi concetti con cui la storio-grafia locale si è a lungo trastullata. Non solo l’indipendenza, in un certo senso,non c’è mai stata, ma nella prima metà del Cinquecento una città delle dimen-sioni e con la posizione strategica di Savona non ha alcuna possibilità di rita-gliarsi uno spazio politico proprio. Le alternative alla sudditanza nei confrontidi Genova sono o una dominazione francese, destinata ad essere effimera, vistoil risultato finale delle guerre d’Italia; o un inserimento nei domini spagnoli,come avverrà in seguito al marchesato di Finale, che peraltro aveva ben altra tra-dizione e consistenza statuale rispetto a Savona; oppure ancora – allorchéEmanuele Filiberto di Savoia rientrerà in possesso dei suoi Stati – l’assorbi-mento nel ducato sabaudo. Di queste tre soluzioni, solo la seconda avrebbe
52
41 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 170.42 F. CASONI, Annali della Repubblica di Genova, Genova 1799-1800, t. II, pp. 38 e 42.
Capitolo 3
forse prefigurato per la città una condizione più favorevole, ma il particolarerapporto di simbiosi tra la Spagna e Genova la rendeva impraticabile, visto chequest’ultima infine aveva subordinato proprio alla sottomissione di Savona l’al-leanza con Carlo V.
Questa alleanza apre una fase decisiva dello scontro franco-asburgico. Il 5agosto 1529 viene firmata la cosiddetta «pace delle due dame» o di Cambrai,con cui Francesco I abbandona le sue mire sull’Italia; il 12 agosto Carlo V arri-va a Genova con un forte esercito per “pacificare” la penisola; fra il 23 dicem-bre 1529 e il 6 gennaio 1530 viene siglata la pace tra l’Impero e gli Stati italia-ni riuniti nella seconda Lega santa; il 24 gennaio Carlo riceve a Bologna la coro-na imperiale da papa Clemente VII, un importantissimo riconoscimento for-male cui si accompagna l’omaggio dei principi italiani; il 12 agosto 1530, conla conclusione dell’assedio di Firenze, cade la repubblica fiorentina per far postoal ducato mediceo, voluto e appoggiato dall’Asburgo; intanto sul finire del1529 l’imperatore ha restituito Milano a Francesco Sforza, ma il ducato è inpratica un protettorato della Spagna, in attesa di essere di lì a poco inglobatonei suoi domini.
Il “nuovo ordine” ispano-imperiale sta rimodellando l’Italia; Genova si è col-locata dalla parte vincente e si appresta a raccoglierne i frutti, ma la situazioneè ancora estremamente fluida e presenta elementi di pericolo. La Francia nonha voluto comprendere la Repubblica nella pace di Cambrai; o meglio, ha postocome condizione per includervela che essa sia dichiarata suddita dell’Impero:una soluzione che il governo genovese rifiuta giudicandola «vincolo grande-mente preiudiciale» alla sua piena indipendenza, ma così facendo rischia discontentare l’imperatore cui non dispiacerebbe il riconoscimento di una supre-mazia politica sulla sua ricca alleata. Anche da un’altra direzione sorgono pro-blemi, perché il duca di Milano mantiene vivo un contenzioso sulle terredell’Oltregiogo acquistate dalla Repubblica: solo nel 1536, dopo l’occupazionedel ducato da parte di Carlo V, quest’ultimo riconoscerà il pieno possesso deiluoghi contesi (Gavi, Novi, Ovada, Rossiglione, Voltaggio e Fiaccone – cioè l’o-dierna Fraconalto), dando anche per questo verso sanzione giuridica alla ricom-posizione del Dominio genovese e contestualmente conferendo al Doge ladignità ducale43. Ma intanto le pressioni francesi sono continuate con ritorsio-ni commerciali e con un’iniziativa diplomatica che nel 1532-33 coinvolge papaClemente VII e che mira a dimostrare – come riferiscono gli “oratori” genove-si presso il pontefice – «la iurisdictione de Saona esser separata de la nostra, etper consequens noi non havere potuto goastare il porto, romper le fortese, némanco prendere le loro [dei francesi] artigliarie»44. La Francia a questa dataspera di potere ancora incidere sull’assetto italiano, e individua proprio nellavicenda savonese un punto critico dal quale partire per rimetterlo in discussio-ne. Però nel 1533, con l’inserzione quale Stato sovrano entro una lega per la
53
43 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria cit., pp. 271-276.44 Ivi, p. 295.
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
difesa d’Italia sotto l’egemonia imperiale, e soprattutto con il riconoscimento,mediante una lettera patente dell’imperatore, dei «privilegi di republica»,Genova comincia a sentire meglio garantita la propria “libertà”45.
Le sue traversie, tuttavia, non sono finite. Nel 1535 Francesco I manda ilproprio segretario Jean de La Forêt come ambasciatore presso il sultanoSolimano il Magnifico, col quale intende stringere uno scandaloso ma proficuorapporto di alleanza. Il La Forêt fa tappa a Tunisi presso Khair ad-dinBarbarossa, il potente ammiraglio della flotta ottomana, e ne sollecita l’aiuto perriconquistare Genova ai francesi. Il piano di Francesco prevede di entrare negliStati sabaudi e di lì invadere la Liguria, mentre il Barbarossa dovrebbe incro-ciare nel Tirreno, predare le navi genovesi e attaccare le Riviere: un piano vani-ficato, in quello stesso 1535, da una vittoriosa spedizione navale di Carlo Vcontro Tunisi. Subito dopo, però, la morte di Francesco Sforza e il riaprirsi dellacontesa per il ducato di Milano danno il via a una nuova guerra: Francesco Iscende in Piemonte mentre viene conclusa l’alleanza con l’Impero Ottomano, eGenova si sente minacciata da terra e dal mare. Il re francese tenta in effetti diimpadronirsi della città ma l’impresa fallisce, e di lì a poco una nuova treguacongela la situazione.
La guerra riprende ancora nel 1542 per concludersi due anni dopo con lapace di Crépy, nella quale Genova è compresa – secondo i suoi desideri – noncome suddita ma come «aderente e confederata dell’imperatore», mentre il re diFrancia deve rinunciare a ogni pretesa nei suoi confronti46. Infine il 5 luglio1546 viene investito del ducato di Milano il principe Filippo d’Asburgo, il futu-ro Filippo II di Spagna, e da allora Milano non sarà più merce di scambio sultavolo delle trattative tra la corona spagnola e quella francese. La soluzione èmolto gradita alla Repubblica, che sa bene quanto i suoi destini siano legati aquelli del ducato: se questo tocca agli Asburgo, i quali già le hanno riconosciu-to i suoi titoli di indipendenza, non ha più nulla da temere. A questo punto ilbilancio dei quasi vent’anni trascorsi dalla sottomissione di Savona può consi-derarsi per Genova ampiamente positivo: «Il nuovo assetto politico nato dallariforma del 1528 si era via via consolidato. La città aveva ottenuto titoli giuri-dici significativi che ne riconoscevano lo status di libera repubblica ed il domi-nio sul territorio ligure […]. Il ceto dirigente aveva dato buona prova di sé perl’abilità e la fermezza con cui aveva perseguito questi obiettivi»47.
Ma nel 1547 una nuova crisi interna, la congiura di Gian Luigi Fieschi,rischia di vanificare tutte queste acquisizioni, tanto più che essa si accompagnaad altre congiure e rivolte (la congiura di Piacenza contro Pier Luigi Farnese, larivolta di Napoli contro l’Inquisizione spagnola, le tensioni a Siena) che sem-brano rimettere in discussione la sistemazione dell’Italia. A quel punto Carlo V«accarezzò per la prima volta il progetto di unire la città ligure ai suoi domini.La Repubblica rischiò di soccombere, stritolata negli ingranaggi della politica
54
45 Ivi, pp. 298-304.46 Ivi, p. 317.47 Ivi, p. 323.
Capitolo 3
internazionale, e solo la ferma opposizione di Andrea Doria consentì di allon-tanare il pericolo»48; pericolo che tornerà un’ultima volta nel 1575-76 con loscontro intestino tra nobili vecchi e nuovi, ma in una situazione talmente diver-sa che allora saranno proprio le grandi potenze a farsi mediatrici per ricompor-re il dissidio e garantire l’integrità dello Stato genovese.
D’altronde, per capire quel che Genova ha rischiato nella prima metà delCinquecento, basta guardare all’esempio di un’altra gloriosa e antica repubbli-ca come Siena il cui destino si conclude nel 1555 con la conquista violenta daparte del granduca Cosimo I de’ Medici: un destino segnato «nel momento incui – è stato scritto con efficace sintesi – i suoi cittadini avevano pensato dipoter continuare a coltivare le proprie discordie senza rendersi conto che l’e-quilibrio del potere in Toscana stava cambiando e che una libertà segnata dafazioni e da ordinamenti pubblici continuamente rivisti […] non era compati-bile con la pace che l’imperatore cercava di introdurre nella penisola»49.
55
48 Ivi, p. 21.49 A. SPAGNOLETTI, Le dinastie italiane nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 34.
Il 1528, annus terribilis: premesse, eventi, conseguenze
Nel capitolo precedente ci siamo soffermati sugli eventi del 1528 e degli anniimmediatamente successivi per sottolineare quanto lunghi, difficili, problema-tici siano stati la costruzione, il consolidamento e il riconoscimento internazio-nale della Repubblica di Genova nata dalla “riforma” di Andrea Doria: il chespiega almeno in parte la durezza che quel governo ha messo in atto allora neiconfronti di Savona. È in corso una lotta decisiva per la sopravvivenza, e tuttigli ostacoli, tutti gli elementi di turbativa vanno rimossi, sia che essi venganodalle velleità di famiglie patrizie come i Fieschi o i Cybo, sia che possano sca-turire dal revanscismo di una città assoggettata con la forza, o dalle mire che unapotenza nemica ha su di essa. Nasce di qui – ne riparleremo – una sorta di osses-sione da parte del ceto dirigente genovese nei confronti di Savona, città consi-derata irrinunciabile e imperdibile, perciò guardata sempre con apprensione,con sospetto, anche al di là dei pericoli effettivi. Se Genova viene ben prestoritenuta da parte spagnola l’«ojo derecho» dell’Impero di Carlo V, Savona verràcitata in tutti i documenti genovesi dell’età moderna con l’appellativo di«occhio dritto della Repubblica». Questa Repubblica, come abbiamo visto, hadovuto attendere la metà del XVI secolo (anzi, qualcosa di più, perché solo nel1562 il Banco di San Giorgio le restituirà diverse terre che esso aveva ricevutoin pegno1) per assumere un assetto territoriale stabile e relativamente compat-to.
C’è chi ha ritenuto il Commune Janue la prima formazione politica italianacapace di far coincidere, fin dal XIII secolo, il proprio Dominio con una preci-sa regione geografica2; ma la natura di quel Dominio aveva poco a che fare conforme più mature di sovranità, si limitava a una serie di pattuizioni (volontarieo forzate) miranti a garantire libertà di traffici, a sancire una certa egemoniamercantile e marittima, ad assicurare un minimo di controllo militare. Lungidal poter vantare primati in questo campo, Genova è stata di molto precedutada città come Milano, Firenze e Venezia, le quali sin dal primo Quattrocentohanno dato vita a quelle formazioni territoriali ampie e coerenti che gli storicihanno poi designato con l’appellativo di “Stati regionali”. Poiché tali Stati sisono costruiti attraverso la sottomissione progressiva di numerose città da partedi una Dominante, uno sguardo sia pure molto rapido ai modi in cui ne è avve-nuta la costruzione può essere utile per meglio situare e comprendere la vicen-da di Savona.
Nell’Italia del basso medioevo città come Pisa, Firenze e Venezia si sono alungo comportate come Genova: inserite in vaste correnti di traffico che spa-
57
1 G. GIACCHERO, Il Seicento e le Compere di San Giorgio, Genova, Sagep, 1979, p. 42.2 V. VITALE, Il Comune del Podestà a Genova, Milano-Napoli, Ricciardi, 1951, p. 76.
Capitolo 4
Comparazioni
ziano dal Levante all’Europa settentrionale, hanno poco curato la conquista ter-ritoriale delle aree circostanti. È semmai nella pianura padana, dove le istitu-zioni comunali hanno presto ceduto il posto a signorie robuste e aggressive, chealcuni centri urbani hanno cominciato a sottomettere in maniera più rigorosail loro comitatus o districtus, e a tentare di allargare via via il controllo ad altreterre. In ciò si sono distinti soprattutto i Visconti di Milano, i quali hanno pre-cocemente conquistato tutte le città lombarde – l’ultima è stata Pavia, presa conla forza nel 1359 – tanto che proprio per reagire alla loro politica di espansio-ne Firenze e Venezia si avviano «a trasformarsi in grandi Stati territoriali, dandovita a vasti domini saldamente organizzati: quasi condizione necessaria per laloro sopravvivenza negli assetti politici italiani»3. Firenze – che già nel XIV seco-lo ha assunto un certo controllo su città come Pistoia, Arezzo, Prato, Volterra –di fronte ai tentativi di conquista di Gian Galeazzo Visconti occupa nel giro ditrent’anni numerosi altri territori, fra cui in particolare Pisa, che verrà sotto-messa nel 1406. Nel contempo decide di inglobare nel proprio dominio comu-ni sui quali in precedenza esercitava, mediante forme di «balìa», solo un’ege-monia indiretta, e di avviare un’ampia opera di organizzazione amministrativae fiscale che renderà infine lo Stato fiorentino uno dei più compatti nel pano-rama italiano4. Venezia, che per secoli è stata unicamente uno Stato da mar, frail 1404 e il 1428 si espande nel Veneto e giunge ad annettersi un’ampia por-zione della Lombardia fin quasi alle soglie di Milano, divenendo la più fortepotenza territoriale italiana5.
Il caso di Venezia, città marittima la cui storia è per molti versi simile a quel-la di Genova, può illustrare alcuni aspetti della vicenda genovese. L’interessedella Serenissima ad esercitare un qualche controllo sul proprio retroterra dataalmeno dalla metà del Duecento, ed è motivato dall’esigenza di garantirsiapprovvigionamenti alimentari e di mantenere aperte le vie commerciali versol’Europa centrale. Per molto tempo, tuttavia, la città lagunare non pensa affat-to di stabilirvi un esplicito dominio politico-militare, limitandosi semmai adaffermare il diritto di nominare nei comuni veneti un proprio cittadino qualepodestà6. Nel 1339 ha sì conquistato Treviso – che peraltro non ha oppostogrande resistenza, perché il suo ceto dirigente era ansioso «di barattare la pro-pria libertà per una qualche forma di sicurezza»7 – e ha fatto del suo territorioun proprio contado e una testa di ponte nella terraferma, ma lì si è fermata.Solo nel 1404-1405, all’improvviso, prima ha persuaso Vicenza a consegnarsi alei, poi ha costretto alla sottomissione Verona, infine ha espugnato Padova e vi
58
3 G. CHITTOLINI, Città, comunità e feudi negli Stati dell’Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo), Milano,Unicopli, 1996, pp. 33-34.
4 E. FASANO GUARINI, Lo Stato mediceo di Cosimo I, Firenze, Sansoni, 1973.5 G. COZZI-M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517,
Torino, Utet, 1986 (Storia d’Italia diretta da G. GALASSO, vol. XII, t. I), pp. 11-18 e 23-26.6 M. BERENGO, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino,
Einaudi, 1999, p. 53.7 E. BRUNETTA, Treviso in età moderna: i percorsi di una crisi, in Storia di Treviso a cura di E. BRUNETTA, vol.
III, L’età moderna, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 3-136 (qui p. 5).
Capitolo 4
ha abbattuto la signoria dei Carraresi i quali avevano pericolosamente mirato adespandersi nel Veneto in alternativa ai Visconti. Frattanto ha occupato Bassano,Feltre, Belluno e altri territori; più tardi, dopo una guerra con i Visconti, strap-perà loro Brescia nel 1426 e Bergamo nel 1428.
Con l’esempio della creazione dello Stato visconteo davanti agli occhi, con ilpericolo immediato dell’espansionismo padovano, e vedendo che anche Firenzesta rapidamente estendendo in forme ben più rigide rispetto al passato il con-trollo sulla Toscana, Venezia ha accettato quasi obtorto collo la logica del grandeStato territoriale, consapevole che ciò comporterà uno stravolgimento della pro-pria politica tradizionale e un oneroso impegno militare nello scacchiere italia-no8. Non gli interessi economici dunque, bensì quelli strategici, difensivi,l’hanno spinta in questa direzione; e lo stesso, almeno in parte, si può dire perFirenze. Certo, la costruzione dello Stato territoriale avrà poi delle conseguen-ze anche sul piano dell’economia: là dove – è soprattutto il caso toscano – esi-stono attività concorrenziali, per esempio le manifatture tessili, la Dominantepotrà favorire le proprie a spese di quelle delle città suddite; i cittadini venezia-ni e fiorentini, garantiti dalla loro supremazia giuridica ed economica, espan-deranno i loro possessi fondiari nei territori assoggettati, sottraendoli in parte aiceti dirigenti locali.
Inoltre i nuovi Stati regionali useranno la leva tributaria per convogliarerisorse finanziarie dalla periferia verso il centro, ancora una volta a vantaggiodelle città dominanti, che nel corso dell’età moderna cresceranno in popolazio-ne, in estensione e in decoro ben più di quelle soggette. Riguardo allo Stato fio-rentino, anzi, c’è chi ha sostenuto che proprio la necessità di aumentare il get-tito fiscale sia tra le principali spinte all’espansione territoriale, tanto è vero cheFirenze arriva rapidamente, nel 1427, a creare un accurato catasto che le con-sentirà un cospicuo e ben regolato prelievo su tutto il suo Dominio9. Ma certonon è questo il caso di Venezia, che per molto tempo non modifica inTerraferma il quadro fiscale preesistente alla conquista, e solo più tardi intac-cherà le immunità godute in questo campo dai nobili del suo Dominio10. Inrealtà gli eventuali vantaggi economico-finanziari rientrano più tra le conse-guenze che tra le cause della costruzione statuale nell’Italia centro-settentriona-le, e ciò vale anche per il caso di Genova (in particolare per la sottomissione diSavona, come già abbiamo tentato di dimostrare), la quale anzi è la più restia acrearsi un proprio Stato territoriale, a lungo preferisce adattarsi alle signorieforestiere – milanesi o francesi – piuttosto che imbarcarsi in quella difficile
59
8 M. E. MALLETT, La conquista della Terraferma, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta dellaSerenissima, vol. IV, Il Rinascimento. Politica e cultura a cura di A. TENENTI e U. TUCCI, Roma, Istituto dellaEnciclopedia Italiana, 1996, pp. 181-244 (in particolare pp. 181-196).
9 M. B. BECKER, Florence in Transition, vol. II, Studies in the Rise of the Territorial State, Baltimore, JohnHopkins Press, 1968, pp. 201-250; A. MOLHO, Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433,Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1971, p. 44.
10 L. PEZZOLO, Sistema di potere e politica finanziaria nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVIII), in Originidello Stato. Processi di formazioni statale in Italia fra medioevo ed età moderna a cura di G. CHITTOLINI, A.MOLHO, P. SCHIERA, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 303-327 (in particolare p. 307-309).
Comparazioni
impresa, e infine vi si decide solo perché costretta da una contingenza storicache le fa temere per la propria sopravvivenza.
Il parto dei nuovi Stati regionali, proprio per le condizioni di necessità in cuisi determina, avviene spesso in forme molto dolorose per chi ne subisce gli effet-ti, e da questo punto di vista Savona è certamente in buona compagnia. La con-quista veneziana di Padova, ad esempio, arriva dopo un duro assedio durato piùdi un anno che ha stremato la città, ed è seguita dall’uccisione di FrancescoNovello da Carrara e dei suoi figli, strangolati per ordine del Consiglio deiDieci, pur dopo ripetute promesse di clemenza e persino di un salvacondotto,perché si intende recidere ogni legame di fedeltà della popolazione padovanaverso il suo signore11. Anche Verona, città renitente ad accettare l’autorità vene-ziana, deve sottostare allo ius belli; tuttavia la Serenissima, ogniqualvolta è pos-sibile, preferisce ricorrere alla libera deditio delle comunità di Terraferma, ben-ché spesso la spontaneità di queste dedizioni sia proclamata nei documenti manon sia del tutto reale12.
Altrove è particolarmente violenta la sottomissione di Pisa da parte diFirenze, seguita poi da una dominazione molto vessatoria, con una grandeespansione della proprietà terriera fiorentina nel contado pisano e una deca-denza secca della città: non per nulla Pisa nel 1494, durante la spedizione diCarlo VIII, si ribellerà e tornerà a sottomettersi solo nel 1509, dopo un’accani-ta resistenza13. Un altro caso emblematico è quello di Pistoia. Già alla fine delXIII secolo ha dovuto accettare una «balìa» di Firenze, cioè il controllo da partedi quest’ultima delle sue strutture amministrative; nel 1331 è stata costretta adaccogliere un «capitano di custodia» e una guarnigione fiorentina; a più ripreseha avuto un podestà fiorentino. In cambio si è garantita un certo rispetto dellesue prerogative; ma nel 1401 in città si sviluppa un partito filovisconteo, il cheper i fiorentini – in un momento per loro critico – equivale a un tradimento.
Pistoia, sotto la minaccia delle armi e del saccheggio, è costretta a sottomet-tersi in maniera assai più netta e ad accettare di essere inglobata nel territorio econtado di Firenze (i suoi cittadini, scrive il cronista Giovanni Sercambi, sono«facti di contado»)14. Quest’ultima riformerà pesantemente gli statuti comuna-li pistoiesi, cambiando persino la denominazione delle magistrature municipa-li; sottrarrà alla città il suo comitatus; la sfrutterà fiscalmente (costringendola alversamento di tributi annuali fissati nei capitoli di sottomissione e imponendo-le l’acquisto di un certo quantitativo di sale); metterà a suo carico i costi delladominazione (a cominciare dal salario del Capitano inviato dalla Dominante);
60
11 M. E. MALLETT, La conquista della Terraferma cit., pp. 186-188.12 A. VIGGIANO, Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello Stato vene-
to della prima età moderna, Treviso, Fondazione Benetton, 1993, p. 26.13 M. PALMIERI, La presa di Pisa a cura di A. MITA FERRARO, Bologna, Il Mulino, 1995; M. LUZZATI, Firenze
e l’area toscana, in Comuni e signorie nell’Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Torino,Utet, 1987 (Storia d’Italia diretta da G. GALASSO, vol. VII/1), pp. 563-828 (in particolare pp. 705, 730-732,778-779).
14 G. CHITTOLINI, La formazione dello Stato regionale cit., p. 329.
Capitolo 4
lascerà sussistere al suo interno una certa divisione tra le due vecchie fazioni deiPanciatichi e dei Cancellieri, con la presenza di due corrispondenti «borse» dacui estrarre i nomi degli amministratori civici; e infine, nel quadro di un glo-bale impoverimento della città, favorirà la concentrazione delle ricchezze inpoche decine di famiglie patrizie a scapito del ceto medio artigiano e produtti-vo15. Chi ha una qualche dimestichezza con la storia di Savona, non faticherà atrovare in tutto ciò parecchie analogie con le vicissitudini della città ligure: ana-logie che riguardano inoltre sia la mentalità collettiva, perché anche a Pistoiadurerà a lungo il rimpianto per la fine dell’autonomia comunale, sia la storio-grafia locale, perché anche qui fino ai giorni nostri resterà saldo il pregiudizioche non valga la pena di studiare «il periodo successivo alla perdita della libertàquando la città venne ridotta a “sobborgo fiorentino”»16.
Forme di sottomissione violenta delle comunità vengono praticate anche, eforse più, dagli Stati di origini non cittadine. Nello Stato Pontificio, costellatodi città grandi e medie specie nelle aree emiliano-romagnola, umbra e marchi-giana, il “recupero” di alcuni importanti centri, per lo più retti da signori, avvie-ne tramite l’annientamento cruento delle signorie locali. Così avviene sottoEugenio IV, o meglio sotto il cardinale Giovanni Vitelleschi suo Vicario, per leterre del Lazio dove «devastazioni orrende accompagnarono queste operazioni»e «borgate e città furono rase al suolo»17. Così accade soprattutto sotto GiulioII, il quale nel 1506, proprio mentre si atteggia a protettore dell’indipendenzasavonese, sottomette con estrema violenza Perugia e Bologna18: contro la primadelle due città, ribellatasi nel 1540 per non pagare l’imposta sul sale, Paolo IIIlancerà un esercito di 10.000 uomini – italiani, spagnoli e lanzichenecchi – e lacostringerà di nuovo all’obbedienza19.
Nel Regno di Napoli all’Aquila, giudicata colpevole di aver aperto le porteall’esercito francese, nel 1529 viene ridotta drasticamente l’autonomia e le vienesottratto tutto il contado, che passa sotto la giurisdizione baronale20. Anchefuori d’Italia il destino delle città che hanno usato la loro libertas per nuocere aun potere superiore può essere molto duro: in Francia e in Inghilterra i sovranihanno spesso la mano pesante nei confronti di alcune comunità ribelli, benchéi loro interventi abbiano di solito carattere transitorio. Ma può verificarsi uncaso estremo come quello di Arras, incorsa nelle ire di re Luigi XI, il quale trail 1479 e il 1484 ne deporta la popolazione, la ripopola di altri abitanti, e vor-rebbe addirittura cambiarle il nome per cancellarne la memoria. Infine recede
61
15 F. NERI, Società ed istituzioni: dalla perdita dell’autonomia comunale a Cosimo I, in Storia di Pistoia, vol.III, Dalla metà del XIV alla fine del XVIII secolo a cura di G. PINTO, Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 1-80 (inparticolare pp. 1-34).
16 Si veda la Premessa di Giuliano Pinto nello stesso volume, alle pp. V-IX.17 L. SALVATORELLI, Sommario della storia d’Italia dai tempi preistorici ai nostri giorni, Torino, Einaudi, 1969,
p. 259; L. VON PASTOR, Storia dei papi dalla fine del medio evo, Roma, Desclée & C., 1942, vol. I, pp. 301-304.18 L. VON PASTOR, Storia dei papi cit., vol. III, pp. 703-720.19 L. VON PASTOR, Storia dei papi cit., vol. V, pp. 216-220. 20 M. BERENGO, L’Europa delle città cit., p. 139.
Comparazioni
dai propositi più estremi, ma ormai l’economia di una città fiorente è stata scar-dinata per sempre21.
La violenza esplicita è tuttavia uno strumento cui in molti casi città domi-nanti e monarchie non hanno bisogno di ricorrere. Nello Stato Pontificio unamiriade di centri grandi e piccoli si sottomettono a Roma mediante patteggia-menti22. Nella Terraferma veneta la classe dirigente di Vicenza, datasi sponta-neamente a Venezia e mantenutasi poi fedele alla Serenissima anche nei dram-matici momenti seguiti alla disfatta di Agnadello, otterrà in cambio autonomiae privilegi che solo nel lungo periodo verranno parzialmente erosi23. Brescia eBergamo, città di frontiera, barattano la loro sottomissione a Venezia con gran-di libertates e garanzie, al punto che nel loro territorio resterà vietata ogni pene-trazione della proprietà fondiaria veneziana24. In linea di massima Venezia con-sacra in Terraferma lo status quo che ha preceduto la conquista e resta vincolataai pacta, alle capitolazioni. Anzi, tende a legittimare il suo potere mostrando cheesso discende dalla libera volontà delle popolazioni locali, dalle loro suppliche«spontaneamente presentate» (per ottenere protezione, per liberarsi da untiranno) e «graziosamente accolte», al punto che la «gioiosa sottomissione» deisudditi di Terraferma diventerà un elemento del mito di Venezia e del suo otti-mo governo25. D’altronde tanto nel Veneto quanto in Toscana – a differenza diquanto accade in Liguria – i governi delle Dominanti si trovano di fronte amolte città popolose, ricche, dotate di antiche istituzioni e di una solida nobiltà:scendere a patti con i corpi locali, garantirsi con larghe concessioni la fedeltà deiloro ceti dirigenti, è quindi un imperativo irrinunciabile, anche quando la con-quista è stata meno pacifica di quanto si vorrebbe far credere.
Che sia stata violenta o pacifica, tuttavia, la sottomissione ha spesso conse-guenze negative per la città che ha dovuto piegarsi all’autorità di un principe odi una Dominante. Nella Terraferma veneziana fra Quattro e Cinquecento imaggiori centri urbani subiscono tutti un ripiegamento, una sclerosi del lorocorpo sociale con la formazione – favorita da Venezia per i propri interessi – dioligarchie rigide26; devono accollarsi «i salari dei funzionari veneziani, […] lamanutenzione delle fortificazioni e il costo delle guarnigioni», oltre a doverpagare un’imposta diretta destinata alle spese militari e assoggettarsi al mono-polio del sale27; sono spesso interessati da fenomeni di vera e propria decaden-
62
21 Ivi, pp. 98-99.22 B. G. ZENOBI, Le “ben regolate città”. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna,
Roma, Bulzoni, 1994, pp. 19-35.23 J. S. GRUBB, Comune privilegiato e comune dei privilegiati, in Storia di Vicenza, vol. III/1, L’età della
Repubblica veneta (1404-1797) a cura di F. BARBIERI E P. PRETO, Vicenza, Neri Pozza, 1989, pp. 45-65; S.ZAMPERETTI, Poteri locali e governo centrale in una città suddita d’antico regime dal dopo Cambrai al primoSeicento, ivi, pp. 67-113.
24 M. BERENGO, L’Europa delle città cit., pp. 142-143.25 Ivi, p. 143; M. MALLETT, La conquista della Terraferma cit., p. 218; A. VIGGIANO, Il Dominio da terra:
politica e istituzioni, in Storia di Venezia cit., vol. IV, pp. 529-575 (in particolare pp. 535-537).26 È la tesi sostenuta nell’ormai classico libro di A. VENTURA, Nobiltà e popolo nella società veneta del ‘400 e
‘500, Bari, Laterza, 1964.27 M. MALLETT, La conquista della Terraferma cit., p. 231.
Capitolo 4
za economica28; vedono in molti casi – come si è già ricordato – le migliori terredei loro contadi acquistate dai patrizi della Dominante: il caso limite è quellodi Treviso, che all’inizio del Seicento sarà ormai «desolata et quasi totalmentepriva di habitanti»29.
Analoga la situazione della Toscana, con il lungo declino di tutte le città sog-gette e il congelamento dei loro ceti dirigenti: si è detto di Pistoia, ma un qua-dro non meno negativo va tracciato per Pisa, o per Siena, città che dalla con-quista fiorentina verrà come “imbalsamata”, ciò che ne ha mantenuta intattafino ad oggi la fisionomia tardomedievale per la gioia dei turisti, ma che forsenon ha giovato agli interessi economici dei senesi nel Sei-Settecento. Qui soloLivorno, new town voluta dai granduchi, ha conosciuto un vero sviluppo nelcorso dell’età moderna, ma anche la sua dinamica presenza ha contribuito adeprimere altri centri, cui sono state sottratte quote e opportunità di mercato.
Nel ducato di Milano il destino delle città suddite segue percorsi analoghi:Pavia, che pure dopo la conquista a metà Trecento da parte dei Visconti ha rice-vuto grandi attenzioni ed è divenuta un centro artistico e culturale di notevoleimportanza, si avvia sotto gli Sforza a una decadenza che diverrà più marcatacon le guerre d’Italia e con la dominazione spagnola, ed entrerà nel Seicento inuna lunga spirale di crisi, tanto che «gli storici han finito localmente con qual-che ragione per avallare l’immagine di una città immersa in un lungo letargo»,da cui non la risveglierà neppure l’età delle riforme30. Cremona, ancora a metàdel Cinquecento, è forse dopo Milano la città più ricca della Lombardia, pienadi mercanti e di manifatture, eppure sul finire di quel secolo la sua decadenza«assumerà un ritmo sempre più rapido fino a diventare, con la peste del 1630,vero e proprio disastro […] da cui essa non doveva mai più risollevarsi»31.
In Piemonte, dove l’iniziativa di conquista territoriale parte da un principe enon da una città, le cose vanno anche peggio: la dinastia regnante, pur ricor-rendo anch’essa in molti casi a forme di dedizione e patteggiamento per assog-gettare le città, nel 1430 – con la promulgazione degli Statuti della Savoia daparte del duca Amedeo VIII – porta un attacco globale alle prerogative e ai pri-vilegi dei comuni32; e via via la fioritura urbana del basso medioevo si spegnecon l’avanzare del potere dei Savoia e con l’incremento che essi imprimono aTorino – una vera capitale, non una dominante. Torino sviluppa, crescendo, «lasua forza anemizzatrice sul territorio circostante», e ciò avverrà soprattutto nelSeicento, quanto essa «profitta della crisi generale del secolo per affermarsi, ulti-
63
28 M. KNAPTON, Tra Dominante e Dominio (1517-1630), in G. COZZI-M. KNAPTON-G. SCARABELLO, LaRepubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino, Utet, 1992 (Storia d’Italiadiretta da G. GALASSO, vol. XII/2), pp. 201-549 (in particolare pp. 447-465).
29 E. BRUNETTA, Treviso in età moderna cit., pp. 97-98.30 G. GUDERZO, Pavia “moderna” fra immagine tramandata e realtà fattuale, in Storia di Pavia, vol. IV, L’età
spagnola e austriaca, t. I, Milano, Banca del Monte di Lombardia, 1995, pp. 9-24.31 G. POLITI, La società cremonese nella prima età spagnola, Milano, Unicopli, 2002, pp. 5-6.32 A. M. NADA PATRONE, Il Piemonte medievale, in A. M. NADA PATRONE-G. AIRALDI, Comuni e signorie
cit., pp. 1-362, in particolare pp. 65-86 e 108-112.
Comparazioni
ma arrivata, come grande città […] a scapito della precedente organizzazioneurbana piemontese»33.
La formazione degli Stati regionali, con la conseguente perdita di libertà daparte di tante città, si è presentata a un certo momento come un processo ine-vitabile e inarrestabile. Ciò, naturalmente, non significa che sia stato sempre unfenomeno positivo, a meno di non credere hegelianamente a una superiorerazionalità del divenire storico. È vero tuttavia che gli ordinamenti politici sca-turiti da quel processo sono costruzioni robuste, destinate a durare a lungo, inpratica sino alla fine del Settecento e alle guerre napoleoniche, e a conferire allapenisola un assetto stabile, che garantisce anche lunghi periodi di pace esternae interna. Non è difficile sostenere, perciò, che il prezzo pagato da molti vecchiprotagonisti della scena politica italiana – i liberi comuni, le respublicae cittadi-ne, le piccole signorie – non è stato vano, che la pacificazione di un universocaotico, turbolento, violento come quello dell’Italia tardomedievale e rinasci-mentale ha rappresentato un risultato da non disprezzare34. C’è stata anzi unalunga stagione storiografica in cui i fenomeni dell’accentramento statale sonostati generalmente considerati come fattori di progresso: prima perché si è rite-nuto che la semplificazione della carta politica andasse comunque in direzionedi quell’unità d’Italia che era considerata il fine di tutta la storia nazionale; poiperché si è pensato che in quell’accentramento si realizzasse la prima forma delcosiddetto «Stato moderno».
Viceversa non è mancato chi dello stesso processo ha dato una lettura forte-mente critica, ravvisando nella formazione dei maggiori Stati rinascimentalisoprattutto una grave crisi della “libertà” italiana. Un grande storico comeMarino Berengo ha insistito a lungo su questo concetto: quando le città italia-ne vengono via via inghiottite da altre maggiori, o da governi principeschi, o daidominatori spagnoli, ciò che esse perdono non è tanto una forma di indipen-denza, quanto il loro «governo largo», le loro istituzioni civiche. Un tipo digoverno che aveva i suoi limiti, non era certo democratico nel senso che oggidiamo a questo termine, anzi si prestava spesso a soluzioni oligarchiche o signo-rili; «ma sino a quando esso è riuscito a conservarsi, ha assicurato la partecipa-zione dei cittadini alla vita pubblica in una misura così larga e continuata qualeè impossibile riscontrare altrove. […] Il numero […] dei cittadini che han sedu-to nei Consigli o han ricoperto magistrature che da essi derivavano […] è statoaltissimo: tra il 10 e il 20% degli uomini validi di una città italiana».
Successivamente gli Stati regionali hanno disperso, di fatto e spesso inten-zionalmente, questo patrimonio civile, cosicché la «crisi di libertà» ha coincisocon il declino «di quella civiltà urbana in cui le forme repubblicane di governo
64
33 G. LEVI, Come Torino soffocò il Piemonte, in ID., Centro e periferia di uno Stato moderno, Torino, Rosenberg& Sellier, 1985, pp. 11-69.
34 Sul «senso di “stabilità” e tranquillità che sembra spirare in quegli anni sulla penisola, sulla sua vita poli-tica, sulle sue istituzioni» insiste ad esempio M. VERGA, Le istituzioni politiche, in Storia degli antichi Stati ita-liani a cura di G. GRECO e M. ROSA, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 3-58 (la frase citata è a p. 4).
Capitolo 4
più avevan avuto presa», e ha investito le città italiane «nei loro aspetti politici,demografici ed economici, modificandone nello spazio di pochi decenni unafisionomia sociale che si era venuta costituendo attraverso un secolare proces-so». Nel Settecento, quando nella penisola si cercherà di avviare una politica diriforme e di progresso, si dovrà constatare che «due secoli di assenteismo poli-tico avevano atrofizzato quasi tutti gli strati della società italiana e, in modo piùdurevole, quelli che non beneficiavano di una cultura d’élite»35.
Un’evoluzione (o involuzione) in qualche misura obbligata, con i suoi risvol-ti positivi e negativi: sono questi i parametri entro cui vanno situate anche lavicenda statuale genovese e la “catastrofe” di Savona. Avvertendo tuttavia che,come è ovvio, il destino delle città assoggettate non è stato uguale per tutte, anziha fluttuato entro margini piuttosto ampi, dipendenti sia dalla condotta dei sin-goli governi, sia da diversi fattori. L’importanza e il peso complessivo delle cittàsoggette hanno lasciato ai governi centrali margini di manovra più ristretti làdove – in Toscana, nello Stato Pontificio o nella Terraferma veneziana – essihanno dovuto fronteggiare un Dominio ricco e composito; mentre in un casocome quello del Genovesato la sproporzione tra la relativa povertà del Dominioda un lato, la ricchezza e la potenza della Dominante dall’altro, hanno conces-so a quest’ultima un maggiore arbitrio.
Un ruolo importante lo hanno giocato – e lo vedremo bene proprio a pro-posito di Savona – le esigenze di natura strategica: negli Stati sabaudi, ad esem-pio, Cuneo viene trasformata in una città-fortezza (un destino che più tardi toc-cherà anche ad Alessandria e a Casale), e ciò ha evidenti ripercussioni sulla fisio-nomia urbana e sulle sue possibilità di sviluppo36; nel Veneto, dopo la crisi diAgnadello, Treviso diventa l’estremo baluardo difensivo della Repubblica, unapiazzaforte all’interno della quale vengono murate non soltanto le case, «bensìanche gli uomini, le intraprese e le idee», il che ben presto ne esaurisce ogni vita-lità commerciale e produttiva37.
Determinanti sono poi i condizionamenti dell’economia: Genova nel suosviluppo economico e statuale ha mirato a subordinare o addirittura a cancella-re gli scali liguri potenzialmente rivali38; viceversa Venezia è da sempre l’unicogrande emporio marittimo del Veneto, nessun centro vicino – almeno fino alsettecentesco sviluppo di Trieste – può farle ombra da questo punto di vista, lecittà del suo Dominio hanno vocazioni molto diverse che non entrano in con-flitto con le sue. Così Verona, che pure ha subito anch’essa dopo Agnadello
65
35 M. BERENGO, Il Cinquecento, in La storiografia italiana negli ultimi vent’anni, Milano, Marzorati, 1970,vol. I, pp. 483-518 (in particolare pp. 484-485); ID., Stato moderno e corpi intermedi, in Origini dello Stato cit.,pp. 633-638.
36 P. BIANCHI-A. MERLOTTI, Cuneo in età moderna. Città e Stato nel Piemonte d’antico regime, Milano, F.Angeli, 2002, pp. 319-333.
37 E. BRUNETTA, Treviso in età moderna cit., pp. 50-59.38 R. PAVONI, Liguria medievale cit., pp. 251-254; G. ASSERETO, Porti e scali minori della Repubblica di
Genova in età moderna, in Il sistema portuale della Repubblica di Genova. Profili organizzativi e politica gestiona-le (secc. XII-XVIII) a cura di G. DORIA e P. MASSA PIERGIOVANNI, ASLSP, vol. CII, 1988, fasc. I, pp. 223-258(in particolare pp. 223-228).
Comparazioni
pesanti interventi di fortificazione, trova ugualmente un certo slancio entro l’e-conomia della Repubblica fruendo della sua felice posizione commerciale edella ricca agricoltura del suo territorio, vede aumentare nel corso delCinquecento e ancora per tutto il Seicento la sua popolazione, conosce formedi fattiva collaborazione e comunanza di interessi fra il suo ceto dirigente e ilgoverno della Serenissima39. E più in generale possiamo ricordare come i citta-dini veneziani, patrizi e borghesi, specie a partire dal Seicento investano note-voli capitali nelle manifatture della Terraferma, promuovendo lo sviluppo dinumerosi settori produttivi in stretto interscambio con la Dominante40.
Altrove Como e Vigevano, nel corso dell’età moderna, sviluppano manifat-ture tessili di un certo rilievo; mentre Pavia, pur conoscendo il complessivoripiegamento di cui si è detto, si ritaglia entro il ducato di Milano uno spazioeconomico complementare a quello della capitale – sia come città di servizi,“terziarizzata” diremmo oggi, sia come centro agricolo – di modo che la suadecadenza si arresta a un livello accettabile, con significativi recuperi demogra-fici tra metà Cinquecento e inizio Settecento41. Proprio a proposito di Pavia, sipuò ricordare un’ultima variabile che può influire sul destino di una città sog-getta, vale a dire la presenza in essa un’università: Pavia appunto, ma anche epiù Pisa, Bologna e Padova, grazie ai loro atenei, all’importanza culturale che nederiva, alla numerosa popolazione studentesca che gravita intorno ad essi, all’e-sistenza di collegi e strutture di sostegno allo Studium, godono di un indiscus-so prestigio e di notevoli opportunità economiche.
Nella casistica qui brevemente richiamata, una città come Savona non occu-pa certamente una posizione di particolare favore, da qualunque parte si pren-da in considerazione il problema dei rapporti con la sua Dominante. Da que-sta globale situazione di svantaggio bisogna dunque partire nel considerare lanatura di tali rapporti, come cercheremo di fare nei capitoli seguenti.
66
39 V. CHILESE, Una città nel Seicento veneto. Verona attraverso le fonti fiscali del 1653, Verona, Accademia diagricoltura scienze e lettere di Verona, 2002, pp. 3-13 e 130-131.
40 I. MATTOZZI, Intraprese produttive in Terraferma, in Storia di Venezia cit., vol. VII, La Venezia barocca acura di G. BENZONI e G. COZZI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 435-478.
41 G. GUDERZO, Pavia “moderna” cit.; e, nel medesimo vol. IV della Storia di Pavia, si vedano i saggi diD. ZANETTI, La popolazione dal XII al XVIII secolo (pp. 111-159) e di G. VIGO, L’economia urbana dall’av-vento della Spagna al tramonto dell’ancien régime (pp. 201-285).
Capitolo 4
La formazione degli Stati regionali italiani, come abbiamo visto, ha compor-tato la riduzione di quasi tutti gli antichi comuni al rango di città suddite di unadominante o di un principe, i quali rivendicano nei loro confronti ampie pre-rogative di sovranità e soprattutto poteri di intervento in materie quali la legi-slazione, l’amministrazione della giustizia, il fisco, gli apparati militari, le isti-tuzioni ecclesiastiche. Alcune di queste città hanno subito la perdita delle lorolibertates con rassegnazione, altre l’hanno vissuta in un modo drammatico, cheha lasciato inevitabili tracce di rancore o forti nostalgie per un passato via viaidealizzato. Ma in un caso e nell’altro il costituirsi delle più vaste formazionipolitiche «non ha significato il “tramonto della città” di fronte al “sorgere delloStato”»; semmai «si è determinata, fra governo regionale e città, una sorta didivisione, e complementarità, di funzioni»: le decisioni di politica generale spet-tano ovviamente al primo, ma la seconda conserva notevoli margini di autono-mia e le sue magistrature non sono semplici corpi amministrativi, ma organi-smi dotati di poteri propri, capaci di organizzare la vita pubblica delle popola-zioni locali, spesso su un’area che si estende ben oltre le mura cittadine1.
Come ha scritto uno dei più acuti studiosi della materia, «lo Stato post-cit-tadino tende a conservare l’identità originaria degli enti che ha fagocitato», per-ciò «il particolarismo non è elemento residuale ma “sostanza” dell’edificio poli-tico»; è un mondo in cui «i poteri locali non sono stati sacrificati affatto sull’al-tare della statalizzazione, ma piuttosto si sono rafforzati con essa, trovando nellacollaborazione col principe una nuova, potente forma di legittimazione»2.Qualcosa di analogo è avvenuto, un po’ dappertutto, alle antiche aristocraziefeudali, che si sono fatte assorbire e disciplinare dal potere statale perdendoparte della loro anarchica indipendenza, ma ricevendone in cambio sicurezza,onori, carriere3.
Nel corso dell’età moderna neppure le grandi monarchie “nazionali” come laFrancia e la Spagna sono riuscite a governare direttamente i loro territori, mahanno dovuto appoggiarsi su una rete di corpi locali – città, comunità, feudi,signorie – che esercitano, essi sì, il controllo immediato sugli uomini e sullecose, salvo poi riconoscere una superiore potestas dello Stato; a maggior ragioneciò avviene nelle repubbliche e nei principati italiani, organismi più deboli e piùpiccoli, formati da costellazioni di città con una lunga tradizione di autogover-
67
1 G. CHITTOLINI, Città, comunità e feudi cit., pp. 27-32 (e l’ampia bibliografia ivi citata).2 L. MANNORI, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei
Medici (secc. XVI-XVIII), Milano, Giuffré, 1994, p. 55; ID., Introduzione a Comunità e poteri centrali negli anti-chi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi a cura di ID., Napoli, CUEN, 1997, pp. 7-42.
3 P. ANDERSON, Lo Stato assoluto, Milano, Mondadori, 1980, pp. 19-21; J. DEWALD, La nobiltà europea inetà moderna, Torino, Einaudi, 2001, pp. 139-140 e passim.
Capitolo 5
Sottomissione, autonomia, consenso
no. In tutta l’Europa, fra XV e XVIII secolo, l’equilibrio fra centro e periferia èdunque di solito sbilanciato a favore della seconda, anche se durante quel perio-do si manifestano un po’ dappertutto tendenze all’accentramento dei poteri,che restano peraltro ben al di qua del modello di Stato centralistico incarnatoper la prima volta dalla Francia napoleonica ed esteso via via a quasi tutto il con-tinente nel corso dell’Ottocento. Tanto più è sbilanciato, quell’equilibrio, nellaRepubblica genovese, la quale è giunta tardi e faticosamente a darsi una strut-tura territoriale analoga a quella dello Stato fiorentino o di quello veneziano4.
La dialettica tra il potere centrale e i corpi territoriali – in particolare le cittàsuddite – può variare, oscillando entro una fascia piuttosto ampia. Per valuta-re il grado di soggezione o di autonomia di una città suddita nei confronti dellaDominante ci sono vari parametri: il rispetto più o meno rigoroso degli statutilocali, l’entità e le forme del prelievo fiscale, le leggi (locali o centrali) in basealle quali si amministra la giustizia, i giudici (anch’essi locali o centrali) che laamministrano. Bisogna inoltre considerare da dove promanino le normative inmateria di lavori pubblici, di annona, di luoghi pii, di corporazioni, di merca-ti, di sanità; quali siano le magistrature incaricate di farle rispettare; che poterie privilegi conservino i cittadini sugli abitanti dei territori circostanti – i “comi-tatini” – e l’estensione stessa del contado5.
Chi voglia comprendere la natura dei rapporti tra Savona e Genova nel corsodell’età moderna, è a questa complessa casistica che deve rifarsi, dimenticandodel tutto gli stereotipi della vecchia storiografia locale che stendeva su tre seco-li un giudizio uniformemente negativo, in cui tutto si riduceva a sfruttamento,prepotenza, fiscalismo, egoismo. Non per rovesciare tale giudizio, o per conce-dere un’assoluzione plenaria ai governanti genovesi, ma per sostituire a un pro-cesso sommario un’indagine un po’ più accurata, che miri ad accertare la veritàe a concedere, se è il caso, qualche attenuante. Questa indagine, tra l’altro, rive-ste un interesse che trascende la vicenda savonese in senso stretto: proprio per-ché la sottomissione è avvenuta in modo particolarmente violento e la città sot-tomessa ha costituito per Genova un serio pericolo (e ancora lo costituirà inseguito), quello di Savona rappresenta, nei rapporti centro-periferia in seno allaRepubblica, un caso limite, a proposito del quale ci si attenderebbe un control-lo strettissimo, esercitato nella maniera più diretta da parte del potere centrale.Analizzare le forme concrete in cui tale controllo si è realizzato significa, perciò,valutare fino a che punto in uno Stato come quello genovese può davvero spin-gersi l’autorità del governo nei confronti del proprio Dominio.
Già abbiamo visto che quando, a partire dal 1523, si giunge alla stretta deci-siva, da parte genovese viene emanata una sentenza in cui i savonesi vengono
68
4 Sui problemi del governo del territorio e dei rapporti centro-periferia nella Repubblica di Genova mi per-metto di rinviare ai saggi L’amministrazione del Dominio di terraferma e Comunità soggette e poteri centrali in G.ASSERETO, Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo, Savona, Elio FerrarisEditore, 1999, pp. 9-96.
5 Per un profilo molto chiaro dei rapporti tra poteri centrali e città subiectae si veda M. BERENGO, L’Europadelle città cit., pp. 39-110.
Capitolo 5
dichiarati «meri sudditi», privi di ogni privilegio e autonomia previsti dalle vec-chie convenzioni: sentenza mitigata nel nuovo accordo del 1526, il quale tutta-via prevede esplicitamente il ritorno alla condizione di totale sudditanza nelcaso di ribellione o comunque di mancato rispetto dei patti. È la clausola chegiustifica il duro intervento del 1528, e di cui troviamo eco in un decretumgenovese del 20 agosto 1529, nel quale si ribadisce che i savonesi hanno viola-to in ogni modo «fidem datam» e si sono ribellati «manu armata», quindi nonpossono più godere dei benefici contemplati dalle precedenti concessioni e ven-gono sottoposti in toto alla giurisdizione genovese6.
Tra le conseguenze pratiche c’è una decisa estensione dei poteri del Podestàgenovese: questi, nominato direttamente dal governo, oltre ad amministrarecome in passato la giustizia (unitamente al suo Vicario), assume un ampio pote-re di controllo sull’amministrazione civica. I magistrati cittadini potranno riu-nirsi solo in sua presenza, e senza di lui non si potrà procedere ad alcuna nomi-na o elezione, né ad alcun appalto di gabelle: una prassi che si ritrova in altrecircoscrizioni amministrative del Genovesato, e che corrisponde a quelle adot-tate nella Repubblica di Venezia – dove il «rettore» inviato dalla Dominantepresiede i consigli cittadini e sorveglia tutta la vita municipale – e nello Statofiorentino. Genova inoltre si riserva il diritto, per rifarsi delle spese sostenutedurante la conquista di Savona, di imporre alla città e al suo territorio qualsia-si onere o imposta personale, reale, patrimoniale; e stabilisce che il distrettosavonese d’ora in avanti avrà come confini il territorio di Albisola a est e quel-lo di Vado a ovest – in pratica, le dimensioni del comune attuale – e che su taliconfini verranno apposti «termini marmorei», a significare l’irrevocabilità delladecisione.
Decurtare i contadi, vale a dire sottrarre alle città soggette fasce più o menoampie di quel territorio che in passato esse avevano subordinato alla loro giuri-sdizione, è a quest’epoca una pratica abituale. «Nell’Italia di tradizione comu-nale, siamo destinati a incontrare molte amputazioni o addirittura soppressionidegli antichi contadi acquisiti da città che sono poi divenute suddite di unoStato pluricittadino», e ciò vale ancor più quando si tratti di punire una comu-nità ribelle. In generale, «la progressiva perdita di potere politico delle città suiterritori […] è una linea di tendenza assai diffusa e concomitante con la for-mazione degli Stati nazionali o regionali. […] La via dell’accentramento sovra-no ha trovato su questo terreno uno dei suoi tracciati d’elezione»7.
Nel caso di Savona non c’è dubbio che la riduzione sia estremamente drasti-ca, al punto che d’ora in poi alla sua giurisdizione resteranno soggetti solo bor-ghi e “ville”, ma nessuna vera comunità8. Va però ricordato – lo si è visto nel
69
6 Concessioni decreti et ordini della città di Savona cit., pp. 30-34.7 M. BERENGO, L’Europa delle città cit., pp. 104, 131, 138 (ma si vedano tutte le pp. 111-170).8 Sotto la giurisdizione di Savona verranno lasciate le ville di Legino e Lavagnola, Segno, Vezzi, la valle di
Vado e parte di Quiliano. Il 3 dicembre 1530 viene staccata dal territorio savonese anche la contrada deiBruciati, presso il confine con Albisola, e inserita nella podesteria di Varazze (ASS, Comune I, 210, libro III, cc.2-4).
Sottomissione, autonomia, consenso
capitolo 2 – che per la maggior parte l’espropriazione è avvenuta già a partiredal XIV secolo, allorché la podesteria di Varazze, voluta da Genova, ha costi-tuito «il “riparo” che blocca il distretto savonese in ambiti ristretti»9: quel cheora viene sottratto si riduce dunque alla perdita della giurisdizione su Vado eQuiliano, ma in quest’ultimo caso si tratta più che altro di definire de iure ciòche già era avvenuto de facto. I quilianesi sono da tempo in rivolta controSavona, e fin dal 1519 sono riusciti a liberarsi completamente della soggezionenei confronti di questo Comune, rifugiandosi sotto l’interessata protezione deigenovesi che nella zona hanno esteso i loro possessi feudali e allodiali: «l’interavallata quilianese si presentava nel 1528 come un vero e proprio distretto geno-vese, anche se privo per il momento di un proprio particolare ordinamento»10.Il Senato, consapevole che il contenzioso riguarda soprattutto lo sfruttamentodelle risorse boschive, nel 1531 fissa tra le due comunità confini precisi propriorelativamente ai diritti sui boschi; e nel 1537 stabilisce che una parte diQuiliano, quella che successivamente si definirà «poder di Savona», resticomunque sotto la giurisdizione di quest’ultima, anche se si tratterà di una giu-risdizione solo nominale, perché in pratica il Podestà di Quiliano sarà un sem-plice Vicario di quello – genovese – di Savona e, nelle lunghe controversie chefino alla caduta della Repubblica si agitano tra le due comunità, il Senato tute-lerà soprattutto gli interessi quilianesi11. Resta però il fatto che, a differenza dialtre città italiane per le quali la sottomissione ha coinciso con la perdita dipoteri su un vasto territorio, il colpo subito da Savona è tutto sommato mode-sto.
Il decreto del 1529, pur contenendo le disposizioni sfavorevoli di cui si èdetto, acconsente tuttavia «de gratia speciali» che nella città e territorio diSavona la giustizia venga amministrata, «tam in procedendo quam in iudican-do», secondo i vecchi statuti locali, anche se la Repubblica si riserva l’«arbi-trium» di confermare, abrogare o rivedere gli statuti stessi. È un punto di fon-damentale importanza, perché il primo strumento che ci consente di capirequanta autonomia sia rimasta a una città è appunto la presenza o meno di sta-tuti propri, nonché l’effettivo rispetto di tali «carte di comune». Ed è tanto piùrivelante se guardiamo alla formazione dello Stato genovese, nel quale fin dalXII secolo è esistita una linea di demarcazione fra due diverse realtà territoriali:un’area più ristretta, il districtus vero e proprio, «di giurisdizione effettiva e disubordinazione immediata al governo»; e una più ampia – che a partire dal XIIIsecolo si definisce nella formula «a Corvo usque Monachum», cioè fra i dueestremi delle Riviere liguri – su cui il Commune Ianue pretende di far valere unapropria sovranità, ma nella quale deve fare i conti sia con altre civitates e i lororispettivi distretti, sia con insediamenti signorili12.
70
9 R. SAVELLI ( a cura di), Repertorio degli statuti cit., pp. 81-82.10 G. MALANDRA, Storia di Quiliano cit., pp. 161-163.11 Ivi, pp. 164-172.12 R. SAVELLI (a cura di), Repertorio degli statuti cit., pp. 78-80.
Capitolo 5
Nella prima zona non c’è produzione statutaria da parte delle singole comu-nità, ma si usano i capitula genovesi; nella seconda (a levante oltre Zoagli, masoprattutto a ponente) ci sono città, in primis Albenga e Savona, che hanno sta-tuti propri e con essi continuano a reggersi, pur accettando patti di subordina-zione. Genova cerca progressivamente di ingerirsi nelle altrui legislazioni e di farvalere almeno in parte la propria; ma, per quanto riguarda gli statuti savonesi,nella redazione del 1345 si precisa che il Podestà genovese vi amministrerà lagiustizia secondo i capitula locali, e nei casi non contemplati da questi secondoil diritto comune, prescindendo quindi dalla normativa statutaria della cittàmaggiore; inoltre, a differenza di quanto avviene per altre città liguri, Savonanon è tenuta a inviare periodicamente gli statuti a Genova perché siano appro-vati o sottoposti a eventuale revisione13. Ancora nella convenzione del 1526 siconcede che la giustizia sia amministrata «secundum capitula et ordinamentaSaone, tam condita quam condenda», lasciando quindi che la città minore nonsolo obbedisca alle proprie leggi, ma conservi anche piena facoltà legislativanelle cose che la riguardano14.
Solo nel 1529, come s’è detto, viene introdotto il diritto di revisione da partedella Dominante, e infatti nel 1539 alcune modifiche ai capitoli criminali diSavona (vale a dire il complesso delle sue leggi penali) saranno per la prima voltaapprovate dal Senato, dopo essere state rivedute e corrette da due autorevoli giu-risti genovesi15. Questo maggior potere, tuttavia, resta ben al di qua di quantoci si aspetterebbe – cioè la pura e semplice estensione a Savona delle leggi geno-vesi e la sua piena inclusione nel districtus della Dominante – visti i fieri pro-positi manifestati da alcuni uomini di governo che avrebbero voluto trattare lacittà sottomessa come una novella Cartagine.
La pratica di governo negli anni successivi al 1528 ribadisce più volte questoatteggiamento di rispetto. Nel 1530 il Senato ordina al Podestà di Savona chein tutte le cause riguardanti gli appalti delle gabelle e il contenzioso fra i mem-bri delle «arti» siano gli Anziani – cioè la principale magistratura della città – adagire quali giudici di prima istanza, restando al Podestà stesso la competenza suiprocessi d’appello. Nel contempo dispone che tutte le gride e i proclami che sipubblicano a Savona siano emanati in nome degli Anziani, sia pure con licen-za del Podestà, ciò che in effetti avverrà da allora in poi, per di più con la pre-cisazione che le gride escono «in osservanza dei laudabili ordini» della città16.Nel 1537 i Supremi Sindicatori – una delle massime cariche della Repubblica– dispongono che il Podestà non interferisca negli atti degli «officiali» savonesi(vogliamo, essi scrivono, che «non vi impacciate né prohibiate la giurisditioneet essecutione loro», ma tutt’al più «quando negligenti fossero li riscaldiate»),limitandosi a verificare che siano stati eletti in modo regolare17; così, ogni volta
71
13 Ivi, pp. 83-87 e 109-117.14 Concessioni decreti et ordini della città di Savona cit., p. 8 (il corsivo è nostro).15 R. SAVELLI (a cura di), Repertorio degli statuti cit., p. 163.16 Concessioni decreti et ordini della città di Savona cit., p. 35; ASS, Comune I, 202.17 Concessioni decreti et ordini della città di Savona cit., pp. 45-46.
Sottomissione, autonomia, consenso
che un Podestà parte per assumere il suo ufficio a Savona, il Senato gli ingiun-ge di non intromettersi nel «governo politico» della città18.
Se nel 1534, con un atto che certamente è dispiaciuto, sono state «abolite lemonete di Savona e l’uso di quelle», disponendo che tutti i prezzi e i contrattisiano riferiti «alla moneta e lira di Genova maggiore d’un terzo di quella diSavona»19, nel 1541 si concede ai savonesi la facoltà di usare le misure localiper i grani che arrivano in città da terra o dal mare, cosa molto gradita perchénelle contrattazioni commerciali l’uso di unità proprie è sempre vantaggioso20.Nel 1556, quando a Genova vengono emanati i nuovi statuti criminali destinatia valere non solo per la Dominante ma per l’intero Dominio, Savona ne è esen-tata al pari di quelle civitates, come Albenga e Sarzana, che conservano una rela-tiva autonomia normativa; e lo stesso avviene con gli statuti civili del 1588,benché essi siano definiti ormai leggi di tutta la Repubblica21. D’altronde neglianni settanta del Cinquecento viene approvata una nuova redazione degli sta-tuti criminali savonesi in cui la gerarchia delle fonti è ancora quella tradiziona-le (valgono in primo luogo gli statuti stessi e, dove essi non soccorrono, il iuscommune), anche se la sostanza è cambiata: «fortissima ora è, infatti, l’influen-za degli statuti genovesi, dai quali molte parti sono state trasferite praticamen-te immodificate». Ma solo nel 1610, quando viene data alle stampe una colle-zione delle norme e degli ordini riguardanti Savona (che ora, significativamen-te, si chiamano concessioni e non più convenzioni), il Senato dispone in modoesplicito che in tutte le cause civili e criminali in cui «defficiunt statuta Saone»si dovrà ricorrere non al diritto comune, bensì a quelli di Genova22.
72
18 ASS, Comune I, 140, 2 maggio 1579; ASG, Senato-Senarega, 511.19 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 178. È bene ricordare, comunque, che qui si tratta di monete di
conto – le lire, appunto – mentre ovviamente le monete coniate continueranno a circolare ancora a lungo.20 Concessioni decreti et ordini della città di Savona cit., pp. 51-52. Il 23 ottobre 1606 verrà però emanato un
decreto che impone le mensurae Ianue per il vino e l’olio (ivi, pp. 173-175). Dopo diversi tentativi falliti (a par-tire dal 1586) di unificare in tutta la Liguria pesi e misure, i Procuratori a partire dal 1637 constatano per l’en-nesima volta che «li pesi e le misure diferiscono in più luoghi del Dominio di Terraferma da quelli che si costu-mano in Genova», affermano di volere «levar da mezzo quest’abuso» introducendo dappertutto quelli genove-si, dispongono inoltre «che ogn’anno si marchino […] alla presenza de’ giusdicenti de’ luoghi» (ASG, Archiviosegreto, 1654, 24 settembre 1637). Nei due anni successivi in effetti ci si muove in tal senso, e in particolare iCensori di Genova cercano di imporre anche a Savona l’uso dei pesi e misure genovesi, ma gli Anziani savone-si sostengono che conviene «prohibire ogni innovatione» perché «la mutatione e diminutione di misure e pesiriuscirebbe totalmente a danno del publico». La mina da grano di Genova, ad esempio è inferiore a quella diSavona (100 mine di Savona sono pari a 109 di Genova), quindi il grano – il cui prezzo è fissato sull’unità dipeso – si pagherebbe più caro, con danno dell’Ufficio di Abbondanza (la magistratura annonaria del Comune)e ripercussioni negative anche sul pagamento delle gabelle; inoltre crescerebbe la percentuale che i mugnai trat-tengono a loro favore sul grano macinato. La protesta degli Anziani otterrà di bloccare il provvedimento (ASS,Comune I, 210, libro III, c. 50); e anche più tardi, nel 1665, un tentativo di far pagare la gabella grano secon-do il peso di Genova verrà rintuzzato (ASS, Comune I, 214, 24 luglio 1665). Sull’importanza dell’uso di misu-re proprie si vedano le osservazioni di W. KULA, Le misure e gli uomini dall’antichità a oggi, Roma-Bari, Laterza,1987, pp. 17-22.
21 R. SAVELLI (a cura di), Repertorio degli statuti cit., pp. 142-146.22 Ivi, p. 164; Concessioni decreti et ordini della città di Savona cit., p. 226. In realtà già il 18 settembre 1600
il Senato decreta che in tutte le cause civili e criminali in cui «deficiunt statuta Savone» si faccia ricorso «ad legeset statuta Genue tam civilia quam criminalia» (ASS, Comune I, 210, libro II, c. 23v).
Capitolo 5
Per intaccare parzialmente l’autonomia normativa savonese, dunque, è dovu-to trascorrere quasi un secolo dalla “conquista”, e non si è trattato certo di unprovvedimento punitivo nei confronti della città ribelle; prova ne sia che nellostesso torno di tempo si giunge alla revisione degli statuti di Albenga e diSarzana, e si avviano procedure analoghe per altre comunità liguri. Ciò che allo-ra si realizza, insomma, non è un atto di “oppressione” o di “prepotenza” diGenova nei confronti di Savona, ma un passo nel processo di statalizzazione cheinteressa la Repubblica nel corso dell’età moderna. Un processo peraltro moltodebole: solo Sanremo, dopo la rivolta del 1753, vede drasticamente cancellatoil proprio statuto municipale e deve rifarsi a quello genovese. E sarà soltanto la“giacobina” Repubblica Ligure, nel 1797, che in attesa di darsi un nuovo codi-ce deciderà di estendere a tutto il proprio territorio gli statuti di Genova23.
La limitata ingerenza di Genova negli affari interni di Savona non è frutto dibenevolenza, o di rispetto della regola romana secondo cui bisogna parceresubiectis, bensì di considerazioni realistiche. Più ancora di altri governi coevi,quello genovese per reggere una città deve lasciare che questa in larga misuraregga se stessa, salva l’obbedienza verso il potere centrale su alcune materie rite-nute imprescindibili. «Uno dei fondamenti della longevità dell’amministrazio-ne patrizia genovese – è stato scritto con lucidità – fu, anzi, l’attribuzione ainotabilati locali di una buona misura di controllo sugli affari comunitari: ciòche faceva del governo metropolitano più l’arbitro che il controllore dei conflittilocali»24. Dopo il 1528 gli ordinamenti municipali di Savona continuano auniformarsi a quanto stabilito negli statuti del 1458, e – almeno dal punto divista istituzionale – la nuova sudditanza non differisce granché da quelle che nelpassato avevano riguardato il ducato di Milano, il Regno di Francia o lo stessoComune di Genova.
Nel 1572 la città avrà, approvati anch’essi da Genova, nuovi statuti politiciche subiranno lievi modifiche negli anni immediatamente successivi e verrannoinfine pubblicati in lingua volgare nel 161025: ma anche questi modificanopoco il quadro quattrocentesco, a parte qualche riduzione di organico.Analogamente al passato (e a quanto avviene all’epoca negli altri contesti urba-ni, in Italia e fuori d’Italia), la nomina a tutte le cariche si effettua attraverso unsistema misto di sorteggio e di elezione, in questo caso partendo da tre «bus-soli» o urne nelle quali sono contenuti i nomi dei cittadini di pieno diritto, sud-divisi nei tre «ordini» dei nobili, dei mercanti e degli «artisti» o artigiani. Di lìsi traggono, a rotazione continua, i componenti del Consiglio grande (21 nobi-li, 12 mercanti, 18 artisti), cui spettano deliberazioni di carattere generale; gli
73
23 R. SAVELLI (a cura di), Repertorio degli statuti cit., pp. XIV e 164-173.24 C. BITOSSI, Il governo genovese cit., p. 78.25 Statuti politici della città di Savona, con le sue rifforme e addittioni rimesse a suo luogo, tradotti in lingua vol-
gare, Genova, Giuseppe Pavoni, 1610. Il testo corrisponde a quello degli Statuta politica et civilia 1572-1592in ASS, Comune I, 9. Gli Statuti politici, al pari di quelli criminali, resteranno poi soggetti all’approvazione delSenato genovese ogni 10 anni.
Sottomissione, autonomia, consenso
Anziani (tre nobili, due mercanti e due artisti), l’organo più autorevole delComune con compiti esecutivi ma anche deliberativi e giudiziari; i MaestriRazionali (due nobili, un mercante e un artista) con competenze di caratterefinanziario e contabile; e tutte le altre magistrature: gli amministratori dellevarie opere pie; il Magistrato di Vie e Darsena; i numerosi uffici di carattereannonario e fiscale; i censori per il controllo di pesi, misure, «mete» (ossia prez-zi amministrati) e mercati; i massari della cattedrale; i regolatori delle arti; i«forieri» incaricati di disporre gli alloggiamenti per i militari.
Su tutto possiede una qualche competenza o un qualche potere di interven-to il Podestà: dal 1576 le Leges Novae – la nuova costituzione politica di Genova– prescrivono che sia un patrizio, analogamente a quanto avviene per i Podestàdi altre sedi ritenute di grande importanza come Chiavari, La Spezia e Sarzana.A partire dal 1606 avrà il titolo e il rango superiore di Governatore, e verrà scel-to in genere tra personaggi di rilievo: «si stimò a proposito – recita un docu-mento settecentesco – di variare la carica di Podestà di Savona in quella diGovernatore […] affinché colla maggiore qualificazione della carica più facil-mente vi si potesse provedere di soggetti quali l’importanza della città e dellasua situazione gli richiedeva»26.
Il Podestà, o il Governatore, è in primo luogo un «giusdicente», cioè ammi-nistra la giustizia civile e criminale assistito dal suo Vicario, ma ha funzioni dicontrollo su tutti gli atti del Comune, sulla gestione dei luoghi pii, persino sulleconfraternite. «È insomma l’occhio, l’orecchio e il braccio del governo genove-se»27; ma deve agire con discrezione, non invadere il terreno riservato alle magi-strature civiche, non metterne in discussione le attribuzioni: Governatore eVicario – prescrivono gli Statuti politici – «siano obligati e tenuti [a] giurare perli Santi Evangelii di Dio di salvare e custodire a tutto suo potere li beni e ragio-ni del Commune di Savona»28. «Essorto le Signorie loro – scrive il GovernatoreGiovanni Battista Doria rivolgendosi nel 1659 agli Anziani savonesi – a voler[…] procedere con quella libertà che la Serenissima Repubblica per particolarprivilegio le concede amplissima […]: quella libertà quale, sin che harò l’hono-re di essere al governo di questa fedelissima città, farò godano maggiore, cosìIddio gliela conceda lungamente come io procurerò che mai per alcun tempo levenga alterata»29.
Le frequenti dichiarazioni circa il rispetto dell’autonomia savonese e la con-servazione degli statuti locali non sono riconoscimenti formali, ma si traduco-no a più riprese in atti concreti. «A chi riandasse la numerosa sequela di filze edi registri contenenti gli atti seguiti sotto i Podestà ed i Governatori – scrivevaall’inizio del Novecento Agostino Bruno – verrebbe fatto di trovare, insieme aprepotenze e ad ordini e disposizioni di mal governo, provvedimenti equi edonesti nell’interesse del Comune e del buon andamento della cosa pubblica»,
74
26 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA, ms. C.VIII.11, cc. 30-31.27 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., p. 19.28 Statuti politici cit., p. 4.29 ASS, Comune I, 214, 8 gennaio 1659.
Capitolo 5
perché «evidentemente eque ed oneste» erano le loro attribuzioni, così come «leistruzioni che loro venivano date da Genova per l’esercizio del loro ufficio»,tanto è vero che molti Governatori si erano resi benemeriti presso la cittadi-nanza30. Questa ammissione, che a uno storico fieramente antigenovese come ilBruno deve essere costata non poca fatica, è sostanzialmente esatta; semmaisono i presunti atti di prepotenza che risultano difficili da individuare sia daparte dei Governatori, sia da parte del Senato, ove si eccettuino le disposizionidi carattere militare che spesso – come vedremo – hanno pesato in misuramolto negativa sulla città. Può persino capitare, nel 1777, che Anziani eRazionali decidano all’unanimità di erigere una «lapide marmorea in ricordan-za […] de’ benefici ricevuti» dall’ex Governatore Cristoforo Imperiale Lercari,memori «del zelo, protezzione e speciale propenzione avuta e che continua-mente ha per questa città e specialmente del suo porto»31.
Al di là della personalità dei singoli giusdicenti, sono la normativa e la pras-si del Senato genovese – i «Serenissimi Collegi» – che mostrano sempre unagrande attenzione per il puntuale rispetto delle prerogative di Savona. Nellefilze e nei registri della corrispondenza fra gli Anziani e il Senato, ad esempio,sono frequenti le istanze o le proteste degli amministratori savonesi – spessorecate a Genova da «ambasciatori», «sindici» o altri delegati del Comune – con-tro tentativi di prevaricazione da parte di gabellieri, funzionari di San Giorgio,Commissari della fortezza, personale della «famiglia» del Podestà o delGovernatore; e ogni volta il Senato, riconoscendo l’abuso di potere, dà ragionealla città soggetta e ne prende le parti, con formule del tipo: «parendone nonpoter mancare ai sudditi in le giuste richieste loro», o «per esser questa la nostravolontà fondata sopra la giustizia»32. La massima autorità della Repubblica giu-dica insomma senza alcuna volontà sopraffattrice né alcun capriccio “dispoti-co”.
La cosa è particolarmente chiara ogni qual volta si è di fronte a un tentativodi disattendere gli statuti politici della città, la sua autonomia e i suoi privilegi.Se i Podestà, ignorando la «gratia speciale» fatta nel 1534 dalla Repubblica cheha concesso alla comunità di Savona una quarta parte delle condanne pecunia-rie da essi irrogate, si attribuiscono l’intera ammenda, il Senato impone loro dipagare quanto dovuto. Se i Censori di Genova pretendono impropriamente diavere una qualche giurisdizione su Savona in materia di prezzi o di regolamen-ti sulle manifatture, i Serenissimi Collegi «intese le bone ragioni di questa città»e del suo «viver politico» proibiscono ogni ingerenza33. Se un Vicario richiedeabusivamente un compenso «per ogni testimonio che esamina a difesa de’ rei»,
75
30 A. BRUNO, Storia di Savona cit., p. 124.31 ASS, Comune I, 116, 2 aprile 1777.32 ASS, Comune I, 209, cc. 199 e seguenti.33 Ibidem, cc. 429-432 (lettera del 26 marzo 1572 e relazione senza data, ma posteriore al 1577). Anche
molto più tardi si segnalano tentativi di ingerenza da parte della magistratura dei Censori genovesi, che cercadi far valere la sua autorità a Savona «confondendo, come già più volte ha tentato, colla giurisdizione che esser-cita ne’ luoghi della Riviera questa città stata sempre immune […] e sottoposta alla sola dipendenza e sogge-zione del Serenissimo Trono» (ASS, Comune I, 143, 2 giugno 1746).
Sottomissione, autonomia, consenso
e di fronte alle proteste degli Anziani li insulta e li tratta «da inobedienti con-tro il principe loro», il Senato prende immediatamente le parti degli Anziani34.Se un altro Vicario, sedendo nel Consiglio grande in rappresentanza delPodestà, ardisce «maneggiare il campanile», cioè – sostituendosi al Priore degliAnziani che ne avrebbe la prerogativa – suonare il campanello per imporre a unconsigliere troppo prolisso di porre termine al suo intervento, lo si redarguiscein modo sferzante35. Se un «commissario ad armas» mandato a dirigere gli affa-ri militari di Savona intende far alloggiare i soldati nelle case e nelle ville dei cit-tadini, gli si ordina di astenersene, perché «la mente et intention nostra è chedetti citadini non siano in questi alogiamenti gravati più del solito et in ognicaso non ci sarà discara ogni comodità che da voi a cotesti citadini vengafatta»36. Se il patrizio Andrea Centurione, «colonello delle militie nostre inSavona», pretende di aver la precedenza rispetto ai magistrati della città «nelleprocessioni et altre demostrationi» gli si ingiunge di non partecipare a pubbli-che cerimonie e di non creare inutili tensioni37. Se personalità genovesi quali«Procuratori, generali, colonelli, ambasciatori e de simili principali dignità» sirecano a Savona per ragioni di ufficio, la loro ospitalità è regolata da norme pre-cise, per non turbare il buon ordine della città e per non gravare più su alcunicittadini che su altri: i magistrati civici hanno compilato un elenco (un «rollo»)delle residenze adatte alla bisogna e ne hanno fatto «due bussole, una delle caseprincipali per le persone di maggior portata, et altra delle case mediocri; secon-do che capitano persone di maggior o minor stoffa cavano da esse bussole, e chiviene a sorte il patron di esse case senza farle difficoltà alloggiano». Il governobada che queste norme siano rispettate, che nessuno pretenda un alloggio supe-riore al proprio rango, e che ai semplici capitani e ai soldati «si debbano dare liloro alloggiamenti su li quarteri dove accaderanno allogiarsi loro compagnie, epiù presso le porte della città che sarà possibile, e che non possino recusare quel-li che gli saranno assegnati»38.
Certo, questi ordini del Senato per lo più intervengono a correggere una pre-cedente prevaricazione di qualche «officiale» o agente governativo, dopo chel’amministrazione civica – gli Anziani, generalmente – ha dovuto inoltrare pro-teste o suppliche. E anche l’obbligo continuo da parte della Comunità di rivol-gersi ai Serenissimi Collegi per ottenerne autorizzazioni, approvazioni, confer-me e simili sembra ribadire ogni volta l’asimmetria dei poteri e la sudditanzadella città minore. Ma in questo continuo scambio di corrispondenza quel cheviene ribadito è anche un altrettanto continuo obbligo di sottostare alle leggi.Petizioni e suppliche da un lato, deliberazioni e concessioni dall’altro, si appel-lano a formule quali la «benevolenza» o la «paterna clemenza» della Signoria
76
34 ASS, Comune I, 209, c. 508, 11 gennaio 1583. 35 ASS, Comune I, 211, cc. 135v-136v, 19 ottobre 1713.36 ASS, Comune I, 209, c. 454, 6 agosto 1573.37 Ibid., c. 522, 13 giugno 1588.38 Ibid., cc. 305 (12 agosto 1558) e 434 (13 maggio 1572). Si veda altresì, in tema di alloggiamenti, il ricor-
so presentato dalla Comunità di Savona nell’aprile 1701, nel quale si ripercorre la storia della normativa in pro-posito (ASS, Comune I, 215).
Capitolo 5
Serenissima, ma di fatto si riferiscono sempre alle leggi della Repubblica o aglistatuti cittadini, in una costante pratica di legalità che non può non essereapprezzata, specie in un’epoca in cui nella maggior parte degli Stati europei l’ar-bitrio dei sovrani e dei loro funzionari ha un ruolo così elevato.
Quando, ogni dieci anni, il «sindico» – cioè l’emissario della Comunità –chiede al Senato di «comprovare li statuti politici e criminali» della città per unaltro decennio, l’istanza è accompagnata dalla formula «acciò possa godere que-sta città le grazie e privilegi contenuti in detti statuti». Per comprendere lasostanza di tali privilegi, e quanto Savona vi faccia conto, bisogna stendere unelenco abbastanza lungo. In cima alla lista, probabilmente, va posta una serie dinorme che garantiscono una certa autonomia tributaria e alcuni sostanziosivantaggi per il ceto dirigente savonese: ma di tutto ciò parleremo in un capito-lo a parte. Altrettanto importante, se non più, è il fatto che Savona in praticapuò ancora ritenersi una città «convenzionata», che come tale «non è soggettaad alcun magistrato della città di Genova, ma solamente vive subordinata alliordini del Senato Serenissimo» o, per usare altre espressioni che ricorrono neidocumenti, dei Serenissimi Collegi, o del Serenissimo Trono39. Questo rappor-to diretto con il massimo organo di governo della Repubblica le permette, inuna certa misura, di trattare “da potenza a potenza” e di mantenere con laDominante un rapporto che conserva alcune caratteristiche politiche e diplo-matiche, non meramente amministrative.
Ciò diventa ancor più rilevante e vantaggioso allorché Genova istituisce ilMagistrato delle Comunità: eretto in via provvisoria nel 1623 e reso perpetuo nel1635, il nuovo organismo – che si compone di cinque membri eletti per dueanni – ha il compito di «procurare per ogni strada l’indennità delle communitàdel Dominio, impedir loro le spese soverchie, giudicare tutte le caose nelle qualio attive o passive hanno interesse»40. Gli si conferisce perciò il compito di tene-re copia dei bilanci delle comunità soggette, e il potere di indagare su chiunquevi amministri denari pubblici, di costringere al pagamento i debitori morosi, difar restituire beni comunali usurpati, di ridurre in ogni modo l’indebitamentodei corpi locali, di procedere sommariamente contro gli eventuali colpevoli dimalversazioni. Analogamente a quanto avviene negli altri Stati italiani dell’epo-ca41, è una magistratura di controllo che realizza una certa estensione dei pote-ri centrali rispetto alle amministrazioni periferiche: tali poteri riguardanosoprattutto le materie finanziarie e contabili, ma consentono un’interferenzaanche sul piano più generale, perché il Magistrato può intervenire «riformandoin qualche luogo il governo delle communità» ove lo ritenga necessario.
77
39 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 4v-5r.40 ASG, Manoscritti, 675. Sull’istituzione di questa magistratura, sulle norme che ne regolano il funziona-
mento e sull’attività da essa esplicata si veda: G. BENVENUTO, Una magistratura genovese, finanziaria e di con-trollo: il «Magistrato delle Comunità», «La Berio», XX, 1980, n. 3, pp. 18-42; G. ASSERETO, Le metamorfosi dellaRepubblica cit., pp. 28-35.
41 Si vedano in proposito i saggi contenuti nel già citato volume Comunità e poteri centrali negli antichi Statiitaliani a cura di L. MANNORI.
Sottomissione, autonomia, consenso
Il principio tradizionale dell’autogestione locale viene così messo esplicita-mente in discussione, e i successivi «capitoli» della magistratura emanati in datediverse fra il 1635 e il 1781 non faranno che restringere ulteriormente l’auto-nomia delle comunità soggette. Sennonché la capacità accentratrice dellaRepubblica è modesta, e molti sono i «luoghi convenzionati» i quali pretendo-no di essere sottoposti solo al Senato, di modo che nessun organo inferiorepossa ingerirsi nei loro affari: sono in queste condizioni, ad esempio, Alassio,Albenga, Pieve, Porto Maurizio, Sanremo, Sarzana, Taggia e Ventimiglia, e inquest’ultima comunità ci si rifiuta persino di pubblicare i proclami delMagistrato (in virtù dei «privilegi e convenzioni» che la rendono sottoposta solo«al Serenissimo Trono») e si protesta che la revisione dei bilanci comunali costi-tuisce «grave pregiudizio delli nostri parlamenti, uffici, usi, convenzioni e decre-ti»42.
Tra i comuni di questo tipo figura appunto anche Savona: nel 1638 ilMagistrato ha intimato ai suoi Anziani di presentare i conti della comunità, «laqual però per gratia del Senato Serenissimo – protestano costoro – resta essen-te dalli magistrati di Genova, quali in essa non hanno giurisdittione alcuna,governandosi con li suoi statuti particolari concessigli e confermatigli dal prefa-to Serenissimo Senato». Invitati a comparire davanti ai Collegi, gli Anziani vispediscono il loro «sindico et avocato» Girolamo Adorno, armandolo di nume-rose pezze d’appoggio, per rivendicare i privilegi di Savona e dimostrare «chedetta città non soggiace al rendimento de conti al Magistrato delle Comunitàné ad altri»43. Successivamente la Repubblica riuscirà ad includere tra i «luoghisottoposti al Magistrato Illustrissimo delle Communità» anche alcune città inprecedenza escluse come Sarzana, Taggia, Ventimiglia e la stessa Savona, che nelsecondo decennio del Settecento vi risulta ormai compresa44. Ma ancora nel1733 gli Anziani savonesi, protestando contro certe pretese ingerenze dello stes-so Magistrato, ricordano ai Serenissimi Collegi che Savona «per speciale privi-leggio di Vostre Signorie Serenissime da tanti secoli gode la fortuna di non rico-noscere altro superiore che cotesto Serenissimo Trono, da cui sino al presente èstata sempre mantenuta in sì glorioso possesso»45. Riprenderemo il discorso piùavanti, ma è bene accennare fin d’ora che questa autonomia finanziaria vienerivendicata così puntigliosamente a difesa non tanto dell’interesse generale dellacittà, quanto piuttosto del suo ceto dirigente, il quale vuole essere libero digestire la cosa pubblica a proprio piacimento, limitando al minimo quei con-trolli che il potere centrale intende attuare anche per garantire un certo livellodi giustizia tributaria e di buona amministrazione a vantaggio di tutti.
I privilegi e l’autonomia toccano poi numerose altre materie. «Tutte le artidella città di Savona si mantengono col buono incaminamento de’ capitoli e
78
42 ASG, Magistrato delle Comunità, 526 e 541; ASG, Senato-Senarega, 2130.43 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 9.44 ASG, Magistrato delle Comunità, 676.45 ASS, Comune I, 143, 10 dicembre 1733.
Capitolo 5
regole che dalla medesima città sono stati formati a ciascheduna arte in parti-colare»: capitoli che ogni quinquennio vengono rivisti da un apposito magi-strato dei Regolatori delle arti, e la cui osservanza «resta appoggiata all’ufficiode’ Magnifici Censori d’essa città»46. Savona ha dunque il diritto di ammini-strare i propri corpi di mestiere, dirimerne le controversie, approvarne o rifor-marne gli statuti, senza che né il governo né le arti di Genova possano aver vocein capitolo, e senza che alcun maestro artigiano “matricolato” altrove possa eser-citare il mestiere in città se prima non vi ha subito l’esame da parte della cor-porazione locale e non ha pagato la «buona entrata richiesta dalle leggi di dettacittà»47.
Savona ha una propria autonoma organizzazione annonaria, incentrata su unUfficio o Magistrato di Abbondanza incaricato di provvedere di grani la città edi fabbricare pane per i ceti popolari. Savona ha un regime particolare per quan-to riguarda le milizie territoriali. Un decreto del Senato in data 19 luglio 1571ha disposto «che li huomini di questa città non restassero ubligati per militaresotto il governo del signor Colonello, ma sotto il governo del MagnificoPodestà, afinché […] fussi differenza dalli cittadini di questa città alli altridescritti nella militia di questo colonellato, huomini per la maggior parte divilla»48; inoltre sono gli Anziani che, ogni anno, eleggono per tali milizie cinquecapitani «con facoltà di portar l’armi»49. Sempre a proposito di forze armate,quando nel 1645 Genova chiede che da Savona e dalla sua giurisdizione «siprovveda di 105 remieri […] per l’armamento delle galere», possibilmentevolontari, se no estratti a sorte dai «rolli» che il patrizio Gian DomenicoPallavicino ha compilato includendovi «non solo i marinari e simili persone attea remare, ma universalmente la cittadinanza tutta niuno escluso», gli Anzianilevano con successo una ferma protesta: «questa città – sostengono con enfasiretorica – è sempre stata e sarà pronta per esporre la vita de’ cittadini tutti indifesa, conservatione et augumento della Serenissima Repubblica», ma nessunopuò pensare di includere tra i rematori coatti la sua «cittadinanza», cioè i suoicives optimo iure, il suo ceto dirigente50: un’altra spia del fatto che i privilegiavengono rivendicati innanzitutto a favore, appunto, dei savonesi privilegiati.
In altri settori i vantaggi dell’autonomia possono essere più generali. Savona,ad esempio, conserva un proprio Magistrato di Sanità, non direttamente sog-getto a quello di Genova e ai suoi commissari, ma sottoposto solo alla supervi-
79
46 ASS, Comune I, 211, c. 57.47 ASS, Comune I, 215, dicembre 1710.48 ASS, Comune I, 210, libro II, cc. 49v-50r. Il Verzellino ricorda, relativamente all’anno 1628: «Fu fatta
scelta in Savona degli uomini delle milizie, acciocché in ogni occasione che potesse nascere fossero pronti e spe-diti a camminare ovunque fosse il bisogno, e furono privilegiati d’oneste condizioni» (G. V. VERZELLINO, Dellememorie particolari cit., p. 239). E fa ben capire come questa forza a tutela dell’ordine pubblico fosse qui un’e-spressione diretta del ceto dirigente.
49 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 24v. Sulle milizie della Repubblica di Genova si veda P. GIACOMONE
PIANA-R. DELLEPIANE, Militarium. Fonti archivistiche e bibliografia per la storia militare della Repubblica diGenova (1528-1797), della Repubblica Ligure (1797-1805) e della Liguria napoleonica (1805-1814), Savona,Elio Ferraris Editore, 2004, pp. 80-102.
50 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 86-87.
Sottomissione, autonomia, consenso
sione del Governatore: il che consente un risparmio (perché non bisogna paga-re le spese determinate dalla presenza di funzionari genovesi) e una certa libertànella materia, così delicata per i commerci e la navigazione, dei controlli sulleimbarcazioni e delle eventuali quarantene da imporre a uomini e merci51.Persino in materia ecclesiastica – benché la Dominante, a sancire la propriasuperioritas, faccia nominare nella città soggetta vescovi che appartengono ingenere al proprio patriziato52 – sopravvive per un certo tempo un privilegio,risalente a Sisto IV, in base al quale nessun savonese può essere tradotto davan-ti al padre inquisitore che siede in Genova; solo tardi e con riluttanza, di fron-te a numerosi casi di «heretici o almeno sospetti di heresia», il Senato mette indiscussione quel privilegio, consapevole tra l’altro che sarebbe rischioso conce-dere troppa autonomia a una diocesi come quella di Savona, soggetta non all’ar-civescovo genovese ma a quello di Milano53.
Sempre a proposito di cose religiose, nel 1621 il Senato favorisce l’insedia-mento a Savona della Compagnia di Gesù e l’anno dopo quello degli Scolopi:due ordini che garantiscono alla città un considerevole sviluppo di istituzioniscolastiche, specie il secondo che si impegna a «insegnar legere, scrivere, abac-co, grammatica, humanità e retorica et altre cose […] a tutte le sorti de’ putti escolari di detta cità et de suoi borghi, senza alcuna mercede», e successivamen-te apre un collegio che all’inizio del Settecento sarà tra i migliori d’Italia e giun-gerà ad annoverare un centinaio di convittori, molti dei quali aristocratici pro-venienti da fuori Stato, in particolare dal Piemonte. Ad esso il Banco di SanGiorgio nel 1696 concederà privilegi fiscali, e nel 1713 il Senato lo prenderàsotto la sua protezione, consentendogli di inalberare «l’arma della RepubblicaSerenissima»54.
Un campo particolare nel quale l’autonomia cittadina risulta tutelata solo inparte è quello che riguarda il Nemus, la grande foresta situata sulle alture allespalle di Savona, che fin dalla sua nascita il Comune savonese ha sottoposto alproprio controllo, e che costituisce un’immensa riserva di materiale da costru-zione, di importanza fondamentale soprattutto per la cantieristica navale. Lasottomissione di Savona comporta in teoria la «cameralizzazione» del Bosco,oggi diremmo il suo passaggio da bene comunale a bene demaniale. Ma nel1530 il Senato ordina al Podestà savonese: «Circa li redditi […] del Bosco, voinon li farete innovatione alcuna, anzi li lasciarete nella forma [che] sono,lasciandoli essigere da chi li essigeva avanti, fino a nostro nuovo ordine»55. Èvero che un decreto del 1532 attribuisce direttamente alla Repubblica la tutela
80
51 ASS, Comune I, 211, c. 8r.52 Dopo il 1528 quasi tutti i vescovi savonesi appartengono a famiglie della Dominante: in particolare tro-
viamo quattro Spinola, tre Fieschi, due Grimaldi, un Centurione, un Durazzo, un De Mari, un Gentile (F.MOLTENI, Cenni sui rapporti tra Savona e Genova nel XVIII secolo, in Genova, 1746: una città di antico regimetra guerra e rivolta a cura di C. BITOSSI e C. PAOLOCCI, Genova, Associazione Amici della Biblioteca Franzo-niana, 1998, pp. 513-522).
53 L. BOTTA, La riforma tridentina nella diocesi di Savona, parte II, AMSSSP, vol. XXXV, 1963, pp. 5-262(in particolare pp. 109-127).
54 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., pp. 218-219; A. M. FERRERO, Le Scuole Pie di Savona. Nuova edizio-ne riveduta e aumentata, Savona, Associazione Amici degli Scolopi di Savona, 2002, pp. 9-10 e 41-45.
55 Concessioni decreti et ordini della città di Savona cit., p. 35.
Capitolo 5
del Bosco, «ma una netta distinzione dei diritti demaniali e comunali non com-pare mai nel regime paternalistico di Genova», a differenza di quanto avvienealtrove, per esempio nello Stato sabaudo, cosicché ancora alla metàdell’Ottocento – quando la Liguria è ormai entrata a far parte appunto di quel-lo Stato – resterà incerto se la giurisdizione vi competa al Comune o al dema-nio. «Per quanto Genova assumesse la cura della conservazione del Bosco e lasorveglianza con suoi appositi agenti, tollerava che anche Savona compisse veriatti di dominio nel fare concessioni temporanee e perpetue o enfiteutiche […].Ché anzi tanto il governo dello Stato come il Comune gareggiavano quasi in taliconcessioni»56.
Il decreto di sottomissione del 20 agosto 1529, che già più volte abbiamoricordato, ha «dichiarata la città di Savona priva de suoi beni, gabelle, introiti,feudi et altre cose»; ma poi di fatto le proprietà del Comune non sono stateincamerate (anche questo è un dato da tenere ben presente per valutare l’atteg-giamento di Genova verso la città soggetta), così come – lo vedremo – è statamantenuta l’autonoma capacità fiscale del Comune stesso. Perciò dopo il 1528la città e la Repubblica condividono l’uso e il godimento del Bosco senza chevengano fissate in modo netto le rispettive competenze; e ogni volta che Savonaha bisogno di legname per opere pubbliche, soprattutto per il porto (costruzio-ne di pontoni, o di «casse» per rinforzare il molo), può sempre tagliare gli albe-ri necessari, così come può farvi legna per provvedere di combustibile la fortez-za. Inoltre il Comune continua «a compiere atti di amministrazione, e spesso didominio, del Nemus, e a far concessioni per locazioni temporanee e perpetue[…] con l’acquiescenza di Genova»57. Senza contare che, a beneficiare di taliconcessioni sotto forma di livelli e di enfiteusi, sono in genere facoltosi cittadi-ni savonesi o opere pie della città. Proprio per difendere il pieno diritto di costo-ro, Savona non smette mai di rivendicare anche de iure il possesso di quell’im-portante bene.
Una Informatione con la quale si prova che il Bosco sia della fedelissima città diSavona58, senza data ma presumibilmente della metà del Seicento, si appella aiprecedenti medievali ma anche a numerosi decreti delle autorità genovesi dopoil 1528, in particolare ad alcune lettere al Podestà degli anni 1583 e 1584 nellequali si ordina di lasciare «che li agenti della città di Savona affittino e rinnovi-no tutte le massarie che sono nel detto Bosco». Si coglie anzi l’occasione per unarivendicazione di carattere ben più generale: Savona non può essere stata priva-ta di alcuno dei suoi beni, perché ancora nel 1526 era città convenzionata e nonsuddita, e «le città convenzionate, se non osservano le convenzioni, non incor-rono perciò in ribellione, il qual delitto non si commette se non da chi è sud-dito». Se la Repubblica ha compiuto atti di possesso sul Bosco, «lo ha fatto
81
56 M. T. SCOVAZZI, Il grande nemus di Savona nella storia politica ed economica della Sabazia e dellaRepubblica di Genova, AMSSSP, vol. XXVII, 1949, pp. 7-54. Si veda anche D. FRANCHELLO, Formazione e svi-luppo di un fronte di penetrazione colonica nell’ambito del Bosco di Savona, AMSSSP, n. s., vol. VI, 1972, pp. 47-69.
57 M. T. SCOVAZZI, Il grande nemus cit., p. 38.58 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 2-4.
Sottomissione, autonomia, consenso
come Prencipe a cui non si può dire cur ita facis?», non perché fosse suo buondiritto. Quantunque il governo genovese nel corso del Settecento cerchi a piùriprese di estendere il proprio controllo sul Bosco59, di fatto la parziale giurisdi-zione savonese su di esso non verrà meno e i suoi cittadini che ne godono i frut-ti continueranno a goderli. Saranno semmai i piemontesi, durante la loro occu-pazione di Savona durante la guerra di Successione austriaca, a impadronirsi delBosco e a sfruttarlo ferocemente ai loro fini per ricavarne legname da ardere eda costruzione.
Infine c’è un settore in cui tutte le città di antico regime sono attentissime arivendicare la propria indipendenza da ogni autorità esterna, tanto laica quan-to ecclesiastica, ed è quello che concerne le opere pie, le istituzioni di pubblicacarità e assistenza: fondazioni utili al buon governo della città, ma nel contem-po importanti centri di potere (perché l’elargizione di elemosine e sussidi con-sente l’instaurarsi di rapporti clientelari) e concentrazioni di patrimoni e rendi-te la cui amministrazione fa gola a molti. Savona non fa eccezione e, con ilbenestare della Dominante, il Comune riesce a mantenere sui propri luoghi piiun pieno controllo. Tale è il caso dell’Ospedale di San Paolo, fondato nel 1517dall’omonima Compagnia che a Savona si era costituita nel 1512, cui nel 1520il Comune ha concesso l’esenzione dalle gabelle sui generi alimentari e nel 1526ha annesso tutti i beni dell’antico Ospedale di San Lazzaro o degli incurabili60.Lo status di opera pia laicale, retta da «protettori» nominati in loco, non mutadopo la sottomissione a Genova; anzi i protettori stessi, nel 1648, chiedono eottengono dal Senato la conferma del privilegio di essere giudici «delle caose checontro qual si vogli può havere esso ospedale», con facoltà di procedere e giu-dicare sommariamente «intesa la sola verità del fatto»61. E nel 1727 una memo-ria redatta dal notaio Filippo Alberto Pollero, riassumendo origini e vicendedell’Ospedale, dimostra la totale autonomia dello stesso non solo dal poterecentrale, ma anche e soprattutto dall’autorità del vescovo62.
La stessa autonomia viene fatta valere nei confronti di altri istituti: il Montedi pietà, uno dei più antichi d’Italia, l’Ospedale grande di Misericordia (o «delloScagno»), i numerosi lasciti e «moltiplichi» destinati ad pias causas. Durante il
82
59 Significativa, in tal senso, è la missione affidata dalla Camera nel 1723 al colonnello Matteo Vinzoni, unodei migliori cartografi della Repubblica, che traccerà una «carta typografica di tutt’il Bosco di Savona» e com-pilerà un «libro contenente le particolari masserie del medesimo Bosco, colle divisioni, siti controversi e termi-ni sì antichi che moderni». La missione ha lo scopo sia di fare un censimento «dell’alboratura», sia di conosce-re le strade «più proprie e più brievi per il trasporto de’ legnami», sia di controllare appunto i confini delle mas-serie per evitare che questi siano abusivamente estesi dagli enfiteuti (ASG, Giunta dei Confini, 109). Più tardi,nel 1769-1770, un altro ingegnere della Repubblica, Gerolamo Gustavo, redigerà una nuova Descrizione delBosco Camerale di Savona (una copia della quale è conservata presso la Biblioteca civica “Barrili” di Savona),nella quale appunto l’aggettivo «camerale» indica la volontà di Genova di rivendicarne la piena giurisdizione.
60 A. BRUNO, L’ospedale di S. Paolo e l’ospizio dei poveri del Santuario, «Bullettino della Società storica savo-nese», I, 1898, pp. 54-63.
61 L. BOTTA, La riforma tridentina cit., pp. 192-193; ASG, Senato-Senarega, 2130, 16 gennaio 1648.62 G. MALANDRA, Una memoria settecentesca sull’ospedale di S. Paolo, AMSSSP, n. s., vol. III, 1970, pp. 143-
146.
Capitolo 5
vescovado di Cesare Ferrero (1576-1581), tra l’altro, si rafforza il carattere lai-cale di queste opere pie, sulle quali l’amministrazione comunale esercita un’au-torità sempre più stretta, rintuzzando ogni ingerenza del vescovo. Nel 1580 gliAnziani nominano una commissione di tre cittadini che si occupino non solodegli istituti di beneficenza, ma anche delle chiese nelle quali il Comune vantadiritti di giuspatronato o per le quali spende soldi propri: un’estensione di com-petenze che il governo genovese non solo non ostacola ma favorisce, contro lepretese delle autorità ecclesiastiche63.
C’è soprattutto una fondazione, di straordinaria importanza nella storia diSavona, sulla quale si può misurare l’autonomia conservata dalla città o più ingenerale valutare i rapporti con la Dominante, ed è il Santuario di NostraSignora della Misericordia. Sull’argomento esistono studi importanti e ancherecenti, che ci esimono dal compito di parlarne diffusamente64: basterà quindiqualche rapido accenno. I fatti sono ben noti a tutti i savonesi: il 18marzo1536, nella valle di San Bernardo alle spalle della città, la Madonna appa-re a un contadino del luogo, Antonio Botta. La divulgazione della notizia pro-voca un grande fermento religioso tra la popolazione, in un momento assai deli-cato sia per la Chiesa (siamo nel pieno della crisi provocata dalla Riforma pro-testante) sia per la Repubblica (la fresca sottomissione di Savona ha lasciato stra-scichi di rancori, e la situazione italiana e internazionale, come si è visto nelcapitolo 3, non è affatto rassicurante). La prima teme che l’evento favorisca «lanascita di novità eterodosse»; la seconda fiuta il pericolo che l’apparizione fac-cia «rinascere un nuovo orgoglio nel cuore dei savonesi»65. Ma Genova, conintelligenza, sceglie di non ostacolare il fervore religioso sorto intorno all’appa-rizione, anzi di favorirlo e guidarlo secondo una strategia in cui alla devozionesi sposa la ragion di Stato. Il culto per la Madonna della Misericordia – tale laveste in cui la Vergine si è presentata in quell’occasione – viene anzi “ufficializ-zato” ed esteso a tutti i territori della Repubblica. Nel contempo si avvia unagrandiosa opera di costruzione del Santuario e dell’Ospizio ad esso collegato,per la quale vengono impiegati soprattutto capitali di famiglie patrizie genove-si (e non è certo un caso che accanto al Santuario e all’Ospizio sorgano unpalazzo Doria e un palazzo Pallavicino66), mentre le stesse famiglie seguiteran-no a profondere donativi d’ogni genere per adornare la chiesa e arricchire l’o-pera pia: «quasi a smorzare le tentazioni del revanscismo savonese anche neglianni a venire, in una sorta di indennizzo economico, ma soprattutto morale,attraverso il riconoscimento di un primato spirituale, capace di orientare ilnuovo modus vivendi nel segno della riconciliazione che la Vergine stessa […]sembrava aver indicato»67.
83
63 L. BOTTA, La riforma tridentina cit., pp. 200-202.64 Riassuntivamente, si rinvia ai saggi contenuti nel già citato volume La Madonna di Savona.65 S. RIOLFO MARENGO, La Madonna di Savona, in La Madonna di Savona cit., pp. 17-44 (in particolare p.
30).66 C. VARALDO, 1536, un anno nella crisi: società ed economia a Savona nell’anno dell’Apparizione, in La
Madonna di Savona cit., pp. 81-99 (in particolare pp. 87-88).67 S. RIOLFO MARENGO, La Madonna cit., p. 30.
Sottomissione, autonomia, consenso
La costruzione del Santuario e dell’annesso Ospizio per i poveri nella valle diSan Bernardo viene decisa il 12 luglio 1536 dal Consiglio del Comune diSavona e, grazie alle ingenti somme subito elargite, è già in gran parte termina-ta nel 1540. Lo stesso Comune nel 1539 promuove la costruzione di una nuovastrada per raggiungerli. Da tutto il nord Italia, e ben presto anche da altri luo-ghi, cominciano ad affluire a Savona migliaia di pellegrini, tanto che il suoSantuario diventa uno dei più importanti centri di culto mariano della cattoli-cità. Vi accorreranno in particolare numerosi aristocratici: esponenti delle mag-giori famiglie genovesi e savonesi, ma anche molti forestieri, tra cui principi eregnanti. Non ultimi i duchi di Savoia, a cominciare da Emanuele Filiberto, chemanifesta una speciale devozione per la Madonna di Misericordia e un partico-lare apprezzamento per la città68. Tutto ciò contribuisce a fare del Santuario unformidabile centro di potere e di ricchezza, che è destinato a rimanere salda-mente nelle mani dell’élite savonese. Grazie ai buoni uffici esercitati a Roma daPaolo Riario, influente personaggio della cerchia “roveresca”, il 3 agosto 1537papa Paolo III concede «il iuspatronato di detto santo luogo alla comunità diSavona», lo fa esente «da qualsivoglia giurisdizione, dominio, potestà, correzio-ne e superiorità del vescovo», lascia agli «officiali» nominati dal Comune «libe-ra facoltà […] d’amministrar l’elemosine, redditi e proventi»69.
Da allora il Comune non lascerà più la presa su quella pingue opera pia. «Lanomina degli amministratori della chiesa e dell’Ospizio di Nostra Signora diMisericordia – ricorda Agostino Bruno – fu tassativamente indicata fra le attri-buzioni principali del Consiglio cittadino negli statuti politici vigenti duranteil dominio della Repubblica di Genova […], ed il Consiglio, malgrado la dipen-denza politica del Comune, vi procedette sempre liberamente […]. Genovastessa riconobbe pieno ed assoluto il diritto del Comune, ed anzi lo sancì comenorma e regola nei suoi statuti e nei decreti successivi»70. Nel 1642, di frontealle manovre del vescovo Francesco Maria Spinola che contesta il giuspatrona-to laicale sul Santuario, il Comune coinvolge «i molti cittadini […] pronti aporgere ogni assistenza per favorire questa causa, perché non si perda devozio-ne così singolare né svaniscano tanti beni e opere misericordiose», e ottiene chepapa Urbano VIII investa della questione la Congregazione del Concilio, laquale darà infine ragione a Savona71. Nel 1686 si ripetono i tentativi d’inge-renza da parte dell’autorità ecclesiastica, e gli Anziani si appellano al Senatogenovese ricordando che esso ha sempre garantito «il singolar privilegio conces-so da Sommi Pontefici a questa loro città della libera amministrazione […] del-
84
68 Sulle numerose visite a Savona da parte di Emanuele Filiberto, e sui legami di amicizia e persino di paren-tela che vi stringe, si veda M. TASSINARI, Le origini della cartografia savonese del Cinquecento. Il contributo diDomenico Revello, Battista Sormano e Paolo Gerolamo Marchiano, ASLSP, CII, 1989, pp. 233-279 (in particola-re p. 235).
69 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, p. 10; L. BOTTA, La riforma tridentina cit., p.17.
70 A. BRUNO, Storia di Savona cit., pp. 129-130.71 E. MATTIAUDA, Per la cappella della Visitazione nel Santuario di Nostra Signora della Misericordia di
Savona, AMSSSP, n. s., vol. XXVI, 1990, pp. 63-79 (in particolare pp. 67-68).
Capitolo 5
l’oratorio et ospitale intitolato di N. S. di Misericordia», e ogni volta che ivescovi hanno voluto intromettersi «in cosa benché minima» sono stati costret-ti a desistere72. Nel 1728, quando nuovamente la Santa Sede riconosce le ragio-ni del Comune contro le mire dell’allora vescovo Agostino Spinola, ciò avvienegrazie all’intervento diplomatico del governo genovese, che gli Anziani ringra-ziano con grande calore: «la città in ogni sua occorrenza e travaglio riconoscel’appoggio delle sue speranze […] nella benignità di Vostre SignorieSerenissime; questi sono potentissimi motivi che ci fanno gloriare di viveresotto il felice auspicio della Serenissima Repubblica che non solo come princi-pe di tutta bontà ci governa, ma come padre ci assiste e difende»73. In partico-lare è la pretesa da parte dell’ordinario diocesano di controllare la gestionefinanziaria del luogo pio a suscitare proteste, che trovano sempre benevoloascolto presso il governo e presso la sua Giunta di Giurisdizione74: la quale, neldifendere le prerogative del potere laicale, non pone in dubbio che in questocaso debba essere la comunità soggetta a esercitarlo.
A dispetto di queste ampie concessioni di autonomia, non c’è dubbio che aSavona, per tutto il corso dell’età moderna, continui a serpeggiare un forte ran-core nei confronti del governo genovese. La sottomissione della città è stata tar-diva, proprio perciò mal digerita, e si è realizzata mediante una forte dose di vio-lenza, in forme che hanno lasciato conseguenze durature: perché un conto èammazzare, come abbiamo visto nel caso di Padova, il signore locale e la suafamiglia; un conto, come è avvenuto altrove, passare a fil di spada un certonumero di cittadini o cacciarli in esilio dopo averne espropriato i beni; e unaltro conto è, come a Savona, distruggere un porto la cui piena ricostruzione inseguito risulterà impossibile, benché – come vedremo – da un certo momentoin poi la Repubblica tenti di favorirne un parziale ripristino. Quella distruzio-ne, lo si è detto, è avvenuta assai più per motivi strategici che per ragioni di riva-lità commerciale, tanto è vero che nei confronti del porto Genova non intendefar valere la politica dell’autonomia locale: lo si vede chiaramente in una lette-ra che il Senato scrive al Podestà di Savona il 15 gennaio 1573 per ricordargliche i magistrati comunali possono continuare a deliberare in tutto con la mas-sima libertà, ma il Magistrato di Darsena non deve intromettersi in alcun modo«in quelle cose che restano reservate all’autorità nostra et che senza la nostraconcessione et volontà non se li può provedere»75. Ma, quale che sia la ratiodelle demolizioni portuali, il risultato per la città non cambia; anzi, proprio lanatura strategica di quelle demolizioni da un lato le rende pressoché irreversi-bili, dall’altro spingerà nel corso degli anni a sempre nuovi interventi di edilizia
85
72 ASS, Comune I, 143, 17 luglio 1686.73 Ibidem, 5 aprile 1728. Su alcuni conflitti giurisdizionali che nel corso del Settecento vedono opposti i
vescovi savonesi da un lato, il Comune o i protettori delle opere pie dall’altro, si veda anche: F. MOLTENI, Cennisui rapporti tra Savona e Genova cit.; G. L. BRUZZONE, Ottavio Maria De Mari (1700-1775), C. R. S., vescovodi Savona, e l’inventario della sua biblioteca, in Erudizione e storiografia settecentesche in Liguria a cura di C.BITOSSI, Genova, Accademia ligure di scienze e lettere, 2004, pp. 151-208 (in particolare pp. 159-160).
74 Si veda ad esempio ASS, Comune I, 210, libro III, c. 262, 18 gennaio e 21 febbraio 1668.75 ASS, Comune I, 209, c. 448.
Sottomissione, autonomia, consenso
militare, destinati ad aprire notevoli ferite nel tessuto urbano. Quanto bruci il ricordo delle distruzioni cinquecentesche lo si intuisce anche
guardando alcune piante e vedute della città disegnate nei secoli seguenti, mariferite al periodo anteriore al 1528 e contenenti la rappresentazione di unaSavona fortemente idealizzata: una cartografia immaginaria che è di fatto forte-mente “rivendicazionista”76. Alla fine del Settecento l’intellettuale-avventurieroGiuseppe Gorani, nel passare in rassegna gli Stati italiani del suo tempo, lodamolto il governo genovese e la sua amministrazione giusta e paterna in tutto ilDominio, capace di affezionargli i popoli. Parlando di Savona («dopo Genova,la più importante città di questo Stato […], ben costruita e molto gradevole»),deve però rilevarne la decadenza economica rispetto a un lontano passato, econfessare che lì ha trovato «degli scontenti», le cui recriminazioni non vertonosu un’eventuale «mancanza di giustizia o di attenzione per il bene generale», masull’antico riempimento del porto77. Pochi anni dopo, caduto il governo aristo-cratico, abbiamo visto (cfr. capitolo 1) che ancora sullo stesso fatto si appunta-no le principali accuse dei delegati savonesi. Il tempo, evidentemente, non hasanato la piaga e questo tipo di rancore appare come una di quelle idee-forzache seguitano ad agire anche quando forse gli interessi economici che le aveva-no fatte scaturire e davano loro sostanza sono venuti meno.
Questo odio di lungo periodo – vero fiume carsico che periodicamente rispun-ta e che infine, come si è detto, verrà pienamente alla luce nell’Ottocento sia insede storiografica sia tra l’opinione pubblica – non impedisce tuttavia che per due-centocinquanta anni e con notevole continuità Savona sia protagonista di nume-rosi episodi di collaborazione e fedeltà nei confronti della Repubblica. Genova saràa lungo ossessionata dall’idea che la città possa ribellarsi o darsi a un principe stra-niero, ma la realtà di fatto – a differenza di quanto avviene in altre comunità delDominio, nel Seicento ad Albenga e nel Settecento a Finale e a Sanremo – è quel-la della sua «durevole e indiscussa sottomissione»78. Se si passano in rassegna alcu-ni momenti topici dei rapporti tra Savona e la Dominante, pare anzi di assistere auna sorta di comportamento schizofrenico: da un lato nella corrispondenza tra ilComune e il Senato si denunciano frequentemente forti motivi di scontento, silamenta l’impoverimento della città, si contestano provvedimenti del potere cen-trale; d’altro lato il comportamento della civica amministrazione e dei personaggipiù in vista nei confronti del governo è assolutamente lealista.
Nel 1575, quando a Genova scoppia tra nobili «vecchi» e «nuovi» quel con-flitto che verrà poi ricomposto solo con una difficile mediazione internaziona-le, i primi escono dalla città e in parte si portano a Savona, dove vorrebberoimpadronirsi delle fortezze; ma non ci riescono, e si ritirano a Finale o in altriluoghi fuori Stato, proprio perché la popolazione locale si mantiene fedele algoverno in carica: «il signor Podestà – annota Verzellino – rimase molto soddi-
86
76 Si veda ad esempio G. B. N. BESIO, Savona iconografica, Savona, Editrice Liguria, 1974, pp. 36-43.77 J. GORANI, Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernemens, et des moeurs des principaux états de
l’Italie, Paris, Buisson, 1793, t. III, pp. 430-437.78 C. BITOSSI, Il governo genovese cit., p. 80.
Capitolo 5
sfatto dell’ubbidienza e prontezza dei savonesi»79. Segni ancor più tangibili didevozione da parte della città suddita si hanno nel 1613, allo scoppio dellaguerra per la successione del Monferrato che sembra minacciare anche laRepubblica: la comunità di Savona offre allora al Senato «cinquecento fantipagati per sei mesi» e replica la medesima offerta l’anno successivo. Qualchepatrizio, come Angelo Gavotti e i suoi fratelli, paga di tasca propria un certonumero di armati, ricevendo in cambio dal Senato il privilegio di stare a capocoperto dinanzi ad esso80. Tanto nel 1613 quanto nel 1614 i Serenissimi Collegiinviano ai «diletti» Anziani savonesi lettere di ringraziamento in cui le espres-sioni di concordia e di fiducia si sprecano:
Se bene il concetto che habbiamo della divotione e fedeltà di cotesta città versola Repubblica è tale che non era di bisogno che lo confermaste maggiormente,nondimeno essendovi piaciuto, per lo maneggio d’armi che si sente nel paese vici-no, farne dimostratione con offerta nobile e degna di voi, è stato ciò da noi gradi-to molto. Di cotesta prontezza vostra teniremo sempre quel conto che si conviene,con affetto paterno e con pensiero di gratificarvene nelle occasioni secondo i meri-ti vostri, […] sicuri che quando vi fussi il bisogno si hariano maggiori agiuti, sìcome voi dalla Repubblica potete sperare e tener per fermo di haver sempre ogniprotettione e difesa per voi e per le cose vostre81.
Tanto più importante e gradita si rivela la fedeltà savonese nel 1625, di fron-te alla grave minaccia portata dall’invasione del duca Carlo Emanuele I diSavoia. Già dalle prime avvisaglie di guerra la città collabora con le autoritàgenovesi, ne ospita con liberalità commissari e ingegneri incaricati di migliora-re le fortificazioni, mentre i principali cittadini vanno «offerendo allaRepubblica la vita e le sostanze»82. Genova «con ogni prestezza possibile fortifi-cava Savona, di cui più temeva, e da cui dipendeva la salvezza di gran parte dellaLiguria»83; ma ai primi rovesci della guerra il Governatore genovese abbandonala città con il suo presidio per correre in soccorso della Dominante. È alloraSavona stessa che si arma a difesa grazie a un Francesco Multedo che organizzale milizie rurali e urbane sino al ritorno dei genovesi e dei loro alleati. Poi la cittàdiventa «piazza d’armi», ospita migliaia di soldati mandati «da Milano, daNapoli e da altri paesi del re Cattolico» per aiutare la Repubblica, viene minac-ciata d’assedio dai piemontesi, appronta con il concorso degli abitanti nuove eonerose fortificazioni per le quali «convenne diminuir in parte li borghi con get-tar a terra in tal urgenza più di cento case et altretanti orti, stimati nel prezzo discudi cento mila». Infine nel 1626, mentre la pace attenua il peso della presen-za di armati e delle installazioni militari sulla città, il Senato per ricompensarlale concede di accrescere il molo e – auspice la mediazione di un savonese illu-stre come Gabriello Chiabrera – le attribuisce il titolo di «Fedelissima», che
87
79 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, p. 95.80 Ivi, pp. 172 e 176; A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., pp. 213-218.81 ASS, Comune I, 210, libro II, cc. 34v e 35v, 22 maggio 1613 e 13 dicembre 1614.82 G. FARRIS (a cura di), Cronaca savonese cit., p. 6.83 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 226.
Sottomissione, autonomia, consenso
d’ora in poi potrà esporre sopra le sue insegne, e che sempre verrà menzionatoda una parte e dall’altra nei rapporti tra Dominante e suddita84.
Se nel 1625-26 è, almeno in parte, una situazione di forza maggiore a deter-minare la fedeltà di Savona, meno di vent’anni dopo la città si rende protago-nista di un’iniziativa spontanea abbastanza clamorosa. In un periodo in cui laRepubblica si sta sforzando di allestire un nuovo stuolo di galere per potenzia-re il proprio armamento, e in cui si è accesa una sorta di gara di generosità traricchi patrizi (l’ex Doge Giacomo Lomellini, il letterato Anton Giulio BrignoleSale, l’entusiasta “navalista” Giovanni Bernardo Veneroso)85, il Comune savo-nese si fa avanti con una propria offerta. All’unanimità il Consiglio cittadinonel febbraio del 1642 delibera la costruzione di «due gallere armate di tuttoponto da fabbricarsi a spese di detta città, acciò che annoverate con le altre delnovo armamento della Repubblica Serenissima possino accorrere ad ogni glo-riosa impresa», mentre i cittadini di Savona si dichiarano «pronti per qualonqueoccasione d’esporre con ogni loro havere anche il proprio sangue per la conser-vazione, accrescimento e grandezza della Serenissima Repubblica»86.
Il dono è stato di certo caldeggiato dal Governatore pro tempore della città,quel G. B. Veneroso che abbiamo appena menzionato e che è uno dei più con-vinti fautori della politica di riarmo marittimo. Per Savona rappresenta unonere molto forte – all’incirca «lire cento milla», una somma enorme per i magribilanci comunali – ma è un formidabile strumento per ribadire la sua fedeltà eper ottenere alcune ricompense onorifiche (il diritto di apporre sulla poppadelle imbarcazioni le insegne cittadine, sia pure in dimensioni un po’ ridotterispetto a quelle di Genova, e la partecipazione dei savonesi alla cittadinanzagenovese)87 e altri vantaggi più concreti, di cui parleremo fra poco. Resta dachiedersi chi abbia pagato quel conto salato, e la risposta cercheremo di darlapiù avanti, nel capitolo riguardante la fiscalità.
In questa breve rassegna delle prove di fedeltà fornite dai savonesi va ricor-dato anche il comportamento tenuto nel 1672, quando di nuovo il duca diSavoia Carlo Emanuele II porta un attacco alla Repubblica: «la nobiltà diSavona e cittadinanza tutta – annota il continuatore delle Memorie di Verzellino– […] ambiziosa di dimostrarsi […] meritevole di quel pregiatissimo titolo difedelissima, […] diede […] a divedere al suo principe, ne’ tempi più pericolosi,con una prontezza più che ordinaria, prendendo l’armi in difesa della città,quanto si pregiasse di vivere suddita della Serenissima Repubblica, […] pron-tissima ad esporsi a qualunque pericolo ed a sacrificare la vita e la robba per ilpubblico servizio»88. Infine, fallito il tentativo del Savoia, vengono accesi «fuo-chi e luminarie d’allegrezze per più sere, e singolarmente alle finestre del palaz-
88
84 Ivi, pp. 226-238.85 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell’età moderna, Torino, Utet, 1978 (Storia d’Italia diretta da
G. GALASSO, vol. IX), pp. 310-312.86 ASS, Comune I, 210, libro II, cc. 55-57. Sull’episodio si veda A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 256-
257; G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 301-307.87 ASS, Comune I, 210, libro II, c. 56 (decreto del Senato, 25 febbraio 1642).88 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, p. 460.
Capitolo 5
zo ove sogliono congregarsi i signori Anziani»; si canta il Te Deum nella catte-drale, dopo di esso viene «ordinato dalla nobiltà savonese un bellissimo concer-to musicale», e i festeggiamenti proseguono sino a notte fonda per tutta la città«con universal applauso»89. A metà del Settecento, quando nel corso della guer-ra di Successione austriaca Savona subisce una lunga occupazione piemontese,inizialmente i patrizi locali sembrano invece inclini a collaborare con gli occu-panti; ma ben presto i militari e i funzionari sabaudi trattano la città con taledurezza da fare rimpiangere il governo genovese90.
La fedeltà, come è facile intuire, è anzitutto il frutto di un calcolo politico. Unavolta constatato che alla sudditanza non esistono alternative realistiche, i ceti diri-genti cittadini preferiscono – almeno ufficialmente – la via della collaborazione.Tra l’altro è difficile ignorare che la collocazione entro la Repubblica genovesepresenta, per tutta la popolazione, alcuni vantaggi corposi: non solo, come si ègià avuto modo di accennare e come preciseremo in seguito, le grandi ricchezzelucrate da Genova in questi secoli si riversano in qualche misura anche su Savona,ma l’indipendenza e la neutralità di cui gode quasi costantemente la Serenissimale consentono una pressione fiscale certamente minore di quella che viene messain atto nell’Italia spagnola o in Piemonte. Inoltre essere sudditi genovesi com-porta un beneficio che nell’età preindustriale – quando così frequenti sono lecarestie – non si può non apprezzare, vale a dire una notevole facilità di approv-vigionamento alimentare: una metropoli come Genova, infatti, con i suoi capi-tali, la sua organizzazione mercantile e la sua forte domanda «consente l’amplia-mento dell’area del commercio internazionale dei grani, fuori del cabotaggiolocale», e «può mettere a confronto mercati lontani quali l’andaluso, l’africano, ilsiciliano, il pugliese, l’orientale, il baltico», facendo in modo che anche negli annipeggiori lo spettro della fame sia scongiurato91. Ma, oltre ai vantaggi per così direoggettivi e automatici, la deferenza verso il governo consente di acquisirne altri,in particolare di conservare efficacemente quegli spazi dell’autonomia locale cosìpreziosi per il ceto dirigente locale, e talvolta anche di ampliarli.
Un documento senza data (ma presumibilmente del 1637) dal titoloInformatione che li magistrati di Genova non si intromettano nelle cose di Savonaper gratia speciale ricorda che quest’ultima città, sin da quando anticamente ha«riconosciuto la Serenissima Repubblica per superiore, e sempre ha perseveratoe persevera con suo felice contento e pace», è stata «conservata in possesso digodere le sue gabelle, introiti, siti e suoli pubblici, giurisdittione, distretto e ter-ritorio pacificamente, e di quelli disporre senza impedimento delli agenti» dellaRepubblica stessa. Ciò è vero a partire dal 1251, ed è stato riconfermato «dal-
89
89 Ivi, p. 486.90 F. NOBERASCO, Le tribolazioni di Savona dal 1746 al 1749, «Gazzetta di Genova», 1914, n. 8-10; P.
VENEZIANI; Breve ristretto di alcuni avvenimenti e notizie in questa città di Savona dal principiare il presente seco-lo MDCC a cura di G. ASSERETO, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», Supplemento savonese, n. 2,1915, pp. 11-61 (in particolare pp. 35-42); F. BRUNO, Breve succinto ed epilogato ragguaglio di quanto successequando il Re Sardo prese Savona, AMSSSP, vol. VI, 1923, pp. 61-101.
91 E. GRENDI, La repubblica aristocratica dei genovesi, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 203-204.
Sottomissione, autonomia, consenso
l’ultime concessioni fatte […] l’anno 1526, 1529, 1573 […] né per dette con-cessioni appare che di questa gratia sia mai stata privata». Tanto che, ove sieccettui la restrizione della giurisdizione territoriale e il divieto sancito nel 1572di poter «provedere circa la darsena senza licenza del Serenissimo Senato», sipuò affermare «che per il resto rimane la città nel suo stato»92; e ciò – si ribadisce– è tanto più indiscutibile da quando Savona è stata designata come fidelissima.
Negli anni trenta del Seicento, in effetti, la città esercita nei confronti delgoverno una forte pressione che ha lo scopo in primo luogo – lo vedremo nelcapitolo dedicato al fisco – di evitare o ridurre alcuni tributi straordinari, maanche di rivendicare una sorta di semiindipendenza, cercando di stabilire unaforte continuità fra le convenzioni medievali e le concessioni posteriori al 1528.Proprio la fedeltà dimostrata nel 1625-26 e la docilità con cui si sono accettatii numerosi interventi di architettura militare decisi allora e negli anni seguentisono gli argomenti avanzati per tutelare gli interessi locali: come se, appunto, sivolesse prendere del tutto sul serio quel titolo di «fedelissima» – che qualche sto-rico ottocentesco considererà quasi una beffa – e metterlo a frutto per garantir-si un trattamento di particolare favore.
Ma i ripetuti atti di fedeltà vanno soprattutto valutati tenendo conto di colo-ro che ne sono protagonisti: non, genericamente, la cittadinanza, bensì i savo-nesi nobili e ricchi, titolari delle principali cariche civiche. È fra il patriziatosavonese e quello genovese che si stabilisce un’alleanza destinata a consolidarsinel corso del Cinquecento e del Seicento. Se Genova riconosce a Savona auto-nomia e privilegi, lo fa perché sa di avere in quella città un ceto di interlocuto-ri affidabili, i cui interessi trovano una ragionevole tutela nell’assetto politicovigente. Quando nel 1572 gli Anziani, rivolgendosi ai Senatori, riconosconoche a Savona da 44 anni – cioè proprio dal 1528 – ci sono «honesta abbondanzae viver pacifico, com’è notorio», mantenuti «in virtù delli benigni ordini diVostre Signorie Illustrissime», non lo fanno semplicemente per piaggeria neiconfronti dei governanti, ma perché ne sono almeno in parte convinti93. Comese ne mostra persuaso, pochi anni dopo, il nobile Pietro Battista Ferrero ilquale, in una sua cronaca, annota che dal 1528 Savona «resta totalmente sottoil felicissimo stato e governo della Signoria Illustrissima nostra di Genova, contanta quiete dell’habitatori, quanto maggior desiderar non si possi, vivendosi inessa ogni uno pacifico possessor e della robba e dell’honor suo»94.
Ebbene, la «quiete» o il «viver pacifico» sono vantaggi di cui tutti possonogodere, ma la tutela della «robba» e dell’«honore» interessano soprattutto chipiù ne possiede. D’altronde non potrebbe essere altrimenti: in tutta l’Italia del-l’età moderna gli Stati, lo abbiamo già ricordato, si reggono principalmente gra-zie alle ampie deleghe concesse dal potere centrale ai notabili locali e al consen-so di questi. Proprio questo meccanismo finisce un po’ dappertutto per assotti-gliare e circoscrivere i ceti dirigenti delle città soggette. Una delle conseguenze
90
92 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 8r-9r (il corsivo è nostro).93 Ibidem, c. 222, 4 settembre 1572.94 F. NOBERASCO, I cronisti savonesi cit., p. 239.
Capitolo 5
più evidenti della crisi politica d’inizio Cinquecento e della fine della libertasItalie è, tanto al centro quanto alla periferia, l’accentuarsi dei fenomeni di “chiu-sura oligarchica”. In particolare nelle città suddite, che formalmente sono ridot-te a enti amministrativi ma che conservano ampi margini di privilegio in mate-ria fiscale, annonaria e giurisdizionale, la gestione della cosa pubblica «sirestringe nelle mani di un ceto abbastanza chiuso e compatto a cui conviene oradare il nome di patriziato»: un ceto che monopolizza le funzioni di rappresen-tare e amministrare la città e di porsi come mediatore tra il principe e i suddi-ti.
Attraverso tale monopolio l’oligarchia locale, che ormai ha perso «ogni pos-sibilità di rivincita nei confronti del principe o della dominante», riesce peròa tutelare adeguatamente i propri interessi «nell’amministrazione delle finan-ze locali, nella distribuzione dei carichi fiscali, nella gestione dei beni comuni,nella direzione dei monti di pietà e dei luoghi pii, nonché […] dell’annona.In ciò il potere nobiliare trova i suoi contenuti limitati ma concreti e dietro adessi si delinea il terreno obiettivo dei suoi contrasti con i ceti popolari urbanie contadini»95. Savona, all’interno della Repubblica genovese, si trova dunquein condizioni molto simili a quelle di tante altre città suddite della Terrafermaveneziana, del Granducato di Toscana o dello Stato pontificio, in cui vieneformandosi un «sistema patrizio» che ha sì garantito fra l’inizio delCinquecento e la fine del Settecento una certa stabilità istituzionale e unalunga pace sociale, ma ha anche fissato il privilegio in forma ereditaria nellemani di un piccolo numero di famiglie, ha accentuato le distanze fra i ceti espesso ha imbalsamato la società cittadina all’interno di una lunga stagnazio-ne economica.
A Savona il governo del Comune – che non è mai stato democratico, perchénessun regime comunale lo era – ha tuttavia favorito a lungo la parte “popola-re”: gli statuti del 1375, ad esempio, garantivano una notevole prevalenza delceto mercantile; quelli del 1404 davano invece la preminenza agli «artefici»; i«nobili» restavano comunque minoritari. Fra Quattro e Cinquecento i giochicominciano però a cambiare, e gli aspiranti alle cariche importanti si riduconoa una cerchia di maggiorenti comprendente nobili, ricchi mercanti, uomini dilegge e notai. Questo gruppo monopolizza via via la formazione dei «bussoli»da cui estrarre i responsabili delle magistrature comunali, e si trasforma così inuna vera oligarchia. «La chiusura fu completa quando i bussoli, fino alloraannualmente rinnovati, vennero in qualche maniera cristallizzati, consentendol’imbussolamento solo a un certo numero di cittadini “abili”, il cui nome erascritto nelle liste degli “ascritti” ai tre ordini dei nobili, dei mercanti e degli arti-
91
95 E. FASANO GUARINI, Potere e società negli Stati regionali italiani del ‘500 e del ‘600, Bologna, Il Mulino,1978, pp. 30-31; A. I. PINI, Dal comune città-Stato al comune ente amministrativo, in Comuni e signorie: istitu-zioni, società e lotte per l’egemonia, Torino, Utet, 1981 (Storia d’Italia diretta da G. GALASSO, vol. IV), pp. 451-587 (qui pp. 519-520).
Sottomissione, autonomia, consenso
sti»96. Sappiamo con certezza che nel 1519 viene nominata dagli Anziani unacommissione di sei cittadini investiti dell’autorità di “imbussolare” coloro chepossono aspirare alle cariche, e anche di promuovere le persone dal bussolodegli artigiani a quello dei mercanti, e da questo a quello dei nobili: a dimo-strazione del fatto che già a quest’epoca esiste fra i tre ordini una gerarchia cheprivilegia, appunto, quello dei nobiles e in seconda istanza quello dei mercatores.
Da questo momento in poi, il ceto dirigente risulta senza dubbio irrigiditoin tre ordini di “ascritti” nettamente separati dal resto della popolazione urba-na, sia pure con un diverso grado di rappresentatività: infatti tutti i nobili equasi tutti i grandi mercanti si ritrovano automaticamente dentro i rispettivibussoli, mentre nel terzo entra solo una parte degli artifices, vale a dire gli arti-giani più ricchi e appartenenti alle arti maggiori, i quali finiranno per conside-rarsi anch’essi parte del patriziato. La piena sottomissione a Genova, la crisi eco-nomica che inevitabilmente ne consegue e la stessa politica della Dominante, laquale ha bisogno in sede locale di un referente stabile e numericamente ristret-to, non fanno che favorire e accentuare questa “serrata” del ceto dirigente. Amezzo secolo dal 1528, mentre l’ascrizione è di fatto divenuta ereditaria, i ran-ghi si sono ormai chiusi e in seguito tenderanno a restringersi ancora97. Manmano che alcune famiglie nobili si estinguono, o che alcuni mercanti si stabili-scono all’estero, bisognerà procedere periodicamente a nuove imbussolazioni opassaggi da un ordine all’altro, superando però ogni volta con fatica le resisten-ze dei già ascritti, i quali non gradiscono ulteriori ingressi all’interno dell’oli-garchia.
Questo patriziato savonese, che già prima del 1528 aveva legami d’interessee una certa affinità sociale con l’aristocrazia genovese, in seguito si viene sem-pre più integrando, sia pure in subordine, con quelli che il vocabolario dell’e-poca qualifica con l’appellativo di «Magnifici», o che definisce «cittadini digoverno», vale a dire gli ascritti al libro d’oro della nobiltà di Genova, gli uniciche hanno titolo per ricoprire le cariche politiche in seno alla Repubblica. Aquesti ultimi spetta la direzione dello Stato, mentre l’élite savonese – soprattut-to i nobiles, ma anche i mercatores ad essi socialmente affini, perché gli stessinobili sono in genere dei grandi mercanti o dei finanzieri – dispone pienamen-te delle leve del potere in sede locale. Attraverso l’autonomia comunale, che
92
96 R. MUSSO, Ceto dirigente cit., p. 41 (ma confronta tutte le pp. 39-47, da cui sono tratte le informazioniche diamo di seguito).
97 Questi i dati relativi ai cittadini ascritti nei bussoli dei tre ordini (ibidem, p. 42):anno nobili mercanti artisti totale1574 71 36 51 1581594 69 63 57 189 1633 29 39 42 1101637 35 42 49 1461645 54 34 46 1341663 56 39 36 1311685 36 29 37 1021694 41 34 41 1161710 25 39 28 92
Capitolo 5
come abbiamo visto essa difende sempre con puntiglio, favorisce i propri inte-ressi economici e rintuzza ogni rivendicazione da parte dei ceti inferiori dellacittà o delle «ville». E intanto si imparenta con i Magnifici genovesi, ha rapportidi affari con loro, si costruisce dimore cittadine o residenze di campagna cheriproducono in tono minore i palazzi di Strada Nuova o le ville di Albaro eSampierdarena; mentre alcune fra le stesse famiglie aristocratiche dellaDominante – i Balbi, i Durazzo, i Doria, i De Mari, i Cambiaso – investono iloro capitali a Savona e dintorni, comprando terreni e facendosi costruire son-tuose case di villeggiatura98; o dispongono donativi e lasciti a favore di opere piee chiese savonesi.
Accade perfino che molti membri della famiglia Doria, nel 1636, «per la lorogran devozione portata a Nostra Signora di Misericordia» chiedano di essereascritti alla nobiltà savonese99. Ma più spesso avviene il contrario: approfittan-do della legge che consente ogni anno di inserire nuove famiglie, anche delDominio, nel libro d’oro del patriziato genovese, alcuni savonesi diventanonobili di Genova, con tutti i diritti politici che ne conseguono. Nel 1576 l’a-scrizione tocca a Nicola Pavese e a suo figlio Camillo, nel 1612 a BartolomeoRiario, nel 1626 a Francesco Maria Pavese e a Nicolò Gavotti (quest’ultimo«ascritto in riconoscimento dell’offerta fatta per le spese belliche»), nel 1629 aun suo cugino omonimo, nel 1647 a Giovanni Battista Grasso, nel 1655 aGiovanni Battista Gavotti, nel 1673 a Lorenzo Ferrero, nel 1698 a suo fratelloGiovanni Battista100. Nel contempo diversi patrizi savonesi, al pari di numero-si loro omologhi genovesi, diventano titolari di feudi, specie nel regno di Napolie in Sicilia (e analizzeremo più avanti le ragioni di queste promozioni sociali);mentre altri, tra XVI e XVII secolo, riescono a entrare nell’ordine dei Cavalieridi Malta, cosa che all’epoca rappresenta una meta molto ambita per gli espo-nenti dei patriziati cittadini, perché ne consacra lo status di aristocratici e garan-tisce loro il riconoscimento internazionale dell’appartenenza ai ranghi più ele-vati della società101.
Infine, nel considerare i fitti intrecci fra i patrizi di Savona e quelli di Genova,non vanno dimenticati i numerosissimi casi in cui esponenti della migliore ari-stocrazia genovese (Doria, Durazzo, Pallavicini, Lomellini, De Mari, Brignole),magari nella veste di ex Governatori, si atteggiano a «patroni» e protettori dellacittà, ne promuovono opere pubbliche, ottengono sgravi fiscali o finanziamen-ti102. Grazie ad essi la Dominante si presenta allora con un volto benevolo, bendiverso da quello della matrigna o della tiranna tramandato dalla storiografialocale, ma ciò non significa che per la città suddita le cose vadano nel miglioredei modi, che non esistano fenomeni di crisi economica e di spopolamento dei
93
98 Su questi temi si vedano le puntuali osservazioni di G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., pp. 21-26.99 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit. vol. II, pp. 272-273.100 M. NICORA, La nobiltà genovese dal 1528 al 1700, «Miscellanea storica ligure», II, 1961, pp. 217-310.101 F. BRUNO, La ricostituzione del “Libro d’oro” del Comune di Savona, parte I, AMSSSP, vol. II, 1919, pp.
43-94 (in particolare p. 50).102 Molti esempi si trovano nei registri copialettere degli Anziani (ASS, Comune I, 140-143).
Sottomissione, autonomia, consenso
quali Genova porta almeno in parte la responsabilità. Quel che però va dettocon insistenza è che la sudditanza, la pressione militare, la decadenza e tutti glialtri fenomeni negativi che indubbiamente hanno interessato la città, nonhanno colpito tutta la popolazione savonese; molti indizi inducono a sospetta-re, viceversa, che per una parte sia pure esigua – un 5-7% di nobili, possidentie grandi mercanti – la dominazione genovese si sia rivelata tollerabile, in alcu-ni casi persino vantaggiosa. È al livello di questa piccola frangia che la sotto-missione, temperata dalla residua autonomia comunale e soprattutto dal privi-legio di ceto, si trasforma in sostanziale consenso. Ancora una volta, dunque,più che guardare al rapporto e allo scontro fra Savona e Genova intese come dueblocchi omogenei, bisogna disarticolare la città suddita nelle sue componentisocioeconomiche, e considerare che, per l’appunto, la “conquista” genovese haavuto sulle diverse classi sociali conseguenze differenti.
Ciò non toglie che, nel breve e soprattutto nel lungo periodo, la città nel suocomplesso abbia subito un impoverimento, difficile da quantificare ma indubi-tabile: nel 1781 un autorevole membro del Minor Consiglio, Niccolò De Mari,denuncerà in modo esplicito che Savona, «città grande e popolata», è ormaidivenuta «un scheletro senza ombra di commercio»103. Resta però da capire sela responsabilità di questa decadenza stia tutta dalla parte della Dominante, onon vada piuttosto condivisa con quel patriziato locale che non ha esitato adaccettare la sottomissione in cambio del proprio quieto vivere e dei propri van-taggi, forse meschini ma ben concreti. È un problema analogo a quello che dadiversi anni la storiografia sta affrontando a proposito dell’Italia spagnola: alleaccuse tradizionali che indicavano nella Spagna l’unica colpevole della crisi ita-liana, oggi fa riscontro un esame approfondito delle classi dirigenti locali, del-l’autonomia che i re Cattolici hanno sempre garantito loro, e quindi della forteresponsabilità che esse hanno avuto in quella crisi.
Dei patriziati lombardi del Cinque-Seicento, ad esempio, è stato detto chenon solo hanno barattato senza esitazione la conservazione dei loro privilegi conla perdita del potere politico a favore di Madrid, ma che addirittura di grandepolitica non hanno voluto più sapere nulla: «ai loro occhi, una sola era la poli-tica reale, effettiva, importante, quella cioè incentrata entro il breve giro dellemura di Cremona, di Lodi, di Milano e poche miglia fuori, nel contado. Ildominio spagnolo fornì loro pertanto un’occasione splendida per non cambia-re quasi nulla di sé, per evitare ogni rinnovamento sostanziale – stese sopra ilDominio una sorta d’ombrello protettivo, alla cui ombra i gentiluomini pote-rono permettersi d’ignorare gli Stati nazionali, le monarchie moderne, tutta lanuova storia insomma, perpetuando, nelle mutate condizioni generali, un veroe proprio basso medioevo»104. In questo contesto, quei Decurioni cremonesiche pensano «sempre e costantemente solo ai propri immediati e mai a degliipotetici interessi dello Stato», di cui non sospettano neppure l’esistenza,
94
103 ASG, Archivio segreto, 1643.104 G. POLITI, La società cremonese cit., p. 296.
Capitolo 5
Sottomissione, autonomia, consenso
mostrano una notevole somiglianza con gli Anziani, i Razionali e i Consiglierisavonesi, chiusi nel breve orizzonte cittadino, preoccupati soprattutto di salva-guardare le loro franchigie fiscali, pronti sempre a piangere – nei loro carteggi– sulle miserie del popolo minuto, ma ancor più solleciti a scaricare sulle suespalle tutti gli oneri. Al punto che, se si riflette alla forte continuità esistente frail patriziato savonese dell’età moderna e la classe dirigente della cittànell’Ottocento e ancora in parte del Novecento, può affiorare un sospetto: chequella classe dirigente, esprimendo una storiografia accanitamente antigenove-se, abbia voluto scaricare ogni torto sulla Dominante e mettere in ombra lecolpe dei propri antenati.
95
La lunga insistenza della storiografia locale sul carattere violento e oppressi-vo della dominazione genovese da un lato ha messo in ombra quelle forme diautonomia e di consenso che abbiamo cercato di analizzare nel capitolo prece-dente, d’altro lato ha in gran parte ignorato gli strumenti effettivi dei quali ilgoverno della Dominante si è servito per controllare il proprio Dominio e tenerlegate a sé le varie comunità. Tra questi certo non manca, nel caso savonese,l’uso sia pure potenziale della forza: l’esistenza a Savona di una grande fortezzae la presenza di un nutrito presidio militare sono mezzi atti a scoraggiare formedi disobbedienza o di rivolta. Di fatto, però, gli apparati militari non verrannomai chiamati in causa in una città mantenutasi tranquilla e – davvero – «fede-lissima» per due secoli e mezzo. Mentre i veri instrumenta regni resteranno, pertutto il corso dell’età moderna, quelli del tutto pacifici abitualmente impiegatidalla Repubblica e dagli altri Stati italiani: il rispetto dell’autogoverno locale daun lato, e dall’altro la funzione giudiziaria.
Il “principe” è tale in quanto è in grado, con i suoi giusdicenti locali e i suoitribunali d’appello centrali, di rendere imparzialmente giustizia ai popoli. «Fareche la bilancia della giustizia non pieghi più da una parte che dall’altra»:Genova sa che non c’è «cosa alcuna che mantenghi la quiete più ferma ne’ luo-ghi». Questo è l’unico cemento che può tenere insieme uno Stato come quellogenovese, dove l’esercito è di modesta entità e le forze di polizia sono evane-scenti, dove manca un interesse comune, una fedeltà dinastica, meno che maiuna compattezza “etnica”. L’autorità e la stessa legittimità della Repubblica,infatti, si fondano proprio sulla capacità arbitrale e trovano una ragione d’esse-re nella litigiosità permanente dei sudditi, i quali disputano frequentementetanto a titolo personale, quanto fra gruppi familiari e sociali o fra comunità,borghi e ville1. Ma appunto questa litigiosità collettiva fa sì che il potere stata-le si esplichi spesso sotto forma di «tutela» nel pieno senso giuridico del termi-ne: «le comunità vengono considerate a guisa de’ pupilli», i cui atti devono esse-re sottoposti alla potestà di un tutore2.
Accanto alla funzione giurisdizionale, dunque, si afferma un po’ dappertuttonell’Italia del Cinque-Seicento un’attività “regolativa” e tutoria da parte deigoverni: «la finalità dichiarata dell’intervento centrale […] sta nella necessità diproteggere la communitas», e in particolare la città suddita, «da tutti coloro chepossano abusare della sua strutturale debolezza. E i primi sospettati sono ovvia-mente i di lei stessi rappresentanti». Gli amministratori civici sono fatti ogget-
97
1 G. ASSERETO, Le metamorfosi della Repubblica cit., pp. 61-62.2 ASG, Magistrato delle Comunità, 541, 10 febbraio 1779.
Capitolo 6
Sovrano tutore e comunità pupilla
to di una serie di divieti e limiti che riguardano anzitutto la gestione finanzia-ria dei comuni (alienare beni, fare spese straordinarie, concedere dilazioni aidebitori, intentare cause inutili, spedire costose “ambasciate” al governo centra-le); nel contempo sono loro imposti alcuni obblighi nello stesso ambito (tene-re una corretta contabilità, gestire oculatamente le proprietà comunali, curarel’esazione delle imposte, mirare al pareggio del bilancio).
Il potere centrale viene così scoprendo che «una mediazione puramente giu-diziaria non è sufficiente a tenere in equilibrio la periferia e che a questo fine èindispensabile il ricorso alla regolazione normativa»3. Senza addentrarci nellacomplessa tematica relativa a queste funzioni di tutela e alla loro rilevanza sulpiano del diritto pubblico, dei rapporti centro-periferia e della costruzione delloStato moderno, in questo capitolo vorremmo limitarci ad esaminare alcuni epi-sodi in cui una certa incapacità da parte della città suddita di governare se stes-sa, di badare alle proprie finanze, di riformare le proprie istituzioni, di risolve-re dispute interne (tra le sue fazioni e i suoi “ordini”) o esterne (nei confronti di“ville” e comunità vicine) richiede l’intervento – “tutorio”, appunto – dellaDominante, e in tal modo ne corrobora e legittima il potere. In un certo senso,dunque, è la stessa comunità subiecta, o per meglio dire il suo ceto dirigente,che rafforza e stringe le proprie catene; ma nel contempo è la sudditanza cheinduce in essa una sorta di “minorità” e la costringe a ricorrere di frequente al“principe”, impedendole di assumere pienamente le proprie responsabilità e diemanciparsi.
Nell’aprile del 1571 i Senatori genovesi riferiscono che, «havendo inteso persuppliche a noi presentate et per altre relationi che in Savona erano nati alquan-ti dispareri tra gl’ordini de’ cittadini nobili, mercadanti et artisti circa il nume-ro che d’ognuno di detti ordini dovessi esser posto nel Consiglio, negli Antianiet altri magistrati di quella città, et circa il modo d’imbussolare dei cittadini etdi variarli da bussula a bussula», e «desiderando sommamente et con paternoaffetto [...] la quiete di quella città», vi hanno inviato due commissari nelle per-sone dei nobili Silvestro Cattaneo e Geronimo Fieschi perché indaghino e sug-geriscano i rimedi. Al termine di tale indagine, il Senato decreta una riformadello statuto politico che non varia la composizione delle magistrature civiche(tranne per quanto riguarda il Consiglio grande, ridotto da 54 a 51 membri,con 24 nobili, 12 mercanti e 18 artigiani e con un numero minimo legale di42), ma obbliga tutti i magistrati «che maneggiano denari, vettovaglie o altrieffetti pubblici» a dare entro un mese dalla fine del loro incarico «buon contodello aministrato con satisfatione di tutto quello e quanto ciascuno restassedebitore»: un resoconto preciso, dunque, e il totale saldo del denaro eventual-mente da essi dovuto. Le delibere dovranno essere approvate da una maggio-ranza di 2/3, ma occorreranno i 3/4 ove si tratti di «spendere, distribuire o
98
3 L. MANNORI, Introduzione a Comunità e poteri centrali cit., pp. 24-27; l’analisi più puntuale della funzio-ne di tutela in uno Stato italiano d’antico regime è, a nostro avviso, quella effettuata dallo stesso Mannori nelsuo citato volume Il sovrano tutore.
Capitolo 6
donare o in altro modo disponere dei denari et beni del Comune». Una partedella riforma, dunque, concerne la gestione della finanza e del patrimonio pub-blico, per la quale vengono precisate alcune regole. L’altra parte riguarda inve-ce il passaggio dei cittadini dall’uno all’altro bussolo: viene confermato che pertale passaggio basta una maggioranza dei 2/3 del Consiglio, ma «perché in que-sto si proceda con più equalità et sincerità et non sia luogho a collusioni et favo-ri indebiti», si dichiara che non si possa trattare più di un singolo caso per voltasia nel Consiglio stesso, che delibera, sia nel magistrato degli Anziani, che pro-pone le eventuali promozioni4.
Le vicende del 1571 restano piuttosto oscure. L’intervento genovese, di fatto,è provocato da un tumulto di maestri artigiani che chiedono al Senato unadiminuzione del peso del secondo ordine – i mercanti – nel governo della città5.Ma quale sia l’esatta dinamica del conflitto fra i tre ordini e come si delineinole alleanze ci sfugge. Carlo Bitossi ha parlato di un «dissidio tra nobili da unaparte, e mercanti e artefici dall’altra», che avrebbe anticipato quello in atto aGenova nel 1575-76 fra nobiltà «vecchia» e «nuova», con esiti analoghi: un ridi-mensionamento del potere dei nobili savonesi, una maggior presenza dei«nuovi» nel governo genovese6. Guido Malandra ha affermato invece che il1571 è «l’anno della consacrazione del dominio nobiliare» a Savona, «perchél’oligarchia genovese introduce a forza le riforme necessarie per cambiare qual-cosa nella forma e non mutare nulla nella sostanza, nell’ovvia difesa di un’oli-garchia savonese alla quale è ormai stretta, oltre che da legami di interesse, dalegami ancora più saldi di parentele»7.
Le due interpretazioni divergono solo in apparenza. Quel che accomuna l’in-tervento genovese del 1571 e le Leges Novae del 1576 è appunto l’intenzione didelimitare in modo preciso il novero dei cittadini di pieno diritto (su un pianolocale nella città suddita, al livello del governo nella Dominante) e di specifica-re a quali condizioni si può entrare a farne parte. Si tratta, in effetti, della defi-nizione di un’oligarchia, che a Genova sarà formalmente unica, a Savonarimarrà tripartita, con una prevalenza dei nobiles – i quali nelle cariche che con-tano hanno tanti membri quanti gli altri due ordini messi assieme – ma con iltentativo di creare un canale di scorrimento preciso, che consenta sia ai merca-tores e agli artifices più ricchi e influenti, già presenti nei bussoli, di salire nel-l’ordine superiore; sia a coloro che ne sono fuori, ma hanno maturato i requisi-ti per farne parte, di entrarvi. In tal modo viene garantita a tutti gli «imbusso-lati» l’appartenenza all’area del privilegio, ma si prospetta anche un moderato eordinato ricambio dell’area stessa. Il fatto davvero importante, però, è che ilconflitto ha sollecitato l’ingerenza del potere centrale, rivelatasi determinanteper riequilibrare la situazione locale, e quindi ha creato un precedente signifi-cativo.
99
4 ASS, Comune I, 209, 1 aprile 1571; A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 193; G. V. VERZELLINO, Dellememorie particolari cit., vol. II, pp. 85-86.
5 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., p. 143.6 C. BITOSSI, Il governo genovese cit., p. 80.7 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., p. 14.
Sovrano tutore e comunità pupilla
Di lì a poco, nella crisi del 1575-76 che sfocia in una vera guerra civile, ancheGenova – i cui patrizi, come sentenzia papa Gregorio XIII, si sono comportatida gente che «non è atta né a comandare né ad essere comandata»8 – dovràricorrere a una mediazione esterna, certo di profilo ben più alto perché vi sonointeressati il pontefice, l’imperatore e il re di Spagna. Ma da un lato la stessapluralità dei mediatori, in sostanziale rivalità fra loro, finisce per garantire erafforzare l’indipendenza genovese; d’altro lato la Repubblica saprà trarre daquella crisi lo stimolo a darsi una costituzione stabile e a pacificare in via pres-soché definitiva il proprio ceto dirigente. Non altrettanto si può dire nel piùmodesto caso di Savona: qui il mediatore è unico e si identifica con il governodella Dominante, il quale ne approfitta per ergersi ad arbitro delle tensioni loca-li, per atteggiarsi a benefico pacificatore, ma anche per avviare quel controllosulla gestione finanziaria e patrimoniale del Comune che in seguito Genova cer-cherà dappertutto di rafforzare.
Quanto all’élite savonese, la sua incapacità di manovrare da sola i meccani-smi del ricambio politico-sociale all’interno della città si rivelerà ben presto cro-nica. I problemi, infatti, qui non derivano tanto da generiche forme di litigio-sità nobiliare – come la faida che nel 1593 contrappone i Del Carretto e iGavotti da una parte, i Ferrero e i Pavese dall’altra9 – quanto appunto dalladistribuzione del potere fra gli ordini. Nel 1599, ad esempio, scoppiano nuovecontroversie per la promozione di alcuni personaggi dall’uno all’altro bussolo eil Podestà Marc’Aurelio Lomellini, nei suoi dispacci al Senato, rileva una sortadi squilibrio permanente nel «reggimento politico» della città. Egli proponeallora di fissare un numero certo degli «ascritti» nei rispettivi bussoli e insistesulla necessità di garantire il rinnovo degli stessi e uno scorrimento regolare,anzi automatico: «questa passata da bussolo a bussolo, se si facessi così ex offitiodarìa grandissima sodisfattione col tempo». Ora a Savona – sostiene il Lomellini– «li nobili prevagliono in maniera che non v’è Stato dove più prevagliano, némeno a Venetia»: essi fanno in modo che nel primo bussolo non possa entrarenessuno che già non appartenga a famiglia patrizia, e anche «che nel mettersinell’altri bussoli ogni cosa debba dipendere da loro».
Tocca allora al Podestà, d’intesa con il Senato, procedere alle operazioni di«imbussolamento», sia pure tra grandi difficoltà e resistenze che dimostranoquanto sensibile sia il patriziato savonese ai propri miseri privilegi di casta, maanche quanto i suoi puntigli lo mettano alla mercé dell’autorità centrale e deisuoi rappresentanti in loco10. Da allora in poi ci sarà uno stillicidio di interventida parte di Podestà, Governatori e Serenissimi Collegi ogni qual volta si trattidi variare qualcosa all’interno dei bussoli. Chi scorra le pagine del Verzellino, adesempio, si imbatte spesso in accenni a contestazioni e disordini relativi a que-sta materia, risolti dal giusdicente genovese «derogando allo Statuto per decre-
100
8 V. VITALE, Breviario della storia di Genova, Genova, Società ligure di storia patria, 1955, vol. I, p. 230.9 R. MUSSO, “Signori in città”: i Del Carretto a Savona (XIII-XVIII secolo), AMSSSP, n. s., vol. XXXVIII,
2002, pp. 5-13.10 C. BITOSSI, Il governo genovese cit., pp. 83-85 e 88-98.
Capitolo 6
to del Senato»11. Ma ancor più se ne trovano nelle filze e nei registri contenen-ti gli atti del Senato stesso relativi a Savona.
La casistica è varia. Nel 1634 i nobili non riescono a far approvare alcunenuove ascrizioni al loro ordine perché mercanti e artigiani vi si oppongono; nel1647 si disputa se qualcuno, non appartenente a famiglia nobile, possa esseremesso nel primo bussolo senza prima essere stato nel secondo; nel 1667 duemercanti, Giovanni Agostino e Giovanni Battista Rizzo, pur essendo «facoltosidi beni di fortuna» e «padroni del feudo di Corticelle in Monferrato con tito-lo di marchesato», stentano a farsi accogliere nel primo ordine. In tutte questeoccasioni i senatori genovesi devono intervenire sollecitando una pronta solu-zione, minacciando («altrimenti ci puoneremo le mani noi»), infine disponen-do d’autorità quel che le magistrature cittadine non riescono a portare a com-pimento12. E ancora: nel 1692 gli Anziani cercano di accrescere con nuovi sog-getti il bussolo degli «artefici», ma il Consiglio non approva le loro proposte,non si sa se perché gli stessi candidati «habbino cercato di fuggire questo cari-co, o per altre mire o pensieri de’ Consiglieri»; nel 1696 ci sono troppi artigia-ni – «persone in quali non concorrono le dovute qualità» – che vogliono il pas-saggio al secondo ordine, ciò che rischierebbe di sguarnire il terzo e «caosereb-be confusioni e pregiudicii anche all’onorevolezza di detto ordine de’ mercan-ti»13.
Come che sia, si finisce sempre per rivolgersi al governo: a volte, appellan-dosi al «paterno affetto» dei Magnifici, sono gli Anziani a pregarli «di supplirecon la loro autorità al mancamento de’ voti»; altre volte sono gli aspiranti all’a-scrizione che chiedono un atto d’imperio dei senatori contro le resistenze deiConsiglieri; altre ancora, come avviene nel 1740, è il potere centrale che impo-ne agli Anziani recalcitranti una grande infornata di ascritti per «la necessitàd’impinguare li respettivi ordini di questi cittadini»14. Un intervento come que-st’ultimo, nient’affatto isolato, si spiega con l’ostruzionismo continuo, da partedei privilegiati, ai nuovi ingressi: una chiusura di ceto che non riguarda solo inobili, ma anche i mercanti. Nel 1716, di fronte alla richiesta di un talFrancesco Felice Bosello – che è «merciaro» ma assai benestante – il quale inten-de essere ascritto al secondo ordine, gli Anziani precisano che tale ordine non èaperto «per ogni genere di mercanti, ma solo per quelle persone che, non essen-do ancora capaci d’esser create nobili, vivono per il più di loro entrate e deco-rosamente, senza esercitare arti mecaniche» e possedendo qualche proprietà ter-riera: «ché se detto secondo ordine ametesse tutti quelli che mercantegiano enegotiano senza alcuna distintione, sarebbero capaci d’entrarci quei che nego-
101
11 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 195, 231, 264, 336-337. Lo Statuto politi-co di Savona prevede che Anziani e Razionali possano ogni anno proporre per l’imbussolamento sino a novecittadini «d’anni venti atti e sufficienti per amministrare et essercitare li officii publici», «servando sempre laparità delli gradi», cioè l’equilibrio fra i tre ordini. Spetta poi al Consiglio approvare o meno le proposte conuna maggioranza di almeno 2/3.
12 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 22v-23r, 105-106, 256-257.13 ASS, Comune I, 143, 9 luglio 1692 e 20 luglio 1696; ASS, Comune I, 211, c. 1.14 ASS, Comune I, 143, 12 febbraio 1740.
Sovrano tutore e comunità pupilla
tiano frutti et anco robbe più vili». D’altronde anche il terzo ordine «non amet-te altre persone che non habbino qualche sostanze e facino qualche arte civi-le»15.
Siamo dunque di fronte a una guerra miserabile all’interno della città suddi-ta, a un egoismo che vede ogni ceto arroccato sulle proprie posizioni di privile-gio e – cosa ancor più curiosa – a un continuo lamento da parte savonese perla scarsità di persone abilitate a reggere la cosa pubblica, cui corrisponde peròun altrettanto continuo rifiuto di allargare la cerchia degli aventi diritto allecariche; il tutto complicato dal fatto che, non di rado, alcuni che possiedono irequisiti per divenire cives optimo iure non hanno alcuna voglia di diventarlo,altri che già lo sono schivano le magistrature considerandole un fastidio, o peg-gio un pericolo perché si può essere chiamati a rendere conto di quanto si èamministrato. Tra il 1638 e il 1640 alcune suppliche degli Anziani chiedono diimpedire che i cittadini si sottraggano con vari pretesti agli incarichi pubblici,o che accettino solo «li uffici honorevoli» schivando quelli «onerosi»16; nel 1650si denuncia che «una parte della miglioranza de’ cittadini cerca di sottrarsi dallicarrichi»17; nel 1742 si ribadisce che «molti preferendo i loro privati interessi a’vantaggi del Comune ànno procurato rendersi immuni da’ pubblici uffici condecreti d’essenzione», e ad essere esentati spesso sono proprio «i più idonei efacoltosi»18. In una forma o nell’altra, sono perciò i maggiorenti savonesi a rico-noscere e a dimostrare con i fatti la propria “minorità”, a sollecitare ad ognioccasione la “tutela” della Dominante.
Tale tutela, come abbiamo già accennato, tende ben presto ad esercitarsianche in altre forme, soprattutto nel campo dell’amministrazione finanziaria.Gli uomini di governo si preoccupano sempre più, tra lo scorcio delCinquecento e il Seicento, di mettere ordine nella finanza delle comunità ligu-ri sia per rendere più agevole e incrementare il prelievo fiscale, sia per ottempe-rare a una norma di buon governo e per dare miglior fondamento alla propriaautorità. Eliminare eventuali abusi o ingiustizie in questo campo significa infat-ti far apparire la Repubblica garante della giustizia e della buona amministra-zione, affezionarsi i sudditi, corroborare una sovranità territoriale posta non dirado in discussione dentro e fuori lo Stato. Nel 1624 ad esempio, a un annodalla creazione del Magistrato delle Comunità, il governo mette in atto unosforzo generalizzato per controllare le spese straordinarie dei corpi locali e permettervi un freno19; negli anni seguenti si cerca in vari modi di contenerne l’in-debitamento.
Così il 16 febbario 1634 il Senato dispone che gli Anziani «in l’avenire deb-bano presentare al Governatore pro tempore in principio del suo governo la
102
15 Ibidem, 24 luglio 1716.16 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 41r.17 ASS, Comune I, 214, 28 settembre 1650.18 ASS, Comune I, 143, 29 gennaio 1742.19 ASG, Senato-Senarega, 1828, febbraio 1624.
Capitolo 6
lista de’ debitori» della Comunità, e che costui usi «ogni possibile diligenza per-ché detti debitori siano esatti»20. Quattro anni dopo in effetti il GovernatoreCesare Durazzo, «desiderando [...] che la città si sollevi tutto quello ch’è possi-bile delli grossi debiti da’ quali è oppressa», ingiunge ai Maestri Razionali diriscuotere «quel danaro che da suoi debitori li è dovuto, acciò col valersi del pro-prio non paghi [...] interesse sopra quello che piglia a censo dalli altri», e si offredi appoggiare tale riscossione «col bracchio della giustitia». Proibisce inoltre chesi emetta alcun mandato «pagabile a quelli che sono notati debitori nelli libripublici», ma che «il credito si contraponghi al debito», altrimenti saranno imagistrati della città a pagare di tasca propria21. Nel 1658 un altro Governatore,Giovanni Battista Doria, giunge a Savona in un momento difficile, dovutoanche all’epidemia di peste che ha colpito la regione. Ma egli non tarda adaccorgersi che esistono vuoti più antichi, causati dalla pessima amministrazio-ne dei magistrati locali. L’anno dopo indirizza perciò al Senato una relazionenient’affatto lusinghiera per il ceto dirigente savonese: questo è spesso in disac-cordo al suo interno, come ben sappiamo, ma è però ben concorde nel «procu-rare con varii pretesti che il denaro publico serva agli interessi de’ privati», e inparticolare dei «capi e potenti nelle fattioni»22. Da ciò è derivata una «granmassa di debiti, che la Communità è stata necessitata in varii tempi adossarsi»,una altrettanto grande massa di crediti «quali per le private passioni non esattiin tempo, si rendono hora impossibili a scuodersi», e una contabilità pubblicaintricata e incomprensibile.
Tutto dipende – sostiene il Governatore – dall’«auttorità conferta a’ cittadinida’ loro Statuti», grazie ai quali i magistrati non vengono controllati che da lorostessi: hanno perciò mano libera negli appalti delle gabelle, nei pagamenti delleforniture, nella riscossione dei crediti, e dovunque favoriscono i loro amici eparenti a danno della collettività. Per «fermar questa ruota, che macinando delcontinuo ridurrà fra breve in polvere questa povera Communità», il Senato spe-disce a Savona una deputazione composta dai patrizi Napoleone Spinola,Francesco Torriglia e Giacomo Saluzzo, i quali nel 1660 presentano un minu-zioso piano di riforma. Esso rivede le procedure, intensifica i controlli, inaspri-sce le pene, crea un nuovo magistrato dei Sindacatori destinato ad accoglieredenunce, anche anonime, dei cittadini e dotato del potere di sorvegliare e giu-dicare ogni «ufficiale» comunale23. Approvato dal Senato e presentato come unapanacea, il piano è in realtà indice dell’impotenza del governo genovese di fron-te al malaffare locale, perché non intende davvero intaccare l’autonomia dellaComunità. I Sindacatori, eletti fra i cittadini savonesi, finiscono più per osta-colare gli interventi del Governatore che per far cessare gli abusi; le nuove
103
20 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 22r.21 ASS, Comune I, 202, 12 agosto 1638.22 La relazione (ASG, Magistrato delle Comunità, 862) è integralmente pubblicata in G. ASSERETO, Una
riforma dell’amministrazione finanziaria di Savona a metà del XVII secolo, «Miscellanea storica ligure», XVIII,1986 (Studi in onore di Luigi Bulferetti), n. 2, pp. 555-585 (in particolare pp. 560-567).
23 Il testo delle Riforme fatte dal Senato Serenissimo sul governo politico di Savona, approvato il 12 ottobre1660, è anch’esso integralmente pubblicato in G. ASSERETO, Una riforma cit., pp. 567-582.
Sovrano tutore e comunità pupilla
norme si accavallano agli Statuti vigenti e, come ogni ripetizione rafforzata diuna legge, denunciano l’inefficacia della legge stessa. Sul finire del secolo il cro-nista Agostino Maria de’ Monti, riferendosi a quegli anni, annota: «Fu creatoun nuovo magistrato de’ Sindicatori composto di tre cittadini, uno per ogniordine, che con il Governatore dovevan censurare gl’Antiani e magistrati: al pre-sente poco o niente si vede esercitar la sua carica»24.
Pochi decenni dopo, dunque, delle riforme del 1660 non resta nulla.L’allegra finanza continua, come pure la cattiva abitudine di emettere mandatipiù o meno pagabili a seconda dei rapporti più o meno buoni esistenti traamministratori e creditori del Comune25. Il risultato non può stupire, perché èla conseguenza di un sistema di potere che non è in grado di mutare davvero irapporti di forza tra il centro e la periferia dello Stato. Che ogni tessera delmosaico rimanga al suo posto, che non si creino entro le comunità tensioni talida mettere in pericolo la quiete della Repubblica, è tutto ciò che il governo puòdesiderare. Qualche ruberia, qualche favoritismo, qualche giochetto nei libricontabili non sono cose da togliere il sonno ai Magnifici, specie trattandosi diuna città come Savona, dove da tempo tutti i principali cittadini hanno accet-tato la sudditanza a Genova e le migliori famiglie si sono segnalate – come sap-piamo – per atti di generosità verso la Signoria. Ma quella cattiva amministra-zione, quei piccoli intrallazzi, contribuiscono anch’essi a fare sì che il patriziatogenovese si senta sempre autorizzato a guardare Savona come una “pupilla”, unacomunità eternamente minorenne, nella quale è legittimo sorvegliare, censura-re, correggere.
Accade così che il governo intervenga a più riprese per riformare gli statuti el’amministrazione delle opere pie laicali. Nel 1619, 1632, 1639 e 1659, adesempio, il Senato deve occuparsi dell’Ospedale Grande di Savona, e nel 1660approva una generale riforma della sua gestione26. Dieci anni prima i «deputatisopra le cose ecclesiastiche», venuti a conoscenza che nell’Ospizio del Santuario«seguono molti maneggi, con danno notabile di essa opera», ottengono che ilSenato vi spedisca un patrizio a rivederne i conti; e nel 1659 sempre il Senatone modifica i capitoli27. Le stesse riforme promosse nel 1660 per iniziativa diGiambattista Doria contengono misure di sorveglianza per «l’Ospitale di SanPaolo» e per la Compagnia che lo amministra, per l’Ufficio di Nostra Signoradi Misericordia, per quello che amministra il lascito di Gerolamo Sacco (unaricca donazione destinata a dotare «povere figlie» e ad «accomodare le strade
104
24 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 268. Già nel 1685, d’altronde, viene chiesta «l’abolizione dellanuova magistratura de’ Sindicatori, atteso che li signori Governatori la riconoscono contraria alla loro autto-rità», e che tre cittadini restano impegnati in essa per un biennio, quando potrebbero ricoprire utilmente altriincarichi (ASS, Comune I, 214, 1 agosto 1685).
25 Così risulta da una denuncia stesa il 9 febbraio 1696 dal Governatore Domenico Spinola (ASG, Anticafinanza, 895).
26 ASS, Comune I, 214, 8 gennaio 1659; Rifforme fatte dal Serenissimo Senato dell’anno 1660 intornoall’Ospitale Grande di Misericordia detto il Scagno (su cui si veda M. T. NOBERASCO, I capitoli dell’OspedaleGrande della Misericordia nei secoli XVI e XVII, AMSSSP, n. s., vol. XXIX, 1993, pp. 15-57, in particolare pp.52-57).
27 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 154; ASG, Magistrato delle Comunità, 862.
Capitolo 6
della città e mezzo miglio fuori di essa», ma le doti prendono spesso altre dire-zioni, e le strade «restano tutte guaste» perché qualcuno impiega quei denari per«fabricar le strade e mura intorno le proprie vigne» o per fare «vetriate nelle lorologgie»), per «l’Ufficio de’ Poveri» (a proposito del quale si abolisce «l’uso cheogni ufficiale singolarmente distribuischi l’elemosine come più li piace»).
Col tempo, il ricorso alla tutela e al patrocinio della Dominante diventa siste-matico e comprende materie d’ogni genere. Ad essa ci si rivolge per ogni con-tenzioso con le «ville» e le comunità vicine: Lavagnola e Legino per questionifiscali o giurisdizionali; Vado e Segno per i diritti sul bosco delle Tagliate;Quiliano per la «terra castaneativa e boschiva» della Consevola, che il Comuneaveva anticamente acquistata dai Del Carretto, ma che i quilianesi occupano«con mala fede» senza pagare «né pigione né livello»28. Se ne implorano di con-tinuo gli interventi per l’arginamento del torrente Letimbro, o addirittura per«fare il regolamento della goduta dell’acqua de’ beudi de’ molini di Lavagnola»,disponendo il calendario dei prelievi per l’irrigazione di orti e giardini29. Se nericerca la protezione contro le ingerenze indebite dell’autorità ecclesiastica, o glisi chiede – come nel 1652 – di premere sulla curia romana per evitare che ven-gano allontanati da Savona i gesuiti, «padri a noi molto grati e necessari a cote-sto popolo»30. Ci si appella ai Governatori perché ricevano le istanze dei conso-li delle arti, procedano contro gli esercenti abusivi, perseguano le infrazioni airegolamenti corporativi, dirimano le controversie fra gli «artisti»31.
Più in generale, chiunque abbia un diritto da rivendicare, un privilegio da farvalere, una grazia da impetrare, è al Senato o al Governatore che si rivolge piùche al Comune, anche al di là di quanto prescriverebbe la legge. La stessa ammi-nistrazione civica non fa che appellarsi all’autorità centrale per qualsiasi delibe-ra: non solo in materia di lavori portuali, per i quali le convenzioni obbliganola città suddita a richiedere il consenso della Dominante, ma quasi per qualun-que affare, tanto che la “minorità” diventa – si può dire – un abito mentale ditutti i savonesi, a cominciare proprio da coloro i quali reggono la cosa pubbli-ca.
Questi ultimi, talvolta, sono persino patetici nella loro dichiarata impotenza,come si può vedere nel seguente esempio. Corre l’anno 1694, e la consueta«scarsità di soggetti nei bussoli» induce gli Anziani e i Razionali a promuoverealcune modifiche allo Statuto: ridurre il numero legale – da 42 a 34 – nellesedute del Consiglio, raddoppiare la durata di alcune cariche, abbreviare daquattro a due anni il periodo di “vacanza” dopo cui un Anziano uscente puòriassumere la carica. Portate più volte in Consiglio, queste proposte non riesco-no ad ottenere la maggioranza necessaria; vengono reiterate nel 1699, con esitougualmente negativo; si torna a discuterne nel 1708, e ormai i toni si sono fatti
105
28 ASS, Comune I, 1169, 1170, 1172; ASS, Comune I, 210, libro III, c. 118.29 ASS, Comune I, 211, c. 153.30 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 176.31 ASS, Comune I, 214, passim.
Sovrano tutore e comunità pupilla
drammatici: «Questa fedelissima città – si legge in una lettera spedita al Senato– non ha mai avuto così poco governo, né già mai è stata in necessità d’haver-ne tanto bisogno come al presente. Li cittadini sono pochi di numero, d’azen-da, d’applicazione e d’affetto alle cose publiche, cooperandovi anche molto lamala contingenza de’ tempi. [...] Li magistrati sono tanto in numero che quasisuperano li cittadini». Inutile dire che, mentre si ripetono e anzi si rafforzano leproposte di allungare la durata delle cariche, ancora una volta si fa resistenza adogni allargamento del ceto dirigente, cioè a nuove imbussolazioni. Comunquesia, le modifiche vengono nuovamente respinte.
Il governo genovese, di cui naturalmente è stato invocato l’intervento, cercadi persuadere i Consiglieri savonesi, ma di fronte alla loro opposizione desiste escrive al Governatore di Savona che «non volendo il Senato Serenissimo infrin-gere in cosa benché minima l’osservanza delli Statuti di quella città, non ha sti-mato perciò bene di comprovare quelle propositioni alle quali non è concorsoil numero legitimo de voti di quel Magnifico Consiglio». Così la pratica nel1719 è ancora aperta e solo nel 1725, dopo un’ennesima supplica degli Anzianial Senato, questo con un atto di forza riesce infine a prolungare la durata dellecariche e a facilitare il rinnovo del Consiglio32. La vicenda ci pare emblematica:nonostante la debolezza del potere centrale e la sua riluttanza a interferire negliaffari locali, il ceto dirigente savonese si mostra talmente incapace di risolvereun problema di governabilità, che infine il diktat dall’alto diviene inevitabile.
Un altro aspetto che in chiusura di questo capitolo è giusto richiamare, siapure di sfuggita, riguarda non più la “minorità” di Savona – di cui Genova s’av-vantaggia, si può dire, quasi senza volerlo – bensì un merito che la Dominanteha saputo costruirsi nel tempo con un’attività costante nel campo giudiziario.Parlando nel Minor Consiglio, durante la sessione dell’aprile 1784, un patriziogenovese di cui non ci è noto il nome sosteneva: «La buona amministrazionedelle due giustizie, come è uno dei primari bisogni delle società governate, cosìè uno de’ principali intenti di un buon governo. Tutti sanno che dalla crimina-le dipende la pena, l’esempio, la tranquillità e la sicurezza; che dalla civile resta-no assicurate le proprietà e amparati [cioè protetti] li diritti tanto attivi quantopassivi delli individui»33. Ebbene, chi scorra le 71 filze e i 64 registri della Curiacriminale di Savona dal 1671 al 1797 vi trova un’imponente documentazionesull’amministrazione della giustizia penale, accurata e formalizzata, rispettosadelle leggi e delle procedure34.
Su questa attività, che è di competenza del Governatore in quanto «giudicede’ malefici», o comunque del suo ufficio, le carte degli Anziani e dei
106
32 ASS, Comune I, 61, 11 febbraio e 8 marzo 1694; 7 e 19 dicembre 1699; 6 settembre, 13 settembre e 19novembre 1708; 8 marzo 1719; ASS, Comune I, 62, 16 gennaio 1726; ASS, Comune I, 211, cc. 62 e 69.
33 ASG, Archivio segreto, 1643.34 Sono i registri e le filze conservati nel fondo Criminalium dell’Archivio di Stato di Savona.
Capitolo 6
Sovrano tutore e comunità pupilla
Consiglieri, nell’arco di oltre un secolo, non rilevano mancanze né denuncianoabusi. È vero che la giustizia criminale è soprattutto l’affare dei poveri e delbasso popolo, e raramente inquieta i maggiorenti; ma molti indizi inducono apensare che le lagnanze non ci siano perché il potere giudiziario si esercita inmodo sostanzialmente corretto ed equo, da parte di giusdicenti che tra l’altro,oltre a perseguire i delitti, si preoccupano di un’infinità di materie d’interessecollettivo. Così, ad esempio, vediamo che i Governatori controllano che il panedei forni pubblici sia ben cotto e lievitato, fanno rispettare – a tutela delle fami-glie – il divieto dei giochi d’azzardo come il biribis o la bassetta o il faraone,verificano che non si peschi «con reti spesse et ordigni chiamati bronzini, gan-gani et altri simili metodi» distruttivi, si adoperano perché i carcerati malativengano ricoverati all’ospedale. Atti che incidono sulla vita quotidiana di molti,e che danno anch’essi il senso di una tutela, di una «paterna benevolenza».
107
Dopo il 1528, scriveva Filippo Noberasco nel 1925, la decadenza di Savonaè lenta, «l’organismo forte e sano tarda a morire», tanto è vero che verso il 1570Agostino Abate nella sua cronaca annovera ancora 112 famiglie nobili, 63 nego-zianti all’ingrosso e molti di più al minuto. «Ma la decadenza – proseguivaNoberasco – è implacabile, fatale. Alla fine del secolo Savona è città morta e isuoi figli migliori sono sparsi a Roma, nel Napoletano, in Sicilia, in Francia,nella Spagna e poi alle Indie per trovare altrove quel pane che la patria più nonpoteva dare». A sostegno di questa affermazione, egli citava un’istruzione datanel 1626 dagli amministratori del Comune a due «oratori» che devono perora-re la causa di Savona preso il Senato: in essa si ricorda che «sono astretti li cit-tadini ad abandonare la città et redursi [...] in dominio forestiere [...], partedella nobiltà si trova habitar Roma, Napoli, Milano e Sicilia, e li mercanti etartisti in Sicilia, Finario, Monferrato et altri paesi [...] alieni per procurarsi ilvivere»1.
In anni più vicini a noi Nello Cerisola ha parlato anch’egli delle «centinaia difamiglie che, in questa triste circostanza, dovettero abbandonare la loro terra,ridotta a ben misera condizione, e rifarsi una vita lontano dalla loro patria».Molte di queste, «che avevano accentrato la maggior parte dei capitali e deicommerci», lasciarono la città: «alcune rientrando nelle zone di provenienza»,di solito il Piemonte, il Monferrato o le Riviere; «altre cercando altrove, specienei regni di Napoli e di Sicilia [...], l’avvenire che la patria non poteva piùgarantire». Tra queste i Bertolotto, i Boccalandro, i Boccone, i Conte, i Ferrero,i Gastodengo, i Grasso, i Naselli, i Pavese, i Raimondi e i Ricci «che crearonopotenti ed attive baronie nel sud d’Italia»2.
Queste affermazioni, che si possono trovare anche in altre storie di Savona,hanno forse bisogno di qualche chiarimento. Il lettore può ricavarne l’impres-sione di una città globalmente immiserita, dalla quale gente di ogni condizionesociale – dai nobili e dai mercanti in giù – è costretta a fuggire spinta dal biso-gno: i più intraprendenti faranno poi fortuna altrove, tanto da procurarsi feudie ricchezze. Ora, se è lecito ipotizzare che con il procedere del secolo XVISavona abbia conosciuto i colpi di una crisi economica determinata dalladistruzione del porto e dalle demolizioni attuate per fare posto ad opere milita-ri (ma vedremo nel capitolo 13 quanto sia difficile ricostruire l’andamento del-l’economia savonese), e se di conseguenza è ragionevole dar credito ai docu-menti che denunciano un certo spopolamento della città causato dai flussimigratori di lavoratori che cercano in altri paesi occasioni di impiego, non biso-
109
1 F. NOBERASCO, I cronisti savonesi cit., pp. 308-309.2 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., p. 243.
Capitolo 7
Fare fortuna nel «secolo dei genovesi»
gna confondere questi ultimi con le famiglie patrizie sopra ricordate, anzi biso-gna tenere ben distinte le due emigrazioni: ricordando soprattutto che quegliillustri personaggi si trasferiscono nell’Italia meridionale non per cercare fortu-na, ma perché lì la fortuna l’hanno già fatta da tempo, e vanno semmai a rac-coglierne i frutti, o piuttosto a incrementarla. Mentre i loro omologhi che scel-gono di restare non hanno vita difficile.
Mai come sotto il dominio di Genova – aveva scritto con acume tanti anni orsono Agostino Bruno – l’antica nobiltà, tranne quelle famiglie che prendendo acuore le sventure della patria o per altri motivi abbandonarono Savona, ebbe campodi mettersi in evidenza e di preponderare nella vita cittadina. I nobili formavanouna casta ricca e potente, ambiziosa di cariche e di onori, non dispregiante però legrandi speculazioni marittime, con importanti relazioni in Italia e all’estero, divisaassolutamente dal resto del popolo e sfolgorante di lusso e di sfarzo, con numerosoesercito di contadini, di operai, di amici o di adulatori ai suoi ordini3.
Prendiamo brevemente in esame questi ultimi, cioè i patrizi e i ricchi mer-canti “sedentari”, che non lasciano Savona. Esiste un fenomeno ben noto, gra-zie soprattutto agli studi di Carlo Varaldo, che rende testimonianza della lorobuona salute economica: verso la metà del XVI secolo, cioè in un periodo tra-dizionalmente considerato di profonda crisi, la città è un cantiere dove nume-rosi palazzi di lusso vengono costruiti ex novo o profondamente ristrutturati edecorati. Tale è il caso delle residenze De Lorenzi, Naselli, Gavotti, Ferrero,Spinola, Pavese, Chiabrera, Sormano e altre ancora4. Ritorneremo su questoargomento nel capitolo 12, ma fin d’ora ci preme sottolineare che la crisi nonha impedito ad alcune famiglie di rimanere ricche, o ad altre di subentrare aquelle decadute, e di effettuare interventi edilizi di grande prestigio, specie serapportati alle dimensioni della città.
Se poi andiamo a guardare da vicino alcune di quelle famiglie, ci accorgiamofacilmente che la loro ricchezza trae origine non tanto dagli affari savonesi,quanto da una serie di operazioni e di reti economiche localizzate lontano dallaloro piccola patria. Il caso più evidente è forse quello dei Gavotti, che sonoanche i più attivi nell’edilizia di lusso: già discretamente ricchi all’aprirsi delCinquecento, essi accrescono di molto le loro fortune proprio in questi anni,grazie soprattutto ai rapporti con Roma e con la Curia pontificia. Troveremoben presto molti di loro insediati nella Città eterna, in un bel palazzo pressoTrinità dei Monti, a contatto con gli ambienti culturali più vivaci e – ciò chepiù conta dal nostro punto di vista – in buoni rapporti d’affari con famiglie delcalibro dei Borghese, dei Barberini e dei Falconieri5. Non diversa la situazione
110
3 A. BRUNO, Storia di Savona cit., p. 130.4 Cfr., ad esempio, C. VARALDO, Insediamenti religiosi e problemi urbanistici nella Savona post-tridentina,
AMSSSP, n. s., vol. XIII, 1979, pp. 43-61.5 Ibidem, p. 50; C. STRINATI, Giovanni Baglione nella cappella Gavotti del Duomo di Savona, AMSSSP, n. s.,
vol. XII, 1978, pp. 27-37; C. VARALDO, Documenti d’arte a Savona: la “fabbrica” del palazzo Naselli Feo e la qua-dreria dei Gavotti, ivi, pp. 53-74; Letà di Rubens, Dimore, committenti e collezionisti genovesi a cura di P.BOCCARDO, Milano, Skira, 2004, pp. 445-451.
Capitolo 7
delle altre famiglie coinvolte nelle iniziative edilizie, le quali hanno sempre qual-cuno dei loro membri attivo a Roma – come i Siri – o più spesso nell’Italiameridionale e in Sicilia, o ancora al servizio della Spagna.
Per capire chi siano i savonesi ricchi e prestigiosi nel Cinque-Seicento non c’èbisogno di svolgere ricerche difficili, ma è sufficiente scorrere la cronaca delVerzellino il quale, a maggior gloria della propria città, ha avuto cura di segna-lare – di solito sotto l’anno corrispondente alla data della morte – i personaggiche hanno percorso le migliori carriere e hanno accumulato le fortune piùcospicue. Si può tentare di raggrupparli in alcune categorie principali, anche senon tutti si lasciano incasellare facilmente. Pantaleo Corradengo Niella, adesempio, è cavaliere gerosolimitano, ma anche cameriere segreto di papa PaoloIII, «d’ordine del quale portò nel fine del mese di gennaio del 1535 la spadaconsecrata ed il cappello fornito di gioie al principe [Andrea] Doria almirantedell’imperatore, ond’egli ne ricevé da esso principe ducati 500, allorquando simosse all’espugnazione della Goletta», presso Tunisi, poi felicemente conqui-stata dal Doria stesso: riunisce quindi in sé l’appartenenza al prestigioso ordinedi Malta (al pari di altri suoi concittadini dell’epoca), il servizio del pontefice,il favore dell’ammiraglio di Carlo V6. Di quest’ultimo Vincenzo Gavotti, mortonel 1544, è «commissario di campo e delle munizioni», e per lui combatteanche suo figlio Gasparo7. Mentre dell’alta burocrazia papale fa parte ScipionePavese, morto nel 1590, che ottiene la carica di protonotario apostolico8.
Qui abbiamo già individuato due tipologie importanti. Ci sono i personag-gi che fanno fortuna a Roma, e che stringono rapporti di natura ecclesiastica ofinanziaria con la curia pontificia e con lo Stato della Chiesa (tali i casi deiGavotti e dei Siri già nominati, di Giuseppe Ferrero arcivescovo di Urbino evice legato di Avignone, di Ambrogio Pozzobonello tesoriere di Perugia e di suofiglio Francesco titolare di numerose abbazie in Italia e in Francia, di GirolamoRaimondi Feo chierico di camera di Gregorio XV, di Francesco Geloso, anch’e-gli protonotario apostolico al pari di suo fratello Giovanni Antonio, mentre glialtri fratelli Giuseppe e Girolamo raggiungono alti gradi fra i Teatini e i MinoriConventuali9), e costoro rappresentano per così dire l’onda lunga, o gli epigo-ni, di quella grande infornata di savonesi che avevano beneficiato dei favorielargiti dai papi Della Rovere. E ci sono coloro i quali percorrono brillanti car-riere militari al servizio degli Asburgo di Spagna o degli «assentisti» genovesi,primi fra tutti i Doria: così Giovanni Battista Pavese, «almirante delle dieci navidelle quali era generale il marchese di Santa Croce [Álvaro de Bazán, marchesedi Santa Cruz], quando riportò vittoria contro il Drac [Francis Drake] famosocorsaro inglese»10; o Giovanni Battista Feo, «capitano della padrona del princi-
111
6 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 36-37 e 53.7 Ivi, p. 43.8 Ivi, p. 128.9 Ivi, pp. 155, 195-196, 232, 261-263. Su Ambrogio Pozzobonello «di Savona», attivo a Roma nel 1622
come banchiere, si veda R. AGO, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Roma,Donzelli, 1998, p. 52.
10 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 166-167.
Fare fortuna nel «secolo dei genovesi»
pe Doria», il quale «si ritrovò in varie imprese con esso principe, che sovente glidiede carico di molte galere, come fece anche il duca Doria suo figliuolo»; oNicolò Rella, «capitano della [galera] capitana di don Carlo Doria Carretto»; oFrancesco Spinola (del ramo savonese di questa famiglia), che nel 1588 «si trovòalla celebre giornata d’Inghilterra [cioè alla battaglia della Invencible Armada]con alcune lancie di suo conto», e poi «fu all’impresa di Algeri con altri cava-lieri a sue spese», ottenendo infine da Filippo III una commenda di SanGiacomo da duemila scudi11.
Ma ben più numerosa e rilevante è una terza categoria, rappresentata da tuttiquei savonesi che si arricchiscono nei regni di Napoli e di Sicilia, divenendo perlo più titolari di feudi. Tra costoro si può ricordare Nicolò Bertolotto, «insertonella famiglia Doria», di cui assumerà il cognome, e «ascritto alla nobiltà diGenova»; il ricchissimo Nicolò Pavese, plurifeudatario napoletano, il cui figlioCamillo si imparenta anch’egli con i Doria, si fa ascrivere al pari di suo padre al«libro d’oro» genovese, va ad abitare a Genova e compra una sontuosa villa aSampierdarena; Giovanni Giacomo Gastodengo, morto a Palermo nel 1590dopo essere divenuto uno dei più ricchi banchieri del regno di Sicilia e averretto assieme ad altri finanzieri savonesi tre dei grandi «caricatoi» dell’isola dacui vengono imbarcati i grani, cioè quelli di Sciacca, Girgenti e Termini Imerese(tantoché, durante la carestia che colpisce anche Savona nel 1590, è proprio alGastodengo che si rivolge il Magistrato di Abbondanza savonese per fargli spe-dire alla sua città natale 1.500 salme di grano12); Giacomo Brignone, che nel1634 ottiene dalla Regia Camera di Palermo per la forte somma di 7.000 onzel’anno l’«arrendamento ossia ingabellazione e fitto» per sei anni delle isoleEgadi, cioè Favignana, Levanzo e Marettimo «con i loro mari, tonnare e peschedel corallo», isole e tonnare che poi cederà ai Pallavicino, con i quali è in affa-ri13; e poi gli altri Bertolotto e Pavese, e i Raimondi, i Ferrero, i Feo, i Nano, iBoccone, i Grasso, i Conte, tutti acquirenti di importanti baronie napoletane,calabresi, pugliesi, siciliane14. Famiglie che talvolta hanno avviato la loro pene-trazione economica nell’Italia meridionale già prima del fatidico 1528, o chel’hanno trionfalmente realizzata soprattutto negli anni successivi: ma nell’uncaso e nell’altro qualificare costoro come emigranti spinti dalla necessità è dav-vero fuori luogo.
112
11 Ivi, pp. 185, 229, 257. Altri savonesi rientrano in queste due tipologie, e in particolare nella seconda: cosìGiovanni Antonio Bertolotto, capitano di Alessandro Farnese, morto nell’assedio di Anversa; SeveroGambarana «maestro di campo cesareo e capitano di Carlo V»; Giulio Gavotti militare al servizio di Filippo II,che si batte eroicamente a Orano dove è creato capitano sul campo; Francesco Multedo «capitano imperialenelle Fiandre»; Filiberto Pavese, capitano con Alessandro Farnese in Fiandra; Andrea, Bartolomeo e UrbanoRella, capitani sulle galere dei Doria, l’ultimo dei tre «comito reale» a Lepanto, e perciò pensionato da donGiovanni d’Austria (F. NOBERASCO, I savonesi illustri, Savona, Tip. Italiana, 1939, ad voces).
12 ASS, Comune I, 209, c. 528.13 N. CALLERI, Un’impresa mediterranea di pesca. I Pallavicini e le tonnare delle Egadi nei secoli XVII-XIX,
Genova, Unioncamere Liguria, 2006, pp. 13-18.14 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 111, 126-127, 142, 149, 151, 160, 183-184,
188, 193-195, 267.
Capitolo 7
Semmai va segnalato che mentre a Savona si estinguono, nel corso delCinquecento, le parentele di più antica origine cittadina, resistono invece e anziemergono prima le famiglie “roveresche”, quelle beneficate in vario modo daSisto IV e da Giulio II, poi soprattutto – dopo la metà del secolo – quelle «chehanno intuito le possibilità esistenti nei paesi spagnoli e che hanno cominciatoa trasferirvi i loro interessi principali, partecipando così a quello che è l’affaredel secolo, l’affare di Spagna. In qualche caso addirittura il nobile savonese siinserisce talmente nel nuovo ambiente oltremarino da recidere quasi i legamicon Savona, dove i suoi interessi si sono andati progressivamente riducendo, edapparire ormai come un emigrato»15. Ma di solito questa emigrazione non spez-za i legami con la madrepatria: chi emigra mantiene stretti rapporti con i paren-ti rimasti a Savona, fa donativi e lasciti alle chiese e alle opere pie della città d’o-rigine, se può vi ritorna in vecchiaia e chiede che i suoi resti vi siano sepolti.Significativo, in particolare, è il caso del convento francescano di San Giacomoche, specie nel Cinquecento, fruisce di cospicui legati e si riempie di monu-menti funebri delle maggiori famiglie, soprattutto quelle – le abbiamo nomi-nate qui sopra – che sono riuscite «a mantenere in vario modo ed accentrare sudi sé un vasto patrimonio finanziario, attraverso contatti con ambienti esterni,[...] con l’acquisizione di latifondi ed investiture nobiliari nel meridione d’Italiaed instaurando un fitto intreccio di rapporti matrimoniali»16. Ma i lasciti vannoanche in altre direzioni, come accade per le somme, erogate dai Pavese e daiRaimondi, che nel 1642 servono ad aprire un «ridotto per le donne converti-te»17; o come i molti denari che vengono spesi per abbellire il Santuario e altriedifici religiosi18.
Resta da chiedersi se le fortune di questi “emigranti” (alcuni dei quali non silimitano a fare affari nell’Italia spagnola, ma ottengono posizioni di rilievo nellaSpagna stessa, come quel Giuseppe Crema divenuto «reggitore della città diValladolid», o nelle colonie del Nuovo Mondo, come quel Giuseppe Lambertiche accumula un’enorme ricchezza in Perù19) abbiano qualcosa che le accomu-na, e la risposta è certamente affermativa. Esse rientrano infatti a pieno titolo inquel grande flusso di affari che si irradia in tutto l’impero spagnolo avendocome epicentro la città di Genova: una corrente copiosa e pressoché inarresta-bile che ha indotto grandi storici come Frank C. Spooner, Felipe Ruiz Martine Fernand Braudel a coniare e divulgare, per il periodo fra l’inizio delCinquecento e la terza (o la quinta) decade del secolo successivo, l’appellativodi «secolo dei genovesi», che è poi divenuto di uso comune. Si può dunqueaffermare in modo netto che i successi savonesi nei regni di Napoli e di Siciliasono stati resi possibili solo da una stretta intesa e comunanza di interessi con
113
15 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., p. 26.16 G. MURIALDO, L’insediamento francescano osservante di San Giacomo in Valloria: un convento per la città,
in San Giacomo, un monumento da conoscere e riutilizzare, Savona, Tip. La Stampa, s. d. [1983?], pp. 7-42.17 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 53r.18 Si veda, ad esempio, E. MATTIAUDA, Per la cappella della Visitazione nel Santuario di Nostra Signora della
Misericordia di Savona, AMSSSP, n. s., vol. XXVI, 1990, pp. 63-79.19 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 361 e 386-390.
Fare fortuna nel «secolo dei genovesi»
le grandi casate genovesi le quali, soprattutto a partire dall’alleanza stipulata fraAndrea Doria e Carlo V, hanno sferrato un assalto senza precedenti alle risorsedi quelle terre. «I Doria – ha scritto Arturo Pacini – [...] furono gli apripista diuna nuova fase della presenza genovese nel regno di Napoli caratterizzata dal-l’espansione di feudi titolati, che finì per assumere nel secolo XVII proporzionia dir poco vistose»20.
Una nuova fase, appunto: perché i genovesi (intendendo con questo terminei liguri in genere, come allora era abituale) non hanno certo atteso l’età di CarloV per stendere le loro reti affaristiche sul Mezzogiorno d’Italia. Alcuni di essisono presenti nei regni meridionali fin dal tempo di Federico II di Svevia e con-solidano tale presenza sotto la dinastia angioina. In Sicilia nel XIV secolo con-trollano ormai il commercio granario, costituendo a Palermo un consorzio perl’acquisto e la distribuzione delle «tratte», cioè i permessi di esportazione deigrani. All’inizio del Quattrocento sono divenuti indispensabili ai sovrani arago-nesi, le cui finanze non possono fare a meno del loro contributo; nel corso delsecolo i loro affari non fanno che dilatarsi in altri settori. Hanno consolati nellecittà più importanti come Palermo, Trapani e Sciacca; hanno proprie cappelle eluoghi di sepoltura; spesso acquistano la cittadinanza palermitana o messineseper ottenere i privilegi giudiziari che ne conseguono. Nel Cinquecento, infine,allargano la loro influenza su ogni genere di commerci e di manifatture. «APalermo un intero quartiere è da loro abitato; vi sono notai che rogano esclusi-vamente per loro [...]. Genovesi sono i maestri setaiuoli di Messina, genovesisono i librai di Palermo [...]; genovese è la carta per scrivere e per stampare,attraverso Genova arrivano i prodotti dell’Europa settentrionale. [...] Hanno ilmonopolio assoluto delle assicurazioni marittime, comprano e vendono tuttociò che è possibile comprare o vendere». Penetrano in forza negli appalti fiscalie nei servizi di tesoreria, gestiscono feudi, «trappeti» da zucchero, tonnare, fer-riere, vetrerie, imprese edilizie. Ma soprattutto accentrano nelle loro mani leoperazioni di banca e i prestiti ai sovrani: prestiti che vengono rimborsati nonin denaro – che manca – ma in «tratte» di grani, uffici, titoli nobiliari, terre,feudi, intere città o isole (come nel caso appunto dei Pallavicini, che resterannopadroni delle Egadi e delle loro tonnare dalla metà del Seicento al 1874). LaSpagna, da cui ora la Sicilia dipende, trae dalle risorse dell’isola il molto dena-ro necessario per le sue azioni militari contro i barbareschi e per pagare la flot-ta di Andrea Doria: ciò contribuisce a far lievitare nell’isola, almeno sino allaguerra dei Trent’anni, le occasioni di guadagno21. Per di più Madrid deve tra-sferire il denaro ricavato dalle gabelle, dai monopoli e dalle vendite di feudi sici-liani in altre parti del proprio impero, a Milano e soprattutto nel teatro di guer-ra delle Fiandre: «un servizio di molti milioni di scudi che i genovesi feceropagare alla Spagna molto caro»22.
114
20 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria cit., p. 151.21 C. TRASSELLI, Genovesi in Sicilia, ASLSP, vol. LXXXIII, 1969, pp. 153-178.22 ID., I rapporti tra Genova e la Sicilia: dai Normanni al ‘900, in Genova e i genovesi a Palermo, Genova,
Sagep, 1980, pp. 13-37 (qui p. 26).
Capitolo 7
È in questi affari di banca che i savonesi si inseriscono proficuamente, comeaccade ad alcuni dei Gastodengo23; ed è altresì nella speculazione sul commer-cio granario che essi accumulano grosse fortune, come è il caso di TommasoRiario e del suo socio Paolo Ferrero. Qui i profitti sono enormi per chi, dispo-nendo di capitali e di merci, può fornire anticipi a piccoli e grandi produttori:in tal modo compra il grano a marzo-aprile a un prezzo bassissimo, e spessopaga in manufatti con un rapporto di scambio estremamente favorevole, perchétalvolta con dieci pezze di stoffa si possono acquistare 40 tonnellate di frumen-to24. Quello stesso Tommaso Riario lo troviamo fra coloro che, negli anni 1556-1559, sottoscrivono ingenti prestiti a favore di Filippo II impegnato nella guer-ra mediterranea contro i Turchi; e con lui ci sono gli altri savonesi Ottaviano eNicolò Ferrero e Giovanni Battista Ricci, che operano unitamente ai grandinomi della finanza genovese: i Centurione, i Doria, gli Imperiale, i Lomellini, iPinelli, gli Spinola25. Ancora Tommaso Riario e Paolo Ferrero lucrano nel 1560sulle forniture alle galere della flotta siciliana, e siccome la Regia Corte di Sicilianon riesce a pagarli, il 16 gennaio 1561 essa garantisce il loro credito su undazio di esportazione, che l’anno seguente i due prenderanno in appalto; unasuccessiva fornitura viene rimborsata mediante un prelievo sui donativi regi e ilrilascio di tratte per l’esportazione di grani. Nelle assicurazioni marittime, anchequi in società con molti genovesi, troviamo attivi nella seconda metà delCinquecento i savonesi Giovanni Filippo Della Rovere e Giacomo Muzio, ilquale ultimo si occupa anch’egli di «tratte» con il suo concittadino RaffaeleFerrero26.
Che genovesi e savonesi in Sicilia vivano fianco a fianco lo si deduce anchedalla loro comune frequentazione della Capela mercatorun januensium nellabasilica palermitana di San Francesco, dove un’epigrafe celebrativa del 1472recante l’insegna araldica del savonese Sisto IV Della Rovere – il quale era statodocente di teologia nello Studium minorita della città – risulta innalzata dai«nobiles ianuenses». Accanto ci sono altre due epigrafi, una dedicata al papagenovese Innocenzo VIII Cybo, l’altra al savonese Giulio II, che ricorda il pri-vilegio da lui concesso ai genovesi (cioè ai liguri) nell’anno IV del suo pontifi-cato «di potersi comunicare nella cappella di San Giorgio, per mano di un cap-pellano secolare da essi stessi eletto». E in quella cappella, tra molte lapidi sepol-crali di genovesi, troviamo ancora una volta i nomi savonesi di GiangiaconoGastodengo e dei fratelli Gian Francesco e Gian Antonio Ferrero27.
115
23 ID., Genovesi in Sicilia cit., p. 168.24 ID., I rapporti tra Genova e la Sicilia cit., pp. 29-30.25 R. GIUFFRIDA, Aspetti dell’attività finanziaria genovese nella Sicilia spagnola, in Atti del III incontro “Genova
e i Genovesi a Palermo”, Palermo, Istituto storico siciliano, 1982, pp. 61-84 (in particolare p. 64). 26 Ivi, pp. 65-70. Sul monopolio genovese delle tratte – in base al quale «dans chaque carricatore un petit
nombre de marchands assure l’écrasante majorité des exportations» – si veda anche M. AYMARD, Le blé de Sicile,année 1500, in Studi dedicati a Carmelo Trasselli a cura di G. MOTTA, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1983, pp.77-97.
27 R. PATRICOLO, La cappella dei mercanti genovesi nel chiostro della basilica di San Francesco in Palermo, inAtti del III incontro cit., pp. 85-110.
Fare fortuna nel «secolo dei genovesi»
La stessa simbiosi la ritroviamo, con analoghi meccanismi, nel Mezzogiornocontinentale. Il Regno di Napoli è infatti per gli Asburgo di Spagna il grandeserbatoio feudale dell’intera penisola, nel quale si possono elargire signorie etitoli in cambio di prestiti e anticipazioni fiscali. Molte sono le famiglie italianeche riescono ad occuparvi principati e baronie, ma fra tutte, per quantità e qua-lità della loro presenza, emergono quelle genovesi, le quali in tal modo otten-gono un doppio risultato: da un lato entrano in un circuito nobiliare ben piùautorevole e prestigioso di quello derivante dalla loro condizione di patrizi cit-tadini, o dal possesso di piccoli feudi imperiali nell’Appennino ligure-piemon-tese (tipico il caso di Andrea Doria e dei suoi discendenti, che vorranno intito-larsi «principi di Melfi», o «duchi di Tursi», feudi situati entrambi in Basilicata);d’altro lato si costituiscono proficue rendite28.
Anche nel Napoletano i genovesi sono presenti da secoli nelle attivitàimprenditoriali e mercantili (grano, olio, vino, seta calabrese), poi si dedicanoall’amministrazione di patrimoni feudali e ai prestiti ai baroni, infine conqui-stano l’egemonia nel rapporto con la finanza pubblica grazie alla nuova collo-cazione filospagnola della loro Repubblica. Dopo il 1528 appartenere allanatione genovese significa «godere, a Napoli come negli altri reinos della coro-na spagnola, di un rapporto privilegiato con la monarchia: a metàCinquecento esso si trasformerà in una sorta di clausola di gruppo stranierofavorito nelle relazioni con il Re Cattolico». Al tempo della guerra deiTrent’anni giunge infine a maturazione la metamorfosi di questa élite mercan-tile in un ceto di funzionari dello Stato «in un triplice senso: come asentistas[...]; come controllori del sistema fiscale di base; come membri dell’ammini-strazione centrale e periferica dello Stato»29. Anche qui essi ricevono feudicome compenso per i loro servizi, o investono i loro profitti nell’acquisto dibaronie, o si sostituiscono ai vecchi baroni dopo aver assunto la gestione delleloro terre ed esserne divenuti creditori.
Nella Calabria studiata da Giuseppe Galasso c’è una vera corsa ad inserirsinel quadro della feudalità regnicola da parte di mercanti stranieri, soprattuttogenovesi: Adorno, De Mari, Giustiniani, Grimaldi, Ravaschieri, e più tardiSaluzzo e Serra30. Accanto a loro, come in Sicilia, troviamo non pochi intra-prendenti savonesi, per esempio quell’Alessandro Raimondi che nel 1596acquista per 32.200 ducati la signoria di Ribollita, e poi quella di RoccaImperiale, entrambe nell’attuale provincia di Cosenza31. Vent’anni prima, nel1577, egli è tra i «caratarii» della «gabella della seta di Calabria», uno dei gran-
116
28 A. SPAGNOLETTI, Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milano, Bruno Mondadori, 1996, pp. 132-135. Per avere un’idea esatta del fenomeno nel periodo 1534-1637 si possono consultare gli elenchi dei «geno-vesi» titolari di entrate provenienti da giurisdizioni feudali pubblicati da G. CONIGLIO, Il viceregno di Napoli nelsecolo XVII, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1955, pp. 97-103.
29 A. MUSI, Mercanti genovesi nel Regno di Napoli, Napoli, E.S.I., 1996, pp. 7, 33-34, 42-45, 89-90 e pas-sim.
30 G. GALASSO, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Napoli, Guida, 19923, pp. 73-75.31 Ivi, p. 57.
Capitolo 7
di cespiti feudali dei Sanseverino di Bisignano, e in questo ruolo è affiancato daaltri savonesi come Nicolò Bertolotto, Tommaso Riario (ancora lui!), Francescoe Gian Francesco Ferrero: quest’ultimo nel 1598 è diventato uno dei maggioribeneficiari di questa gabella unitamente al suo compatriota Nicolò Pavese32. Sulfinire del secolo, allorché la Calabria entra in una fase di crisi da cui è destina-ta a non risollevarsi più, questi speculatori, lungi dal mollare la presa, diventa-no sempre più rapaci e prevaricatori, nel tentativo di sfruttare al massimo lerisorse delle loro terre e delle comunità locali: ed è in questa veste che nelleprime decadi del Seicento troviamo in azione altri personaggi savonesi comeMarcello Raimondi, Clemente Della Rovere, Ottaviano Doria, Girolamo eBenedetto Corsi, Pietro Raimondi Feo33. Nel contempo altre famiglie, come iGavotti, sono attive in Puglia, a stretto contatto con il potente clan genovese deiDe Mari34.
Nella vicina Basilicata – oltreché, come abbiamo visto, in Calabria – hannoavviato le loro fortune “extrasavonesi” i Ferrero, che nel Cinquecento vi acqui-stano la baronia di Tricarico, mentre un ramo di essi, che abbiamo già incon-trato, si trasferisce in Sicilia dove trova tali occasioni di guadagno da divenirequello principale: giungerà ad essere una delle famiglie più ricche dell’isola,prima di estinguersi nel Settecento, a Palermo. Cugino dei Ferrero di Tricaricoe fratello di alcuni Ferrero “siciliani” è quel Bernardo Ferrero costruttore delpalazzo che oggi ospita la Camera di commercio savonese, al quale GuidoMalandra ha dedicato anni fa un bellissimo volume che ne ricostruisce la bio-grafia, mostrandoci un percorso esemplare di questi intraprendenti nobili-mer-canti. Bernardo nasce intorno al 1513 in una famiglia che già ha allacciato pro-ficui rapporti con il Mezzogiorno, e che «ha il suo punto di forza [...] nellaSicilia occidentale, a Sciacca, dove in questi anni è fiorente una colonia di savo-nesi dediti, oltre che ai commerci più diversi, ad attività di prestito di capitali edi appalti di gabelle, detenendo [...] il controllo quasi totale delle esportazionidi grano». Egli, al pari dei suoi fratelli, vive tra la Sicilia e Savona e assume viavia la statura di mercante internazionale: opera come grande spedizioniere nelsettore granario, investe nelle assicurazioni marittime e negli appalti di gabelle,si specializza in forniture alle truppe spagnole, infine immobilizza parte dei pro-fitti in acquisti di terreni nel Savonese. Muore a Palermo nel 1575, lasciando uncospicuo patrimonio di 150.000 scudi d’oro e la titolarità del feudo diCacchino presso Milazzo. Suo figlio Marc’Antonio, destinato ad ereditare tuttele baronie siciliane della famiglia (Pettineo, San Mauro, Maglia, Auredo, Polinae Migardo), si trasferisce definitivamente nell’isola, dove risulterà «uno dei piùragguardevoli membri della media nobiltà siciliana, rinunciando [...] alla vec-chia titolatura di cittadino di Savona». Lasciati gli affari, si dedica alla vita pub-blica: sarà Governatore di Palermo, poi Capitano generale di giustizia35.
117
32 Ivi, pp. 264-268.33 Ivi, pp. 382-388.34 A. MUSI, Mercanti genovesi nel Regno di Napoli cit., p. 106.35 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., pp. 63-102.
Fare fortuna nel «secolo dei genovesi»
Queste strepitose carriere napoletane e siciliane, come abbiamo detto e comegiova ripetere, sarebbero inimmaginabili senza una totale comunanza di inte-ressi con le grandi casate genovesi che per quasi due secoli hanno dominato l’e-conomia di quei regni e hanno goduto d’un rapporto di assoluto favore con lacorona spagnola. Ma un discorso non molto diverso va fatto per l’altro centroin cui si realizzano le fortune di alcune famiglie e aziende savonesi, vale a direRoma. Qui – vi abbiamo già accennato – sono soprattutto i Gavotti e i Siri aguadagnare posizioni di grande prestigio e ricchezza, grazie all’attività bancaria;ma accanto a loro non mancano altri cognomi savonesi, alcuni dei quali ormaici sono familiari: i Ferrero, i Pavese, i Raimondi, i Pozzobonello, i Feo. Comesi è detto, costoro hanno cominciato a insediarsi a Roma grazie al favore deipapi savonesi; ma già allora è difficile, per un ligure, farsi strada nella capitaledella cristianità al di fuori della forte colonia genovese che vi gestisce grossi affa-ri, dall’alta finanza all’annona, dagli appalti fiscali al commercio dell’allume diTolfa, una merce strategica per l’epoca36.
Negli anni seguenti è solo se si lavora in pieno accordo con gente che si chia-ma Centurione, De Mari, Doria, Fieschi, Giustiniani, Grimaldi, Imperiale,Lercari, Negrone, Pinelli o Spinola che si possono fare affari su quella piazza, etale è appunto la collocazione dei nostri savonesi, che infatti troviamo perfetta-mente inseriti in quella confraternita romana di San Giovanni Battista che è unvero e proprio consolato genovese, dotato di ampi privilegi e in grado di svol-gere un’azione di tutela nei confronti della «nazione» ligure. Di essa possono farparte tutti i genovesi residenti a Roma, «tanto quelli della città come gli altri delDominio di Terraferma e delle isole», e a dirigerla in qualità di «governatori»troviamo spesso dei Gavotti o altri ricchi mercanti di Savona37. Peraltro iGavotti, che sono i capofila di questa colonia savonese-romana e ottengono isuccessi più sfolgoranti e duraturi, hanno iniziato la loro ascesa sociale traffi-cando con la Spagna già alla fine del Quattrocento o mettendosi al servizio deisovrani di quel regno38: anche in questo caso va detto che solo in pieno accor-do con i grandi speculatori genovesi un savonese può operare con profitto nellapenisola iberica.
Seguendo le tracce di questa élite di Savona ricca e cosmopolita, che ha fini-to per lasciare i segni più cospicui nel tessuto urbano della città fra Cinque eSeicento e anche oltre, che ha avuto stabilmente qualche suo membro nellamagistrature comunali, che ha amministrato le opere pie e le fabbricerie dellechiese, che ha innalzato cappelle gentilizie ed edificato piacevoli residenze dicampagna nelle «ville» di Legino o di Lavagnola, troviamo dunque non oppo-
118
36 Si veda, riassuntivamente, G. DORIA, Nobiltà e investimenti a Genova in età moderna, Genova, Istituto diStoria economica, 1995, pp. 121-123; e, per la forte e duratura presenza di genovesi fra gli alti funzionari pon-tifici, R. AGO, Carriere e clientele nella Roma barocca, Roma-Bari, Laterza, 1990, passim.
37 M. MOMBELLI CASTRACANE, La confraternita di S. Giovanni de’ Genovesi in Roma. Inventario dell’archivio,Firenze, Olschki, 1971, pp. 200-216.
38 N. GAVOTTI, La famiglia Gavotti. La preistoria e lo sviluppo, 1150-1550, AMSSSP, vol. XXV, 1943, pp.65-94 (in particolare pp. 75-82).
Capitolo 7
sizione o rancore verso il patriziato genovese “oppressore”, ma piena collabora-zione con esso sul piano economico, nonché una larga integrazione culturale,sociale, familiare. Le parentele di nobili affaristi che siamo venuti via via citan-do conducono infatti un train de vie molto simile a quello dei «Magnifici» diGenova, ne condividono i gusti e le aspirazioni (a cominciare dall’acquisizionedi titoli nobiliari più prestigiosi, ottenuti tramite le baronie meridionali o l’in-gresso nell’Ordine di Malta), finiscono quasi sempre per imparentarsi con qual-cuno di loro (specie con quelle casate – i Balbi, i De Mari, i Doria, i Durazzo,gli Imperiale, i Multedo – che hanno scelto come luogo di villeggiatura proprioi dintorni di Savona39), e non appena possibile cercano di farsi ascrivere nelLibro d’oro della Dominante.
Vogliono anche – e molta della loro sempre ribadita fedeltà alla Repubblicaha proprio questo scopo – una generale equiparazione di diritti tra i cittadinisavonesi e quelli di Genova, che è una richiesta nient’affatto platonica: «li citta-dini genoesi – scrivono il 25 aprile 1644 gli Anziani di Savona – per li ordinireggii novamente fatti dal re Cattolico possono riscottere li fiscali et altre entra-te che tengono nel regno di Napoli». Perciò «desiderano li savonesi ancora,come cittadini di Genova per mera gracia e bontà di cotesta RepubblicaSerenissima, esser annoverati nell’istesso godimento di privileggi, per puoteranch’essi essigere le loro entrate in detto regno»40. Due anni prima i maggiorentisavonesi, come si ricorderà, hanno fatto alla Repubblica il ricco dono di duegalere armate, e c’è da supporre che nel compiere quel passo avessero qualchescopo concreto. La preoccupazione per i difficili pagamenti delle rendite napo-letane e di quelle spagnole in genere, cui le maggiori famiglie savonesi sonointeressate al pari di quelle genovesi, spiega almeno in parte quel dono, cheperaltro si rivela un buon investimento. Il 27 aprile 1644, infatti, un decreto delSenato attesta che «tutti i liguri nostri sudditi vanno considerati genovesi, e per-ciò in ogni parte del mondo godono di tutti i privilegi spettanti ai cittadinigenovesi, e tra gli altri sono tali i liguri savonesi»41.
Se questi privilegi stanno a cuore ai ricchi rentier che lucrano sui pagamentidella corona spagnola, non è detto che la città nel suo complesso ne tragga moltivantaggi. A quell’epoca le grandi famiglie di affaristi si sono come ripiegate suse stesse, incassano rendite parassitarie, vivono in un mondo dorato fatto di beipalazzi urbani e di ariose ville suburbane, hanno ormai scarsi rapporti con quelche resta dell’economia mercantile e manifatturiera della città. I loro rami piùintraprendenti sono per lo più staccati dalla madrepatria, stanziati e “naturaliz-zati” altrove, divenuti romani o napoletani, messinesi, palermitani o quanto-meno genovesi. Presto cominceranno ad estinguersi, e nel Settecento ne rimar-
119
39 G. ROSSINI, Architettura di palazzo e architettura di villa a Savona tra Cinque e Seicento, AMSSSP, n. s.,vol. XIII, 1979, pp. 97-120.
40 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 66.41 «Ligures omnes cives et subditos nostros censeri et esse genuenses, et ideo in quibusvis orbis terrarum par-
tibus gaudere et frui omnibus privileggis civibus genuensibus competentibus, et inter ceteros tales esse liguressaonenses» (ibidem).
Fare fortuna nel «secolo dei genovesi»
ranno poche: tra queste i Gavotti, che nel 1794 risulteranno l’unico cognomesavonese ancora presente nel patriziato di Genova42. Questa vecchia classe diri-gente di Savona ha dunque compiuto una lunga parabola all’ombra e sotto laprotezione delle grandi famiglie genovesi: ne ha tratto vantaggi, ha accumulatoricchezze, ha compiuto una diaspora analoga a quella dei patrizi dellaDominante, infine è andata sempre più trascurando la sua piccola patria, cheper lei era diventata nulla più che un luogo di residenza e di villeggiatura, e avolte neppure questo. Nel 1746 gli Anziani savonesi devono preoccuparsi perun palazzo sito nella Fossavaria, la strada principale della città, che fa parte del-l’asse ereditario di Giambattista Ferrero. Si trova «in tale pessimo stato di rovi-na» che se ne teme il crollo, il Magistrato di Vie e Darsena ha cercato di per-suadere gli eredi a farvi delle riparazioni, ma costoro «sono in maggior parte cit-tadini di Genova» e se ne disinteressano totalmente43. È una vicenda da nulla,ma simboleggia bene i destini di Savona e il ruolo di un ceto ristretto che hasaputo curare assai bene i propri affari, non altrettanto gli interessi della collet-tività di cui faceva parte.
120
42 C. BITOSSI, “La Repubblica è vecchia”. Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento, Roma, Istitutostorico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1995, pp. 46-48.
43 ASS, Comune I, 143, 1 giugno 1746.
Capitolo 7
Nel 1697 uscì a Roma, presso la Stamperia di Marc’Antonio e OrazioCampana, il Compendio di memorie historiche della città di Savona, opera delsacerdote Agostino Maria de’ Monti. Di umili origini, nato a Savona nel 1656,una volta presi i voti il Monti fece una buona carriera: insegnò umanità e gram-matica a Roma presso San Lorenzo in Damaso, tenne per trent’anni la cattedradi latinità nel Seminario Romano e qui ebbe tra i suoi allievi i figli del principeBorghese, del duca di Massa e di altri grandi aristocratici italiani, il che gli con-sentì di intrecciare legami di clientela con importanti famiglie e personaggidotti del suo tempo1. Il suo Compendio è dedicato «all’eminentissimo e reve-rendissimo principe il signor cardinale Marcello Durazzo legato di Bologna», enel preambolo dell’opera si profonde in lodi per la famiglia di costui – una dellepiù ricche e potenti in seno al patriziato genovese – e per i molti benefici da essalargiti a Savona, tanto da figurare come una sorta di “patrona” della città.All’epoca è un Durazzo, Vincenzo Maria, a guidare la diocesi savonese («è quel-lo che di noi ha il pastorale governo, e con tanta pietà e zelo ci regge», ricordaMonti). Alla stessa parentela sono appartenuti tre Governatori che hanno lascia-to buona memoria di sé: Cesare, che ha ricoperto l’ufficio nel 1637-38;Girolamo, che lo ha tenuto nel 1655-56; e soprattutto Eugenio, spericolato eabilissimo finanziere di caratura internazionale, il quale durante il suo “gover-no”, nel 1676, ha attuato a Savona un’importante riforma del debito pubblico(ne parleremo più avanti), vi ha realizzato opere pubbliche di rilievo, ha tutela-to al meglio gli interessi delle maggiori opere pie2. Una benevolenza non casua-le, visto che i Durazzo dalla metà del secolo hanno importanti interessi fondia-ri nella vicina piana di Albisola, dove in seguito – a partire dal 1736 – costrui-ranno la splendida residenza oggi conosciuta come villa Faraggiana3.
Date queste premesse, non c’è da stupirsi che il Compendio offra una rico-struzione molto “filogenovese” della storia di Savona, rifacendosi spesso a unautore come l’Agostino Giustiniani dei Castigatissimi annali, opera che esprimein forma semiufficiale il punto di vista del serenissimo governo. Vengono infat-ti ricordate come assai positive tutte le convenzioni stipulate con Genova, eviceversa stigmatizzate le rotture di queste alleanze, fino ai “tradimenti” cin-quecenteschi, quando la punizione si fa più drastica e meritata «per haver que-sta città tentate tutte le strade di separarsi dal genovese dominio, e con il ricor-
121
1 G. B. PASSANO, I novellieri italiani in prosa, parte I, Torino, Stamperia Reale, 1878, pp. 433-435.2 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., pp. iniziali non numerate.3 Su questa famiglia, o meglio sul ramo di essa cui appartengono i personaggi sopra citati, rinvio a G.
ASSERETO, I “Durazzo di Palazzo Reale”. Breve storia di una grande famiglia patrizia, in Da Tintoretto a Rubens:capolavori della collezione Durazzo a cura di L. LEONCINI, Milano, Skira, 2004, pp. 25-41.
Capitolo 8
L’esproprio della memoria
so a Giulio II sommo pontefice suo cittadino, e con la potenza del re diFrancia»4. Benché lo sguardo del cronista manifesti pietà per il destino infelicedella sua patria, le distruzioni e la rovina del porto vengono di fatto giustifica-te in base ai superiori interessi della Dominante. Uno storico animato da fieropatriottismo municipale come Filippo Noberasco fulminerà contro il Monti ungiudizio di severa condanna: «la lettura di questa cronaca ingenera, nell’animodel lettore imparziale, un senso di profondo disgusto per il suo spirito spietata-mente avverso alla città natia e supinamente ligio verso la prepotenza genove-se»5.
Posizioni ideologiche a parte, quella del Monti è un’opera piuttosto povera escarna: priva di spirito critico, sciatta nello stile, non sempre bene informata.Eppure – come notava Girolamo Rossi, buon conoscitore della storia e dellastoriografia ligure – formerà «per un secolo e mezzo l’unico pascolo degli stu-diosi di cose storiche savonesi», perché fino alla metà dell’Ottocento resterà l’u-nica cronaca di Savona data alle stampe6. Solo sul finire di quel secolo – in unacittà divenuta un ricco centro industriale, con un ceto dirigente che, orgoglio-so di sé, vuole ricostruire e celebrare il proprio passato – vedranno la luce prima,tra il 1885 e il 1891, la corposa cronistoria di Giovanni Vincenzo Verzellino edel suo continuatore padre Angelo Lamberti, poi, nel 1897, le vivacissimememorie di Agostino Abate. Di essere l’unico autore edito il Monti stesso sivanta nel proemio, e quasi rimprovera i cronisti suoi predecessori per non avervoluto «rendere communi con le stampe» le loro fatiche. Non sa, o finge di nonsapere, che il suo primato non è del tutto casuale. È vero che in gran parte i cro-nisti savonesi, da quel Pietro Gara «primo scrittore dell’antichità di Savona» ingiù, sono stati di un livello talmente modesto da non aver meritato, come untempo si diceva, che i torchi gemessero per loro; e la recente pubblicazione dialcuni loro scritti, pur meritoria, non può che confermare il giudizio7. Ma lostesso non si può dire per l’opera del Verzellino, che è sì pedissequa e povera dicomprensione storica, ma è anche frutto di un’intera vita dedicata allo spogliodi testi e documenti, basata su una consultazione diretta di molte carte d’archi-vio, perciò talmente ricca di informazioni da rappresentare a tutt’oggi uno stru-mento indispensabile – e di solito attendibile – per chi voglia ricostruire la sto-ria della città. Sennonché la mancata pubblicazione di quest’opera non è dipe-sa dalla volontà del suo autore: viceversa, essa gli è stata impedita in nome diinteressi superiori.
122
4 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., pp. 1-15, 45, 167-177.5 F. NOBERASCO, I cronisti savonesi e Giovan Vincenzo Verzellino, AMSSSP, vol. XX, 1938, pp. 225-312 (qui
pp. 262-263).6 G. ROSSI, Savona e i suoi scrittori cit., p. 422.7 Per una breve panoramica su questi scrittori si vedano i saggi di F. Noberasco e G. Rossi citati nelle note
che precedono. Quanto alle cronache pubblicate di recente, ci riferiamo a: G. FARRIS (a cura di), Cronaca savo-nese dal 1600 al 1675 cit.; G. FARRIS (a cura di), Memorie di successi notabili avvenuti a Savona nel secolo XVIIInarrate da Domenico Grandone sacerdote savonese, Savona, Sabatelli, 1999.
Capitolo 8
Annota il cronista Giovanni Battista Pavese, riferendosi al 1638: «Seguì inquest’anno a dì 4 agosto la morte di Gian Vincenzo Verzellino nobile, e fu attri-buita la cagione a gran travaglio e disgusto per esserli stata tolta l’opera sua,ossia Istoria degli huomini illustri di Savona, da Federico Federici allorGovernatore, afflitto invero per una degna fatica di 25 anni, dovendola dar allestampe»8. Il canonico Andrea Astengo, editore ottocentesco delle Memorie delVerzellino, ricorda che per molto tempo s’erano perdute le tracce del mano-scritto: «correva comune una tradizione, che quella storia venuta a mano dellaRepubblica di Genova, come essa aveva distrutto la città, così avesse distrutto ilmonumento delle sue glorie», o meglio lo avesse sequestrato e chiuso nei pro-pri archivi. L’Astengo ricostruisce i contorni della vicenda, accerta che in effet-ti il Federici si è impossessato del manoscritto, precisa – sulla base d’una testi-monianza documentale – che costui ha agito per ordine del Senato e che l’ope-ra è finita nelle mani degli Inquisitori di Stato, la magistratura creata nel 1628con compiti sì di controllo sulle stampe, ma soprattutto di alta polizia politica.La conclusione è lapidaria: Genova avrebbe agito in questo modo perché,«tiranna delle Riviere e gelosa delle glorie di Savona, che aveva quasi affattodistrutto, voleva tolta di mezzo una storia che poteva spiacerle e che se non altroavrebbe potuto alimentare nei savonesi sentimenti di patrio amore e d’indipen-denza, da creare imbarazzi alla sua dominazione»9.
La testimonianza del Pavese e la ricostruzione dell’Astengo sono sostanzial-mente confermate anche dall’erudito secentesco Michele Giustiniani, e poiriprese dal Noberasco10. Sul coinvolgimento del governo genovese in questaaffaire che si configura come un vero e proprio sequestro premeditato non sem-brano esserci dubbi, e la stessa personalità del Federici offre sostegno a questatesi: erudito, storico e genealogista, la sua figura potrebbe dar credito a una ver-sione secondo la quale egli avrebbe semplicemente chiesto in prestito, per curio-sità di studioso, la cronaca del Verzellino, e solo in seguito sarebbe stato costret-to a cederla agli Inquisitori. Ma Federici non è semplicemente un intellettuale:è un patrizio che ha ricoperto e ricoprirà in seguito numerose cariche di gover-no, ed è un uomo di cui la Repubblica in più occasioni si è avvalsa per soste-nere il proprio punto di vista in importanti dispute diplomatiche (con i suoiscritti ne ha difeso infatti le ragioni sul marchesato di Finale e soprattutto ne hasostenuto l’aspirazione ad essere considerata «testa coronata»); come tale ha unaparticolare competenza e sensibilità per i problemi concernenti la sicurezzadello Stato11.
Quel che però non convince è la motivazione che viene attribuita al seque-stro: le Memorie del Verzellino conterrebbero affermazioni azzardate, sgradite alpotere costituito, in grado d’instillare sentimenti pericolosi nelle teste di suddi-
123
8 G. FARRIS (a cura di), Cronaca savonese dal 1600 al 1675 cit., p. 15.9 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. I, pp. 18-20 e 35-36.10 Gli scrittori liguri descritti dall’abbate Michele Giustiniani patritio genovese de’ signori di Scio e dedicati alla
Serenissima Repubblica di Genova, Roma, Nicol’Angelo Tinassi, 1667, p. 413; F. NOBERASCO, I cronisti savone-si cit., pp. 278-280; sull’affaire Verzellino si veda anche N. CERISOLA, Storia di Savona cit., p. 282.
11 Sul Federici si veda la bella “voce” stesa da Carlo Bitossi per il Dizionario biografico degli Italiani.
L’esproprio della memoria
ti indocili; perciò si sarebbe reso necessario farle sparire per sempre. Ma chi oggiscorra le pagine di quel libro fa davvero fatica a trovarvi passi che possano susci-tare la disapprovazione del serenissimo governo. Per convincersene, basta guar-dare la cronaca relativa al terzo decennio del Cinquecento, così tragico perSavona: dell’acuirsi delle tensioni con Genova non si dice quasi nulla, e giuntial cruciale 1528 si dà, come notizia principale, l’avvento alla testa della diocesisavonese di monsignor Agostino Spinola, del quale si tesse un lungo panegiri-co. Viene poi ricordato brevemente che «addì 12 settembre i signori genovesicon una riforma tra di loro (a persuasione di Andrea Doria) scacciarono daGenova i francesi, e deliberando in ogni maniera di scacciarli da Savona anco-ra, vi mandarono al primo d’ottobre trenta galere, col suddetto Doria, carichedi fanteria ed un esercito per terra di 7 in 8 mila persone, le quali accampatesinelle vicine ville assediarono la città», arresasi il 29 settembre allorché «i citta-dini deputati diedero […] le chiavi al medesimo Andrea ed al conte FilippinoFiesco». Sulle distruzioni delle mura e del porto quasi si sorvola («fu dannifica-ta nelle mura, baloardi, fortezze e nel porto»); e viceversa si ricorda con enfasiche gli Anziani «mandarono Andrea Gentilriccio, Giovanni Rocchetta e NicolòSambaldo ambasciatori alla Serenissima Repubblica a giurarli ubbidienza, cheIddio lungamente conservi ed accresca per essere retta la città da essa consomma tranquillità, come da padri amorevoli»12.
Il tono, come si vede, non è certo quello di un oppositore o di un ribelle, népotrebbe esserlo vista la personalità dell’autore: un giureconsulto provenienteda una buona famiglia mercantile, ascritto nel 1636 al «bussolo» dei nobili, conun buon cursus honorum nelle magistrature civiche, dotato di cospicuo patri-monio, con amicizie e frequentazioni di prestigio. Un uomo d’ordine, insom-ma, rispettoso dell’autorità e per nulla incline alla critica corrosiva, meno chemai alla sovversione. Per capire il destino del suo testo bisogna allora guardarele cose da un altro punto di vista e ricordare che la Repubblica non solo appli-ca, come tutti i governi coevi, una rigida censura sulla stampa per bloccare qua-lunque opera contraria alla morale, alla religione e al buon ordine dello Stato,ma – specie a partire dall’inizio del Seicento – adotta una strategia politica ditotale reticenza, che consiste nel non parlare né (possibilmente) lasciar parlaredi sé, rinunciando anche – al contrario di quanto avviene a Venezia – a qua-lunque forma di autocelebrazione, di storiografia ufficiale o ufficiosa. Dopo il1576 – ha scritto Claudio Costantini «su Genova era calato il silenzio», e «abba-stanza presto la scelta del silenzio fu resa ufficiale e diventò obbligatoria pertutti. Anche la registrazione delle vicende della Repubblica perse per il governoogni interesse acquistando […] un che di sospetto e di allarmante»13.
124
12 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. I, pp. 450-453. Il curatore ottocentesco delleMemorie, commentando queste pagine, ipotizzerà «che le ultime linee sieno un’ironia assai fina contro la nuovadominazione».
13 C. COSTANTINI, Politica e storiografia: l’età dei grandi repubblichisti, in La letteratura ligure. La repubblicaaristocratica (1528-1797), Genova, Costa & Nolan, 1992, pp. 93-135 (in particolare p. 103). Sul tema dellacensura e della “politica editoriale” a Genova mi permetto di rinviare a G. ASSERETO, Inquisitori e libri nelSeicento, in ID., Le metamorfosi della Repubblica cit., pp. 133-162.
Capitolo 8
L’esproprio della memoria
In tutto il XVI secolo vengono pubblicate solo tre storie di Genova: iCastigatissimi Annali di Agostino Giustiniani nel 1537, le Historiae di ObertoFoglietta nel 1585 e gli Annali di Jacopo Bonfadio nel 1586. A tutto ciò cheviene scritto dopo, anche quando si tratti di lavori commissionati dal governostesso, viene consentita un’ampia circolazione in copie manoscritte fra il cetopatrizio, ma ne viene vietata la stampa, tanto che dalla fine del Seicento in poisaranno quasi solo autori forestieri, soprattutto francesi, a pubblicare opere sto-riche complessive su Genova e la Liguria. Il maggior tabù per gli Inquisitorigenovesi è diventato appunto ciò che riguarda il passato e il presente dellaRepubblica, e questa riluttanza nasce dall’estrema cautela di uno Stato il qualeteme che ogni affermazione sul proprio conto possa – per così dire – essere usatacome prova contro di lui, metterlo in difficoltà nei confronti di altre potenze,svelarne l’incerta legittimità e la debole sovranità.
Genova da un lato si è sforzata, per secoli, di presentarsi e di farsi riconosce-re come uno Stato sovrano, una respublica superiorem non recognoscens; ma d’al-tro lato per lunghi periodi si è sottomessa a signorie straniere, non ha mai rego-lato in modo chiaro i propri rapporti di dipendenza dal Sacro Romano Impero,e infine ha accettato per opportunismo una sorta di tutela da parte dellaSpagna. Questo statuto politico incerto (che nel 1637 la induce, per rassodareil proprio status e aumentare il proprio peso diplomatico, a rivendicare per sé ladignità regia e a proclamare regina la Vergine Maria) si rivela particolarmentedelicato allorché si tratta di definire i rapporti con il Dominio, tanto più neiconfronti di una città sottomessa a fatica e tardivamente. Ha la Repubblica suf-ficienti titoli per governarla, o un sovrano straniero (l’imperatore o il duca diSavoia, il re di Francia o quello di Spagna) potrebbe rivendicarne il possesso? Èin questa luce che anche l’innocuo e fedele cronista Verzellino può diventarepericoloso: non perché critichi il governo o recrimini su antiche violenze, masemplicemente perché, nel ripercorrere le vicende di secoli lontani, evoca idiversi poteri che si sono succeduti su Savona, o gli antichi diplomi imperialiche, concedendo alla città privilegi e “immunità”, attestano per ciò stesso anchela superioritas dell’imperatore su di essa e sulla stessa Genova.
Non va dimenticato che siamo in un’epoca in cui il diritto internazionale, secosì si può dire, è ancora incerto e fluido, in cui i piccoli Stati in Germania e inItalia non hanno una personalità giuridica autonoma, non possiedono la legit-timità dei grandi poteri universali – il Papato e l’Impero, da cui anzi in qualchemodo dipendono – né delle antiche monarchie di Francia, d’Inghilterra, diCastiglia o, in Italia, di Napoli e di Sicilia, e neppure del ducato di Savoia, i cuiprincipi possono almeno vantare da tempo la dignità di vicari imperiali. Siamoin un’epoca in cui quei piccoli Stati devono lottare per avere un posto dignito-so nel firmamento delle potenze, in cui non a caso sono così accanite quelledispute formali per la precedenza (con quale ordine gli ambasciatori devonoessere ricevuti nelle corti? se due navi appartenenti a Stati diversi si incrocianoin mare, quale deve salutare per prima?) che ai nostri occhi appaiono tanto grot-tesche quanto i duelli che i gentiluomini del tempo ingaggiano per decidere a
125
chi tocchi cedere il passo. Sono tempi in cui una terra suddita – e questo, in uncerto senso, lo capiamo bene anche oggi, di fronte alle numerose secessioniattuate o minacciate in giro per l’Europa – potrebbe da un momento all’altrorivendicare il proprio buon diritto a tornare indipendente o a darsi a un altrosignore, in cui basta poco per rimettere in discussione assetti consolidati dagrandissimo tempo, come si vedrà bene quando nel Granducato di Toscanagiunge ad estinzione la dinastia medicea e lo Stato sembra frantumarsi nelle sueantiche componenti14. È un’epoca, infine, in cui l’antichità di un documento odi una tradizione è ritenuta essenziale, sia per affermare la nobiltà di un uomoe di una famiglia, sia per fondare la legittimità di un corpo politico. Gli indivi-dui combattono allora le loro battaglie a colpi di genealogie (reali o immagina-rie), di antiche investiture, di pretese res gestae dei loro antenati. E gli Stati nonsono da meno, perché sanno che è solo dalla loro storia (veridica, manipolata oinventata) che può derivare la legittimazione del loro potere15.
Per quanto riguarda il Dominio genovese, il caso più chiaro è quello dellacomunità di Sanremo, che a partire dal 1729 entra in conflitto col serenissimogoverno per difendere certe antiche «immunità» che la Repubblica vorrebbeerodere, in nome di una maggiore estensione del proprio potere. Inizia da allo-ra una lunga disputa giuridica che è anche, o soprattutto, una disputa storica,perché ciascuna delle parti cerca nel passato gli argomenti per sostenere le pro-prie ragioni. Da un certo momento in poi l’argomento fondamentale dei san-remesi è la rivendicazione dell’antica superioritas imperiale su Sanremo e – quelche è più pericoloso per la Repubblica – su tutta la Liguria, cioè il richiamo alcarattere di feudo imperiale di tutto lo Stato genovese; quindi la possibilità, anzila liceità, da parte degli stessi sanremesi, di ricorrere alla suprema autorità del-l’imperatore per dirimere i contrasti. Si comprende allora tutto il pericolo insi-to nell’eccitare «quistioni de i titoli del Sacro Romano-Germanico Imperiosopra di Genova e dello Stato suo», rivangando «tempi remoti e tenebrosi»16.
I timori sono ben fondati, sia perché l’Impero dall’inizio del secolo ha assun-to nei confronti degli Stati italiani un atteggiamento ben più aggressivo che inpassato, pretendendo di far valere titoli di «alto dominio» che da tempo eranocaduti in desuetudine17; sia perché di lì a pochi anni, con la guerra diSuccessione austriaca che coinvolge la Repubblica, la “questione imperiale”diventerà sempre più delicata; sia infine perché l’insofferenza di Sanremo, nel1753, esploderà in aperta rivolta e avrà una risonanza internazionale, visto chel’argomento del contendere diventa più che mai la presunta «imperialità» sia
126
14 Durante le contese per la successione di Gian Gastone, ultimo granduca della famiglia de’ Medici, «allosfasciarsi del potere statale corrispose il riemergere delle antiche strutture politiche delle terre granducali. […]Le vecchie ossa riapparivano nel corpo esangue del granducato: Firenze, Siena, Pisa coi loro privilegi, le lorogelosie, le loro pretese. […] Ogni terra, ogni valle pareva ritrovare una umbratile vita nelle dispute dei diplo-matici e dei giuristi. Quel che sembrava non esistere più era il granducato mediceo» (F. VENTURI. Settecentoriformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, 1969, pp. 6-7).
15 R. BIZZOCCHI, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 1995.16 V. TIGRINO, Castelli di carte. Giurisdizione e storia locale nel Settecento in una disputa fra Sanremo e Genova
(1729-1735), «Quaderni storici», XXXIV, 1999, n. 101, pp. 475-506.17 S. PUGLIESE, Il Sacro Romano Impero in Italia, Milano, Treves, 1935, pp. 231-235 e passim.
Capitolo 8
della cittadina rivierasca, sia dello Stato genovese nel suo complesso18. A sug-gello della vicenda, è significativo che, una volta domata con la forza la ribel-lione sanremese, la Repubblica provveda a sequestrare l’archivio di quella cittàe a trasferirlo nella Dominante: segno di quanto consideri pericolose le antichecarte e le dispute giuridiche che su di esse si possono imbastire19.
Ben prima dello scoppio di questa grave crisi, tuttavia, Genova è consapevo-le di quanto sia delicata la propria posizione, e di come i vecchi documentivadano gelosamente custoditi o prudentemente occultati, a seconda della loronatura. Nasce proprio di qui la sua diffidenza nei confronti degli storici (queglistorici barocchi che, oltretutto, si mettono così volentieri al servizio e al soldodi qualche potenza per dimostrare a furia di pergamene e diplomi il suo buondiritto a prevaricare su un vicino più debole20), e l’attenzione con cui guarda agliarchivi. Nel 1587, quando in seno al serenissimo governo è stata creata unanuova magistratura – la Giunta dei Confini – incaricata di vegliare alla tuteladel territorio e di dirimere le controversie con gli Stati vicini, tra i suoi compi-ti è stato subito individuato quello di raccogliere tutte le «scritture» in grado diprovare la sovranità della Repubblica sui vari luoghi del suo Dominio21.Ebbene, una delle caratteristiche salienti dei rapporti tra Savona e Genova traXII e XVI secolo è appunto quella di aver prodotto una straordinaria quantitàdi documenti di grande rilevanza giuridica. «L’interminabile querelle tra le duecittà […] nasceva proprio dall’avere ciascuna, alle spalle, una serie ininterrottadi sentenze e capitula a sé favorevoli»22: convenzioni, diplomi imperiali, pro-nunciamenti di pontefici, editti di re, decreti di duchi. Una secolare guerra dicarte alle quali si può attingere per rivendicare privilegi e immunità da unaparte, poteri di controllo e di intervento dall’altra; ma in cui si può intrufolareanche un terzo incomodo per vantare titoli di sovranità.
Certo è che la città minore, la quale ha sempre cercato di bilanciare il pote-re di Genova o addirittura di sottrarvisi ricorrendo a istanze superiori (l’Impero,soprattutto), ha anche avuto cura di conservare i documenti a lei favorevoli: isuoi «registri della catena», ad esempio, sono in buona misura ampie raccolte diprivilegi e convenzioni che non a caso si aprono con il diploma imperiale diFederico II del 1221 che conferma tutti i diritti dei savonesi e annulla le limi-tazioni imposte, specie in materia di navigazione, dalla convenzione conGenova del 1202; e proseguono con la registrazione di carte utili per rivendica-re la propria autonomia comunale23. Più tardi Savona deciderà di dare alle stam-pe proprio i testi delle convenzioni con la Superba, unendovi tutti i documen-ti utili alla difesa dell’autonomia cittadina24.
127
18 N. CALVINI, La rivoluzione del 1753 a Sanremo, 2 voll., Bordighera, Istituto internazionale di studi liguri, 1953.19 F. VENTURI, Saggi preparatori per “Settecento riformatore”, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2002, pp. 53-56.20 S. BERTELLI, Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca, Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 193-218.21 C. BITOSSI, “La Repubblica è vecchia” cit., p. 28.22 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., p. 56.23 I Registri della Catena del Comune di Savona a cura di D. PUNCUH e A. ROVERE, ASLSP, vol. C, 1986, fasc.
I, pp. XXX-XXXII.24 Conventiones inter Communitatem Ianue ex una et Communitatem Saone ex altera, Saone, per Franciscum
Silvam, 1503; cfr. R. SAVELLI ( a cura di), Repertorio degli statuti cit., p. 156.
L’esproprio della memoria
Avvenuta la sottomissione, molte di queste vecchie carte possono diventarescomode o addirittura pericolose per la Dominante: andranno tenute sotto con-trollo, e all’occorrenza sequestrate, mentre dal canto suo la comunità savonesecercherà di non farsene espropriare. L’archivio civico dalla metà del XIV secoloè conservato nella sacrestia del convento di San Domenico, sulla rocca delPriamàr; ma nel Cinquecento, dopo le distruzioni operate in quella parte dellacittà per fare posto alla fortezza, passa nel convento di Sant’Agostino doveresterà sino al 1609, allorché verrà trasferito presso la nuova Cattedrale appenaultimata, per rimanervi almeno sino al 1740. Nel frattempo il patrimoniodocumentario si è andato dividendo in tre nuclei distinti: mentre le carte dinatura amministrativa sono presso la cancelleria degli Anziani e le carte conta-bili presso quella dei Maestri Razionali, nella sacrestia dei frati agostiniani (e poinella Cattedrale) resta l’«archivio dei privilegi» contenente le scritture che vannocustodite più gelosamente. Sono riposte in una cassa munita di tre chiavi, affi-date rispettivamente al priore e sottopriore degli Anziani e al priore deiRazionali, cioè alle massime autorità cittadine. Ma questo geloso controllo pati-sce un’eccezione, perché ora il Podestà genovese ha il potere di far estrarre dal-l’archivio qualunque scrittura25: indizio inequivocabile, questo, dell’interesseche il governo nutre nei suoi confronti, e che periodicamente affiora. Comequando, il 19 maggio 1599, il Senato scrive a Gerolamo Testarossa, che ricoprea Savona l’ufficio di Vicario: «Importa alla Republica nostra ch’ella habbia copiao sia transonto aotentico di alcune scritture publiche antiche che […] si con-servano nell’archivio publico di cotesta nostra città»; e perché la «copia privile-giorum Saone» che viene richiesta sia più attendibile «e faccia maggior fede», siordina al Vicario di chiamare a testimonio il vescovo26.
Naturalmente tale interesse da parte di Genova cresce nei momenti in cui cisono tensioni internazionali o scontri diplomatici, così come l’amministrazionecivica savonese è tanto più attenta alla custodia e all’esatta catalogazione deidocumenti quanto più cerca di ritagliarsi margini di autonomia rispetto allaDominante. Forse non è casuale, ad esempio, che nel 1633 – in un momentoin cui, come si è visto nel capitolo 5, è molto forte lo spirito di collaborazionedel ceto dirigente locale nei confronti del governo, ma nel contempo viene con-dotta da quello stesso ceto un’azione tesa a strappare il maggior numero di pri-vilegi – la città affidi il compito di riordinare il proprio archivio appunto aGiovanni Vincenzo Verzellino: riordino che in realtà verrà portato a termine,dopo la morte di costui, da Giacomo Cortino e Gian Francesco Rocca nel1639-4027. Nel contempo Genova, nel 1636, è preoccupata perché ha in corsocon Vienna un contenzioso relativo a molte terre soggette alla Repubblica ma
128
25 M. CASTIGLIA, L’antico archivio del Comune di Savona e i suoi inventari, AMSSSP, n. s., vol. XXVII, 1991,pp. 59-67; A. ROCCATAGLIATA, La legislazione archivistica del Comune di Savona, Genova, Ecig, 1996, p. 28-29.
26 ASG, Archivio segreto, 361, n. 55-56. La copia, contenente la serie degli otto privilegi imperiali concessialla città di Savona dal 1014 al 1414 viene eseguita dal cancelliere del Comune Lorenzo Besio, «nil addito necdiminuto». Verrà poi autenticata nel 1609, all’atto del trasferimento nella Cattedrale dell’archivio dei privilegi(ASG, Manoscritti, 148 bis).
27 M. CASTIGLIA, L’antico archivio cit., pp. 62-63.
Capitolo 8
ritenute feudi imperiali, per le quali il Consiglio Aulico pretende che il Senatochieda il rinnovo delle investiture e paghi per ottenerle. L’ambasciatoreGirolamo Rodino ha parato abilmente il colpo, ricordando i «tanti augustissi-mi imperatori – a cominciare da Federico Barbarossa nel 1162 – che ad ogget-to de’ grandi meriti della Repubblica Serenissima le hanno con ampli rescritticonceduto o sia corroborato il dominio e possesso de’ luoghi che gode, con lar-ghe formalità generalmente comprensive di ogni acquisto di terre, città e giuri-sdizioni, senza imporle verun obligo di chiederne speciale investitura»; e richia-mando in particolare i diplomi con cui Carlo V il 29 giugno 1529 e il 1°novembre 1536 ha confermato «tutti li privilegi, concessioni, indulti e diplomisopra ogni ragioni, libertà, esentioni, immunità, consuetudini, proprietà, pro-vincie e territorii», nonché su «qualsivoglia altre terre, castelli, luoghi e cittàtanto in terraferma quanto oltre mare [che] in quel tempo la Repubblica tene-va e possedeva»28.
Nella controversia del 1636, da parte imperiale si nominano alcuni luoghi dinotevole importanza strategica, come Ovada o La Spezia, ma – con gran sollie-vo della Repubblica – non si menziona Savona. Nondimeno l’accavallarsi dellepretese feudali di Vienna e di quelle autonomistiche dei savonesi – per non par-lare delle mire sabaude sul ponente ligure, rintuzzate con le armi nel 1625, masempre pronte a riemergere – rende il momento assai delicato. È appunto inquesto quadro che il manoscritto del Verzellino risulta scomodo e va fatto spa-rire. D’altronde il cronista Pavese ci informa che, nello stesso 1638 in cui avvie-ne il sequestro, «il Governatore Federico de’ Federici historiografo di Genova,richiesta la communità nostra, prese alcune carte di scritture antiche per valer-sene in sue opere»29: i due interventi sono paralleli e hanno evidentemente lemedesime finalità.
Di fronte a simili ingerenze, non c’è da stupirsi che la città suddita perda viavia interesse per il proprio archivio e quindi – si potrebbe dire – per il propriopassato. Nel luglio 1664 una lettera al Senato dei «sindicatori ordinari» – imagistrati che annualmente il governo spedisce nel Dominio per controllare l’o-perato dei giusdicenti e dei loro sottoposti – denuncia il cattivo stato dell’ar-chivio savonese, nel quale «si è trovato non esservi le scritture tutte che vi hannoad essere, e parte delle ritrovate sfilate e in mal’ordine»; ragion per cui il Senatostesso chiede al Governatore di farlo riordinare30. Lo stesso si riscontra nel1716, e di nuovo il Senato ingiunge agli Anziani di rimediare31. Tuttavia solonel 1772 – dopo che una deputazione civica ha ispezionato l’archivio e lo haritrovato «molto confuso e bisognoso di essere posto in buon ordine, partico-larmente molte scritture antiche che devono conservarsi con ogni attenzione eriguardo» – i Razionali nomineranno un «pubblico archivista» nella persona del
129
28 ASG, Archivio segreto, 294, relazioni del 3 giugno e dell’ottobre 1709; ASG, Archivio segreto, 361, n. 57.29 G. FARRIS (a cura di), Cronaca savonese cit., p. 15.30 ASS, Comune I, 214.31 ASS, Comune I, 211.
L’esproprio della memoria
nobile Giovanni Tommaso Belloro, «molto idoneo a tal uopo, il quale si mostròpronto ad impiegarvisi senza mercede alcuna e per puro zelo del serviggio diquesta città»32. Ma in realtà, perché venga realizzato un vero riordinamento,bisognerà attendere gli anni trenta e quaranta dell’Ottocento, quando ormai loStato genovese non esiste più33.
Il fatto è che il vero interesse per l’antico archivio savonese, da un certomomento in poi, si è spostato dalla parte del governo, non della città suddita.Lo si vede bene nei primi anni del Settecento, all’epoca della guerra diSuccessione spagnola, quando – lo abbiamo già ricordato – si riaccende l’inte-resse dell’Impero per tutte le terre italiane sulle quali esso può vantare il proprio“dominio diretto”. Nell’Archivio di Stato di Genova è conservato un ricco dos-sier, relativo agli anni 1708-1709, contenente «informazioni, consulti, relazio-ni alla Giunta dei Confini ed altre scritture […] per la causa di Savona»34. Il 23giugno 1708 i Serenissimi Collegi discutono una pratica che riguarda numero-se pressioni messe in atto dalla corte di Sua Maestà Cesarea «in ordine al dover-si prendere dalla Repubblica Serenissima le investiture per Savona e Nove»(ossia Novi), città che rivestono entrambe la massima importanza per il gover-no genovese; come ne riveste in generale la questione dei rapporti con l’Impero,in un momento in cui l’ambasciatore genovese a Vienna riferisce che è stataappena concessa al duca di Savoia l’investitura del Monferrato con la sovranitàsui feudi delle Langhe, terre confinanti con la Repubblica e in cui molti patrizigenovesi hanno interessi35.
La Giunta dei Confini viene subito incaricata, il 6 luglio, di consultare imigliori «legisti» e di raccogliere «le scritture di maggior conseguenza» riguar-danti Savona. Gli illustri giuristi consultati, Giuseppe Bottini e Giulio CesareBaldisone, il 3 giugno 1709 presentano una relazione in cui riassumono accura-tamente la situazione di Savona nei confronti del Sacro Romano Impero. «Lacittà di Savona – vi si legge – in tre tempi può considerarsi. Prima delle con-venzioni fatte da essa con questa Repubblica Serenissima di Genova, che comin-ciarono l’anno 1153. Durante le medesime convenzioni. E queste poi estintenelle cose concernenti il benefizio della detta città». Nella prima fase Savonaaveva ancora legami di dipendenza dai suoi marchesi, e per pararne le pretesericorreva agli imperatori, ottenendone documenti come il Privilegium concessio-nis jurisdictionis Saonae factum per Henricum imperatorem del 1014. Nella secon-da fase, fra il 1153 e il 1526, essa aveva stretto con Genova ben nove conven-zioni, che tutte comportavano «confederationi ineguali con soggezione per laparte della città di Savona», e in base alle quali pertanto la Repubblica aveva
130
32 ASS, Comune I, 62.33 M. CASTIGLIA, L’antico archivio cit., p. 64.34 ASG, Archivio segreto, 294. In ASG, Archivio segreto, 361 si conserva un altro corposo dossier di settanta
fascicoli, in parte originali e in parte maggiore in copia, che rappresenta un’accurata raccolta di convenzioni,privilegi e investiture, realizzata presumibilmente all’inizio del Settecento per avere sott’occhio tutta la docu-mentazione riguardante la situazione di Savona dal punto di vista dei rapporti con l’Impero. Un manoscrittosecentesco dal titolo Privilegi concessi da diversi Imperadori alla città di Savona è conservato in ASCG,Manoscritti Brignole Sale, n. 240.
35 ASG, Archivio segreto, 2554.
Capitolo 8
L’esproprio della memoria
acquistato «superiorità e giurisditione» nei confronti di essa. Ma le convenzioni– precisano i giuristi – non avevano annullato la sovranità dell’Impero, ragionper cui il Commune Saone aveva sempre condotto una politica ambigua, alter-nando le pattuizioni con Genova agli atti di fedeltà nei confronti di Sua MaestàCesarea. Così, ad esempio, la comunità di Savona «l’anno 1256 suplicò l’impe-ratore Federico II et ottenne che la città con li suoi castelli ville e distretto tuttofosse sempre tenuta nel dominio dell’imperatore et Impero, né fosse mai sottrat-ta dalle mani del imperatore o ad altri conferta». Però, dopo il 1414, «non si èveduto che la città di Savona habbia riconosciuto l’imperatori»; anzi, prestandonel 1441 e nel 1458 giuramento di fedeltà e omaggio nei confronti di Genova,«si pose di fatto in stato di non riconoscere più per superiori l’imperatori».
Riconosciuta la supremazia esclusiva della Superba, il Comune savonese siera però reso colpevole di «contraffationi e malo operare […] contro la formadelle conventioni», e addirittura di «frequenti ribellioni»: ragion per cui consentenza resa nel 1523 dal Doge, dall’Ufficio di Savona e dal Consiglio degliAnziani i savonesi erano stati dichiarati «meri suditi». Dando prova di «cle-menza e pietà», Genova aveva stipulato nuove convenzioni nel 1526, ma in esse«fra le altre cose si convenne che la Republica hebbe et ha la superiorità e tota-le giurisditione nelli huomini e città di Savona e tutto il suo distretto». Infinel’ultima ribellione aveva indotto i Serenissimi Collegi, nel 1528, a ribadire lariduzione di Savona a «mera sudita della Repubblica». Subito dopo la città erastata espugnata «a forza d’armi», cosicché Genova «per giusta guerra ne prese ilpossesso et aquistò legittimamente l’assoluto e pieno dominio, anche approva-to dalla maestà cesarea dell’imperatore Carlo V» e poi confermato dai suoi suc-cessori Ferdinando I, Rodolfo II e Ferdinando II. Nel privilegium concesso daCarlo V compariva sì – con la formula «nostris tamen et Imperii iuribus sem-per salvis» – una riserva a favore della corona imperiale, ma i giuristi spiegava-no trattarsi di un’affermazione generica, riguardante la suprema autorità diCesare, e non l’effettiva sovranità della Repubblica, la quale «poteva liberamen-te havere, tenere e possedere tutti li luoghi e città e loro territorio, e di tutto colmero e misto imperio e totale giurisditione». Senza contare che Genova per 180anni, dal 1528 al 1708, aveva «pacificamente posseduto la città di Savona e suodistretto», e in tale spazio di tempo ogni eventuale altro diritto sarebbe statoprescritto. Al termine di questa dotta disquisizione, però, i giuristi aggiungonoun suggerimento un po’ sorprendente: se l’imperatore pretendesse «che la cittàdi Savona fosse in qualche parte suo feudo e ne richiedesse dalla RepubblicaSerenissima la ricognizione», dopo aver protestato la propria ignoranza «che inessa sii alcuna qualità feudale» e aver ribadito che la si possiede «per il corso dilunghissimo tempo come libera e di pieno et assoluto dominio», sarebbe oppor-tuno infine «non negarne la qualità feudale, per non dare con tale negativa mag-giore pretesto alle pretensioni della corte cesarea».
Poco più tardi, nell’ottobre 1709, viene stilata una memoria per il rappre-sentante genovese a Vienna36, dalla quale risulta evidente che la questione di
131
36 ASG, Archivio segreto, 294.
Savona ha assunto ormai una dimensione ben più ampia, concernente i princì-pi generali del diritto pubblico, perché dalla soluzione che ad essa viene datapuò dipendere, per certi versi, il ruolo internazionale della Repubblica. Lamemoria parte dalla constatazione che la sovranità genovese su Savona – laquale data «da tempo cui non è a memoria d’huomin il principio» – «si pruovanella guisa che ogni principe cristiano tiene con giustitia il suo Stato».L’imperatore, per grande che sia il suo potere, non può certo pretendere ildominio del mondo; come «li re delle Spagne, Francia, Inghilterra e tanti altriprincipi» e «le repubbliche di Venetia, Olanda et altre» godono di piena sovra-nità, così deve valere per Genova. Su questa querelle, dunque, si gioca non ilsemplice possesso di Savona – che, come i saggi giuristi hanno suggerito, puòessere assicurato con una sorta di atto di cortesia nei confronti dell’Impero –bensì la piena indipendenza della Repubblica, la cui affermazione è tanto piùvitale in un periodo nel quale la controversa successione al trono di Spagna stasconvolgendo la carta politica della penisola.
È per questa ragione che nel febbraio 1709 il Senato ha dato ordine aGiacomo Maria De Franchi, allora Commissario nella fortezza di Savona, di«destramente ritirare li privileggi concessi a quella città dagli imperadori EnricoVI, Ottone IV, Federico II, Carlo IV e Sigismondo negli anni 1191, 1209,1222, 1276, 1364, 1368 e 1414, che conservavansi autentici presso personeparticolari di detta città», per poi consegnarli al suo ritorno alla Giunta deiConfini37. Il De Franchi si rivolge al nobile savonese Cesare Siri «presso di cuiritrovavansi estratti in autentica forma tutti li privileggi suddetti», e costui da«fedelissimo suddito» glieli consegna con prontezza. Ma scopre poi che deglistessi privilegi ci sono altre copie, di cui una custodita dai Maestri Razionali «inun libro chiamato della Catena e serrato in una cassa di ferro, la chiave dellaquale resta in custodia al più antico di età di detto magistrato». Il libro – checontiene anche atti di acquisto di terre (Albisola, Segno, Quiliano e altre) fattida Savona in varie epoche – «difficilmente si vede, tenendolo il sudetto magi-strato rinchiuso con gran gelosia, restando ancora inteso da pochi per esserescritto in carattere antico».
Il patrizio genovese suggerisce che, «senza privarne la detta città, che controppo gran patimento se lo vedrebbe uscir dalle mani più per affetto di osten-tazione che vi ha che per l’utile che ne possa ritrarre», basterebbe mettere allacassa un’altra serratura «la di cui chiave dovesse star sempre presso l’illustrissi-mo signor Governatore con positivo e preciso ordine di non permettere estra-zioni di alcune scritture da quel libro senza l’espressa licenza ed assenso» delGovernatore stesso, previa consultazione con il Senato. Quanto all’estratto pos-seduto dal Siri, esso è copia di quello ordinato dalla Repubblica nel 1599, sullabase delle carte ora conservate nell’archivio vescovile, entro la Cattedrale; e il DeFranchi pensa che sarebbe opportuno «farle levare affatto da quell’archivio […],non essendo per altro dette scritture d’alcun profitto o utilità né per l’econo-mico né per il spirituale a quella Mensa». Ma la cosa non è finita, perché altre
132
37 Ibidem, lettera di Giacomo Maria De Franchi al Senato (senza data, ma del gennaio 1710).
Capitolo 8
copie pare siano «presso ad altri signori di questa città»: certamente ne ha unaGiovanni Battista Pavese, il cronista nel quale già ci siamo imbattuti, e nonsarebbe male se il Governatore se la facesse consegnare. Inoltre risulta che varipersonaggi in vista – i patrizi Giovanni Battista Ferrero, Francesco MariaSpinola e Angelo Maria Rocca, le famiglie Verzellino e Lamberti, il notaioFilippo Alberto Pollero – possiedono «molte memorie della città di Savona, chehavevano in parte ereditato da loro avi et in parte compilate da loro stessi»; mail Commissario genovese non ha osato chiederne conto a costoro, «giudicandol’istanza pericolosa, così per non essere troppo informato de’ loro temperamen-ti, che sul riguardo di non richiamare alla memoria quelle scritture».
Tutto sommato pare che non ne facciano più gran conto, mentre un paleseinteressamento delle autorità di governo potrebbe «risvegliare memorie sepolte,che venute a notizia di qualche persona poco affezionata» rischierebbero di«partorire mali oggetti»; e tali persone non mancano, perché su Savona gravitaun gran numero di spie del duca di Savoia che cercano di «raccogliere quantescritture le puonno capitare alle mani» e riferiscono a Torino «tutto quello chesi opera in Savona». Il De Franchi suggerisce perciò ai Senatori di servirsi di untal Gerolamo Arbora, commissario della dogana per conto di San Giorgio, per-sona abile e bene introdotta tra i maggiorenti savonesi, il quale potrebbe, chie-dendo di leggere quelle scritture per sua curiosità, farsele prestare «per ricavar-ne tutto ciò che vi trovasse a proposito e potesse meritare la notizia di VostreSignorie Serenissime». Due anni dopo, il 7 ottobre 1712, per incarico delSenato il notaio genovese Domenico Musso redige un «inventario di tutte lescritture della città di Savona che al presente si ritrovano nella masseria dellachiesa cattedrale di detta città», dopo un’ispezione avente come scopo di con-trollare che alcune carte non siano finite – come correva voce – nelle mani diVittorio Amedeo II, le cui mire sul Savonese sono note38.
Tutto ciò fa ben comprendere quanto timore incutano alla Repubblica quel-le vecchie scartoffie, e con quanta attenzione la memoria storica di Savona – dicui nonostante tutto ancora si conservano tracce nel pubblico archivio e negliarmadi delle maggiori famiglie – vada sorvegliata e soffocata. Del resto la “pauradel passato” giunge fino a far ritenere pericolosa (e quindi meritevole di confu-tazione) la leggenda medievale di Aleramo e Adelasia, così diffusa nelle terre delbasso Piemonte e della Riviera di Ponente. In uno dei già citati dossier riguar-danti la dipendenza di Savona dal dominio genovese si può trovare uno scrittonel quale, per dimostrare che la città è «libera e non feudale», si ricorda che essanon è «compresa nella donazione fatta da Ottone ad Alerame di Sassonia», e siaggiunge che è «favolosa la donazione, e favola l’arte di carbonaro dell’Aleramee moglie». Lo scritto è anonimo, ma sappiamo che ha richiesto l’impegno di ungiurista di fama, e la revisione da parte di due teologi consultori in iure39.
133
38 M. CASTIGLIA, L’antico archivio cit., p. 61.39 ASG, Archivio segreto, 361, n. 70.
L’esproprio della memoria
I timori, placatisi dopo la firma dei trattati di pace del 1713-14, ritornanocon la guerra di Successione austriaca. Nell’ottobre del 1742, quando FrancescoMaria Doria ambasciatore genovese a Parigi riferisce al cardinale Fleury «la noti-zia sparsasi di qualche convegno fra la corte d’Inghilterra e quelle di Vienna edi Torino per la cessione di Savona» a Carlo Emanuele III, il primo ministro diLuigi XV lo rassicura, ma non può fare a meno di prospettargli il pericolo cheil re di Sardegna possa vantare qualche titolo di possesso su quella città, tantopiù che a Torino sarebbe stata creata una deputazione «per cumularne leprove»40. Ancora la preoccupazione per le vecchie carte, dunque, come poiavverrà – s’è detto – nel 1753, quando però sarà Sanremo e non Savona il moti-vo del contendere.
Nel frattempo, tuttavia, è quest’ultima città a ritrovarsi in larga misura pri-vata della propria identità storica. Ma questo esproprio della memoria, che puòsembrare una forma particolarmente sottile e crudele di violenza, in realtà è ladebole arma difensiva di una piccola repubblica che si sente accerchiata da vici-ni troppo potenti. Per difendersi dai loro artigli, si sforza di cancellare il passa-to delle città suddite, ma è poi costretta, come abbiamo accennato in prece-denza, ad occultare anche e più il proprio. «La quasi totale perdita della memo-ria storica è […] il fenomeno più sconcertante del Settecento genovese», hascritto un profondo conoscitore di quel periodo come Salvatore Rotta41. È neifondi manoscritti delle biblioteche genovesi, nell’Archivio di Stato e in quellodel Comune di Genova che è rimasta racchiusa e imprigionata, al pari della fati-ca di Giovanni Vincenzo Verzellino, molta della storiografia prodotta dallaGenova settecentesca, solo in seguito e parzialmente riportata alla luce. Fino al1797 nessuno studioso sarà ammesso a consultare documenti dell’archiviogenovese, cui talora potranno accedere solo i giuristi incaricati dal governo diribattere le pretese di superiorità dell’Impero o di contrastare le ragioni dei sud-diti ribelli: persino le cronache medievali vi verranno custodite come segreti diStato, tanto che neppure al grande Ludovico Antonio Muratori sarà consentitala consultazione del codice contenente gli Annali di Caffaro e dei suoi conti-nuatori42. Solo dopo la caduta della Repubblica la classe dirigente genovese tor-nerà ad occuparsi del proprio passato, e per molto tempo lo farà con un sensodi rancore e di frustrazione per la perduta indipendenza, che somiglia non pocoa quello manifestato fra Otto e Novecento dalla storiografia savonese.
134
40 ASG, Archivio segreto, 2223, lettere di Francesco Maria Doria dal 16 ottobre al 17 dicembre 1742.41 S. ROTTA, Introduzione a Il bombardamento di Genova nel 1684, Genova, La Quercia, 1988, pp. 14-17. 42 G. BALBI, Giorgio Stella e gli “Annales Genuenses”, in Miscellanea storica ligure, vol. II, Milano, Feltrinelli,
1961, pp. 123-215 (in particolare pp. 149-152).
Capitolo 8
Nella sua Storia di Savona, Nello Cerisola ricorda con parole accorate chesulla città, onorata di un titolo di «fedelissima» che a suo parere suonava comeuna beffa, Genova «continuò [...] ad esercitare un pesante fiscalismo che simanifestò in varie forme: [...] nel 1611 il Senato raddoppiò la gabella sul vino;nel 1630 venne aumentata la gabella dell’ancoraggio; nel 1632, mentre aumen-tavano le tasse della “canna, peso e copeta”, veniva applicata una impostastraordinaria di quattro soldi per ogni soma sulle frutta e le ortaglie per soppe-rire alle spese delle nuove mura cittadine; nel 1641 fu attivata la tassa dell’u-guaglianza, che per poco non eccitò una generale sollevazione fra il popolo».Tanto che «l’eccessivo carico fiscale condizionò [...] l’auspicata ripresa econo-mica»1. Il giudizio di Cerisola non fa che riprendere, precisare e amplificarequelli che si possono trovare in altre opere più vecchie, e infatti tutti hanno incomune due caratteristiche: danno per scontata la rapacità del fisco genovese edevitano di entrare nei particolari, limitandosi a qualche esempio e a una gene-rica condanna. È un atteggiamento, questo, che peraltro non riguarda solo ilcaso savonese: per molto tempo la storiografia, magari credendo un po’ fretto-losamente a tutto quel che era scritto in qualche supplica o lamentela o ricorso(è mai esistito un contribuente che non considerasse eccessive le imposte chedoveva pagare?), ha parlato per gli Stati di antico regime di fiscalismo oppri-mente, di rapacità degli esattori e di simili nefandezze, senza troppo preoccu-parsi dell’effettiva entità del prelievo fiscale. In alcuni casi il fraintendimento èstato totale: ancora oggi noi bolliamo con l’aggettivo borbonico il nostro siste-ma tributario quando lo giudichiamo complicato e ingordo, e tuttavia lo studiodella finanza pubblica napoletana fra Sette e Ottocento ha da tempo chiaritoche in realtà il prelievo era tenuissimo. Oggi sappiamo che, nella maggior partedegli Stati italiani dell’età moderna, il problema non era tanto l’alta incidenzadella tassazione su quel che noi chiamiamo prodotto interno lordo, ma semmail’ingiusta ripartizione del carico, o la difficoltà per i ceti inferiori – che spessovivevano prevalentemente di autoconsumo – di procurarsi il denaro per pagarele imposte.
Nel caso specifico della Repubblica di Genova, la pressione fiscale è rimastasempre piuttosto modesta, anche se – in uno Stato che ha così scarsi caratteri diuniformità – anche il fisco non ha colpito dappertutto con la stessa forza e nellestesse forme. Due aspetti vanno comunque tenuti presenti. Il primo riguardal’abilità politica grazie alla quale, da Andrea Doria in poi, la Repubblica hasaputo salvaguardare la propria indipendenza sia nei confronti della Spagna, siapiù tardi nei confronti del ducato di Savoia. Se oggi sulla dominazione spagno-
135
1 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., p. 286.
Capitolo 9
Gli artigli del fisco
la in Italia si può dare un giudizio meno negativo che in passato, resta il fattoche i territori italiani direttamente soggetti al governo di Madrid hanno dovu-to pagare un prezzo all’onerosa politica “imperialistica” dei sovrani asburgici.Nel regno di Napoli ciò ha comportato una sorta di svendita del territorio abaroni vecchi e nuovi, una colossale cessione di cespiti dello Stato a favore difinanzieri e speculatori, un generale impoverimento del paese; ma anche nelducato milanese ha reso necessaria una tassazione piuttosto pesante. «Se aMilano – ha scritto Domenico Sella – la Spagna adottò volutamente una pru-dente politica di rispetto delle esistenti istituzioni e fece così largo affidamentosulla collaborazione del patriziato che di quelle istituzioni era geloso custode,improrogabili e crescenti esigenze finanziarie [...] la costrinsero tuttavia a pren-dere drastiche misure [...] in materia fiscale [...], sia con l’inasprimento dei tri-buti esistenti sia con la creazione di nuovi tributi», in particolare il cosiddetto«mensuale»2. L’eventuale inserzione della Liguria o di una parte di essa neidomini asburgici, ventilata nel Cinquecento, o l’annessione a quelli sabaudi,che a partire dal primo Seicento diventa un’ipotesi non del tutto platonica,avrebbero comportato una tassazione ben più pesante, viste le forti spese mili-tari che spesso anche i Savoia si sono trovati ad affrontare. L’indipendenzagenovese, dunque, ha consentito tanto alla Dominante quanto al suo Dominiodi non soggiacere a questi carichi.
Un altro aspetto da considerare riguarda specificamente la politica tributariadella Repubblica, di fronte alla quale gli osservatori stranieri si stupiscono e siindignano constatando che alle enormi ricchezze del patriziato genovese corri-sponde una singolare ristrettezza dei bilanci statali. In realtà questo squilibrio èil frutto di una strategia perseguita con successo dal ceto di governo, che da unlato mira a salvaguardare i propri interessi privati, dall’altro si appoggia allaSpagna per quasi tutte le esigenze di difesa esterna e così ne addossa a quest’ul-tima i costi. I maggiori beneficiari di tale strategia sono ovviamente gli aristo-cratici genovesi, ma anche nel resto dello Stato i ceti possidenti ne traggonovantaggio, quantunque ci sia un rovescio della medaglia: perché il fisco leggerocomporta una spesa pubblica molto modesta, specie nei confronti del Dominio,il quale non può attendersi dal governo – per dirla col linguaggio odierno –investimenti in infrastrutture.
Date queste premesse, cerchiamo di vedere brevemente i caratteri del sistematributario genovese, che è imperniato soprattutto sulle imposte indirette, men-tre vi hanno un’importanza minore i tributi diretti sul patrimonio e sul reddi-to3. Questi ultimi si suddividono in tre categorie: le imposte ordinarie sulDominio, quelle straordinarie sempre sul Dominio, e infine quelle straordina-rie sulla Dominante, dove – per evidente privilegio dei cittadini della metropo-li – non esiste tassazione diretta ordinaria. Le imposte della prima categoria ven-
136
2 D. SELLA, Sotto il dominio della Spagna, in D. SELLA-C. CAPRA, Il Ducato di Milano dal 1535 al1796,Torino, Utet, 1984 (Storia d’Italia diretta da G. GALASSO, vol. XI), pp. 1-149 (qui pp. 48-49).
3 Il sistema fiscale della Repubblica di Genova è descritto in modo puntuale in G. FELLONI, Scritti di storiaeconomica, Genova, Società ligure di storia patria, 1998 (ASLSP, vol. CXII), pp. 201-212 e 224-252. Da que-sto testo sono tratte le notizie che diamo qui di seguito.
Capitolo 9
Gli artigli del fisco
gono riscosse regolarmente ogni anno, e si cerca in genere di renderle propor-zionali alla ricchezza e alla quantità di popolazione delle singole circoscrizioniterritoriali; quelle delle altre due categorie vengono levate in circostanze ecce-zionali, per finanziare opere difensive di grande impegno o per coprire spesebelliche.
Nel Dominio di terraferma i tributi diretti ordinari riscossi dallo Stato, o permeglio dire dalla «Camera», sono l’«avaria ordinaria», la tassa per le galere, quel-la per l’olio e quella di macina, oltre ad altre imposte minori. L’avaria, che col-pisce circa il 55% della popolazione, è pagata a contingente o «a distaglio»: laCamera, basandosi principalmente sul patrimonio fondiario, fissa l’importodovuto da ciascun corpo locale, dopo di che questo paga con i propri proventi(rendite pubbliche, gabelle), o se questi non bastano, come avviene quasi dap-pertutto, copre il residuo ripartendolo per due terzi sui beni immobili e per unterzo sulle «teste», cioè su tutti gli abitanti maschi adulti «habiles ad arma por-tanda». Il valore delle proprietà fondiarie viene rilevato nelle varie circoscrizio-ni mediante appositi censimenti (le cosiddette «caratate») compilate da squadredi estimatori sotto la sorveglianza di commissari governativi, censimenti checonsiderano immuni le proprietà dei cittadini genovesi di qualunque ceto.
La tassa dell’olio, istituita nel 1571 per assicurare l’approvvigionamento dellaDominante e applicata ai territori con una produzione olearia superiore allenecessità locali, viene pagata per lo più in contanti anziché in natura e ha ungettito molto modesto; quella delle galere, decisa alla fine del Seicento, è di fattoun’addizionale all’avaria, anche se si applica su un maggior numero di circo-scrizioni; quella della macina, creata nel 1610, è riscossa in quasi tutto ilDominio e anch’essa finisce per configurarsi come un’addizionale all’avaria,anche se fornisce un gettito più importante della tassa dell’olio. In aggiunta aqueste, il Dominio viene colpito di quando in quando da imposte straordina-rie, la cui aliquota è talvolta fissata all’1% dei patrimoni più consistenti (le«aziende» superiori a £ 6.000 o a £ 12.000), altre volte si tratta di una quotaassegnata a ciascuna circoscrizione che verrà poi ripartita su quegli stessi patri-moni. Naturalmente la fiscalità statale (cui va unita quella dipendente dalBanco di San Giorgio) non esaurisce affatto il prelievo, perché una buona partedi esso è rappresentato da tributi pagati alle amministrazioni locali e spesi perle esigenze particolari delle singole comunità.
Va ricordato che, nel corso del tempo, la pressione fiscale da un lato cresce intermini complessivi, dall’altro tende a spostarsi sempre più dalla Dominante alDominio: nel 1550 il rapporto fra le imposte camerali che gravano sulla metro-poli e quelle che colpiscono il resto del territorio è di 14:1; verso il 1650 è scesoa circa 5:1; cento anni dopo è giunto a 3:1. Le imposte prelevate nel Dominioa favore della Camera passano così dalle £ 58.269 del 1550 alle £ 539.582 del1650, per giungere alle £ 911.736 del 1750. Se la prima somma è certamenteirrisoria, anche l’ultima tuttavia non può considerarsi pesante sia se viene messaa confronto con il prelievo totale (£ 5.310.647), sia ancor più se paragonata allerendite milionarie delle maggiori famiglie patrizie genovesi.
137
In questo quadro generale, come si colloca Savona? Ci sono forse particolaristrumenti punitivi messi in opera da Genova nei suoi confronti, per vendicarsidella sua lunga ostilità e fiaccarne la popolazione? Inizialmente la Dominante sipresenta con un volto molto duro: per rifarsi delle spese sostenute nella con-quista armata della città – lo abbiamo già ricordato nel capitolo 5 – nel 1529essa si riserva il diritto di imporre alla comunità locale qualsiasi imposta perso-nale o reale. Tre anni prima – ricorda Agostino Abate nella sua cronaca –Genova le ha ingiunto di pagare 10.000 scudi in dieci anni per risarcire il prez-zo delle navi affondate nel suo porto e delle giornate dei «guastatori»4. Fino adallora Savona ha goduto di una quasi totale autonomia fiscale e ha finanziato leproprie spese pubbliche con introiti derivanti da una serie di gabelle su derratealimentari, di dazi commerciali, di imposte di fabbricazione: una tassazioneunicamente indiretta, che fornisce un gettito annuo medio di circa 25.000 liregenovesi5.
Dopo la “sottomissione”, la situazione resta sostanzialmente identica: alme-no a partire dal 1537 il Comune rientra nel pieno possesso della propria capa-cità contributiva, i suoi magistrati curano ogni anno l’appalto delle gabelle econservano un’esclusiva giurisdizione nei confronti di appaltatori e gabellotti6.La Repubblica ha infatti concesso a Savona di riscuotere le proprie gabelle: uni-che condizioni sono che in questa materia i savonesi non introducano innova-zioni senza il consenso del Senato, e che i «cives Ianue» abbiano un trattamen-to fiscale moderatamente agevolato7. Per tutta la durata del dominio genovese,dunque, le entrate fiscali savonesi saranno gestite dalla città, e saranno i suoiAnziani e Razionali, all’occorrenza, a deciderne gli aumenti, sia pure col bene-placito del governo genovese. Il Comune, d’altronde, non si perita di rivendi-care la propria autonomia in materia tributaria con estrema puntigliosità: versola metà del Seicento, ad esempio, di fronte a un tentativo dei gabellieri genove-si di tassare «le cotonine e bombasine che fabricate in detta città si conduconoa Genova», gli Anziani protestano che, in base alle convenzioni esistenti, Savona«non può esser gravata d’alcuna colletta, dacio, imposto né gabella più di quel-lo che nell’instrumento di dette conventioni si contiene, come appare nelStatuto politico». Infatti «li cittadini di Savona devono esser trattati come li cit-tadini di Genova nel pagamento de’ dritti e gabelle [...]: nelle conventionisogliono sempre esser reciprochi li privileggi e franchigie, onde se li cittadini diGenoa non pagano le gabelle di Savona, conseguentemente li cittadini diSavona non sono tenuti a pagare le gabelle della città di Genoa»8.
In origine le principali gabelle imposte dal Comune di Savona sono leseguenti: canna (su stoffe, panni, tele, pelli, carta), peso (su spezie e droghe,vetriolo, rame e stagno, polvere e salnitro, lane di Roma, d’Inghilterra, diCatalogna etc., gualdi, cuoi, cotoni, ferramenta, ferro e vena ferro, piume, cana-
138
4 A. ABATE, Cronache savonesi cit., pp. 78-79.5 ASG. Camera del governo, 4.6 Statuti politici della città di Savona cit., pp. 28, 34, 37, 40, 204-205, 207-208.7 Concessioni decreti et ordini cit., pp. 15-26. 8 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 4v-5r.
Capitolo 9
pe, mercerie), vino al minuto (quello venduto da osti e tavernieri, con tariffe piùalte per i vini pregiati come «moscatella, vernacias, malvasias et roxezia»), forni(su tutto il pane venduto all’ingrosso e al minuto, nonché sul biscotto), grasciae olio (su olio, lardo, sevo, candele, carni salate), copeta (su frumento, castagne,legumi, fichi, nocciole, noci, mandorle, granaglie), pesci (su pesci freschi crudidi passaggio o venduti «in chiappa», cioè nel locale mercato del pesce, e su pescicotti e salati), formaggi (sui formaggi di Sicilia e Sardegna, e su «ogni altro for-maggio e butirro»), pedaggio (sulle merci che escono da Savona e suo distrettoper mare e per terra: tessili, cereali, carni e bestiame, natanti), fornaci (per ogni«cotta» o infornata di laterizi, pignatte, stoviglie), macelli, vino proibito (cioè suivini forestieri), farina (sui grani mandati a macinare).
Per l’anno 1666, il continuatore del Verzellino offre un elenco delle «gabelleed augumenti che oggidì si trovano in Savona» nel quale poco è cambiatorispetto al quadro precedente: tra le novità si segnalano le gabelle dell’ancorag-gio, del pane bollato, della tara, degli osti, dei fidelari9. La prima è stata istituitanel 1546, su istanza della città e approvazione del Senato, per reperire i fondinecessari alle riparazioni della darsena, e verrà poi continuamente rinnovata eaumentata10. La seconda è stata concessa nel 1572, sempre su richiesta delComune, che ritiene onerosa la tassa di «lire mille l’anno per conto della estin-tione del dritto dell’oglio», decisa l’anno prima dalla Signoria, e ritiene che«facendosi bollare il pane quale si vende alle hostarie e taverne», e facendo paga-re su questo pane un balzello fino a 10 soldi per mina più di quello «pro usuuniversali», si potrebbe «sgravare la comunità, e tutto il danno sarebbe de’ fora-stieri»11. Le altre gabelle sono nate anch’esse dall’iniziativa del Consiglio comu-nale, che ne utilizza il gettito per pagare gli interessi di alcuni mutui contrattiper le proprie esigenze. C’è poi una nutrita serie di «augumenti» – cioè di addi-zionali alle gabelle – tutti messi in atto con la solita procedura, cioè la richiestadel Consiglio savonese e l’approvazione del Senato genovese, destinati anch’es-si al «dispaccio della darsena» e ad altri lavori portuali.
Accanto alle entrate locali gestite dal Comune si situano, come s’è detto,quelle destinate alla Camera: la tassa dell’olio, che abbiamo visto convertita inquella sul pane bollato; quella delle galere; quella di macina «per la quale sipagano soldi dieci, moneta di Genova, per ogni mina di grano che si macina almolino»12. Nel 1610 Savona ha entrate per un totale di £ 39.247, e di questepaga al fisco della Repubblica meno di 3.000 lire per la tassa dell’olio, quelladelle galere e altre imposte minori; più gravose semmai sono le spese che ilComune deve sostenere per i salari del Governatore (ben 3.200 lire), del Vicario(£ 600) e del personale alle loro dipendenze, anche se non bisogna dimentica-re che tutti costoro svolgono un servizio (amministrazione della giustizia, tute-
139
9 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 396-398.10 G. ASSERETO, Porti e scali minori cit., pp. 234-235.11 Concessioni decreti et ordini cit., pp. 106-107; ASS, Comune I, 209, c. 247. Una mina, misura di capacità
per gli aridi, corrisponde a circa 116,5 litri.12 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, p. 398.
Gli artigli del fisco
la dell’ordine pubblico) a favore della città13. Nel bilancio del 1717-1718,quando le imposte «camerali» sono tutte da tempo a regime e la macina ha rice-vuto una consistente «additione», Savona risulta tassata in totale a favore dellaCamera per £ 13.46714.
Fin qui, dunque, nulla di particolarmente esoso od oppressivo. Alla città pesapiuttosto la gabella del vino «che si esigge per conto dell’Illustrissima Casa diSan Giorgio», forse non tanto per il suo importo quanto perché è vista come ilfrutto di una sopraffazione. Imposta nel 1531 sul vino «ch’entrasse in città e chenascesse fra certi limiti da Lavagnola a basso» – cioè quello prodotto nelleimmediate vicinanze – in ragione di soldi 10 per ogni mezzarola misura diSavona, questa gabella cambia destinazione allorché, fra il 1542 e il 1544, ilBanco di San Giorgio concede alla Repubblica un prestito per finanziare lacostruzione della fortezza sul Priamàr15. Il Banco in quell’occasione emette4.100 «luoghi» per un valore nominale di £ 410.000, e ottiene «per pegno et inamministrazione detta gabella», il cui gettito dovrebbe servire a pagare gli inte-ressi su quei luoghi (a «far le paghe», come si dice all’epoca), e in parte a estin-guere il debito stesso, perché 370 luoghi sono lasciati come «coda di redenzio-ne», i cui proventi vanno appunto a ridurre di anno in anno il capitale.
Che un reddito della città serva a coprire le spese per quella fortezza che hacomportato la distruzione di una parte di essa, non è certo una decisione accet-tata a cuor leggero, anche se per molti anni – fin verso la metà del Seicento –l’appalto di questa gabella non solo consente di pagare gli interessi a SanGiorgio in ragione di circa £ 13.000 all’anno, ma fornisce alla Comunità unreddito aggiuntivo di circa £ 3.700, che essa può spendere in lavori pubblici.Però con l’andare del tempo, mentre Savona perde abitanti e traffici, il gettitosente anch’esso «la giattura della città», cosicché si è costretti ad aumentarne laquota perché il ricavato non cali. Nel 1662 è salita a soldi 33 a mezzarola (osoldi 44, se si usa la misura di Genova), mentre la coda di redenzione – che aquest’epoca avrebbe consentito l’estinzione o quasi del prestito – nel frattempoè stata stornata in altri usi per decreto della Camera. Nel 1731 si è giunti ariscuotere soldi 53 a mezzarola misura di Genova, eppure quel che se ne ricavaè insufficiente; senza contare che è diventato sempre più difficile trovare chiprenda in appalto la gabella, ragion per cui il Comune è costretto a curarnedirettamente la riscossione e spesso ci scapita16. Qui dunque siamo di fronte aun balzello che da un lato è odioso per la sua origine – anche se c’è da suppor-
140
13 ASG, Magistrato delle Comunità, 835, cc. 68-73. Il giusdicente genovese e la sua «famiglia» ricevono quicompensi sensibilmente più alti rispetto ad altri luoghi della Repubblica (Sanremo, ad esempio, paga £ 510 peril suo Podestà, Rapallo £ 1.100 per il Capitano, Porto Maurizio £ 397 per Podestà e Vicario, Albenga £ 1.500per il Podestà e £ 800 per il Vicario). Sui carichi di Savona a quest’epoca si veda anche Una fonte per la geogra-fia storica della Liguria. Il Manoscritto 218 dell’Archivio di Stato di Genova a cura di M. P. ROTA, Genova, CivicoIstituto Colombiano, 1991, p. 98.
14 ASG, Magistrato delle Comunità, 676, c. 250r. 15 Traggo le informazioni relative alla gabella vino da una memoria del 1662 in ASS, Comune I, 211, cc.
224-228; da un’altra relazione senza data (ma certamente posteriore al 1659) in ASS, Comune I, 214; e daiCapitoli et ordini fatti per conto della gabella del vino del molto illustre Ufficio di Santo Georgio, anch’essi senzadata, ibidem. La mezzarola di Savona vale circa 119 litri, quella di Genova circa 159.
16 ASS, Comune I, 62, 25 maggio 1720; ASS, Comune I, 143, 28 novembre 1731.
Capitolo 9
re che col tempo pochi in città di tale origine si ricordino – e dall’altro, pur nonessendo in sé molto gravoso, lo diventa man mano che la città s’impoverisce.
Tuttavia è appunto su questo impoverimento della città che non riusciamoad avere le idee chiare. Ne riparleremo più diffusamente in seguito, ma qui bastidire che, quando gli Anziani di Savona sciorinano davanti al Senato il quadrodelle miserie cittadine per lamentare il peso insopportabile della tassazione, nonsempre è lecito prestar loro fede. Proprio la memoria del 1662 di cui ci siamoserviti per discorrere della gabella vino ne offre un esempio chiaro: gli Anzianiprotestano che, fra le molte disgrazie, Savona nel biennio 1656-57 è stata col-pita dalla peste e ha visto morire più di mille abitanti. Ma in risposta a questa,un’altra relazione stesa da una commissione del Senato rileva che nel 1656, adifferenza di quanto accaduto a Genova, non c’è stata peste a Savona; al che gliAnziani replicheranno: «ve ne fu il sospetto, che fece appartar le persone alleville», provocando una minore vendita di vino e quindi un minor gettito dellagabella. Una replica davvero sconcertante, da cui si deduce che chi – scrivendoa pochi anni dai fatti – è capace di inventarsi mille morti, non può certo arre-trare di fronte ad altre menzogne.
Questa civica amministrazione spesso incline a piangere sulle proprie miseriee a lagnarsi dell’eccessivo carico fiscale, non si lascia però mai sfuggire una paro-la su un fatto che viceversa va preso in attenta considerazione per valutare i rap-porti fiscali con la Dominante. Come abbiamo ricordato più sopra, Genovapreleva in molte località del proprio Dominio le cosiddette «avarie», imposte ditipo diretto fondate almeno in parte sulla proprietà immobiliare, al cui accerta-mento sono finalizzate le «caratate». Giuseppe Felloni ha ricostruito i contin-genti annui dell’avaria ordinaria sulle comunità del Dominio fra il 1466 e il1532, ed è interessante notare che nell’elenco di tali comunità Savona non com-pare né prima né dopo il fatidico 152817: ulteriore riprova che la sottomissionenon è stata così pesante come da alcuni si pretende, e che la città ha conserva-to anche in questo caso un importante privilegio di cui godeva come «luogoconvenzionato». È vero tuttavia che Genova decide di effettuare, nell’ottobre1530, una minuziosa caratata «che costituisce il più antico documento catasta-le conosciuto della città, rimasto unico [...] fino all’epoca napoleonica»18. Il rile-vamento è davvero una novità assoluta, perché a Savona non solo non si sonomai pagate le avarie alla Camera, ma neppure all’interno del Comune è mai esi-stita alcuna forma di tassazione sul patrimonio immobiliare.
La decisione genovese sembrerebbe preludere all’introduzione di qualcheprelievo diretto, ma in realtà la caratata resta lettera morta; e quando l’anno suc-cessivo viene compilato un Registrum carattate seu extimationis bonorum totiusRipariae orientalis et occidentalis che raccoglie dati delle precedenti rilevazioni e
141
17 G. FELLONI, Scritti di storia economica cit., p. 251. 18 C. VARALDO, La topografia urbana cit., p. 29: il Libro de la caratata di Savona (ASG, Magistrato delle
Comunità, 782) è stato attentamente esaminato da Varaldo in questo volume, al quale rimandiamo per ogniinformazione in proposito.
Gli artigli del fisco
contiene «ampie informazioni sugli imponibili, sui tributi, sulle popolazioni esulle risorse economiche delle singole comunità», Savona neppure vi compare19.Secondo Carlo Varaldo, il fatto che non sia stata applicata un’imposta direttaanche per Savona risponde a una strategia politica genovese «dettata dal saggiocriterio di non inasprire ulteriormente la popolazione con un nuovo genere ditassazione»20. Ma qui non si tratta, genericamente, della popolazione savonese,bensì dei ceti possidenti: sono loro, infatti, che hanno qualcosa da temere daquel tipo di imposta. La carata del 1530 – che tra l’altro è servita a Genova peravere un quadro esatto di una città fino ad allora rimasta abbastanza mal nota– ha rappresentato quasi una minaccia nei loro confronti, che però è stata poilasciata cadere. Si è usato insomma prima il bastone e poi la carota, nella con-sapevolezza che l’alleanza con l’élite locale è comunque indispensabile.
Da allora il patriziato savonese fa dell’opposizione alle imposte dirette, che locostringerebbero a pagare in base alle proprie ricchezze, un vero dogma. Lo sivede bene in occasione delle tasse straordinarie, prelievi una tantum deliberatiin vari anni «per i bisogni e spese della Repubblica», cioè soprattutto per esi-genze militari e difensive che interessano lo Stato nel suo complesso. Come si èdetto, alle singole comunità vengono di solito addossati dei contingenti fissatid’imperio dalla Camera: apposite commissioni locali devono poi ripartire ilcontingente fra i possidenti di ciascuna circoscrizione21. Naturalmente ancheSavona soggiace a queste tassazioni straordinarie, al pari del resto del Dominio,ma la forma in cui paga o cerca di pagare questi tributi è peculiare e degna dinota.
Se apriamo la cronaca del Verzellino all’anno 1628, troviamo annotato che ilgoverno genovese introduce a quell’epoca due nuove tasse, dell’1% e delle for-tificazioni; ma Savona, per liberarsene e «per trovarsi i cittadini in tal tempomolto esausti, fece un donativo alla Serenissima Repubblica di £ 60.000 per latassa dell’1%, e per quella delle fortificazioni di £ 46.000, le quali £ 106.000furono subito pagate, avendo presi denari a interesse; e così furon liberati i cit-tadini dalle tasse»22. Il cronista commette qui un errore di data (è in realtà nel1630 che Savona paga alla Camera «per donativo e sussidio» le somme suddet-te, la seconda delle quali deve contribuire alle spese per le nuove mura diGenova che verranno costruite fra 1630 e 163223), ma soprattutto non ci spie-ga il senso dell’operazione: perché una città «esausta» decide di sborsare d’uncolpo così tanti quattrini? La risposta è semplice: pagando subito, e “a forfait”,Savona ha certo risparmiato qualcosa, ma soprattutto, prendendo il denaro aprestito, ha evitato ogni forma di tassazione diretta. Il mutuo – capitale e inte-
142
19 G. FELLONI, Scritti di storia economica cit., pp. 239-240. Il Registrum (ASG, Manoscritti, 797 e 797 bis)è stato analizzato e pubblicato (con inesattezze e incomprensioni) da G. GORRINI, La popolazione dello Statoligure nel 1531 sotto l’aspetto statistico e sociale, in Atti del congresso internazionale per gli studi sulla popolazione,Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1931, pp. 521-575.
20 C. VARALDO, La topografia urbana cit., pp. 29-30.21 G. FELLONI, Scritti di storia economica cit., pp. 207-208.22 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 240-241.23 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 10r-12v.
Capitolo 9
ressi – verrà infatti restituito con il gettito di appositi «augumenti» delle gabel-le sui generi di consumo, e quindi scaricato sulle spalle della popolazione nelsuo complesso, mentre avrebbe dovuto gravare su quelle dei ceti possidenti24.
La cosa è ancor più chiara nel caso di un’altra imposta straordinaria delibe-rata nel 1636 per un importo di £ 112.000, cui si aggiungono £ 19.160 per la«fabrica delle nove mura» di Savona, da prelevarsi sui maggiori patrimoni: laComunità – dopo aver protestato con qualche buona ragione per le molte spesedi carattere militare che ha dovuto sostenere a partire dal 1625, e aver pretesouna riduzione degli importi – ha chiesto «di sodisfare questi due debiti permezzo d’impositione et accrescimento di qualche gabella»25. Il Senato accoglie laprima richiesta: concede che i tassati possano estinguere il pagamento con solidue terzi dell’importo, purché paghino in buona moneta (cioè in scudi d’ar-gento) nel termine di tre anni fra il 1641 e il 1643; e decide che «per gratia restiquella città essente dal pagamento della seconda tassa delle nuove mura» in con-siderazione delle molte spese sostenute e per aver già pagato «gran somma dedanari in la fabrica dell’incaminamento delle fortificazioni il lo piano fuori diSavona et in altre fabriche publiche». Ma ritiene che non sia «giusto, conve-niente né di serviggio publico di consentire che il debito delle persone partico-lari per la detta tassa si paghi e si estingua con simile impositione et accresci-mento di gabelle in quella città ove ne sono molte», perché sarebbe una proce-dura mai adottata nel Dominio per questo genere di imposte26.
Sono dunque i governanti genovesi – i quali pure a loro volta non amano latassazione diretta e la accettano solo in casi straordinari – a deplorare questoatteggiamento, di cui invece non si vergogna affatto il ceto dirigente savonese.Lo stesso gioco delle parti si ripropone nel 1754, dopo la guerra di Successioneaustriaca e la conseguente occupazione piemontese della città che ha compor-tato danni e debiti per un totale di quasi 172.000 lire. D’intesa con il Comune,il commissario genovese Gerolamo De Mari viene incaricato dal governo di«cercare seriamente i mezzi che atti fossero ad indennizzare i cittadini da tantee sì fatali sofferte disgrazie». Ne nasce un progetto che prevede come al solitoalcuni aumenti gabellari, suggerisce una capitazione di 100 lire all’anno sulle tre«ville» di Legino, Lavagnola e San Bernardo, ma propone anche una tassa suibeni stabili degli abitanti di Savona e dei suoi borghi «a raguaglio di mezzo permigliaio», un’altra «sopra il mercimonio di uno per migliaro», e una «sopra l’in-dustria di soldi tredeci e denari quattro per centinaio».
Ancora una volta si ritiene dunque necessario ricorrere all’imposizione diret-ta, ma il Consiglio savonese fa ostruzione al piano, quantunque il commissarioDe Mari sostenga che sin «troppo tenue e non corrispondente all’equità edequilibrio raporto alle altre imposizioni riesce la tassa d’un mezzo per migliarosu de’ beni stabili di questi cittadini», mentre eccessivi sono i prelievi sulle atti-vità artigiane, o peggio su coloro che non hanno né stabili, né industria né mer-
143
24 Ivi, cc. non numerate, relazione 1° febbraio 1670.25 Ivi, cc. 60v-62r (il corsivo è nostro).26 Ibidem.
Gli artigli del fisco
cimonio. La Comunità ha contratto gran parte dei debiti proprio per risarcire ipossidenti, le cui proprietà sono state danneggiate da distruzioni e saccheggi,ma pensa poi di rifarsi a spese degli altri, esentando i possidenti anche da quelpoco che dovrebbero direttamente pagare. Una lettera degli Anziani in data 5ottobre 1755 spiega con molta impudenza che la tassa è «impossibile regolarlacolla dovuta giustizia» per le continue variazioni della mercatura e soprattuttodel valore degli stabili, che tutti i cittadini facoltosi se ne sono lagnati, che l’e-sazione sarebbe comunque difficilissima. Ci vorrà infatti un atto d’imperio delSenato, il successivo 28 ottobre, per far approvare il piano del De Mari, lascian-do tuttavia agli Anziani e al Consiglio la possibilità di modificarlo in futuro27.
In altri casi – per esempio quando nel 1681 e nel 1685 vengono addossate aSavona «e sua giurisdizione e ville» due imposte straordinarie ciascuna da £50.000 – l’ostruzionismo si manifesta in modo diverso. Il governo ordina alConsiglio cittadino di eleggere sei «ripartitori», due per ogni bussolo, destinatia distribuire la tassa fra tutti i «particolari quali hanno di patrimonio più di £6.000 tanto in effetti stabili quanto in negotio, contanti, monti o altro capita-le». Ma la scelta di questi «tassatori» è difficile come quella dell’albero cuiBertoldo doveva essere impiccato, visto che il 17 aprile 1695 non si è ancorariusciti a nominare quelli che dovrebbero eseguire il riparto relativo al 1681, eil 2 giugno 1704 è ancora in ballo l’elezione di coloro ai quali addossare quellodel 168528. Contemporaneamente si susseguono le suppliche e le ambasciate di«sindici» e «oratori» savonesi presso il governo per chiedere riduzioni e «ristori»lamentando le miserie della città e i raccolti sempre cattivi; o si apre un con-tenzioso con le ville di Legino, Lavagnola e San Bernardo, dove – si sostiene –diversi proprietari «hanno patrimonio sufficiente per la tassa universale» ma sirifiutano di «pagare per la città»; o ancora si pretende che alla quota di Savonaconcorrano anche le comunità di Quiliano e della Valle di Vado, che invece laCamera vorrebbe tassare separatamente29.
Tra suppliche e liti il tempo trascorre e i versamenti slittano: nel 1701, alGovernatore costretto per l’ennesima volta a «intimare a’ cittadini il pagamen-to del residuo della tassa dell’anno 1681», il Comune risponde che i savonesisono pronti «a sacrificar gl’haveri per ubbidire con ogni pontualità» agli ordinidel serenissimo governo, ma prega «di haver qualche risguardo alle miserie con-siderabili che tutto dì qui prendono maggior piede, et al tenue raccolto statol’anno trascorso in questo territorio». Ragion per cui si implora di differire ilsaldo all’anno seguente, «o pure a quel tempo che meglio le parrà»30.
Le pretese fiscali della Dominante, d’altronde, trovano il loro principale limi-te e contrappeso proprio nella “renitenza contributiva”, o per meglio dire nellamorosità cronica della città suddita. Nell’amministrazione tributaria genovesequesta difficoltà di riscuotere le imposte locali è un dato abbastanza consueto,
144
27 ASS, Comune I, 62, 7-8 novembre 1754 e 28 ottobre 1755; ASS, Comune I, 143, 5 e 23 ottobre 1755.28 ASS, Comune I, 61, 25 luglio 1688, 23 febbraio e 17 aprile 1695, 2 giugno 1704.29 ASS, Comune I, 143, 25 aprile 1693, 9 maggio e 20 dicembre 1695.30 Ivi, 25 febbraio 1701 (il corsivo è nostro).
Capitolo 9
ma nel caso savonese tocca vertici particolarmente alti. Qui l’enorme ritardonella riscossione delle imposte straordinarie costituisce la regola (nel 1665 latassa del 1636, sulla quale la Camera aveva concesso uno sconto del 33% pur-ché fosse pagata sollecitamente, resta ancora in buona parte da incassare31), manon va meglio per altre entrate. Può accadere infatti che nel 1673 venga richie-sta al Comune di Savona una consistente somma a saldo della gabella vino del1651-52, saldo che nel 1715 non è ancora avvenuto, tanto che infine il Senatosi rassegnerà ad abbonare quel debito32.
A parte questo caso eccezionale, i ritardi nel corrispondere i proventi di talegabella sono una costante e danno luogo a una fitta corrispondenza tra Genovae Savona, nella quale le ingiunzioni si fanno sempre più pressanti, senza tutta-via sortire gli effetti desiderati33. Nel 1664 si scrive al Governatore di Savonache la città è debitrice di £ 44.807 «per occasione della gabella del vino» deglianni 1648-1657, «e se bene di già se ne sono fatte molte instanze, non hannocurato sin hora dare soddisfattione alcuna»34. La Camera adotta talora i modidella dolcezza, di fronte alle lamentele savonesi per le tristi condizioni della cittàconcede «rilasci» e abbuoni condendoli con espressioni melliflue («in conside-ratione [...] della stima che facciamo di una città così benemerita a questaSerenissima Repubblica e di un popolo tanto ossequente e divoto della mede-ma»); altre volte usa toni intimidatori, minaccia di arrestare i magistrati locali edi rifarsi sulle loro sostanze, se la prende anche con i Governatori ricordandoche devono comunque far arrivare a Genova i denari di tasse e gabelle, e che lalegge impone loro di versarli «scosso o non scosso», cioè rimettendoceli di tascapropria se non sono riusciti a ottenere quanto dovuto. Ma blandizie e ingiun-zioni servono a poco, manca un’effettiva capacità di coercizione, e sembra chela fedelissima città lo abbia ben presto capito e ne approfitti.
A fronte di una tassazione ordinaria che rimane abbastanza tenue, non c’èdubbio che le imposte straordinarie – quantunque deliberate di solito per esi-genze di interesse generale – risultino piuttosto gravose, specie nei confronti diuna città che, per quanto incerti siano i contorni della sua situazione economi-ca, tra Cinque e Settecento non si trova in condizioni floride. Per di più, comesi è detto, esse servono di solito per fronteggiare spese di carattere militare, dellequali Savona più che beneficiaria si sente vittima, dato che riguardano spessofortificazioni da realizzare sul proprio territorio a danno del tessuto urbano. Ilgoverno stesso, non di rado, si rende conto di questa situazione: nel 1591, adesempio, allorché si discute di come «ridurre a perfettione» la fortezza delPriamàr «dalla cui conservatione quasi depende la salvezza della Repubblica», aGenova alcuni sono del parere che tutte le spese dei lavori vadano addossate aSavona. Si raccolgono perciò accurate informazioni «degl’introiti et essiti della
145
31 ASS, Comune I, 214, 5 maggio 1665.32 ASS, Comune I, 211, cc. 139r-141r.33 ASS, Comune I, 214, passim.34 Ivi, 15 gennaio 1664.
Gli artigli del fisco
città», ma si riconosce infine che da essa non si può «esser soccorsi [...] di mag-gior somma che di £ 60 sino in 70 milla, percioché essendo com’è verissimo ch’ègravata de molti carichi e che da tempo in qua è diminuita della maggior parted’habitanti, e perciò non convenendo di gravarla di vantaggio, ci par che il giu-sto e l’honesto richieda che non si ricerchi da loro maggior soccorso»35. Il dena-ro, inutile dirlo, verrà poi reperito prendendo «dalle entrate publiche diSavona», cioè dalle sue gabelle, un importo di £ 4.000 annue con cui coprireun prestito. Più tardi una supplica degli Anziani in data 30 gennaio 1637, cioèal tempo in cui Genova sta disponendo il rafforzamento della cinta muraria diSavona e la sua estensione anche dalla parte di mare, ci mostra bene la tensio-ne generata da queste operazioni:
Il Signor Governatore ha già fatto dar principio alle muraglie longo la callata diessa città per la quale ne resta sepolta o per il meno imprigionata, oltre al notabilepregiudicio per cagione del traffico qual verrà a scemarsi et a rendersi più difficol-toso, ma se queste mura e nuove fortificazioni doveranno assicurar maggiormentedetta città con la cautella in conseguenza del Stato Serenissimo e conservationedella libertà, beveremo volentieri quest’amarezza, essendo ancor noi savonesi aparte di detta libertà. Che poi la fabrica resti a carrico nostro, Signori Serenissimi,la città di Savona si dichiara impotente, non havendo più fiato, non più spirito36.
Seguono, come di prammatica, le lamentele sulle condizioni deplorevolidella città e le rivendicazioni dei suoi meriti: le molte spese sostenute nelleemergenze di guerra, i denari già profusi nella costruzione della sua nuova cintamuraria, le enormi somme pagate per la conservazione del suo porto, «tutto ciòin ordine al serviggio publico del Stato». Affermazione, quest’ultima, assaidiscutibile, perché le mura – per non parlare del porto – servono innanzituttoalla città stessa, e anche gli oneri di guerra vanno sopportati solidalmente datutte le comunità dello Stato: infatti una commissione nominata dal Senato habuon gioco nel sottolineare che, «circa la spesa della muraglia che deve farsilungo la callada», Savona è certo tenuta a contribuirvi, «poiché trattandosi dimunimento che ne riceve è pur di ragione che, sentendone il beneficio e com-modo, senta anche il peso della spesa»37.
Si riconosce tuttavia che «le debolezze di quella città» sono reali, e le si con-cede di accrescere varie gabelle, come al solito per poter prendere somme a pre-stito e pagare interessi e capitale col gettito delle stesse. È d’altronde il mecca-nismo che Genova ha sempre usato nella gestione della propria finanza pubbli-ca, accendendo prestiti con San Giorgio e cedendo al Banco la riscossione divarie imposte indirette: ma questo sistema – che nel contesto genovese, pur pre-sentando inconvenienti e generando ingiustizie, trova un correttivo nella ric-chezza della Dominante e nel ruolo utile che lo stesso San Giorgio vi svolge –nella piccola città suddita non può che contribuire all’impoverimento della
146
35 ASG, Archivio segreto, 1028, n. 35.36 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 28r-v.37 Ivi, cc. 28v-30v.
Capitolo 9
popolazione e accentuare la disuguaglianza sociale. Qui l’ostinato rifiuto daparte del ceto dirigente di assumersi responsabilità fiscali e di pagare qualcosadi tasca propria va certamente additato fra le cause della crescente tassazione, diun indebitamento cronico e irreversibile, e infine della stessa crisi economicacittadina.
Insomma, non si va troppo lontano dal vero se si afferma che le difficoltàfinanziarie del Comune dipendono in buona misura dal modo in cui ilComune stesso è amministrato. Basti vedere come vengono gestite le gabelle dacui provengono quasi tutte le entrate comunali. Numerosi capitoli degli Statutipolitici e molti decreti del Senato ne regolano gli appalti secondo norme rigo-rose38, che intendono obbligare con ogni mezzo gli appaltatori o i loro fideius-sori (le «sigurtà», come si dice allora) a pagare quanto pattuito, e vietano tassa-tivamente qualunque «restitutione, compensatione, satisfattione o emenda dialcuna quatità de denari o cose o sia pretio di alcuna gabella [...] per occasionedi alcuno caso fortuito, pericolo o fortuna». In teoria, dunque, chi ha preso inappalto la riscossione di una gabella deve pagare il prezzo concordato a caden-ze trimestrali, qualunque sia l’andamento del gettito, e non può appellarsi allacongiuntura – una diminuzione di traffici o di consumi – per chiedere sconti o«ristori» sul dovuto. Di fatto, però, la stessa normativa attribuisce agli Anzianie ai Razionali del Comune tutti i poteri in materia di appalti fiscali: approva-zione delle fideiussioni, riforma dei contratti, escussione dei gabellotti morosi,giurisdizione sulle cause concernenti le gabelle. Quanto al Governatore geno-vese, anch’egli ha compiti di controllo ed è tenuto «a costringere li compratorio collettori delle gabelle del Commune di Savona [...] e le loro [...] sicurtà perquello che doveranno dare al Commune per il pretio di dette gabelle», ma ciò«a sola e semplice richiesta della maggior parte dell’officio degli Antiani».
Come abbiamo visto nel capitolo 6, quando un Governatore prova a guar-dare da vicino quel che succede in questo campo, scopre un groviglio di «falsitàe ladroneccio», di corruzioni, di complicità grazie alle quali ci sono individuiche non solo ottengono gli appalti a preferenza di altri, ma poi riscuotono senzaversare quanto dovuto: «i gabellotti vanno allongando più che si può li paga-menti e secondando i desideri di chi governa con grossi presenti, et alle volte coldenaro contante»39. Il Senato tenta a più riprese di intervenire: nel 1634, adesempio, ordina che gli Anziani in avvenire debbano presentare al Governatore,non appena questi entra in carica, la lista dei debitori della Comunità, affinchécostui usi «ogni possibile diligenza perché detti debitori siano esatti»40. Talvoltasono alcuni degli stessi amministratori a lagnarsi col governo per i troppi «risto-ri» concessi agli appaltatori, e pregano i Senatori che «si degnino con loro pub-blico decreto ordinare che restino prohibiti li sudetti ristori»41. Gli ordini, però,
147
38 Statuti politici cit., pp. 5-7, 28, 34, 37, 40, 204-220; Concessioni decreti et ordini cit., pp. 48-49, 196-197,201-205, 217-219; ASS, Comune I, 209-211, passim.
39 G. ASSERETO, Una riforma cit., pp. 560-561.40 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 22r.41 Ivi, cc. 146-148.
Gli artigli del fisco
lasciano di solito il tempo che trovano, anzi può accadere che un gabellotto ilquale non ha ottenuto il «rilascio» dall’amministrazione civica, ma ha buoneentrature presso il governo, riesca a farsi concedere un abbuono per interventodel Senato stesso.
Inutile dire che la stessa libertà goduta dal lato delle entrate la si ritrova daquello delle uscite: come lamenta un Governatore nel 1776, gli Anziani «inten-dono di aver diritto di fare da essi soli qualonque deliberazione di spese», o dialienare a loro beneplacito beni di pertinenza pubblica42. La possibilità di spen-dere senza controllo porta non solo a malversazioni e favoritismi, che non dirado emergono dalle fonti, ma addirittura a far sì che il deficit cronico e il graveindebitamento della Comunità dipendano anche da cause che forse non ciaspetteremmo. Leggiamo ad esempio un’accorata supplica degli Anziani in data15 luglio 1670, che può assurgere a paradigma di tante altre analoghe:
Sono ora molti anni che questa povera città va molto discapitando et hora siriduce a tal termine e miseria che li introiti annuali di essa sbilanciano con li debi-ti e spese ordinarie in £ 10.000 circa l’anno, onde resta in debito con li locatarii ecreditori in somma di £ 45.000 circa. Il che è proceduto dalla diminuzione chehanno fatto e tuttavia fanno le gabelle per mancamento del popolo e totale aliena-tione de’ trafichi e negotii, come anche per le gravi spese straordinarie sostenute e chesostiene particolarmente in liti43.
Il riferimento alle «liti» come causa importante del deficit comunaletorna in molti documenti dell’epoca: è una litigiosità cronica – che non riguar-da certo la sola Savona, ma che è presente in molte comunità del Dominio44 –fatta di dispute con i paesi vicini, con i borghi e le ville per questioni di confi-ne, di sfruttamento di terre, di riparto d’imposte, di giurisdizione; o di causeinterminabili su lasciti pii, proprietà d’interesse pubblico, crediti inesatti e«attrazzati» (cioè accumulati nel tempo); o di controversie con lo stesso poterecentrale. È un rivolo di denaro che esce continuamente dalle casse pubbliche afavore di avvocati, giurisperiti, notai, «oratori», «sindici», patroni per sostenerevertenze che quasi sempre portano poco frutto dopo essere costate molto.
Periodicamente il governo tenta di arginare questo flusso, stabilendo chenessuna comunità possa intentare liti senza l’autorizzazione del Senato, ma lafalla è difficile da turare, e infatti lo spreco continua, cosicché a più riprese ilComune deve chiedere al Senato, per fare fronte ai propri debiti, l’«accresci-mento» di qualche balzello: col risultato che, negli stessi documenti in cui gliAnziani lamentano che «non solo continuano, ma augumentano le miserie diquesta città», avanzano poi richieste di inasprimenti fiscali. E tocca semmai al
148
42 ASG, Magistrato delle Comunità, 425, 28 agosto 1776.43 ASS, Comune I, 214, 15 luglio 1670 (il corsivo è nostro).44 G. ASSERETO, Le metamorfosi cit., pp. 61-65.
Capitolo 9
Senato mostrare qualche scrupolo, fare attenzione che non si aumentino legabelle sui consumi della popolazione più povera45.
Per quanto strano possa apparire a quegli storici locali che hanno biasimatosenza riserve gli artigli del fisco genovese, sono le magistrature della Dominanteche si sforzano, a Savona come altrove, di ottenere un minimo di equità fiscalee di contenere i debiti comunitativi46: lo fanno certo nell’interesse del governo,per non pregiudicare la capacità contributiva dei sudditi, ma anche per quellafunzione di tutela di cui abbiamo parlato in un capitolo precedente. Purtroppoquesto sforzo non è coronato da gran successo: ancora nel 1778, in MinorConsiglio, il patrizio Gian Antonio De Franceschi sostiene «che le communitàtutte dello Stato sono nel loro economico amministrate malamente, che da chiè da esse diputato ad esiggere i debiti si trascura di farlo per fini privati, che nonostante [ciò] si fanno spese straordinarie e che ogn’anno vanno crescendo i debi-ti communali, e ne siegue perciò una sensibilissima oppressione dei sudditi eparticolarmente dei poveri»47. Più che a una fiscalità rapace e oppressiva, biso-gna pensare a una sostanziale debolezza del governo centrale, alla condottaincerta e non di rado contraddittoria di chi – come già altre volte abbiamo detto– non è mai davvero in grado di imporsi alle élite locali.
Per quanto riguarda Savona, infine, va segnalato – come vedremo in un capi-tolo successivo – non solo il relativo stato di crisi della città, ma anche l’espan-dersi nel suo territorio, tra Sei e Settecento, della proprietà di enti ecclesiasticie di cittadini genovesi, esenti in tutto o in parte da quelle forme di tassazionediretta che pure talora si vorrebbero applicare nelle imposte straordinarie:«Essendo stato per parte dell’Illustrissimo Signor Governatore di Savona – reci-ta una lettera al Senato datata 5 settembre 1704 – notificato alli MagnificiAntiani della città di Savona essere stata detta città tassata in £ 40.000, non pos-sono a meno li stessi di non esponere riverentemente alla benignità di VostreSignorie Serenissime essere detta tassa molto eccessiva alle loro deboli forze, etimpossibilitati a pagarla, atteso massime che le sette ottave parti degl’effetti stabilie più pretiosi situati nella loro giurisditione sono de’ Magnifici Cittadini abitantinella presente città e qui tassati [cioè a Genova], e d’opere pie e di religiosi clau-strali e preti secolari non soggetti a detta tassa»48.
In realtà la proporzione indicata è di molto approssimata per eccesso, maresta il fatto che a quell’epoca una parte cospicua della ricchezza locale non èpiù nelle mani dei savonesi, e questo non può che inasprire i conflitti locali. Chi
149
45 Un’ampia documentazione su questo tipo di problemi è in ASS, Comune I, 214, 15 luglio 1670, 19 set-tembre, 17 novembre e 3 dicembre 1671, 26 agosto 1681, 1 agosto 1685; e in ASS, Comune I, 210, libro III,relazione 1 febbraio 1670 citata.
46 G. ASSERETO, Le metamorfosi cit., pp. 43-52.47 ASG, Magistrato delle Comunità, 541, 8 gennaio 1778.48 ASS, Comune I, 215 (il corsivo è nostro). Qualche anno prima, in occasione di un’altra tassazione straor-
dinaria, c’è stato addirittura il tentativo di sottrarsi al pagamento da parte di quei personaggi (i Gavotti, i Riario,i Girinzana) che hanno sì lo status di «nobili genovesi», ma sono di famiglia savonese e a Savona risiedono. LaCamera, però, ha disposto che essi paghino (ASS, Comune I, 214, 4 luglio 1695).
Gli artigli del fisco
ha un po’ di potere cerca con più ostinazione di sottrarsi ai carichi o di trarrevantaggio dal denaro pubblico; nel frattempo il debito del Comune è cresciutoin modo spaventoso e il pagamento degli interessi su quel debito assorbe buonaparte delle entrate. Nel 1697 il Governatore Agostino De Mari calcola che taledebito abbia raggiunto la somma di £ 1.357.774: debito irredimibile, va da sé,ma per il quale bisogna pur corrispondere qualche provento ai titolari dei «luo-ghi di monte», cioè a coloro che, nel passato più o meno lontano, hanno fattoprestiti alla civica amministrazione49. Nel 1676 un altro Governatore – EugenioDurazzo, un mago della finanza nel quale già ci siamo imbattuti – ha cercato dimettere ordine nella materia: ha regolato l’appalto delle gabelle in modo da farlerendere un po’ di più, ha disposto il pagamento puntuale delle spese vive manmano che i denari si riscuotono, ha fatto un piano per riuscire a distribuirealmeno qualche interesse fra i «montisti»50. Ma il piano mostra presto la corda,anche perché si apre un conflitto fra prestatori privati da un lato e «opere pie,ospitali e monasteri» dall’altro, che sono anch’essi titolari di una quota cospicuadel credito pubblico, ma finiscono spesso per avere la peggio nel riparto degliinteressi, e così perdono anche la capacità di fare interventi di beneficenza51.Anche il De Mari propone una qualche forma di tassazione diretta per potermeglio corrispondere gli interessi, specie quelli spettanti alle opere pie, ma natu-ralmente non la spunterà. Così i poveri della città finiscono per perdere, comesi suol dire, dalla spina e dal tappo: vedono sempre aumentare le gabelle suigeneri di largo consumo, mentre diminuiscono le risorse della pubblica carità.
Un breve accenno va fatto, infine, a un paio di altre questioni che riguarda-no i rapporti fiscali tra Genova e Savona. La prima concerne quella «tassa del-l’uguaglianza» che, nella citazione di Cerisola dalla quale abbiamo preso lemosse, appariva uno degli elementi dell’oppressione genovese. In realtà è vero ilcontrario: questa tassa, votata dai Consigli della Repubblica nel 1634, deve ser-vire a ripartire fra tutte le comunità del Dominio le spese «dell’alloggio della sol-datesca» di stanza al di fuori della città di Genova e delle principali fortezze. IlMagistrato di Guerra alla fine di ogni anno dovrà calcolare il costo complessi-vo e suddividerlo nello stesso modo in cui si è fatto il riparto per le nuove muradi Genova. Da tale suddivisione devono però restare escluse «le comunità diSavona, di Ventimiglia, del Porto Maurizio, della Pieve, di Triora e di Zuccarelloe Castelvecchio, [...] havuto risguardo che le suddette comunità per diversi annihanno sofferto gravezze e fatto spese di rilevata somma per alloggi continui de’soldati»52. Savona, che è forse la principale piazzaforte della Repubblica, hadunque solo da aspettarsi vantaggi da quella decisione. E se negli anni successi-vi partecipa anch’essa al riparto delle spese per la soldatesca, lo fa in misuramodesta: nel 1641, ad esempio, è «quotizzata» per £ 6.667, cioè molto meno dicircoscrizioni più piccole come Rapallo (£ 8.000), Chiavari (£ 10.500),
150
49 ASS, Comune I, 215, 1 agosto 1696.50 ASG, Magistrato delle Comunità, 425, 12 maggio-6 luglio 1676.51 ASS, Comune I, 215, 5 marzo, 29 marzo, 12 maggio e 8 agosto 1697. 52 ASS, Comune I, 1197, 28 giugno 1634.
Capitolo 9
Sanremo (£ 7.930), Diano (£ 7.040)53. Ancora una volta, il problema non stanella “malvagità” genovese, ma semmai nella complessiva inefficienza con cui laRepubblica gestisce il suo bilancio militare: giustissima in linea di principio, latassa dell’uguaglianza incontrerà poi numerosi intoppi, e ancor più ne incon-trerà il tentativo di realizzare un appalto generale per le forniture ai militari delpresidio savonese. Così la città si troverà a sopportare disagi ben superiori aldovuto, anticipando denari e materiali la cui restituzione resta incerta e preca-ria.
L’altra questione, cui vogliamo accennare in poche parole, è forse marginalema emblematica. Nel 1632 il Senato autorizza il Comune savonese ad aumen-tare di 10 soldi a mezzarola la gabella vino. L’«augumento» dovrebbe durare finoall’estinzione di un prestito acceso «per il dispaccio della darsena», cioè per dra-gare e rendere agibile quell’unica porzione del porto che è rimasta alla città; matale estinzione non si realizza perché nel 1642 – come abbiamo raccontato nelcapitolo 5 – Savona ha fatto costruire e armare due galere che ha poi donato allaRepubblica, e il Senato ha concesso che il mutuo necessario a coprire il costodelle galere sia garantito appunto con quell’addizionale sul vino54. Con queldono, il ceto dirigente della fedelissima città ha acquistato grandi benemerenzeagli occhi dei governanti genovesi, e ne ha addossato il costo non solo sullapopolazione nel suo complesso, ma proprio sulle classi più umili. Perché i“signori” non pagano quella gabella: bevono il vino dei propri poderi, o quellodi pregio che fanno arrivare dall’estero.
151
53 Ivi, riparto per il 1641: per la tassa dell’uguaglianza ogni comunità paga circa il 7,5% rispetto a quellasulle nuove mura, ma per Savona e le altre comunità su indicate la percentuale va calcolata solo su 2/3 dellatassa.
54 ASS, Comune I, 210, relazione 1 febbraio 1670 citata.
Gli artigli del fisco
L’aspetto più visibile e più drammatico della presenza genovese a Savonadopo il 1528 è rappresentato certamente dalle demolizioni, dagli sventramenti,dalle distruzioni di intere parti della città che si sono susseguite fino al pienoSettecento, tanto da assumere connotati persecutori che la storiografia non hamancato di enfatizzare, ma che già erano percepiti come tali dai savonesi di allo-ra. Forse è leggenda che, nelle discussioni seguite alla sottomissione violenta,qualche patrizio genovese abbia proposto una sorta di delenda Carthago, macerto la mano della Repubblica nel 1525 e più nel 1528 si è accanita in modomolto pesante contro le opere portuali abbattendo i moli, riempiendo lo spec-chio d’acqua principale e lasciando in funzione la sola, piccola darsena1. E,come ogni savonese sa, nel 1542-43 la costruzione della grande fortezza sullacollina del Priamàr ha comportato l’atterramento del quartiere più antico emonumentale della città, ricco di luoghi pii, monasteri e chiese, tra cui la cat-tedrale di Santa Maria di Castello2; inoltre ha messo in opera un apparato stra-tegico che, nei due secoli successivi, ha richiesto continui adeguamenti, modi-fiche e ampliamenti, tradottisi sempre in nuove violenze al tessuto urbano. Idue densi volumi dedicati al Priamàr nel 1959 e nel 1982, citati nella nota cheprecede, ci esimono dal dovere di ricostruire la storia della fortezza e delle opereannesse, così come possiamo tranquillamente rimandare il lettore al vecchiolavoro di Nello Cerisola – anch’esso appena ricordato – per tutto ciò che con-cerne le vicende delle opere portuali savonesi fra Cinque e Settecento. Qui vor-remmo limitarci a ripercorrere molto sinteticamente alcuni fatti che riguardanotanto le strutture difensive quanto il porto – e in misura minore le strade, l’ar-ginatura del torrente, l’arredo urbano – per cercare di capire le motivazionidegli interventi genovesi e le loro ripercussioni sia sulla struttura, sia sull’eco-nomia della città.
Partiamo dalla fortezza, perché non c’è dubbio che essa abbia prodotto unaferita molto dolorosa nel corpo della città, che sia rimasta per tutta la durata deldominio genovese uno strumento ben visibile di sottomissione e che, essendogiunta pressoché intatta fino ai giorni nostri, rappresenti ancora oggi nell’im-maginario collettivo un simbolo dell’antica “oppressione”. A questo propositoil primo fatto da tenere presente – la storiografia locale lo ha messo in luce datempo – è che la destinazione militare della collina è di vecchia data e risaleaddirittura al XIII secolo. Su una delle sue alture, a partire dal 1213, viene eret-
153
1 F. NOBERASCO, Il porto di Savona nella storia, cit., AMSSSP, vol. III, 1920, pp. 83-112; N. CERISOLA,Storia del porto di Savona, cit., Savona, Editrice Liguria, 1968, pp. 21-77.
2 Per gli edifici presenti prima delle distruzioni genovesi si veda: Il Priamàr, AMSSSP, vol. XXX, 1959, pp.25-55; R. MASSUCCO, M. RICCHEBONO, M. TASSINARI, C. VARALDO, Il Priamàr prima pietra cit., pp. 19-29.
Capitolo 10
Distruggere e costruire
to il castello di Santa Maria «che, dopo i vari ampliamenti successivi, speciequelli quattrocenteschi, e la trasformazione in Castello Nuovo, verrà pratica-mente ad occupare l’intera porzione centrale del Priamàr; ugualmente, il colledi San Giorgio viene occupato da un altro apparato militare, il castello omoni-mo, che Genova imporrà nel 1253, cancellando le case private, il cimitero e lacanonica, mentre la chiesa rimarrà chiusa all’interno del recinto fortificato»3.Con l’erezione di questi due apparati militari, per il Priamàr inizia una nuovastoria: il centro abitato e le attività commerciali e manifatturiere si sono trasfe-riti a valle, mentre la terza altura, non occupata dai forti, assume quel «caratte-re di cittadella spiccatamente religiosa», che all’inizio del Cinquecento saràormai del tutto consolidato4. La realizzazione del 1542, lungi dall’essere il frut-to di un’improvvisa decisione punitiva, non fa che perfezionare un ruolo difen-sivo già da tempo assegnato a quel sito: «nel XV secolo il Castello Nuovo diSavona era divenuto il più potente baluardo militare che Genova custodisse inLiguria, anticipando decisamente l’analoga funzione della futura fortezza cin-quecentesca»5.
Questo destino strategico, sancito dalla topografia e dalle vicende politiche,si configura nel tempo come una specie di maledizione, ma non ha nulla a chefare con la presunta “perfidia” genovese: tanto è vero che alcuni interventi assaidolorosi vengono effettuati già prima del fatidico 1528. Nel febbraio del 1527Pedro Navarro, luogotenente del re di Francia Francesco I, ha cominciato incittà grandi lavori di fortificazione per i quali vengono sacrificati «tutto il borgodi San Giovanni fino a Santa Chiara, tutto il borgo di porta Belaria fino allacrosa, tutte le case e i muri degli orti verso la città sino alla Foce», causando tral’altro gravi danni all’arte della lana, che è una delle più floride a Savona. Ai cit-tadini danneggiati si assicura che saranno indennizzati, ma le promesse nonvengono mantenute; mentre «sul Comune smunto e immiserito i dominatori[francesi] rovesciavano imposizioni d’ogni genere, come dire alloggiamenti disoldati, corvées per lavori pubblici, prestiti forzati di denaro»6. Il re ha deciso –riferisce Agostino Abate nelle sue memorie – «che se dovese metere la cità deSaona in fortesa, non havendo respeto né a case, né a giardini, né a palaci»7.L’intenzione è quella «di cambiare radicalmente il destino della città, facendo-ne uno stabile caposaldo tattico, su cui impostare il controllo dell’intera regio-ne marittima e delle vie dell’interno»8. È quindi al sovrano francese, propriocolui che – lo si è detto – voleva fare di Savona una seconda Genova e metter-la a capo della Riviera di Ponente, che va attribuito il disegno di trasformare la
154
3 M. RICCHEBONO-C. VARALDO, Savona cit., p. 29.4 Ibidem.5 R. MASSUCCO, M. RICCHEBONO, M. TASSINARI, C. VARALDO, Il Priamàr prima pietra cit., pp. 16-17.6 I. SCOVAZZI-F. NOBERASCO, Storia di Savona cit., vol. III, pp. 102-103; V. POGGI-P. POGGI, Cronotassi dei
principali magistrati che ressero e amministrarono il Comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autono-mia, parte VI, AMSSSP, vol. XXII, 1940, pp. 3-155 (qui p. 122).
7 A. ABATE, Cronache savonesi cit., p. 84.8 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., p. 69.
Capitolo 10
città in una piazzaforte: i genovesi non faranno che riprenderlo pochi annidopo, spinti da circostanze che non lasciano loro molte altre scelte.
Come si è visto nel capitolo 3, dopo il 1528 la situazione politica interna-zionale è tutt’altro che stabilizzata, l’equilibrio su cui si regge l’indipendenzagenovese è quanto mai precario, la guerra riprende a ondate continue, mentrel’alleanza della Francia con i turchi rende più gravi i pericoli anche dalla partedel mare. È soprattutto nel 1542, con lo scoppio del quarto conflitto franco-asburgico, che Genova torna a temere seriamente per l’incolumità del proprioStato: il vicino Piemonte diventa ancora una volta campo di battaglia fra i duecontendenti, e nell’agosto di quell’anno un’armata franco-barbaresca comanda-ta da Francesco di Borbone e dal Barbarossa assale Nizza, che viene bombarda-ta furiosamente, occupata e devastata. La Repubblica, formalmente neutrale madi fatto legata alla Spagna, è esposta anch’essa a un attacco francese, il quale nonpotrebbe che far perno su Savona, come in passato. Il Governatore spagnolo diMilano, Alfonso d’Ávalos marchese di Pescara, suggerisce perciò al governogenovese di fortificare in modo deciso la città o, in alternativa, di abbatternetutte le difese e le mura per ridurla a “città aperta”, su cui il nemico non possapiù fare alcun conto9.
Questa seconda eventualità – nient’affatto peregrina, anzi ben contemplatadai dettami strategici dell’epoca – sarebbe, essa sì, una vera tragedia per Savona,ed è strano che i vecchi storici locali non vi abbiano riflettuto: privata della suacinta muraria, avrebbe perduto perfino lo status di città, sarebbe stata «con-dannata al degrado e alla progressiva ruralizzazione»10. Ma anche l’ipotesi di tra-sformare Savona in una città fortificata non potrebbe che avere conseguenzenefaste, benché i rappresentanti del Comune savonese la caldeggino, facendonotare al Senato che le fortezze si addicono ai tiranni, mentre Venezia, repub-blica mantenutasi indipendente per quasi mille anni, «non le castelle, ma le cittàà fortifichate; [...] sì che per parer nostro se Vostre Signorie designano tener liinimici alla longa pensino di fortificar tutta la città, il che si farà forsi con minorspesa et serà impresa molto più sicura e senza preiudicio dell’honor di Dio etdel proximo»11. In realtà proprio nell’ambito veneto ci sono esempi illuminan-ti come quello di Treviso che già abbiamo ricordato nel capitolo 4, città che apartire dal primo decennio del Cinquecento viene trasformata appunto in unagrande fortezza, perde completamente il ruolo e la fisionomia precedenti, ecrolla su se stessa «isterilendosi e immeschinendosi entro l’ambito della piùgenerale crisi del Seicento»12.
Anche per Genova, d’altronde, rafforzare le tradizionali difese di Savona èuna soluzione rischiosa: non è ciò che già volevano fare i nemici francesi? E unacittà troppo forte non rischierebbe di nuovo di far gola a chi attenta alla libertà
155
9 I. SCOVAZZI-F. NOBERASCO, Storia di Savona cit., vol. III, pp. 141-142.10 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., p. 77.11 ASG, Archivio segreto, 361, n. 62. La supplica savonese mirante a scongiurare la costruzione della fortez-
za è edita, ma con una trascrizione assai scorretta, in R. MASSUCCO, L’estremo tentativo cit., pp. 309-319 (in par-ticolare pp. 311-313).
12 E. BRUNETTA, Treviso in età moderna cit., p. 5.
Distruggere e costruire
della Repubblica, magari con la complicità dei savonesi stessi? Così «Genova,genialmente, scelse una terza via: edificare, nel cuore stesso della città, unapoderosa fortesa inespugnabile, che, mantenuta assolutamente estranea alla civi-tas (quanto a struttura, uso e gestione), ne fosse insieme guardia e difesa»13: uneccellente antemurale verso ponente da dove più facilmente possono giungerele minacce; una sentinella a protezione sia della darsena di Savona, che conser-va comunque una certa importanza strategica, sia della rada di Vado, portonaturale di grande interesse per l’alleato spagnolo; infine un utile strumento –come rileva con qualche malizia il cronista Agostino de’ Monti – per «cautelarla fede de’ savonesi»14.
Il nuovo insediamento militare sul colle del Priamàr, dunque, è certamenteuna novità amara per la città, ma non è il frutto di una vendetta o di una puni-zione contro l’antica rivale, anzi si inquadra in un generale potenziamento del-l’apparato difensivo ligure, che inizia nel 1537 con il rafforzamento delle muragenovesi e prosegue negli anni seguenti con interventi in molte città e borghicostieri15. In quei frangenti è forse la soluzione più logica e, a ben vedere, anchela meno dannosa: infierisce su una parte del tessuto urbano che ormai ha solofunzioni religiose e rappresentative, ma non è più luogo di insediamenti abita-tivi né di attività economiche; e serve a garantire una sicurezza esterna, e in defi-nitiva una lunga pace, dalla quale anche la cittadinanza savonese potrà trarrevantaggio. Senza contare che i lavori, portati avanti con grande energia e rapi-dità, offrono per diversi anni buone occasioni di impiego a molte maestranze,occupate anche nella contemporanea ricostruzione, entro la città da basso, degliedifici religiosi “sfrattati” dal Priamàr16.
Il vero dramma, a ben vedere, non risiede tanto nella costruzione della for-tezza e nelle demolizioni che la precedono (per le quali sembrano tutto som-mato più afflitti i posteri, e in particolare gli archeologi e gli storici dell’arte, chenon i savonesi del Cinquecento), quanto nelle conseguenze di quell’atto.L’opera, una volta innalzata, ha le sue necessità strategiche: esige una zona dirispetto, deve avere angoli di tiro liberi per le proprie artiglierie, deve eliminarenelle vicinanze i luoghi elevati da cui sarebbe facile colpirla. Perciò fra il 1544 eil 1552 vengono mozzate le vecchie torri della città; fra il 1555 e il 1558 sidemoliscono una quarantina di case e tre torri; e anche in seguito il cantiereresta aperto, talché su Savona pende sempre la minaccia di sventramenti e muti-lazioni. Inoltre l’erezione della fortezza ha comportato forti spese, assai gravoseper le deboli finanze della Repubblica. La Camera – cioè l’erario – non dispo-ne di mezzi sufficienti e ricorre, come è usuale in caso di spese straordinarie, a
156
13 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., p. 77.14 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 183. In una relazione genovese del 1696 questi obiettivi sono luci-
damente elencati: «Tre – vi si legge – sono i motivi per li quali li prencipi fabbricano le fortezze o mantengonole fabbricate: 1° per guardare città grandi e numerose di popolo, e tenerle a freno; 2° per custodire qualche portocapace di refuggiare grosse armate; 3° per diffendere qualche passo importante alle frontiere dello Stato» (ASG,Senato-Foglietta, 1227).
15 R. MASSUCCO, M. RICCHEBONO, M. TASSINARI, C. VARALDO, Il Priamàr prima pietra cit., p. 41.16 C. VARALDO, Insediamenti religiosi cit., pp. 47-48.
Capitolo 10
un prestito del Banco di San Giorgio, al quale bisogna garantire un’entrata perpagare gli interessi sui «luoghi», vale a dire sui titoli di debito emessi per finan-ziare l’opera. Toccherà a Savona stessa – con il pretesto che ad essa rimane for-malmente la proprietà della fortezza, riservandosene Genova soltanto l’uso – farfronte a questo pagamento, con una cospicua gabella sul vino che da allora verràriscossa a favore del Banco; e toccherà sempre a Savona, per risarcire secondogiustizia i proprietari degli stabili demoliti, emettere propri titoli di debito(«lochi de Comune», come li chiama l’Abate) garantiti sulle entrate di nuovegabelle17: misure, queste, che naturalmente vengono subite dai savonesi comeuna beffa.
A parte ciò, la scelta si dimostra felice, e una relazione ai Serenissimi Collegistesa il 6 giugno 1591 lo riconosce in modo molto esplicito:
La città di Savona è, come ben sanno Vostre Signorie, l’occhio dritto dellaRepubblica, e come molto opportuna alla sicurezza di essa si sforzarono i nostrimaggiori con molta spesa et industria munirla di fortezza tale, che dovesse esserbastante ad assicurarla dalle insidie de’ maligni e dagl’inganni di chi vi potesse des-signare, e ciò fecero con tanto giudicio e prudenza che si conosce chiaramente esserstata posta e fondata in così buono e sicuro luogo, che niuno altro circonvicino aquella città migliore né più atto si poteva elegere: così rifereno i migliori e più peri-ti ingegneri che hoggidì si ritrovino in Italia18.
A quest’epoca, tuttavia, la fortezza è ormai considerata «piena di diffetti» ebisognosa di modifiche, «percioché quando si lasciasse nella maniera che siritrova potrebbe con facilità essere espugnata, che Dio nol consenta mai, echiunque poi ne fusse padrone havrebbe molta commodità, per essa così bensituata, di ridurla inespugnabile»19.
È il destino di tutte le piazzeforti le quali, se non adeguatamente munite, rap-presentano più un pericolo – perché un potenziale nemico se ne può impadro-nire – che una difesa. Quindi bisogna intervenire, ampliarla perché ora è «capa-ce di poca gente per difenderla», modificarla perché «non signoreggia punto ladarsina»: gli esperti hanno già steso un progetto (un «modello») che, se realiz-zato, renderà quella fortezza «una delle migliori [...] d’Italia». Ma ci vuole dena-ro che naturalmente la Repubblica, con i suoi magri bilanci, non possiede:come già si è visto nel capitolo 9, si raccolgono perciò informazioni sul bilan-cio pubblico di Savona perché alcuni, nel governo, pensano «che tutta la spesadi tal fortificatione si cacciasse da quella città». L’idea è assurda: un primo pre-ventivo fissa l’importo dei lavori in 30.000 scudi, cioè più di 200.000 lire, maben presto la somma lievita fino a 433.000 lire e oltre, mentre il Podestà di
157
17 A. ABATE, Cronache savonesi cit., pp. 179 e 199.18 ASG, Archivio segreto, 1028, n. 35. Può essere curioso notare come l’appellativo di «occhio dritto di
Genova» fosse usato, nel basso medioevo, per designare l’isola di Chio, perla dell’impero coloniale genovese.Solo in seguito, appunto modificato in «occhio dritto della Repubblica», esso passò ad indicare prima Savona– a testimonianza della sua importanza strategica – e infine direttamente la sua fortezza.
19 Ibidem.
Distruggere e costruire
Savona, prese le opportune informazioni, riconosce che la città non è certo ingrado di sopportare un simile onere20.
La pratica si trascinerà per alcuni anni, con una comprensibile resistenza delComune savonese a finanziare – sia pure in parte – quei lavori. Ma qui, più cheseguire nei dettagli le vicende edilizie e finanziarie relative al Priamàr, ci inte-ressa ribadire che da questo punto di vista i maggiori danni per Savona nonprovengono dalla «malitia» o dalla prepotenza genovese, bensì dipendono inparte dalla forza delle cose (cioè, negli anni a venire, le sempre rinnovate minac-ce di guerra e di aggressione), in parte dalle peculiari istituzioni dellaRepubblica, e in parte dalla stupidità umana, che è sempre presente sotto tuttii cieli e non ha certo risparmiato i pur prudenti uomini di governo dellaSerenissima.
Quanto alle minacce, neppure la definitiva pace di Cateau-Cambrésis traSpagna e Francia, nel 1559, le fa venir meno: proprio in seguito a quel trattatoil duca sabaudo Emanuele Filiberto rientra in possesso dei suoi Stati ereditari econ un’accorta politica fa del Piemonte-Savoia un piccolo potentato che da allo-ra aspirerà ad acquistare nuovi e più agevoli sbocchi verso il mare oltre alla con-tea di Nizza. Militare al servizio della Spagna, e poi di fatto alleato di Filippo II,il duca non può volgere le armi contro una Repubblica che del sistema spagno-lo fa parte integrante, ma nulla gli impedisce nel 1576 di comperare dai Doriail feudo di Oneglia, che interseca pericolosamente la Riviera di Ponente; e benpresto le mire espansionistiche verso il Genovesato diverranno una costante peri suoi successori.
Certo è che quando in seno al governo genovese viene creata, nel 1587, laGiunta dei Confini col compito di tutelare da ogni pericolo esterno il territoriodello Stato, è soprattutto alla Riviera di Ponente che essa deve rivolgere la pro-pria attenzione, perché è quella l’area più delicata: nel 1571, prima ancora dellaperdita di Oneglia, il marchesato del Finale al quale Genova aspirava da tempoè stato occupato dalla Spagna, che nel 1598 lo acquista in via definitiva. Tenutasaldamente da una potenza alleata sì, ma la cui alleanza col passare del tempodiviene sempre più problematica, l’enclave finalese – che i più antichi storicigenovesi definiscono «piaga della Liguria» – è in effetti una ferita aperta nelcorpo della Repubblica21. Inoltre in tutto il Ponente il Dominio è estremamen-te sfilacciato, costellato da una miriade di feudi che ne rendono deboli e preca-ri i confini, legato alla Dominante da rapporti più fragili, cosicché per Genovala frontiera realmente difendibile è incentrata proprio sull’asse Savona-Vado22:lo si vedrà bene nel 1625, quando tutta quella Riviera sino ad Albenga cadràfacilmente nelle mani di Carlo Emanuele I di Savoia, mentre proprio Savona e
158
20 Ibidem.21 Si veda, riassuntivamente, G. ASSERETO-G. BONGIOVANNI, «Sotto il felice e dolce dominio della
Repubblica». L’acquisto del Finale da parte di Genova e la Distinta relazione di Filippo Cattaneo De Marini,Savona, Elio Ferraris Editore, 2003, pp. 7-31.
22 C. BITOSSI, Il governo genovese cit., pp. 78-79.
Capitolo 10
la sua fortezza rappresenteranno un importante centro di resistenza. Il de’Monti, riferendosi a quegli anni, commenta:
Qui più che altrove vigilava la Repubblica, ove pareva tendessero le mire del suoavversario, che come unico scopo de’ suoi acquisti haveva prefisso alla mossa dellesue armi questa città, la quale molto opportuna riusciva alli suoi Stati e lo facevasignore del rimanente della Riviera fin a Villa Franca. Non guardava perciò ad alcu-na spesa la Repubblica in ben munirla perché con tali fortificationi veniva a difen-dere tutt’il paese che essa comanda di là e di qua da Savona, come propugnacoloet antemurale della Liguria, e salvava anche la Capitale da tutti quelli pericoli edisturbi che provarebbe, se da diverso prencipe fosse comandata Savona, poi chesenza di questo dominio sminuirebbe le sue fortune e porrebbe in evidente rischiola sua grandezza23.
In seguito la situazione non muta: nel 1631 il patrizio Gian VincenzoImperiale – nominato dal Senato «commissario e visitatore generale per tutta laRiviera di Ponente, con suprema autorità e cura di visitar tutti li posti, rivederle milizie e riformar l’esercito» – effettua una lunga ispezione militare di queiluoghi, e al termine compila una dettagliata relazione nella quale è palpabile lacondizione di uno Stato che si sente assediato e la cui difesa è estremamenteproblematica24. Nel 1630 è morto Carlo Emanuele I, ma il suo successoreVittorio Amedeo I briga anch’egli ai danni di Genova alimentandovi congiure;ancor più – durante il suo lungo ducato – lo fa Carlo Emanuele II, le cui mire,che si appuntano soprattutto su Savona, sfoceranno nell’attacco alla Repubblicadel 167225. Il copione peraltro si ripete sotto Vittorio Amedeo II, anche se aquell’epoca la Repubblica mette a segno un eccellente colpo diplomatico acqui-stando nel 1713 – proprio a dispetto del Savoia – il Finale. Tuttavia questoingrandimento territoriale, anziché diminuire l’importanza strategica della for-tezza savonese, la accresce, perché Genova si affretta a smantellare le difese chegli spagnoli avevano eretto nel marchesato considerandole mal difendibili, eperché già sullo scorcio del XVII secolo tutta la difesa del Dominio si è con-centrata nelle tre piazzeforti di Gavi, di Santa Maria nel golfo della Spezia, eappunto del Priamàr a Savona, mentre le altre fortificazioni vengono o distrut-te o dismesse26.
159
23 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 241 24 Viaggi di Gian Vincenzo Imperiale con prefazione e note di A. G. BARRILI, ASLSP, vol. XXIX, 1898, fasc.
I, pp. 241-249; De’ Giornali di Gio. Vincenzo Imperiale dalla partenza dalla patria anno primo, al signor AgabitoCenturione, con prefazione e note di A. G. BARRILI, ivi, fasc. II, pp. 711-731.
25 V. VITALE, Breviario cit., vol. I, pp. 286-289. Sulle pressioni sabaude negli anni sessanta del Seicento, esulle misure prese dalla Repubblica in materia di fortificazioni con l’intervento di numerosi ingegneri militariforestieri, i quali si occupano soprattutto della situazione savonese, si veda M. QUAINI, Per la storia della car-trografia a Genova e in Liguria. Formazione e ruolo degli ingegneri-geografi nella vita della Repubblica (1656-1717), ASLSP, vol. XCVIII, 1984, fasc. I, pp. 217-266 (in particolare pp. 231-238)
26 L. C. FORTI, Fortificazioni e ingegneri militari in Liguria (1684-1814), Genova, Compagnia dei librai,1992, pp. 41-42.
Distruggere e costruire
L’acquisto del Finale, d’altronde, non spegne affatto, anzi rinfocola le miresabaude e i timori genovesi. Nel 1723 il cartografo Matteo Vinzoni, in missio-ne per conto della Camera nel Bosco di Savona, vi scopre a più riprese spie pie-montesi che lo percorrono per rilevare le migliori vie di invasione, e sente cir-colare voci insistenti circa la volontà della corte torinese di appropriarsi diFinale e di Savona27. Nel 1742 – come s’è visto – Francesco Maria Doria, amba-sciatore genovese in Francia, riferisce con preoccupazione al cardinale Fleury,primo ministro di Luigi XV, degli accordi segreti fra le corti di Londra,Viennae Torino «per la cessione di Savona al re sardo» e gli prospetta, «quando se neverificasse il trattato», le «luttuose conseguenze di tale perdita», a cominciaredalla «desolazione del nostro comercio» e dal fatto che «resterebbe tagliata affat-to con tal cessione la communicazione della maggior parte della Riviera diPonente» con Genova28. Quando poi Genova decide nel 1745 di parteciparecon Francia e Spagna alla guerra di Successione austriaca e subisce i vittoriosiattacchi austro-sardi, è proprio nei confronti di Savona che si esercita la mag-gior pressione dei piemontesi, i quali la occupano per quasi due anni sperandodi giungere a una formale annessione in caso di vittoria finale.
Questa aspirazione plurisecolare della corte di Torino verso il Ponente ligure,e verso Savona in particolare, rende dunque ragione della continua necessità ditener munita la fortezza, senza farsi troppi scrupoli se a tale esigenza si devonospesso sacrificare gli interessi della città: lo spostamento semantico che abbiamosegnalato più sopra, il fatto cioè che con l’espressione «occhio dritto dellaRepubblica» si indichi dapprima Savona, e poi sempre più spesso il Priamàr,simboleggia bene questa realtà. A ciò si deve aggiungere – lo abbiamo detto –la particolare struttura istituzionale dello Stato genovese, con la sua debolezzamilitare che rende tanto più essenziali alcune piazzeforti, e soprattutto con l’e-siguità dei suoi bilanci. La gestione, la manutenzione e il potenziamento dellafortezza, in queste condizioni, sono sempre assai problematici; e la tentazionedi addossare una parte considerevole dei costi alla comunità locale è forte ericorrente. Non ci addentreremo in un esame – complicato e tedioso – dellemanovre finanziarie messe in atto dalla Repubblica a questo scopo, ma una cosaalmeno va rilevata: da un certo punto di vista, non ci sarebbe nulla di ingiustoo di prevaricatore se la Repubblica chiedesse a Savona un contributo anche con-sistente per il buon mantenimento della piazzaforte, visto che essa contribuiscealla difesa di tutto il territorio ligure e in primo luogo di Savona stessa29. Ma pergiustificare quei sacrifici bisognerebbe uscire dalla logica dello Stato cittadino:
160
27 ASG, Giunta dei Confini, 109, 12 e 21 agosto 1723. Sulla continua attività di spie piemontesi attorno aSavona e alle sue fortificazioni si veda Carte e cartografi in Liguria a cura di M. QUAINI, Genova, Sagep, 1986,pp. 174-178.
28 ASG, Archivio segreto, 2223, 29 ottobre e 3 dicembre 1742.29 Nel 1637, di fronte alla decisione del Senato di «dar principio alle muraglie longo la callata» di Savona,
gli Anziani protestano che la città ne rimarrà «sepolta o per il meno imprigionata, oltre al notabile pregiudicioper cagione del traffico, qual verrà a rendersi più difficoltoso». Riconoscono tuttavia che, «se queste mura enuove fortificazioni doveranno assicurar maggiormente detta città con la cautella in conseguenza del StatoSerenissimo e conservatione della libertà, beveremo volentieri quest’amarezza, essendo ancor noi savonesi aparte di detta libertà». Ma, giustamente, non possono accettare che tutta «la fabrica resti a carico nostro» (ASS,Comune I, 210, libro III, c. 28).
Capitolo 10
applicare tanto al Dominio quanto alla Dominante una tassazione uniforme eragionevolmente perequata dalla quale trarre le risorse per la difesa, e forseanche chiamare a responsabilità politiche qualche esponente delle classi diri-genti locali. Non essendovi nulla di tutto ciò, non si può chiedere che una cittàaccetti a cuor leggero di vivere all’ombra di un’enorme fortilizio, le cui esigen-ze strategiche impongono sempre nuove ferite ai quartieri urbani, sempre nuovibalzelli alla popolazione.
Infine c’è l’insipienza umana: governi che adottano misure contraddittorie,fanno e disfanno con leggerezza, decidono una linea strategica e poi la rinnega-no incuranti dei costi materiali e umani che ciò comporta. È curioso, ad esem-pio, che solo nel 1683 il Senato genovese si renda conto che lo spalto esternodella fortezza va ampliato, il che comporta «l’atterramento delle case per passicento andanti dallo spalto del castello», e fra queste «le officine dell’ontoria[cioè le concerie], arte che hoggidì è forse le maggiore di questa città». È altret-tanto curioso che solo dopo la presa del Priamàr da parte delle truppe piemon-tesi nel 1746 gli esperti militari si accorgano che per migliorarne le difese ènecessario demolire l’intero borgo del Molo, ciò che verrà attuato nel 1749. Ilrisultato è un «conflitto vitale fra una città e un castello-fortezza che [...] neisecoli potenzia e modifica la sua funzione e, dilatandosi smisuratamente, mor-tifica l’abitato e lo spinge sempre più lontano da sé, ad esso sostituendosi, finquasi ad annientarlo30.
Questo destino, però, era tutt’altro che scontato: dopo l’aggressione sabau-da del 1625, durante la quale Savona (come si è visto nel capitolo 5) ha datoampie prove di fedeltà, Genova è infatti tornata al proposito di fortificare lacittà, il che consentirebbe un risparmio di uomini e mezzi rispetto al manteni-mento della fortezza. Nel 1626 il Senato dispone la costruzione di nuovi baluar-di intorno all’abitato: ciò comporta l’abbattimento di «orti, giardini e case [...]ch’erano d’impedimento alla perfezione del lavoro» per un valore di «scudicento mila, da pagarsi dall’Illustrissima Camera a’ particolari cittadini». Dueanni dopo arriva a Savona il padre Vincenzo da Fiorenzuola (al secolo GaspareMaculano), uno dei più brillanti ingegneri militari dell’epoca, e successivamen-te Ansaldo De Mari («quel che fece il meraviglioso Molo Nuovo in mezzo l’ac-qua nel porto di Genova»), che perfezionano il baluardo dello Sperone e innal-zano una tenaglia sopra il monastero di Santa Chiara. Nel 1629 si dà il via adaltre fortificazioni a Savona e a Vado, e infine nel 1631 si innalzano mura dallaparte della calata, benché il Comune spedisca a Genova un proprio oratore «pervedere se se ne poteva a meno, per non levare una tanta commodità di sbarcoed allegrezza d’aria». Infine nel 1668 giungono in città «molti periti ed archi-tetti per rivedere le fortificazioni, e tra gli altri il primo ingegniero ed architet-to dello Stato di Milano», il celebre Gasparo Beretta, e anche questa volta i lavo-ri comportano qualche abbattimento di muraglie private, comprese quelle di un
161
30 R. MASSUCCO, M. RICCHEBONO, M. TASSINARI, C. VARALDO, Il Priamàr prima pietra cit., pp. 35-37.
Distruggere e costruire
giardino presso il monastero di Santa Teresa, proprietà del senatore genoveseAlessandro Grimaldi: a dimostrazione del fatto che, quando si tratta di esegui-re fortificazioni, non si guarda in faccia a nessuno31.
Sennonché, dopo tanti sforzi, sacrifici e spese, tra il 1679 e il 1680 la politi-ca militare genovese cambia radicalmente indirizzo. Negli anni precedenti alcu-ni esperti hanno suggerito di potenziare ancora le difese cittadine di Savona,realizzando una grande cinta analoga a quella eretta intorno a Genova con le«mura nuove»; ma il progetto sarebbe troppo dispendioso, e allora si opta perun’alternativa più economica: smantellare tutte le opere fortificate intorno allacittà – eccettuate le mura medievali, che serviranno ormai solo come barrieradaziaria – e concentrare ogni difesa nella fortezza. Qualcuno arriva a proporreche con le macerie delle fortificazioni si colmi la darsena, eliminando definiti-vamente da Savona qualunque attrezzatura portuale, per vanificare ogni «dise-gno di qual si sia gran potenza» su di essa; ma non si arriva a tanto. La darsenaviene risparmiata; in compenso la città negli anni seguenti viene effettivamen-te sguarnita e le viene tolto il presidio militare, benché i cittadini protestino sen-tendosi indifesi ed «esposti a un sacco»32.
Così la fortezza cresce ancora e quasi raddoppia la propria superficie, anchese pochi anni dopo si torna a metterne in dubbio l’utilità e a prospettarne lademolizione parziale o totale, e tra le ragioni che infine ne suggeriscono la con-servazione non manca l’antico proposito di «tenere a freno la città di Savona»33.Un’anonima relazione sul Priamàr – stesa probabilmente sullo scorcio delSeicento – si sofferma, in una premessa dai toni barocchi, sulle «mutationi de’tempi» cui corrispondono «mutationi de’ dominii, provincie, città e castella»:per questo la Repubblica ha dovuto «fare et disfare fortifficazioni, fortezze,munir porti et altre diligenze che per l’interesse di Stato convenivano farsi», per-ché «i principi e repubbliche fanno e disfanno quando occorre e quando portacosì la congiontura e positura delle faccende del mondo». Non è difficile legge-re in queste frasi una excusatio per le contraddittorie vicende delle fortificazionisavonesi: esse – si afferma - «non furono disfatte senza prudenti riflessioni, sìper l’impegno di mantenerle e diffenderle con grosso numero di pressidio, comeper i diffetti a che soggiacevano»34. Ma è una giustificazione che non convince,e che non può certo ripagare i savonesi di allora per tutto quanto hanno dovu-to subire a causa di una politica incerta e contraddittoria.
162
31 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, pp. 218-219, 235-236, 241, 256, 428-429.32 R. MASSUCCO, M. RICCHEBONO, M. TASSINARI, C. VARALDO, Il Priamàr prima pietra cit., pp. 50-53.33 Ivi, p. 56.34 ASG, Giunta dei Confini, 103. Per il succedersi – spesso contraddittorio – di progetti relativi alla fortez-
za del Priamàr e alle fortificazioni della città si veda anche M. QUAINI (a cura di), Carte e cartografi in Liguriacit., pp. 171-174: dove si ricorda «come il discusso dispositivo difensivo savonese fosse il principale banco diprova degli ingegneri “nazionali” o “foresti” assoldati dalla Repubblica»; e come dai pareri di tali ingegneri deri-vasse «il continuo pendolo delle decisioni che talvolta porta a distruggere ciò che appena è stato costruito».Sull’accavallarsi di piani destinati a mettere nelle migliori condizioni di difesa la piazzaforte savonese si vedainoltre C. BARLETTARO-O. GARBARINO, La raccolta cartografica dell’Archivio di Stato di Genova, Genova,Tilgher, 1986, pp. 326-351.
Capitolo 10
«Fare et disfare», distruggere e costruire, sono verbi che, nel loro alternarsi,descrivono bene anche la politica genovese nei confronti delle opere portuali diSavona. Nel corso del medioevo, lo sappiamo, si sono succedute molte distru-zioni parziali, e nel 1528 ha avuto luogo quella più radicale, che qualcuno avreb-be voluto totale e definitiva. Abbiamo visto che quest’ultima è nata dal propo-sito di colpire non tanto una rivale commerciale quanto un’antagonista politica,e ha avuto motivazioni più strategiche che economiche. Andrea Spinola, il piùacuto scrittore politico genovese del Seicento, ha sostenuto in modo esplicito:«Non ci torna conto, per alcun verso, che li luoghi marittimi dello nostro Stato,i quali non hanno porto o ver darsina, ne faccino». Ogni luogo di facile appro-do lungo le Riviere rappresenta un «pericolo di perder lo Stato e la libertà, condisgusti, ansietà e pregiudicii continui», perché ogni potenziale nemico potreb-be impadronirsene e usarlo come base per offendere Genova35. Secondo il cro-nista Agostino Abate, i propositi genovesi di annientare perfino la darsena diSavona mirano «a ciò che li inimici non ge facesino disegno»36; la stessa costru-zione della fortezza del Priamàr obbedisce in buona parte alla logica di sorve-gliare l’accesso dal mare, e analoghe preoccupazioni inducono la Repubblica afortificare la rada di Vado e il golfo della Spezia37. Ci sono tentazioni ricorrentidi risolvere il problema cancellando del tutto gli approdi esistenti: nel 1640 ilpatrizio Marco De Franchi giungerà a proporre di colmare il golfo spezzinomediante una deviazione del fiume Magra, per ricavarne terre fertili e insiemeper chiuderlo alla navigazione, cosicché «le armate non vi potranno stantiare conquella libertà con la quale fanno al presente», e si risparmieranno le spese dellefortificazioni38; e abbiamo visto poc’anzi come l’idea di colmare definitivamen-te la darsena savonese non sia stata estranea agli uomini di governo.
Il 1528 segna la riduzione non solo delle attrezzature portuali di Savona, maanche dei poteri della città in questa materia. Nell’ambito dell’amministrazionecomunale il Magistrato di Vie e Darsena conserva alcuni compiti di sorveglian-za (far dragare periodicamente la darsena stessa, impedire che vi si gettino rifiu-ti, curarne la manutenzione), ma non dispone più né di entrate ad hoc, perchéè stata abolita la tassa di ancoraggio con cui si finanziavano in passato i lavoriportuali, né dell’autorità di effettuare interventi straordinari39. Abbiamo ricor-dato, nel capitolo 5, che nel 1573 il Senato vieta al Magistrato di intromettersiin cose riservate all’autorità del governo; e per maggiore chiarezza un decretodel 1596 proibisce tassativamente ai savonesi – senza l’autorizzazione deiSerenissimi Collegi – di accrescere lo specchio della darsena prolungando ilmolo e collocando delle capsae o «cassie», i cassoni riempiti di pietrame e maltache vengono calati in mare per rafforzare le difese portuali40.
163
35 A. SPINOLA, Ricordi politici (ASCG, Manoscritti Brignole Sale, 106 C 4), pp. 76-77.36 A. ABATE, Cronache savonesi cit., p. 134.37 G. ROSSINI, Le fortificazioni genovesi a Vado dal XVI secolo: un capitolo di architettura militare, AMSSSP,
n. s., vol. XIV, 1980, pp. 107-139; P. CEVINI, La Spezia, Genova, Sagep, 1984, pp. 189-198.38 P. CEVINI, La Spezia cit., pp. 200-201; A. FARA, La Spezia, Bari, Laterza, 1983, pp. 22-23.39 Statuti politici della città di Savona cit., pp. 84-94.40 ASS, Comune I, 210, libro II, c. 14.
Distruggere e costruire
Naturalmente alle ragioni strategiche possono andar congiunte quelle com-merciali, e molti a Genova vedono di buon occhio l’eliminazione di un portorivale e la concentrazione di tutti i commerci all’ombra della Lanterna. Ma cisono limiti che è opportuno non oltrepassare: come i delegati savonesi hannosostenuto fin dal 1526, deprimere oltre misura i traffici della città soggettarischia di danneggiare l’intera Repubblica, rendendo Savona «impotente inqualsivoglia bisogno a dar soccorso al suo prencipe»41. L’interesse dello Stato èil tasto sul quale continueranno a battere negli anni seguenti gli amministrato-ri savonesi, insistendo sul fatto «che veramente quella povera darsena è di pub-blica utilità non solo a questa Eccellentissima Repubblica ma a tutto il [...]Dominio, essendo refugio e ricettacolo di molte barche che altrimente in litempi fluttuosi si perderìano»42.
Toccata da questi argomenti, Genova comincia ben presto a fare concessio-ni: nel 1539 consente al Comune savonese di applicare addizionali su alcunegabelle per pagare la manutenzione della darsena; nel 1546, riconoscendo chequello scalo è utile a tutti coloro che navigano lungo le Riviere, stabilisce che,se un’imbarcazione dà fondo a Savona provenendo dalle località costiere delDominio o da fuori Stato, è tenuta a pagare alla città una gabella di ancoraggioil cui provento è destinato a finanziare i lavori portuali. Concesso dapprima invia eccezionale, il diritto d’ancoraggio viene poi sempre prorogato a partire dal1550 e aumentato nel 1630, 1634, 1699; intanto nuove «additioni» a favoredella darsena vengono autorizzate nel 1556 sulla gabella di macina, nel 1632 suquella del vino, nel 1634 su quella delle carni43. In questo modo la città puòdisporre di entrate destinate alle opere portuali, ma il diritto di levare questeimposte viene accordato sempre pro tempore e le proroghe devono essere«implorate» ogni volta dai rappresentanti comunali. Inoltre il Senato accorda aicittadini di Genova l’esenzione dal pagamento delle gabelle di Savona, e rifiutaqualsiasi sovvenzione statale, specificando che ogni lavoro va fatto a spese dellacittà suddita, «sine aliquo gravamine Reipublicae»; anzi, talora storna il gettitodelle gabelle “portuali” per pagare lavori di fortificazioni o per sostenere oneridi guerra che spetterebbero al governo44.
La gabella di ancoraggio, per di più, si riscuote con difficoltà dalle imbarca-zioni che danno fondo fuori della darsena, e che pure vi sarebbero tenute (undecreto del 1634 ha concesso la facoltà di riscuoterla nella rada di Vado «intutto come nel porto di Savona»45), mentre ovviamente gli ingressi in darsenadiminuiscono per numero e portata man mano che aumenta l’insabbiamentodei fondali, problema cronico dello scalo savonese, cioè proprio quando cisarebbe più bisogno di denaro per pagare il dragaggio. Così la manutenzioneportuale procede a sbalzi, gli interventi di un certo rilievo vengono effettuatiquando l’agibilità dello specchio d’acqua è fortemente compromessa, i lavori
164
41 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 170. 42 ASS, Comune I, 209, cc. 441-443.43 G. ASSERETO, Porti e scali minori cit. pp. 234-235.44 Concessioni, decreti et ordini cit., pp. 9-10; ASS, Comune I, 209, cc. 136 e 428; ASS, Comune I, 212, n. 272.45 ASS, Comune I, 212, n. 178.
Capitolo 10
straordinari possono essere pagati solo mediante l’accensione di prestiti i cuiinteressi prosciugano le entrate ordinarie46.
La Repubblica, dal canto suo, non si disinteressa di quei lavori. È vero che tal-volta, come accade nel 1590 e nel 1638, non si fa scrupolo di requisire il pon-tone usato dai savonesi per dragare la loro darsena, e di fronte alle proteste dicostoro risponde che le comunità soggette sono come «musculi del corpo, et [...]al corpo è più necessario diffendere il capo, dal quale dipende il spirito vitale ditutto il corpo, che non è necessario di diffendere uno membro, senza il qualeancora può reggersi il capo»47. Più spesso, tuttavia, ci sono forme di collabora-zione: se Genova non intende spendere, in compenso fornisce a più riprese assi-stenza tecnica, inviando a Savona personale esperto in opere marittime per effet-tuare perizie e stendere progetti, o concede ai savonesi di tagliare alberi nelBosco camerale per costruire pontoni o casse48. Tra la fine del Seicento e l’iniziodel secolo successivo, in particolare, la Repubblica decide di prendersi cura delladarsena savonese impiegandovi uomini e mezzi, spinta a ciò da una relativa crisidello scalo genovese e dalla necessità di trovare nuove vie commerciali.
È d’altronde un atteggiamento ricorrente, in seno al governo, quello di guar-dare con più interesse alle città soggette nei momenti di difficoltà: la minacciadi Livorno, ad esempio, fa balenare – a partire dalla metà del XVII secolo – ilproposito di sfruttare La Spezia come concorrente del porto toscano, attrezzan-dola e concedendole il privilegio di portofranco49. Nel 1693 il Governatore diSavona sollecita più volte dal Senato qualche intervento straordinario per la dar-sena savonese, perché la pur «incessante applicazione» della comunità ottienepoco, e «se mai, Dio non voglia, si chiudesse questa bocca resterebbero prive diporto le galee per un longo tratto di mare da Genova sino a Monaco eVillafranca». Inoltre ne soffrirebbe «un rilevante danno nell’economico la Casadi San Giorgio», che dalla dogana savonese ricava buone entrate50. È proprioSan Giorgio, infatti, che di lì a poco decide di erogare per i lavori della darsenasavonese un donativo di 2.000 scudi d’argento e di concedere un prestito age-volato di 4.000 lire, pretendendo però che la Camera presti a sua volta 8.000lire e che il governo garantisca con la propria assistenza e sorveglianza il buonesito dell’operazione51. Il governo in effetti manda a Savona i migliori tecnici dicui dispone, vi trasferisce imbarcazioni e uomini solitamente al servizio delporto di Genova, ordina che un abitante per ogni casa della città e delle villepresti una giornata di lavoro gratuito, ma ottiene scarsi risultati. «Il spaccia-mento di questo porto – scrive il Governatore nel novembre 1698 – mi è con-venuto toccare con mani riuscire di pochissimo profitto [...] per che quello si vaguadagnando lentamente con le fatiche di più mesi si perde ad ogni sbatuta di
165
46 G. ASSERETO, Porti e scali minori cit. pp. 237-238.47 ASG, Padri del Comune, 316, 5 giugno 1589.48 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 21 e 204.49 G. GIACCHERO, Storia economica del Settecento genovese, Genova, Editrice Apuania, 1951, pp. 59-71.50 ASG, Antica finanza, 895, 29 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre 1693.51 Tutta la documentazione relativa ai finanziamenti e ai lavori di quegli anni è in ASG, Antica finanza, 895:
una filza che reca il titolo Porto, molo e darsena di Savona, 1693-1706.
Distruggere e costruire
mare, che di nuovo ricumula maggior copia d’arena». Il 17 luglio 1699 unalunga relazione ai Collegi ribadisce l’inutilità degli interventi e il sempre mag-giore indebitamento della città52.
I lavori riprendono nel 1702, allorché il governo dispone un piano di finan-ziamento mediante l’emissione di 400 luoghi di San Giorgio, cui la Casa aderi-sce «considerando quanto influisca al trafico della Liguria» il porto savonese;per pagare gli interessi sui luoghi verrà usata l’intera gabella d’ancoraggio, con-siderevolmente aumentata due anni prima. Il finanziamento consente di stipu-lare un grosso contratto d’appalto che prevede «la fabrica del nuovo mole,purgo et escavatione del porto e darsina, da darsi tutto questo terminato [...] inquattr’anni al più tardi»53.
Questa volta l’esito sembra confortante: nel 1705 il Governatore si dichiarasoddisfatto dei lavori, e nel 1708 il Gran Consiglio delle Compere di SanGiorgio vara una nuova legge di portofranco che sembra aprire migliori pro-spettive anche ai porti delle Riviere54. Ma le timide aperture liberiste già dueanni dopo vengono sconfessate; nel frattempo il contratto per la manutenzionedel porto savonese sfocia in una lunga controversia e la darsena torna nelle cat-tive condizioni di prima55: verrà lasciata «in stato deplorabile» almeno sino allametà del Settecento. Tutto ciò è dipeso in parte dall’atteggiamento miope edegoistico di Genova: finché ha ritenuto utile potenziare il commercio degli scalidel Dominio si è interessata dell’approdo savonese; quando ha cambiato strate-gia – e ciò è accaduto soprattutto dopo che, nel 1713, ha acquistato il marche-sato del Finale e ha così eliminato la più pericolosa via alternativa fra il marLigure e il Piemonte – non ha più avuto ragione di occuparsene. Ma in parte vihanno contribuito gli stessi amministratori savonesi, come ha denunciato sindal 1696 l’allora governatore Domenico Spinola in una relazione al Senato:
In questo tempo che ho avuto l’honore di servire Vostre Signorie Serenissimequi, ho cognosciuto ancora che la forma che si tiene di spendere le entrate assignateal spacciamento di questo porto non sono conforme devono essere, [...] sì perchésono le ultime ad essere sborzate et assignate ne’ peggiori debitori, come per esse-re distolte in qualche altro uso e bisogno della città, come ancora per essere benspesso li sogetti a cui ne resta appoggiata la cura o incapaci o trascurati56.
C’è dunque un uso improprio dei fondi destinati alla darsena, come se que-sta non fosse ritenuta una priorità. E ci sono fenomeni di vera e propria corru-zione o malversazione: i maggiori appaltatori delle opere portuali, che godonodi complicità nel Comune, vengono pagati fin troppo rapidamente per acqui-sti gonfiati o per lavori mai eseguiti. «Di molti certo si è che sono di fabbricar-
166
52 Ivi.53 ASS, Comune I, 211, cc. 37-38.54 L. BULFERETTI-C. COSTANTINI, Industria e commercio in Liguria nell’età del Risorgimento (1700-1861),
Milano, Comit, 1966, pp. 125-132.55 ASS, Comune I, 172, 29 gennaio e 8 febbraio 1725; ASS, Carte Noberasco, IV, n. 3.56 ASG, Antica finanza, 895, 9 febbraio 1696.
Capitolo 10
visi sopra una vendemmia», sostiene nel 1702 una «dichiarazione» del MinorConsiglio auspicando la nomina di una deputazione di controllo, «altrimenti lamaggior parte del denaro se ne andrà in mangerie»57. Nel 1721 una supplica alSenato rivela che gli appaltatori del porto sono «sette de’ più floridi cittadini»di Savona i quali, «confidati più su le loro aderenze che su l’assistenza della giu-stizia, doppo d’essersi imborzata la somma di £ 177.369 si sono fatti lecito d’ab-bandonare de facto detto appalto, con lasciar detto porto pieno di sabbia pocomeno di quello fosse in tempo che si sono assonti l’obligo d’evacuarlo»; il tuttoè avvenuto perché fra gli Anziani e i Maestri Razionali sono «sempre stati [...]framischiati o qualche d’uno di detti appaltatori, o altri lor parenti o faotori»58.
Nel 1763, quando finalmente si decide di sottoporre a revisione i libri con-tabili del Magistrato di Vie e Darsena, vi si scoprono «falsità di addebitazioni emancanza di più somme»59. Ancor più della disonestà, però, è il disinteressedelle istituzioni locali che sorprende: ci vogliono anni per riformare il suddettoMagistrato, o per prendere provvedimenti anche banali, come la nomina di uncustode del porto. Se si eccettuano periodi di emergenza, o momenti in cui è laRepubblica stessa ad assumere l’iniziativa, del porto di Savona sembra che nes-suno voglia occuparsi. Dagli atti ufficiali trapela che solo una parte – e non lamaggiore – del ceto dirigente cittadino ha a cuore il problema e si sforza di risol-verlo. Nel 1699, ad esempio, è il Senato che si preoccupa di sapere se i lavori di«scavamento» procedono nel modo dovuto e chiede «se la città [...] faccia le sueparti, [...] non essendosi più [...] avuta notitia di maggior applicatione ad unaffare che importa loro quanto ognun sa»: la Repubblica ha preso a cuore la fac-cenda e sta stanziando fondi, quindi si aspetterebbe un vivo interesse da partedei savonesi, che invece manca60. Più tardi, nel 1749, il Senato è nuovamentecostretto ad intervenire rimproverando gli Anziani savonesi perché non proce-dono con la dovuta sollecitudine a far eseguire i lavori di dragaggio61.
«A conservar la darsena – ha scritto l’annalista Verzellino – non è bastantespendervi annualmente [...] il doppio di quello che da’ navigli si riscuote»62. Inquesta frase sta, a nostro avviso, la principale spiegazione del fenomeno: unporto – per quanto piccolo – è una struttura costosa, solo una ricca città mer-cantile ha forze e motivazioni sufficienti per accollarsene gli oneri. Ma Savona,a quest’epoca, non è più un importante centro manifatturiero e commerciale;la sottomissione del 1528, più che annientarne le libertà comunali, ne ha scon-volto il tessuto economico colpendo sia l’attività portuale, sia la produzioneartigiana che alimentava traffici di vasto respiro63. Ormai è una città sonnolen-ta e graziosa, ricca di dimore signorili e di istituti religiosi, utilizzata «nell’am-
167
57 C. CIPOLLINA, L’insabbiamento del porto di Savona tra Sei e Settecento, «Bollettino ligustico», XXIII, 1971,pp. 45-62 (in particolare pp. 49-50).
58 ASS, Carte Noberasco, IV, n. 3.59 ASS, Comune I, 139, relazioni contabili 1763-1796.60 ASS, Comune I, 215, 4 agosto 1699.61 ASS, Comune I, 143, 5 maggio 1749.62 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. I, p. 63.63 C. VARALDO, 1536, un anno nella crisi citato.
Distruggere e costruire
bito dello Stato genovese come un’area periferica, pianificata a puri fini di ser-vizio»64. Il suo ceto dirigente, come sappiamo, si è trasformato sempre più in ungruppo di proprietari terrieri e di rentier, per i quali l’esistenza di un porto nonè essenziale; e quando le spese per la sua conservazione rischiano di far aumen-tare oltre misura la pressione fiscale o di compromettere il pagamento degliinteressi sul debito pubblico comunale, essi vi si oppongono, solidali in ciò conquelle opere pie e quei corpi religiosi che sono i maggiori detentori di «luoghidi monte». Questa debolezza degli interessi mercantili, unita al fatto che all’e-poca la navigazione di cabotaggio può anche fare a meno delle strutture por-tuali, genera un circolo vizioso: produce meno risorse per il porto, quindi peg-giora le condizioni di quest’ultimo, che di conseguenza non è in grado di favo-rire alcuno sviluppo commerciale e marittimo. Per rompere tale circolo occor-rerebbe un intervento deciso e continuo da parte dello Stato, ma – tranne chein alcuni momenti – la Repubblica non è per nulla sollecitata a intervenire e hamezzi finanziari scarsi.
Una timida inversione di tendenza si ha solo nella seconda metà delSettecento, specie a partire dal 1769, quando Genova prende particolarmente acuore le sorti di Savona, sollecitata da vari fattori, ma soprattutto dai timori perla concorrenza del porto di Nizza in un momento in cui i progetti sabaudi mira-no a potenziarlo65. Il 6 marzo di quell’anno una supplica al Senato da parte del-l’amministrazione civica di Savona ricorda le molte spese affrontate in annirecenti dalla città per le opere di manutenzione straordinaria ai moli e di «pur-gazione» delle sabbie, ma lamenta che l’impegno si era rivelato insostenibile.«Fino a tanto che è stato sperabile colle nostre forze di mantenere pratticabilequesto piccolo porto, non si sono sparagnate né fatiche, né denari, né erezionid’impieghi, né quote personali, né perfino il concorso d’ogni condizione di per-sone ad evacuarlo dalle arene». Ora però gli Anziani savonesi si vedono costret-ti a ricorrere «a Vostre Signorie Serenissime come a sovrani e nel tempo stessopadri amorevoli»: al governo centrale, insomma, si chiede di assumersi le pro-prie responsabilità e risolvere un problema di interesse collettivo66.
Il 9 aprile 1769 la situazione negativa viene confermata dal Governatore diSavona e il 20 giugno la Camera stende una lunga relazione nella quale si pren-de atto dell’importanza di quel porto «per il sicuro asilo che presta alle galee ebastimenti della Riviera occidentale», della necessità di intervenirvi, nonchédella «notoria universal decadenza di detta città»67. Prende avvio allora un’af-fannosa ricerca di fondi, si nominano commissioni e deputazioni ad hoc, siappaltano lavori per il prolungamento dei moli e per il dragaggio dei fondali68:un’operazione complessa, destinata a durare per diversi anni, che denota un
168
64 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., p. 74.65 Si veda, riassuntivamente, G. RICUPERATI, Il Settecento, in P. MERLIN, C. ROSSO, G. SYMCOX, G.
RICUPERATI, Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna, Torino, Utet, 1994 (Storia d’Italia diretta daG. GALASSO, vol. VIII/1), pp. 439-834 (in particolare pp. 543-549).
66 ASS, Comune I, Porto 5.67 Ibidem.68 ASS, Comune I, Porto 3; ivi, Porto 7, fasc. 10; N. CERISOLA, Storia del porto di Savona cit., pp. 106-109.
Capitolo 10
Distruggere e costruire
certo zelo da parte del serenissimo governo, ma che non riuscirà ad avviare unanuova politica portuale.
Anche per quanto riguarda altre opere pubbliche o infrastrutture, la politicagenovese nei confronti di Savona è abbastanza inconcludente, ma non per unapresunta malevolenza nei confronti della città soggetta. I problemi, ancora unavolta, sono di altra natura, riguardano la debolezza finanziaria e le preoccupa-zioni strategiche. Le intenzioni possono essere lodevoli e dettate da princìpi dibuon governo, come nei numerosi interventi disposti per arginare i torrenti cheattraversano le «ville» suburbane, ma ogni volta le ristrettezze dell’erario, o l’in-capacità di costringere al pagamento delle spese i proprietari dei terreni circo-stanti, rendono inadeguati e precari i lavori che via via si realizzano69. A maggiorragione l’inadeguatezza si riscontra nei lavori stradali: mancanza di fondi, diffi-coltà del terreno e timori che ogni via di comunicazione terrestre si riveli unaporta aperta alle invasioni dei nemici fanno della Repubblica di Genova unodegli Stati italiani più restii a costruire strade carrozzabili, tanto che la stessaDominante avrà sempre collegamenti scadenti con il proprio retroterra. Nel casodi una città soggetta, la disponibilità è ancora minore, le perplessità più forti.
Lo si vede bene quando, nel 1650, giunge al governo notizia di una stradache il duca di Mantova vorrebbe costruire per mettere in comunicazione le sueterre del Monferrato con la Liguria, e precisamente Acqui con Albisola. La stra-da potrebbe essere utile a Savona, nonché alla Casa di San Giorgio che incasse-rebbe i dazi di transito, ma vengono subito avanzate preoccupazioni sia di carat-tere fiscale (bisogna stare attenti che la strada non sbocchi in luoghi troppoaperti e mal sorvegliati, dove sarebbero facili i contrabbandi), sia di natura mili-tare (il Magistrato di Guerra teme che la fortezza del Priamàr sia più facilmen-te raggiungibile), sia infine d’ordine economico, perché bisogna riflettere «seconvenga alla Repubblica il ripartire con Savona il traffico per Monferrato» sot-traendone una porzione a Genova.
La pratica così resta ferma per due anni, nonostante le pressioni del Comunesavonese e il parere favorevole del Governatore, ma riparte nel 1652, quando ilSenato dispone che «con ogni applicatione venga perfettionata» una strada cheda Savona risalga la valle del Letimbro, valichi l’Appennino in località Cà diFerrè, si diriga «al Ponte delli Prati feudo del signor Antoniotto Invrea» (cioèl’attuale Pontinvrea), di lì prosegua verso «Mioglia, Pareto e per molti altri luo-ghi del Monferrato» utilizzando un tracciato già esistente («per strada romera»),oppure verso Giusvalla feudo degli Spinola (dove «quelli di detto luogo hannodi già dalla loro parte accomodata la strada»), quindi a Piana dove un’altra «stra-da romera» conduce, lungo la Bormida, a Spigno e Acqui, o un’altra ancora rag-giunge Cortemilia.
169
69 Sui numerosi interventi per l’arginamento del torrente Lavagnola (l’attuale Letimbro), cui partecipa an-che Giovanni Bassignani, uno dei più brillanti ingegneri al soldo della Repubblica, si veda M. QUAINI (a curadi), Carte e cartografi in Liguria cit., pp. 183-186.
Grazie a questa via di comunicazione – pagata in parte dal Comune savone-se, ma con un significativo contributo di San Giorgio – i mulattieri evitano ildazio delle Carcare, territorio appartenente al Marchesato del Finale e quindialla Spagna, e hanno altri vantaggi, come precisa una lettera del Senato: «Niunoalonga la strada, molti l’accursano, e se in Savona vi sarà una stapola di sale conla quale li mulatieri si rendino sicuri di trovar carrico al ritorno, non v’è dubioalcuno che ne risulterà grandissimo utile a tutte le gabelle e si vivificherà il traf-fico nella città»70. Per disporre il semplice riattamento di una mulattiera – per-ché di questo, infine, si tratta – bisogna dunque che il governo superi varie per-plessità, si accerti della convenienza doganale, scelga un tracciato che serpeggiatra feudi amici (perché investiti a patrizi genovesi) e si collega a vie che già altrisi sono incaricati di aggiustare per ridurre i costi all’osso, e infine disponga – suistanza del Magistrato di Guerra – che al valico di Cà di Ferrè sia posto un«rastello», una barriera guardata da un piccolo presidio.
Per Savona si tratta comunque di una conquista, ma negli anni seguenti lacittà deve difendere con puntiglio e con molte spese legali la «franchigia» dellastrada, cioè il fatto che per transitarvi non si debbano pagare dazi, dai ripetutitentativi dei gabellieri che pretenderebbero di riscuotervi qualche diritto e maga-ri – con la complicità «di soldati corsi armati con archibuggi», come accade nel1693 – arrestano i mulattieri e sequestrano le loro bestie e il rispettivo carico. Ilgoverno le dà ogni volta ragione, spalleggiato da San Giorgio che intende «diver-tire il negotio del Finale con portarlo nello Stato della Repubblica»71; ma è chia-ro che se il destino di questa o di altre strade dipende solo dall’interesse fiscaleo militare, la città soggetta rischia ogni volta di perdere le proprie opportunità.Basta vedere le molte relazioni che la Giunta dei Confini fa compilare sulle vieche da fuori Stato portano verso Savona, relazioni in cui si disquisisce non sucome mantenerle in buono stato, ma su come fortificarle, trincerarle e renderleimpraticabili in caso di emergenza72; o le molte suppliche – non solo dei savo-nesi, ma anche di altre comunità del Dominio – che soprattutto negli anni ventidel Settecento, non a caso dopo l’acquisto dell’enclave finalese, lamentano losfacelo delle strade e ne sollecitano la riparazione73.
Questo, peraltro, è il risultato inevitabile del modus operandi di unaRepubblica che applica ovunque la politica della lesina, che dappertutto spen-de e investe pochissimo, che alla magnificenza privata dei suoi patrizi contrap-pone una costante meschinità negli interventi pubblici; una Repubblica nellaquale l’apertura di una strada che ai nostri occhi sembra così agevole ed essen-ziale come quella che percorre la val Polcevera e congiunge Genova conCampomorone deve attendere il pieno Settecento e la munificenza deiCambiaso, ricchi banchieri di fresco nobilitati, i quali comunque pensano sì alpubblico interesse, ma anche e più a valorizzare i terreni di loro proprietà chela strada attraversa.
170
70 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 160-164; ASS, Comune I, 214, 23 maggio 1652.71 ASS, Comune I, 214, 29 aprile e 13 settembre 1697.72 ASG, Giunta dei Confini, 103.73 ASG, Magistrato delle Comunità, 550.
Capitolo 10
«Egli è tutto il lito de’l mare di questa regione da Monaco infino al principiodi Toschana senza porto, benché ritrovinsi alcuni piccioli luoghi disposti a rice-vere li navighevoli legni»: così scrive nel 1550 il geografo Leandro Alberti a pro-posito delle coste liguri, sottolineando il fatto che, ove si escluda ovviamenteGenova, la regione a quell’epoca non dispone di alcuna vera attrezzatura por-tuale1. Più tardi, all’inizio del Seicento, l’acuto scrittore politico Andrea Spinola– descrivendo a sua volta il litorale della Repubblica – traccia un quadro menopessimista ed elenca un certo numero di approdi utili (la rada di Alassio, quel-la di Vado «bastante a ricettar un’armata e sicurissima dalle fortune maggiori»,la darsena di Savona «capace di alquante galee», l’insenatura di Portofino e infi-ne il golfo della Spezia «il quale, capace di molte armate, contiene in sé variiseni, che sono sicurisimi porti»)2; ma si tratta, con la sola eccezione della darse-na savonese, di specchi d’acqua protetti dalla natura, non da moli o da altreopere. «Tra Savona e Villafranca non esiste alcun porto», dirà due secoli dopo ilconte di Chabrol nella sua Statistique del dipartimento di Montenotte3. E nellaRiviera di Levante l’amministrazione napoleonica trova un analogo vuoto sinoal golfo spezzino, che essa progetterà di trasformare in una grande base milita-re.
La conformazione delle coste è certamente responsabile di questa situazione,ma vi ha contribuito non poco l’azione degli uomini. Il processo attraverso ilquale Genova ha via via sottomesso gran parte della Liguria e ha formato il pro-prio Stato territoriale ha comportato anche l’eliminazione di molti potenzialiconcorrenti nell’attività commerciale. I piccoli approdi di Ventimiglia o diAlbenga vengono ben presto cancellati4; e nei capitoli di soggezione delle comu-nità rivierasche, poi ribaditi in un decreto generale del 1440, si dispone chetutte le merci di loro spettanza, in entrata e in uscita, debbano passare per ilporto di Genova e pagarvi i diritti doganali5. Da parte della Dominante, dun-que, è stata messa in atto senza dubbio una strategia monopolistica nell’ambitoportuale. Tuttavia, come abbiamo più volte affermato nei capitoli 2 e 3, perquanto riguarda Savona il quadro è più complesso: da un lato Genova ha spes-so cercato di tenere a freno, con i trattati e anche con la forza, una città che può
171
1 L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia et isole pertinenti ad essa, Bologna, Anselmo Giaccarello, 1550, c. 9 v.2 A. SPINOLA, Ricordi politici cit., p. 76.3 G. CHABROL DE VOLVIC, Statistica delle provincie di Savona, di Oneglia, di Acqui e di parte della provincia
di Mondovì, che formavano il dipartimento di Montenotte a cura di G. ASSERETO, Savona, Comune di Savona,1994, vol. II, p. 377.
4 G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia, Oneglia, Tip. Ghilini, 1886, p. 73-74; J. COSTA RESTAGNO,Albenga, Genova, Sagep, 1985, p. 20.
5 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova cit., p. 326.
Capitolo 11
Ostacoli e incentivi all’economia
farle ombra nei commerci marittimi; ma d’altro lato l’ha considerata per lunghiperiodi un utile partner commerciale e ha intrattenuto proficui rapporti di col-laborazione con i suoi mercanti. Quando infine ha deciso di distruggerne ilporto lo ha fatto – ripetiamo – soprattutto per motivi strategici, e in parte ancheperché Genova si sta trasformando in una piazza prevalentemente finanziaria, ecome tale ha assai meno bisogno di appoggiarsi a un porto sussidiario nellaRiviera di Ponente.
Nel corso del Cinquecento, allorché la sovranità genovese sulle Riviere èormai incontrastata, la normativa che impone ai naviganti rivieraschi di farcapo alla dogana di Genova si fa meno rigida e vengono stipulate convenzioniche garantiscono alle comunità del Dominio una certa libertà di commercio,consentendo uno sviluppo anche cospicuo del cabotaggio e degli scambi locali,quelli in particolare che interessano il retroterra piemontese e monferrino divari approdi liguri: Sanremo, Alassio, Ceriale e Savona, le cui marinerie cresco-no compensando in parte il declino dello scalo genovese, o assicurando partedelle comunicazioni fra questo scalo e l’importante emporio di Livorno. Talesviluppo, d’altronde, reca vantaggi alla stessa Dominante, non solo perchéaumenta la prosperità dei sudditi del suo Dominio e li rende più docili a subir-ne l’autorità e a sopportarne i pesi fiscali, ma anche perché quei circuiti com-merciali alimentano introiti doganali che vanno a vantaggio della Camera edella Casa di San Giorgio, la quale mantiene nei principali scali rivieraschi (inprimis a Savona) appositi commissari per svolgere le pratiche doganali senza chele merci siano costrette a passare per Genova.
C’è però una contraddizione di fondo che percorre tutta la politica commer-ciale della Repubblica nel corso dell’età moderna: da un lato esiste un indubbiointeresse – per le ragioni appena ricordate – a far sì che le comunità delle Rivieresvolgano una discreta attività commerciale; d’altro lato quell’attività non devesottrarre traffici al porto della Dominante, perché tale è la logica di uno Statocittadino, e perché è lì che riscuote le principali gabelle San Giorgio, da cuidipende il delicato equilibrio finanziario della Repubblica. Contemperare que-ste due esigenze diventa tanto più difficile a partire dall’inizio del Seicento,allorché Genova – che ormai ha perduto l’antica potenza marinara ma vuole«conservare o conquistare [...] il ruolo di grande emporio internazionale, inter-cettando o addirittura monopolizzando alcune grandi correnti di traffico» –decide di adottare una politica di portofranco, anche per controbattere il ruolocrescente di Livorno nei commerci del Mediterraneo6.
La prima legge di portofranco – temporanea, ma rinnovata e ampliata a piùriprese – viene approvata nel 1613, e costituisce un oggettivo attacco ai portiminori, visto che garantisce la franchigia solo ai natanti che giungono a Genovasenza fare scalo in alcun punto della costa compreso tra Viareggio e Antibes7.Negli anni seguenti si avanzano proposte intese a revocare tutte le convenzioni
172
6 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova cit., pp. 323-325.7 G. GIACCHERO, Storia economica del Settecento genovese cit., pp. 13-31.
Capitolo 11
che avevano garantito alle Riviere una relativa libertà di commercio: benché intal modo si rischi di deviare i flussi mercantili verso località non soggette allaRepubblica (come il Finale e le enclave sabaude), queste proposte si tradurran-no infine nella «legge delle Riviere», approvata nel maggio 1662, che rimette invigore per tutto il Dominio il decreto del 1440 e il conseguente obbligo per inatanti rivieraschi di fare scalo a Genova8.
In questo quadro incerto e spesso incoerente – che peraltro riguarda tutta lalunga vicenda del portofranco e della strategia daziaria genovese – si inserisce ilcaso di Savona. Già abbiamo visto nel capitolo 10 come la Repubblica abbiadovuto pian piano preoccuparsi, sia pure in misura insufficiente e in manieracontraddittoria, della darsena di questa città, per garantirne un minimo fun-zionamento. La sopravvivenza della darsena, tuttavia, ha un senso solo se ven-gono garantiti dei flussi commerciali che la attraversino: si tratta quindi di favo-rirli, o quantomeno di non ostacolarli con una politica doganale onerosa. Nel1613, in occasione della prima legge di portofranco, Genova ha dovuto conce-dere a Savona una limitata franchigia sulle merci che scendono dal Piemonteper essere imbarcate9; e sappiamo che le imbarcazioni savonesi non sono piùtenute a fare scalo nel porto della Dominante. In seguito, però, questi privilegisono stati limitati o revocati, anche per il timore di troppo facili contrabbandi,e il 15 marzo 1644 gli Anziani savonesi si vedono costretti a inviare al Senatoun loro «oratore» con diverse richieste per risollevare la città «che ogni hora piùsi distrugge». La più importante riguarda la concessione di un vero portofran-co per «vascelli e robbe» che giungono a Savona, o almeno l’autorizzazione –valida sino a pochi anni prima – ai bastimenti savonesi perché, una volta fattoil carico a Livorno, possano «andarsene a golfo lanciato, senza esser astretti atoccare in questo porto di Genova», dove la sosta fa lievitare noli e costi.
L’argomento addotto a sostegno di questa richiesta è tale da non lasciareindifferenti i Serenissimi: tra Finale e Loano – terre appartenenti l’una allaSpagna e l’altra al Savoia – ci sono «più di venti vascelli che fanno il traffico daLivorno in detti respettivi loghi» senza sottostare ad alcun obbligo, col risulta-to che le merci da loro importate hanno prezzi molto più bassi, e i piemontesivanno lì a provvedersi, o noleggiano quelle imbarcazioni per le loro importa-zioni, mentre nessuno va più a comprare a Savona. «La città si va distruggendocon perdita della dogana», come risulta dai registri d’entrata degli ultimi anni,e ben presto «saranno astretti li mercadanti et artisti mutar paese [...] come digià molti hanno fatto, essendo le strade intiere con le botteghe chiuse»10. Oltrea questo, i savonesi lamentano che ultimamente il commissario della dogana hadi molto aumentato il dazio sui formaggi giunti via mare e diretti «perPiemonte, Langhe e Lombardia», col risultato che i mulattieri non solo vanno
173
8 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova cit., pp. 364-371.9 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p. 212.10 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 67-69.
Ostacoli e incentivi all’economia
ora a caricare i formaggi a Loano e a Finale, ma non portano più in città «risi,tele, caneppe, grani et altre vettovaglie e merci, le quali cose davano utile allegabelle della città, giovavano li artisti, mantenevano la povertà [cioè la poveragente] che si nutrisce del negotio, e [...] la dugana era più fruttuosa»11.
Il governo presta attenzione a queste richieste, «trattandosi di città beneme-rita e fidelissima», e San Giorgio si affretta a concedere il privilegio di porto-franco ai vascelli savonesi di portata non superiore a 1.200 cantari e a riportaresul piede antico la tariffa dei formaggi12. Non sappiamo che effetto abbianoqueste misure, ma pochi anni dopo, il 7 febbraio 1651, gli Anziani tornano asupplicare che, «per benefitio non tanto della città quanto di Santo Georgio»,si favorisca il transito delle merci «così per via di terra come di mare» adottan-do una tariffa doganale moderata («venti soldi per ogni collo di rubbi nove dellerobbe che dovranno essitarsi»): così, «dalla grandissima quantità che ne passa-rebbero per Savona, San Giorgio resterebbe non poco utilitato con non minorsollievo e sodisfattione della loro fedelissima città, provandosi al presente chetutto il traffico, per schivar la grossa gabella in Savona, si fa di Livorno imme-diatamente in Finale, Loano et Oneglia, e dal Piemonte a Finale ove non si pagagabella alcuna»13.
Questa insistenza sulla concorrenza di comunità rivierasche prive di porto,sia detto di passata, dimostra ancora una volta quanto sia relativa l’importanzadelle attrezzature portuali per quanto riguarda il commercio di cabotaggio –compreso quello a largo raggio, dalla Sicilia alla Catalogna – cui ormai datempo è ridotta la piazza savonese. Comunque sia, nel 1653 si torna a denun-ciare che a Savona il commercio langue e «da qualche tempo in qua è stato tra-sportato in luoghi non soggetti al Dominio della Repubblica»: ciò richiedeanche che si realizzino nuove comunicazioni stradali col Piemonte e ilMonferrato – ne abbiamo parlato nel capitolo precedente – «senza necessità ditoccare in Stati di altri prencipi, per poter schivare li datii che in quelli siriscuottono con ogni rigore»; ma soprattutto che si concedano riduzioni dellegabelle «sopra quelle robbe e merci che per detta città passeranno tanto di entra-ta quanto di uscita per trasportarsi fuori del Dominio».
Il governo ritiene – risposta molto significativa – «che non si possa metterein pericolo l’introito delle dugane di Genova»; ma accetta che si restituisca «alladetta città di Savona quel traffico che li è stato usurpato da i luoghi e popoliconfinanti». Si ristabilisce perciò la vecchia tariffa di 20 soldi a collo «sopra lemerci che vengano dal Piemonte, le quali per lo più sogliono essere telarie,dobletti [tele di lino e cotone] e fustanei, e da Monferrato le quali sogliono esse-re caneppe, coiri [cuoi], stracci e qualche altre cose che si porteranno a Savonaper transito per fuori del Dominio». La stessa tariffa agevolata deve valere per lemerci «che da Livorno et altri luoghi e paesi si portassero a Savona per transitoper Piemonte e Monferrato [...], come sono salumi, drogherie, zuccari, aman-
174
11 Ivi, c. 74, 22 giugno 1644.12 Ivi, c. 75. Un cantaro è pari a kg. 47,6496.13 Ivi, cc. 161-162. Il rubbo è pari a kg 7,94, quindi il collo pesa kg 71,47.
Capitolo 11
dole, pignoli, pepi, zebibi, canelle, piombi, stagni, vachette, panni, pannine,alumi et altre cose»14. Il provvedimento, approvato nel dicembre 1653 per duesoli anni ma con facoltà di proroga, è limitato al transito da e per il Piemontee il Monferrato, ed esclude «le sete, peli di capra, panni di seta, cociniglie et altremerci e cose di consimil valuta»: il timore è che i traffici savonesi possanoriguardare mercanzie pregiate che si vogliono far passare solo per il porto diGenova, o che possano estendersi verso mercati – la Lombardia, l’Europa set-tentrionale – che devono essere serviti solo dallo scalo della Dominante.
Sia pure con queste cautele, le agevolazioni doganali vengono più volte rin-novate e in parte anche ampliate: nel 1666 i Protettori di San Giorgio ritengo-no che si possa «far qualche altra permissione la quale servirebbe non meno abeneficar l’introito delle gabelle che a porgere a quella città l’aiuto desiderato»,e il 12 gennaio 1668 si concedono forti riduzioni sui dazi dei grani, legumi ecastagne provenienti dall’entroterra che «si estraono per fuori del Dominio pervia di mare»15. Frattanto il 7 luglio 1667 una lunga relazione stesa dal patrizioNicolò Grimaldi ha inteso dimostrare che, «venendo ampliato il portofrancode’ colli concesso alla città di Savona», esso non farà diminuire i traffici dellaDominante16.
Le piccole imbarcazioni che giungono nello scalo savonese non possono«condur merci né d’Inghilterra, né d’Olanda, né di Fiandra, né di Spagna», e silimitano a servire i mercati di quelle parti del Piemonte e del Monferrato piùvicine alla città. Neppure c’è da temere che vada a gravitare su Savona il com-mercio con la Lombardia, per la quale lo scalo di Genova è più conveniente diqualunque altro: stanno a dimostrarlo tutti i tentativi fatti dai finalini «per usur-parsi qualche negotii e corrispondenze con dette provincie lombarde», che sonofalliti perché troppo difficili sono le comunicazioni terrestri fra la Riviera diPonente e lo Stato di Milano. Viceversa gli stessi finalini hanno «fatto magaze-ni di ogni genere di mercantia» e intercettato i traffici tra il Piemonte da un lato,la Sicilia e la Sardegna dall’altro, il tutto a spese di Savona, dove perciò «sonoscemati li negocianti», e le imbarcazioni si sono spostate a Finale, Loano eOneglia: trasportano «ferri, sartiami, legnami e simili merci in dette isole, didove riconducono quantità di grani in tale abbondanza che hoggi in detti luo-ghi provvedono di grano e fideli a tutte le Riviere da Genova a Ponente [...]senza verun introito alla Casa di San Giorgio».
Invece, se si permettesse «l’ingresso d’ogni qualità di mercantie di fuoriDominio in Savona per via di mare», il grano duro siciliano e sardo arriverebbelì, potrebbe esservi immagazzinato, e i pastai – i «fidelari» – andrebbero a com-prarvelo a prezzo più basso, di modo che «potrebbero anco loro vender li fide-li al prezzo di Finale e divertir li compratori da detto luogo e render utilitata laCasa di San Giorgio della sua gabella». Se inoltre «a detta ampliatione di por-
175
14 ASS, Comune I, 210, libro II, cc. 176-179.15 ASS, Comune I, 214, 10 maggio 1666 e 12 gennaio 1668.16 ASG, Marchesato del Finale, 86: Papeli presentati all’Eccellentissimi e Magnifici deputati sopra la pratica del
Finale dal Magnifico Nicolò Grimaldi. Ringrazio Paolo Calcagno che mi ha comunicato questo documento.
Ostacoli e incentivi all’economia
tofranco» si aggiungesse la possibilità di esportare con un dazio moderato «ognisorte di ferri nuovi» fabbricati nelle ferriere dell’entroterra savonese «et ancheogni sorte di sartiami per uso delle tonnare di dette isole», tutti andrebbero aprovvedersi di queste merci a Savona, dove alla comodità di un porto si unisceuna buona strada «per salire in Piemonte e Monferrato». Infine il Grimaldi sug-gerisce, oltre ad altre facilitazioni minori, uno snellimento delle pratiche doga-nali; la riduzione – rispetto alla tariffa standard di venti soldi a collo – del daziosulle «merci di gran peso e di poca valuta come [...] salumi, piombi, zolfi, cuoiapelose e simili»; e il permesso di vendere a Savona il sale «a’ forestieri diPiemonte, Monferrato e Langhe al medesimo prezzo che si vende al Finale», perinvogliare i mulattieri a portare lì le loro mercanzie, sapendo di poter semprecontare su un conveniente carico di ritorno17.
Quello del Grimaldi, come si vede, è un piano coerente che, senza pregiudi-care in nulla gli interessi del commercio genovese, potrebbe rivitalizzare quellosavonese mediante un’opportuna divisione di compiti: alla città suddita verreb-be lasciato quel traffico a corto raggio con il suo retroterra che è poco appetibi-le e mal praticabile per la Dominante, alla quale invece resterebbe per intero ilricco mercato della pianura padana, e in particolare del Milanese. San Giorgiodovrebbe compiere un piccolo sacrificio, ma presumibilmente la maggiorequantità delle merci in transito compenserebbe la diminuzione delle tariffedaziarie. Né San Giorgio, né soprattutto il governo hanno però il coraggio dipercorrere questa strada fino in fondo.
Nel 1685 Lorenzo Curtino, «oratore» per la città di Savona, riferisce alSenato che continua la «mancanza del traffico», e per incrementarlo occorre«toglier al possibile quelle gravezze che fanno divertire i negozianti et applicarea far i loro negozii in altri luoghi, dove provano maggiori facilità». Un puntofranco con ampie immunità è stato concesso alla comunità di Ceriale e già siera deciso, nel 1680, di estendere la concessione a Savona, ma la Camera nonha approvato questo provvedimento; frattanto una nuova gabella sull’olio è ser-vita solo a deviare «il concorso de’ mulattieri [...] al Finale, dove trovano a car-ricarne senz’alcun aggravio»18. La pratica viene esaminata dalla Giunta delTraffico (la quale si mostra favorevole a un deciso sgravio fiscale, ma non all’e-liminazione della gabella sull’olio a favore di Savona, perché «compiacendosi inquesta parte la detta città» tutti farebbero passare di lì i trasporti d’olio, quindi«sarebbe afatto perduto questo introito per tutto il resto della Riviera»19), e poida una deputazione ad hoc, che nella sua relazione ricorda come le concessionisinora fatte non siano state sufficienti «a portare il traffico desiderato in Savona,mentre ne’ luoghi fraposti nel Serenissimo Dominio non sogetti non si pagavacos’alcuna». La maggiore facilità di approdo e le migliori strade non sono basta-te, infatti, a compensare l’onere dei dazi e il fastidio delle pratiche burocratiche,
176
17 Ibidem.18 ASS, Comune I, 214, 1 agosto 1685.19 Ivi, 10 settembre 1685.
Capitolo 11
ragion per cui si rende indispensabile la riduzione della tariffa doganale da 20 a5 soldi per collo, già proposta inutilmente qualche anno prima.
Chi fino ad ora si è opposto a questa misura lo ha fatto sulla base di un cal-colo miope, per il timore cioè che tutte le tele provenienti dal Piemonte e diret-te «in quantità non mediocre» tramite Savona al portofranco di Genova si fer-mino nella città suddita «con due cattivi effetti: l’uno che il negotio delle teleanco per quella che si fa in Genova si transporterebbe in Savona; l’altro che ladogana di Genova mancarebbe di quell’introito che si va cavando da detta qua-lità di merci», il che causerebbe «il disimpiego del denaro di molti [genovesi]che l’imprestano a’ piemontesi sopra il pegno delle robe che portano qui». Masecondo i relatori si tratta di timori infondati: con la tariffa più bassa arriveran-no più tele e merci piemontesi a Savona, di conseguenza ne giungeranno di più,via Savona, anche al portofranco di Genova, cosicché da questo andranno versoil Piemonte più merci di quelle che ora provengono da Livorno20.
Si giunge così, nell’estate del 1686, ad approvare lo sgravio fiscale per cinqueanni al fine di risollevare una città in crisi, che a malapena riesce ad appaltare lesue gabelle, «e se pur le vende lo fa con gran discapito [...] atteso il poco traffi-co e commercio che al presente vi è», mentre con le nuove misure «s’introdur-rebbe [...] gran concorso di negozii e traffico di molte persone, quale potrebbeapportare grandissimo utile et accrescimento alle dette gabelle». Ma il governosi vuole cautelare e dispone che la città di Savona faccia «legitima obligationed’annue £ 2.500» nei confronti dei Protettori di San Giorgio: questi, cioè,vogliono che sia garantito un gettito minimo della dogana, e di conseguenzaimpegnano il Comune a coprire l’eventuale minor introito. Condizione che ilConsiglio comunale si affretta ad accettare, tanto più che «molti cittadini etartisti [...] si sono offerti rilevare la città dal sudetto obligo per le somme checiascuno di loro s’è tassato»: sia l’amministrazione civica, sia i privati sono infat-ti convinti che il commercio crescerà, e con esso cresceranno tanto i profitti deimercanti quanto il gettito delle gabelle comunali21. La vicenda è per moltiaspetti illuminante: da un lato mostra la genuina sollecitudine di alcuni uomi-ni di governo per le sorti di Savona e la loro capacità di guardare all’interessegenerale della Repubblica; ma d’altro lato rivela la grettezza di tanti piccoli egoi-smi privati, nonché la meschinità di una finanza pubblica per la quale il desti-no di una città si gioca intorno a poche lire.
La meschinità, però, non sta da una parte sola: nel 1689, a soli tre anni dal-l’avvio della nuova e più favorevole tariffa doganale, sono gli Anziani savonesiche chiedono ai Protettori di San Giorgio di ristabilire quella vecchia. La richie-sta appare sorprendente e autolesionista, ma ha una sua ragion d’essere: gli sgra-vi fiscali hanno davvero incrementato i traffici di Savona («li mercadanti diPiemonte allettati dal puoco pagamento [...] tralasciavano di far passare le loromerci ne’ luoghi non soggetti al Serenissimo Dominio e le facevano condurrein detta città, come appare da’ libri di dogana»), ma all’inizio ciò è avvenuto
177
20 ASS, Comune I, 210, libro II, cc. 316-319.21 ASS, Comune I, 61, 12 e 31 luglio 1686.
Ostacoli e incentivi all’economia
molto gradualmente, quindi l’introito della dogana è stato inferiore a quelle£ 2.500 garantite e nessuno – né il Comune né i privati – vogliono accollarsi ilpagamento della differenza.
Quel che risulta dai documenti è che in tre anni Savona ha accumulato versoSan Giorgio un debito di £ 4.561; che il Comune ha chiesto una dilazione nelpagamento (o, per meglio dire, ha chiesto che i conti si facciano alla fine deicinque anni per cui deve durare la riduzione della tariffa) ma che i Protettorinon l’hanno concessa; e che l’agevolazione tariffaria viene revocata (il 31 agosto1689) proprio nel momento in cui si poteva sperare che cominciasse a dare isuoi frutti22. Si torna così al vecchio dazio di venti soldi a collo, di cui comun-que gli Anziani devono chiedere la proroga nel 169323, e che nel frattempo èstato abusivamente maggiorato «del carico del peaggio et altre gabellette, pesi etaggravi» che solo una legge del gennaio 1700 abolisce come arbitrari24. Ma ipiccoli soprusi non cessano, e sia nel 1703, sia nel 1714, i savonesi lamentanoche a Genova si sono tassati – cosa mai avvenuta in precedenza – alcuni carichidi canapa piemontese spediti a Livorno da un Filippo Filippone mercante diSavona: fatto grave, «essendo questa specie di mercanzia poco meno che l’uni-ca rimasta a noi fra quelle che calano di Piemonte», e perché l’arte dei filatoridi canapa «alimenta buon numero de poverelli» della città. Senza contare che,se non arrivano le canape, cessa «anche l’esito delle mercanzie [...] come ogli,merlucci, pesci, vacchette et altro che nel ritorno portavano i mulatieri inPiemonte»25.
Ben più preoccupante, però, è ciò che avviene a partire dal 1713, anno in cuila Repubblica conclude l’acquisto del Finale che, «chiudendo la falla più gravenella barriera genovese dalla parte del Piemonte, indusse a revocare i privilegi ele franchigie di cui godevano Savona ed altri scali del Ponente», con una parti-colare accelerazione a partire dal 172326. Così Savona torna a penare più diprima («la povera città resta totalmente spogliata dell’antico utile che aveva nellespeditioni»), anche perché al nuovo possedimento di Finale viene concessaqualche agevolazione doganale. Genova però non ne trae i vantaggi sperati: giànel 1718 e nel 1720 risulta che ora le merci prendono spesso un’altra via, quel-la della «nuova scala franca di Nizza», e più tardi anche quella di Oneglia, puressa resa franca dal re di Sardegna27. Nel 1729 una nuova legge di portofrancocancella definitivamente le convenzioni con gli approdi delle Riviere, sostituitida una regolamentazione uniforme: unici punti franchi – a parte la Dominante– restano, in concorrenza con Nizza e Oneglia a Ponente e con l’Avenza aLevante, gli scali di Ceriale e di Bocca di Magra. Ma ci si accorge presto chetutto ciò, mentre ha più che dimezzato il traffico di Savona, non ha avvantag-
178
22 ASS, Comune I, 214, 22 agosto, 31 agosto e 25 novembre 1689.23 ASS, Comune I, 143, 26 gennaio 1693.24 ASS, Comune I, 215, 25 gennaio 1700.25 ASS, Comune I, 143, 22 novembre 1703; ASS, Comune I, 211, 14 dicembre 1714. Solo il 2 settembre 1715
il Senato darà ragione a Savona, precisando che sono soggette al pagamento unicamente le canape pettinate.26 L. BULFERETTI-C. COSTANTINI, Industria e commercio in Liguria cit., p. 132.27 ASS, Comune I, 143, 28 marzo 1718 e 16 maggio 1720.
Capitolo 11
giato il portofranco genovese28. La legge resta nondimeno in vigore fino al1751, provocando una generale opposizione – e un conseguente, diffuso con-trabbando – tra i popoli delle Riviere e in particolare di Savona, e suscitandomalcontento anche tra la popolazione genovese, costretta a pagare più caremolte merci importate tramite l’emporio di Livorno.
Nel 1751, infine, San Giorgio compie una svolta di tipo liberista, ricono-scendo che l’antica politica discriminatoria nei confronti di Livorno non hafunzionato, e prendendo atto che non è possibile costringere i mercanti a por-tare le merci se non là dove trovano la maggiore convenienza. Ma è soprattuttoil governo della Repubblica a rendersi conto che ormai non può sostenere guer-re doganali con gli Stati vicini: la Francia, che ha potenziato lo scalo diMarsiglia; il Piemonte, che punta con sempre maggiore convinzione sul propriosbocco al mare di Nizza-Villafranca; e la stessa Toscana, che non è più il debo-le Stato mediceo, ma è entrata nell’ambito della grande potenza asburgica.Tuttavia il nuovo portofranco del 1751 non sposa fino in fondo il principiodella libertà di commercio, non lo estende cioè ai paesi del Dominio. Su que-sto punto Genova è diffidente, teme continuamente una flessione delle entratefiscali, stenta a comprendere che è cattiva politica abbandonare le comunitàsuddite al loro destino. In tali comunità i commerci e le manifatture hannopotuto sopravvivere solo se limitate a un ambito locale; le poche industrie ingrado di produrre per l’esportazione – come le ferriere, o le fabbriche di lateri-zi e terraglie così diffuse nel Savonese – non sono mai state tutelate dal gover-no. Si può certo parlare, a questo proposito, di egoismo; ma forse è più giustodenunciare la miopia e la grettezza di un ceto dirigente che, come quello geno-vese, è abituato a giudicare i meccanismi economici in base a considerazionipuramente fiscali, e quindi non riesce a compiere i passi decisivi per promuo-vere lo sviluppo del territorio statale nel suo complesso.
A partire dal 1769, tuttavia, qualcosa sembra cambiare: come abbiamo vistonel capitolo precedente, il timore per la concorrenza di Nizza spinge Genova ainteressarsi dello scalo savonese, sia pure con risultati modesti. A ben vedere,tutto si muove in un solco tradizionale: la preoccupazione di contrastare le ini-ziative del Savoia e la necessità di tutelare gli interessi della Camera, ma ancorpiù della Casa di San Giorgio, la quale sarebbe danneggiata da un eccessivo calodei flussi commerciali savonesi. In quegli stessi anni, tuttavia, il “problemaSavona” rappresenta, almeno per un attimo, anche un episodio significativonella breve stagione riformatrice genovese, e la cultura dei lumi vi fa capolinograzie alla presenza di qualche esponente del piccolo gruppo dei patrizi novato-ri.
Tutto comincia, come spesso accade a Genova, con un «biglietto di calice»
179
28 L. BULFERETTI-C. COSTANTINI, Industria e commercio in Liguria cit., pp. 137-138.
Ostacoli e incentivi all’economia
letto nella seduta del Minor Consiglio del 4 maggio 1772. Vi si denuncia unarealtà ben nota a tutti:
Savona, la prima città del Dominio dopo la capitale, è senza porto, senza popo-lo e vicina a soccombere della morte de’ Stati, se il governo non dà prontamenteaiuto alle sue estreme circostanze. Ella sarebbe il più serio oggetto di ogni altroprincipato, e noi l’osserveremo perire così indifferentemente? Signori Serenissimi,in questi casi ci vuole la più assidua applicazione di giunta straordinaria destinataa ciò solo, la quale intendendosela coll’Illustre Governatore di detta città esaminilo stato del male e ne suggerisca i possibili rimedi, altrimenti fra non molto avrà ilgoverno l’inutile rimorso di non avervi pensato in tempo29.
Le demolizioni del 1749 – sostiene l’anonimo – hanno aumentato «l’estremaspopolazione della città». Le poche famiglie di una certa importanza che vi sonorimaste si sono impoverite, oppure «non azzarderebbero a imprestare al com-mercio la minima somma, per quella diffidenza che non va mai scompagnatadal troppo vicino decadimento. Così la circolazione è ridotta al minimo segno,le gabelle vanno deteriorando un giorno più dell’altro, e durando di questopiede essa diverrà di molto aggravio alla Repubblica». Bisogna dunque «soste-nerla in ogni maniera possibile», perché la sua importanza è fuor di dubbio: «ilgolfo di Vado, la sua fortezza, la vicinanza a Stati esteri, tutto inspira di tener-ne conto, oltre li principii di decoro di principato, e di umanità e compassionedirimpetto a’ propri sudditi».
Il biglietto viene letto il giorno stesso nei Serenissimi Collegi, che deliberanodi trasmetterne copia al Governatore di Savona «con incarico di prender sulluogo le più esatte informazioni sul contenuto nel medesimo biglietto»; nelcontempo nominano una Deputazione composta da Nicolò De Mari, daFrancesco Maria Doria e dallo stesso Governatore di Savona. Quest’ultima cari-ca, dal 30 settembre 1771, è ricoperta da Giovanni Battista Grimaldi, perso-naggio che negli anni successivi si segnalerà come uno degli esponenti di spic-co dell’illuminismo genovese30. Il 5 maggio 1772 i Collegi comunicano appun-to al Grimaldi la sua nomina nella Deputazione e gli ordinano di assumere «lenecessarie cognizioni e lumi per formarne una precisa e distinta relazione».
Onde «porre rimedio a quella eccessiva spopolazione che è il primo male equello da cui tanti altri ne derivano per necessità ne’ paesi vuoti di gente»,Grimaldi deve esaminare «quali e quante sieno le arti vive in Savona attual-
180
29 ASG, Senato-Senarega, 315. I documenti citati di qui innanzi, salvo diversa indicazione, sono tratti daquesta filza.
30 Su Giambattista Grimaldi (1740-1805), figlio di Pierfrancesco che sarà Doge nel 1773, e sulla sua atti-vità come intellettuale riformatore si veda: S. ROTTA, Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione delpensiero di Montesquieu, «Il movimento operaio e socialista in Liguria», VII, 1961, pp. 205-284 (in partic. pp.245-248); M. CALEGARI, La Società patria delle arti e delle manifatture. Iniziativa imprenditoriale e rinnovamentotecnologico nel riformismo genovese del Settecento, Firenze, Giunti, 1969, pp. 13-25 e passim; S. ROTTA,L’illuminismo a Genova: lettere di P. P. Celesia a F. Galiani, tomo II, «Miscellanea storica ligure», V, 1973, pp.135, 154-160, 266-269. Sul suo ruolo negli ultimi anni del governo aristocratico numerose indicazioni si tro-vano in C. BITOSSI, «La Repubblica è vecchia» cit., ad indicem.
Capitolo 11
mente esistenti, che capitale vi s’impieghi, quante braccia vi lavorino giornal-mente»; e passare poi «a riflettere quali nuovi mezzi d’industria si potessero sta-bilire in cotesta città per dare comoda sussistenza a quelle persone che riuscisseivi chiamare dal superfluo di altri paesi delle nostre Riviere e Dominio, eccet-tuata la Capitale, per mezzo di quelli vantaggi che gli dovessero essere propostia norma di quanto viene praticato da’ savi governi in simili disgustose circo-stanze».
Il costo de’ generi di prima necessità, il fitto delle abitazioni di gente da travaglio,il corrente prezzo de’ salari delle manifatture vi faranno formare una idea di quellaqualità e grado d’industria a cui si possa condurre la città di Savona. La fertilità delterritorio e la posizione al mare sono le due cagioni del poco caro e comodo ap-provisionamento di vittovaglie; e questo conduce in massima parte a quel costantebuon mercato, che non solo mette in concorrenza, ma fa ordinariamente preferirela mercanzia di quel paese, ove si accorda. In questi casi non è superfluo gettare uncolpo d’occhio sopra l’indole degli abitanti, per conoscere a qual sorta di travaglioindustrioso sieno più portati o disposti; benché per altro gli uomini si pieghinocostantemente a fare tutto ciò che loro procura la più comoda sussistenza.
Si percepisce in queste istruzioni un leggero soffio d’aria nuova, un interes-samento più caldo del solito per la «pubblica felicità» e per il progresso econo-mico, benché subito temperato da alcune vecchie riserve: l’apprensione, comes’è visto, che le provvidenze per Savona possano attirarvi gente dallaDominante, la cui popolazione invece non deve essere per nulla diminuita; o iltimore di mettere in discussione il sistema fiscale vigente. Il Senato raccoman-da infatti che, almeno per il momento, Grimaldi non si occupi affatto di even-tuali modifiche alle tariffe doganali, materia che «esigerebbe una maggioreestensione di viste, ed avendo connessione con altri rapporti riuscirebbe in ognievento di troppo dubbia esecuzione». E neppure deve occuparsi del «sostanzia-lissimo articolo del porto, […] essendo un tale oggetto già preventivamentecommesso ad altra Eccellentissima Deputazione». Bisogna invece indagare se«l’estremo decadimento delle gabelle» dipende unicamente dal calo di popola-zione, o anche da «vizi particolari di amministrazione municipale»; e se la «diffi-denza degl’imprestatori di denari per commercio» deriva solo da mancanza difiducia, o se proviene «dalla estrema povertà delle classi rispettive degli abitan-ti».
Il 10 agosto 1772 – tornato a Genova alla scadenza del suo incarico diGovernatore – Grimaldi presenta ai colleghi della Deputazione un Saggio direlazione sopra lo stato attuale della città di Savona, con alcuni suggerimenti diret-ti ad arrestarne la decadenza31: è un’analisi attenta, ricca di dati che fino ad allo-ra nessuno s’era preoccupato di rilevare, e un interessante abbozzo di program-
181
31 Il Saggio è pubblicato in appendice a G. ASSERETO, La Repubblica e le riforme. Genova e Savona nella secon-da metà del Settecento, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXII, 2002, pp. 325-362 (in parti-colare pp. 343-362).
Ostacoli e incentivi all’economia
Capitolo 11
ma per la rinascita economica di quella comunità, le cui cattive condizioni –«una città ormai vicina a perdersi» – vengono pienamente confermate. Gli abi-tanti sono soltanto 6.455, compresi quelli dei borghi suburbani. Ci sono anco-ra 41 «arti», la maggior parte però ridotte a poche unità di maestri e lavoranti.Le sole che presentano un interesse effettivo sono le fabbriche di ancore, quel-le di calze di lana e l’arte «de’ figoli o pignattari», di cui vivono le borgate delleFornaci e di Zinola. La prima merita «protezione a ragione della sua singolaritàin tutta l’Italia, e le altre due perché impiegano la più povera gente ed un mag-gior numero di persone». C’è poi il carenaggio dei bastimenti, molto redditiziovisto che i soli naviganti di Spotorno vi spendono ogni anno circa 30.000 lire,onde è facile immaginare «qual somma vi lascino gli altri bastimenti nazionalied esteri».
Per il resto è crisi, con una parziale eccezione per le botteghe e i mestieri lega-ti all’attività marittima, la cui sorte dipende però interamente dalle condizionidel porto. La marineria si trova «dispersa pel mondo massimamente dopo lademolizione del borgo del Molo, per cui tante famiglie si espatriarono». In cittànon restano che vecchi e ragazzi, e ci sono soltanto dieci imbarcazioni. I prezzidei generi di prima necessità non sono particolarmente vantaggiosi, i comme-stibili costano all’incirca come a Genova. «La ragione è chiara, quasi tutto siricava da paesi esteri, […] e venendo i viveri a misura del consumo giornale,mai si prova l’abbondanza, alla quale si oppone per ultimo l’estrazione de’medesimi per la provvista de’ paesi di Riviera, il che finisce di rialzare i prezzi».In compenso anche i salari sono poco al di sotto di quelli della capitale, il chepuò piacere ai lavoranti, ma non è certo un incentivo per impiantare nuovemanifatture. «A vilissimo prezzo» sono invece gli affitti delle case, effetto evi-dente dello spopolamento e del pessimo stato in cui sono tenute le abitazionipopolari.
Il panorama cambia, però, appena fuori delle mura cittadine. «Il territorio diSavona è così ben coltivato ed è di tale estensione, che all’amenità sua unisce ilpreggio di dare la sussistenza a quelli cittadini meglio assai che l’industria ed ilcommercio, sebbene una gran parte sia trapassata in mano di signori genovesi edi manimorte». Fatto, quest’ultimo, di cui Grimaldi non può tacere gli effettinegativi sulle finanze locali, perché quei proprietari – come sappiamo – hannosempre preteso di non pagare le «avarie personali e reali, […] in luogo dellequali preferirono in ogni tempo nuove gabelle o addizioni alle antiche per lespese della città e per i tributi camerali».
I prodotti principali sono il vino (30.000 mezzarole – cioè 47.700 ettolitri –in «quel tratto di paese che giace fra il capo di Albisola e quello di Vado»), lafrutta, la seta (la cui abbondanza è testimoniata dalla moltitudine dei gelsi) einfine gli ortaggi, che ogni giorno partono in gran quantità per il Piemonte. Lacampagna savonese è però «ancora lungi dall’eguagliare la perfezione dellaPolcevera e del Bisagno», anche perché «sarebbe desiderabile si mantenesse unamaggior quantità di bestiame per ricavarne il concime in abbondanza e dimi-nuire il consumo dei butirri e delle carni che si ricevono dal Piemonte». C’è poilegname a volontà, ma se ne esporta molto e se ne fa un fortissimo consumo
182
Ostacoli e incentivi all’economia
nelle ferriere e nelle fornaci, tanto che c’è da temere la devastazione dei boschi,mentre «il rincarimento delle fascine, che in oggi si pagano il doppio della pre-scritta meta, produce quello della calcina, mattoni, stovigliami etc., che sonopure la branca principale del commercio attivo di Savona».
Fin qui la breve descrizione delle condizioni economiche del paese, cuiGrimaldi fa seguire una serie di interessanti considerazioni sui possibili inter-venti e sulle innovazioni auspicabili. La prima indicazione, tuttavia, apparepiuttosto curiosa, poiché si appunta sull’indole degli abitanti e sul fatto che inessi più non si trova «quello spirito d’industria, di frugalità, di amore al trava-glio che è il proprio carattere de’ genovesi, siccome di tutti i popoli commer-cianti». Il lusso – nientemeno! – «si è andato dilatando nel popolo, malgrado loscemamento delle ricchezze in tutti gli ordini di persone, e insieme a lui è cre-sciuta la pigrizia e la crapola». I lavoranti, «guadagnato uno scudo, più non vo-gliono travagliare fino a che non lo abbiano consunto all’osteria»: osti e taver-nari sono gli unici a far fortuna. Il Governatore non ha dubbi circa le cause diquesto malcostume:
Credo senza ingannarmi di potere attribuire alla quantità dell’elemosine l’indif-ferenza di quel popolo al proprio vantaggio e la poca previdenza sull’avvenire. […]Non dicesi apertamente da tutti che l’Opera della Madonna gli riceverà in vec-chiaia, l’Ospitale di San Paolo quando saranno malati, e la Dispensa Niella prov-vederà la dote alle loro figlie? Che largo campo di riflessioni e di provvedimenti!
Il taglio del discorso appare fastidiosamente moralistico, eppure Grimaldi stafacendo qui i primi approcci a un problema – quello relativo alla lotta control’accattonaggio – che negli anni seguenti lo impegnerà a lungo, portandolo acontatto con la più moderna cultura economica europea. Il suo Ragionamentoteorico-pratico sopra le cagioni, gli abusi e i rimedi della mendicità, presentato nel1783 ai Sindaci dell’Ufficio dei poveri di Genova, susciterà negli ambienti rifor-matori genovesi dibattiti ampi e di notevole livello culturale: un testo profondoe radicale, che tuttavia finisce per proporre – come gran parte della trattatisticaprodotta in questo campo nell’età dei lumi – una sola misura veramente prati-cabile nell’immediato, vale a dire la chiusura o il drastico ridimensionamentodelle opere pie tradizionali, da sostituire con istituzioni repressive come le casedi lavoro forzato. Anche nella memoria savonese del 1772 compare infatti laproposta di «una casa di correzione per quelli che ricusano di travagliare», tantonecessaria «in un paese dalle elemosine reso infingardo» e rapidamente realizza-bile con locali e risorse dell’ospizio di Nostra Signora della Misericordia, in atte-sa di destinarvi i beni derivanti dalla «suppressione di qualche casa religiosa,imitando l’esempio di qualche principe italiano».
Quanto al ricettario per far rifiorire l’economia della città, esso si apre conalcune considerazioni circa la situazione finanziaria, che riecheggiano aspetti giàincontrati nei capitoli precedenti: un bilancio comunale modesto (pareggiaintorno a 34.600 lire) quasi tutto assorbito dai tributi camerali e dall’onorario
183
Capitolo 11
del Governatore e della sua «famiglia»; un deficit cronico di quasi 1.300 lireall’anno; entrate che procedono quasi esclusivamente da gabelle «sopra i com-mestibili più necessari», riscosse da appaltatori privati; un consistente debito divecchia data, sul quale però non si riesce neppure a pagare gli interessi dovuti ai«luogatari»; un’estrema «facilità di commettere le frodi», grazie anche alla con-nivenza delle famiglie privilegiate, prime fra tutte quelle dei patrizi genovesi chesono i maggiori proprietari terrieri del circondario savonese; una gestione dellegabelle alquanto misteriosa e certamente difettosa, anche per le complicità fraappaltatori e amministratori civici. A tutto ciò Grimaldi non sa proporre altrorimedio che «la riunione di tutte le gabelle in una sola compagnia di gabellot-ti», suggerimento assai poco sagace in un’epoca in cui le «ferme generali» hannogià fatto le loro prove in Lombardia e in Toscana, e sono state accantonate dallapolitica dei riformatori asburgici.
Quanto alla «vera origine della poca circolazione di denaro» e alla scarsa pro-pensione agli investimenti, tutto pare dipendere da un misto di diffidenza emiseria. «Una provincia che non ricupera nel traffico tanto da pareggiare ildenaro che ne esce, non può a meno che restarne esaurita in breve»: quel pocoche ne rimane non si indirizza certo con facilità verso gli impieghi a rischio,come i moribondi trasporti marittimi. Così si assiste allo strano caso di una cittàche, pur avendo il vantaggio di un porto, finisce per «cederla a piccoli borghiper l’industria e la navigazione, e impoverire quando quelli arricchiscono».Spotorno, Albisola e Celle nel giro di pochi anni hanno messo insieme unamodesta ma agguerrita flotta mercantile; gli spotornini trasportano vini dallaSpagna e dal Regno di Napoli; gli albisolesi e i cellesi «vanno lungi per esitarela loro terraglia e provvedersi dei generi necessari al loro negozio». Indolenza deisavonesi? Forse, ma qualcosa deve pur dipendere – Grimaldi non può scacciarequesto sospetto – dal fatto che «con nuove leggi della dogana fu inceppato eristretto il commercio»: perché ai buoni affari dei paesi rivieraschi non è certoestranea la facilità del contrabbando, che «all’opposto in Savona si rende senzaparagone ben più difficile».
Fatta questa diagnosi, ci si potrebbe attendere che Grimaldi proponga unaterapia liberista, ma i suoi suggerimenti vanno in direzione diversa. Anzitutto,proprio dopo aver ricordato il fiorente commercio di quei paesi rivieraschi chenon dispongono di alcuna attrezzatura portuale, egli mostra di condividerequella che è allora la preoccupazione principale del governo riguardo a Savona;pensa cioè al restauro del porto, quindi alla necessità di reperire fondi per ese-guirvi costosi lavori straordinari e manutenzioni ordinarie. Escogita perciò unaserie di complicate alchimie finanziarie per rinvenire almeno 12.000 lire all’an-no: somma modesta in sé, ma ragguardevole per un bilancio asfittico comequello di Savona e tale da impoverire ulteriormente la città prima che gli even-tuali benefici del porto possano compensare quel salasso.
A parte questo, il piano del Governatore – nonostante le raccomandazionidel Senato – parte proprio da una manovra fiscale che mira a favorire la princi-pale produzione locale, vale a dire il vino. Occorre «togliere la concorrenza deivini […] forestieri, i quali sebbene chiamati in Savona vini proibiti, e come tali
184
Ostacoli e incentivi all’economia
soggetti a un leggerissimo dazio, si esitano nonostante per più di lire cento millaall’anno». A tal fine si deve «riaggravare la gabella ai vini navigati e a quelli diMonferrato», e nel contempo «altretanto diminuire l’imposizione sopra i vininostrali», oltre a prevedere un rigoroso censimento della produzione locale perdecidere d’autorità «quanto si debba lasciare da ciascuno nelle cantine per l’ap-provisionamento del paese» e quanto invece si possa esportare. La macchinositàdella procedura è evidente, la sua efficacia estremamente dubbia. Lo stesso, opeggio, può dirsi per le misure proposte a salvaguardia di un’altra importantericchezza locale, cioè i boschi. Qui la soluzione prospettata è il divieto di«imbarcare per riviera legna e fascine»; ma è un divieto che già esiste da secoli– ovviamente disatteso, perché il gran consumo delle molte fornaci rende assaiconvenienti quei traffici – e non si capisce come si speri di farlo rispettare.D’altronde tante importanti “manifatture del fuoco”, a cominciare dalle fabbri-che di terraglie savonesi e albisolesi, non possono certo fare a meno del com-bustibile.
Passando alle manifatture, Grimaldi stima «desiderabile se ne introducesserodelle nuove, mediante quelle esenzioni e privileggi [che] stimasse il Principe diaccordare a coloro venissero a stabilirsi in Savona». Ma aggiunge che «taliallettamenti dovrebbero proporsi a quelli che sciegliessero il loro domicilio incittà, non ne’ sobborghi», in quanto «non v’ha dubbio che i borghesi si profit-tano grandemente nelle frodi e in esentarsi dalle gabelle della città»: singolarecontraddizione di chi auspica franchigie fiscali e teme nel contempo elusionitributarie, senza tener conto tra l’altro che la dislocazione delle manifatturefuori dei centri urbani è da tempo un fenomeno irreversibile, ben noto ancheal Genovesato. Resta il fatto che, «per sollievo delle arti già esistenti», iProtettori di San Giorgio negli anni addietro hanno in effetti soppresso alcuneimposte sulla fabbricazione di ancore, maioliche, seggiole di paglia e altro, maquesto non è bastato «a far respirare la città». Altre manifatture, per esempioquelle delle calze di lana e dei berretti, che occupano «quantità di poverissimagente, e per lo passato ànno apportato grandissimo lucro», sono in crisi perchéil prezzo dei loro prodotti non è più concorrenziale. Anche in questo campooccorre, secondo Grimaldi, una manovra fiscale: intervenga la Casa di SanGiorgio, «inalzando in dogana l’imposizione sopra le calze di Roma e gratifi-cando l’esportazione per fuori Dominio, ad esempio dell’Inghilterra e dellaPrussia, a proporzione della gabella [che] si paga per introdurre le lane». Forsesarebbe più semplice abolirla, quest’ultima gabella, ma ciò potrebbe ledere gliinteressi di San Giorgio.
Il Governatore mostra poi di fare gran conto su altre possibili innovazioni.Una, «a cautelare la buona fede fra’ mercanti», consiste nell’introdurre nella giu-risdizione savonese la pratica della «insinuazione», cioè la registrazione degli attie dei contratti in un apposito libro pubblico: pratica mai adottata a Genova, chetuttavia egli, non si capisce perché, ritiene adatta «in una città ove il traffico èridotto a nulla», anzi capace da sé sola di «rendere alla circolazione le somme da’facoltosi impiegate nelle banche de’ principi». Un’altra è l’apertura della giàmenzionata casa di lavoro coatto, misura davvero provvidenziale in una città
185
Capitolo 11
dove la disoccupazione è forte! Un’altra ancora riguarda l’opportunità – consi-derando Savona «siccome la piazza d’armi principale dello Stato» – di «desti-narvi quel maggior numero di soldati ed ufficiali che si potesse», ivi compresi igiubilati «concedendo loro di poter scuodere colà le loro pensioni, senz’ob-bligarli di venire ogni volta a Genova»: un espediente per accrescere un poco lapopolazione e la circolazione del denaro, non si sa però quanto gradito agli abi-tanti di Savona, per i quali la presenza della fortezza e della sua guarnigione nonè davvero un motivo di gioia.
Migliori senza dubbio altri intenti di Grimaldi, come quello di stabilire cheogni anno due galee vadano a svernare nel porto di Savona «perché le ciurmefossero impiegate a’ lavori ed escavazione delle arene»; o quello di costruire unastrada carrozzabile da Voltri ad Albisola:
Sono evidenti i vantaggi di questa nuova strada: maggiore concorso al Santuario,passaggio di forestieri che vanno o ritornano di Francia, allettamento a quelli chevengono a veder Genova di portarsi a visitare il Santuario, le ville di Albisuola, ilgolfo di Vado, cose tutte da trattenere un paio di giorni. L’amenità del territorio ela facilità del viaggio inviterebbe i nobili genovesi ad acquistare delle tenute e casi-ni di campagna per passarvi l’autunno. Quanto denaro non si sparge egli mai tuttigli anni in Nove per essere quella la villeggiatura di moda. Se nel settembre lo dive-nisse quella di Savona, che grandioso profitto!
Il progetto è già stato avanzato in passato e accantonato per mancanza didenaro, ma il Governatore ritiene di aver trovato la soluzione. Presenta «estimie calcoli apposti con tutta esatezza» da cui risulta «che questo lavoro importe-rebbe £ 301.400, dalla qual somma dedotta la spesa di £ 126.000 per setteponti rimane ridotta a sole £ 175.400», ricavabili con i soliti espedienti chel’amministrazione genovese usa in questi casi (e che già ha adottato per i lavoridel porto di Savona), vale a dire l’impiego di legati pii che giacciono più o menoinoperosi e che possono essere temporaneamente stornati per finanziare operedi pubblica utilità. In realtà è un’altra alchimia di dubbia riuscita, un raschiareil fondo del barile che comunque – nella migliore delle ipotesi – partorirebbe labella realizzazione di una strada senza ponti, perché quelli si dà per scontato checostino troppo e non si possano costruire.
Un’ultima proposta è l’adozione «del proggetto promosso dal signor GianBattista Bozello negoziante di tutta capacità, quale è diretto a riunire in com-pagnia tutti i bastimenti, interessando nella medesima tutti coloro volesseropartecipare colle loro azioni», cosa da cui la navigazione savonese potrebbe trar-re «un incredibile incremento». Ma a dire il vero il Bosello, in una memoria giàpresentata ai Protettori di San Giorgio che Grimaldi allega alla propria relazio-ne, ha semmai insistito su altri strumenti indispensabili per rianimare il com-mercio marittimo e terrestre: alleggerire il regime daziario sulla strada verso ilPiemonte e soprattutto rendere pienamente operante il punto franco di Savona,anche nell’interesse della Camera e della stessa Casa di San Giorgio, che viriscuotono le gabelle del grano, vino, riso, vena, grascia, polvere, tabacco,
186
acquavite, carte e carta bollata, «presentemente ridotte a nulla». Con un beninteso regime di portofranco, invece, il gettito di quelle gabelle potrebbeaumentare, e insieme si otterrebbe il risultato «d’avere ravivata una città, chesenza il richiesto opportuno sussidio si vede assolutamente perduta».Argomentazioni, queste, della cui esattezza il Governatore è costretto a prende-re atto, riconoscendo – ancora una volta! – che certe restrizioni sono servite sol-tanto a favorire Nizza, «dalla nostra negligenza ingrandita e dal timore non fon-dato di recar nocumento al nostro scalo di San Lazaro», nel porto dellaDominante.
Un’istanza moderatamente liberista Grimaldi finisce comunque per avanzar-la in forma esplicita relativamente al commercio dei grani. Inutile sperare di«mantenere l’industria, se la mercede dei manifatturieri non è a prezzi discreti»,e ciò dipende da quelli dei viveri, primo fra tutti il grano, «la di cui abbondan-za quasi mai si conosce in Savona», perché «il più delle volte sono chiuse inPiemonte le tratte» e perché «i grani di marina si commettono dai mercanti apoco a poco e il paese non è mai provvisto». Perciò il cosiddetto «pan venale» aSavona si vende «di minor peso che in Genova», dove pure la gabella è doppia.Esiste in città un Ufficio di Abbondanza, che però secondo Grimaldi ad altronon serve che a mantenere i prezzi alti. Basterebbe invece che fosse permesso illibero magazzinaggio dei grani: «dico permesso, non già perché vietato espressa-mente, ma perché il grano in Savona è soggetto a pagare la gabella egualmentequando sbarca come allorché si rimbarca, motivo per cui non può esservi unemporio di grani. Cosa strana opposta alla legge di San Giorgio, eppure prati-cata in un paese ove le sole leggi debbono commandare».
Tolta questa aberrazione, i mercanti savonesi si potrebbero dedicare a queltraffico di grani che ora prospera a Loano e in altri paesi «immuni» della Rivieradi Ponente. Grimaldi per il momento non aggiunge altro, ma l’osservazionediretta del caso savonese è destinata a rafforzare certe idee che proprio allora vameditando su un piano più generale, relativo all’intera organizzazione genove-se. Il 17 marzo 1773, dopo aver letto i Dialogues sur le commerce des bleds, eglisi rivolgerà Ferdinando Galiani, autore di quell’esemplare libretto, chiedendo-gli «un consulto super re frumentaria» e ottenendolo sotto forma di alcune inte-ressanti considerazioni, nelle quali l’economista napoletano mena robusti colpisul sistema annonario di Genova: la Repubblica, che riceve da fuori Stato qua-si tutto il grano, può e deve avere un commercio esterno e interno «pienamen-te libero», dotandosi tutt’al più – per le emergenze di una pestilenza e di unassedio, o per esercitare una funzione calmieratrice – di un semplice «magazzi-no di precauzione»32. Un parere, questo, che naturalmente piacerà al Grimaldi,come pure al corrispondente genovese di Galiani, Pietro Paolo Celesia, secon-do il quale l’annona della Superba «è carica di debiti e reca tenuissimo e pas-
187
32 S. ROTTA, L’illuminismo a Genova cit., pp. 154-159 e 266-267. Per lo scritto inviato dal Galiani a G. B.Grimaldi si veda F. GALIANI, Considerazioni sul sistema annonario di Genova a cura di L. DAL PANE,Bagnacavallo, Società Tipografica Editrice, 1935.
Ostacoli e incentivi all’economia
seggero sollievo alla penuria pubblica».Tornando alla relazione grimaldiana, essa si conclude con l’auspicio che i
mezzi proposti, unitamente ad altri che certo non possono «isfuggire all’accor-to discernimento dell’Eccellentissima Deputazione», facciano risorgere unacittà «che più d’ogni altra dà splendore e proffitto alla Dominante». L’aumento«di popolo, d’industria, di ricchezze» migliorerà le finanze di quel comune,ponendolo in grado di avviare l’estinzione del proprio debito che ammonta apiù di un milione; e questo fine può essere raggiunto solo a patto che in futu-ro ogni spesa straordinaria venga subordinata all’assenso «del deputato per i luo-gatari», cioè da chi rappresenta gli interessi dei creditori del Comune. È l’ulti-ma contraddizione di uno scritto che già ne contiene parecchie: perché blocca-re le spese in nome degli interessi dei detentori di «luoghi» del debito comuna-le equivale a favorire gli interessi parassitari a detrimento di eventuali progettidi sviluppo. Ma va subito aggiunto che queste contraddizioni non sono tantodel Grimaldi (il quale pure paga il prezzo di una relativa inesperienza, e si rive-lerà più accorto quindici anni dopo, al tempo di un suo incarico come com-missario straordinario a Porto Maurizio33), quanto del sistema politico,amministrativo e fiscale nel quale egli si trova ad operare. Sono le ristrettezze diun bilancio pubblico che non si vuole modificare, gli interessi intangibili di SanGiorgio, i privilegi fiscali del patriziato locale e quelli economici dellaDominante a rendere inconseguenti molte proposte che l’allora Governatore diSavona avanza con entusiasmo e con genuino compatimento per i mali dellacittà. Dalle sue diagnosi, come s’è detto, scaturiscono istanze liberiste chepotrebbero forse sanare alcuni di quei mali, ma che poi si scontrano con il siste-ma tributario vigente. Nel contempo ogni progetto che punti invece sull’inter-vento dello Stato per realizzare sia pur modeste infrastrutture viene vanificatodalla mancanza di fondi.
Tutto questo risulta con una certa chiarezza da un’altra relazione cheGrimaldi presenta di lì a poco, in ottemperanza a un decreto del Senato che loincarica di riferire circa i mezzi da lui accennati per «assicurare la conservazio-ne del porto». È un documento che contiene l’elenco di cespiti miserabili einsufficienti, unitamente a una raffica di espedienti finanziari assai improbabi-li: i soliti storni di lasciti pii, «doni gratuiti» da parte di ecclesiastici, ritocchi digabelle, perfino le multe inflitte ai patrizi che rifiutino la carica di Commissarionella fortezza del Priamàr. Ma è difficile arrivare lontano con questi mezzucci,e infatti il 23 aprile 1773 viene letto nei Collegi un biglietto di calice dove sichiede che diavolo abbiano concluso le due Deputazioni nominate per Savona,una per il porto (composta da Marcello Durazzo e Francesco Gaetano Doria) el’altra, che già conosciamo, «per alcuni articoli vantaggiosi a quella città».
188
33 ASG, Manoscritti, 774; M. CALEGARI, La Società patria cit., pp. 15-16.
Capitolo 11
Ostacoli e incentivi all’economia
La risposta della seconda Deputazione è disarmante:
Qualonque fossero per essere le varie divise che l’Eccellentissima e MagnificaDeputazione stimasse sottoporre a riflessi de’ Serenissimi Collegi, tutte suppongo-no una città marittima, il di cui porto sia di uno stabile accesso e non più sogget-to a quella vicenda di riempimento che in una stagione più che in un’altra lo ren-dono di abordo impraticabile.
Insomma, non è possibile risollevare la città senza restituirle un vero porto,ma quel porto è impossibile mantenerlo in funzione se la città non ha fondiadeguati da impiegarvi ogni anno, cioè se non è già risollevata: «Se la mancan-za delle somme ulteriormente necessarie ad assicurare per sempre l’accesso nelporto de’ bastimenti commercianti non fosse per mettere il SerenissimoGoverno nella certezza di vedere stabilmente conseguito un simile oggetto, ognialtro pensiero sarebbe inutile, come che mancante della sua base». Il circolovizioso – che già abbiamo rilevato nel capitolo precedente – non potrebbe esse-re espresso con parole più chiare; ma si può aggiungere che questo è il risultatodi una politica che non è in grado né di intervenire concretamente a favore diuna città soggetta, né di abbandonarla del tutto a se stessa e di lasciare che conle sue sole forze, senza intralcio di regolamenti, dazi e gabelle, provi a trarsi fuoridalla stagnazione.
Poco tempo dopo Francesco Maria Doria, membro della suddettaDeputazione e divenuto a sua volta nell’autunno del 1773 Governatore diSavona, stende una relazione che serve a chiarirci ulteriormente la questione.Circa le proposte che il suo predecessore e collega Grimaldi ha avanzato inmateria di commercio dei grani è categorico:
L’accordare a’ Savonesi il beneficio del portofranco per i grani, oltre i monopolia’ quali potrebbe dar maggior adito, dovrìa dipendere dai Consegli della Repubblicae delle Compere di San Giorgio, essendovi legge che restringe tal benefizio alla solacapitale. Non è poi sperabile che gli appaltatori di detta gabella vi dassero mai l’as-senso attesa la maggior facilità delle frodi che ne deriverebbero. Deve in oltre ri-flettersi al pregiudizio che risulterebbe alla capitale dal farsi in Savona un emporiodi grani, che sarebbe atto a facilitare i raggiri de’ negozianti in un tempo in cui leloro speculazioni si sono raffinate a segno di assicurarsi profitti eccessivi e perpetua-re in tal guisa la carestia d’un genere sì necessario all’umano sostentamento.
Quanto a un altro progetto scaturito in seguito dalla mente feconda dellostesso Grimaldi, riguardante la produzione di trame di seta, egli non ha nulla incontrario. Ma la seta greggia deve arrivare da Genova, e «non vi troverebbero imercadanti il loro conto, attesa la spesa del nolo sì di andata che di ritorno, chene accrescerebbe il prezzo». La soluzione consiste nel «libero traffico di dettesete» e nella «libera loro estrazione pe’ paesi esteri ridotte in trame».
189
Ma non è mai sperabile che la Casa di San Giorgio si presti all’accordare di pote-re sbarcare in dirittura in Savona le sete, ed imbarcarvisi le stesse ridotte in tramepe’ paesi esteri, essendo ciò troppo contrario alle sue regole e leggi, e troppo facilea pregiudicarne i diritti. È in oltre da riflettere, se convenga dilatar cotanto l’artesuddetta delle trame, che facilmente potrebbe comunicarsi a paesi finitimi e farmancare non solo alle maestre di Polcevera il lavoro che alimenta tante di quellefamiglie, ma diminuire ancora il commercio ed estrazione che di esse si fa da que-sta capitale, e l’introito non leggiero che ne ricava la Casa di San Giorgio34.
Anche in questo caso, non si potrebbe spiegare meglio la logica in base allaquale i Savonesi devono mettersi il cuore in pace. E proprio perché non nutro-no le stesse illusioni di Grimaldi, gli amministratori di Savona hanno presenta-to in quel torno di tempo un altro progetto, firmato dal celebre ingegnereGiacomo Brusco: si tratta di realizzare «ne’ siti arenili del riempimento delporto» – mediante il lascito del concittadino Girolamo Sacco – una «piantag-gione d’alberi a viali da passeggio» e una «muraglia di riparo nel gioco del bal-lone, con altri lavori fatti a ferro di cavallo per li sedili», il tutto per rendere quelluogo «più ameno e più comodo al passeggio de’ cittadini». Ma il Governatore,sentito il parere degli ingegneri militari Policardi e Codeviola, boccia anchequeste opere in quanto «pregiudiziali alla fortezza», facendo per di più un po’di moralismo circa «la deformità ed irragionevolezza di pensare oggidì ad impie-gare in tali oggetti le somme da ricavarsi dall’opera Sacca, quando più utilmen-te potrebbero […] spendersi nel prolungamento del molo e nello spacciamen-to di quel porto.
Un suo ruolo in questa vicenda ce l’ha anche il terzo membro dellaDeputazione, Nicolò De Mari, pure lui un esponente del movimento riforma-tore genovese, anzi una sorta di coscienza critica del governo35. Il 28 giugno1773 stende un «ricordo» dal titolo Alcuni capi di commercio quali potrebberoaversi presenti per dar qualche risorsa a quello della città di Savona. Vi si suggeri-sce anzitutto di concedere alla città «l’ius esclusivo della raffinatura del zucca-ro»: fabbriche del genere – ma piuttosto scadenti – sono state introdotte aVenezia e a Trieste, e per la maggior parte si approvvigionano in Genova di zuc-cheri d’infima qualità provenienti da Lisbona. Perché dunque non impiantarneuna nel Serenissimo Dominio? Certo bisogna migliorare la qualità, raffinare glizuccheri «all’uso di quelli d’Olanda», ma questo non è un problema perché«assai facilmente potrebbero da colà aversi delle persone pratiche di tal arte,giacché può ivi ogni professore trasportarsi a suo piacimento in altri paesi,essendovi per legge fondamentale una pienissima libertà». Perché mai questi«professori» debbano avere voglia di trasferirsi a Savona, e chi sia disposto amettere i propri capitali in questa intrapresa, l’illustre riformatore non lo dice.
190
34 La quale Casa di San Giorgio, secondo quanto riferisce il Governatore Doria, ha invece accordato una«minorazione de’ dritti sopra vari generi di merci», ma in un ben congegnato gioco delle parti è stato il CollegioCamerale ad opporsi.
35 M. CALEGARI, La Società patria cit., pp. 25-26; C. BITOSSI, «La Repubblica è vecchia» cit., pp. 110-120,457-482 e passim.
Capitolo 11
Ostacoli e incentivi all’economia
Consiglia poi «di stabilire una compagnia di pescatori nell’isola di Capraia,con la condizione et obbligo di dover portare tutti li pesci a vendere in questanostra città». In Inghilterra e nei Paesi Bassi si pesca a distanze ancora maggio-ri, e i pesci arrivano vivi a terra perché al centro dei pescherecci viene «costrut-to un vivaio dov’entra e ne può sortire l’acqua salata, ed ivi ripongono i pesciper indi portarli a terra fatto che n’abbiano buona provvista». Basta dunque «farfabbricare o due o quattro di simili bastimenti muniti delli necessari attrazzi perfar la pesca come si pratica in dette parti», e magari «tener nell’isola competen-te provvista d’olio e d’aceto con delle cucine adattate per potervi friggere i pescie marinarli», e così conservati «mandarli qui ad esitare dov’averebbero prontoconsumo anche ridotti a tal qualità non solamente per il paese che per le vici-ne provincie di Lombardia e Piemonte». Di nuovo, il De Mari non stimaopportuno occuparsi del modo in cui reperire i capitali.
Capitali ne occorrerebbero anche per le fabbriche di terraglie, onde «mante-nere i lor magazzeni meglio assortiti» e incrementare le vendite, ma il patriziogenovese non sa proporre altra soluzione che quella – da lui stesso giudicatapoco praticabile – di prendere a cambio qualche somma «a carico comunale».In compenso non costerebbe nulla «l’introduzione d’una accademia di agricol-tura» che produrrebbe «beneficio considerabile alla città e territorio di Savona».In particolare si potrebbe promuovere la coltura degli ulivi («sa ciascuno quan-to gli ulivi apportino di reddito in questi tempi alla Riviera di Ponente, massi-me nelle campagne situate al di là di Savona») e dei fichi («egli è notorio il gran-dioso commercio che se ne fa annualmente in questa città di Genova, ove gion-gono da Napoli numerosi bastimenti carichi di tali frutti secchi, venendo poiqui comprati per inviarli in Amburgo et in diverse parti della Germania»); men-tre della viticoltura, che tanto stava a cuore a Grimaldi, non si parla affatto.Resta da chiedersi perché l’olivicoltura prosperi nel Ponente senza alcuna acca-demia, perché qui invece l’accademia sia giudicata necessaria, e da dove questapossa trarre forza e lumi.
Questi i suggerimenti principali, ma De Mari ne aggiunge ancora un paio «asolo riflesso di nulla omettere», e sono davvero sconcertanti. Uno riguarda lapossibilità di sfamare la povera gente riservando ad essa le acque del porto per-ché vi peschi «coll’amo». L’altro – ancor più grottesco – prevede, visto che ormaiquel medesimo porto è «reso inabile per la difficoltà dell’entrata», di «farvi get-tare qualche migliaia d’ostriche di Corsica per popolarlo di simil specie di frut-ta di mare». Ci sarebbe da ricavarne un utile ragguardevole, «mentre sì frescheche salate potrebbe aversene gran esito per il Piemonte e la Lombardia, ovegiongerebbero assai più fresche di quelle che attualmente ricevono in Milanotrasportate per fiume sin da Venezia dentro barili e legata ogniuna con fil diferro». Per «agevolare la moltiplicazione di dette ostriche nel sopradetto porto»,poi, quale espediente migliore – proprio nel momento in cui la Repubblica siaffanna a promuovere il dragaggio dello scalo savonese! – di «gettarvi entro dellirottami di vasi di creta de’ quali sono amantissime»?
Certo, queste ultime stravaganze possiamo pensare che siano solo il frutto delcervello balzano di una singola persona, ma il complesso delle proposte che
191
Capitolo 11
abbiamo esaminato nelle pagine precedenti da un lato non è frutto di capricciindividuali, e d’altro lato mostra bene in quali incertezze e in quali aporie sidibatta la politica genovese. Cosicché, ancora una volta, più che chiamare incausa l’egoismo o il dispotismo della Dominante bisogna chiedersi quali effet-tivi margini di manovra ci siano in quella Repubblica, nei cui meccanismi nonsi può toccare quasi nulla senza rischiare di incepparli: e infatti anche i tentati-vi di cui abbiamo ora parlato sono destinati a risolversi in un nulla di fatto. Èovvio, quindi, che in questa situazione i sudditi finiscano per sentirsi persegui-tati: nel 1807, rispondendo a un questionario dell’amministrazione napoleoni-ca, il maire di Finale interpreterà un sentimento molto diffuso affermando chein Liguria «la scienza dei traffici non fu giammai un’occupazione del [potere]pubblico», e che gli oggetti ad essa relativi «non furono giammai presi sottoalcun ponto di vista, se non per incepparli, giacché tale fu sempre il progettodel Senato di Genova, allorché parlavasi di commercio o di navigazione di unqualche paese delle due Riviere»36.
In un’altra parte di questo libro abbiamo ricordato che nel 1797, caduto ilregime oligarchico, una deputazione savonese giunta a Genova per felicitare ilgoverno provvisorio della democratica Repubblica Ligure aveva pronunciatodure accuse contro la «tirannia aristocratica», la sua «infernale politica», la sua«mano di ferro». I componenti di quella deputazione si erano fatti forse trasci-nare dalla retorica del momento, dimenticando che il serenissimo governo avevamostrato proprio nei decenni prerivoluzionari di avere a cuore le sorti diSavona, di fare progetti per risollevarla, e di impiegare a tal fine alcuni dei suoiuomini migliori o ritenuti tali. Eppure avevano qualche ragione di pensare che,in fin dei conti, quella era stata davvero un’«infernale politica» e che soltanto undrastico mutamento di regime, con il rovesciamento completo della vecchialogica di governo, avrebbe potuto cambiare i destini della loro città. Sennonchéquel mutamento di regime – se ne sarebbero accorti i savonesi come gli altriliguri – avrebbe assunto ben presto forme tali da eclissare la retorica giacobi-neggiante e da far rimpiangere i vecchi tempi.
192
36 ASS, Dipartimento di Montenotte, 47, fasc. 2, 4 agosto 1807.
«A canto della città è posta la fortezza, che è la maggiore e la migliore chehabbia la Repubblica et è quella che ella unicamente tiene nella Riviera occi-dentale e che gli [sic] assicura il possesso di essa»: così all’inizio del SettecentoFilippo Casoni, nella sua Breve descrittione della Liguria e della città di Genova1.«Di quanta importanza sia alla Repubblica nostra la Rocca e Cittadella diSavona [...] sarebbe soverchio il dilatarsi in parole», basti dire «che è l’ochio drit-to della Repubblica», cosicché «è necessario metter ogni studio, cura e diligen-za per ben custodirla»: così, nel corso del Seicento e oltre, le formule usate nelleistruzioni ai Commissari inviati da Genova nella fortezza del Priamàr2. Frasi diquesto tipo se ne possono citare molte, e tutte testimoniano il ruolo fonda-mentale della piazzaforte savonese nella strategia difensiva dello Stato ligure.Abbiamo visto nel capitolo 10 quali conseguenze ne siano derivate per la cittàsuddita, ferita a più riprese da demolizioni di interi quartieri, sventramenti,costruzioni costose di mura e bastioni che poi vengono abbattuti perché giudi-cati non più utili. Ora vorremmo soffermarci un poco su un altro aspetto, menoappariscente e più quotidiano, vale a dire su ciò che ha significato per Savona,giorno dopo giorno e prescindendo dai grandi interventi edilizi, la presenza siadella fortezza e della sua guarnigione, sia di un non trascurabile presidio di sol-dati entro la città, la cui delicata posizione richiede che anche all’interno dellemura ci siano uomini armati per difenderla.
La fortezza rappresenta – almeno in teoria – una sorta di corpo separato dallacittà e del tutto indipendente dal territorio circostante, tanto è vero che essanon rientra nella giurisdizione del Governatore di Savona, ma è sottopostadirettamente all’autorità del Senato, il quale vi invia dei propri Commissari:sono semmai costoro che, qualche volta e in via eccezionale, sono chiamati asostituire il Governatore quando deve assentarsi. Per le piazze più importanti,quale certamente è quella del Priamàr, in base al capitolo XXXVII delle Legesnovae del 1576 costoro devono essere «cittadini nobili di età superiore atrent’anni, astenutisi dalle arti meccaniche da non meno di otto e particolar-mente capaci»3. «Sin all’anno 1545 vi andava un Commissario solo [...] ogni tremesi, [...] poi per l’accrescimento della Cittadella dall’hora in poi ve ne sonodoi»4: due sono infatti i nuclei difensivi della fortezza, la Cittadella appunto e
193
1 M. QUAINI (a cura di), La conoscenza del territorio cit., p. 204.2 G. RAPETTI, L’ochio dritto della Repubblica. Amministrazione e vita quotidiana nella fortezza genovese del
Priamàr di Savona nei secoli XVII e XVIII, Savona, Elio Ferraris Editore, 1998, p. 22. Di questo bel testo ci var-remo spesso nel presente capitolo, anche al di là dei casi in cui viene espressamente citato.
3 P. GIACOMONE PIANA-R. DELLEPIANE, Militarium cit., pp. 33-34.4 M. P. ROTA (a cura di), Una fonte per la geografia storica cit., p. 100.
Capitolo 12
La fortezza e le soldatesche
il Maschio, quest’ultimo più munito e più difficile da espugnare, tanto è veroche dei due Commissari «quello che sarà nel Maschio doverà sempre havere laprincipalità»5. Una legge del 1588 precisa che non devono avere più di ses-sant’anni, che durano in carica solo due mesi, e che se prima «potevano esseredi tutto il corpo della nobiltà», d’ora in avanti vanno scelti tra i nobili «di MinorConsiglio»6. Nel 1665 si decide di nominarli per un intero anno e nel 1672 siopta per l’elezione di un solo Commissario, affiancato da un ufficiale «stipen-diato» con il ruolo di «comandante delle armi», perché il governo incontra sem-pre molta difficoltà a trovare patrizi che accettino l’incarico nella fortezza savo-nese, dove devono restare rinchiusi come prigionieri finché dura il loro manda-to: «gli ricchi non vogliono andare» – nota un patrizio nel 1575 – e mandarci inobili squattrinati, quindi più corruttibili, sarebbe pericoloso7. Dal momentoin cui compare la figura del «comandante delle armi», che è un militare di pro-fessione, il ruolo del Commissario risulta ridimensionato, anche se formalmen-te il comando della piazza spetta sempre a lui, per una regola ferrea dellaRepubblica in base alla quale sono sempre i «cittadini di governo», cioè i nobi-li ascritti nel Libro d’oro, ad avere le responsabilità più alte.
Agli ordini dei Commissari stanno dei contingenti che variano nel tempo,come varia la forza armata complessiva dello Stato genovese. Verso il 1560, sucirca novecento soldati al servizio della Repubblica, nella fortezza di Savona cen’è una settantina; poi crescono fino al centinaio, e più di metà sono tedeschi,che hanno cominciato ad esservi inviati nel 15668. All’inizio del Seicento glieffettivi totali sono cresciuti sino a circa duemila uomini, e crescono ancora dimolto in occasione della guerra del 1625. Contestualmente si incrementa ilcontingente della fortezza: 70 italiani e 107 «alemanni» nel 1606, poi ridotti a60 e 90 nel 1616, ma di nuovo aumentati per i «rumori di guerra» pochi annidopo. Nel 1686 la truppa si è ulteriormente diversificata perché all’interno delMaschio e della Cittadella sono presenti «quattro nazioni, oltramontani, pae-selli, corsi e fortuna», che non sempre vivono in buon accordo fra loro9. Altempo della guerra di Successione spagnola – nei primi anni del Settecento – laguarnigione aumenterà prima fino a 330, poi addirittura fino a oltre 500 uomi-ni10.
Non bisogna però lasciarsi trarre in inganno dalle cifre ufficiali riportate negliorganici o nei «rolli», cioè nei registri in cui sono riportati gli effettivi: gli orga-nici sono spesso incompleti, viceversa i «rolli» sono gonfiati perché non tutti i
194
5 G. RAPETTI, L’ochio dritto cit., p. 30.6 ASG, Archivio segreto, 1028, settembre 1593. 7 C. BITOSSI, Il governo genovese a Savona cit., p. 86.8 M. P. ROTA (a cura di), Una fonte per la geografia storica cit., pp.103-104: «L’anno 1581 a 16 di febraro da’
Serenissimi Collegi per loro decreto [...] fu stabilito il detto numero de soldati in l’avenire dover essere centotra italiani e thedeschi».
9 ASG, Archivio segreto, 2707/H, 96. «Oltramontani» sono definiti i mercenari tedeschi e svizzeri; «paesel-le» sono quelle compagnie – destinate inizialmente proprio a rinforzare il presidio di Savona – reclutate a par-tire dal 1617 nella Riviera di Levante tramite una rudimentale forma di coscrizione, e in seguito arruolate subase volontaria; di «fortuna» sono le compagnie composte da italiani non sudditi della Repubblica.
10 G. RAPETTI, L’ochio dritto cit., pp. 47-48.
Capitolo 12
militari che vi compaiono sono effettivamente presenti, ma alcuni possono esse-re dei «passavolanti», persone che vengono pagate senza in realtà prestare servi-zio, come peraltro avviene in quasi tutti gli eserciti dell’epoca. Proprio a questoproposito troviamo un primo punto di contatto fra la fortezza e la città: perchéda un lato, se l’organico è incompleto, ciò può dipendere dal fatto che alcunimilitari vengono impiegati fuori del Priamàr, in compiti di polizia nel circon-dario urbano, o per la sorveglianza del Bosco di Montenotte; e d’altro lato acca-de che siano dei cittadini savonesi coloro che si prestano a fare da passavolanti,dividendo poi il soldo abusivamente guadagnato con qualche ufficiale disone-sto. Così gli uomini della fortezza possono assumere il volto dei tutori dell’or-dine o degli scherani del governo, ma anche offrire occasioni di guadagni illeci-ti.
Nel complesso, lo ripetiamo, il forte resta tuttavia un microcosmo appartatoe autosufficiente: possiede forni per il pane, cucine, «officine» e rispettivi arti-giani, un mulino, un’osteria; ha anche un proprio cappellano-confessore «conobligo non solo di celebrare ogni giorno la Santa Messa, ma di dormire in for-tezza per far quello bisognassi circa le confessioni»11. Ciò non impedisce, però,che ci sia un’osmosi continua, nel bene e nel male, fra ciò che avviene dentro ela realtà esterna. In primo luogo il Priamàr è, per dirla con gli economisti, unnotevole “fattore di domanda” per tutta la zona circostante. La costruzione (ola demolizione) di opere murarie rappresenta una opportunità di impiego perla manodopera locale, nonché di forniture di materiali da costruzione, a comin-ciare dai laterizi e dalla calce, gli uni e l’altra prodotti in quantità dalle fornacisavonesi. Anche l’approvvigionamento ordinario rappresenta un capitolo inte-ressante: se il grano arriva direttamente da Genova via mare (ma di solito sonoi «patroni» savonesi che lo trasportano sui loro leudi e le loro gondole, e sono imugnai di Lavagnola e di Quiliano che lo macinano), e solo raramente se neacquista sul mercato locale qualche partita proveniente dal Piemonte, tutti glialtri generi alimentari vengono comprati sul posto, anzi esiste un diritto di pre-lazione: sin dal 1595 il Podestà, così come poi il Governatore, ogni qualvolta iCommissari hanno bisogno di rifornimenti, deve fare in modo «che ne sianoprontamente provisti per mezzo della dovuta mercede et prezzo, e che siano ante-posti a qualsivoglia persona di che qualità che sia»12. Del pari, è a Savona e nelsuo circondario che si svendono a basso prezzo i viveri immagazzinati nelPriamàr quando rischiano di deteriorarsi, o quelli che – come avviene da chemondo è mondo nelle caserme e in altri analoghi istituti – qualche magazzinie-re riesce a sottrarre e a smerciare a proprio vantaggio. Così tanto chi vendequanto chi acquista può giovarsi della presenza di quel forte, che pure la cittànel suo complesso non ama; e possono trarne vantaggio tutti coloro che lavo-rano al servizio della guarnigione, siano essi artigiani o lavandaie, mugnai o pro-stitute.
195
11 Ivi, pp. 44-46; M. P. ROTA (a cura di), Una fonte per la geografia storica cit., p. 101.12 ASS, Comune I, 209, c. 532 (il corsivo è nostro).
La fortezza e le soldatesche
Altre forniture hanno un regime particolare, regolato per legge, e non sem-pre i fornitori le vedono di buon occhio. Ciò vale per la legna da ardere, che le«ville» di Savona e le comunità di Quiliano, Vado e Segno sono obbligate aprovvedere, a rate quadrimestrali, per un quantitativo annuo prima di 2.000,poi di 3.000 e infine – all’inizio del Settecento – di 5-6.000 cantari, pagati a unprezzo piuttosto basso e non per intero, perché una parte deve essere elargitagratuitamente: di solito viene scaricata all’esterno della fortezza, e questo con-sente qualche traffico illecito, dal semplice furto alla rivendita abusiva13.Analogo obbligo di fornire legna, e anche paglia, esiste nei confronti delle trup-pe del presidio di stanza in città: nel 1647 «le quattro povere ville di Savona,cioè Legino, Zinola, Lavagnola e San Bernardo» se ne lamentano in una sup-plica indirizzata al Senato, perché sentono quell’obbligo come una prepotenzanei loro confronti da parte della città e dei suoi Anziani, e chiedono di essererimborsate per il non piccolo quantitativo che – anche in questo caso – sonotenute a somministrare gratuitamente14.
La città stessa, tuttavia, ha i suoi oneri: secondo una «notta de quello haveràda proveder la communità di Savona alli soldati di pressidio», stesa dal gover-no, essa deve procurare al capitano che comanda quel presidio «stanza concamera e letto fornito con mattarazzi e coperta di filosella per dormire lui et unsuo servitore con commodità di cucina»15. Ai soldati vanno date «tavolette perdormire» e, nella misura di uno per ogni tre uomini, «sacconi di canavazzo ecoperte di lana», ma le coperte solo dal primo ottobre al primo maggio; l’alfie-re, pur dormendo con i soldati, ha diritto a un saccone e a una coperta perso-nali, oltre ad una «straponta». Bisogna poi provvedere dei «cabani di arbaxo perquelli soldati che fanno la sentinella» alle porte della città, e dare ogni sera unquarterone d’olio «per lo lume delli corpi di guardia»16. L’istruzione precisa chela paglia per i sacconi deve essere cambiata una volta all’anno «quando sonofatte le paglie nuove, perché di poi li huomini delle ville non habbino obligofuor di staggione e sia loro meno gravezza»; stabilisce altresì che i tre corpi diguardia abbiano 400 cantari di legna, e che i soldati non possano «prender altrelegne alle porte o altrove dalli mulatieri, conduttori et altri, ma lassino passarogni uno liberamente»; dispone infine che coperte, sacconi, cabani e altri mate-riali procurati dal Comune non possano essere asportati dai soldati quandocambiano sede, e che «oltre le predette cose non possino dalla communità pre-tendere altra comodità, asnesi et altro di qual si voglia sorte senza l’ordineespresso del Serenissimo Senato».
Sagge disposizioni, queste ultime, ma con la loro stessa presenza lascianointendere che spesso le cose procedono altrimenti, che i soldati esigono con laforza più di quanto è loro dovuto, che le suppellettili spariscono. D’altrondequegli stessi soldati, il cui compito sarebbe di difendere la città, possono vice-
196
13 G. RAPETTI, L’ochio dritto cit., pp. 76-79. Il cantaro vale kg 47,6496.14 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 108-109.15 Ivi, libro II, c. 43.16 Il quarterone equivale a l. 0,51.
Capitolo 12
versa rappresentare un grave problema di ordine pubblico. Il 26 maggio 1628il Governatore di Savona chiede al Senato «come io mi habbia a contenere circail governo della soldatesca, intorno alla quale io non so che auttorità io mi hab-bia»: il problema è che «i soldati delinquiscono tutto il gorno, e [...] se d’ognidelitto si deve far processo, sarà di gran lunghezza alli agenti di questa corte»17.È una lamentela non infrequente, che infatti induce il governo a conferire alGovernatore la carica di «Commissario d’armi», con piena autorità nei con-fronti della «soldatesca pagata» di stanza nei vari presidi18.
Questi sono tuttavia inconvenienti di poco peso, se paragonati a quello chela città deve sopportare nelle emergenze di guerra, o anche solo quando i«romori d’armi» ai confini della Liguria mettono in allarme la Repubblica e lainducono a spedire a Savona grossi contingenti. Così accade nel 1625, quandomolti soldati devono essere alloggiati «per le case, ville e giardini de’ cittadini»,e in seguito a ciò – oltre ai danni e alle spese – muoiono oltre «cento capi dicase et altri di malatie maligne e quasi contagiose per infettione della soldatescanumerosa che vi alloggiava». La città per l’alloggio dei soldati spende (o alme-no sostiene di aver speso) dal 1625 al 1633 ben £ 400.000, per coprire le quali«ha imposto molte cabelle nuove, altre n’ha acresciute»19. Nel 1641 «mantienela piazza d’armi di soldati 800 a serviggio publico di tutto il Stato» e «spendeper tal effetto £ 10.000 in circa ogn’anno quali paga prontamente», mentre neviene poi rimborsata «con difficoltà e con perdita grande». Un onere ingiusto,se si pensa che «in la Fiandra et Alamagna sono esenti dalle contributioni tuttele terre e luoghi per le quali alloggia o passa l’essercito», e che nel regno diNapoli «si dichiarano impotenti da pagamenti fiscali le terre nelle quali allogia-no li soldati»20. Un onere cui bisogna aggiungere, tra Cinque e Seicento, il pas-saggio di truppe spagnole, che di solito sbarcano a Vado e proseguono versol’interno senza toccare Savona, o preferiscono la via di Finale, ma che talorascelgono la più sicura darsena savonese e attraversano il territorio del Comuneper dirigersi – a seconda di qual è il teatro di guerra – verso il Milanese, ilPiemonte o il Monferrato. Più tardi, al tempo della guerra di Successione spa-gnola, anche i francesi non si faranno scrupolo di usare Vado come punto disbarco e di passare molto vicini alla città.
Per provvedere alle necessità dei soldati a un certo punto il governo pensa dirivolgersi a un appaltatore che si accolli tutte le forniture e le incombenze rela-tive agli alloggiamenti. Nel 1637 il Senato incarica il Magistrato delleComunità di «deputar un impresario per l’alloggio della soldatesca in la città diSavona per sollievo di detta città e miglior ordine a detto alloggio»21. Nel 1643si fa avanti un tal Giacomo De Lucchi, il quale – dando una «sigortà», cioè unafideiussione, di mille scudi – offre «di pigliare l’impresa dell’alloggio a sue pro-
197
17 ASG, Senato-Senarega, 1013.18 ASG, Archivio segreto, 2707/E, n. 128 e passim.19 ASS, Comune I, 214, s. d. (1641).20 Ibidem.21 ASS, Comune I, 1197, 18 marzo 1637.
La fortezza e le soldatesche
prie spese di tutta la soldatesca che piacerà alla Serenissima Repubblica di tene-re per l’avenire nella città di Savona». Ottiene in effetti l’appalto, ma non perquesto Savona ne risulta sollevata, non solo perché una parte delle spese restacomunque a suo carico, ma anche perché il De Lucchi si rivela spesso inadem-piente: pretende che le forniture di legna e paglia continuino ad essere a caricodella città o delle sue ville, ed esegue il suo compito in modo tale che, negli annia venire, il Comune è costretto ad aprire con lui un lungo contenzioso22.
In confronto al presidio, che pur rivestendo un’indubbia utilità per la difesadella città le procura anche molte spese e molti grattacapi, la guarnigione delPriamàr sembrerebbe meno problematica, proprio in virtù dell’isolamento dicui parlavamo in precedenza. «Si tenevano le porte sempre chiuse [...] – riferi-sce un documento seicentesco – eccetto che l’entrata de’ Commissarii a pigliar-si il possesso, o straordinaria occasione, et occorrendo uscire soldati si calavanocon corda giù per le mura»23. Ma già nel 1622 le regole si ammorbidiscono, iCommissari possono concedere ai soldati permessi d’uscita «per comprarsiqualche comestibile o per altri loro affari» – purché escano pochi per volta e nonpassino fuori la notte – e gli stessi Commissari non sono più tenuti alla strettaclausura d’un tempo. Anche gli ufficiali ottengono permessi, e si assentano nelleore notturne, mentre i frequenti ordini dei Collegi miranti a proibire ogniabuso in termini di “libere uscite” dimostrano che gli abusi vengono regolar-mente commessi.
Si vorrebbe anche limitare quanto più è possibile ogni contatto fra i civili e imilitari della guarnigione: ai soldati è vietato fraternizzare in qualunque modocon la popolazione, non possono andare «a ballare sopra le feste», intrattenere«amicizia di donne», «interrompere la quiete de’ paesani» con schiamazzi oscherzi. Ma è inutile dire che non solo questi divieti vengono violati, benché siinfliggano spesso punizioni severe, ma che gli uomini della fortezza, al pari diquelli del presidio, si rendono colpevoli di furti, prepotenze, risse, «atti di sodo-mia», violenze sessuali nei confronti di «figlie, donne maritate o vedove»24. Altricontatti, più pacifici, riguardano una fitta compravendita, in cui trovano largoposto le prestazioni sessuali da un lato, e dall’altro il commercio di equipaggia-menti, armi e munizioni che i soldati non si fanno scrupolo di vendere ai civi-li, con tanto maggiore disinvoltura se sono in procinto di disertare.
Al pari dell’uscita, anche l’ingresso alla fortezza è in teoria estremamentelimitato: «quanto il castello sta più chiuso, sempre è più sicuro», recita un’i-struzione del Senato. L’apertura delle porte deve avvenire solo in certe ore delgiorno, sotto la personale sorveglianza del Commissario e con una proceduraimprontata alla massima cautela; ma via via le maglie si allentano, l’accessorimane aperto «passato il mezzo giorno per il necessario commercio con lacittà», tanto che spesso i Collegi devono richiamare i Commissari e invitarli a
198
22 ASS, Comune I, 215, 15 gennaio 1643; ASS, Comune I, 214, 25 gennaio 1647.23 ASG, Archivio segreto, 2707/H, 96 (citato in G. RAPETTI, L’ochio dritto cit., p. 116).24 G. RAPETTI, L’ochio dritto cit., pp. 171-173.
Capitolo 12
una maggiore prudenza25. La proibizione a chiunque di mettere piede nella for-tezza sarebbe tassativa: persino il Governatore, se talvolta vi entra «accadendo ilbisogno e necessità di consigliare», deve lasciare fuori la propria scorta di ala-bardieri, almeno sino al 1672, data in cui il loro ingresso comincia ad essere tol-lerato. Di fatto, però, gli estranei al servizio presenti dentro il «castello» sononumerosi: vi si ammettono servitori d’ambo i sessi «per servigio deiCommissari» nonché le mogli e i figli dei Commissari stessi, sia pure con il con-senso del governo; soprattutto vi risiedono numerosi familiari di soldati, ben-ché la cosa sia espressamente vietata.
Esiste un «proveditore generale [...] fuori della Rocca e Cittadella», cui spet-ta occuparsi di tutto ciò che serve ai Commissari, agli ufficiali e ai soldati (peresempio, far lavare i panni e la biancheria), perché non si vuole «che donne ealtri entrino in quelle fortezze in modo alcuno». Ancora una volta, però, nonmancano le eccezioni: motivi d’urgenza possono richiedere l’ingresso di medi-ci, chirurghi, barbieri e confessori; nelle «feste di comando» entrano spesso deipreti a celebrare le funzioni, e «per lettera de’ 17 agosto 1605» si permette aiCommissari più timorati di introdurre «doi sacerdoti» per dir messa tutti i gior-ni, con l’unica clausola «che non si cresca spesa alcuna alla Camera»26. Al di làdi questi casi, tutto sommato plausibili e non troppo numerosi, si intravede poiuna violazione continua e quasi generalizzata delle regole: nella fortezza si entraper comprare illegalmente pane, vino, legna, attrezzi, e non ci si fa scrupolo diospitarvi «meretrici e femine di cattiva vita».
Se – nonostante i divieti severi, le molteplici porte e «rastelli», i baluardipoderosi – si riesce a intrattenere continui commerci con i militari della fortez-za, tanto più facile risulta trafficare con quelli del presidio cittadino. «Nonvogliamo che i soldati che sono o saranno pro tempore in presidio di cotestacittà faccino fondaco da vino né macello da carne per vendere [...] in pregiudi-cio e danno delle gabelle», recita un’istruzione del Senato al Governatore in data14 gennaio 161027. A quest’epoca il problema è ormai annoso, visto che sin dal1537 il «castellano di Savona», cioè l’ufficiale che comanda il piccolo forte diSanta Maria, «par che habbi posto una taverna fra le due porte del castello, inla quale fa vendere vino et ogni altra cosa che li piace a tutto homo», benché icastellani possano «solamente far taverna dentro del castello per uso e consumodei soldati»28. Le raccomandazioni e le proibizioni del governo da allora si sus-seguono a ritmo costante, come costante è la loro inefficacia. I soldati e gli uffi-ciali del presidio e quelli della fortezza fanno a gara nel tenere «biscacce» (oggili chiameremmo «spacci militari») nelle quali i savonesi possono andare a rifor-nirsi di vino, pane e altri commestibili frodando le gabelle: una sorta di duty freeshop che conviene agli acquirenti (la fortezza, in particolare, è un ricco emporiodove si produce molto pane destinato anche al presidio urbano, e dove ci sono
199
25 Ivi, pp. 119-121.26 Ivi, p. 122-123.27 ASS, Comune I, 210, libro II, c. 39v.28 Concessioni, decreti et ordini cit., pp. 46-50; ASS, Comune I, 209, c. 112.
La fortezza e le soldatesche
ampie riserve di vino «nostrale» e forestiero), ma non certo all’amministrazionecomunale, la quale si vede privata di importanti cespiti fiscali. Gli Anziani se nelagnano spesso, e nel 1711 un loro esposto provoca una lunga relazione delSenato, dalla quale risulta che «ritrovansi ormai in colmo le frodi che si com-mettono nelle gabelle del pane, vino et altre» per colpa della fortezza29.
Le norme che proibiscono di vendere all’esterno le vettovaglie sono disatte-se, con danno tanto del Comune quanto dell’erario: nel Priamàr si panifica inquantità sovrabbondante e vi entrano molte farine in più rispetto a «quelle for-nite dalla Camera per uso militare»; parimente, la fortezza acquista «in fran-chigga» – cioè senza pagare imposte – molto più vino del necessario, e poi quelvino «viene portato via in fiaschi, barrili, mezzi barrili e altri vasi in frode dellegabelle della città», il tutto grazie alla complicità dei soldati e delle loro mogli.Nel 1710 il Governatore Giulio Spinola ha denunciato che la gabella di pane emacina, «la migliore [che] habbi questa città» e alla quale la Camera è cointe-ressata, «patisce danni insofribili da questa fortezza in cui non si fabricano lesolite razioni de’ soldati, ma anche si provede ad una parte della città e luoghivicini». Soldati e bottegai («stapolieri») vendono pubblicamente le razioni, «etil pane s’introduce [...] nelle case de’ particolari, che mandano anche a prove-dersi di farine, et è difficile il poter rimediare a questi disordini se il rimedio nonviene dalla fortezza», perché i pochi birri e «famegli» agli ordini del Governatore«non ponno contrastare con tanti soldati». Ne seguirà un inasprimento di penedestinato, naturalmente, a lasciare tutto come prima, tanto è vero che nel 1756ritroviamo ancora le solite proteste perché la guarnigione della fortezza abusadelle molte franchigie fiscali di cui gode30.
Le vendite illecite dei commestibili sono certamente una prevaricazione, maalmeno una parte della città vi trova il proprio tornaconto. In altri casi, invece,la violazione delle norme riesce solo svantaggiosa. È ciò che accade ai pescatorisavonesi i quali, secondo la normativa vigente, durante il giorno possono libe-ramente calare le loro reti in prossimità della fortezza, e solo di notte non devo-no avvicinarsi a meno di «due tiri d’archibuggio»31. Ma nel febbraio 1595 a unabarca intenta a pescare sul primo mattino viene sparato dal Priamàr un colpo di«smeriglio» – un cannoncino di piccolo calibro – che rischia di affondarla32. Èil primo episodio – almeno per quanto ne sappiamo – di una lunga disputa trai pescatori che rivendicano i loro diritti e i soldati della fortezza che voglionoimpedir loro di pescare, ne confiscano le reti, li bersagliano con le armi. Loscopo apparente dei militari è di garantire la sicurezza della piazzaforte, ma inrealtà mirano ad altro, cioè ad esercitare una pressione sui pescatori per costrin-gerli a «far andare in castello tutti i pesci [che] si prendono sotto l’una e l’altra
200
29 ASS, Comune I, 211, cc. 132 sgg. Ma analoghe lagnanze e analoghi provvedimenti del Senato si trovanoa più riprese nei registri della corrispondenza tra Savona e Genova
30 ASS, Comune I, 143.31 Concessioni, decreti et ordini cit., pp. 152-154.32 ASS, Comune I, 210, libro II, c. 13r.
Capitolo 12
spiaggia» della fortezza. Pretendono cioè di esercitare una sorta di diritto di pre-lazione sul pescato, e a un certo punto «vogliono anche impossessarsi di queipochi [pesci] che restano per la città» e che si pescano presso il porto, nella«spiagietta che si chiama delle casse». Dalla fortezza, talvolta, si sono mandatipersino degli armigeri perché si accaparrassero i pesci con la forza, suscitando leire dello stesso Governatore e provocando infine l’intervento del Senato33.
Una storia minima, come si può vedere, eppure è anche intorno a questi epi-sodi di poco conto che nascono e crescono tensioni, rancori, frustrazioni. Speciese dietro alle piccole prepotenze quotidiane della guarnigione c’è quella presen-za così ingombrante della fortezza e degli altri apparati difensivi che altroveabbiamo ricordato, o se qualche evento devastante – come gli incidenti alle pol-veriere – viene a rinfocolare l’odio verso una fortificazione che è vista assai piùcome simbolo d’oppressione che come strumento di difesa. È il caso, soprat-tutto, del disastro avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1648, quando un ful-mine penetra nella santabarbara del «castello» e provoca l’esplosione, si dice, dioltre mille barili di polvere. La catastrofe coinvolge non solo le strutture delforte e la cinta muraria prospiciente la darsena, ma anche, e in larga misura, iltessuto urbano: nei vari quartieri della città crollano 209 case, con 850 morti e663 feriti.
Il rimanente in quelle vicinanze – riferisce il Monti – stette così intronato e lace-ro che convenne demolir molt’altre case e ripigliarle da’ fondamenti. [...] Datant’impeto e fragore poche furon le case che non traballassero, o si scommettesse-ro. Cascaron da per tutto le vetriate, [...] si spalancaron le botteghe, porte e fene-stre, s’apriron nelle chiese i sepolcri, [...] si scompaginaron le volte, si sgomentaronle mura. Patì assai il palazzo del Governatore, la Raiba luogo ove si vendono e siconservano le biade, il magazeno del vino con perdita di due mila e cento barili divino e sessanta grosse botti, li forni [...]. Venne a terra la chiesa e convento delleScuole pie.
Perfino la darsena viene prosciugata dal calore dello scoppio: «si trovaron insecco le barche e una galera di questo Dominio fu sbalzata in alto più di cinquepalmi»34.
Lo scoppio – che suscita anche aspre polemiche, perché a più riprese gliAnziani savonesi avevano chiesto al Senato di custodire in modo più sicuro lepolveri – aggrava la crisi economica della città. «Con la rovina de’ precitati edi-ficii e mortalità degl’habitanti – commenta ancora Monti – si perdettero moltearti». Le gabelle, riferiscono gli oratori del Comune di Savona poco tempodopo, «non si troveranno più a vendere» neppure con una forte riduzione e lacittà perderà almeno 16.000 lire all’anno «essendo estinta l’arte de’ bottari, bar-rilari, pescatori e gran quantità di begudieri [cioè locandieri], revenderoli, hosti
201
33 ASS, Comune I, 214, 13 dicembre 1675.34 A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., pp. 260-261; maggiori particolari in G. GALLOTTI, 7 luglio 1648: testi-
monianze inedite sullo scoppio del castello di San Giorgio, AMSSSP, n. s., vol. XXXIX, 2003, pp. 227-238.
La fortezza e le soldatesche
et altre persone che introducevano grandissimo traffico e guadagno alle gabel-le». Per non parlare di quei circa settecento disgraziati che sono rimasti senzanulla «con haver perso la casa, robba e parenti»35.
L’amministrazione civica implora, a risarcimento dei danni, una serie di con-cessioni: che siano «rilasciate a favore della città» la gabella del vino spettante aSan Giorgio e le porzioni delle gabelle sulla macina e sul pane bollato di com-petenza della Camera; che durante le quattro fiere da tenersi a Savona nei mesidi febbraio, marzo, agosto e settembre si conceda ampia franchigia fiscale a«robbe e vettovaglie che venissero in questa città, essendo questa una potentestrada d’ingrandire la città e levare il traffico a Loano et al Finale»; che nella dar-sena savonese possano «d’hora in appresso venire qualsivoglia vascelli di qualsi-voglia portata non ostante la prohibitione che non ve ne possano venire se nondi capacità di mine 400 in circa»; che venga stornata a beneficio della città latassa per l’armamento delle galere; che San Giorgio eroghi cospicui sussidi36.
Il governo prende in seria considerazione queste richieste, calcola accurata-mente il gettito delle imposte, ma infine stabilisce che la maggior parte di quel-le gabelle non può essere destinata a favore di Savona, perché gli introiti spet-tanti alla Camera «non solo fanno ad essa di bisogno per le spese ordinarie, allequali con essi anco difficilmente si supplisce, ma convien di più giornalmenteapplicar l’animo per trovar forma di supplire alle straordinarie, che per raggiondi buon governo conviene fare in questi tempi». E quanto alle agevolazionifiscali e ai nuovi regolamenti per la darsena, non se ne può far nulla se ciò con-trasta con gli interessi di San Giorgio37. Ancora una volta, dunque, sono laristrettezza dei bilanci pubblici e l’oculatezza estrema della gestione finanziariagenovese che comandano il gioco.
La Repubblica, tuttavia, si onora di non aver mai «abbandonati li suoi sud-diti», e cerca comunque di venire incontro alla città ferita – che già prima del-l’esplosione era «molto indebitata et essausta» – cedendole parte delle gabelledella macina e del pan bollato, consentendole col gettito di queste di accende-re dei mutui, sollecitando sussidi da parte di San Giorgio per ricostruire le casedei cittadini «quali non hanno il modo di reedificarle de’ proprii danari». Ineffetti San Giorgio, dolendosi di non poter fare di più «per la qualità de’ tempie la scarsità degl’introiti delle gabelle», fornisce dei finanziamenti – da rimbor-sare, s’intende – per le «ristorazioni di quelle case rovinate de’ poveri cittadi-ni»38. «La Serenissima Repubblica – conferma un anonimo cronista – [...] nonha mancato di condolersi con gravi parole, e subito mandò molte lire per ipoveri privati delle case loro, e comandò che i feriti nella rovina [...] fossero con-dotti per mare agli spedali di Genova»39. Ma la parsimoniosa carità del governonon riesce certo a pareggiare i conti: tanto più che, come ricorda lo stesso cro-
202
35 ASS, Comune I, 210, libro III, cc. 131-133.36 Ibidem.37 Ivi, cc. 133-134.38 Ivi, cc. 142-143.39 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., p. 302.
Capitolo 12
nista, se la Repubblica si offre «d’aiutare questa città tanto abbattuta in sì dolo-roso accidente», si affretta anche a comperare «il sito degli abbattuti edificii [...]per accrescere piazza e dar spalto alla fortezza».
Resta il fatto che – anche per quanto riguarda i problemi relativi alle solda-tesche e alle fortificazioni – è la forza delle cose più della volontà degli uominia determinare una situazione sfavorevole per Savona, e da un eventuale muta-mento politico non si possono sperare grandi miglioramenti. La città lo speri-menta dolorosamente – vi abbiamo già fatto cenno – al tempo della guerra diSuccessione austriaca e dell’occupazione piemontese. Tornerà a sperimentarlosul finire del Settecento, quando gli eserciti della Francia rivoluzionaria in guer-ra con la Prima Coalizione cominciano ad avanzare nel Genovesato – che pureè ufficialmente neutrale – e naturalmente fanno base intorno a Savona, data lasua importanza strategica. Ecco che allora, nella primavera del 1795, gli Anzianidenunciano i gravi disagi per «il numero accresciutosi dell’armata francese dapiù mesi stazionata nel territorio savonese» e chiedono aiuto al governo geno-vese per provvedere adeguati alloggiamenti ed evitare che le truppe si insedinoin città, «il che recarebbe danni incalcolabili». E un anno dopo, nel maggio1796, lamentano che sono state «danneggiate ed in alcune parti distrutte lecampagne, saccheggiate le case dalle truppe alloggiatevi, dispersi senza speranzadi più ricuperarli la maggior parte de’ letti [...] in grandissima copia provisti,evacuati a precipizio e con gravissime perdite cinque monasteri di claustrali edue di monache»40. La vecchia Repubblica sta per cadere, ma i nuovi padroninon si annunciano sotto migliori auspici.
203
40 ASS, Comune I, 143, 8 marzo 1795, 29 maggio 1796 e passim.
La fortezza e le soldatesche
«Savona contava un tempo 40.000 anime; oggi ne conta 8 o 10, a quantodicono, e stento perfino a credervi che vi siano»1. Montesquieu, viaggiando nel1728 per la Riviera, raccoglie questa voce e la riferisce volentieri, perché lo spo-polamento della città è una prova del malgoverno di quella Repubblica diGenova a cui egli non risparmia le critiche più aspre. In tempi più recenti moltistudiosi hanno fornito – a proposito della popolazione savonese – valutazionimeno catastrofiche rispetto a quella del filosofo francese, e tuttavia non moltopiù fondate, oltre che discordanti tra loro. Scrivendo sul finire dell’Ottocento,Federico Bruno sostiene che Savona nei primi anni del Cinquecento aveva circa18.000 abitanti entro le mura, scesi a 11.000 nel 1567, 9.500 nel 1613, 8.000nel 1625, 6.200 nel 1667; gli stessi dati verranno ripetuti una trentina d’annidopo da Filippo Noberasco e Italo Scovazzi2. Più tardi, Giovanni Battista Besioparla di circa 16.000 abitanti nel 1504, 12.000 nel 1531, 8-10.000 nel 1542,5-6.500 nel 15553; Carlo Varaldo – riferendo di un «andamento demograficoin continua inarrestabile contrazione» – sostiene che i 18-20.000 abitanti nelcentro urbano del primo Cinquecento si riducono a 14.000 nel 1569, a 9.000nel 1594, a 8.400 nel 1629, a 6.200 nel 16674; mentre Nello Cerisola stima a11.000 anime – come Bruno – la popolazione urbana nel 1567, e a 9.000 –come Varaldo – nel 1594. I conti insomma non tornano e non c’è da stupirse-ne, visto che i dati certi sono pochissimi, e quei pochi, per di più, sono con-traddittori. Così Edoardo Grendi, mettendo a confronto le stime relative al1535 riportate negli Annali di Agostino Giustiniani e il censimento realizzatonel 1608, ha potuto indicare per la circoscrizione di Savona un incrementodemografico pari addirittura al 56%5!
Quasi vent’anni fa Guido Malandra ha detto chiaro che per tutto ilCinquecento non esistono rilevazioni demografiche né si sono conservati statid’anime parrocchiali. Disponiamo soltanto, per il 1549, di una Descrizione ditutti i fuochi di Savona, e di un altro «focatico», ma relativo alle sole «ville», peril 1587: elenchi, cioè, di nuclei familiari (stesi a fini fiscali o per l’arruolamen-
205
1 C.- L. DE MONTESQUIEU, Viaggio in Italia cit., p. 104. La stessa stima di 40.000 abitanti la si ritrova nellepiù tarde memorie di Giuseppe Gorani (J. GORANI, Mémoires secrets et critiques cit., t. III, p. 435), segno che sitrattava di una diceria comune.
2 F. BRUNO, Dell’antica e moderna popolazione di Savona, Savona, Tip. Bertolotto, 1894, pp. 28 sgg.; I.SCOVAZZI-F. NOBERASCO, Storia di Savona cit., vol. III, pp. 150-151.
3 G. B. N. BESIO, Evoluzione storico-topografica di Savona, Savona, Tip. Palagi, 1963, pp. 28-30; ID., Savona.Il centro storico cit., p. 32.
4 M. RICCHEBONO-C. VARALDO, Savona cit., p. 82.5 E. GRENDI, Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova, Genova, F.lli Bozzi, 1973, pp. 47-
49.
Capitolo 13
Una storia economica da fare
to di rematori), dai quali non è possibile dedurre in maniera adeguata il nume-ro delle persone se si ignora la consistenza media delle famiglie6. Integrando que-ste scarse notizie con quelle riferite dai cronisti, possiamo ragionevolmente sup-porre che Savona, verso la metà del Cinquecento, avesse 6.000-6.500 abitantientro le mura, altri 6-700 nei due borghi suburbani di San Giovanni (o «supe-riore») e di Porta Bellaria (o «inferiore»), e fra i 4.800 e i 5.500 abitanti nel«distretto», cioè nelle ville sottoposte alla giurisdizione del Comune savonese:Legino, Quiliano «poder di Savona», Segno, Valle di Vado, Vezzi, Lavagnola,San Bernardo7.
Questa situazione era già il frutto di una contrazione demografica?Presumibilmente sì, ma tutto induce a pensare che il fatidico 1528 – da questopunto di vista – sia una data poco significativa, o quantomeno che non abbiadeterminato quel brusco calo di popolazione che viceversa alcuni storici localidanno per scontato. Il vero tracollo, infatti, è avvenuto prima, con le epidemiedel 1501, 1504 e 1523-24 che secondo i cronisti avrebbero causato 8-9.000morti, e con l’emigrazione di intere famiglie che abbandonano la città durantegli anni di guerra8. Certamente dopo il 1528 ci saranno altri flussi migratori,che interesseranno in particolare quei ricchi mercanti e finanzieri di cui ci siamooccupati nel capitolo 7. Ma nel corso del Cinquecento il movimento demogra-fico sembra addirittura in lieve espansione: i registri parrocchiali, pur lacunosi,mostrano «per tutta la seconda metà del secolo XVI un costante incrementodelle nascite e dei matrimoni, ed una regolare presenza di uomini e donne pro-venienti da paesi esterni al territorio savonese», in particolare dal bassoPiemonte9.
Proprio sui registri delle quattro parrocchie urbane della Cattedrale, diSant’Andrea, di San Giovanni e di San Pietro Maria Carla Lamberti ha con-dotto, oltre trent’anni fa, un’indagine di lungo periodo: partendo dalla consta-tazione che gli studiosi locali per il periodo che va dal 1528 all’iniziodell’Ottocento «non rinvengono nella storia di Savona nessuna cesura significa-tiva, ma un tutto globale che viene descritto in termini di decadenza e squallo-re», la studiosa ha inteso non ribaltare tale valutazione, ma semmai cercare «nelquadro politico della decadenza cittadina modulazioni e ritmi finora ignora-ti»10. Ne risulta un andamento non sempre negativo: le curve di natalità e nuzia-lità mostrano una città in ascesa demografica nei primi decenni del Seicento,che raggiunge le 9.500 anime nel 1613 e resta sostanzialmente stabile negli anniseguenti. Un vero e proprio tracollo si ha invece verso la metà del secolo, ma lecause sono da imputare non tanto alla crisi economica quanto a due diversi
206
6 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., p. 143.7 Ivi, p. 16.8 Cfr., in particolare, C. VARALDO, La topografia urbana cit., pp. 53-55. L’Autore compie in queste pagine
un notevole sforzo per ricostruire l’andamento demografico del Cinquecento, ma la sua lunga elaborazionedimostra più che altro l’impossibilità di attingere dati precisi e attendibili.
9 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., pp. 16-18.10 M. C. LAMBERTI, Popolazione e movimenti immigratori a Savona nei secoli XVII e XVIII, in Territorio e
società nella Liguria moderna. Studi di storia del territorio, Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 167-206.
Capitolo 13
eventi traumatici: lo scoppio della polveriera nel 1648 (ne abbiamo parlato nelcapitolo 12) e la grande pestilenza che dilaga in Liguria nel 1656-1657 (cheperaltro, come abbiamo visto altrove, colpisce solo parzialmente Savona). Poic’è una leggera ripresa, ma nel corso del Settecento – pur tra alti e bassi – si assi-ste a una sostanziale stagnazione: anche il modesto flusso immigratorio non èsufficiente a rimpiazzare le perdite del saldo naturale e di una eventuale emi-grazione. Resta il fatto che da un lato non si riesce a stabilire alcun collegamentopreciso tra le fasi economiche della città e il movimento della popolazione; d’al-tro lato bisogna ammettere che l’andamento demografico di Savona in questisecoli non si discosta poi molto da quello della Liguria nel suo complesso, segnoche non è possibile inferirne una particolare condizione di degrado e di oppres-sione11.
Le considerazioni che precedono possono dunque farci sospettare che – perquanto riguarda Savona in età moderna – alcuni dati proposti dalla storiografialocale siano scarsamente attendibili e che lo siano del pari i giudizi fondati sudi essi. Ma quel che si è detto a proposito della demografia va ripetuto, a mag-gior ragione, per le vicende dell’economia nel corso dei secoli XVI-XVIII. Ilquadro di maniera, quello che presenta una lunga, progressiva, inarrestabiledecadenza, è in realtà basato su conoscenze imprecise, fragili, episodiche.Eppure è soprattutto da tali conoscenze che si fa discendere – lo abbiamo vistonel capitolo 1 – la valutazione della politica genovese nei confronti di Savona.Bisogna invece confessare che un giudizio compiuto e articolato in propositorichiederebbe un’analisi approfondita della storia economica savonese traCinquecento e Settecento: analisi complessa, che non è nostro compito pro-porre in questa sede, e per la quale oltretutto c’è da temere che i documentiscarseggino, perché se si può contare su un ricco fondo notarile e su registri efilze di natura fiscale, mancano in compenso rilevazioni attendibili della pro-prietà immobiliare e ancor più mancano – per quanto ne sappiamo – quegliarchivi familiari che a Genova, viceversa, sono copiosi e si rivelano sempre piùutili alla ricerca storico-economica. Nelle pagine che seguono vorremmo inve-ce, molto modestamente, radunare le poche conoscenze di cui a tutt’oggi sidispone, metterle a confronto, avanzare alcuni dubbi che esse possono suscita-re e proporre alcune considerazioni puramente “impressionistiche”.
Come tutti i cultori di storia patria sanno, la vivace cronaca di AgostinoAbate trae origine da una disputa accesasi nel 1565 tra alcuni savonesi, i qualisostengono che la città a quell’epoca «era più rica che mai era stata, alegandoalcuni citadini molto richi», e altri di parere opposto, tra cui infine lo stessoAbate che – dopo avere ben meditato e messo per iscritto le proprie memorie –nel 1571 parlerà di «una cità con tanti poveri artista [...] sensa alcuno avia-mento, con tute le vitoalie in grandi precii», che può affidarsi solo alla miseri-cordia di Dio12. Il fatto che un uomo intelligente ed esperto di commerci e
207
11 K. J. BELOCH, Storia della popolazione d’Italia, Firenze, Le Lettere, 1994, pp. 590-598.12 A. ABATE, Cronache savonesi cit., pp. 224-226.
Una storia economica da fare
manifatture come l’Abate, vivendo in un periodo in cui la crisi della cittàdovrebbe essere conclamata, impieghi molto tempo e molto sforzo per giunge-re a una conclusione negativa, non può non farci riflettere e non indurci a pen-sare che forse la crisi ha perlomeno aspetti diversi, contraddittori, e può colpi-re una parte della popolazione proprio mentre un’altra trova ottime opportu-nità di profitto. Giulio Fiaschini, vent’anni fa, si è posto qualche domanda intal senso e ha risposto – a nostro avviso in maniera molto appropriata – checerto la città aveva subito un collasso di cui gli atti notarili forniscono varietestimonianze, ma forse non per tutti era facile rendersene conto, e c’erano dav-vero «i ricchi e i ricchissimi, e ancora venivano esibiti i segni dell’opulenza dainuovi signori del denaro che, affiancandosi o sovrapponendosi alle vecchiefamiglie di estrazione roveresca, godevano di ampie rendite fondiarie e, dei traf-fici, avevano in mano quel che restava»13.
Carlo Varaldo, che appunto sui notai del Cinquecento ha lavorato, non hadubbi sul tracollo seguito al 152814. «La contrazione del movimento del portoè impressionante e di estrema evidenza se mettiamo a confronto la situazionedel 1476 con quella del 1536. [...] Scompaiono quasi completamente le imbar-cazioni a grande tonnellaggio», e «sono anche i navigli medi e quelli minori asubire una fortissima riduzione». Venendo meno i «mezzi di trasporto maggio-ri che il porto non è più in grado di ospitare, si assiste alla scomparsa di tutte lerotte a più ampio raggio, e al ripiegamento del commercio marittimo savonesesui più limitati orizzonti tirrenici». A farne le spese sono naturalmente le mani-fatture locali, in primo luogo «l’attività portante dell’artigianato cittadino, laproduzione dei panni, che nel trentennio 1450-1480 occupava nelle sue varieoperazioni oltre il 40% della forza lavorativa» e nel 1536 ne occupa solo il21,8%; flessione in parte compensata dallo sviluppo della produzione di ber-rette, che tuttavia conoscerà anch’essa una crisi di lì a poco.
Miglior tenuta ha invece l’altro grande settore dell’artigianato cittadino, valea dire la concia delle pelli, anche se deve restringere sia l’area di approvvigiona-mento della materia prima, sia i mercati di sbocco, e se un gravissimo colpo leverrà portato dalla costruzione della fortezza, con la conseguente distruzione dinumerose concerie al fine di creare un’ampia fascia di rispetto. Tiene anche,paradossalmente, l’industria cantieristica (che tuttavia lavora prevalentementeper committenti non savonesi), e si fanno più attivi i traffici marittimi con lapenisola iberica grazie all’inserzione del Genovesato nell’area d’influenza spa-gnola. La flessione dunque c’è, ma non è così generale e drammatica comealtrove viene lamentato. Perfino uno dei più convinti costruttori della “vulgatacatastrofica”, Filippo Noberasco, ammette che non tutto decade e muore nellacittà: «I cantieri durarono e [...] pel 1664 e pel 1672 si ricordano vari di grossegalee. Attive rimasero le arti della figulina grossa e minuta, dei fabbri, della fila-tura. Le maioliche, poi, acquistarono fama europea»15. Anche Nello Cerisola
208
13 G. FIASCHINI, Savona: destino di una città minore cit., pp. 49-52.14 C. VARALDO, 1536, un anno nella crisi cit., pp. 81-91.15 F. NOBERASCO, Gli scrittori della città di Savona cit., p. 189.
Capitolo 13
riconosce che, dopo l’iniziale tracollo, le principali arti restano pur sempre vivee nel secondo Cinquecento, allorché sono ancora attive circa quaranta organiz-zazioni di mestiere, segnano una certa ripresa16. In particolare la ceramica, chesi era già ben affermata nella prima metà del Seicento, nella seconda parte delsecolo – quando le officine savonesi adottano i modelli decorativi del barocco– conosce un notevole incremento produttivo e acquista grande prestigio, tantoche il Senato della Repubblica concede ai fabbricanti il diritto di imprimere aimanufatti il loro marchio, in modo da differenziare e tutelare la loro produzio-ne17.
Il dato sul quale tutti gli autori concordano, anche perché in questo caso letestimonianze davvero non mancano, riguarda però la grande fioritura ediliziadella seconda metà del XVI secolo. Inizialmente c’è un notevole sforzo per rico-struire gli edifici e gli istituti religiosi “sfrattati” dal Priamàr: negli anni quaran-ta sorgono così in città numerosi oratori e la nuova sede dell’ospedale SanPaolo18. Ma prima ancora – è bene ricordarlo – nelle immediate vicinanze diSavona è stata innalzata e condotta «in poco più di tre anni a perfezione» la granmole del santuario dedicato alla Madonna di Misericordia, insieme con il primoospizio, «albergo de’ divoti forastieri e pellegrini», cui ne seguirà a partire dal1593 un secondo ben più imponente; e negli anni a venire il santuario è desti-nato ad essere un formidabile polo d’attrazione per nuove attività edilizie, deco-ri d’ogni genere, lasciti preziosi19. A partire dagli anni cinquanta delCinquecento, poi, è l’edilizia privata a richiamare notevoli investimenti: comegià abbiamo visto, le maggiori famiglie di antica o di più recente ricchezzafanno ristrutturare o costruire ex novo i loro palazzi, e in seguito li riempiono diarredi e di quadri preziosi. Bertolotto, Chiabrera, De Lorenzi, Ferrero, Gavotti,Naselli, Pavese, Raimondi, Siri, Sormano, Spinola: sono queste le casate prota-goniste della nuova stagione architettonica e urbanistica che testimonia l’esi-stenza di cospicue ricchezze e che probabilmente ha indotto gli interlocutoridell’Abate a ritenere la Savona di quegli anni più prospera che mai.
Sono le stesse famiglie di cui ci siamo occupati nel capitolo 7, quelle chehanno fatto fortuna, in stretto accordo con il patriziato genovese, approfittan-do delle molte occasioni offerte dall’inserimento di Genova nell’impero spa-gnolo. I loro investimenti nell’edilizia di prestigio – prima i palazzi di città, poisempre più spesso le belle ville suburbane nelle piane di Legino e di Lavagnola,o sul lungomare verso Zinola – rappresentano da un lato un immobilizzo, una“pietrificazione” di capitali che non alimentano più, come nel tardo medioevo
209
16 N. CERISOLA, Storia di Savona cit., pp. 274-277. 17 G. FARRIS, La ceramica savonese in età barocca, AMSSSP, n. s., vol. XIII, 1979, pp. 21-28. Si veda anche,
per il buon andamento delle manifatture fittili in genere – «l’arte sottile e l’arte grossa dei figuli», vale a dire lesia le ceramiche sia i laterizi – M. RICCHEBONO-C. VARALDO, Savona cit., p. 83.
18 C. VARALDO, Insediamenti religiosi e problemi urbanistici nella Savona post-tridentina, AMSSSP, n. s., vol.XIII, 1979, pp. 43-61.
19 Si vedano in proposito i saggi di Marco Ricchebono, Mauro e Vittorio Natale, Giuliana Algeri, ElianaMattauda, Magda Tassinari, Rosalina Collu e Flavia Folco nel citato volume La Madonna di Savona; e inoltreIl Museo del Santuario di N. S. di Misericordia a cura di G. ROTONDI TERMINIELLO, Savona, Marco Sabatelli,1999.
Una storia economica da fare
e nell’età d’oro dell’economia savonese, i commerci e le manifatture della città;ma d’altro lato indicano che per molto tempo a Savona – grazie a queste dina-stie di mercanti e finanzieri “genovesizzati” – continuano a giungere dall’esteroflussi cospicui di denaro, i quali si traducono in occasioni di lavoro e talvoltapersino di benessere per la popolazione locale: «le famiglie emigrate e annobili-te per i compri feudi a Napoli, in Sicilia, in Piemonte – riconosce FilippoNoberasco – nei continui rapporti colla madre patria recavanle ricchezze elustro»20. Più tardi, vi abbiamo già accennato, saranno anche alcuni esponentidell’aristocrazia della Dominante come i Balbi, i Doria, i De Mari, i Durazzo, iMultedo, gli Imperiale, i Cambiaso che si faranno costruire case di villeggiatu-ra a Savona e nei dintorni per andarvi a passare l’estate e l’autunno, al puntoche – secondo quanto sostiene uno studioso autorevole – nel Seicento gli abi-tanti della città «vivevano in gran parte dei beni e degli stanziamenti dei geno-vesi»21.
All’edilizia privata si affianca poi, in misura molto cospicua, quella religiosa:fra il tardo Cinquecento e la prima metà del Seicento vengono costruite, oristrutturate per adattarle ai dettami del concilio tridentino, numerose chiese;sorgono cappelle, oratori e opere pie; soprattutto si diffondono gli insediamen-ti degli ordini religiosi maschili e femminili. «Si tratta [...] di un mutamentodella fisionomia della città, letteralmente invasa da queste nuove istituzioni chefioriscono ad ogni passo e che [...] hanno la forza e il sostegno per mantenersiin vita. [...] Nel corso di un secolo, dal 1585 al 1692, si registrano oltre 50 can-tieri, di cui 34 rappresentati da costruzioni totalmente ex novo ed una decina dirifacimenti totali di edifici preesistenti»22. Sul finire del Seicento un’alta per-centuale dello spazio urbano – pari addirittura al 34,5% – risulterà così occu-pato da insediamenti religiosi23. L’invasione è tale che già nel 1628 gli Anzianiprotestano presso il Senato perché la città è «assai aggravata per le religioni nuo-vamente venute» ed è «hormai [...] convertita in chiese e conventi»24.
Tutti gli storici locali hanno riscontrato questo fenomeno, peraltro senzachiedersi da dove provengano i cospicui capitali necessari per pagare le costru-zioni e gli arredi. Eppure per saperlo basta scorrere la cronaca del Verzellino,dove a più riprese si menzionano le “rimesse” e i lasciti dei ricchi savonesi inse-diatisi nell’Italia meridionale o a Roma, e si sottolinea che spesso vengonoimpiegati – accanto ai denari profusi dai loro parenti rimasti in patria – appun-to per finanziare la realizzazione di edifici ecclesiastici e di opere pie, ma anche
210
20 F. NOBERASCO, Gli scrittori della città di Savona cit., p. 191.21 G. FARRIS, Gabriello Chiabrera, savonese di nascita e di elezione, in F. BIANCHI-P. RUSSO (a cura di), La scel-
ta della misura cit., pp. 51-74 (in particolare p. 51).22 C. VARALDO, Insediamenti religiosi cit., pp. 51-54 (dove sono elencate tutte le congregazioni religiose che
vengono a stabilirsi a Savona, i nuovi oratori, le chiese e le cappelle).23 Oltre al citato saggio di Varaldo, si veda: L. BOTTA, La riforma tridentina nella diocesi di Savona cit., pp.
85, 103-108, 173-174; M. RICCHEBONO, L’architettura religiosa del Seicento a Savona. Considerazioni prelimi-nari, AMSSSP, n. s., vol. XIII, 1979, pp. 63-96; G. B. N. BESIO, Savona. Il centro storico cit., pp. 34-35
24 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, p. 240; A. M. DE’ MONTI, Compendio cit., p.244.
Capitolo 13
di scuole gestite da religiosi quali i gesuiti o gli scolopi. Protagoniste sono dun-que ancora le stesse famiglie che abbiamo ricordato poc’anzi, e accanto ad essetroviamo numerosi membri del patriziato genovese, spesso gli stessi che com-paiono tra i benefattori del Santuario25, appoggiati anche dal governo dellaRepubblica, che a quegli insediamenti religiosi si mostra in genere favorevole.Emblematico, nel 1624, è l’arrivo a Savona delle monache Carmelitane scalzedi Santa Teresa: vi giungono guidate dalla priora Anna Maria Centurione,accompagnate da Gian Andrea Doria e da Francesco Maria Pavese, ospitate neipalazzi Spinola e Ferrero26: come si vede, l’iniziativa fa capo ad alcuni dei piùbei nomi tanto della Dominante quanto della città suddita, personaggi di soli-to imparentati fra loro, con analoghi stili di vita, abituati ad agire di concertotanto negli affari quanto nelle iniziative intraprese ad maiorem Dei gloriam e perla salvezza delle loro anime.
Bei palazzi, splendide ville suburbane, chiese monumentali, ricchezza semprepiù concentrata in poche famiglie che – assieme agli enti religiosi, alle mani-morte – si sono accaparrate quasi tutte le proprietà immobiliari urbane e rurali:è un’immagine che accomuna Savona a molte città italiane fra il tardoCinquecento e il Settecento. E anche qui, a smorzare le eventuali tensioni socia-li intervengono – oltre alla stessa disparità delle fortune, che al contrario diquanto spesso si pensa è un fattore di quiete, di rassegnazione – l’attività assi-stenziale di quelle opere pie che forniscono elemosine ai poveri e assistenza aglianziani, alle vedove, agli orfani, agli esposti; e l’organizzazione annonaria delComune, che garantisce il basso prezzo dei generi alimentari di base.
Quanto all’economia nel suo complesso, lo abbiamo già detto, il panoramanon è facile da delineare. Un autore come Guido Malandra, tanto documenta-to quanto disincantato e poco incline alla retorica municipalistica o al vittimi-smo, ha sostenuto che la Savona del tardo Cinquecento non è una città morta.Il suo commercio è certamente decaduto rispetto alla grande stagione quattro-centesca, ma resta vivace: nella sua darsena entrano il grano d’oltremare «desti-nato al mercato piemontese fino a Torino ed oltre, [...] le sabbie e le ceneri diProvenza e di Spagna destinate alle vetrerie di Altare, o le lane per i berrettai diSavona e i filatoi del distretto cittadino»; di lì partono per l’Italia meridionale eper il Levante i vetri altaresi, i ferri lavorati nelle ferriere dell’Appennino, i late-rizi e le maioliche, i tessuti, i berretti, i cuoi che ancora vengono prodotti dallearti cittadine. Il piccolo porto savonese resta un importante scalo terminale perle imbarcazioni che navigano il Tirreno fino alla Sardegna e alla Sicilia, o perquelle dirette verso la Provenza e la Spagna, anche se «non mancano gli appro-di di navi provenienti o dirette al Portogallo, alle Fiandre, all’Inghilterra e,all’opposto lato del Mediterraneo, alla Dalmazia, a Venezia, a Trieste»; senzacontare l’«intensa navigazione di piccolo cabotaggio lungo le due riviere liguri
211
25 Si veda ad esempio E. PARMA ARMANI, Un committente genovese per il Santuario della Misericordia diSavona tra Cinque e Seicento: Franco Borsotto, AMSSSP, n. s., vol. XXIX, 1993, pp. 59-94.
26 G. V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., vol. II, p. 197.
Una storia economica da fare
fino a Marsiglia da una parte ed all’estremo nord della Toscana dall’altra»27.Sono commerci e traffici che, lungi dal dare ombra alla Dominante, si possonosvolgere (e infatti continueranno a svolgersi) in pieno accordo con mercanti epatroni genovesi, oltreché con il beneficio delle dogane camerali e di SanGiorgio.
Per quel che riguarda le manifatture, certamente decadono quelle che si rivol-gevano a un mercato vasto sia per l’approvvigionamento delle materie prime, siaper la vendita dei prodotti finiti. Ma le arti che producono per il mercato inter-no «non risentono di alcuna apparente crisi [...] perché la relativa stabilità dellapopolazione mantiene pressoché inalterata la domanda»28; le fabbriche di late-rizi o le fornaci di calce possono addirittura conoscere un trend positivo legatoa quell’attività edilizia di cui abbiamo detto prima; e in genere certe produzio-ni più povere e andanti, come quelle delle terraglie e delle stoviglie, resterannofloride sino all’Ottocento e oltre. Ancor più prospero diviene, tra Sei eSettecento, il settore agricolo: le grandi famiglie savonesi e genovesi, che inve-stono nella costruzione di ville suburbane e si accaparrano porzioni sempre piùampie di terreno nelle fertili piane alle spalle della città, incrementano la coltu-ra di orti, agrumeti e frutteti, facendo dell’hinterland di Savona una sorta diparadiso terrestre – come ancora ricordano le persone nate nei primi decennidel Novecento – che la civiltà industriale si incaricherà poi di devastare senzapietà.
Chi voglia giudicare l’economia savonese di quei secoli, deve comunqueprendere in considerazione il quadro generale della decadenza italiana, per nonimputare alla realtà locale (e in particolare ai rapporti tra Genova e Savona) ciòche invece è comune a gran parte della penisola; e d’altro lato deve stare atten-to a non dare troppo credito ad alcune testimonianze ricorrenti, che disegnanoun panorama assolutamente catastrofico. Chi scorra le filze e i registri della cor-rispondenza tra il Comune savonese e il Senato di Genova si imbatte in unaserie interminabile di lamenti sul commercio e sulle manifatture che languono,sulle «aversità continue», sulle «contingenze pessime de’ tempi calamitosi», sulla«annichilatione di quasi tutte l’azende private» e «l’estintione delle famiglieintiere», sulla fuga continua di mercanti e artigiani che non possono più trova-re alcuna opportunità di lavoro e di guadagno.
Quella che viene presentata è un’immagine sempre più disastrosa della città,e ci troviamo di fronte a un formulario di querimonie (la situazione, si dice ognivolta, è giunta allo stremo, la miseria e lo spopolamento sono totali, ogni atti-vità è prossima a morire) che proprio per la loro ossessiva ripetitività finisconoper divenire poco credibili. Anche perché spesso, se conviene farlo, l’immagineviene improvvisamente ribaltata. È cio che accade, ad esempio, nel 1648, dopo
212
27 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., p. 28. All’inizio dell’Ottocento l’anonimo autore dell’opuscoloRiflessioni sopra la decadenza della marina savonese e mezzi di ristabilirla (Savona, Stamp. Sabazia, 1816), purpronunciando giudizi molto negativi sulla dominazione genovese, ricorda giustamente che il vero tracollo diquella marina avviene in età napoleonica, quando «quei miserabili avanzi di risorse, che ancora le rimanevano,furono ridotte al nulla» (ivi, p. 18).
28 G. MALANDRA, Bernardo Ferrero cit., p. 32.
Capitolo 13
il funesto scoppio della polveriera del Priamàr: a quest’epoca la città, a giudica-re dalle molte lagnanze dei suoi amministratori, è entrata da tempo in una spi-rale di crisi irreversibile; ma nelle istruzioni fornite all’«oratore» AgostinoGiancardi, il quale deve andare a perorare la causa di Savona presso il Senato, sifa presente che l’esplosione ha rovinato «l’arte de’ bottari che governavano gros-so numero di gente e davano grand’utile alle gabelle per l’introduzione deilegnami da far botti e barrili»; che ha ucciso «diversi buoni artisti, revendaroli,pescatori, osti, tavernari, gente tutta di guadagno e alle gabelle profittevole»; cheha danneggiato i magazzini del Magistrato del Vino il quale «era per così direla miniera di questa città, calcolandosi che fruttasse da lire 14.000 circa l’an-no»29.
C’è una regola, a tutt’oggi seguita da ogni contribuente quando si rivolge alfisco, secondo la quale bisogna negare ogni profitto e amplificare le perdite. Ec’è un’altra regola, cui si uniforma chiunque solleciti dall’autorità il risarcimen-to di un danno, in base alla quale si deve dire che gli affari andavano benissi-mo. A entrambe queste regole si attengono gli amministratori savonesi fra ilCinquecento e il Settecento, cosicché l’immagine della loro città che ne vienefuori è un po’ contraddittoria. Intanto quella continua giaculatoria che siriscontra nelle lettere spedite dal Comune alla Dominante – su cui la storio-grafia locale ha talora fondato il giudizio pesantemente negativo riguardo agli“anni genovesi” – viene improvvisamente meno se si esaminano i documentiinterni all’amministrazione savonese, per esempio i registri delle deliberazionidel «Consiglio grande» o quelli contenenti gli atti degli Anziani30. Ma nella stes-sa corrispondenza con il Senato si assiste a un’altalena continua tra la denunciadi una situazione calamitosa – quando si chiedono sgravi fiscali, sussidi, prov-videnze di vario genere – e l’ammissione di un discreto andamento economicoquando invece si chiedono rimborsi, o si supplica di non fare innovazioni chepotrebbero compromettere il buon andamento di un’attività: così quando l’ar-te dei «bombaciari» di Savona protesta nel 1641 perché i Censori di Genovavorrebbero imporre un certo disciplinare (circa la larghezza e il numero dei fili)alle loro «bombacine» o cotonine, si fa presente che ciò rischia di distruggereuna manifattura «con la quale si mantengono quattromila anime in più»31.Analoga la disputa che nel 1707 oppone ai Censori genovesi gli «ontori», cioè iconciapelli, e anche in questo caso si rileva da parte savonese che quest’arte (laquale secondo alcuni storici sarebbe già quasi sparita da molto tempo) non vaassolutamente molestata perché è una «delle più conspicue», e «la fabrica de’coiri d’essa città è molto stimata e produce molto traffico»32.
Nel 1703 un tentativo di tassare le canape piemontesi che i mercanti savo-nesi spediscono per mare a Livorno e in altri luoghi suscita proteste perché quel
213
29 G. GALLOTTI, 7 luglio 1648 cit., pp. 233-234.30 ASS, Comune I, 54-63 e 68-117.31 ASS, Comune I, 210, libro III, c. 40r-v.32 ASS, Comune I, 21, c. 57.
Una storia economica da fare
commercio è florido e non si deve rischiare di comprometterlo33. Nello stessovolgere di anni un’altra protesta contro il fisco ci informa sui grandi quantitati-vi di pesci «scabecciati o salati» che da Savona «si mandano in Lombardia ePiemonte»34. Nel 1723 gli Anziani si lamentano perché la strada diCantagalletto, che porta sulle alture alle spalle della città, è assai danneggiata acausa del continuo trasporto «di grossissimi legni che dalla parte di Cadibonacalano [...] a Savona strascinati da dieci sino in quattordeci e più paia di bovi,oltre quelli che sopra pesanti carrettoni si introducono per le strade della cittàal ponte e al molo in uso delle fabbriche de’ bastimenti»35: la menzione di que-sti cantieri che consumano tanto legname sfugge, quasi inavvertitamente, inmezzo ai continui pianti sulle «grandi angustie e miserie in quali si trova questafedelissima città caosate dal poco trafico».
Nel 1727 il Comune propone a San Giorgio di divenire per 50 o 100 anni,o meglio ancora in perpetuo, appaltatore della gabella dell’ancoraggio – quellapagata dai battelli che entrano nella darsena savonese – perché ha un ottimogettito, tanto che ogni anno rende quanto basta «non solo a far le paghe» (cioèa corrispondere gli interessi) su 400 luoghi che la città ha avuto in prestito, maanche a finanziare per 8-10.000 lire i lavori di dragaggio del porto36. Nel 1670gli amministratori comunali, alla ricerca di un introito aggiuntivo per fare fron-te al deficit del bilancio comunale, chiedono al Senato di poter aumentare lagabella delle fornaci che si paga sulla «fabrica de vasellami sottili e grossi e demattoni», di cui si fa buon commercio, e specialmente «della mercantia sottilese ne smaltisce gran quantità fuori Stato». Il Governatore conferma l’opportu-nità dell’aumento, rilevando che l’affare dei vasellami «a quelli che li maneggia-no porta tanti utili, che di gente miserabile si sono tutti di breve tempo inri-chiti, onde quando vi si aggionga qualche poco peso è da credere vi haverannoancora utili giovevoli»37. Questa volta – come è facile indovinare – sarà l’arte deifiguli a piangere miseria, sostenendo che non si possono colpire pochi e picco-li produttori, «i quali sono per propria conditione huomini di villa e poveri, equel che più preme restano per altri capi tanto aggravati che col detto accresci-mento riesce a loro insoportabile il carico», tanto che saranno «obligati a mutararte o paese»38.
214
33 ASS, Comune I, 143, 22 novembre 1703.34 ASS, Comune I, 215, s.d.35 ASS, Comune I, 210, libro III, 4 agosto 1723.36 Ivi, 21 novembre 1727.37 ASS, Comune I, 214, 15 luglio 1670 e 19 settembre 1671.38 Ivi, 22 gennaio 1672. Nel 1677 i Censori savonesi compiono un’inchiesta sulle fornaci da mattoni e ne
censiscono tre antiche (una grande a Zinola, di proprietà di Paolo Givetto; una media e una piccola alle Fornaci,di proprietà rispettivamente di Giuseppe Siccardo e Andrea Rinaldo) e otto nuove i cui proprietari sonoGiovanni Battista Valdora, Battista Fiamberto, Stefano e Francesco Salamone, Bernardino Scotto, BartolomeoSerisola. La produzione totale è di oltre 306.000 mattoni per ogni «cotta» o «fornaxiata». L’inchiesta approda aun nuovo aumento d’imposta «per ogni fornaciata di mattoni, coppi et altro», naturalmente tra le proteste deifornaciai, i quali sostengono che gli affari vanno male e che la gabella andrebbe semmai ridotta (ivi, s. d. [ma1677] e 1 febbraio 1678).
Capitolo 13
Le citazioni di questo tipo si possono facilmente moltiplicare, e anche se diper sé non ci dicono nulla di certo sull’economia cittadina, servono almeno afarci diffidare dell’immagine desolata che si ricava da altre fonti. Le manifattu-re, benché ridotte rispetto al periodo tardomedievale, continuano ad essere invita, come dimostrano anche i molti corpi di mestiere presenti. A metà delSeicento una «lista dell’arti della fedelissima città di Savona» ne elenca unnumero notevole e un campionario ragguardevole: «camalli; misuratori dellaRaiba [cioè del mercato dei grani]; pescatori; molinari; ortolani; osti e taverna-ri; basteri, sellari e brillari [cioè fabbricanti di basti, selle e briglie]; mastri d’a-scia, carafatti e remorari; censari [sensali]; revendaroli; pignatari di vasi sotili ed’arte grossa; muratori e picapietre; barillari; ferrari; chiapuzzi e calderari; for-maggiari; tessitori di panni; fornari; cartari e librari; bottari; cassiari; tentori;callegari; pellizzari; cirusici e barbieri; sartori; calzolari; ontori; filatori di gros-so e sottile; bombaciari; merzari; barrettieri; lanieri; fraveghi [orefici]; speciali edroghieri»39. È un elenco che da un lato comprende molti mestieri “piccoli”,presenti in ogni modesto centro abitato; ma d’altro lato annovera artigiani dimanifatture importanti, capaci di alimentare flussi commerciali. Prova ne siache se la Camera genovese e ancor più la Casa di San Giorgio – lo abbiamo visto– sono sempre restie a liberalizzare il commercio e la navigazione dei savonesi,non lo fanno perché temono la concorrenza da parte di una città e di un portoche ormai non possono certo fare ombra alla Dominante, ma perché nonvogliono rinunciare agli introiti doganali e gabellari che quel commercio è ingrado di assicurare.
Tra la fine del Seicento e buona parte del Settecento il Comune, tramite lemagistrature dei «Regolatori ordinari» e dei «Regolatori straordinari d’arti»,riforma i capitoli di molti corpi di mestiere, compresi alcuni che non si trova-no nella lista precedente: «archibuggieri», «tessitori di calzette», farmacisti,«fidelari», «ferrarii», «stoppieri», marinai, tessitori di tele, «capellari» (cioè par-rucchieri e acconciatori), «guantieri e profumieri», «drapperi», mulattieri, «tor-nadori» (tornitori di legno)40. Sono riforme che da un lato indicano la persi-stenza di una discreta attività artigianale e manifatturiera, ma d’altro lato segna-lano una progressiva sclerosi delle arti, che irrigidiscono i loro regolamenti e icriteri di accesso perché il mercato si restringe e bisogna difendere ad ogni costole posizioni acquisite. D’altronde, lo ripetiamo, man mano che si avanza neisecoli XVII e XVIII Savona è sempre meno una città “industriale” e sempre piùun luogo di residenza per rentier i quali, siano essi di famiglia savonese o geno-vese, hanno riunito nelle proprie mani grosse proprietà fondiarie intorno ai loropalazzi di campagna e vi hanno fatto investimenti per renderle ad un temposplendidi luoghi di villeggiatura e aziende produttive di vino, frutta, ortaggi.
Giulio Cesare Croce, il geniale creatore di Bertoldo, visita Savona sul finiredel Cinquecento e ne riceve un’impressione tanto buona che celebrerà in versi
215
39 ASS, Comune I, 202, s. d. (forse 1659).40 ASS, Comune I, 61, 62, 63 e 211, passim.
Una storia economica da fare
quel luogo «colmo d’ogni piacere, d’ogni diletto», popolato da uomini cortesi,dame leggiadre, gente «grassa, sana e rubiconda», dove gli orti e i frutteti sonoubertosi e non c’è mai carestia: «La città di persone e di ricchezze/Può star alparagon de l’altre tutte»41. Pochi anni dopo, una Descrizione di luoghi e terreappartenenti alla Serenissima Repubblica di Genova ricorda che Savona «è orna-ta in tutto il cerchio di belli giardini e belle ville a modo di Genova»42. In unaquasi coeva Descrittione ad opera del geografo Giovanni Antonio Magini e delletterato Ippolito Landinelli Savona è reputata «città illustre, antichissima,nobile, fertile per tutte le cose e per il vitto humano e mercantile, la primadoppo Genova di tutte le città di questo Dominio»43. Intorno al 1700 lo stori-co Filippo Casoni, in una sua Breve descrittione della Liguria, sostiene a sua voltache «Savona doppo Genova è la più nobile città della Liguria, et alla sua magni-ficenza corrispondono le fabbriche pubbliche e private, sicome anche le ame-nità e fertilità del territorio e le famiglie qualificate che compongono la di leinobiltà»44.
Non bisogna credere ciecamente a questi testi, che talora si copiano l’un l’al-tro e magari si rifanno a più antiche descrizioni quattrocentesche, ma troppetestimonianze concordano sul fatto che Savona, nei secoli della decadenza, è unluogo di grande piacevolezza, nel quale non a caso si villeggia volentieri, e vi siricevono grandi personaggi, si fanno feste, si allestiscono banchetti. Viceversa,come abbiamo visto nel capitolo 11, sul finire del Settecento alcune voci in senoal ceto dirigente genovese denunciano che la città è in agonia. Ma a ben vede-re tra le immagini ridenti e quelle cupe non c’è vera contraddizione: l’agricol-tura è prospera, i terreni sono coltivati a regola d’arte (qualche anno dopo susci-teranno l’ammirazione del grande prefetto napoleonico Chabrol), le ville sonosplendide. Una douceur de vivre vi è diffusa non solo tra i ricchi abitanti deimaggiori palazzi, ma anche – in un certo senso – tra una popolazione più vastache si muove intorno ad essi: servitori, fornitori, «manenti» e coltivatori dei loropoderi, o gente che abita e lavora sulle terre della Chiesa.
Si può ragionevolmente pensare che le immagini di miseria e fame siano ingenere menzognere, che nella città e nei suoi dintorni si viva abbastanza bene,ciascuno al suo livello. Eppure tutto vi è come bloccato, imbalsamato, senzafuturo, con una popolazione che non riesce a crescere perché non può contaresu risorse nuove (e viene quasi la tentazione di paragonare la Savona settecente-sca a quella degli ultimi decenni del Novecento, che dopo la rapida deindu-strializzazione ha conservato ottimi livelli di vita, ma al prezzo di un comples-sivo immobilismo, di un ripiegamento demografico, di una perdita di prospet-tive soprattutto per i più giovani). La «città fedelissima» ha compiuto un per-corso simile a quello di tante altre realtà urbane dell’Italia moderna, e special-
216
41 F. CROCE, Savona cinque-seicentesca: Giulio Cesare Croce e Gabriello Chiabrera, AMSSSP, n. s., vol. XIII,1979, pp. 147-155.
42 M. P. ROTA (a cura di), Una fonte per la geografia storica cit., p. 97.43 M. QUAINI (a cura di), La conoscenza del territorio cit., p. 157.44 Ivi, p. 204.
Capitolo 13
Una storia economica da fare
mente delle civitates subiectae, vissute all’ombra delle rispettive dominanti,“colonizzate” dai loro patriziati, sempre più piene di chiese e di conventi, sem-pre più vuote di opifici: luoghi sprofondati in un letargo magari piacevole, masenza via d’uscita. Ci sono delle responsabilità precise, in tutto questo, da partedi Genova e del suo governo? Probabilmente no, perché si è trattato di un pro-cesso comune ai vari Stati della penisola, favorito dalla generale decadenza ita-liana che ha colpito specialmente le economie cittadine. Anche la distruzionecinquecentesca del porto, pur gravissima, non è stata di per sé sufficiente a can-cellare le attività commerciali e manifatturiere; ma pian piano la proprietà ter-riera e la rendita fondiaria hanno assunto un ruolo sempre più importante,mentre gli interessi e gli stili di vita di un’aristocrazia savonese fatta di rentier sisono trovati a coincidere con quelli dei patrizi genovesi e del loro governo, il chene ha rafforzato il conservatorismo e l’immobilismo.
Insomma, più che parlare di una perversa e oppressiva condotta dellaDominante, bisognerebbe accusare un meccanismo complesso, in base al qualela comunità suddita è stata progressivamente svuotata di energie e di potenzia-lità, e consegnata alla leadership di un ceto che appunto su quella stagnazioneha fondato la propria stabilità, la propria capacità di perpetuarsi nei secoli comegruppo dirigente.
217
Abate, Agostino, 20, 29, 45, 48, 50, 109, 122, 138, 154, 157, 163, 207-209Adelasia, 133Adorno, famiglia, 33-36, 51, 116Adorno, Antoniotto, 43Adorno, Geronimo, 44Adorno, Girolamo, 78Ago, Renata, 111, 118Airaldi, Gabriella, 29, 30, 63Alberti, Leandro, 171Aleramo, 133Algeri, Giuliana, 209Amedeo VIII, duca di Savoia, 63Anderson, Perry, 67Arbora, Gerolamo, 133Asburgo, dinastia, 111, 116Assereto, Giovanni (1842-1916), 20, 89Assereto, Giovanni, 20, 23, 65, 69, 77, 97, 103, 121, 124, 139, 147-149, 158,
164, 165, 171, 181Astengo, Andrea, 19, 123Ávalos, Alfonso d’, marchese di Pescara, 43, 155Aymard, Maurice, 115
Balbi, famiglia, 93, 119, 210Balbi, Giovanna, 134Baldisone, Giulio Cesare, 130Barbarossa, vedi Khair ad-dinBarberini, famiglia, 110Barberino, Antonio, 50Barbieri, Franco, 62Barlettaro, Caterina, 162Barrili, Anton Giulio, 159Bassignani, Giovanni, 169Becalla, famiglia, 35Becker, Marvin B., 59Belloro, Giovanni Tommaso, 130Beloch, Karl Julius, 207Benvenuto, Grazia, 77Benzoni, Gino, 66Berengo, Marino, 58, 61, 62, 64, 65, 68, 69
219
Indice dei nomi
Beretta, Gasparo, 161Bertelli, Sergio, 127Bertoldo, 144, 215Bertolotto, famiglia, 109, 112, 209Bertolotto, Giovanni Antonio, 112Bertolotto, Nicolò, 112, 117Besio, Giovanni Battista Nicolò, 25, 86, 205, 210Besio, Lorenzo, 128Bianchi, Fulvio, 33, 210Bianchi, Paola, 65Biondo, Flavio, 34Bitossi, Carlo, 33, 73, 80, 85, 87, 99, 100, 120, 123, 127, 158, 180, 190, 194Bizzocchi, Roberto, 126Boccalandro, famiglia, 109Boccanegra, Simone, 34Boccardo, Piero, 110Boccone, famiglia, 109, 112Bonfadio, Jacopo, 39, 48, 125Bongiovanni, Giuseppe, 158Borghese, famiglia, 110, 121Bornate, Carlo, 47Boselli (o Bosello), Giovanni Battista, 186Boselli, Paolo, 17-21, 29, 35Bosello, Francesco Felice, 101Botta, Antonio, 83Botta, Leonardo, 80, 82-84, 210Bottini, Giuseppe, 130Bracelli, Giacomo, 34Braudel, Fernand, 113Bresciano, famiglia, 35Brignole, famiglia, 93Brignole Sale, Anton Giulio, 88Brignone, Giacomo, 112Brunetta, Ernesto, 58, 63, 65, 155Bruno, Agostino, 16, 19, 48, 74, 75, 82, 84, 89, 110Bruno, Federico, 93, 205Brusco, Giacomo, 190Bruzzone, Gian Luigi, 85Bulferetti, Luigi, 166, 178, 179
Caffaro, 134Cadenas y Vincent, Vincente de, 47Calcagno, Paolo, 175Calenda di Tavani, Andrea, 16Calegari, Manlio, 180, 188, 190
220
Indice dei nomi
Calleri, Nicola, 112Calvini, Nilo, 127Cambiaso, famiglia, 91, 170, 210Campana, Marc’Antonio, 121Campana, Orazio, 121Cancellieri, famiglia, 61Capra, Carlo, 136Carlo IV di Lussemurgo, imperatore, 132Carlo V d’Asburgo, imperatore, 42-44, 46, 47, 49, 53, 54, 57, 111, 112, 114,
129, 131Carlo VIII di Valois, re di Francia, 37, 39, 60Carlo Emanuele I, duca di Savoia, 87, 158, 159Carlo Emanuele II, duca di Savoia, 88, 159Carlo Emanuele III, duca di Savoia, 134Carrara, Francesco II da, detto Novello, signore di Padova, 60Carraresi (o da Carrara), famiglia, 9Casoni, Filippo, 45, 52, 193, 216Castiglia, Marco, 128, 130, 133Cattaneo, Carlo, 15Cattaneo, Silvestro, 98Catullo, famiglia, 35Celesia, Pietro Paolo, 187Centurione, famiglia, 80, 115, 118Centurione, Andrea, 76Centurione, Anna Maria, 211Cerisola, Bartolomeo, vedi Serisola, Bartolomeo.Cerisola, Nello, 17, 20, 25-27, 29, 109, 123, 135, 150, 153, 168, 202, 205,
208, 209Cerrato, famiglia, 35Cevini, Paolo, 163Chabrol de Volvic, Gilbert-Joseph-Gaspard, 24, 171, 216Chiabrera, famiglia, 110, 209Chiabrera, Gabriello, 87Chilese, Valeria, 66Chittolini, Giorgio, 15, 16, 25, 26, 58-60, 67Cipollina, Clara, 167Clemente VII (Giulio de’ Medici), papa, 53Codeviola, Michele, 190Colesanti, Massimo,Collu, Rosalina, 209Coniglio, Giuseppe, 116Conte, famiglia, 109, 112Corradengo Niella, Pantaleo, 111Corsi, Benedetto, 117Corsi, Girolamo, 117
221
Indice dei nomi
Cortino, Giacomo, 128Cosimo I de’ Medici, granduca di Toscana, 55Costa Restagno, Josepha, 171Costantini, Claudio, 88, 124, 166, 171-173, 178, 179Cozzi, Gaetano, 58, 63, 66Crema, Giuseppe, 113Croce, Franco, 216Croce, Giulio Cesare, 215Crosetti, Alessandro, 37Curtino, Lorenzo, 176Cybo, famiglia, 57
Dal Pane, Luigi, 187De Franceschi, Gian Antonio, 149De Franchi, Giacomo Maria, 132, 133De Franchi, Marco, 163Del Carretto, famiglia, 100, 105Della Rovere, famiglia, 111Della Rovere, Clemente, 117Della Rovere, Giovanni Filippo, 115Dellepiane, Riccardo, 48, 79, 193De Lorenzi, famiglia, 110, 209De Lucchi, Giacomo, 197, 198De Mari, famiglia, 80, 93, 116-119, 210De Mari, Agostino, 150De Mari, Ansaldo, 161De Mari, Gerolamo, 143, 144De Mari, Nicolò, 94, 180, 190, 191Dewald, Jonathan, 67Doria, famiglia, 34, 35, 83, 93, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 158, 210Doria, Andrea, 25, 42, 46-48, 55, 57, 111, 114, 116, 124, 135Doria, Carlo, 112Doria, Filippino, 47, 48Doria, Francesco Gaetano, 188Doria, Francesco Maria, 134, 160, 180, 189, 190Doria, Gian Andrea, 112, 211 Doria, Giorgio, 49, 65, 118Doria, Giovanni Battista, 74, 103, 104Doria, Ottaviano, 117Doria Del Carretto, Carlo, 112Drake, Francis, 111Durazzo, famiglia, 80, 93, 119, 121, 210Durazzo, Cesare, 103, 121Durazzo, Eugenio, 121, 150Durazzo, Girolamo, 121
222
Indice dei nomi
Durazzo, Marcello, cardinale, 121Durazzo, Marcello, 188Durazzo, Vincenzo Maria, 121
Emanuele Filiberto, duca di Savoia, 52, 84, 158Enrico VI di Svevia, imperatore, 26, 132Eugenio IV (Gabriele Condulmer), papa, 61
Falconieri, famiglia, 110Fara, Amelio, 163Farnese, Alessandro, 112Farnese, Pier Luigi, vedi Pier Luigi Farnese, duca di Parma,Farris, Giovanni, 19, 87, 122, 123, 129, 210Farris, Guido, 209Fasano Guarini, Elena, 58, 91Federici, Federico, 123, 129Federico I di Svevia, detto Barbarossa, imperatore, 26, 129Federico II di Svevia, imperatore, 26, 27, 114, 127, 131, 132Felloni, Giuseppe, 136, 141, 142Feo, famiglia, 112, 118Feo, Giovanni Battista, 111Ferdinando I d’Asburgo, imperatore, 131Ferdinando II d’Asburgo, imperatore, 131Ferdinando II, detto il Cattolico, re d’Aragona, 40Ferrero, famiglia, 35, 100, 109, 110, 112, 117, 118, 209, 211Ferrero, Anna Maria, 80Ferrero, Bernardo, 117Ferrero, Cesare, 83Ferrero, Francesco, 117Ferrero, Giovanni Antonio, 115Ferrero, Giovanni Battista, 93, 120, 133Ferrero, Giovanni Francesco, 115, 117Ferrero, Giuseppe, 111Ferrero, Lorenzo, 93Ferrero, Marc’Antonio, 117Ferrero, Nicolò, 115Ferrero, Ottaviano, 115Ferrero, Paolo, 115Ferrero, Pietro Battista, 90Ferrero, Raffaele, 115Fiamberto, Battista, 214Fiaschini, Giulio, 18, 36, 40, 45, 47, 127, 154-156, 168, 208Fieschi, famiglia, 57, 80, 118Fieschi, Filippino, 48, 124Fieschi, Geronimo, 98
223
Indice dei nomi
Fieschi, Gian Luigi, 54Filippo II d’Asburgo, re di Spagna, 54, 112, 115, 158Filippo III d’Asburgo, re di Spagna, 112Filippone, Filippo, 178Fleury, André-Hercule, 134, 160Foglietta, Oberto, 125Folco, Flavia, 209Fornari, Giovanni Battista, 52Forni, Arnaldo, 15Forti, Leone Carlo, 159Francesco di Borbone-Vendôme, conte d’Enghien, 155Francesco I di Valois, re di Francia, 41-46, 53, 54, 154Francesco I Sforza, duca di Milano, 36Francesco II Sforza, duca di Milano, 53, 54Franchello, Dario, 81Fregoso, famiglia, 33-36, 51Fregoso, Gian Galeazzo, 34Fregoso, Giano, 34Fregoso, Ottaviano, 41Fregoso, Tommaso, 34
Galasso, Giuseppe, 29, 49, 58, 60, 63, 88, 91, 116, 136, 168Galiani, Ferdinando, 187Gallotti, Giovanni, 201, 213Gambarana, Severo, 112Gara, Pietro, 122Garbarino, Ofelia, 162Garoni, Nicolò Cesare, 16Gastodengo, famiglia, 109, 115Gastodengo, Giovanni Giacomo, 112, 115Gavotti, famiglia, 35, 100, 110, 111, 117, 118, 120, 149, 209Gavotti, Angelo, 87Gavotti, Gasparo, 111Gavotti, Giovanni Battista, 93Gavotti, Giulio, 112Gavotti, Nicolò (sec. XVII), 93Gavotti, Nicolò, 118Gavotti, Vincenzo, 111Geloso, Francesco, 111Geloso, Giovanni Antonio, 111Geloso, Girolamo, 111Geloso, Giuseppe, 111Gentile, famiglia, 80Gentilricci, Andrea, 124Giacchero, Giulio, 57, 165, 172
224
Indice dei nomi
Giacomone Piana, Paolo, 79, 193Giancardi, Agostino, 213Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano, 33Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano,Gian Gastone de’ Medici, granduca di Toscana, 126Giovanni d’Austria, don, 112Giovio, Paolo, 49Girinzana, famiglia, 149Giuffrida, Romualdo, 115Giulio II (Giuliano Della Rovere), papa, 36, 37, 41, 61, 113, 115, 122Giustiniani, famiglia, 116, 118Giustiniani, Agostino, 36, 45, 121, 125, 205Giustiniani, Michele, 123Givetto, Paolo, 214Gorani, Giuseppe, 86, 205Gorrini, Giacomo, 142Grasso, famiglia, 35, 109, 112Grasso, Giovanni Battista, 93Greco, Gaetano, 64Gregorio XIII (Ugo Boncompagni), papa, 100Gregorio XV (Alessandro Ludovisi), papa, 111Grendi, Edoardo, 89, 205Grimaldi, famiglia, 80, 116, 118Grimaldi, Alessandro, 162Grimaldi, Giovanni Battista, 180-190Grimaldi, Nicolò, 175, 176Grimaldi, Pierfrancesco, 180Grubb, James S., 62Guderzo, Giulio, 63, 66Guicciardini, Francesco, 40, 44, 47, 49Gustavo, Gerolamo, 82
Imperiale, famiglia, 115, 118, 119, 210Imperiale, Gian Vincenzo, 159Imperiale Lercari, Cristoforo, 75Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi), papa, 27Innocenzo VIII (Giovanni Battista Cybo), papa, 115Invrea, Antoniotto, 169
Khair ad-din, detto Barbarossa, 54, 155Knapton, Michael, 58, 63Kula, Witold, 72
La Forêt, Jean de, 54Lamberti, famiglia, 133
225
Indice dei nomi
Lamberti, Angelo, 122Lamberti, Giuseppe, 113Lamberti, Maria Carla, 206Landinelli, Ipplito, 216Leoncini, Luca, 121Leone X (Giovanni de’ Medici), papa, 41Lercari, famiglia, 118Levi, Giovanni, 64Lévy, Fabien, 43Lisciandrelli, Pasquale, 46Lomellini, famiglia, 93, 115Lomellini, Giacomo, 88Lomellini, Marc’Aurelio, 100Ludovico Sforza, detto il Moro, duca di Milano, 31, 36, 40Luigi XI, re di Francia, 39, 61Luigi XII, re di Francia, 40-42Luigi XV di Borbone, re di Francia, 134, 160Luzzati, Michele, 60
Macchia, Giovanni, Maculano, Gaspare, vedi Vincenzo da Fiorenzuola. Magini, Giovanni Antonio, 216Malandra, Guido, 50, 70, 74, 82, 93, 99, 113, 117, 205, 206, 211, 212Mallett, Michael E., 59, 60, 62Mannori, Luca, 67, 77, 98Marín, Fernando, abate di Nájera, 44Marx, Karl, 32Massa Piergiovanni, Paola, 65Massucco, Rinaldo, 17, 153-156, 161, 162Mattiauda, Eliana, 84, 113, 209Mattozzi, Ivo, 66Merlin, Pierpaolo, 168Merlotti, Andrea, 65Mita Ferraro, Alessandra, 60Molho, Anthony, 59Molteni, Ferdinando, 18, 80, 85Mombelli Castracane, Mirella, 118Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di, 20, 205Monti, Agostino Maria de’, 20, 28, 29, 44, 48, 49, 72, 80, 87, 99, 104, 121,
122, 156, 159, 164, 172, 201, 210Moretta, Francesco Solaro conte di, 47, 48Motta, Giovanna, 115Mozzarelli, Cesare, 49Multedo, famiglia, 119, 210Multedo, Francesco, 87, 112
226
Indice dei nomi
Muratori, Ludovico Antonio, 134Murialdo, Giovanni, 113Musi, Aurelio, 49, 116, 117Musso, Domenico, 133Musso, Riccardo, 18, 27, 28, 30, 32-35, 51, 92, 100Muzio, Giacomo, 115
Nada Patrone, Anna Maria, 29, 63Nano, famiglia, 112Naselli, famiglia, 109, 110, 209Natale, Mauro, 209Natale, Vittorio, 209Navarro, Pedro, 154Negrone, famiglia, 118Neri, Francesca, 61Nicolini, Angelo, 18, 30, 31Nicora, Maria, 93Noberasco, Filippo, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 40, 45, 50, 89, 90, 109, 112, 122,
123, 153-155, 205, 208, 210Noberasco, Maria Teresa, 104
Ottone I di Sassonia, imperatore, 133Ottone IV di Brunswick, imperatore, 27, 132
Pacini, Arturo, 41-45, 53, 114Pallavicino, famiglia, 83, 93, 112, 114Pallavicino, Agostino, 52Pallavicino, Gian Domenico, 79Palmieri, Matteo, 60Panciatichi, famiglia, 61Pandiani, Emilio, 37, 41Paolo III (Alessandro Farnese), papa, 61, 84, 111Paolocci, Claudio, 18, 80Parma Armani, Elena, 211Passano, Giovanni Battista, 121Pastor, Ludwig von, 61Patricolo, Roberto, 115Pavese, famiglia, 35, 100, 109, 110, 112, 113, 118, 209Pavese, Camillo, 93, 112Pavese, Filiberto, 112Pavese, Francesco Maria, 93, 211Pavese, Giovanni Battista, 19, 111, 123, 129, 133Pavese, Nicola (o Nicolò), 93, 112, 117Pavese, Scipione, 111Pavoni, Romeo, 26, 29, 30, 37, 65
227
Indice dei nomi
Pescara, marchese di, vedi Ávalos, Alfonso d’, marchese di.Pezzolo, Luciano, 59Piergiovanni, Vito, 26, 27Pier Luigi Farnese, duca di Parma, 54Pinelli, famiglia, 115, 118Pini, Antonio Ivan, 91Pinto, Giuliano, 61Pistarino, Geo, 18Poggi, Poggio, 20, 154Poggi, Vittorio, 20, 154Policardi, Domenico, 190Politi, Giorgio, 63, 94Pollero, Filippo Alberto, 82, 133Pozzobonello, famiglia, 35, 118Pozzobonello, Ambrogio, 111Pozzobonello, Francesco, 111Preto, Paolo, 62Pugliese, Salvatore, 126Puncuh, Dino, 18, 127
Quaini, Massimo, 34, 159, 160, 162, 169, 193, 216
Raimondi, famiglia, 109, 112, 113, 118, 209Raimondi, Alessandro, 116Raimondi, Marcello, 117Raimondi Feo, Girolamo, 111Raimondi Feo, Pietro, 117Rapetti, Giovanni, 193, 194, 196, 198Ravaschieri, famiglia, 116Rella, Andrea, 112Rella, Bartolomeo, 112Rella, Nicolò, 112Rella, Urbano, 112Riario, famiglia, 149Riario, Bartolomeo, 93Riario, Paolo, 84Riario, Tommaso, 115, 117Ricchebono, Marco, 17, 20, 32, 153, 154, 156, 161, 162, 205, 209, 210Ricci, famiglia, 109Ricci, Giovanni Battista, 115Ricuperati, Giuseppe, 22, 168Rinaldo, Andrea, 214Riolfo Marengo, Silvio, 18, 83Rizzo, Giovanni Agostino, 101Rizzo, Giovanni Battista, 101
228
Indice dei nomi
Rocca, Angelo Maria, 133Rocca, Gian Francesco, 128Roccatagliata, Ausilia, 128Rocchetta, Giovanni, 124Rodino, Girolamo, 129Rodolfo II d’Asburgo, imperatore, 47, 131Rosa, Mario, 64Rossi, Girolamo, 15, 122Rossini, Giorgio, 119, 163Rosso, Claudio, 168Rota, Maria Pia, 140, 193-195, 216Rotondi Terminiello, Giovanna, 209Rotta, Salvatore, 134, 180, 187Rovere, Antonella, 127 Ruiz Martin, Felipe, 113Russo, Carlo, 17, 25, 27, 32, 33, 37Russo, Paolo, 33, 210Sacco, Girolamo, 190Salamone, Francesco,Salamone, Stefano, 214Saluzzo, famiglia, 116Saluzzo, Giacomo, 103Salvago, Giovanni, 45Salvatorelli, Luigi, 61Sambaldo, Nicolò, 124Sanseverino di Bisignano, famiglia, 117Sansone, famiglia, 35Santa Cruz, Álvaro de Bazán, marchese di, 111Sanuto (o Sanudo), Marin, detto il Giovane, 49Savelli, Rodolfo, 37, 49, 70-73, 127Savoia, dinastia, 136Scarabello, Giovanni, 63Schiera, Pierangelo, 59Scotto, Bernardino, 214Scovazzi, Italo, 16, 17, 19, 20, 30, 40, 45, 50, 154, 155, 205Scovazzi, Maria Teresa, 81Sella, Domenico, 49, 136Sercambi, Giovanni, 60Serisola (o Cerisola), Bartolomeo, 214Serra, famiglia, 116Sforza, dinastia, 33, 63Sforza, Francesco, vedi Francesco I Sforza, duca di MilanoSforza, Gian Galeazzo, vedi Gian Galeazzo Sforza, duca di MilanoSiccardo, Giuseppe, 214Sigismondo di Lussemburgo, imperatore, 132
229
Indice dei nomi
Signorotto, Gianvittorio, 49Sismondi, Jean-Charles-Léonard Simonde de, 15Siri, famiglia, 111, 118, 209Siri, Cesare, 132Sisto IV (Francesco Della Rovere), papa, 36, 80, 113, 115Solimano I, detto il Magnifico, sultano turco, 54Soria, Lope de, 43Sormano, famiglia, 110, 209Spagnoletti, Angelantonio, 55, 116Spinola, famiglia, 34, 35, 81, 110, 115, 118, 169, 209, 211Spinola, Agostino (sec. XVI), 124Spinola, Agostino (sec. XVIII), 85Spinola, Andrea, 163, 171Spinola, Bartolomeo, 44Spinola, Domenico, 100, 166Spinola, Francesco, 112Spinola, Francesco Maria, 84, 133Spinola, Giulio, 200Spinola, Napoleone, 99Spooner, Frank C., 113Strinati, Claudio, 110Symcox, Geoffrey, 168
Tassinari, Magda, 17, 84, 153, 154, 156, 161, 162, 209Tenenti, Alberto, 59Testarossa, Gerolamo, 128Tigrino, Vittorio, 126Tocci, Giovanni, 22Torriglia, Francesco, 103Torteroli, Tommaso, 15, 16, 18, 33Trasselli, Carmelo, 114Trivulzio, Teodoro, 45Tucci, Ugo, 59
Urbano VIII (Maffeo Vincenzo Barberini), papa, 84
Valdora, Giovanni Battista, 214Varaldo, Carlo, 17, 18, 20, 31, 32, 35, 37, 83, 110, 141, 142, 153, 154, 156,
161, 162, 167, 205, 206, 208-210Veneroso, Giovanni Bernardo, 88Veneziani, Pasquale, 89Ventura, Angelo, 62Venturi, Franco, 126, 127Verga, Marcello, 64Verzellino, famiglia, 133
230
Indice dei nomi
Indice dei nomi
Verzellino, Giovanni Vincenzo, 19, 20, 28, 79, 84, 86-88, 93, 99-101, 111-113, 122-125, 128, 129, 134, 139, 142,162, 167, 210, 211
Viale, famiglia, 35Viggiano, Alfredo, 60, 62Vigo, Giovanni, 66Vincenzo da Fiorenzuola, al secolo Gaspare Maculano, 161Vinzoni, Matteo, 82, 160Viola, Massimo, 15Visconti, dinastia, 33, 58, 59, 63Visconti, Dante, 49Visconti, Giovanni, signore di Milano, 31Vitale, Vito, 18, 57, 100, 159Vitelleschi, Giovanni, 61Vittorio Amedeo I, duca di Savoia, 159Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sardegna, 133, 159Vivanti, Corrado, 16
Zamperetti, Sergio, 62Zanetti, Dante, 66Zenobi, Bandino Giacomo, 62
231