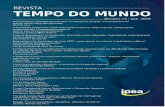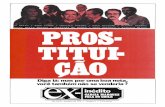TUTELA PAESAGGISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO IN ITALIA
Transcript of TUTELA PAESAGGISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO IN ITALIA
Università degli studi di Firenze
-Scuola di Scienze Politiche- “Cesare Alfieri”
TUTELA PAESAGGISTICA E GOVERNO DEL
TERRITORIO IN ITALIA:
LA PROPOSTA DELLA REGIONE TOSCANA
SILVIA MANGINIESAME “CITTA' E POLITICHE URBANE”
2014
INDICE
INTRODUZIONE
CAPITOLO I IL PAESAGGIO NELLE SUE DIVERSE ACCEZIONI,
QUALE PRESUPPOSTO AI FINI DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA PIANIFICAZIONE
1.1)LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO
1.2)UN BREVE EXCURSUS GIURIDICO DELLE FONTI IN MATERIA ITALIANE E GLI ATTUALI
SISTEMI DI TUTELA ALLA LUCE DEL DETTATO DELLA CONVENZIONE EUROPEA
1.3)IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
CAPITOLO II LO SPATIAL PLANNING ITALIANO: DUE MOVIMENTI DI RIFORMA
2.1)L'ESPERIENZA DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ITALIANA: UN RIPENSAMENTO DELLA
PRASSI AMMINISTRATIVA?
2.2)IL PIANO STRATEGICO COME STRUMENTO DI MODIFICA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO: LE
DIVERSE TIPOLOGIE
2.3)IL SIGNIICATO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NELLA CULTURA NAZIONALE ITALIANA
CAPITOLO III PIANIFICAZIONE STRATEGICA NELLA REGIONE TOSCANA:
LA PROPOSTA DI LEGGE N. 282/2012 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
3.1)ANALISI DEI CONTENUTI Più RILEVANTI DELL'ARTICOLATO
3.2)LA L. N.282/2013 QUALE REALE STRUMENTO DI IMPLEMENTAZIONE DI GOVERNANCE
TERRITORIALE DELLA REGIONE TOSCANA
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
INTRODUZIONE
L'obiettivo di questo lavoro, è quello di definire un quadro, sebbene generico, della disciplina
italiana in materia di tutela del paesaggio e governo del territorio.
L'interesse verso l'oggetto dell'indagine, nasce dal ritenere queste due tematiche di rilevanza
cruciale per variegati motivi: in primis, la tutela paesaggistica costituisce oggi una materia
fondamentale, e non trascurabile dai poteri pubblici, al fine di consentire oltre che la salvaguardia
del patrimonio storico, artistico e culturale della nazione anche uno sviluppo sostenibile, necessario
al fine di garantire una buona qualità della vita della popolazione. Il fine della presente indagine, è
quindi quello di osservare come, e se, la nozione di tutela paesaggistica nello Stato italiano, si sia
evoluta in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione europea del Paesaggio, la quale ha
sposato una nozione dell'oggetto di protezione, ampia ed adeguata alle esigenze poste dal processo
di modernizzazione. Si tratta infatti di una nozione di paesaggio estesa, la quale considera
meritevole di tutela non solo quella porzione di territorio caratterizzata da fattori estetici di
eccellenza, ma il paesaggio nel suo complesso. Una concezione di tale tipo, implica una tutela
completa del territorio, sottolineando la necessità per la quale i poteri pubblici debbano farsi carico
di tutto quell'insieme di processi che investono la realtà territoriale/ambientale: tra questi il recupero
delle aree dismesse o interessate da processi di degrado, la conservazione di aree verdi, la
valorizzazione di quelle rurali, la limitazione degli effetti negativi talvolta causati da un uso
spregiudicato delle risorse da parte delle attività economiche, ma anche lo sviluppo di energia da
fonti rinnovabili e la valorizzazione del patrimonio culturale esistente. Un'accezione di questo tipo,
porta a considerare il paesaggio, oltre che mero patrimonio estetico-culturale, anche una risorsa di
tipo economico, la quale può, se ben protetta, fornire benefici allo Stato e alla popolazione che esso
ospita.
L'altro fattore oggetto di indagine, il governo del territorio (che nella analisi è indagato con
particolare riferimento alla Regione Toscana) è un tema strettamente connesso con quello della
tutela paesaggistica. Questo poiché oggi, la lettura e la definizione di paesaggio costituiscono un
passo preliminare e necessario di ogni intervento di pianificazione e trasformazione territoriale1.
Inoltre, l'interesse verso quest'ultimo tema, nasce dalla mia propensione a considerarlo di
fondamentale importanza, al fine di diffondere la pratica del buon governo a livello territoriale.
Difatti, nonostante il tema della governance territoriale sia stato più volte menzionato nei numerosi
strumenti normativi emanati negli ultimi anni, la reale esistenza del governo del territorio resta un
fattore da constatare dal punto di vista empirico. Questo poiché la governance territoriale implica
la capacità di cooperazione tra i diversi livelli territoriali di governo nel definire obiettivi comuni da
1 A.MAGNIER, V. PAPPALARDO “Interpretando il paesaggio percepito”, p.1
perseguire, oltreché nell'utilizzare le risorse disponibili in maniera consapevole e improntata sulla
condivisione; la capacità di cooperazione inoltre, deriva da una volontà di cessione della propria
sovranità da parte degli enti territoriali, che più volte invece si sono dimostrati chiusi nelle loro
realtà campanilistiche e locali adottando politiche per il territorio più volte scoordinate tra loro,
spesso addirittura in contrapposizione e che in fine hanno causato sprechi di risorse ed effetti
negativi per le popolazioni interessate.
Il legame tra i due oggetti d'indagine emerge anche alla luce del concetto di pianificazione
strategica, emerso nella cultura nazionale italiana come strumento attraverso il quale ripensare le
dinamiche caratterizzanti la prassi amministrativa. La pianificazione strategica infatti, sposando una
nozione di paesaggio e territorio onnicomprensiva, si pone l'obiettivo di implementare politiche
territoriali a tutto tondo, che investono discipline plurisettoriali e che coinvolgono tutti i livelli
territoriali di governo, i quali sono chiamati a cooperare nella realizzazione di obiettivi comuni.
Al fine di analizzare queste tematiche la ricerca si è articolata in tre diversi momenti, suddivisi in tre
capitoli.
Nel capitolo 1 vi è una analisi della normativa italiana ed europea in tema di tutela paesaggistica.
Qui vi è un breve excursus giuridico delle norme in materia di tutela del paesaggio italiane ed un
analisi del Codice dei beni culturali e del Paesaggio alla luce delle disposizioni della Convenzione
europea in vigore dal 2000.
Nel secondo capitolo invece vi è una introduzione al concetto di pianificazione strategica ed un
breve riferimento alla prima esperienza italiana che ha portato alla nascita della rete “Città
strategiche” che attualmente raccoglie le principali esperienze che si sono cimentate su questo
obiettivo. Nello stesso capitolo vi è anche un'esposizione della connotazione che ha assunto la
pianificazione strategica nella cultura nazionale italiana.
Il capitolo 3 infine, riporta una breve analisi della Legge n.282/2013 “Norme per il governo del
territorio” della Regione Toscana, tuttora in via di approvazione. In questo capitolo ho osservato
solo gli articoli della Legge in esame inerenti con l'indagine sopra riportata; si sono quindi
sottolineati i riferimenti alle disposizioni della Convenzione europea del Paesaggio e le disposizioni
della Legge che a mio avviso risultano in conformità con gli obiettivi proclamati dalla
pianificazione strategica.
Osserveremo nelle conclusioni se la presente indagine sia riuscita a riscontrare l'esistenza o meno
della governance territoriale in Italia, e se quindi sia avvenuta una reale evoluzione della nozione di
paesaggio quale oggetto di tutela, la quale implichi una visione onnicomprensiva del territorio che
coinvolga tutti gli interessi in esso presenti.
1) IL PAESAGGIO NELLE SUE DIVERSE ACCEZIONI, QUALE PRESUPPOSTO AI FINI
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA PIANIFICAZIONE1.1)LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO; 1.2)UN BREVE EXCURSUS GIURIDICO DELLE FONTI IN MATERIA ITALIANE E
GLI ATTUALI SISTEMI DI TUTELA ALLA LUCE DEL DETTATO DELLA CONVENZIONE EUROPEA; 1.3)IL CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO
La disciplina del paesaggio, rappresenta un ambito d'analisi non poco complesso. Tale complessità
deriva da una molteplicità di fattori: in primis le diverse accezioni qualificanti l'idea stessa di
paesaggio, talvolta riferito ad espressione dell'identità culturale delle popolazioni che ospita, tal
altra identificato in quelle categorie di beni culturali di particolare bellezza o pregio. Si tratta quindi
di una nozione dai confini non chiaramente definiti e determinati, che porta con se
conseguentemente, problematiche di rilievo nella definizione dell'oggetto avente diritto di tutela.
Altro fattore non trascurabile, che incide profondamente sulla complessità di questa disciplina, è
dato dalla molteplicità di fonti normative che ne determinano le forme di protezione, e che non
sempre, risultano facilmente coordinabili tra loro2.
A causa di questi fattori, a lungo, sia il panorama europeo che quello italiano, hanno adottato,
sebbene con accezioni diverse, delle nozioni di paesaggio che non corrispondevano ad una
formulazione onnicomprensiva, la quale includesse, all'interno dell'oggetto di tutela della disciplina,
tutti gli aspetti della nozione “paesaggio” meritevoli di protezione.
1.1)LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO
La Convenzione europea del paesaggio, muove i suoi primi passi nel 1995, anno in cui l'Unione
mondiale per la Conservazione della Natura, pubblica il documento “Parchi per la vita”. Obiettivo
dell'Unione, era quello di creare, attraverso tale documento, le basi per l'adozione di una
convenzione sul paesaggio rurale europeo, intento da ascriversi nella più generale volontà di creare
basi identitarie e culturali comuni tra gli stati membri d'Europa. L'idea a fondo, era quella di
colmare il divario e la disomogeneità tra le diverse discipline sul paesaggio in Europa.
Così la Convenzione europea del paesaggio venne adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa e sottoscritta a Firenze nel 2000. La Convenzione è in vigore dal 2004 ed è stata ratificata
dall'Italia nel 20063.
Precedentemente all'adozione della Convenzione, sebbene vi fossero stati degli accordi
internazionali approvati dal Consiglio d'Europa (tra i quali ad esempio la Convenzione di Berna del 2 D. SORACE, Paesaggio e paesaggi della Convenzione Europea in G.F. CARTEI, Convenzione europea del
paesaggio e governo del territorio, Bologna, 2007, p.17ss.3 Legge n.14 del 19 Gennaio 2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il
20 ottobre del 2000
1979), non vi era nessun documento che prevedesse una tutela del paesaggio onnicomprensiva.
Tutti i sistemi di tutela paesaggistici adottati in precedenza, si limitavano a considerarne solo aspetti
particolari.
Da questo punto di vista, la Convenzione Europea ha rivoluzionato le modalità di protezione del
paesaggio, poiché solo con essa si è definitivamente affermata una disciplina di tutela del territorio
globalmente inteso, e non più circoscritta quindi, a singoli aspetti di esso4.
Il paesaggio cui riferisce la Convenzione europea, non è più unicamente ascrivibile ad una
“dimensione differenziata per eccellenza5” ; la nozione si estende anche alla tutela di aree non
caratterizzate da interessi storico-artistici, ed aree nelle quali sono presenti fenomeni di degrado. La
tutela paesaggistica, così non si limita più a comprendere unicamente la protezione di aree di
particolare bellezza o pregio, ma va ad abbracciare anche la nozione di riqualificazione del
territorio, al fine di consentirne una fruizione più consona per le popolazioni che vi abitano.
La Convenzione difatti, pone in correlazione diretta la nozione di paesaggio e territorio, facendo
riferimento anche alle zone interessate da trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali, ed
estendendo così la tutela a tutti gli ambienti della fruizione quotidiana6.
Essa è divenuta quindi, lo strumento atto a promuovere la salvaguardia, la gestione e
pianificazione del paesaggio, obiettivi perseguiti sia attraverso disposizioni di principio contenute
nel documento, che tramite meccanismi di cooperazione europea.
Altro merito della Convenzione, è stato quello di promuovere una nuova gestione del paesaggio,
che non si limita più all'azione dei governi nazionali, ma che coinvolge direttamente anche gli enti
territoriali locali, quali soggetti più consoni alla gestione di tali aree, poiché ovviamente più
coinvolti e consapevoli delle problematiche che le caratterizzano.
“Con la Convenzione si rivoluziona il panorama normativo e si introduce una concezione del
paesaggio caratterizzata da una propria autonomia, non improntata a canoni meramente estetici,
ma ad una sua dimensione oggettiva e globale7” .
L' oggetto di tutela diviene così caratterizzato da componenti naturali e umane, nucleo sinergico nel
quale i fattori culturali si intrecciano agli elementi naturali che lo caratterizzano. Assume rilevanza
una concezione sociale del paesaggio, quale fattore che contribuisce profondamente al benessere
delle popolazioni che lo abitano.
Essendo riconosciuto quale bene pubblico e collettivo, il paesaggio viene concepito per la sua
natura democratica ed egualitaria, venendo così meno l'accezione che lo aveva qualificato in
precedenza, di carattere elitario, che ne limitava la tutela e protezione solo in riferimento a quelle
aree caratterizzate da un alto valore estetico. Attraverso la Convenzione, per la prima volta un testo 4 C. DRIGO, Tutela e valorizzazione del paesaggio. Il panorama europeo online su www.giurcost.org5 G.F.CARTEI, La disciplina del paesaggio:la prospettiva giuridica6 ivi7 M. PRIEUR, La Convention Européen du Paysage in Enviromental Policy and law ,31/3, 2001, p. 168 ss
normativo riconosce la natura collettiva del paesaggio, quale bene di cui devono poter beneficiare
tutte le popolazioni europee. Nel testo sopra citato infatti, non vi è nessun riferimento ad aree
paesaggistiche particolari (vi era invece una lista di queste aree nel progetto iniziale).
Il Consiglio d'Europa ha sposato una concezione del paesaggio come insieme univoco del territorio
globalmente inteso il cui valore scaturisce dalla percezione che ne hanno le popolazioni che vi
abitano8.
La Convenzione è composta da un Preambolo e quattro capitoli:
● Preambolo: vi sono esplicitati i principi e valori sui quali si fonda la tutela paesaggistica
europea, tra i quali emerge lo sviluppo sostenibile, ed una concezione del paesaggio
socialmente inteso, quale fattore che se adeguatamente tutelato, può contribuire allo
sviluppo economico e sociale delle nazioni, incrementando l'occupazione. La nozione di
paesaggio, viene qui evocata anche in termini di patrimonio culturale e naturale europeo, ed
è menzionato anche quale fattore che contribuisce a definire la qualità della vita delle
popolazioni che vi vivono.
Nel Preambolo della Convenzione, la salvaguardia del paesaggio è concepita anche come
un dovere del singolo, cui ogni cittadino deve adempiere al fine di poter fruire del rispettivo
diritto di vivere in un ambiente favorevole, che contribuisca al benessere individuale.
Il Preambolo si conclude affermando la volontà di creare un nuovo strumento (la
Convenzione) dedicato alla salvaguardia, gestione e pianificazione di tutti i paesaggi
europei9.
● Capitolo I- Disposizioni generali. Il capitolo si compone di tre articoli. Nel primo, vengono
esposte tutte le definizioni cui la Convenzione fa riferimento. Si tratta di un elenco di
cruciale importanza, dal quale difatti emerge con forza la concezione sociale del paesaggio
definito come “parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni10”.
Tutte le altre formulazioni contenute all'interno di questo elenco (tra le quali “Politica del
paesaggio”, “Obiettivo di qualità paesaggistica”, “Salvaguardia dei paesaggi” etc.)
riferiscono ancora una volta, ad una nozione dell'oggetto di tutela, data dalla relazione tra
fattori ambientali/naturali e intervento umano.
L'articolo due dello stesso capitolo, definisce il campo di applicazione della tutela
paesaggistica. Qui vengono menzionate sia le aree di interesse storico-artistico, che quelle
legate alla fruizione quotidiana e le zone interessate da processi di degrado. Si tratta di una 8 C.DRIGO op. cit. p.49 Convenzione europea del Paesaggio, Preambolo, Firenze, 20 Ottobre 2000, traduzione a cura di Manuel R. Guido,
Daniela Sandroni, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici10 Convenzione europea del Paesaggio, op. cit. capitolo 1, art.1, punto a
disposizione estremamente rilevante poiché esplicita l'estensione della tutela del paesaggio a
tutto il territorio globalmente inteso, superando i limiti delle forme di tutela precedenti, che
interessavano solo le zone di peculiare bellezza o pregio11.
Nel terzo articolo sono definiti gli obiettivi della Convenzione, la quale si propone di
“promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la
cooperazione europea in questo campo12”.
● Capitolo II-Provvedimenti nazionali. L'articolo 4 (contenuto in questa sezione) definisce la
ripartizione delle competenze tra i paesi membri, sottolineando che essa debba avvenire nel
rispetto del principio di sussidiarietà, e conformemente alla suddivisione delle competenze
tra stati centrali ed enti locali, come prescritto dalle norme vigenti nei diversi stati
firmatari13. Nel capitolo II, negli articoli 5 e 614 vengono definiti i provvedimenti generali e
specifici cui devono adempiere gli stati membri. Tra le misure specifiche compare la
sensibilizzazione riguardo l'importanza del paesaggio, ma anche la formazione e
l'educazione ai fini dell'intervento su di esso. Ogni parte è tenuta a definire alcuni obiettivi
di qualità paesaggistica da perseguire.
● Capitolo III-Cooperazione europea. In questo capitolo vengono esplicitati i metodi di
coordinamento tra i paesi membri in merito alle politiche e programmi internazionali (art.7),
assistenza reciproca tra i paesi interessati (art.8), e le modalità di tutela dei paesaggi
transfrontalieri (art. 9) per i quali potrebbero essere necessari meccanismi di cooperazione
tra stati membri15. L'articolo 10 enuncia le modalità di controllo sull'applicazione delle
disposizioni precedentemente annunciate
● Capitolo IV-Clausole finali.
Dalla lettura dell'articolato della Convenzione, emerge quindi chiaramente, come più volte
specificato sopra, una nuova idea di paesaggio data dalla relazione tra fattori naturali e azione
umana. Viene più volte menzionata l'importanza della percezione che le popolazioni hanno del
paesaggio e del territorio, poiché assume rilevanza la protezione dell'ambiente della fruizione
quotidiana, come fattore determinante la qualità della vita.
Letto in questi termini, il paesaggio diviene un importante strumento di partecipazione democratica
che coinvolge direttamente i cittadini nelle decisioni inerenti alla sua tutela e valorizzazione16.
Un simile approccio, al fine di produrre risultati positivi, necessità quindi una grande opera di
sensibilizzazione della popolazione verso le tematiche strettamente inerenti al territorio; serve
11 ivi, art. 212 ivi, art. 313 ivi, capitolo 2, art.414 ivi, artt. 5, 615 ivi, capitolo 3, artt. 7, 8, 916 C. DRIGO, op. cit., p. 5
quindi una educazione al paesaggio e alle sue necessità che coinvolga i cittadini dei diversi paesi e
le istituzioni locali, di modo che l'obiettivo del paesaggio di qualità possa venire progressivamente
esteso ad aree sempre più vaste17.
1.2)UN BREVE EXCURSUS GIURIDICO DELLE FONTI IN MATERIA ITALIANE E GLI
ATTUALI SISTEMI DI TUTELA ALLA LUCE DEL DETTATO DELLA CONVENZIONE
EUROPEA
La disciplina italiana sulla protezione e tutela del paesaggio ha radici antiche. La prima legge in
materia, è difatti precedente alla Costituzione; si tratta della Legge Rava18 emanata al fine di
tutelare la pineta di Ravenna19 nel 1905.
La tutela del paesaggio assunse il vincolo quale strumento giuridico esteso, con la Legge n. 788 del
1922 la quale disciplinava la protezione di bellezze naturali e di particolari immobili, caratterizzati
da interesse storico. Questa Legge, segna la nascita di un filone normativo in materia paesaggistica,
il quale, sostanziava i meccanismi di protezione, in limitazioni d'uso dei beni oggetto di tutela, che
in questa fase, venivano identificati in “oggetti” dall'alto valore estetico e storico-artistico.
Basata sull'impostazione ideologica della L.788/1922, è la L. n. 1497 del 1939, (Legge Bottai)
ancora ancorata sulla protezione delle bellezze naturali, la quale segna un punto di apertura nella
evoluzione della disciplina italiana in tema di paesaggio. Un elemento di novità, è dato dalla
disposizione dell'art. 520 della Legge, il quale introdusse la facoltà per le amministrazioni
interessate, di predisporre dei piani paesistici al fine di tutelare il territorio da quelle trasformazioni
che ne avrebbero potuto pregiudicare il carattere di particolare bellezza o pregio.
Dalla fine degli anni '60, vennero introdotte numerose disposizioni21 a tutela della dimensione
paesaggistica nella disciplina urbanistica, tutte orientate alla conservazione di aree di particolare
pregio storico-artistico.
Il regime vincolistico introdotto dalla L. Bottai del '39, trovò in parte conferma nella L.
Galasso22del 1985, la quale introdusse la definizione di vincolo paesaggistico. La L. Galasso, però
apportò comunque alcune innovazioni di notevole portata nella normativa italiana della tutela
paesaggistica; difatti estese il vincolo paesaggistico ad intere tipologie di territorio (specificate
nell'articolato della legge) ed amplificò la portata dell'istituto della pianificazione paesistica. E'
17 ivi18 L.411/190519 S.SETTIS, Paesaggio Costituzione Cemento (La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile), Torino 2010, p.
115 ss 20 L.1947/1939, art.521 Ne sono alcuni esempi la L.765/1967; L.1187/1968 etc.22 L.431/1985
grazie a questa Legge infatti, che le Regioni hanno assunto l'obbligo di stilare il piano territoriale
paesaggistico e quello urbanistico, nel rispetto e nella tutela dei valori paesistico-ambientali23.
Si tratta di innovazioni fondamentali, poiché l'entrata a pieno titolo del regime pianificatorio
all'interno della disciplina paesaggistica, segna la fine dell'approccio esclusivamente vincolistico
introdotto dalla L. Bottai del 1939.
Successivamente, merita menzione il Testo Unico24 in materia di beni culturali e ambientali,
emanato al fine di riordinare la disciplina esistente in materia, conciliando le disposizioni contenute
nelle due leggi fondamentali italiane: quella del '39 e quella del 1985.
L'idea di paesaggio cui riferiscono questi provvedimenti normativi, rispecchia una concezione
restrittiva di tutela del territorio; gli oggetti della tutela paesistica, sono infatti solo quelle aree
caratterizzate da particolare bellezza o pregio, oppure quelle che manifestano caratteri di interesse
storico-artistico per la nazione, facenti parte quindi del patrimonio culturale dello Stato.
Tale linea interpretativa, che ha caratterizzato tutta la normativa italiana fino al recepimento dei
dettami della Convenzione europea del Paesaggio, è sicuramente frutto anche dell'influenza del
dettato costituzionale che all'art.9 recita: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione25”.
Il testo costituzionale ha profondamente influenzato tutta la disciplina sulla tutela paesaggistica
italiana, imprimendo (anche sulla base del solco lasciato dalla tradizione) una connotazione
estremamente restrittiva rispetto alla concezione di tutela del territorio emersa in seguito dal dettato
della Convenzione europea.
1.3)IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Il Codice dei beni culturali e del Paesaggio26, è attualmente la principale fonte normativa vigente in
materia di tutela del territorio. Emanato nel 2004 e successivamente corretto ed integrato nel 2006,
il Codice contiene in principi fondamentali della tutela ambientale e paesaggistica avvicinandosi,
anche se ancora con forti limiti, al dettato della Convenzione europea del 2000.
Il Codice ha apportato una revisione, per certi aspetti, fortemente innovativa, alla legislazione
italiana in materia di paesaggio, pur restando, per altri, ancora saldato alla tradizione.
La terza parte del Codice, è stata redatta con l'obiettivo di riformulare il sistema di salvaguardia e
23 ivi , art.1-bis24 Dlgs. n.490 del 29 Ottobre 199925 Costituzione italiana-Principi fondamentali, art.926 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio; dlgs. n.42/2004 in seguito corretto dal dlgs. n.157/2006, Gazzetta
Ufficiale n.97 del 27 Aprile 2006)
protezione del paesaggio, in conformità con i principi inscritti nella Convenzione, sebbene essa sia
stata ratificata dall'Italia solo in seguito all'emanazione del Codice.
Elementi di affinità tra in Convenzione e Codice possono rinvenirsi già dalla lettura della formula
definitoria iscritta nell'art.13127 “Per paesaggio si intende il territorio espressivo delle identità, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” .
La menzione,indica la volontà di superare l'antica prassi secondo la quale, meritevoli di tutela,
erano solo quei siti di particolare interesse o valore estetico-culturale, ampliando la protezione a
tutto il territorio nazionale.
Altri fattori affini riguardano in primis il tentativo (avvenuto per la prima volta nella normativa
italiana) di esplicitare una definizione chiara ed univoca di paesaggio, ma anche la previsione della
cooperazione tra gli enti amministrativi ai fini della tutela del territorio e la concezione di tutela
paesistica legata allo sviluppo sostenibile28.
Per quanto concerne la pianificazione territoriale, merita segnalare che il Codice qui ha apportato
cambiamenti significativi. Si nota un totale superamento della disciplina delineata dalla vecchia
Legge del '3929. Iscrivendosi nel tracciato delineato dalla L. Galasso (sopra commentata), il Codice30
ha attuato le prescrizioni stabilite dalla CEP: la pianificazione territoriale è stata estesa a tutto il
territorio nazionale. Si tratta di una disposizione di rilevanza sostanziale, la quale ha sancito il
superamento della vecchia concezione elitaria di tutela e pianificazione del territorio31.
La normativa vigente, prevede che i piani paesaggistici ripartiscano il territorio di ciascuna regione
in “ambiti paesaggistici” di modo che per ciascuna area vengano predisposte disposizioni particolari
e consone in relazione alle diverse specificità territoriali. Suddetta disposizione fa si che tutto il
territorio dello Stato, sia oggi oggetto di tutela da parte della legge.
L'art. 14332 del Codice, esplicita chiaramente le finalità del piano, non più limitate alla
conservazione dei caratteri costitutivi di determinate aree territoriali o beni di pregio, ma
comprendenti anche interventi di riqualificazione e recupero di aree soggette a degrado. E' altresì
prevista l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio.
La pianificazione paesaggistica assume quindi i caratteri propri della pianificazione a competenza
generale, caratterizzata da interventi di riqualificazione e ripristino finalizzati alla tutela della
27 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio,Parte terza-Beni paesaggistici, TITOLO I-Tutela e valorizzazione, Capo I-Disposizioni generali, art.131
28 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio,Parte terza-Beni paesaggistici, TITOLO I-Tutela e valorizzazione, Capo I-Disposizioni generali, art. 133
29 G.F.CARTEI op.cit. p.230 , art. 13531 R. GAMBINO, Il ruolo della pianificazione territoriale nell'attuazione della Convenzione, relazione al Convegno
“La Convenzione europea del paesaggio: itinerari interpretativi e applicazioni”, Università di Firenze, 200632 Codice dei beni culturali e del Paesaggio- Capo III, Pianificazione paesaggistica, art. 143
trasformazione del territorio33.
Ancora l'art.143 prevede che all'interno del Piano, siano contenute le analisi relative alle modalità di
trasformazione del territorio e la comparazione con l'azione degli altri strumenti previsti ai fini della
pianificazione territoriale e la difesa del suolo.
Di notevole importanza, ai fini dell'individuazione dell'apertura del Codice alle disposizioni della
CEP, è la previsione della lettera “e” dello stesso articolo. Qui è attribuita alla elaborazione del
Piano paesaggistico, la possibilità di “individuare ulteriori contesti” ampliandone così la potestà
regolamentare. Il Piano diviene lo strumento atto anche ad obiettivi progettuali di trasformazione
del territorio, tradizionalmente competenza delle amministrazioni degli enti locali.34
Nonostante i fattori innovativi presenti nel Codice, in linea con quanto prescritto dalla Convenzione
europea, una lettura più attenta di esso mostra ancora un forte ancoraggio alla tradizione35.
Questo ancoraggio, può leggersi già nella formula definitoria dell'art. 131, che pur individuando
(nel primo comma) il paesaggio come territorio composto dalla relazione tra fattori umani e
ambientali, esplicitando l'oggetto del codice, fa riferimento ai beni paesaggistici. Questa menzione
mostra un passo in dietro rispetto alla volontà di estendere la tutela a tutte le aree del territorio
nazionale, poiché sempre secondo l'articolato del Codice, per “beni paesaggistici” debbono
intendersi quelli elencati nell'art. 13436, i quali corrispondono sostanzialmente a quelli previsti nelle
passate leggi del '39 e del 1985.
Queste disposizioni evidenziano una eccessiva attenzione del Codice per beni ed aree caratterizzati
da un particolare valore estetico-culturale, fattore che si pone decisamente in contrasto con i
principi sui quali è basata la Convenzione.
In termini più generici, si può anche assumere che la stessa definizione di “paesaggio” enunciata nel
Codice risulta incompatibile con quella della Convenzione.
La CEP, all'art. 1.a, difatti esplicita che “Il paesaggio designa una parte di territorio così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall'azione dei fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni” , mentre il Codice37 definisce il paesaggio come “parti di territorio i cui
caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”.
Il termine “distintivi” nega al Codice, la previsione di una forma di tutela del territorio
onnicomprensiva, ed implicitamente sta a significare che, ai fini della tutela, sia necessario che le
33 P.URBANI, Per una critica costruttiva all'attuale disciplina del paesaggio, in Il diritto dell'economia, 2010, p.50 ss34 S.AMOROSINO, Art.143 in Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.CAMMELLI, Bologna 2007,
p.582 ss35 G. CAIA, Beni culturali e paesaggio nel recente Codice: i principi e la nozione di patrimonio culturale, in Studi in
onore di Leopoldo Mazzarolli, vol.III, Padova, 2007, p.161 ss.36 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio,Parte terza-Beni paesaggistici, TITOLO I-Tutela e valorizzazione, Capo I-
Disposizioni generali, art. 13437 Codice dei beni culturali e del Paesaggio, op. cit., art.131, comma 1
porzioni di territorio considerate mostrino caratteri eccezionali o di eccellenza. Inoltre, nel dettato
del Codice, non vi è alcun riferimento alla percezione delle popolazioni rispetto al loro territorio
d'appartenenza, per cui viene a mancare la componente soggettiva ed etica che è invece posta alla
base dell'istanza di partecipazione propria della Convenzione.
“...rischia di smarrirsi proprio quella dimensione sociale del paesaggio che costituisce il
fondamento principale della svolta politico-culturale impressa dalla Convenzione Europea38”Inoltre, riguardo ai fattori di incoerenza riscontrabili nel Codice rispetto al dettato della Convenzione, è necessario sottolineare che in esso è assente una articolazione sul territorio del meccanismo di pianificazione paesaggistica che avvicini le popolazioni al processo decisionale39.L'art. 13540 del Codice, infatti prevede un unico piano regionale, le cui disposizioni sono vincolanti gli enti territoriali locali.Si tratta di disposizioni, che se non accostate da norme atte a garantire un reale coinvolgimento degli enti locali e di tutti gli organi competenti in materia di governo del territorio, producono un processo decisionale gerarchico a cascata, e non quindi basato sulla concertazione e compartecipazione attiva, come auspicato dalla Convenzione.
In termini conclusivi, si può assumere quindi che, sebbene il Codice presenti notevoli elementi di novità, che avvicinano le sue disposizioni ai principi e valori iscritti nella Convenzione, esso rimane ancora fortemente ancorato alla tradizione legislativa italiana, tendente a privilegiare una visione elitista di tutela del paesaggio, e ancora nettamente lontana dai principi partecipativi atti a coinvolgere le popolazioni nei processi decisionali in materia di governo del territorio. Le possibilità di apertura del Codice attraverso un'interpretazione innovativa del suo dettato, potrebbero essere ottenute integrandone la lettura proprio alla luce di quanto prescritto nella Convenzione41.In particolare, il riferimento è alla partecipazione. Il ruolo subordinato degli enti locali nel processo decisionale, che emerge dalle disposizioni sopra citate, potrebbe essere riequilibrato da una interpretazione “estensiva” dell'art. 14442, il quale fa riferimento alla concertazione istituzionale e alla partecipazione dei soggetti interessati oltre che le associazioni ambientaliste.Il riferimento alla concertazione, può essere utilizzato, alla luce della richiesta di partecipazione auspicata dalla Convenzione, per il coinvolgimento degli enti istituzionali locali e per i cittadini.Una integrazione del Codice alla luce del dettato della Convenzione, potrebbe avvenire anche in merito alla identificazione del paesaggio con i beni paesaggistici. Si tratta di una prospettiva abbracciata anche dalla Convenzione ma che, come meglio specificato sopra, estende la tutela a tutto il territorio comprendendo anche aree prive dei caratteri di eccellenza o degradate. La menzione del Codice, a favore della individuazione di obiettivi di qualità paesaggistica, potrebbe così essere integrata alla luce del dettato della Convenzione, che individua nella qualità del
38 GAMBINO, 2006, op. cit.39 ivi40 op.cit.41 G.F.CARTEI, op. cit. p.13 ss42 op.cit.
paesaggio una delle caratteristiche essenziali delle politiche a tutela del territorio43.
43 G.F.CARTEI, op. cit., p. 14
2)LO SPATIAL PLANNING ITALIANO: DUE MOVIMENTI DI RIFORMA2.1)L'ESPERIENZA DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ITALIANA: UN RIPENSAMENTO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA?
2.2)IL PIANO STRATEGICO COME STRUMENTO DI MODIFICA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO: LE DIVERSE TIPOLOGIE
2.3)IL SIGNIICATO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NELLA CULTURA NAZIONALE ITALIANA
E' a partire dagli anni '90 che l'Italia è investita da due movimenti di riforma inerenti all'attività degli enti locali nel governo del territorio.Si tratta della riforma della pianificazione fisica e della diffusione della pianificazione strategica territoriale. Entrambi i movimenti sono accompagnati dalla contestuale riforma dell'attività regionale di pianificazione, il primo (la pianificazione fisica) a causa dell'affermarsi del federalismo urbanistico, il secondo (quella strategica) per l'opzione scelta dall'Italia nel delineare il Quadro Strategico Nazionale, che ha condotto ad affidare alle Regioni, la potestà di individuazione delle proprie linee strategiche, sempre nei limiti imposti dal governo centrale.
L'esperienza pilota di pianificazione strategica, è quella torinese, delineatasi a partire dal 1998, che in breve tempo ha coinvolto, se pur con modalità diverse, altri piccoli e grandi comuni, oltre che alcuni capoluoghi di provincia.L'esperienza torinese, si delinea contemporaneamente all'affermarsi di grandi cambiamenti nelle modalità di attuazione della pianificazione fisica, sia urbana che territoriale, che dagli anni '90 hanno contribuito a delineare nuove tipologie di spatial planning.Fattore fortemente innovativo, ed innescato da questo processo, è dato dal largo coinvolgimento dell'apparato normativo del governo del territorio all'interno di un processo di razionalizzazione e ricostruzione, ad oggi non ancora concluso.Si tratta di un passaggio di rilevanza cruciale, che vede la pianificazione socio-economica integrarsi con la pianificazione fisica attraverso la cooperazione di più livelli decisionali, trasformando la semplice urbanistica in governo del territorio44.Se la riforma della pianificazione fisica è stata generata da una comunità di pensiero facente capo all'urbanistica o alla giurisprudenza, il merito dell'affermazione della pianificazione strategica è da attribuirsi al contributo delle scienze sociali: economia, scienza dell'amministrazione e non meno importante, alla sociologia.E' difatti un sociologo, Arnaldo Bagnasco, ad aver ispirato l'esperienza pilota di pianificazione strategica, ovvero quella torinese. Le città aderenti a questa prima manifestazione, sono oggi in larga parte, le componenti della rete “Città strategiche” che costituisce attualmente l'unica rete italiana che raggruppi le città aderenti a questo tipo di progetti (pur essendovi stati nel tempo anche tentativi alternativi).La Rete45 “si muove nell'ambito della promozione e del sostegno della governance locale. La rete intende affermare e sviluppare modelli di governance efficaci per la definizione di strategie urbane e la loro messa in atto, attraverso il confronto tra strumenti e procedure funzionanti, già in corso nelle città europee, e l'individuazione e la sperimentazione di nuovi modelli possibili.46”
44 A.MAGNIER, Sociologia e spatial planning:l'esperienza italiana45 per “Rete” si fa riferimento all'esperienza della rete “Città strategiche”46 www.recs.it
Gli obiettivi dichiarati dalla Rete riferiscono quindi alla volontà di diffondere la prassi della pianificazione strategica come modello di governance locale, ripensando quindi, quelle che sono attualmente le dinamiche di governo del territorio, ma anche sviluppare nuove strategie urbane attraverso processi imitativi delle best practice “benchmarking” nell'ottica di sviluppare progetti urbanistici improntati all'efficienza.Le città che costituiscono il gruppo promotore sono Firenze, Torino, Trento, Venezia, Verona, Spezia e Pesaro; pur avendo adottato il piano strategico con modalità differenti, esse ne condividono i principi ispiratori e gli obiettivi programmatici. Affiancate a queste, oggi se ne trovano una trentina di nuove.Attualmente la Rete rappresenta il luogo nel quale avviene “la codifica culturale dominante del movimento italiano per la pianificazione strategica47”
2.1)L'ESPERIENZA DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ITALIANA: UN
RIPENSAMENTO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA?
L'ambito della pianificazione socio-territoriale è tuttora l'area delle politiche pubbliche in cui resta più difficile individuare un modello uniforme tra le esperienze dei paesi europei. Osservando il piano strategico, la pianificazione socio-territoriale assume funzioni e posizione istituzionale profondamente diverse, in relazione ai diversi sistemi di pianificazione esistenti, i quali rispecchiano diverse tradizioni nazionali.Ne consegue una pluralità di tipologie di pianificazione territoriale fortemente influenzate dalle prassi nazionali, per cui, in un'ottica comparata, risulta difficile analizzare ed esprimere giudizi sul funzionamento dei diversi sistemi, i quali assumono significato difforme in relazione ai contesti nei quali vengono adottati48.In Italia la riforma della pianificazione fisica e la diffusione di quella strategica hanno sperimentato processi diversi di istituzionalizzazione. Se il primo movimento di riforma ha contribuito a creare un nuovo sistema giuridico, per quel che concerne la pianificazione strategica non può dirsi altrettanto. Infatti essa si è manifestata attraverso una moltiplicazione di esperienze libere e informali, talvolta all'apparenza scoordinate l'una dall'altra49.Nel nostro paese, come negli altri caratterizzati da un governo locale con un impianto di matrice napoleonica, le esperienze di piano strategico proliferano in una cornice di governance territoriale che privilegia l'urbanistica come strumento culturale e tecnico. Il comune rappresenta l'attore principale dello spatial planning, ad esso spetta l'attività regolativa e quella di programmazione di tutte le attività svolte sul territorio, e questo anche a causa di una mancanza di compartecipazione da parte degli altri enti territoriali.Così in Italia, come negli altri paesi dell'Europa meridionale, la pianificazione strategica si costituisce in sovrapposizione e talvolta in contrapposizione alle norme proprie dell'urbanistica. 47 A.MAGNIER, op. cit.48 ivi49 ivi
Inoltre la definizione del piano strategico, come quella del piano regolatore avviene senza che gli enti pubblici che ne sono promotori (spesso i comuni) dispongano degli strumenti necessari alla realizzazione degli obiettivi predeterminati.Questa inadeguatezza che caratterizza l'attività dei soggetti istituzionali locali nella realizzazione delle opere urbanistiche, ha generato la nascita di un discorso politico contraddittorio che ha condotto il dibattito pubblico sull'inadeguatezza del sistema di pianificazione, sullo sviluppo locale, e non quindi sull'integrazione funzionale degli strumenti previsti. Il focus è sulla necessità di “piegare il sistema pianificatorio alle esigenze dello sviluppo locale50”.Date queste premesse, in Italia, come negli altri paesi del Sud Europa, la pianificazione strategica costituisce un momento di rottura con la tradizione urbanistica (la quale come sopra accennato è per prassi la disciplina dominante della governance territoriale); l'obiettivo della pianificazione strategica è così costituito da un più generale ripensamento della prassi amministrativa poiché ambisce a rivoluzionare i processi e ad accrescere le competenze degli attori coinvolti. I documenti di pianificazione territoriale che si autodefiniscono strategici, emergenti nella varie regioni dell'Europa meridionale si pongono obiettivi comuni:
● volontà di collocare le scelte di breve periodo in un quadro di previsione di medio e lungo periodo, collocando così il piano in un orizzonte temporale ampio ma ben definito
● utilizzo di un approccio multidisciplinare di analisi e interpretazione dei processi che caratterizzano la trasformazione degli spazi
● creare un legame tra le diverse politiche di settore● interpretare la pianificazione come un processo dinamico e negoziabile, non quindi come un
prodotto
2.2)IL PIANO STRATEGICO COME STRUMENTO DI MODIFICA DEL GOVERNO DEL
TERRITORIO: LE DIVERSE TIPOLOGIE
Un riferimento ormai divenuto usuale nella letteratura sul tema, è quello proposto da Ghibelli51 fondato sull'idea di una successione temporale delle diverse tipologie di piano strategico. Questa distinzione idealtipica costituisce uno strumento utile al fine di osservare le diverse modalità con cui il Piano52 ha agito nel cambiare il governo del territorio in paesi con diverse tradizioni urbanistiche.
● piani sistemici – documenti di meso-pianificazione etichettati come di pianificazione strategica. Trattasi di piani sovralocali di matrice socio-economica aventi l'obiettivo di inquadrare lo sviluppo territoriale in un quadro di medio e lungo periodo. Un esempio ne è la Francia che ha adottato i “Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme” regionali.La definizione di piani sistemici deriva dal fatto che essi esprimono una volontà di ordinare l'azione degli enti locali dal centro del sistema decisionale. Si tratta di piani che segnano la
50 ibidem51 M.C. GHIBELLI Tre famiglie di piani strategici: verso un modello reticolare e visionario in F. CURTI, M.C.
GHIBELLI Pianificazione strategica e gestione dello sviluppo urbano, Firenze, 1996, p.2452 per “Piano” si intende Piano strategico
nascita di una struttura di pianificazione “gerarchica” che ha alla base la pianificazione fisica comunale seguita dai piani di indirizzo economico, sociale e spaziale su vasta scala, collocati in un ottica di programmazione di medio e lungo periodo.
● piani aziendalisti- Compaiono negli Stati Uniti e in Europa si diffondono a partire dagli anni '80; si tratta di piani presenti ancora oggi in larghe aree del Sud Europa. Questi piani prevedono una definizione degli obiettivi di lungo periodo, accompagnata da una attività di controllo sui processi atti a realizzarli, al fine di ottimizzare i risultati prestabiliti. La forte attenzione sul controllo dei processi volti alla realizzazione degli intenti, deriva probabilmente dal fatto che le prime esperienze di questo tipo di piani, si manifestano negli Stati Uniti durante la deregulation caratterizzata da scarsità di risorse finanziarie. I progetti locali, vengono realizzati spesso tramite sistemi di partenariato tra pubblico/privato, attraverso la contrattazione quale misura adottata per garantire vantaggi alla collettività urbana.Si tratta di modelli privilegiati dalle leadership urbane imprenditoriali, le quali vi vedono la possibilità di “raggiungere l'obiettivo pragmatico del get something done53” realizzando opere visibili in conformità con gli obiettivi dichiarati dalle pubbliche amministrazioni e legittimando quindi il loro operato.
● piani reticolari- sono i così detti piani di terza generazione. Si tratta di piani che rispondono alle più alte esigenze di innovazione poiché implicano un largo coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali relativi allo sviluppo locale. L'obiettivo fondamentale di quest'ultima tipologia di piani, è quella di definire gli obiettivi largamente condivisi nella società locale, al fine di improntare l'azione pubblica su un vasto consenso da parte delle popolazioni interessate. Si vuole in altri termini, migliorare la razionalità procedurale degli attori preposti all'elaborazione delle politiche, di modo che essi, possano tener conto della pluralità degli interessi presenti sul territorio.
Questa tipologia di piani strategici evidenzia tre difformi sistemi di pianificazione. I primi due modelli (sistemici e aziendalisti) fanno riferimento alla pianificazione razionale e razionale comprensiva, attribuendo la potestà di pianificare al planner (nel primo caso) e all'élite politica (nel secondo). Il terzo tipo di piano fa parte invece della tradizione della pianificazione comunicativa.I modelli, evidenziano concezioni diverse del significato sociale del piano54 : nel primo caso esso è il fulcro della razionalità dell'organizzazione pubblica, nel secondo il piano rappresenta lo strumento di competizione tra enti locali o leadership politiche, nel terzo caso rappresenta il simbolo attraverso il quale creare partecipazione ed allargare il consenso in merito alle politiche territoriali attuate.
53 A.MAGNIER, op.cit.54 ivi
2.3)IL SIGNIICATO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NELLA CULTURA NAZIONALE ITALIANA
In Italia, come negli altri paesi della regione amministrativa dell'Europa meridionale, il termine “pianificazione strategica” esprime in primo luogo l'ambizione di un ripensamento e revisione culturale dei percorsi formativi dei dirigenti della pubblica amministrazione, i quali non dovrebbero più fondarsi su nozioni di diritto amministrativo ma sulla capacità di adattamento alle sfide poste dal continuo cambiamento che caratterizza la gestione pubblica, la quale si trova ad operare in un contesto caratterizzato da risorse scarse.“la pianificazione strategica esprime in breve l'essenza del reinventing government italiano55”Il movimento di revisione delle prassi amministrative è molto variegato, per cui produce risultati difformi che vanno a comporre il largo universo sottostante al termine “pianificazione strategica”.Al fine di analizzare il mutamento della cultura amministrativa italiana è utile partire dalla definizione di pianificazione strategica proposta da Archibugi:“è una disciplina che addestra all'impiego di metodi mirati a migliorare la razionalità delle decisioni nella gestione sistematica degli affari pubblici.56”
La pianificazione strategica dunque mira a creare le basi per diffondere un particolare tipo di razionalità, che è la razionalità rispetto allo scopo. Trattandosi di uno scopo che è per definizione politico, la sua determinazione cambia a seconda delle caratteristiche del sistema istituzionale considerato: in un sistema rappresentativo lo scopo che muove tale tipo di razionalità sarà competenza della classe politica, in un sistema politico fondato sulla democrazia deliberativa e nella quale quindi vengono auspicate pratiche di democrazia diretta, la definizione dello scopo sarà competenza della popolazione. Ma in entrambi i casi non si tratta di uno scopo definito dalla pubblica amministrazione.Archibugi propone una definizione specifica anche di razionalità rispetto allo scopo:“è razionale una decisione (o azione) che è coerente o compatibile con le possibilità e i vincoli esistenti e/o con i mezzi (o risorse) a sua disposizione57”La pianificazione strategica pubblica inoltre si distingue fortemente da quella privata, poiché la prima deve porre una notevole attenzione agli effetti prodotti dalle scelte operate, la valutazione degli output prodotti dall'azione è un fattore decisivo e qualificante la pianificazione strategica pubblica58. Essa deve tenere di conto dell'eventuale danno prodotto mediante la sua azione all'operato delle altre organizzazioni pubbliche; e contestualmente deve impegnarsi nell'obiettivo di attuare scelte che comportino un lavoro sinergico e complementare con le altre organizzazioni pubbliche operanti sul territorio, al fine di consentire un risparmio complessivo di risorse per il settore pubblico considerato nella sua interezza.59
55 ibidem56 F.ARCHIBUGI, Introduzione alla pianificazione strategica in ambito pubblico, Firenze, 2005, p.27 sg57 ivi, p. 2858 ivi, p.3159 ivi
Nelle organizzazioni pubbliche quindi il termine “strategico” diviene un rafforzativo di quello “pianificazione”.Con riferimento al contesto italiano quindi, il tema della pianificazione strategica costituisce un elemento rilevante al fine di rivoluzionare la prassi di funzionamento di tutta la macchina amministrativa. Esso pone l'obiettivo di realizzare un coordinamento dell'azione delle organizzazioni pubbliche, propone un monitoraggio continuo sugli effetti delle scelte attuate da queste, impone una analisi delle risorse disponibili ai fini della realizzazione degli interventi, di modo da proporre degli obiettivi programmatici coerenti con tali risorse e propone un lavoro sinergico e complementare da parte degli enti promotori di tali interventi al fine di consentire un risparmio di risorse complessivo60.
Sulla base di questa definizione, la pianificazione strategica in Italia diviene lo strumento attraverso il quale affrontare le problematiche che condizionano le capacità di agire degli enti pubblici italiani, dovute ad ostacoli organizzativi e culturali; per cui rappresenta il tentativo di un ripensamento e revisione culturale delle modalità d'azione della dirigenza amministrativa.
60 A.MAGNIER, op.cit.
3)PIANIFICAZIONE STRATEGICA NELLA REGIONE TOSCANA: LA PROPOSTA DI LEGGE
N. 282/2012 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”3.1)ANALISI DEI CONTENUTI Più RILEVANTI DELL'ARTICOLATO
3.2)LA L. N.282/2013 QUALE REALE STRUMENTO DI IMPLEMENTAZIONE DI GOVERNANCE TERRITORIALE DELLA REGIONE
TOSCANA
La legge n.282/2012, intitolata “Norme per il governo del territorio” interviene dopo più di otto anni dall'entrata in vigore della precedente Legge 1/2005. Gli obiettivi cui la Legge auspica, menzionati nella relazione illustrativa dell'atto, riguardano:
● valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico al fine di consentire uno sviluppo regionale sostenibile e durevole
● il contrasto all'uso del suolo attraverso la promozione di un ruolo multifunzionale del territorio rurale
● sviluppo della partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani
La Riforma61 si iscrive nella cornice normativa generale esistente, apportando però numerosi cambiamenti nel tentativo di migliorarne determinati aspetti critici riguardanti sia le modalità di attuazione del principio di sussidiarietà, (relazionandolo a quello di adeguatezza) sia l'applicazione di determinate disposizioni concrete. Ne è un esempio il limite al consumo del suolo. Gli obiettivi prefissati, vengono applicati con la volontà di non appesantire ulteriormente i procedimenti attuativi, attraverso la fissazione di tempi massimi per i procedimenti urbanistici e razionalizzando gli adempimenti dei soggetti pubblici.
Dall'esperienza applicativa delle leggi precedenti, è emersa la necessità di una maggiore chiarezza riguardo agli strumenti di governo e di pianificazione del territorio, con riguardo alle peculiarità che caratterizzano ciascuno di essi e in merito alle procedure che ne caratterizzano il percorso di approvazione e vigenza.
Nella relazione illustrativa, vi è un esplicito riferimento alle problematicità cui sono sottoposti i territori a causa dell'attuazione di politiche sconsiderate, attuate a causa della scarsità di risorse degli enti promotori.La crisi economica e quella finanziaria degli enti locali, unita all'alto tasso di disoccupazione, comporta il prevalere di scelte di investimento attuate senza considerarne pro e contro, le quali sottopongono i territori oggetto delle disposizioni, ad un processo di trasformazione che si disinteressa di fattori di rilevanza cruciale, quali la sostenibilità ambientale. Obiettivo della disposizione è quindi che questi valori vengano considerati per la loro sostanziale rilevanza e che le scelte di investimento vengano collocate in una prospettiva territoriale più ampia, al fine di produrre effetti positivi sull'economia reale e scongiurare crisi profonde e ricorrenti.
61 Legge n.282/2013 “Norme per il governo del territorio”
Al fine di limitare i rischi di “cattura del regolatore” cui sono sottoposti gli enti pubblici promotori delle politiche, nell'attuazione di scelte talvolta sconsiderate, viene proposto un percorso che conduce alla pianificazione territoriale improntato sulla concertazione e la partecipazione di tutti gli interessi presenti sul territorio.Adottando la tipologia proposta da Ghibelli62, viene quindi proposto un piano reticolare, improntato sulla partecipazione. Ne è stato una conferma anche il percorso di elaborazione del piano, che in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Toscana, ha visto la compartecipazione della Regione, ANCI63, UPI64, ed UNCEM65.
La proposta di legge, comporta l'abrogazione della norma precedente (Legge regionale 1/2005).
Obiettivo finale della proposta di legge, approvata dalla Giunta il 30 Settembre scorso, è quello di migliorare l'efficacia della governance interistituzionale sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, e differenziazione, oltre a quello di rendere più chiare ed efficaci le procedure in un quadro attuativo che è in continua trasformazione66.
Principali innovazioni apportate:● consumo del suolo: Al fine di ridurre al minimo l'uso del suolo, (il quale viene etichettato
come solo riferimento di principio nel testo attualmente vigente) vengono proposte alcune disposizioni concrete. In primis viene qui precisato in modo puntuale il territorio urbanizzato e definite in modo chiaro le procedure per l'intervento all'interno di esso, distinguendole da quelle atte ad intervenire in aree diverse, con particolare attenzione alla conservazione e salvaguardia del territorio rurale e con l'obiettivo di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane interessate da processi di degrado o dismesse. Tra i limiti all'uso del suolo, compare la previsione del divieto di nuove edificazioni residenziali nelle aree esterne al territorio urbanizzato. L'uso del suolo per destinazioni diverse da quella residenziale vengono assoggettati al parere obbligatorio della conferenza di copianificazione di area vasta67.
● correttezza delle procedure ed efficacia delle norme di legge: al fine di contrastare interpretazioni divergenti ed ampie delle norme di riferimento derivanti dalla forte autonomia di cui godono gli enti locali è stato rafforzato il ruolo della conferenza paritetica interistituzionale , come strumento di riferimento per la regolazione dei conflitti (a seguito di una valutazione positiva del suo operato precedente). Tale “conferenza” è stata dotata di poteri più cogenti attraverso il richiamo di tutti i soggetti istituzionali al rispetto delle sue
62 op. cit.63 Associazione Nazionale dei Comuni Italiani64 Unione delle Province d'Italia65 Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani66 Proposta di legge regionale “Norme per il governo del territorio”, Relazione illustrativa, Sintesi del percorso di
revisione e dei contenuti essenziali, p. 1 sg., su www.RegioneToscana.it67 L.282/2013, “Norme per il governo del territorio”,Titolo I Disposizioni generali, Capo I principi generali, art.4;
art.24
conclusioni in merito ai conflitti di interpretazione degli atti68.● informazione e partecipazione: nonostante la Legge vigente preveda la costruzione
partecipata dello statuto dei piani, l'accesso all'informazione risulta tuttora spesso difficoltoso. Al fine di limitare questa problematica, ed in coerenza con la nuova Legge regionale sulla partecipazione,69 è previsto che le attività di partecipazione vengano inserite nelle procedure di formazione degli atti del governo del territorio. A tal fine, vi è stato un riordino degli articoli dedicati alla partecipazione degli abitanti nei procedimenti del governo del territorio attraverso la previsione di linee guida comuni che rendano omogenea la disciplina in tutto il territorio regionale.Al fine di garantire la partecipazione e l'informazione viene altresì prevista la possibilità di accedere agli atti amministrativi riguardanti i procedimenti del governo del territorio senza specifica motivazione70.
● monitoraggio dell'esperienza applicativa della legge e valutazione della sua efficacia: al fine di sopperire all'attuale mancanza dell'attività di monitoraggio sull'applicazione della legge che ne possa evidenziare problematiche operative, e di fronte all'assenza di una valutazione della sua efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati viene conferito alla conferenza paritetica interistituzionale il dovere di monitorare (attraverso le sue strutture tecniche) il percorso di pianificazione. La conferenza dovrà formulare annualmente eventuali proposte alla Giunta sul funzionamento della pianificazione.La Regione al fine di valutare l'efficacia della Legge dovrà promuovere il confronto con le rappresentanze istituzionali, con le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo della cultura e dell'Università71.
● patrimonio territoriale: in assenza di una definizione chiara di statuto del territorio, i piani previsti dalle disposizioni normative precedenti hanno interpretato lo statuto come mera elencazione di beni culturali e di aree protette, dunque da una prospettiva vincolistica e non comprendente l'idea di una corretta trasformazione dell'intero territorio rendendo quindi inefficace la relazione tra la componente statutaria e quella strategica dei piani.L'introduzione del concetto di “patrimonio territoriale” esteso a tutto il territorio regionale vuole realizzare un progresso culturale che pone fine, per la Regione Toscana, ad una concezione vincolistica di pianificazione per aree specifiche al fine di valorizzare la progettualità del territorio e del paesaggio nella loro interezza.
● pianificazione di area vasta: vengono predisposte forme di pianificazione intercomunali al fine di rimediare all'attuale frammentazione delle pianificazioni e con l'obiettivo di produrre una scala che sia adeguata alla valutazione di scelte progettuali che possono produrre effetti anche al di fuori dei confini dei singoli Comuni ed in conformità con gli ambiti di paesaggio previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Viene pertanto valorizzato il piano strutturale intercomunale che insieme alla conferenza di copianificazione diviene lo
68 ivi, artt. 45 ss.69 Legge n.46/2013 “Legge sulla Partecipazione”70 L.282/2013, op. cit., artt.34 ss71 L. 282/2013“Norme per il governo del territorio”, Titolo II Norme procedurali per la formazione degli atti di
governo del territorio, Capo I disposizioni procedurali comuni, art. 15
strumento atto a garantire una progettazione unitaria e multisettoriale delle trasformazioni inerenti all'area vasta72.
● politiche per la casa: viene predisposto che la pianificazione territoriale e urbanistica concorra alla formazione delle politiche per la casa attraverso il riconoscimento di standard urbanistico degli alloggi sociali. Essi devono essere assicurati tramite la cessione di aree e unità immobiliari73.
● prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologico e sismico: a fronte dei più recenti eventi alluvionali e sismici è stata sottolineata l'importanza strategica di inserire nella pianificazione territoriale e urbanistica regole precauzionali precise.
● qualità del territorio rurale: viene sovvertita l'idea per la quale il territorio rurale sia un'area priva di valore da trasformare attraverso interventi di nuova urbanizzazione. Il mantenimento del territorio rurale, grazie alla sua multifunzionalità diviene un valore fondamentale e riconosciuto dalla legge, per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, e alla garanzia di produzione di prodotti alimentari di qualità oltre che per la riproduzione del paesaggio, equilibrio idrogeologico e benessere economico della Regione.L'attività agricola viene quindi riconosciuta come attività economico-produttiva. Tale riconoscimento porta alla volontà di limitare il più possibile la frammentazione del territorio ad opera di interventi non agricoli74.
● riordino lessicale: per promuovere una facilità di lettura degli atti accessibile a tutti i soggetti interessati, è stata disposta una riscrittura delle norme al fine di chiarire le relazioni tra i diversi dispositivi procedurali e di contenuto.
● tempi della pianificazione: i tempi relativi alla pianificazione sono stati abbreviati al fine di sopperire i deficit di efficacia verificatesi in precedenza. E' stato a tal fine, disposto un periodo massimo di due anni per la formazione di uno strumento di pianificazione a seguito dell'approvazione del medesimo (a fronte dei sei anni di tempo vigenti in precedenza)75.
● tutela paesaggistica: sono stati perfezionati i riferimenti alla normativa nazionale vigente in materia di tutela del paesaggio, adeguandola alle disposizioni del Codice, poiché essa presentava una stesura antecedente alla approvazione dello stesso.sono anche stati specificati i compiti dell'osservatorio regionale del paesaggio, che avrà il ruolo fondamentale di promuovere, attuando le disposizioni della Convenzione europea, la partecipazione delle popolazioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale76.
72 L.282/2013 op. cit., Titolo II, Capo II Disposizioni per la pianificazione intercomunale, art. 2273 L.282/2013 op.cit., art.6174 ivi, art.62 ss.75 ivi, artt. 201 e 20276 ivi, artt. 56 ss.
3.1)ANALISI DEI CONTENUTI Più RILEVANTI DELL'ARTICOLATO
Art.1- Oggetto e finalità della legge “1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione perseguono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge: a) la conservazione e la gestione del patrimonio territoriale, promuovendone la valorizzazione in funzione di uno sviluppo locale sostenibile e durevole; b) la riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone; c) la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la massima sinergia e integrazione tra i diversi territori della Regione; d) lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, della montagna e della fascia costiera, coniugando funzioni produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; e) lo sviluppo di politiche territoriali attente all’innovazione di prodotto e di processo; f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca: 1) la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori; 2) l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena fruibilità degli spazi pubblici per le diverse categorie della popolazione; 3) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani; 4) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici; 5) il risparmio idrico; g) l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca l’accessibilità all’intero sistema insediativo e all’intermodalità; h) l’effettiva ed adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.”
L'articolo 1 esplicita l'oggetto e le finalità della legge, riassumendo nei suoi contenuti gli obiettivi appunto, e i valori cui la legge si ispira. Si tratta di un articolo dalla rilevanza sostanziale, poiché riferisce agli obiettivi di tutela territoriale, per cui nelle sue disposizioni, contempla una visione univoca di territorio da tutelare nella sua interezza recependo così la visione adottata in parte anche dal Codice e sposata in toto dalla Convenzione europea. In merito vengono citati gli obiettivi di sviluppo sostenibile e durevole quali cardini su cui deve improntarsi l'attività di governo del
territorio. L'articolo sottolinea anche la necessità di integrazione dell'azione delle diverse amministrazioni territoriali, citando Regioni, Province e Comuni, le quali devono improntare le loro politiche in un'ottica sinergica e condivisa al fine di realizzare obiettivi comuni. Tra gli obiettivi particolarmente innovativi vengono enunciati la produzione di energia e la riduzione dei consumi energetici, quali fattori fondanti ai fini dello sviluppo sostenibile, tra questi inoltre è citato anche il risparmio idrico.L'articolo quindi, enunciando gli obiettivi e le finalità della legge, contiene nel suo dettato l'essenza della concezione di pianificazione strategica sposata dalla cultura nazionale italiana, ovvero il ripensamento della prassi amministrativa, in altre parole il reinventing government. Questo emerge in particolar modo, come nelle disposizioni di altri articoli, dal focus sull'importanza di un'azione coordinata e “sinergica” tra le diverse amministrazioni coinvolte. Nell'articolo sono ben evidenti anche gli echi della Convenzione europea del paesaggio, nelle previsione della tutela del territorio, la quale implica una considerazione globale del paesaggio oggetto di protezione e salvaguardia.
Art.2- Il governo del territorio “1. Ai fini della presente legge, si definisce governo del territorio l'insieme delle attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con riferimento agli interessi collettivi e alla sostenibilità nel tempo. 2 .Il governo del territorio si esplica mediante il coordinamento intersettoriale delle politiche, la coerenza dei piani e dei programmi di settore con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, mediante il coordinamento e la collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo”.
Il secondo articolo, esplicita la nozione di governo del territorio. Questo è l'articolo che racchiude l'essenza della pianificazione strategica quale strumento di attuazione delle politiche pubbliche della Regione Toscana. L'articolo difatti riferisce all'insieme delle attività che concorrono alla trasformazione del territorio, e ne sottolinea la necessità di coerenza e di coordinamento intersettoriale.
Art.3 - Il patrimonio territoriale “1. Con la presente legge, la Regione promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale con le modalità di cui all’articolo 5. Per patrimonio territoriale si intende l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità. 2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1 è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito da:
a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici; b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora; c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale. 3. Le componenti di cui al comma 2 e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti. 4. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice. 5. Gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, le loro interrelazioni e la loro percezione da parte delle popolazioni esprimono l'identità paesaggistica della Toscana”.
Nel terzo capitolo viene esplicitata la definizione di patrimonio territoriale, il quale rappresenta la nozione di paesaggio adottata dalla Convenzione europea. Come nel testo della Convenzione (ed in parte come recepito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio) il patrimonio territoriale viene considerato come tutto il territorio regionale, e le cui caratteristiche derivano dalle trasformazioni indotte dalla “coevoluzione tra ambiente naturale e insediamenti umani”. Oggetto di tutela da parte della Legge, non sono quindi sono determinate aree che presentano caratteri di pregio o qualità ma il territorio globalmente inteso e costituito da fattori naturali e umani, oltre che dal prodotto delle loro interrelazioni.
Art. 15 - Monitoraggio “ 1. La Regione, le province e i comuni, sulla base del monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica effettuato dall’osservatorio paritetico della pianificazione di cui all’articolo 52, verificano il perseguimento delle finalità di cui al Titolo I, Capo I della presente legge. 2. Il monitoraggio di cui al comma 1 è svolto sulla base di selezionati elementi conoscitivi conferiti e trattati da Regione, province e comuni attraverso l’infrastruttura dei dati territoriali di cui all’articolo 53. 3. I soggetti istituzionali di cui al comma 1 collaborano nell’implementazione dei dati conoscitivi anche al fine del contrasto all’abusivismo. 4. Al fine di valutare l’efficacia della presente legge e lo stato complessivo della
pianificazione, la Regione promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo della cultura e dell’Università. Con propria deliberazione la Giunta regionale organizza le modalità attuative del confronto. 5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle attività di monitoraggio di cui al comma 1 e degli esiti delle valutazioni di cui al comma 4 con cadenza biennale”.
L'articolo, collocandosi nell'ottica di un miglioramento della qualità delle politiche adottate attraverso l'adozione del Piano, sottolinea l'importanza e la necessità dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, al fine di coglierne i limiti applicativi e verificare l'osservanza delle disposizioni in esse contenute. L'attività di monitoraggio rappresenta un requisito indispensabile nell'ottica di diffondere nel governo del territorio pratiche di benchmarking, le quali si fondano sull'obiettivo primario di attuare politiche improntate all'efficienza e all'efficacia.
Art. 34 -L’ informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio “1. La Regione, in collaborazione con le province e i comuni, promuove e sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio. A tal fine promuove altresì iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio, anche sulla base della programmazione annuale delle risorse finanziarie necessarie approvata con apposita deliberazione della Giunta Regionale. 2. I comuni, le province e la Regione assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti di cui al Titolo II, capi I e II e al Titolo III, capo I. Nell’ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell’entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4. 3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione procedente. 4. La Regione definisce con regolamento le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 35 e linee guida per garantire livelli prestazionali omogenei adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio. 5. Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r.10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione.”
L'articolo 34, facente parte delle disposizioni del capo IV “gli istituti della partecipazione” pone in risalto la natura reticolare del Piano strategico della Regione Toscana. Qui si sottolinea l'importanza della partecipazione della popolazione nei processi decisionali inerenti alle politiche territoriali. Si tratta di un valore di rilevanza primaria, non solo al fine di implementare politiche largamente condivise e basate per ciò su un vasto consenso, ma anche al fine di improntare le procedure amministrative sul requisito primario della trasparenza. La disciplina della partecipazione viene enunciata in ben quattro articoli facenti parte questa sezione (34-38), dato che rimarca l'importanza che la Legge attribuisce alla concertazione ed al confronto al fine dell'attuazione di politiche territoriali consapevoli e condivise. Art. 39 - Accordi di pianificazione “1. Qualora si renda necessario, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 10, la definizione o variazione contestuale di almeno due di essi, il comune, la provincia o la Regione, in base all’interesse prevalente, promuovono la conclusione di apposito accordo di pianificazione, secondo quanto previsto dal presente capo. 2. Con l’accordo di pianificazione le amministrazioni di cui al comma 1 definiscono consensualmente le modifiche da apportare ai rispettivi strumenti della pianificazione territoriale e, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di governo del territorio, anche ai piani operativi con le forme e le modalità procedurali previste dall’articolo 40. I piani operativi sono comunque oggetto dell’accordo di pianificazione nei casi di definizione o variazione di un progetto di territorio del PIT di cui all’articolo 83, comma 5, lettera c). 3. Nel caso in cui, nell’ambito della conferenza convocata ai sensi dell’ articolo 40, comma 1, sia verificato che la proposta di piano non comporti la variazione degli altri strumenti, la conferenza prende atto dell’esito della verifica. In tale ipotesi, il procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione di cui si tratti, prosegue con le forme e le modalità procedurali disciplinate dal Titolo II, capo I.”
Tra gli istituti di collaborazione interistituzionale vengono menzionati gli accordi di pianificazione quali strumenti di coordinamento della pianificazione territoriale adottabili da Regioni, Province e Comuni. Questi accordi tra gli enti territoriali, consentono di apportare modifiche agli strumenti della pianificazione al fine di coordinare gli interventi e di perseguire gli obiettivi del governo del territorio.
Art. 57 - Finalità del piano paesaggistico e osservatorio regionale “ 1. Il PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici, d’ora in avanti denominato “piano paesaggistico”, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d’uso in attuazione degli articoli 131, 133, 135,143 e 145 del
Codice. 2. Il piano paesaggistico, elaborato secondo il procedimento di cui all’articolo 135, comma 1 e di cui all’articolo 143 del Codice, ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale. 3. Con propria deliberazione, la Giunta regionale organizza l’osservatorio del paesaggio, garantendone la partecipazione degli enti locali, con il compito di: a) esercitare il monitoraggio dell’efficacia del piano paesaggistico; b) mantenerne aggiornato e svilupparne il quadro conoscitivo; c) promuovere, in attuazione della convenzione europea sul paesaggio, la partecipazione delle popolazioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale”. L'articolo 57, facente parte delle disposizioni del Titolo IV in materia di tutela del paesaggio, definisce gli obiettivi del piano paesaggistico, il quale si impegna nel riconoscere le caratteristiche peculiari del territorio regionale toscano, ne individua gli obiettivi di qualità e ne determina le limitazioni d'uso. Nell'articolo viene altresì prevista l'organizzazione, da parte della Giunta, dell'Osservatorio del paesaggio, quale strumento incaricato ad attuare un'attività di monitoraggio sull'efficacia del piano e di promuovere la partecipazione attiva della popolazione in conformità con quanto previsto dalla Convenzione. Sempre a garanzia di rappresentatività della molteplicità di interessi presenti sul territorio, viene altresì disposto che l'Osservatorio debba essere composto anche da rappresentanti degli enti locali.
Art. 58 - Valorizzazione dei paesaggi “1. La valorizzazione dei paesaggi consiste nella: a) corretta manutenzione e riproduzione del patrimonio territoriale e delle invarianti che ne strutturano le diverse componenti; b) riqualificazione o ricostruzione dei paesaggi urbani, rurali, naturali compromessi o degradati; c) creazione di nuovi paesaggi che si integrino nel contesto esistente migliorandone la qualità complessiva. 2. La Regione concorre alla valorizzazione dei paesaggi regionali anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro”. L'articolo 58 definisce le modalità attraverso le quali deve esplicarsi la tutela del paesaggio. Anche
in questo articolo si legge chiaramente il recepimento del dettato della Convenzione europea, in
particolare grazie alla disposizione contenuta nella lettera b. la quale riferisce alla riqualificazione
delle aree interessate da processi di degrado. La tutela e valorizzazione del paesaggio non si limita
più quindi, ai soli beni e luoghi di eccellenza, sul solco della concezione tradizionale del Codice e
della vecchia normativa italiana, ma anche nelle disposizioni normative della Regione Toscana va a
collocarsi in un'ottica più ampia, la quale investe il territorio globalmente considerato.
3.2) LA L. N.282/2013 QUALE REALE STRUMENTO DI IMPLEMENTAZIONE DI GOVERNANCE TERRITORIALE DELLA REGIONE TOSCANA
Alla luce dell'analisi dell'articolato della Legge e della lettura dei suoi principi ispiratori, si può
forse assumere che qualora la legge regionale 282/2013 venisse approvata dal Consiglio, essa
potrebbe rappresentare uno strumento efficace per realizzare un effettivo coordinamento
nell'attuazione delle politiche territoriali della Regione.
Tra i suoi principi ispiratori difatti, emerge la chiara volontà di sottolineare l'importanza di una
interdipendenza dei soggetti istituzionali nell'attuazione delle politiche, requisito che si basa sulla
diffusione della concertazione quale valore che orienti i rapporti delle amministrazioni territoriali.
Tale pratica risulta un requisito indispensabile anche al fine di implementare politiche basate su un
utilizzo delle risorse ponderato, in un quadro di scarsità delle stesse, come quello attuale.
L'importanza della partecipazione è sancita anche dalla volontà di coinvolgere la popolazione
all'interno del processo decisionale, al fine di attuare politiche condivise e basate su un largo
consenso, che in ultima istanza, non sottopongano le pubbliche amministrazioni al rischio di
“cattura del regolatore”, che spesso si verifica qualora le scelte degli enti pubblici producano effetti
indesiderati per la popolazione che le subisce.
Date queste premesse, la natura del Piano appare reticolare, improntata quindi al più largo
coinvolgimento degli interessi presenti sul territorio.
La legge risponde anche ai requisiti e agli obiettivi della pianificazione strategica, quale sistema
attraverso il quale ripensare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche italiane; questo appare
evidente grazie alla lettura di alcune disposizioni, quali ad esempio la previsione del monitoraggio
sull'attuazione delle politiche, pratica che consente di coglierne i limiti applicativi e migliorarne
l'efficienza e l'efficacia. L'attività di monitoraggio rappresenta un requisito di importanza cruciale al
fine di orientare l'attività degli enti pubblici verso il benchmarking, ovvero verso un continuo
miglioramento delle pratiche.
La Legge inoltre si pone in perfetta sintonia con le disposizioni della Convenzione europea del
Paesaggio, grazie in particolare alla nozione di tutela territoriale, riferimento che sta a indicare il
passaggio da un'antica concezione di salvaguardia del paesaggio che considerava meritevoli di
tutela solo beni e territori che presentavano caratteri di eccellenza, per abbracciarne invece una
nuova la quale mira alla valorizzazione dell'intero territorio regionale.
Il giudizio complessivo sulla Legge quindi, appare positivo, poiché essa esprime nei suoi contenuti,
molti degli elementi innovativi e funzionali adottati dalla più recente normativa sul tema.
Ovviamente non è possibile esprimere conclusioni nette in merito, poiché il testo normativo non è
ancora stato adottato, ed anche perché i suoi effetti potranno essere constatati solo in seguito alla
sua attuazione, e dipenderanno in ultima istanza dalla capacità di tutti gli enti territoriali coinvolti di
promuovere una gestione politica del territorio basata sul confronto e sulla concertazione.
CONCLUSIONI
L'obiettivo iniziale della ricerca era quello di indagare le modalità attraverso le quali si esplica la
tutela del paesaggio e del territorio in Italia, data l'importanza assunta dalla nozione di paesaggio
come presupposto ai fini della pianificazione.
In merito è stato rilevato che sebbene il Codice dei beni culturali e del Paesaggio abbia recepito il
dettato della Convenzione europea, esso rimane ancora fortemente legato alla tradizione vincolistica
italiana, volta a tutelare prevalentemente le aree territoriali caratterizzate da particolare bellezza o
pregio. E' stato anche osservato però, che una apertura del Codice può essere ottenuta attraverso una
integrazione di esso con le prescrizioni della Convenzione.
La ricerca ha in seguito osservato le forme di pianificazione strategica presenti in Italia, aspetto che
correlato a quello della riforma della pianificazione fisica, ha condotto alla definizione di un nuovo
spatial planning italiano.
Si è osservato che se mentre la pianificazione fisica ha subito un processo di istituzionalizzazione,
la pianificazione strategica invece ha dato vita ad una pluralità di esperienze libere e talvolta
scoordinate tra loro, le quali però presentano degli obiettivi comuni:
● diffondere la prassi della pianificazione strategica come modello di governance locale
● sviluppare nuove strategie urbane attraverso processi imitativi delle best practice
“benchmarking” con l'obiettivo di realizzare processi improntati all'efficienza
Tali aspetti hanno condotto a definire la nozione di pianificazione strategica come un
ripensamento della prassi amministrativa italiana, la quale dovrebbe caratterizzarsi per una
sinergia e cooperazione dei rapporti tra le amministrazioni dei diversi livelli territoriali.
In merito alla Legge regionale n.282/2013, è stato osservato che essa contiene disposizioni rilevanti
e innovative, che la pongono tra gli strumenti giuridici all'avanguardia ed in sintonia sia con gli
obiettivi propri della pianificazione strategica, che con quelli enunciati nella Convenzione europea
del Paesaggio.
La conclusione sul merito della Legge però resta ambiguo, poiché solo a seguito della sua
attuazione sarà possibile valutarne gli effetti, che dipenderanno oltre che dalle disposizioni
contenute nel suo articolato, dalla capacità dei soggetti istituzionali di applicarle, dando vita a
politiche territoriali basate sulla cooperazione interistituzionale e sulla concertazione, coinvolgendo
anche la cittadinanza.
Conclusioni simili possono essere espresse anche in merito al concetto di pianificazione strategica
italiana, generalmente considerata.
Come si è osservato, si tratta di un processo in corso e non ancora definito che ha prodotto il
proliferare di esperienze libere prive ancora di istituzionalizzazione.
Si può allora forse concludere assumendo che il concetto di governance territoriale sta iniziando a
plasmare i rapporti tra i diversi livelli territoriali di governo, ma che la sua concreta affermazione vi
sarà solo nel momento in cui questi ultimi saranno disposti a cedere parte della propria sovranità al
fine di realizzare politiche comuni, improntate una volta per tutte alla realizzazione di risultati
efficienti e largamente condivisi dalla popolazione.
Riferimenti bibliografici
A. MAGNIER “Sociologia e spatial planning:l'esperienza italiana”
A. MAGNIER, V. PAPPALARDO “Interpretando il paesaggio percepito”
C.DRIGO “Tutela e valorizzazione del paesaggio, il panorama europeo” online su www.giurcost.org
D. SORACE “Paesaggio e paesaggi della Convenzione Europea” in “Convenzione europea del paesaggio e
governo del territorio” a cura di G.F. Cartei, Bologna, 2007
F.ARCHIBUGI, Introduzione alla pianificazione strategica in ambito pubblico, Firenze, 2005
F. MERUSI “Commentario alla Costituzione” a cura di G. Branca, vol. I, Bologna, 1975
G. CAIA, Beni culturali e paesaggio nel recente Codice: i principi e la nozione di patrimonio culturale, in Studi
in onore di Leopoldo Mazzarolli, vol.III, Padova, 2007
G.F. CARTEI “La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata”, Torino, 1995
G.F. CARTEI “Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio”, Bologna, 2007
M.C. GHIBELLI Tre famiglie di piani strategici: verso un modello reticolare e visionario in F. CURTI, M.C.
GHIBELLI Pianificazione strategica e gestione dello sviluppo urbano, Firenze, 1996
P. MARZARO “Paesaggio e autonomie territoriali, ovvero sulla necessità della dimensione paesaggistica del
territorio” in “Governo del territorio e autonomie locali” a cura di G. Sciullo, Bologna, 2010
P. URBANI “Per una critica costruttiva all'attuale disciplina del paesaggio”, in “Diritto dell'economia” 2010
R. BAROCCHI “La pianificazione del paesaggio”; Quaderni del centro studi economici politici Ezio Vanoni
n.3/4; 2005, Trieste
R. GAMBINO, Il ruolo della pianificazione territoriale nell'attuazione della Convenzione, relazione al Convegno
“La Convenzione europea del paesaggio: itinerari interpretativi e applicazioni”, Università di Firenze, 2006
S. AMOROSINO “Introduzione al diritto del paesaggio”, Bari, 2010
S. AMOROSINO “Il codice dei beni culturali e del paesaggio” a cura di M. Cammelli, Bologna, 2007
S.SETTIS “Paesaggio Costituzione Cemento (La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile)”, Torino, 2010
Riferimenti normativiCostituzione italiana
Codice dei beni culturali e del Paesaggio (versione aggiornata dal dlgs. n.157/2006)
Convenzione europea del Paesaggio 2000
Legge n.14/2006 “Ratifica della Convenzione europea sul paesaggio” fatta a Firenze il 20 Settembre del 2000
Legge n.282/2013 “Norme per il governo del territorio”
Legge n.411/1905
Legge n. 1497/1939
Legge n.431/1985
Dlgs. n.490/1999
Sitografiawww.consiglio.regione.toscana.it
www.giurcost.org