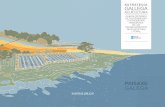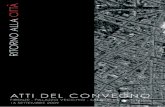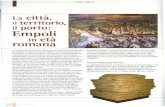Città, territorio, ambiente, educazione
Transcript of Città, territorio, ambiente, educazione
Città, territorio, ambiente ed educazione
di Giorgio Matricardi
Una città che educaQuando, tra il 10 e l’11 dicembre del 1999,
presi parte alla riunione costitutiva delForum della città educativa e solidale1 indetto dalComune di Genova e rivolto a tutti i soggetticoinvolti nel settore educativo, ero più omeno consapevole che la mia città avesse neisuoi geni una forte connotazionepartecipativa: la liberazione di Genova adopera delle forze della Resistenza il 25aprile del 19452 e la protesta del 30 giugno1960 contro la convocazione a Genova del VICongresso del Movimento Sociale Italiano3 sono
1 Per una sintesi del percorso sviluppato a Genova attorno all’idea di Città Educativa si veda: http://www.pianoregolatoresociale.comune.genova.it/portal/template/viewTemplate?templateId=0qjum2b0y2_layout_nrwuztb0y5.psml2 Taviani P. E., Breve storia dell’insurrezione di Genova, Le Monnier (Firenze), 1982.3 Parodi A. G., Le giornate di Genova, Editori Riuniti (Roma), 2010.
1
solo due momenti della storia della mia cittàche danno un esempio di come il ritrovarsinella piazza centrale, Piazza De Ferrari,attorno alla grande fontana circo-lare sia ungesto che, per chi vive in questa cittàcomplessa, voglia dire “mettiamoci assieme efacciamo sentire la nostra voce”. Nonconoscevo però, se non in minima parte, le 250e più realtà ed iniziative che già in cittàfacevano riferimento e rendevano concretequelle dimensioni della cittadinanza attivache sarebbero state declinate, proprio in queigiorni, quale base del Patto di eugeni@ che am-ministrazione e cittadini avrebbero suggellatonell’anno successivo.
Attraverso un percorso schiettamentepartecipativo, i lavori del Forum, riconvocatoanche in incontri successivi, hanno permessodi identificare i valori di base su cui sidoveva fondare la reciproca assunzione diresponsabilità nel riconoscere e rispettare idiritti umani legati ai bisogni elementari edi valore civile che costituiva il patto traamministrazione e cittadinanza. Tra questivalori sottolineerei i seguenti: la città, quale sistema di relazioni, è un
luogo educativo; la città diventa contesto educativo nella
misura in cui i suoi abitanti sonoprotagonisti e attori del proprioterritorio;
2
una città che educa e valorizza laricchezza della convivenza e del confrontonelle diverse culture e nei diversi spazi;
l’educazione, quale leva trasversale dicambiamento, capace di condizionare lepolitiche e la progettualità locale dellacittà, anche rispetto alle dimensioni nonesplicitamente e tradizionalmenteeducative4.Uno dei principali riferimenti a
disposizione dei partecipanti al Forum era ladefinizione di “città educativa” contenutanella Charter of educating cities5 stilata aBarcellona nel 1990 in occasione del primoCongresso Internazionale della IAEC(International Association of Educatine Cities). Nelpreambolo della Carta si legge: “La città Educativaha una personalità propria, integrata nel paese dove èubicata. La sua identità è, pertanto, interdipendente da quelladel territorio a cui appartiene. È anche una città che sirelaziona con l’ambiente circostante, con altri nuclei urbanidel proprio territorio e con città di altri paesi. Il suo obiettivocostante sarà quello di apprendere, scambiare e condividereesperienze e, in questo modo, arricchire la vita dei suoiabitanti”. Ne risulta un’immagine di città come
4 Galliano S. e De Paoli M., Genova, un’occasione di incontro, in: Portolano T. e Ravecca A. (a cura di), Città educativa.Limiti e potenzialità, Fondazione per la scuola di Compagnia di S. Paolo (Torino), Quaderno n. 9: pp. 57-78, 2008.5 Si veda al sito http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/angles/sec_educating.html
3
entità in stretta relazione con il territorio(vicino e lontano) e che caratterizza lapropria identità sulla base della rete diinterazioni tra le diverse componenti dellasua struttura che, a loro volta, sono ilfrutto della possibilità di sviluppo di retisociali propria della città e costituiscono laragione prima della sua soggettività e dellasua organizzazione.
La città come sistemaLa mia formazione nel campo delle scienze
della vita (sono laureato in biologia e da piùdi vent’anni mi occupo di educazione su ar-gomenti scientifici) mi porta a prediligere unpunto di vista che consideri innanzitutto ilfenomeno vita come centrale per la comprensionedi ciò che mi circonda e quindi mi è statonaturale, fin dai primi incontri del Forum,considerare la città come un insieme di esseriviventi (di questi, naturalmente, gli umanisono solo una parte) in interazione tra loro econ un ambiente fisico e chimico che lorostessi hanno contribuito e contribuisconoquotidianamente a modificare anchepesantemente; è quindi comprensibile come leparole della Charter of Educatine Cities mi abbianorichiamato alla mente un concetto che inbiologia risulta particolarmente importante:
4
il concetto di autopoiesi6. In pratica, e moltoin sintesi, si tratta di definire un esserevivente come un sistema autopoietico la cuiorganizzazione (e quindi la suariconoscibilità rispetto a ciò che locirconda) si poggia su una rete di processiinterattivi che costituisce la struttura delsistema (in biologia questa rete si definiscemetabolismo) e che, grazie all’interazione conl’esterno (da cui il sistema ricava materialied energia), autoproduce proprio quellecomponenti che, a loro volta, re-alizzanocontinuamente la stessa rete e definiscono ilsistema come una unità ben distinguibile.Benché sembri una definizione un po’complicata, permette di capire come l’identitàdi un essere vivente corrisponda alla suaorganizzazione e dipenda strettamente dallarete di relazioni che si instaurano tra levarie componenti della sua struttura; piùquesta struttura di interazioni è complessa emaggiori sono le possibilità che essa ha dimodificarsi sotto i disturbi che le vengonodall’ambiente, mantenendo comunque inalteratal’organizzazione del sistema e, quindi,mantenendo l’identità del vivente. Come èevidente, il concetto di autopoiesi può essereapplicato ad una città, che si può considerarecome super-sistema autopoietico (ladefinizione corretta sarebbe sistema autopoietico di6 Maturana H. e Varela F., L’albero della vita, Garzanti (Milano), 1999.
5
ordine superiore) e, quindi, come un insieme dicittadini (sistemi viventi, che necostituiscono parti della strutturainterconnesse tra loro) ed oggetti (case,strade ecc.) che tra loro interagiscono edefiniscono l’identità della città (cioè lasua organizzazione); come tutti i sistemiautopoietici, anche la città si trova aconfrontarsi con le perturbazionidell’ambiente esterno.
Come per un essere vivente, anche per unacittà la storia delle modificazionistrutturali che sono state innescate dadisturbi esterni (dall’ambiente fisico-chimico, da altri sistemi sociali limitrofiecc.) e che non hanno portato alla perdita diidentità della stessa (e quindi al suodisfacimento) giustifica la sua attualeorganizzazione (struttura sociale, economica,politica, istituzionale, culturale ecc.) eracconta di come essa sia stata in grado direagire alle situazioni di disturbo che havissuto; l’identità attuale di Genova narra,ad esempio, di come, nel 1500, la città siastata in grado di reggere alle incursioni deipirati barbareschi dal mare7, di come si siamodificata nel passaggio dall’epoca medievalea quella moderna8, di come la rivoluzione7 Gosse P., Storia della pirateria, Bologna, Odoya (Bologna), 20088 Donaver F., Storia di Genova, Nuova Editrice Genovese (Genova), 2010
6
industriale ne abbia modificato il tessutosociale e abbia dato origine alle Società diMutuo Soccorso9, e così via. Dunque, neldipanarsi della sua storia, la mia città, comeogni altra città o paese, ha assunto emodificato quella che Marc Augé definisceessere la sua natura di luogo antropologico10,quella caratterizzazione di una parte di unterritorio che diviene “principio di senso per chi loabita e principio di comprensibilità per chi lo osserva”; Augécontrappone questa definizione di luogo aquello che lui stesso chiama non-luogo, unterritorio privo di identità, di una storia edin cui non si realizzano relazioni.
La città come luogoIn un contesto educativo può essereinteressante chiedersi, a questo punto, cosapossa significare che il territorio sia,innanzitutto, principio di senso per chi vive alsuo interno. Come suggerisce Fritjof Capra11,per l’essere umano riconoscere una fonte disenso nella realtà che lo circonda implica unainterazione tra la sua cultura personale e lapercezione di ciò che incontra nell’ambienteche lo circonda; Jerome Bruner12 chiarisceancor meglio questa interazione, definendo il
9 Arvati P. e Rugafiori P., Storia della camera del lavoro di Genova, Editrice Sindacale Italiana (Roma), 198110 Augé M., Nonluoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità, Elèuthera (Milano), 2009.11 Capra F., La scienza della vita, RCS Libri (Milano), 2004
7
concetto di “costruzione della realtà”; conqueste parole intende infatti esplicitare comel’attività del fare significato, che si mettein moto ogniqualvolta siamo impegnati nellaconoscenza di qualcosa, sia condizionata eplasmata dagli strumenti percettivi che lastruttura del soggetto può mettere adisposizione e che sono gli organi di senso,il sistema nervoso e la cultura che ilsoggetto già possiede. Dunque, il sistemaautopoietico “uomo”, entro i limiti impostidalla sua struttura, costruisce significatidel mondo che lo circonda, personali macondivisibili con altri suoi simili attraversouna rete di relazioni. Così come accade inogni città o paese, ciascun abitante di Genova(e non necessariamente solo quelli che dagenerazioni vi risiedono), si è fatto, peresempio, una chiara rappresentazione mentaledei diversi quartieri che la compongono graziealle immagini, agli odori, ai sapori, ai suonied alle percezioni tattili che ha raccoltonelle diverse occasioni in cui è stato in queiluoghi, e grazie agli agganci che questepercezioni hanno trovato con la conoscenzapersonale acquisita nella sua storia di esserevivente. È proprio Bruner a suggerirel’apertura al contesto educativo sottolineandocome l’educazione “deve aiutare i giovani a usare glistrumenti del fare significato e della costruzione della realtà,12 Bruner J., La cultura dell’educazione, Feltrinelli (Milano),2001: pag 33
8
in modo che possano adattarsi meglio al mondo in cui sitrovano e, se necessario, cambiarlo”13; tradotto nelcontesto di un sistema autopoietico questosignifica che l’apprendimento (che è unprocesso interattivo in cui le personeimparano l’una dall’altra grazie ad unoscambio reciproco, secondo la definizione chene dà lo stesso Bruner14) permette aicomponenti di parte della struttura delsistema-città (i cittadini, sottosistemianch’essi autopoietici) di mettere in comune irisultati della storia delle modificazioni chela struttura personale (sensitiva, percettivae culturale) ha affrontato nella vitaquotidiana sotto perturbazioni esterne,supportando il mantenimentodell’organizzazione della stessa città equindi la sua identità. Insomma, la scuola el’educazione non formale ed informalepermettono ai futuri cittadini di essere ingrado di mantenere, con consapevolezza ecapacità critica, un’identi-tà storica dellacittà.
Ma Augé non si limita al carattere disignificazione del luogo antropologico,aggiunge che esso deve essere anche fonte dicomprensibilità per chi vi si trova comevisitatore, quindi come soggetto che con quelluogo non ha una storia di interazioni. Ilverbo comprendere racchiude molti significati,13 ibidem14 ibidem, pag. 35.
9
ma tra questi ce ne sono due che mi sembranoparticolarmente utili per esplorare l’aspettoeducativo della definizione di Augé: il primoindica il gesto dell’includere qualche cosa,del contenerla come uno dei propri elementi oentro i propri limiti; il secondo si riferisceall’associare la percezione ad un’idea giàpresente nella mente, al rendersi conto, alpercepire il senso di qualche cosa. Di nuovo,il punto di vista autopoietico ci può aiutarea esplorare i significati della definizione:il sistema umano (in questo caso non è più uncittadino di quel luogo ma un visitatore chepotrebbe venire da lontano) entra in contattocon un ambiente con cui non ha un passato direciprocità: la sua struttura (fisica ma anchementale) inizia ad essere soggetta ad unaserie di perturbazioni da parte del nuovoambiente. A meno che questo non sia cosìostile per il visitatore, così incomprensibile dacausare la distruzione della suaorganizzazione e quindi la morte, all’internodel soggetto si avvia una serie dimodificazioni strutturali che tentano direggere alle perturbazioni che gli vengonodall’ambiente (ha caldo? ha freddo? nondigerisce bene cibi sconosciuti? fatica acomprendere la lingua locale? ha difficoltà adorientarsi?); in questo processo, si modifical’ar-chitettura delle sue varie componenti (sitenga presente, ad esempio, che ogni nuovaesperienza modifica la stessa struttura
10
biologica e cellulare del cervello15). Questemodificazioni hanno lo scopo di riaggiustarela rete di relazioni tra le componenti dellastruttura del soggetto secondo un nuovoequilibrio (in biologia si usa definireomeostasi questo processo di aggiustamentodell’equilibrio interno alle condizioniesterne, anche se, dato il suo carattere dicontinuo divenire, sarebbe preferibileconsiderarlo come una omeodinamica, comesuggerisce Steven Rose16) permettendo ilmantenimento della sua identità o della suastessa esistenza. Come si è già accennato,questo è un processo che coinvolge anche lasfera mentale e che comporta l’inclusionedelle nuove percezioni nella culturapreesistente dell’individuo, la loroassociazione a conoscenze pregresse, chefacilita quindi quella comprensione delladefinizione di Augé.
Per allargare anche la seconda parte dellacaratterizzazione del luogo antropologico allasfera educativa, risulta utile riferirsi acome Howard Gardner intende la comprensione: “Sidà comprensione di un concetto, di un’abilità, di una teoria odi un campo del sapere, quando l’individuo è in grado diapplicare opportunamente tale comprensione in unasituazione nuova”17. È evidente il ruolo deisistemi educativi nello sviluppo di queste15 Moro V. e Filippi B., La plasticità cerebrale, SEID Editori (Firenze), 200916 Rose S., Linee di vita, Garzanti (Milano), 2000
11
capacità di comprensione della persona, maoccorre anche tener presenti i due livelli sucui si articola la comprensione, come mette inevidenza Edgar Morin18: quello intellettuale equello intersoggettivo. Mentre il primo livellocomporta il cogliere assieme “il testo e il suocontesto”, come afferma Morin, cioèl’apprendere intellettualmente ciò che sipercepisce ed il contesto in cui esso sitrova, il livello intersoggettivo comporta ilcoinvolgimento emozionale con l’oggetto dellacomprensione attraverso un processo diempatia, di identificazione e di proiezione.Una città che sia luogo comprensibile, permettequindi al visitatore di cogliere la suaessenza materiale complessa e di confrontarsicon essa attraverso una interazione tra lapropria storia personale e quella del luogo incui si è venuto a trovare. Quando percorro lecalli di Venezia o passeggio sulle mura diLucca, qualche cosa coglie le mie emozioni edentra in comunicazione con la mia esperienzadi vicoli stretti e di viali alberati etranquilli e mi permette di percepire l’iden-tità di quelle città.
La città è quindi un’entità che potremmodefinire viva, in interazione col territorio econ l’ambiente in cui è insediata e ricava da17 Gardner H., Sapere per comprendere, Feltrinelli (Milano),1999: pag. 12318 Morin E., I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina Ed. (Milano), 2001
12
queste interazioni la sua identità e tutto ciòche ne giustifica l’esisten-za; l’educazioneè, a sua volta, lo strumento che permetteall’essere umano di entrare in interazione conla città, di coglierne l’identità e,contemporaneamente, di contribuireemozionalmente alla sua identificazione.
Il “Giardino dell'Erba Voglio”Per rendere in qualche modo evidente la
traduzione sul piano esperienziale di quantodetto fin qui, mi pare utile concentrare l’at-tenzione su un progetto realizzato a Genovaben prima dell’avvio del processo di cittàeducativa e della firma del Patto di eugeni@ matuttora operativo.
Nella mia città, alla fine degli anni ’80,in via Ferrara (una delle strade che siarrampicano sulla collina immediatamente allespalle del porto) vi era un piccolo pezzo diterreno di circa 1200 m2 già destinato alpubblico servizio, ma trasformato in unadiscarica dal degrado e dall’abbandono. Dasempre la città ha poco spazio persvilupparsi, stretta com’è tra mare e monti, equindi sull'area era stato presentato unprogetto per la costruzione di un parcheggiomultipiano destinato ai privati; questaproposta aveva suscitato, però, le protestedegli abitanti del quartiere che chiedevano alComune di recuperare l’area a verde pubblico.I cittadini presentarono, quindi, un loro
13
progetto di sistemazione dell’area, del tuttoinnovativo all’epoca, che prevedeva l’impegnodel Comune a fornire i materiali necessari ela consulenza per la corretta realizzazionedei lavori, mentre i cittadini si sarebberooccupati a titolo volontario dell’attuazionedel progetto. L’idea piacque ma difficoltàburocratiche e gestionali, specie nei rap-porti tra il gruppo di volontari el’amministrazione locale, rallentarono moltol’avvio dei lavori; comunque nel 1996 laristrutturazione fu completata ed il Comunecominciò la ricerca di un soggetto a cuiaffidare la gestione dell’area. La ricerca sidimostrò subito difficoltosa a causa deilimiti strutturali dell’area, priva di serviziigienici, di locali coperti e non ancoradotata di fornitura di energia elettrica edacqua; si aggiunsero inoltre tensioni socialiprovocate nel quartiere dalla variazione didestinazione di questo spazio. La situazionedi stallo, che rischiava di compromettere illavoro di piantumazione di oltre un centinaiodi specie botaniche gratuitamente offertedalla cittadinanza per arredare il giardino,portò alla costituzione dell’associazione “Er-ba Voglio” che, tra i soci, raccoglieva anchequei cittadini che si erano dedicativolontariamente ai lavori di ristrutturazionedell’area, e si risolse con la stipula, nel1997, di una convenzione con l’amministra-zione locale per la gestione di quello che
14
sarebbe poi stato denominato “Giardinodell’Erba Voglio”: ai cittadini era demandatol’impegno dell’apertura e chiusura delgiardino pubblico, della sua manutenzioneordinaria e della sua sorveglianza. Èsingolare ricordare come l'apertura alpubblico del giardino avvenne senza pubblicitàné cerimonia di inaugurazione e come ladenominazione “Il Giardino dell' ErbaVoglio” non sia nata per una scelta politico-amministrativa, ma col tempo, attraverso ilpassa-parola tra i bambini frequentatori delluogo che, uscendo da scuola, si davanoappuntamento: "Allora ci vediamo all'Erba Voglio", in unprocesso che si potrebbe definire a sua voltapartecipativo. Nel tempo che separa il 1997 daoggi, l’Erba Voglio è cresciuta:l'associazione, spinta dalle necessitàespresse dal quartiere e dalla sensibilità dialcuni soci, ha progettato numerose attività,collaterali a quelle previste dallaconvenzione con il Comune e con finalitàessenzialmente educative: l’avvio di progettidi servizio civile, la collaborazione con lescuole (sia del quartiere che di altre zonedella città), esperienze di lettura e prestitodi libri e book-crossing19, celebrazione dicompleanni, feste e altre occasionistrutturate di svago per bambini ed adulti.
19 Vergari L. e Cao M., Bookcrossing, Tenué Ed. (Latina), 2006.
15
Il quadro complessivo di questo progettopresenta quindi la realizzazione di una realtàterritoriale urbana impostata sullacittadinanza attiva e sulla partecipazione perla gestione di un bene comune, quale è ilverde pubblico, che si è dimostrata in gradodi affrontare man mano le più diversedifficoltà: da quelle di natura sociale comeil rispetto di norme e regolamenti, lanecessità di far coesistere bisogni di adultie bambini, il mantenimento delleresponsabilità gestionali da parte divolontari. Non sono mancati inoltre gliostacoli burocratici che hanno punteggiato lastoria dell’Erba Voglio.
Naturalmente il Forum genovese costituentedel progetto di città educativa ha indicatoquesta esperienza come un modello possibile diconcretizzazione dei valori declinati dagliaderenti al Patto di eugeni@, mettendolo adisposizione della cittadinanza grazieall’impegno di alcuni dirigenti e funzionaricomunali che hanno messo a punto una proceduraamministrativa apposita per l’adozione dispazi a verde pubblico da parte di gruppi dicittadini; tutto ciò ha favorito la nascita,negli anni che vanno dal 1999 al 2004, dinumerose esperienze più o meno simili e sparseper tutta la città.
Cerchiamo ora di cogliere, in questaesperienza, lo snodo tra città, territorio,ambiente ed educazione più nel dettaglio,
16
facendo riferimento alla visione sistemica eautopoietica della città mssa a punto inprecedenza. Innanzitutto dobbiamo tenerepresente la storia della città di Genova inepoca industriale: l’inclusione dellefabbriche del ponente nel perimetro cittadino,la creazione di grandi agglomerati abitativiconcentrati nei pochi spazi liberi ai piedidei monti, la sostituzione di intere parti dicittà storica con complessi abitativi adelevata capienza, la trasformazione di luoghidi socializzazione quali piazze e piazzette inzone di transito e sosta per crescentiquantità di veicoli20, sono state scelte dipianificazione urbana facilmente riconducibilialla logica della globalizzazione che, a causadell’assenza di una progettazione complessiva,hanno dissolto, come afferma EleonoraFiorani21, il paesaggio e la natura intorno ailuoghi dell’abitare umano. Ne è risultata unacittà che, in molti suoi spazi, non offre piùluoghi identitari prodotti da storie diinterazione tra cittadini e territorio, maspazi omologati destinati al semplice transitodi veicoli e di persone: il rione, la strada,la piazza e il giardino pubblico sonoscomparsi in diversi quartieri e, di
20 Bellicini L. e Ingersoll R., Periferia italiana, Maltemi Ed. (Roma), 2001: pag. 4621 Fiorani E., La città a rete, in I luoghi dell’abitare a cura di G. Barbieri e E. Fiorani, Apèrion Ed. (Bologna), 1999: pp. 3-19..
17
conseguenza, il sistema-città, come tutti isistemi autopoietici, ha vissuto unriequilibrio dei rapporti tra le componentidella sua struttura: questo ha comportato, tral’al-tro, che i cittadini rinunciassero afrequentare quei luoghi che non c’erano piùnel tessuto urbano, perdendo occasioni disocialità e di interazione che più passava iltempo e più si dimostravano necessarie permantenere proprio l’identità complessiva delluogo e quindi la sua stessa vivibilità.L’uomo però è, a sua volta, un essere viventee quindi un sistema autopoietico e, come tale,la sua struttura reagisce ad uno scompensogenerato da perturbazioni che gli vengono dacambiamenti in ciò che lo circonda; ed è unsistema particolarmente complesso checomprende, tra gli elementi della suastruttura, anche la cultura, fatta diesperienze e significati. La richiesta direcuperare lo spazio verde degradato di ViaFerrara, a Genova, può essere quindi spiegataanche come conseguenza culturale di unaricerca di nuovo equilibrio interno deicittadini, turbati dalle mutazioni indotteall’ambiente urbano, attraverso il recupero diuna rete di interazioni sociali ricca esignificativa. E il numero incredibile difrequentanti del Giardino dell’Erba Voglio,che ad oggi si contano in media attorno alle200 presenze giornaliere, è la traduzionenella realtà di questo nuovo equilibrio. Sul
18
piano educativo, il significato e lacomprensibilità empatica di questo luogo hannoprodotto risultati altrettanto incredibili:oltre al già citato rapporto con le scuole, ilgiardino è divenuto ed è strumento disocializzazione per soggetti adulti afferentiall’Associazione Nazionale Famiglie di Personecon Disabilità Intellettiva e/o Relazionale(ANFFAS22) attraverso attività di volontariatoche vi svolgono da circa 5 anni, è realtà perinserimenti lavorativi di persone svantaggiatee di reinserimento di ragazzi conproblematiche giudiziarie, mantenendo peròininterrotta la sua vocazione ad area a verdepubblico di quartiere.
Come ho già detto, l’esperienza del Giardinodell’Erba Voglio si è dimostrata un buonmodello per il processo di città educativainiziato a Genova nel 1999: ne è testimonianzal’avvio, negli anni successivi, di un numerosuperiore al centinaio di azioni più o menosimili, tutte motivate dai valori declinatinel Patto di eugeni@, con un evidenti risultati:dal punto di vista educativo i cittadini sonostati aiutati a rapportarsi conl’amministrazione e a curarsi del territoriocittadino inteso come bene comune;contemporaneamente le strutture amministrative22 Dal 2002, a seguito di modifiche statutarie a livellonazionale, si è creata la Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS, che prosegue le attivitàa livello locale.
19
hanno dovuto imparare a rapportarsidirettamente con la popolazione, sulla basedei diritti che le sono propri, e a rimodularele procedure e le burocrazie allo scopo di unamaggior comprensibilità e praticabilità per ilcittadino. Anche dal punto di vistaamministrativo i risultati sono staticoncreti, con un guadagno sensibile in terminidi vivibilità urbana ed un non indifferenterisparmio di risorse da partedell’amministrazione comunale.
Una ricognizione del sito internet dedicatoal percorso di città educativa all’interno delportale del Comune di Genova23 permetterà peròdi notare come, a partire dal 2006, non sianopiù segnalate attività riconducibili alprocesso di città educativa: in quell’annoinfatti, con un seminario di riflessione suitemi emersi durante l’VIII Congressodell’AICE24 (tenutosi proprio a Genova nel2004), il Comune di Genova ha dichiaratoconclusa l’esperienza avviata nel 1999,mettendola a disposizione di quello che èstato definito il “Piano regolatore sociale”(PRS)25 della città; questo piano è una23 Si veda all’indirizzo: http://www.comune.genova.it/portal/template/ viewTemplate?templateId=ymghztjsr2_layout_72jttzjsrk.psml24 Si veda all’indirizzo: http://www.aice2004.comune.genova.it/25 Si veda all’indirizzo: http://www.pianoregolatoresociale.comune.genova.it/
20
modalità attraverso la quale, come riportanoSilvia Galliano e Marta De Paoli26, “il Comune sipropone non solo come agente diretto della programmazionee della gestione dei servizi, ma anche come interlocutore diuna pluralità di soggetti pubblici e privati” perconfrontarsi con i problemi complessi dellacittà. É singolare inoltre osservare come neidocumenti relativi al PRS reperibili sulportale del Comune di Genova non vi siatraccia diretta del percorso di cittàeducativa. Uno dei firmatari di peso delpatto, dunque, ha deciso di abbandonare ilpercorso fin lì sviluppato, di non contribuireulteriormente all’azione di coordinamento delprocesso; si potrebbe quindi dedurre chequesto allontanamento si sia riflessosull’intera rete che realizzava il Patto dieugeni@ ed in particolare sul Giardinodell’Erba Voglio e su tutte le altreesperienze di gestione partecipativa del verdepubblico nate su questo modello. É accadutoinvece il contrario: non solo il giardino e lealtre realtà sono tuttora esistenti ed attive,ma altre ne sono nate grazie all’operato deiMunicipi. Inoltre, in occasione di un recenteincontro presso un’associazione culturalegenovese in cui si discuteva più in generaledi utilizzo dei beni territoriali per scopisociali, si sono manifestati alcuni gruppi dicittadini che, senza avere la minima
26 op. cit., pag. 7821
conoscenza del percorso già realizzatosi incittà e delle procedure amministrative giàesistenti, chiedevano proprio la possibilitàdi adottare piccole aree di verde più o menodegradate per riportarle alla originaledestinazione di verde pubblico a disposizionedella città e dei suoi abitanti.
Ancora una volta l’interpretazioneautopoietica della città ci può aiutare acomprendere la recente evoluzione delprocesso. Nei documenti ufficiali cheaccompagnavano il Patto di eugeni@, così comenelle numerose occasioni di discussione, laparola preferita per definire la presenza delComune di Genova all’interno della rete dicittadinanza attiva generata dal patto era“presidiare”, un termine che implica azioni dicontrollo, di sorveglianza, di difesa e cherichiama l’attribuzione, all’interno dellarete, di un livello gerarchicamente piùelevato all’Amministrazione rispetto a quelloriconosciuto ai cittadini. Ma abbiamo giàvisto come la rete di relazioni che mantienel’identità della città possa andare incontro amodificazioni sotto la pressione di agentiesterni; si può riconoscere che, comesottolinea Giovanni Moro27, le esigenze di unmondo politico sempre più lontano dallacittadinanza che lo ha eletto a gestire ipropri bisogni e le proprie aspettative di27 Moro G., Manuale di cittadinanza attiva, Carocci Ed. (Roma), 1998
22
buona vita possano essere definite, “agentiesterni” alla dimensione civica. Dunque, laperdita di un nodo, seppur importante, dellacomplessa rete di relazioni che si eracostruita attorno al bisogno di spazi a verdepubblico si è tradotta in un riaggiustamentodella stessa rete su una struttura che noncomprendeva più proprio il soggetto Comune diGenova. Non vi era più un presidioamministrativo del processo che, da quelmomento, ha però continuato a dipanarsi nellacittà e prosegue tuttora sempre vivace;l’Ammi-nistrazione locale ha perso l’occasionedi “accompagnare” il processo (e non di“presidiarlo”) ed ha delegato la gestione diqueste realtà alle sue strutturecircoscrizionali, impreparate nei confrontidei processi partecipativi. Con questo,naturalmente, si è reso più complesso ilraggiungimento di quei risultati, in terminidi organizzazione del sistema-città che, perGenova, possono rappresentare un rafforzamentodi identità.
Da un certo punto di vista è stato un veropeccato; ma il Giardino dell’Erba Voglio,assieme ai molti altri giardini, pizzette,spazi vedi più o meno attrezzati, aiuole,parchi, anche oggi è aperto ed accoglie coloroi quali cercano di migliorare il loro viveregrazie alla conoscenza, alla relazione conaltri, alla responsabilità, all’impegno, alla
23