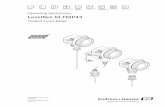La città Nuova. Introduzione
Transcript of La città Nuova. Introduzione
9
l e c i t t à n u o v e
m a r c o d e m i c h e l i s
Certo è che i disegni esposti da Antonio Sant’Elia alla mostra milanese di Nuove Tendenze del 1914 inauguravano un tema, quello della città futura, che, fino a quel momento, non aveva conosciuto nulla di simile nella cultura architettonica occidentale a cavallo tra Ottocento e Novecento.Pochi anni prima, Otto Wagner aveva provato a delineare le modalità di crescita “senza limiti” di una metropoli moderna e la configurazione di un distretto-tipo, utilizzando Vienna come caso-studio da indagare. Hendrik C. Andersen e Ernest Hébrard avevano immaginato nel 1912 la sede dell’International World Center nelle forme di quella “city beautiful” che Daniel Burnham aveva elaborato per la fiera colombiana di Chicago e poi, nel 1907, per il piano urbanistico della metropoli americana.Il concorso per la Grande Berlino del 1910 aveva costituito l’occasione per un vasto confronto sui modelli insediativi diversi della città moderna, integrandovi sia le edificazioni in altezza che quelle a bassissima densità costruttiva teorizzate pochi anni prima da Ebenezer Howard per la sua “città-giardino” che, secondo il suo inventore, avrebbe consentito di eliminare tutti i mali e le contraddizioni della città moderna.Ma, in tutti questi casi, si trattava di tentativi di migliorare, perfino di ri-formare, i modelli reali della grande città all’alba del XX secolo. Non di città future immaginate dai loro inventori.Durante il medesimo scorcio del primo decennio del Novecento, il francese Henri Sauvage aveva elaborato il progetto di un nuovo edificio residenziale “a gradoni” alto tra gli otto e i dieci piani, il cui obiettivo era quello di dilatare verso l’alto il profilo verticale della strada, migliorando le condizioni igieniche delle abitazioni, ed era riuscito a realizzarne un prototipo nella parigina rue Vavin.
Jean-François Raffaeli, Les Champs Elysées, 1902, olio su tela, 65,5 x 81,5 cm. Reims, Musée des Beaux-Arts
10 11marco de michelis le città nuove
Si tratta senza dubbio di un capolavoro fuori del comune, ma privo del carattere paradigmatico e visionario a cui ci abitueranno certe creazioni degli anni venti e trenta dello stesso secolo! Proprio il realismo minuzioso e misurato dell’invenzione di Garnier sembra suggerirne una origine ancora legata a quelle restituzioni archeologiche che erano allora caratteristiche degli “invii” dei borsisti del Prix de Rome e che Garnier aveva polemicamente deciso di sostituire con l’invenzione di una città contemporanea.Sant’Elia aveva sicuramente imparato dai disegni architettonici degli allievi della Wagner-Schule, in particolare l’utilizzo di quella prospettiva dal basso così adatta ad accentuare lo slancio verticale degli edifici. Probabilmente aveva anche conosciuto i progetti di Henri Sauvage per degli edifici residenziali “a gradoni”, dei quali l’architetto francese si era sforzato di sottolineare il realismo, piuttosto che lo slancio visionario futurista. Altrettanto probabilmente, invece, nulla aveva saputo degli studi di Hénard e anche la “cité industrielle” di Garnier non può in ogni modo essere considerata una fonte utilizzabile per l’architettura visionaria del giovane comasco.L’architetto comasco aveva di certo anche conosciuto alcune spettacolari rappresentazioni di una possibile metropoli del futuro con alti grattacieli che fiancheggiavano strade dove il traffico era vertiginosamente distribuito su più livelli e oggetti volanti attraversavano lo spazio. Ma non si trattava di disegni di architetti, quanto piuttosto delle invenzioni di illustratori pubblicati sui giornali popolari, prima dell’America, e poi anche dell’Europa e, in Italia, su “L’Illustrazione italiana”. E vi erano, infine, a disposizione le pagine di scrittori come Jules Verne o Emilio Salgari, che raccontavano di città future con strade enormi, fiancheggiate da edifici alti venti e perfino trenta piani.Con Sant’Elia, la cultura architettonica europea iniziava a occuparsi della città pronta a venire. E, per un secolo intero, non avrebbe più smesso di farlo.
Va detto che i disegni dell’architetto comasco sono, nella maggior parte, rappresentazioni prospettiche di singoli edifici, con poche e sporadiche notazioni architettoniche come sezioni e piante. Mancano soprattutto rappresentazioni di insieme, nelle quali poter riconoscere i tracciati stradali della “Città Nuova”, gli spazi pubblici, la distribuzione delle funzioni, le topografie e le geometrie insediative. L’enfasi è riposta nel sovrapporsi dei diversi livelli delle strade; nelle impennate vertiginose delle torri degli ascensori; nello sviluppo verticale delle facciate a gradoni degli edifici, ancor più sfuggente a causa del punto di vista abbassato delle costruzioni prospettiche. Soprattutto nella assenza assoluta di qualsiasi riferimento agli stili del passato, di qualsiasi apparato decorativo, sostituito dall’alternanza sapiente delle pareti vetrate e delle murature.Vi è una affinità profonda tra lo slancio fantastico delle visioni santeliane e l’energia esplosiva che scuote la città che “sale” di Boccioni, che si gonfia e si trasforma trascinata dall’avanzata poderosa del cavallo, che si inerpica sulle prospettive impennate delle strade deserte di periferia dipinte da Sironi. Siamo di fronte a uno
Perfino gli studi di Eugène Hénard per le trasformazioni di Parigi, pubblicati in otto fascicoli tra il 1903 e il 1909, contenevano proposte per migliorare l’assetto urbano della capitale francese e, in particolare, le condizioni del traffico, talvolta ipotizzando futuristiche soluzioni come la distribuzione su più livelli delle strade e delle reti e la diffusione di automobili e aeroplani ospitati in grandi garage multipiano. Ma non una idea coerente di una intera città concepita sulla base delle necessità peculiari del nuovo secolo appena iniziato, se si eccettua per una ingenua prospettiva a volo d’uccello presentata in occasione del della? Town Planning Conference di Londra del 1910, con innumerevoli velivoli che affollavano il cielo sopra una città irta di torri e campanili, con un grande viale circolare su cui si attestano le stazioni ferroviarie e una spettacolare torre centrale issata su uno zoccolo monumentale aperto sui quattro lati.A ben vedere, il solo progetto che, nei primi anni del Novecento, provava a dare una forma organica e originale a una “città nuova” è quello di Tony Garnier, ultimato nella sua prima versione nel 1904. Qui l’architetto francese disegnava ex novo ogni elemento, pubblico e privato, industriale e infrastrutturale, topografico e geografico, della sua città industriale. Stabiliva le diverse zone funzionali e le relazioni che le collegavano. Individuava le diverse tipologie edilizie, gli edifici pubblici e quelli di servizio, sempre rispettando il carattere mediterraneo suggerito dalla localizzazione idealmente collocata nel sud della Francia. Il risultato era un insediamento lineare, orizzontale nelle sue linee di fondo, che seguiva con attenzione le curve di livello del suolo, affacciandosi sulla valle sottostante, con grandiose strutture industriali e modernissimi altoforni a una estremità e, sullo sfondo, la monumentale diga della centrale idroelettrica che garantiva l’energia necessaria all’intero insediamento.
Eugène Hénard, Una città del futuro vista dall’aeroplano, da “L’architecture”, 1910, n. 46
12 13marco de michelis le città nuove
Mario Sironi, Sintesi di paesaggio urbano, 1919, olio su tela, 40 x 43 cm. Roma, collezione privata
spirito che non è più quello festoso e colorato dei panorami affollati della Parigi dei tardi impressionisti e non ancora quello caotico e disperato della metropoli rappresentata dagli espressionisti tedeschi, come il luogo in cui una umanità disperata, sopravvissuta agli orrori della guerra, non riesce a ritrovare la pace, sopraffatta da un tragico disordine che non può cancellare l’odore della morte e le ingiustizie della vita.
Con la “Città Nuova” di Sant’Elia si apre una stagione straordinariamente fertile, ma anche, è importante notarlo, destinata a consumarsi nel breve scorrere di poco più di due decenni.Dovremmo ricordare i disegni fantastici tracciati dal tedesco Bruno Taut durante i lunghi anni della Prima guerra mondiale, nei quali questi prefigurava la dissoluzione della città ottocentesca in piccole comunità sparse nella campagna con, al centro, il volume cristallino svettante della cattedrale laica che della città costituiva, appunto, la “corona”.Ma il vero inizio di questo nuovo capitolo, nel 1922, è il progetto per la “Città contemporanea per tre milioni di abitanti” di Le Corbusier. Qui l’architetto svizzero elabora per la prima volta un progetto organico per una città contemporanea, nel quale compone le tre “figure” di un centro urbano dominato dai volumi svettanti dei grattacieli cruciformi disposti a scacchiera attorno a una grande stazione centrale dove confluiscono i livelli diversi del traffico motorizzato e su rotaia, mentre la copertura piana viene utilizzata come pista d’atterraggio degli aeromobili; a sua volta circondato dagli edifici residenziali disposti in corpi in linea dal profilo spezzato a “redan”, che interrompono la continuità della edificazione lungo le strade o in grandi isolati rettangolari con vaste corti verdi all’interno. Tutt’intorno, liberamente sparse nel verde della campagna circostante, piccole città-giardino dovevano ospitare la maggioranza degli abitanti impiegati nella grande zona industriale della città. Il progetto di Le Corbusier non può dunque essere considerato come una “utopia”, della quale non possiede il carattere astratto e totalizzante, quanto piuttosto una sintesi paradigmatica del più aggiornato stato dell’arte della architettura urbana europea nel primo scorcio successivo alla fine della Prima guerra mondiale.Non è, dunque, un caso che il prototipo lecorbusieriano conoscesse successive varianti e nuove formulazioni, sia da parte del medesimo architetto svizzero nelle numerosissime occasioni che si riproponevano, a partire dal Plan Voisin per Parigi del 1925, fino alla metà degli anni trenta, quando prendeva forma la sua versione più matura della “Ville Radieuse”; sia da parte di architetti come il tedesco Ludwig Hilberseimer che, già nel 1924, proponeva una sua alternativa “città verticale” nella quale le diverse funzioni – residenziale, lavorativa e di servizio – risultano sovrapposte con un profondo zoccolo di base destinato alla produzione, sopra il quale si elevano delle sottili lame residenziali di quattordici piani, collegate tra loro da una rete di
14 15marco de michelis le città nuove
i n a r r i v o n u o v a
Fernand Léger, The Scaffolding (First State),1919, olio su tela, 64,9 x 53,8 cm. Filadelfia, Philadelphia Museum of Art, A. E. Gallatin Collection
percorsi pedonali in quota lungo i quali si aprono le vetrine delle attività commerciali. Anche Richard Neutra, attivo fin dai primi anni venti nella lontana California, non rinunciava alla opportunità di elaborare una sua variante di metropoli futura con il progetto di “Rush City Reformed”, ricercando, in particolare, una peculiare fisionomia “americana” della sua città, annunciata fin dal titolo nel quale la “velocità” caratterizza il processo di trasformazione – di “riforma” – delineato nel progetto, e il nome stesso rievocava con ironia quella “corsa all’oro” che era stata all’origine della urbanizzazione della costa occidentale americana. Neutra lavorava a “Rush City” ancora durante gli anni trenta, progettando vaste aree residenziali caratterizzate da edifici alti collegati tra loro con passarelle in quota alternate a edificazioni basse con case unifamiliari con giardino; centri comunitari e mercati drive-in dedicati agli utenti motorizzati; complessi scolastici con le aule disposte ad anello e la copertura curiosamente utilizzata come pista per la corsa. Anche a Rush City, come già nella Città Nuova di Sant’Elia e nella Ville contemporaine di Le Corbusier, il terminal ferroviario assume un carattere straordinariamente complesso di nodo “intermodale”, nel quale si incontrano traffico ferroviario, automobilistico e aereo. Ancora una volta, le visioni di Neutra non assumono tanto la configurazione perfetta tipica dei progetti utopistici, quanto piuttosto appaiono come un mosaico flessibile di soluzioni puntuali, un catalogo che riassume un quarto di secolo di esperimenti e riflessioni dell’architetto sulla città contemporanea. Troveremo ancora altri progetti per una città futura, tracciati durante gli anni venti e trenta: in Francia con le “Maison-Tours” di Auguste Perret del 1922; in Olanda ad opera di Theo van Doesburg e di Cornelis van Eesteren e, in particolare, con il progetto di quest’ultimo per un “Quartiere commerciale di una grande città contemporanea” del 1926, dominato da costruzioni in altezza al centro di isolati quadrati con una bassa edificazione perimetrale. Ma era soprattutto l’Unione Sovietica degli anni venti la patria di una intensissima ricerca e di una straordinaria discussione sulle forme originali che la “città socialista” era destinata ad assumere: dalla città lineare di Miljutin, a quella del tutto dissolta nel paesaggio naturale dei disurbanisti, a quella che riformulava le esperienze recenti della architettura residenziale tedesca in un paradigma complesso di cellule abitative standardizzate e di moduli urbani integrati con le residenze e i relativi servizi primari per le nuove città industriali sovietiche ad opera del tedesco Ernst May e del suo collettivo. Il progetto di Ivan Leonidov e delle Brigata OSA, in occasione del concorso per la nuova città di Magnitogorsk nel 1930, immaginava un insediamento lineare nel quale, la regolare successione di isolati quadrati ospitava le diverse funzioni – torri verticali, edifici bassi disposti a scacchiera, attrezzature culturali e impianti sportivi – che si susseguivano, tracciando nel paesaggio ancora indenne da ogni preesistenza urbana un segno perentorio e armoniosamente ritmato, preciso nei suoi bordi laterali e sconfinato nella sua capacità di prolungarsi all’infinito.
16 17marco de michelis le città nuove
La ricerca di una discontinuità violenta nei confronti della tradizione modernista – che aveva avuto il suo manifesto urbano nella Carta d’Atene discussa durante il congresso dei Ciam che, nel 1932, aveva portato i suoi partecipanti da Marsiglia ad Atene e, più tardi, era stata rielaborata e pubblicata da Le Corbusier – caratterizza le nuove generazioni di architetti – e di artisti – che daranno vita alle diverse espressioni delle neoavanguardie degli anni cinquanta e sessanta. Di questa nuova atmosfera sono testimoni artisti come il danese Asger Jorn, che, dopo aver collaborato con Le Corbusier negli anni trenta, dava vita a una furiosa polemica antifunzionalista negli anni cinquanta, fondando il movimento per una “Bauhaus immaginista”, e l’olandese Constant, che dedicherà vent’anni della sua vita, dal 1957 fino all’inizio degli settanta, al progetto di “New Babylon”, una città concepita per una società finalmente liberata dalla schiavitù del lavoro e dalla conseguente immutabilità delle sue strutture insediative. L’abbandono delle gerarchie funzionali immutabili della città moderna, quelle che letteralmente legavano la residenza e il lavoro, il pubblico e il privato, corrispondeva alla rivendicazione del movimento situazionista ispirato da Guy Debord di una inedita libertà nella quale il ruolo di protagonista doveva essere affidato al gioco. Secondo questo modello, gli abitanti del pianeta avrebbero avuto la libertà di spostarsi illimitatamente lungo un sistema spaziale sospeso sul suolo, labirintico e continuamente cangiante sulla base del mutare dei bisogni e dei desideri.Nel 1957, i principi per una “architettura mobile” elaborati dal franco-ungherese Yona Friedman avevano proposto tematiche non del tutto diverse: che le nuove costruzioni dovessero essere sospese sul suolo; che fossero smontabili e spostabili; che il loro utente potesse modificarle continuamente a proprio piacimento. In questa
Le Corbusier, Diorama della città contemporanea per tre milioni di abitanti, 1922. Parigi, Fondation Le Corbusier (FLC by SIAE 2013)
Le Corbusier, Plan Voisin, 1925, fotografia del plastico. Parigi, Fondation Le Corbusier (FLC by SIAE 2013)
In questo clima, ancora caratterizzato da una straordinaria attenzione per l’originalità delle sperimentazioni e per la consapevolezza di dover dar forma a un progetto socio-politico del tutto innovativo, non deve stupire che, nelle scuole sovietiche e in particolare nel leggendario VChUTEMAS, venissero discusse con favore tesi come quella nella quale il giovane Georgij Tichonovic Krutikov immaginava nel 1928 una città volante che si librava sulla terra con case-comuni verticali montate lungo il perimetro di un anello circolare, dove potevano “attraccare” piccole capsule volanti destinate ai nuovi abitanti della città. Proprio vent’anni prima, l’artista tedesco Wenzel Hablik si era immaginato qualcosa di simile, nelle forme di una “colonia nell’aria”, nella quale grappoli di cellule abitative erano sostenuti da una miriade di eliche rotanti sui tetti semisferici.Il rovinoso concludersi della Seconda guerra mondiale e la scia di inaudite distruzioni e di morti che questa si lasciava alle spalle concludevano irrimediabilmente questa stagione eroica e visionaria della architettura occidentale, ma, come vedremo, proprio l’urgenza materiale della ricostruzione delle città distrutte inaugurava un inedito terreno nel quale sembrava che il futuro potesse essere disegnato a partire da una tabula rasa, come faceva, ad esempio, Hans Scharoun con il suo collettivo quando, nel 1946, cercava di dare forma a una nuova Berlino dimentica della sua struttura originaria e trasformata in una città-paesaggio, costituita da un insediamento lineare sparso, in un apparente disordine casuale, tra le superfici verdi e i giardini che avevano sostituito il mare di case e di asfalto della città distrutta. Non è un caso che approcci non essenzialmente differenti caratterizzassero anche alcune voci del dibattito sulla ricostruzione di altre città europee, dalla Londra di Alison e Peter Smithson, all’Olanda …città… di Aldo van Eyck.
18 19marco de michelis le città nuove
Pochi anni dopo, nel primo scorcio degli anni sessanta, il gruppo inglese degli Archigram ribadiva quella medesima illimitata fiducia nella tecnica che aveva costituito uno dei motori della ricostruzione e di quell’ottimismo che ne aveva consentito il successo. Non deve essere sottovalutato il fatto che si deve allo storico inglese Reyner Banham la riscoperta di Sant’Elia e del movimento futurista nel suo seminale Theory and Design in the First MAchine Age uscito in prima edizione nel 1960 e che il futurismo influenzava i primi progetti di Peter Cook, Michael Webb, Dennis Crompton e Ron Herron, non meno dei fumetti, dei racconti di fantascienza e dei primi successi della corsa allo spazio. Lungo tutti gli anni sessanta, Archigram cercava di trasferire le forme e i meccanismi della macchina nel mondo della città futura. Ne denudava gli involucri, esibendone i dispositivi funzionali e, ancor più, i circuiti, le reti, i diagrammi, che ne consentivano il funzionamento. Le megastrutture di “Plug-in City”, di “Computer City” e di “Walking City” parlavano una lingua
prospettiva, sia la New Babylon di Constant che le “città spaziali” di Friedman – che nel frattempo avevano stabilito un rapporto – introducevano l’idea di una città totalmente destrutturata nelle sue zonizzazioni tradizionali e, in ultima analisi, fiduciosa nelle potenzialità offerte dalla tecnica, sia nella prospettiva della emancipazione dal lavoro grazie alla diffusione delle macchine, che in quella della realizzabilità delle grandi strutture sospese nello spazio, destinate a ospitare le cellule vitali delle nuove città. Le costruzioni a piastra sperimentate in quegli anni da architetti come Candilis, Josic e Wood; le strutture a grappolo tridimensionali proposte dagli Smithson per Berlino; il carattere continuamente “non-finito” degli edifici progettati da Cedric Price destinati, come nel caso del suo Fun Palace, a mutare ininterrottamente configurazione e funzioni; tutti questi elementi dimostrano come l’universo visionario di Constant e di Friedman era ben permeabile con quello delle neoavanguardie contemporanee e non isolato nei confini ben serrati dell’utopia.
Wenzel Hablik, La colonia volante, 1908. Itzehoe, Wenzel-Hablik-Stiftung
Ivan Il’ic̆ Leonidov (Collettivo della Brigata OSA), Piano per la nuova città di Magnitogorsk, 1930, assonometria e veduta prospettica
20 21marco de michelis le città nuove
essenzialmente coerente con quella del piano per Tokyo disegnato da Kenzo Tange sulla superficie acquea della baia antistante la capitale giapponese e del progetto del metabolista Arata Isozaki per una città di grappoli di case appesi a enormi pilastri che sovrastavano la edilizia minuta della città esistente. Dall’Unione Sovietica “kruscioviana” e, per l’ultima volta convinta della propria superiorità, degli anni sessanta (Gruppo NER), ai paesi socialisti della Europa centrale come la Polonia o la Cecoslovacchia, a quelli della intera Europa occidentale, fino agli Stati Uniti dove la lezione del piano di Philadelphia di Louis Kahn e Anne Tyng (1954) riecheggiava nei progetti fantastici di Paul Rudolph fino a quelli di Stanley Tigerman e dove le sperimentazioni di Buckminster Fuller trovavano un fertile terreno nei movimenti hippy e in gruppi alternativi come quello di Ant Farm, le tematiche megastrutturali sembravano offrire, se non soluzioni concrete immediatamente utilizzabili, almeno gli stimoli decisivi per riflettere con confermato ottimismo sul futuro prossimo venturo.Il lungo ciclo, iniziato al principio degli anni cinquanta, si concludeva quasi venti anni più tardi, quando i sommovimenti del Sessantotto sancivano l’aporia intrinseca a una interpretazione facilmente ottimistica dello sviluppo tecnologico e, con quello, dello sviluppo capitalistico e, al tempo stesso, del progetto di costruzione di una società socialista negli stati della Europa centrale. I movimenti radicali, nati in Italia attorno al Sessantotto, pretendevano un azzeramento disincantato del punto di partenza: che accadesse nelle forme estreme della fabbrica-città capitalistica, ridotta a uno spazio continuo senza qualità e senza distinzioni nel quale la profezia di Tafuri della dissoluzione dell’oggetto architettonico nello spazio della metropoli moderna trovava la più estrema realizzazione, come pretendeva il gruppo dei fiorentini Archizoom; o prendesse, invece, le sembianze di una ricerca “negativa” sugli archetipi e sulle forme simboliche, indagando la possibilità estrema di sopravvivenza della nozione stessa di architettura, come faceva un altro gruppo di giovani fiorentini riuniti sotto la sigla
di Superstudio. Nelle loro essenziali differenze, alle quali, tuttavia, corrispondevano altrettanto essenziali affinità, i due gruppi proponevano entrambi un percorso antiutopico e disincantato, destinato fin dal suo nascere a consumarsi nel breve spazio di qualche anno. Paradossalmente, la radicalità delle proposte di entrambi Archizoom e Superstudio le condannava a non essere capite neppure da coloro ai quali, in verità, esse erano dedicate. Non da Tafuri, del quale gli Archizoom si erano alimentati voluttuosamente, che non riusciva a dimenticare la lezione di Adorno sul carattere essenzialmente nostalgico e “banale” dell’utopia nel mondo tardocapitalistico e tantomeno ad apprezzare gli sprazzi neoavanguardisti e i compromessi commerciali che le incursioni nel mondo del design avevano portato con sé. Né, ancora, da Aldo Rossi e dagli altri rappresentanti del gruppo di Tendenza – al quale i Superstudio avevano pur guardato con rispetto e interesse, inizialmente ricambiato dallo stesso Rossi –, che gli rinfacciavano l’avanguardismo utopistico, destinato a scontrarsi con l’obiettivo fondamentale della “rifondazione disciplinare”. Come osservava Massimo Scolari, nella “volontà di ricominciare da zero”, Superstudio negava “la storia per ritrovare un nuovo, quanto illusorio, punto di partenza”. Con loro, concludeva Scolari, ci si poteva aiutare “come lo possono fare i sogni, non la scienza”.
I sogni erano davvero finiti. Ma non i processi di trasformazione del fenomeno urbano che ormai dilagavano nel mondo intero. E neppure gli sguardi interrogativi di chi cercava di intendere il senso e le ragioni di questi processi: architetti, urbanisti, sociologhi e geografi. Ma erano soprattutto gli artisti che, dal finire degli anni sessanta, rivolgevano una crescente attenzione al fenomeno urbano e al paesaggio che lo circonda. Mentre tra gli architetti si esauriva l’impulso visionario e la stessa capacità di interpretare tempestivamente i nuovi fenomeni di trasformazione urbana che portavano alla diffusione dello sprawl e delle nuove megalopoli globali, toccava agli artisti di fare delle città contemporanee il teatro delle loro pratiche e anche l’argomento prediletto delle loro osservazioni critiche. Per Dan Graham, come per Gordon Matta-Clark e per Robert Smithson, i processi entropici di degrado e di abbandono di pezzi di città, indotti da quelli paralleli di trasformazione e di espansione, costituivano delle vere e proprie sfide a scavare sotto le apparenze per riportare alla luce bellezze e significati che sembravano essere andati inesorabilmente perduti. E non era diverso l’atteggiamento di quelli – ancora Smithson, Walter De Maria, Michael Heizer – che utilizzavano gli sconfinati paesaggi desertici dell’ovest americano come lo sfondo di nuovi, giganteschi, esperimenti sculturali.Non può dunque stupirci che, proprio nelle ricerche degli artisti delle ultime generazioni, possiamo ancora oggi ritrovare quella tradizione di pensiero radicata nell’idea di una urbanistica visionaria con la “città futura” come protagonista. Il punto di partenza di queste sperimentazioni è una riflessione acuta sui prototipi moderni,
Ludwig Hilberseimer, Hochhausstadt, 1924, vedute prospettiche
22 23marco de michelis le città nuove
sulle loro formulazioni più assolute, risalenti a quegli eroici anni venti durante i quali la nuova architettura aveva dato una forma al mondo che sembrava realizzarsi, alle città e al territorio.L’obiettivo non sembra più essere quello di delineare fisionomie plausibili di processi ancora indefiniti, di disegnare la nuova apparenza delle città future, di immaginare mondi capaci di fornire risposte a nuovi bisogni e nuovi desideri. Ma sarà piuttosto quello di ritornare all’origine di questi processi. Non più di inventare, ma di indagare i fondamenti e le ragioni di quella stagione moderna che aveva ancora saputo interrogare fiduciosamente il futuro. Da qui possiamo iniziare a spiegare a noi stessi perché un artista come Carsten Hoeller riscopre la fantastica città volante della tesi di laurea di Krutikov e, in qualche modo, le dona vita trasformandola in trasparenti sculture di plexiglass, proprio come Rirkrit Tiravanija, Manglano-Ovalle o Tom Sachs hanno fatto con i capolavori di Le Corbusier o Mies van der Rohe. Possiamo cercare di interpretare l’universo parallelo realizzato da Cao Fei nello spazio virtuale di Second Life, popolato non tanto da sfrenate fantasie del futuro, quanto da figure ed edifici del nostro vicino presente: le scarpe di Roger Vivier e gli abiti di Martin Margiela, non meno degli edifici spettacolari disegnati da Herzog & de Meuron o da Rem Koolhaas e Ole Scheeren per la nuova Pechino. Il futuro risiede anche nella nostra capacità di dare un senso alle nostre esperienze e alle memorie: come il sogno di Chris Burden di una sterminata Los Angeles interamente costituita da migliaia di case giocattolo.
Richard Neutra, Rush City Reformed, fine anni venti, prospettiva a volo d’uccello e veduta del Terminal Building
Paul Citroen, Metropolis, 1923, riproduzione fotografica del collage originale, 76,1 x 58,5 cm. Leida, Collection Leiden University Library, PK-F-57.337
24 25marco de michelis le città nuove
Lucia Moholy-Nagy, Berlin, fotografia del fotomontaggio di László Moholy-Nagy proiettato sulla scena di Der Kaufmann von Berlin di Walter Mehring, regia di Erwin Piscator, scene di Moholy-Nagy, 1929, 25,8 x 38 cm. Colonia, Theaterwissenschaftliche Sammlung
Arata Isozaki, Cluster in the air, 1962, modello in legno, acciaio, filo metallico, 27 x 120 x 90,5 cm. Francoforte sul Meno, Deutsches Architektur Museum (DAM). Foto: Hagen Stier