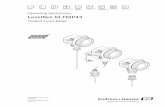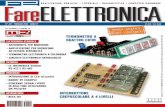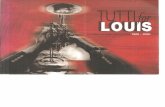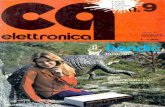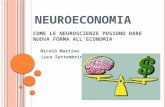nuova-elettronica-099.pdf - Adrirobot
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of nuova-elettronica-099.pdf - Adrirobot
~EIIIIIWIIII¦ARIVISTA MENSILEAnno 11 - n. 99IM SM. Abu Pmi. Gr. M0
PIù MEMORIA per || vosTno v|c.2o
MAGICO sensore per LUCI
UN avvlsatore dlATTESA telefonica
CONTAGIRI per nuto con PLL
UN ESPOSIMETRO per FLASH
ANALIZZATORE GRAFICO dI _BF
Tanti sono diventati in que-sti ultimi tempi i Conces-sionari e i Distributori clnostri Kit che per eiencarlitutti dovremmo ogni mesesacrificare più di quattropagine della rivista. Poichèpreleriamodedicarequestepagine alla presentazionedi nuovi progetti, riportia-mo in hasso solo quei puntivendita in cui ci è stata es-sicurala la prestazione diuna valida assistenza tec-nica, sia come consulenzache come riparazione.
Nella canina sono indicatisolo i capoluoghi principali.
Prelendete sempre dai vostro lornitore.kit sigillati nel caratteristico cartoncinoblul con stampata la dicitura Nuova Elet-tronica; cosi lacendo avrete la certezza diricevere maleriaie di 1` scelta GARANTI-TO, che verrà sempre sostituito gratuita-mente, semprechè voi stessi, incauta-mente. non lo mettiate fuori uso.
c.R.E. - vl- Cncovia, 19 - Tal. OSI/461 Imma... ELETTIOGMÀ - V ma.. BID - Tli. USO/m
CJ! E. -V Flrri. l TILDZISINSBlVil nlxzi del 99. 7B - Tll. 055/4315536
7.7.5. - VI! Duøeíu dl BOHUrISBglII. 60/62 ~ Tel. 055/113300IAICROKIT › 6.10 Tn e. 07 Rosso - Tel. 010/561500ANTEI A RAOLIICCI mi. A viale lillin 471/453 - Tui. Div/mmieELETTRONICA ANDROSIANA - vin cum, A › ni. 02/3612312LORENZO" ELETTRONICA - Vil Duarrin 12/A - Tal. Nl/BSZIQDIAARTINELLI MARCO i C. - v ainuuo. eo -T=|. 059/3110536“HAVE ANTONIO - Wu S. Cosmo Nollr'nv l2l - Tel. Mim-miuLORENZO» ELETTRONICA um. - via venezia. 115 - Tei. 041/4211429RTE. ELETTRONICA - via A. Du Murano. 'ro _ Tui. 049/605710LABORATORIO GANG! † vm A Poliziano. :9 - TEL Del/552301ELETTROMECCANICA M l Il - Vil Sclllhrini. 50 - Tel. 0523/252"PAOLINI A LOMLIARDI u.: .le Pexmccni. 21 YTel. 0513/27166EMPORIO ELETTRONICO ~ Via Moliruri. 53 - Telv 0434/35402GJI. ELETTRONICA - vi: v-I silluro. :in A Tel. 06/1110415:n.11. ELETTRONICA - v Delia Giulim. 107 - Tuus/3154066.11. ELETTRONICA - V Guzicii Lame. 22 - Tunis/:1500111
..EICIÃ M... mCINIIELLO IILWO (Il
ELETTRON A Ricci - in PLr-nm. 2 - Tal. 03:2mLH. i Tnmbetìl 35/A - Tal. 045/552
mmm :dum-uNuovA ELEI-mocvin cwmviu. 19 _ BOLOGNAwenn-o (osv) 45.11 .oosuwlmnw sum"HOTOOFFSET:unFuNo - (ammmm. lun.PAnmNI e c m.Home - Pinm lmipønu-nu, u /sm. :Io/asmaUmch PuhhllfilflMEDIATRONViâ BOCOICCIO. 13 - NlllmYll. 02/4633353
nluum eum-umanu-uni GiumpeMnInpømllhBllnl Mine
AulnrlmáomTrlh. CMI! dl BOIDflIHIL 5055 GGI 21/2/03
RIVISTA MENSILEN. 99 - 1985ANNO XVIIFEBBRAIO
WLMIOMDOIE
NI- :Mm Num Emuaucn ma»uo non-nome mm I una".Grammi manici wwe-mx pmqnm muzznl «vr-nm mm u:Awww." possmlmeme non ImIn aim» a nm (num-m unum-Ie u un dimm (anche n mama)alle acum. unum.L'mmln ma pubblicano sono I!'mammina mmm.. wunm.gu :I own impegna: a 'Iwa-mm ai «mm ai quel leumi cm ruux-me I mogano. non wanna rIuscIII:a mmm i viaunln mmm".GII .moon van-nno r'mmpmnu 1mannaro". .vv-mu. Fmoqune.MI m num". :neu u non'.munari mn vorranno rullmm.
E lrno
I drcum dammi lu uuuu RIM.m I" una mm a ammo.qulml pm emma permuu InIullxlllm dl qulfllb MimIl! "to dlølllflflfllfib, ne è pwbIIlIl IOIIIZIAZMI I CIIIIIIID :MrmIIOIIIl Id Induflrllle. _
1'q I «mm dx vip-namen- ø m-amml pun a pmi-n mi .m-wu pvnuxmi. «I sumi. 'ma m.m 'how-u n mmmi ai a".w wu! I Fun › u pumamxmmw um 'Mu- wo aur- “comuunum ama .umfimfiømmm un". Dinam- dI NumEllfllfllfifl.
`$°MMAI|°
HHIIIIIHIGAL. 8.000L. 3.000
ABIIONAMENTIIfllll 12 numeri L. 80.000Elmo 12 numofl L. 90.000
Numorc llngoloNNIIIII
UN ESPOSIMEI'RO per FLASH LX.693 .........L............. 2UN lvvlsaredl ATTESA IeleIonIcl LX.684 ...._......... ..-......... 14ANALIZZATORE GRAFICO dI BF LX.660 .......... ......... 20MAGICO sensore per LUCI LX.685 .............................0... 42CONTAGIRI economico per AUTO LX.696/LX.697 .CONTAGIRI a 3 cIIre con PLL LX.698/LX.697 ......L'OSCILLOSCOPIO In LABORATORIO LX.676 ..............._ 12PIU MEMORIA per II VOSTRO VIC.20 LX.700 ..................... 02 _PER GUARIRE con L'ELETTROSTIMOLAZIONE ................... 90CARICA PILE NI-Cd con BATTERIA n 12 VOLT LX.687 .......... 96TELEVIDEO sul volIro TV ..............CONSIGLI ed ERRATA CORRIGE .. 105PROGETTI In SINTONIA .............................. 108
Mmllku III'USPI(Umane .Ilmpl
WIOdlcl MKII!)
ln meno di un mese abbiamo ricevuto ben 634lettere che chiedevano tutte un progetto di “espo-simetro per flash". Il contenuto di queste letterechiarisce già dl per se le ragioni per cui tale stru-mento e oggetto di cosi larghe richieste.
l`ll costo di questi esposimetri è davvero esorbl-tante e. poiche sono esperto dl elettronica. Il trovolnglustilicati. l più economici. il cui costo si aggiraintorno alle 150000460000 lire. mi sono statisconsigliati dal negoziante per la loro scarsa affi-dabilitàÀ Per avere un valido e preciso esposimetrooccorre spendere non meno dl 350.000 lire".
"Ho trovato su di un'altra rivista uno schema dillashmetro che ho subito costruito e che purtrop-po. a montaggio ultimato. non ha funzionato. Hospedito il llashmetro a tale rivista per un controllo.ma mie stato restituito nelle stesse condizioni conla seguente risposta - Non laoclamo riparazioni, sirivolga a qualche tecnico della sua città - lo sonoun tecnico. ma per quanti sforzi abbia tatto il mioflashmetro si rlliuta di lunlionare. quindi mi rivolgoa voi, ecc"4 '
"Da anni seguo assiduamente la vostra rivista ed
Un semplice e preciso esposimetro per llash elettronici che vi indl-oherà direttamente quale dlatramma utilizzare ln tunzlone delle sen-alblllta della pellicola utilizzata.
eseguo con pieno successo i vostri progetti. Oraavrei bisogno. per il mio studio fotograllco, di unpreciso esposimetro per llash, In modo da poterstabilire quale diaframma utilizzare per non spre-care inutilmente della pellicola. Poiche non aveteancora presentato sulla vostra rivista questo etru-mento. vl pregherel di prendere In considerazionetale richiesta".
Non proseguiamo oltre. perche queste 3 letteremettono gia sullicientemente in risalto il perchè dltanto interesse per questo strumento
Considerando che per rispondere personalmen-tead ognuna di queste richieste avremmo impiega-to una ventina di giorni circa. abbiamo prelefitoutilizzare questo tempo per progettarlo. disegnar~ne il circuito stampato. montarlo e collaudarlo esoriverne l'articolo per la rivista.
Presentendo un eeposimetro per llaeh di leciteesecuzione, molto preciso e il cui costo. come po-trete constatare, e alla portata dl ogni tasca. rite-niamo di accontentare tutti i nostri lettori appea-sionati di lotogralla.
2
Prima dl pubblicarlo, abbiamo riunito nel nostrolaboratorio. tutti i llash dei nostri collaboratori edabbiamo anche acquistato due coatoslnalml espo-slmetrí professionali. da utilizzare come campionidi riferimento per accertare la precisione del no-stro strumento.
Riteniamo utile sottolineare che il nostro circuitoe tecnicamente un pò più solisticato del classiciesposimetri per flash. in quanto realizzato esclusi›vamente con integrati con ingresso a let.
La scala di lettura, prowista di B diodi led. ciindicherà subito quali degli adialrammi più comu-nemente usati cioè 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - B - 11 -16 - 22.dovremo utilizzare. scegliendo. per l'otturatore.una velocita di 1/50 o 1/60 di secondoA
Abbiamo inline evitato dl util` zara perla memo-ria. dei condensatori elettrolitici: sapendo che laloro capacita varia notevolmente nel tempo.avremmo intatti ottenuto uno strumento non moltoaffidabile
Perannullare la caduta dl tensione introdottadaldiodo raddrlzzatore nel circuito di memoria. ab-
it
ån'
biamo utilizzato un circuito di ingresso con 2 ope-razionall. ottenendo così un perfetto e sempliceesposimetro. con caratteristiche professionali.senza dover spendere l'astronomica cilra dl350.000 e più lire.
SCHEMA ELETTRICOCome molti di voi sapranno. i più comuni espo-
slmetrl perflash utilizzano, come elementi sensibilialla luce, delle cellule solariÀ Queste. colpite dallampo. generano una tensione che viene poi usataper caricare il condensatore di memoria.
Assieme al mobiletto dell'eapo-elmetro vl lomlremo una etichettaautoadesive con sopra riportati Idlalramml da utlllzzare In lunzlo-ne alla aenllblllta della pelllcolaImpiegata. L'ultlmo diodo led po-ato nella colonna In alto e quellodl reaet.
In altrl modelli. vlene invece Impiegato un loto-transistor per modilicare la polarizzazione di basedi un transistor amplilicatore. per poter così otte~nere una tensione da immagazzinare in un con-densatore elettrolitico utilizzato come memoria.
Come gia accennato. questi ultimi modelli. perI'elevata tolleranza del condensatore elettrolitico.le immancabili perdite e la scarsa linearità. dilli-cilmente consentono di raggiungere un'elevataprecisione.
Per owiare a tutti questi inconvenienti. nel pro-gettare questo nostro esposimetro. abbiamo scar-tato entrambi i sistemi tradizionalmente lmpiegatlutilizzando un lotodiodo collegato ad uno stadioconvertitore corrente/tensione.
Per comprendere più lacilmente il funzionamen-to di questo circuito. osserviamo la lig. 1. dove eriportato lo schema elettrico dl "base" del nostrocircuitoA
Sull'ingresso invertente di un operazionale coningresso a let. ad elevata impedenza di Ingresso.abbiamo collegato un lotodiodo FD1. polarizzatoinversamente.
I 'Il'
Flg. 1 ln queato eepoelmetro, perdite-nere mlaure più precise. abbiamo utlltz-zato un normale lotodiodo collegato aduno stadio convertitore corrente/len-alone. Ouando ll lampo del 'leali colpi-m ll lotodiodo. ln ueclta dl ICI/A serepreeente una tensione che aervlra percaricare Il condensato" CG.
Fl¢.2 ConlloirwltorlportatolnIlg.t el presenta I'lnconvonlentedella oedull del diodo DSZ, percul tutte le variazioni lnlerlorl e0,1 volt non verrebbero memoriz-zate lul condensatore CS. Per ov-viare a questo Incomenlento oc-oom ogglungere un altro opere-flonala come "dal In ligure.
ln condizioni normali, cioe con il lotodiodo noneccitato da un liash, questo sl comporta come uncircuito "aperto". cioe presenta una elevate resi-stenza ohmmioaA
Poichè l'ingreeso non lnvertente dell'operallo-nale risulta collegato ad una tensione dl rìlerlmen-to di 3.9 volt. ottenute tramite il diodo zener DZ2.questa tensione la utilizziamo come masse llttizle.
Risultando Inserita tra l'uscita dell'operazionalee I'Ingresso invertente. la resistenza di retroazioneRr, necessaria a mantenere in "equilibrio" il circui-to. anche su questo secondo ingresso sarà presen-te una tensione di 3.9 volt.
Sapendo che il lotodiodo. se non eccitato da unllaah. si comporta come un circuito aperto, risul-tando la resistenza Rr scollegata da massa. nonverrà attraversata da alcuna corrente.
Pertanto la caduta di tensione ai capi di Flr, risul-terà nulla. come sara possibile verificare con lanota legge di Ohm:
V:Rllcioe:Vzltrxlìzl)
Poichè la tensione in uscita deli'operazionaie.dovra polarizzere l'lngresso invertentesul valore di3,9 volt. necessari per equilibrare Il circuito, risul-tando nulla la caduta di tensione ai capi della resi-stenn Rr. il suo valore sarà:
3.'Voil+0V0ll:3,0vollQuando ii lotcdiodo viene colpito dal lampo dl
luce proveniente dal flash, al porta in conduzione.abbassando cosi la sua resistenza ohm'mlce. Suquesta resistenza. inserita ora tra I'ingresso inver-tente e la messa. scorrere una corrente che provo-cherà una caduta dl tensione al capi della resisten-
4
za di retroazione Flr e perciò. euii'lngreeeo inver-tente` non saranno più presenti l 3,9 volt necessariper l'equiilbrio.
Per ripristinare la condizione deli' equilibrio cosimodificato. sarà necessario che i'operezlonaleaumenti la sua tensione d'uscita. in modo da com-pensare la caduta di tensione ai capi Hred ottenerenuovamente sull'lngresso Invertente. ì necessari3,9 volt.
Ammesso che il valore della resistenza Rr risultidi 22.000 ohm. se nel lotodiodo, colpito dalla lucedel llash. scorrere una corrente di 0.1 mA (equiva-lente a 0,0001 Amper), nella resistenze Ftr. comepotremo ancora verilicare con la nota legge diOhm. si avrà una caduta dl tenalone pari a:V:l\l|
cioe:V:fl.WlO,m1:2.2Voll
Per riaveresul terminale lnvertentedeli'integratoICt/A ancora 3,9volt, I'operazlonale domaaumen-tare la sua tensione In uscita lui valore di:22 + 3.! : 6,1 Volt
Perciò, la variazione dl corrente ln Ingresso. pro-vocata dalla luce del llash che colpisce il fotodio-do. verrà convertita in uscita, in una variazione dltensione: avremo cioe ottenuto il convertitore cor-rente/tensione necessario per il lunzionarnento diquesto esposimetro.
In teoria ora potremmo gia aggiungere un circui-to di memoria costituito. come vedesl ln tig. 1. daun diodo raddrizzatore e da un condensatore dielevata capacità.
Cosi lacendo non viene. pero tenuto conto dellecaduta di tensione dei diodo raddrizzatore DSZ(0.7 volt circa), per cui tutte le variazioni di uscitaInferiori a tale tensione, non verrebbero memoriz-
FIQJ Schumaoloìmeoddl'upoollmopufiah.
.Lll “H'ì' TTI-'T
R1 : 22.000 ohm MmmorR2 : 2200 ohm 1/4 “11R0 : 41.000 ohm 114mR4 : 3.900 ohm 1/4 In!!R5 : 330 ohm 1/4vll11110 : 3.900 ohm 1/4 vm!R1 : 3,900 ohm 11401011R0 : 3.000 ohm 1/4 Il!!!R9 : 3.900 ohm 1/4 willR10 .900 ohm 1/4 waltR11 .000 ohm 1/4 mi!R12 .900 ohm 1/4 woìlR13 500 ohm 1/4 Il!!R14 560 ohm 1/4 'III1115 500 ohm 1/4 vuflH1G 560 ohm 1/4 wallR10 500 ohm 1/4 Il"R17 500 ohm 1/4 Il!!R10 500 ohm 1/4 'IllR10 : 5000hm 1/4 Il"
'1
HU
ELENCO COMPONENTI LW
G1 : 41 mF eleflr. 10 vøll100.000 pF pollaio!!100.000 pF pollon-Io100.000 ur poli-mn10 mF elellr. 10 v0"1 mF pollulm
dlødn 1N4140
C203C4C5C0
DZZ enel 3.9 vull 1/2 mDL1-DLO : dlødfl lßd m
i'
Flg. 4 Schoml pnllco 6| montaggio doll'uposhmlro. Poichè ll circuito dlmpllo Oun doppia 'noch I Iorl mmlllmtl. qulmfl non mllmblle lfllgllmlmnnh, abbiamoritenuto Inutil. rlporurne Il dluqno. Sl vlcordl che bbognerù "Id-rc ll lotodlodo F01dal Mo oppone dol clmullø mpllo (poddom vldno I IC1 o a R2).
vuw“iFoto dal pregatolngnndlìo.Lodl- s 6 t i Lmlmlonl rull loponiamo "dmIn n.4.
zate e di conseguenza non avremmo mal una veli-da indicazione sui bassi livelli di luminosità.
Non potremo nemmeno eliminare sull'usciia ildiodo D82 perchè. così facendo` la tensione pre-sente sul condensatore di memorie verrebbe im-mediatamente scaricata sull'operazionale e nuo-vamente la lettura verrebbe sfaisata.
Per cwiare a questo inconveniente, e assoluta-mente necessario aggiungere allo stadiodi ingres-so. un secondo operazionaie, collegato come ve-dasi in tig. 2.
Con questo secondo operazionale riusciremo acorreggere automaticamente le caduta di tensionedal diodo raddrizzatore, ottenendo cosi misureprecisissime anche con una luce di debole intensi-
_ tà. come quella ottenuta dalla riflessione di sogget-ti posti alquanto distante dal flash.
Osservando la fig. 2. potremo subito notare chel'uscita del diodo DSZ della memoria4 è collegataall'ingresso non invertente del secondo operazio-nale - lCi/B. mentre la tensione di polarizzazione.che giunge sul catodo del fotodiodo attraverso Rr.non e più prelevata dali'uscita del primo operazio-nale` ma bensì dall'uscita del secondo.
Fiiportando Ia tensione di uscita di ICI/B. attra-verso la resistenza di retroazione Rr, sull'ingressolnvertente del primo operazionale lCi/A. avremoeliminato automaticamente la caduta di tensionedel diodo D$2 e di conseguenza sull'uscita dilCl/B. avremo un valore di tensione esattamentecorrispondente alla realta.
Precisiamo che il circuito è sensibile solo allevariazioni "impulslve" della luce. cioè a quelle va-riazioni di luminosità ambientale generate da unlampo improwiso. come appunto la luce generatada un flash. Pertanto. anche in ambienti illuminatida altre lampade. la lettura non verrà mai ialsata.
Con il circuito adottato` considerando che I'im-pedenze di carico applicata ai capi del condensa-tore di memorie CG, risulterà estremamente eleva-ta. pari cioe all'impedenze tipica di ingresso dl unoparazionale con ingresso a let (100 megahomcirca), la tensione memorizzate verrà mantenutecostante per un tempo molto lungo (svariati minu-ti). iino a quando cioè non verrà premuto il tasto diRESETv
Avendo a disposizione una tensione memorizza-ta. proporzionale ali'intensita luminosa "impulsi-va" rivelata dal iotodlodo. occorrerà a questo pun-to "visualizzarla" e per questo abbiamo utilizzatoun voltmetro elettronico, a diodi led, aggiungendoal circuito altri due integrati n.064, contenenticiascuno 4 amplificatori operazionali con ingressia fet.
Osservando lc schema elettrico di iig. 3. potre-mo subito notare che tutti gli ingressi invertentidegli otto operazionail iCZ e lCa. sono collegati.all'uscita del convertitore corrente/tensione. (pie-dino 7) di lCi/B.
Flg. 5 Con une pila de 9 voitpiù una mlaienxe da 1.000ohm, riueoiremo facilmente adistinguere ii diodo menor da8.8 voit da quello da 3,0 voti.
Fig. I Se il leeter vi Indi"une tensione di soli 0,1 voil,aiqllflce che avete collocato lefaccia che contoma ll corpo inmodo errato (vedi iig. 5).
Gli ingressi non lnvertenti degli otto operazionailiCZ e lCa. risultano invece collegati ai capi di unpartitore resistivo. costituito dalle resistenza R4.H5, R6. R7. R8. R9. R10. R11 ed R12. Così facendo.i'ingresso non invertente di ciascun operazionale.risulta polarizzeto con una dlllerenie tensione. viavia crescente. con incremento liseo da uno all'aitrodl 412.5 millivolt. _
Ad ogni gradino di tensione cosi ottenuto. corri-spondere l'accensione di uno degli otto diodi led. equesto ad una diversa apertura dei dlalramma del-la macchina fotogralice.
Achi cl domanderà perche non abbiamo utilizza-to. ln sostituzione dei due integrati TLOM. un soloIntegratot UAA.110 o UAAJSO o una barra adiodi led. rispondiamo subito che, per utilizzarli,avremmo dovuto alimentare Il circuito a 18 volt estabillnare l'allmentazione a 15 volt. ottenendoquindi un circuito molto più lngombranie. con unmaggior consumo di corrente.
REALIZZAZIONE PRATICAIl circuito stampato da utilizzare per questo pro-
getto. e con lori metallizzatl. quindi. risultando giapresenti tutti i collegamenti necessari ira le pisteinteriori e quelle superiori. dovremo solamente ln-serire tutti i componenti nelle posizioni indicatedella serigralia e saldarii. cercando di non provo-care. con un eccesso di stagno. dei cortocirculti irale piste dello stampato.
Prendendo come rllerlmento lo schema praticodi lig. 4. inizieremo Inserendo I ire zoccoli per gliintegrati e. terminata questa operazione. prosegui-remo con tutte le resistenze.
' Per I quattro diodi da inserire nel circuito, biso-gnera lare molta attenzione e non conlondere i 2diodi al silicio con I due diodi zener e. poiche nonsempre si riuscire a leggere agevolmente la siglasul minuscolo involucro di tale componente. oon-verra controiiaria con un tester. per evitare di inse-rire lo zener da 3.3 volt dove andrebbe inseritoquello da 3.9 volt o viceversa.
Come vedesi in ilg. 5. collocando In serie al dio-do zener una resistenza da 1.000 ohm ed alimen-tando il tutto con una pila da Svolt. potremo subitorilevare con il tester la tensione ai capi del diodozener ed individuare con estrema laclllta lo zenerda 3.3 volt rispetto quello da 3.9 volt.
Ellettuando tale misura. non dovremo preoccu-parci se la tensione indicata dal tester risulterlleggermente diversa da quella richiesta; inlatti. acausa della tolleranza del diodo ed anche del te-ster. sara più che normale leggere. per lo zener da3.9 volt, una tensione di 4 volt o di 3.8 volt.
Inserendo questi diodi. dovremo anche rispetta-re la polarita A-K dei due terminali e se la lascettadi riferimento ci lascera qualche dubbio, con la
prova di lig. 6 sara possibile individuare anchequesti due terminali. lnlatti. se ll diodo zener verraInserito in senso inverso. ai auoi capi rilevaremouna tensione di 0.6-0.`I volt.
Proseguendo nei montaggio, potremo inseriretutti i condensatori al poliestere e gli elettroliticiI iltrimmer R1 e rivolgere inline la nostra attenzioneallotodiodo e ai diodi led.
ll lotodlodo. come possiamo vedere in lig. 7. slpresenta come un minuscolo rettangolino plasticoda cui fuoriescono i due piedini dl collegamento.Essendo un diodo. anche questo andrà Inseritorispettando la polarità di collegamento perche.montandoio in senso inverso, il circuito non potramai lunzionare.
L'anodo (A). come riportato anche nello schemaelettrico di lig. 3. andra collegato a massa. mentre ilcatodo (K) andra collegato suli'ingresso invertentedeli'amplilicatore operazionale iC1/A.
ll terminale catodo (K) si potra lacilmente identi-licare perche. a ditlerenza dell'altro terminale. hauna piccola sporgenza sul piedino (vedi llg. 7):comunque. per dissipare qualsiasi dubbio. potre-mo guardare come risulterà disposto internamenteil chip del lolodiodo.
Come si potra lacilmente constatare. questochip non si trovera al centro dei piccolo rettangoloplastico. ma spostato tutto verso ll terminale K equesto perche il terminale A. internamente risultacollegato al chip attraverso un sottile tenninaie. alorma di T.
Riconosciuti i due terminali. potremo inserire illotodiodo sul circuito stampato e saldarlo.
Anche per i diodi led bisognerà lare molta atten-zionea non conlondere i due terminali A-K. indivi-duarli. comunque. e molto semplice in quanto idueterrninall non hanno la stessa identica lunghezza(llg. 7): íi terminale più lungo e l'anodo (A) e. comevedesi nello schema elettrico, andrà rivolto verso laresistenza da 560 ohm. mentre ii più corto e ilcatodo (Ki che andrà sempre rivolto verso l'uscitadell'amplllicatore operazionale.
Solo Ii diodo DL9. cioe quello che abbiamo uti-lizzato per indicare il reset deil'eapoaimetro. dovraessere collegato all'anodo (terminale più lungo)verso la resistenza da 560 ohm. mentre li catodo(terminale piú corto) verso massa.
Nell'inserire questi diodi. bisognerà saldarli inmodo che risultino tutti ad uguale altezza controi-lando inline che non luorieecano troppo dal co-perchio del mobile, dove inseguitoracchluderemotutto il circuito stampato.
Terminato tutto il montaggio, potremo inserirenegli zoccoli'i tre integrati. rispettando la tacca dirllerlmento posta su di un iato deli'invoiucro. Inmolti casi. questa tacca potra essere sostituita daun piccolo loreliino. posto sull'invoiucro in pmsimita del piedino 1.
“I
"IITII Illl
BPWSI
q. 1 Connmlonl degli lnlogml vlad dlll'lllo e qunlll dal blodlodo I dlodl bd. Pulndlvldulrl nel lolodlodol mmlnlll A a K guadlhlo lnbmamonh: Il hflnlnlløl Il upon!un lolflll llflnlnlll, che non inviamo Invia dal Illooppoclo K. Furl dlod lod, ll bmllnllllè amp'. più lungo dal lormlnnlø K.
Dcvrtmo uporllre Il grata qu.-du, "Impala su un solo capof-chlo. ullllmndo Il punk del ul-dalorl I Incolla" all'lnlomo dalloro ollmulo. Il pozullo dl plull-ucolor blanco Illln ch. el uniràdi dlflulore dl luci.
ln quali loto i vlllblle sulla namlupulon del clreullo mmpalo lllolodlodo cm vom cool s lronnldl "onu alll llnuln del capor-chlo vlllbllc qul dl Ialo. Sl noll llpollzlom In cul dovnmo collage-nliplllllduløomlndlsì 0M.
A questo punto. per controllare che tutto funzio-na correttamente, potremo collegare al circuito idue iili della presa pila da 9 volt. rispettando ilcolore rosso per il positivo ed il nero per il negativo.poi il pulsante P1 sul due terminali posti vicino aR3.
Inserendo la pila, se il montaggioastato esequi-io correttamente, si accendere uno qualsiasi deidiodi led presenti nel circuito, ma appena pigere-mo il pulsante P1. questo diodo casuale dovrà as-solutamente spegnersi ed accendersi solo ll diodo
`led LDQA questo punto potremo collocare Il nostro
esposlmetro a 2-3 metri dl distanza dal ilaah edeccltandolo, subito si dovrà accendere uno degli 8led della scala.
Ovviamente, non avendo terato iI circuito a nonavendo ancora applicato di ironte al iotodiodo lldíiiusore plastico, sara normale che si acoendasempre uno degli ultimi diodi dell'esposimetro.
II diodo led che sara acceso, rimarrà ln tale con-dizione per un lungo periodo per cul. volendo tarauna nuova misura, dovremo pigiare ancora Il pul-sante P1 di reset, in modo da scaricare la l'memo_ria" e riaccendere il diodo led LDS.
Il circuito, non presentando ditiicolta di mon-taggio. dovrà subito iunzionare regolarmente e, secosi non tosse, avrete sicuramente commeswqualche piccolo errore. come ad esempio, l'averinserito un componente in senso inverso. oppurel'aver dimenticato una saldatura.
Stabiliio il buon iunzionemento del circuito, po-tremo ore collocarlo ell'lnterno del mobiletto pla-stico che abbiamo scelto per questo progetto.
Questo mobiletto dispone, su di un lato dal co-perchio, dl una piccole grate quadrata che dovre-mo asportare perche, sotto questa, andrà incollatela plastica bianca del diiiusore.
Appoggiando al centro dl questa grata la puntacalda del saldatore. potremo iacllmente periorariae in questo modo, con un paio di pinze o di iorbici,togliarla completamente e rliinire in seguito conuna lima i contorni della ilnestrella cosi ottenute.
internamente sl dovrà pol iissare. con qualchegoccia dl cemantatutto, il pezzetto di plasticabianca color latte, da noi iomita. che servirà dadliiusore di luce. mentre sul coperchio opposto.come vedesi anche nelle loto e nei disegni. si do-vranno praticare sotto lo spazio occupato dallaplla. ldue iorl necessari al montaggio dell'intarrut-tore di accensione Si e del pulsante di reset Pt.
Sempre su tale lato della scatola, dovremo eee'gulre. con una punta da trapano da 3 mm. nove loriallineati ira loro, dei quali spergeranno i novadiodldoll'asposimetro.
A questo punto non cl resterà che iissara all'in-temo della scatola il circuito stampato. inserendosotto a questo del distanllatori. in modo da avvici-
10
tieni-nn tina ul!
:DDMmmm
04m04-od-04-O4-O4-04-O-
-IVl im
Flo. I Dopo aver torato I'upoelme-tro, u mettendo ll iluh si dovsaulooandora ll quinto diodo lad, cono-scendo la sensibilità della pellicolaInserita nella macchina iotograflca.potremo subito siabillrasu quale dla-iramma dovremo regolare ll nostroobiettivo.
Flg. 9 Ammesso che la pailieoiaioase una 100 ASA, dovremmo rogo-lara ll dlairamma au "5.6. se tosseinvece una 000 ASA, con lo slusodiodo led acceso. dovremmo regola-re Il diaframma sui/11.
Flg.10 Permlaurareeaal-tamente la luce r'lfieasa dalsoggetto. tenete I'aaposi-metro In prosalmlla dellamacchina fotografica. Do-po aver fatto scattare llflash. potrete leggero sulretro il diaframma da sce-gliere per una esatta upo-sizione.
Y "I try
.Jvar.
m ' '4"rai
nare ll più possibile il fotodlodo al diffusore diplastica bianca. Completeremo Infine ll montaggiocollegando I'Interruttore in serie ad uno dei fili del-la pila, i terminali del pulsante P1 ai due terminalipresenti sul circuito stampato ed applicando sulcoperchio l'adesivo con indicata la sensibilità dellapellicola ed il diaframma corrispondente.
Avendo completato il montaggio dell'esposime-tro, potremo ora passare all'ultima e più importan-te operazione di tantum.
TARATURA
Nei primi prototipi da noi realizzati. non avevamoinserito alcun trimmer di taratura però, in fase dicollaudo. ci siamo accorti che. a causa delle tolle-ranze dei componenti. la lettura non risultava sem-pre quella desiderata. Per questo motivo. abbiamopreferito inserire un tri mer (vedi R1) per potercosi ritoccare la sens lita dell'esposimetro edadattarla con maggior precisione a qualsiasi flash.
Tarare questo trimmer risulterà abbastanzasemplice in quanto sarà il nostro stesso flash afornirci la "luce campione" per la messa a puntodell'esposimetro
Come potremo notare infatti, in ogni flash è pre-sente una tabella che indica quale apertura di dia-framma utilizzare in funzione della distanza delsoggetto e della sensibilità della pellicola utilizzata.
Su tre modelli da nol presi come esempio. peruna pellicola da 100 ASA. abbiamo trovato questetabelle:
rllodofloA :3m.fl$,I-2m.lll -1,5m.I/11"106.l :SmJll -2IILU11-1,5m.fl1lmOdOIIOC : JmJ/fl -2m.|/16-1.5m.f122
Come è facile constatare, ll modello A è menopotente del B ed il C e quello che dispone dl unapotenza maggiore perche, ad uguale distanza. siutillna una minore apertura del diaframma.
Ammettiamo, per esempio. di disporre del flashdi tipo B; sapendo che ad una distanza di 2 metridal soggetto occorre impostare ll diaframma suf/11. dovremo procedere come segue:
Mettere una persona. possibilmente non venitetutta di bianco. al centro di una stanza. pol portarsicon il flash e l'espoaimetro ad una distanza di 2metri dal soggetto.
Dopo aver azzerato l'esposimetro piglando P1,far scattare II flash e controllare quale diodo led siaccende.
Ammesso che si accende il quinto led, pari ad unl/B, dovrete ruotare leggermente il trimmer R1 insenso antlorerio. Far scattare nuovamente Il flashecontrollare se si accende il sesto led. corrispon-dente ad un diaframma di f/11. À
Se si dovesse accendere ll settimo ledl dovrem-mo ruotare il trimmer R1 in senso opposto. mentre.se si dovesse accendere il quarto diodo led. pari adun 115,6, significherebbe che abbiamo ruotato lltrimmer in senso opposto al richiesto.
Ricordatevi di FilTOCCAFlE tale trimmer solodopo averazzerato la memoria. agendosul pulsan-te P1 di reset`
Se lo rltoccheremo quando e ancora acceso unled della scala dell'esposimetro, riusciremo ad ac-cendere il diodo led interessato. ma la taraturasarebbe solo apparente perche, cosi facendo. mo~dlficheremo solo ed esclusivamente la correntechescorre nel fotodlodoe non l'elfettive sensibilitàdel circuito.
Pertanto la taratura andre effettuata sempre esolo sul LAMPO.
Abbiamo consigliato di mettere il soggetto nelmezzo della stanza e di portarsi con il flash e l'e~sposimetro ad una distanza da questo di 2 metri,per evitare che la luce riflessa dalla parete. spe-cialmente se bianca. possa influire sulla taraturadello strumento.
11
Effettuate la taratura, potremo allontanarcl dalsoggetto di un metro. cioe portarci a 3 metri e, cosifacendo. noteremo che si accendere il diodo ledrelativo al diaframma f/B.
Non bisognerà meravigliarsi se. allontanandocí.i'osposimetro anziche indicarci un f/B ci indicheràancora un f/f 1: non dobbiamo dimenticare infatti.che l'esposimetro è uno strumento di precisione emisura esattamente le quantità dl luce che impres-sione la pellicola; pertanto potrà verificarsi la con-dizione che. a 3 metri dal soggetto. alla pellicolagiunga più luce rispetto che ad una distanza di 2metri.
E facile intuire che. allontanandoci dal soggetto.il nostro flash illuminera una maggior superficie disoffitto e di parete e. se questa risultano bianche.una maggior quantita dl luce raggiungerà il sog-getto, per cui l'intensita della luce che impressio-nera la pellicola potra. in tal caso. risultare maggiore.
ll pregio di un esposimetro per flash, e proprioquello di rilevare questa condizione. valutando laluce riflessa da pareti bianche o scure. da tendag-gi. da specchi ecc4 e fornire quindi i'esatta indica-zione dell'apertura dell'obbiettivo. in relazione al-l'amblente in cui ci troviamo.
A questo punto e comprensibile quanto risultiindispensabile disporre di un esposimetro. perchele indicazioni riportate sulla tabella di ogni flash,cioe 2 metri : f/l1. 3 metri : ila, ecc.. sono indi-cazioni puramente teoriche. che non tengono con-to di questi fattori.
A volte queste tabelle non sono neppure moltoaffidabili; Infatti misurando con il nostro esposime-tro l'intensita luminosa di duedíversi flash, che, paruna distanza di due metri dal soggetto consiglia-vano entrambi un diaframma di l/11, mantenendolo stesso soggetto nella stessa stanza, con un mo-dello si otteneva effettivamente f/11, mentre conl'altro f/B.
Scattando delle foto dl prova. abbiamo poi rile-vato che effettivamente occorreva. per il secondoflash, un diatramma di f/Be non di t/11 come ripor-tato ln tabella.
Inserendo nel nostro esposimetro il trimmer ditaratura R1. si avrà l'ulterlore vantaggio di potersempre ritoccare la sens ta del circuito peradattarlo con assoluta preclslone al nostro flash.Infatti, se dopo due o tre prove di sviluppo delnegativo, constateremo che la pellicola e sotto oaovraesposta. potremo sempre modificare la sen›sibilità dell'esposlmetro per una esatta apertura didiaframma.
COME Sl USAPer poter misurare la luce riflessa dal soggetto.
cioe quella che impressionera la pellicola. l'espo-aimetro dovrà essere posto in prossimità della
12
macchina fotografica. con Il fotodiodo rivolto ver-so la persona o ie persone da fotografare (veditig. lo).
Più il soggetto risulterà lontano. minore sara laquantità dl luce riflessa e. logicamente. nell'espo-slmetro si accenderà il diodo led che Indica qualediaframma utilizzare, conformementeal tipo di pel-licola utilizzata ed alla quantita di luce riflessa dallepareti.
Ad esempio, se si accendere il quinto diodo led.dalla tabella dl fig. 8 potremo rilevare che, con unapellicola da 100 Asa (pari a2! Din). dovremo rego-lare iI diaframma su f/8. Se la pellicola risultasse da200 Asa (pari a 24 Din) si dovrà invece regolare ildiaframma su i/11.
Come gia detto precedentemente. l'esposimetrodeve trovarsi in prossimità della macchina fotogra-fica; dieci centimetri in più o In meno non falseran-no la lettura, l'importanteè impedire chela lucedelflash colpisce direttamente il diffusore plastico po-sto di fronte al fotodiodo.
Se vogliamo evitare fin d'ora che. nelle nostrafoto. i soggetti in primo piano risultino piatti e for-temente illuminati. mentre quelli in secondo pianotroppo scuri. non dovremo mai direzionare il flashverso le persone, bensi verso I'alto, in modo che lepareti diffondano in modo equo la luce anche sulsoggetti più lontani.
Sara il nostro espoaimetro che ci aiuterà a sce-gliere. In tali condizioni. il diaframma più idoneoper una giusta esposizione.
0031'0 DI REALIZZAZIONETutto il necessario per la realizzazione dell'e-
sposimetro per flash LX.693 completo dl circuitostampato a lori metallizzati. integrati e relativi loc-colil lotodiodo. diodi led. condensatori. resistenze|presa pila, pulsante. deviatore. mobile plasticoPPA. più il plexiglass diffusore dl luce e la tabellaautoadesiva dei diaframmi L. 25.800
ll solo circuito stampato a forl metallizzatiLX.693 ....................... L.3.300
Nel prezzo non sono ncluse le spese postali dispedizione.
L 'Enciclopedia Laboratorio di Elettronica Digitale eMicrocomputer, oltre che essere una guida chiara,
professionale ed esauriente, Le offre tutto ilmateriale, cherimanediSuapropn'età,perrealizzareoltre100 esperimentie5apparecchiaturespecialistiche:
In un mondo in cui I'Elellronica del Computer ci aiuta continuamenleamigliorare la qualità della nostra vita, ecco per rulli la chiave per entrarein questo universo tanto affascinanle quanto indispensabile e tuttaviamisteriosa. La nuova Enciclopedia Laboratorio di Elellronica Digitalee Microcompuler Le insegna Ia filosofia del Computer: per conoscerlo.per sapere come funziona, per parer/o riparare. per programmarlo. per
FARE PER SAPEREENCICLOPEDIA
è LABORATORIO
DIG/TALE EMICROCOMPUTER
v Minilab(laboratorio dielettronicasperimentale)
0 Tester(analizzatore universale)
ß ülgilalr(laboratorio digitale datavolo)
I EpromProgramma(programmatore di memorie
'Elemcompülclsßßm(microcalcolatore basato su 280)saperlo uxure.
16 VOLUMIcon robusta rilegaturae Sovraccoperla plasti -ficata, piú di 5000pagine, numerosissimeillustrazioni. oltre 870componentiper lesperimentazioni e larealizzazione di 5apparecchiaturespecialistiche.
iln'ampla dacumentadane epmntaperlel,gratultamentee senza impegna.Complli, ritagli e spediscoquesta tagliando In bustachiusaa:
ß©Elettra
Via Stallone 5 - 10126 TorinoTal. (011) 614432
\\|/ / M"una,,,.ev- ,_-I' n
Con la nuova Enciclopedia LaboratoriodiE/ettranicaDigitale e Microcomputeri segreti, le scoperte e le applicazionidell 'elettronica farannoconcretamenteparte della Sua cultura.
ßÖ., Elettra -v Le Enciclopedie Laboratorio.'lgg--I--I--I-I--Ig-g!-g"
mDI INFQHAZIONI SULL' ENCICLOPEDIAmigrfiügê ammonio m16..,1'¦M am DlflIl'llO\lCADlGlTAIIEillClOOOHPlIl'fl¦
I nluunnwfl. iI..liliiiiiiiiiiiiiiiiI-l
wv
lmflmìliiill Ig;.i,-,a
I OOGNONE _r_r_t_|_t_|_|...t_t._t_t_r_t__r_t._|_|_r_| ¦¦ "WE _r-t-t-t-t-tdq-Jq-tdg-J-l-r-JJ-J-r II V14 _.J_|_r_r_|_|_t._r_t_r_t_t_r_t_r_| W_:_.|_r_t I
LOW-"À _|_r_|_t_r_r_t_i_.|_|_.r._r_t_t_t._r._i_r_ø II CAP _.r_|._t_|_t m4_a"~†5L_.|_J_.r_J-r_r_t_r_t_| I
Penuwonofl Psnnoeevtl
`IIiiiIIIIIIIiiiìiIIIIII
I ETÀ _t-t WWE _t_t_t_|_.t_t_t_.t_|_|_t_t_|_t Imvooeuanrcmesm (i
Molti clrcultl elettronici. per quanto semplici. sirivelano di grande utilità pratica. Per questo moti-vo. sulle pagine della nostra rivista. ira progetti piùcomplessi e sofisticati. trovano posto frequente-mente anche schemi molto semplici` che possonoservire da spunto per la risoluzione di piccoli pro-blemi, oppure come idee di progetto. per applica-zioni ben diverse rispetto a quelle da noi suggerite.
ll progetto di "awisatore di attesa telelonica"che ora vi proponiamo. può risultare utile in svaria-te circostanze: ad esempio. quando al telefono
Se nel corso dl una teletonata vorrete tar capire al voatro Interlocutoreche, per qualche istante, dovrà attendere al ricevitore. Inserite questoavvisatore dl attesa telefonica ed egli, durante tate pausa, ascolteràun semplice motivo musicale che lo rassicurerà dl essere sempre inlinea. Questo circuito potrà essere anche utilizzato dal CB per tra-smettere una nota dl separazione tra due comunicazioni o perlnvlareun segnale di presenza sul canale utilizzato.
chiedono di una persona che` per un qualsiasi rno-tivo, sl trovi momentaneamente lontana dal ricevi-tore e che potra raggiungerlo solo entro 2 o 3minuti.
Negli uitici dove4 a volte, e necessario attenderechela persona chiamata. occupata già su un'altralinea, si metta in comunicazione con noi.
In praticav utilizzando questo accessorio. po-tremo rassicurare il nostro interlocutore che nonl'abbiamo dimenticato. o chela linea non è caduta.perchè al suo orecchio giungeranno. durante l'at-tesa. le note di un simpatico motivetto musicale enon le voci ed i suoni confusi. provenienti dall'am-biente circostante.
Ci si potrà servire. inoltre. di questo apparecchioper non lar sentire a chi si trova all'altra capo deliilo cio chela persona con cui chiede di parlare cista suggerendo di rispondergli. ad esempio "che euscita". invece di ricorrere al consueto metodo dichiudere con una mano il microlono della cornetta.
Poichè. inline. il nostro circuito e veramente difacile esecuzione ed anche poco costoso` potraessere utilizzato dagli speakers delle radio privateper separare un annuncio puhblicitario dall'altrc edai CB per cedere Il microfono ai propri corrispon-denti.
Per quest'ultima applicazione occorrerà modifi-care il nostro progetto seguendo le istruzioni che viforniremo di seguito.
14
, : 101000 ohm 1/4 MM : 22.000 ohm 1/4 Watt
: 1.000 ohm 1/4 vllflÀ :1,5meøoohm114flfl
4.100 ohm 1/4 'Il: 100.000 ohm 1/4 M
V : 07.000 ohm 1/4'01!. 0 : 220.0000hm Vinti: 41 mF etattr. 10 volt
100.000 pF potiechn10.000 pF poliaetot'e100.000 pF poliestere41.000 pr pullman15.000 pF poliestere410.000 pF pollo-un1.000 pF pollm
diodo "44100zener 8.2 vott 1 'ottenlr 8.2 volt 1 in!!
diodo ledponte raddr. 100 volt 1PNP tipo BC.,
SCHEMA ELETTRICOLo schema elettrico riportato in tig. 1 dimostra
quanto sia semplice tale circuito. infetti, per questarealizzazione, sono richiesti due soll integrati, duetransistor e pochi componenti passivi.
Su un solo tilo della linee telefonica, dovremocollegare il deviatore Sl che ci permetterà di misteri-re ia comunloazione all'apperecchio teletonlco o alnostro avvisatore rt'attesaA
Spostando tale deviatore verso l'awisatore mu-sicale. la linee telefonica risulterà collegata al pon-te roddrizzatore siglato R81, il quale prowederà atrasferire il positivo di alimentazione verso le resi-
stenza R1 ed il negativo e massa. Indipendente-mente daila polarità presente in linea.
ll diodo zener DZi da 8,2 volt, serve a limitare ilvalore delle tensione applicata tra l'emettitore ed ilcollettore del transistor TRl. in modo da proteg-gerlo da eventuali sovratensioni. mentre DZ2, unozener ancora da 8.2 volt, svolge la lunzlone di carl-co di linee e di stabilizzatore di tensione per ottene-re gli 8,2 volt necessari per alimentare tutto II cir-cuilo.
Avendo impiegato degli integrati C/Mos. il cen-sumo del circuito sera rldottisslmo. pertanto Iltensione presente sulla linea teletonica non subirealcuna ceduta. tanto che sarà impossibile capire seil circuito sia collegato o meno.
Utilizzeremo l'integrato CDAOGO, riportato nelloschema elettrico con la sigla lCZ, per generare lenote musicali. mentre il 60.401 1. più precisamentei tre nand siglati lC1/A~lCl/B-lC1/C` come “misce-
A fianco. Il loto del progetto cosi come Ilpresento I eoltruflone ultimata.
Flg. 1 Schema elettrico.
15
Flg. 2 Chl volessecollegare questo av-vtoetore d'altm adun preamplltlcatoradl BF o ad un rlcetra-unettltore. dovrlmontare sul circuitostampato questi aollcomponenti.
111°
latore digitale". per ottenere in uscita le 6 note dlBF da lnvlara sulla linea teletonlca.
L'oacllletoreoontenmoall'intemo dell'integratolc2.ta capo al piedini 9, 10 e11.l.a sua frequenza dioeclllazione viene determinata dalle resistenze R9 edR10. collegate sui piedini 10 e11. e dal condensatore08. collegato sul piedinotl. con ivalori da noi adottatiei ottiene urla frequenza di circa 10.000 Hz.
Sempre all'interno di tale integrato. sono presen-ti 14 llip-llop. posti in serie. che prowedono a divi-dere la frequenza generata dali'oscillatore per:
ma 'um 1m lulù!!sul piedino a ammo fillfl'"
64 sul piedino l avremo 156 Hz120 sul piedino 6 avremo 18 Hz
sul piedino 13 avremo1.024 sul piedino 15 avremo 9 Hz4.036 sul piedino 1 avremo 2 Hz i
m , :mio ig;, ` . Im
Attraverso le porte nand lC1/B. preleveremo sulpiedini di uscita 5 e 2 una irequenza di 312 H1 eduna di 1 Hz. che applicheremo sui due ingressi delnand lC1/B.
La lrequenza di 1 Hz. owiamente non utilizzabilecome nota dl BF perche cade iuori dalla gammaaudio. la utilizzeremo per abilitare o disabilitare ilnend lCi/tãA In questo modo. aul piedino di uscita11 di IC1/B. sarà presente la nota dl 312 Hz. conuna frequenza di ripetizione pari alle lrequenza dlcommutazione. cioè 1 HzA
Analogamente, con il secondo nend. siglatolCl/C. prelevaremo sui piedini 7 o 3 di IOZ, una
16
trequenza dl 625 Hz ed una lrequenza dl commuta-zlone di 0.6 Hz; pertanto. sul piedino dl uscite 3dllC1/C. avremo una seconda nota di BF a 625 Hz.con una lrequenza di ripetizione di 0.6 Hz.
Polche le uscite di questi due nand, risultanocollegate sugli ingressi del nand lCl/A. questolunzionerà da "miscelatore digitale".
lnlatti. quando è presente. su uno dei suoi In-grassi, una soia delle due note di BF. ritroveremotale nota immutata in uscita` mentre. quando sonopresenti entrambe. sull'uscita troveremo una terzanota di BF, derivata dalla miscelazione digitale dal-le due note fondamentali.
Cosi dicendo. è facilmente comprensibile che lnuscita si potranno ottenere 3 sole note di BF. e non6 note. come da noi accennato.
Per ottenere in uscita 6 note. ulíllzzeremo la reli-stenza R8 ed il diodo DSl . collegati tra il piedlrlo1di 102 ed il punto in comune di RQ-lì10-CBA
Corne vedesi nella tabella precedentemente ri-portata. su tale piedino risulterà presente la ire-quenza dell'oscillatore divisa per 4.096volte. cioe2Hz, vale a dire che 2 volte al secondo. questo piedi-no passerà dal livello logico 1 al livello logico 0 a.cosi facendo. modilicherà la lrequenza dell'oscilla-tore come segue:umieleqlen :monomarcamalologleøoflmoflulm
varlando la lrequenza dell'oscillatore. verieran~no anche tutte le frequenze in uscita aui piedini 5-2e 7-3 per cui. miscelando. come abbiamo vistoprecedentemente. queste nuove lrequenze. rica-veremo altre 3 note diverse che. sommate alle 3precedenti. cl daranno In totale 6 note.
004060ClJlllliq. 3 Connessioni degli iniegrlil vlltl dlli'lllo .dei hlmillorvlfll Invece del bollo.Noi diodo led, Il terminale più lungo e l'enodo.
80237BCJZl
Queste 6 note di BF, attraverso la resistenze R4.il condensatore 05 e la resistenza R3. giungerannosulla base del iransistorTRl, un PNPtipo 36328, esaranno prelevate dali'emettitore di quesi'uitimt).per raggiungere. tramite la resistenze R1 ed il dio-do RSI. la linea telelonica.
Utilizzeremo il quarto nand lC1/D. contenutonell'integrato ICI tipo 004011. perintrodurre unapausa di circa 0,6 secondi tra due gruppi di 6 note.Tale tempo di pausa viene stabilito dalla resistenzeR6. de 1.5 megaohrn. e dei condensatore C7. da410.000 pF, collegato tramite R7. sul piedino 3 dii02.
Volendo. è possibilevariare tale intervallo. modi-iicandc semplicemente ll valore del solo conden-
Fig. 4 Schema pratico di montaggio. Per colle-garlo alla linu ieioionioo. dopo ever togliotoi dueiili, occorrerà collegare I due che provengonodaitelefono I quelli lopruilnti e gli altri due dellelinea l quelli sottostanti.
saiore C7. portandolo cioe e 390.000 pF se deside-riamo ridurlo o a 5604000 pF. se vogliamo aumen-tario.
Questo nand, oltre a pilotare il piedino 12 dl l02per ottenere io spegnimento dell'osciiiatore duran-te il tempo di pausa. io utilizzeremo anche perpoiariuare la base dei transistor TR2, il quale. at-traverso la resistenze R5. prowederà e iar accen-dere il diodo led DLl che ci servirà da SPIA.
intatti non dobbiamo dimenticare che, spostan-do il deviatore Sl verso ii nostro generatore dinote. scoilegnererno i'apparecchio teleionicodallalineal ponente. se questo diodo led risulterà noce-so. signiiicherà che qualcuno è in linee, in attesa diuna risposte
17
Se per un qualsiasi motivo cadeese la comunica-zione o se il nostro interlocutore mettesse giù lecornetta. la linea risulterebbe occupata e. in que-sto caso. nessuno potrebbe più chiamarci: veden-do questo diodo led acceso sapremo che il nostrotelefono e scollegato dalla linea. pertanto. per riat-taccarlo, dovremo spostare S1.
LA IIODIFICA PER I CDPer chi non volesse utilizzare questo generatore
di note come avvisatore d'attesa teletonica. ma lovolesse Impiegare via radio. come nota di ricono-sclmento. o come intermezzo tra gli annunci pub-blicitari. oppure come mezzo per richiamare l'at-tenzione del pubblico prima di una comunicazioneimponente (ad esempio la partenza di una corrie-ra. un avviso in un super-mercato. la ricerca di unapersona in un'oflicine). dovremo apportare al cir-cuito delle semplici modlliche.
Prima dl tutto. dovremo togliere il ponte R81. leresistenze R1 ed R2. i due diodi zener DZi-DZE edIl transistor TRI.
Occorrerà poi alimentare II circuito con una ten-sione continua. compresa tra gli 8 ed l 12 volt.collegando owiamente il positivo dì alimentazionesul positivo del condensatore elettrolltlco Ci ed ilnegat a massa. come vedesi ln tig. 2.
Preleveremo quindi il segnale dl BF. tra Gil-R3(cioe sul punto che. precedentemente. si collegavaalla base del transistor TR1) ela massa. e lo colle-gheremo sull'ingresso BF del preampliticatore odel ricetrasmettitore. In parallelo al microlono.
A tale scopo. potremo utilizzare un pulsante. col›legato in serie al lilo che preleva il segnale di BF dalnostro generatore. in modo che. plgiandolo. aipossa trasterire il segnale d'usclta sull'lngresso BFdel trasmettitore.
REALIZZAZIONE PRATICA
Una volta in possesso del circuito stampato li-glato LX.684. potremo montare tutti l componentirichiesti. iniziando dai due zoccoli per gli integratilCt-IC2. proseguiremo con le resistenze. i con-densatori e termineremo con i dlodl. i transistoradIl ponte raddrizzetore R31.
Tutti i diodi andranno montati con la tascla checontorno un lato del corpo disposta come apparenello schema pratico di tig. 4. cercando owlamen-te di non confondere l due diodi zener con il diodoal silicio DS1.
Anche i due transistor andranno inseriti nei cir-cuito stampato rispettando la disposizione deiterminali E-B-C. pertanto. la parte piana del corpodovre essere rivolta come visibile sulla serigrafiadel circuito stampato.
18
Poichè dovremo racchiudere tutto Il circuito en-tro un piccolo mobile. non impone se di metallo oplastica. tisseremo il diodo led ed ii deviatore Stsul coperchio o sul pannello frontale. collegandoiipoi al circuito con dei corti spezzoni di tilo isolatoin plastica.
Per applicare il circuito al teletono. dovremo ta-gliare i tili che arrivano all'apparecchio. uno pervolta. perchè. risultando presente su questi unatensione continua di circa 30-40 volt. se li tagliere-mo contemporaneamente putrem mo provocare uncortocircuito e tar saltare il tusibile presente nellascatola di derivazione.
Come riportato nello schema pratico di tig. 4. deidue tili della linea che entreranno nella scatola.uno lo collegheremo al terminale centrale dell'in-terruttore St. mentre l'altro andre saldato diretta-mente sul terminale dello stampato. l due lili Inuscita. andranno poi ricollegati ali'apparecchio te-lefonlco.
Eltettuati questi collegamenti. alzando la cornet-ta. se il deviatore e posto in posizione “comunica-zione". dovremo sentire il solito segnale “tu-tu-tu":a questo punto spostando il deviatore in posizione"attesa". il teletono verrà escluso dalla linea ed,automaticamente. si dovrà accendere il diodo led.
Se ciò non si veritlcasse potremmo solo avercollegato In modo errato i due terminali K-A. quin-di. per vederlo accendersi. occorrerà Invertlre llled.
Constatando che tutto funziona regolarmente.riporteremo il deviatore St in posizione "comuni-cazione" e proveremo a chiamare un nostro amico;avuta la comunicazione. gli chiederemo di rimane-re in ascolto e. subito. sposteremo il deviatore St inposizione "attesa". Dopo qualche secondo. ri-prenderemo la linea chiedendogli se il nostro nuo-vo progetto risulti di suo gradimento A questopunto non meravigliatevi se vi chiederà di costruir-gliene subito un'altro anche per il suoapparecchioteleionico.
cOSTO DI REALIZZAZIONETutto il necessario per la realizzazione del pro-
getto LX.684. cioè il circuito stampato a lori metal›Iizzati. l due integrati. gli zoccoli, ll ponte raddrina-tore, i transistor. le resistenze, l dlodl zener e led. ildeviatore Sl L. 14,000
II solo circuito stampato a doppia taccia a lorimetallizzati. siglato LX.684 .......... L4 2.800
Nel prezzo non sono incluse le spese postali dispedizione.
Oscilloscopio doppia Vtraccia 15 MHz
I Schermo B x 10 cml Banda passante dalla
c.c. a 15 MHz (-3 dB)I Sincronizzazione
ì fino a 30 MHz. : I Sensibilità: ,
. i' 5 mV/cm + 20 V/CmI.:Lit. 530.000 / . Funzionamento XY(comprese due sonde 1:1/iz10) I Estrema facilità
di utilizzoI Prova componenti
incorporatoI Segnale di calibrazienr i
_. .(-f-i. i' '.>,,
. , .Rappresentante "dum", P" I "alla Sono inievessaloa: Ei Ricevere documemazione tecnica
I E DE LORENzu instrumon's E visiiadi un vosuoiecnico
20090 soNAsco PIEVE E. (M11 NOME vvia Piemme, 14 - Tel. iozi 90722441/2/3 -Tlx 325065 Du | vi»` v v iROMA: Sani 406! 536977 - TORINO: DELO l. OVEST (DH) 4473906 CAP CITTÀ v. iFIRENZE: Gim'arlnflii (055! 486011 - BOLOGNA: Carl" (051! 213714 DITTA v. .......... MANSIONI
Da sempre la musica, oltre che ascoltarla. el de-sidera anche vederla ed è per questo che. dopo leluci psichedeliche, si è cercato di abbinare all'am-pliiicatore stereo degli analizzatori gralici. utiliz-zando. come vísualizzatori, dei normali diodi led.
Conoscendo il prezzo a cui tali analizzatorl ven-gono venduti. abbiamo pensato che, con una cifranotevolmente interiore. si poteva realizzare unostupendo "visualizzatore gigante". utilizzando loschermo della propria TV a colori.
Precisiamo subito, che il televisore non viene inalcun modo manomesso in quanto. nel nostro ana-lizzatore. e presente un minltrasmettitore in gam-ma UHF, che captato dal televisore come una qual›siasi altra emittente TV. ci consentirà di tar appari-re sullo schermo tutto lo spettro delle lrequenzeaudio.
diremo che In tale anallzzatore` è possibile nonsolo modificare i colori delle colonne. ma ancheaggiungere o ellmlnare i riferimenti della scalegraduata su cui appaiono le varie colonne.
SCHEMA A BLOCCHIPrima di passare alla descrizione dello scheme
elettrico nel suoi particolari, pensiamo sia utilespiegare, più in generale` le lunzioni svolte deglistadi presenti in tale circuito, ed avere cosi subìtochiaro il suo principio di iunzionamento4
Per questo motivo, abbiamo riportato in tig. 3, loschema a blocchi dell'analizzatore audio, indican-do sinteticamente la lunzione svolta in ogni stadio.
ll segnale di BFv prelevato sull'uscita di un pre-amplificatorev di un linale o da una qualsiasi radio
I ANALIZZATOREPer collegare l'uscita del nostro analizzatore alla
presa d'antenna del televisore senza dover semprescollegare posterjormente il connettore dell'an-tenne esterna` si potra utilizzare il commutatored'antenna LX.651, pubblicato sul n. 96 di NuovaElettronica.
Applicando all'ingresso dell'analizzatore un se-gnale di bassa lrequenza proveniente da un qual-siasi amplificatore o registratore. sullo schermodella TV appariranno 20 barre a coloril 10 per ilcanale sinistro e 10 per il canale destro, ciascunacentrata sulle seguenti lrequenze:
32-83-125-250-500-1.M-2.m-4.000-l.000-16.000Hz
Pertanto, ascoltando un qualunque brano musi-cale, potremo vedere. istante per istante. l'amplez›za delle lrequenze dei bassi. dei medi` degli acuti edei superacutiA
Questo analizzatore audio. oltre a rendere “visi-va" la vostra musica. potrà servire pure come vali-do strumento di misura per controllare la bandapassante di un qualsiasi amplificatore o preampli-licatore stereo ed anche come etiicace mezzopubblicitario in quanto. "Folletto" visivo che si ot-tiene suilo schermo del televisore. osservando 20colonne colorate che. a tempo di musica variano inampiezza ed in colore, è senza dubbio tale da ri-chiamare l'attenzione e la curiosità di chiunque
Per rendere ancor più vario l'ettetto finale, vi
20
K' m. 1 coatruandoqueato anallxxatiwaglllb.iee dl BF, potrete tar apparire nullo acharmedel voalro televlaore 10 barre per II canale de-m e 10 per ll canale alnlstre. ognuna centra-h au una dlvem lrequanza. Ognl barra vell-cde appare In tra colori, Glallo-Blu-Rooae.dt. potrete modltlcara In Dlu-Glollo-Roalø
4mentionedunappealtolimitatore.
:1. ai
"Colorato" la rnualca. aggiungendo al vostro Implanlo ad alta ledel-ta o alla vostra discoteca, questo analluatore audlo atereo che, colle-
'gato alla presa d'antenna del vostro TV-COLOR, vl presenterà aulloschermo tutte le ampiezze delle lrequenze acustiche dl entrambl Icanali con barre a tre coloriv
Fm! Ollraamodlllcareleolorldalahlre'altloall e pure poulbtla aggiungere o ellll-
› naraaullo schermo ll retloolo dl rtlerllnentoclaI dltlennu e vlalblle eontrontondo questa liga-
ra oon la tlg. 1. Ognl tacca dl ratlcoto cont-,aponda ad un aumento dl potenza dl 2 I,
qllndl rlwlhndo 15 ll tacche In «M epaaaltilta raflunøare un Inaulrno 0+”O.
E -~ ì-:i_».afl___ H. Rum
o registratore. raggiungerà il primo blocco cheprovvederà, con i suoi dtect tlltrt aotetttvl. a separa-re il segnale BF in 10 bande, ognuna centrata sullefrequenzeai32~ea-125-250-500-14000-2ooo-4000 - 8.000 - 16.000 HZ.
Il segnale presente sull'uscita di questo primostadio. verrà subito reddrizzeto da dieci circuitirettttleatort. (vedi secondo blocco) onde ottenereuna tensione continua. il cui valore risulterà pro-porzionale all'ampiezza del segnale applicato :ul-l'ingressoA
Per tale lunzione. come vedremo in seguito. ab-biamo utilizzato dei rettiticatori "ideali". in gradocioè di raddrizzare segnali di BF anche di pochimillivolt. Condizione questa che mai si riuscirebbead ottenere con dei normali diodi reddrizzatori.che. come si sa. iniziano a condurre solo quandol'ampiezza del segnale supera i 700 millivoltÀ
Queste dieci tensioni di diverso valore. giunge-ranno sullo stadio multipluar. che. sincronizzatodal blocco contatore acanalona multipluor. prov-vederàa lornirle in uscita, ad intervalli regolari. unaper volta, per poterle visualizzare sullo schermo TV.
A questo punto tali tensioni dovranno essereconvertite in una barra verticale la cui altezza rap-presenterà I'ampiezza della lrequenze del segnaledi ingresso selezionato.
A questa tunzione prowede il blocco del “corn-paratora dl acala". il quale. come lascia intuire ilnome stesso. comperando Il livello di tensione in
21
ingresso con la tensione proveniente del bloccogeneratore dl rlmpo esponenziale, stabilisce l'al-tezza ed il colore da assegnare. in quell'istante. allacolonna visualizzata.
Sullo schermo otterremo delle barre verticali lacui altezza variera logarltmlcementl. come in unnormale V-Meter.
Ad ottenere sul video le 20 barre tutte equamentedistanziete prowede il blocco generatore dl tem-perlzuzlenl video.
Tutti i segnali già dosati in ampiezza, in orizzon-tale ein colore ragglungeranno ora il modulotoreVideo PAL. per poter cosi ricavare in uscita unsegnale video, completo del segnale di si ncronisrnoverticale ed orizzontale, del Burst colore. del Blancke_del clock di scansione.
Dall'uscita di quest'ultimo stadio, risulterà dis~ponibile un segnale video che potremmo applicaresolo sull'ingresso di un monitor colori "composi-to". ma non su di una normale TV.
Poichè a noi interessa lrasterirlo proprio sull'in-grasso d'antenna di un televisore a colori` utilizze-remo questo segnale per modulare un minltra-smettitore UHF che lavora sul canale 36.
Collegando con un corto spezzone di cavo coas-siale da 75 ohm, l'uscita di questo minitrasmettito-re sull'ingresso di un'antenna di un qualsiasi tele-visore sintonizzato sul canale 36. vedremo appari-re sullo schermo le nostre 20 barre a colori.
Il circuito è stato progettato per ottenere dellebarre verticali a tre colori, GIALLO - BLU - ROSSOche potremo modificare` agendo su dl un semplicedeviatore, in BLU - GIALLO - ROSSO; inline po-
22
trema sovrappone delle righe orizzontali di riteri-mento (vedl tig. i e tig. 2).
SCHEMA ELETTRICOPer sempliticare lo schema elettrico avremmo
potuto riunire` in un unico rettangolo, i 4operazio-nali..o le 4 porte nand. o i 6 inverter contenutl i unsolo integrato e riportare i soli collegamenti di in-gresso e di usclta di tall integrati.
Cosi tacendo. avremmo ottenuto uno schemaelettrico alquanto compatto, però non molto chia-ro per il lettore che deve comprenderne il tunzio~namentoA
Come si può constatare osservando le tig. 5. 6 e7, tale schema potrebbe. a prima vista` risultarealquanto complesso. ma sara sutticiente osservarela tig. 9. percepire che il circuito non presenterà. intese dl montaggio. alcuna seria ditticoltà ed anzirisulterà molto più semplice di un qualsiasi altromontaggio di elettronica perche, essendo un cir-cuito digitale, non esistono parti critiche nè stadida tarare.
Il primo stadio che prenderemo in esame sarà ìIcirculto dei tiltri d'ingresso. uno per il canale sini-stro (vedi tig. 5) e l'altro per il destro (vedi tig. 6).
Poichè entrambi i canali. destro e sinistro. risulAtano pertettamente similari. sia come lunziona-mento che come valori dei componenti. (cambiasolo la numerazione di sigla delle resistenze e deicondensatori). descriveremo solo lo stadio del ca-nale sinistro. riportato in tig. 5.
Fig. 3 Con questo schema e blocchi risulteràpiù laclle comprendere levarie funzioni svoltelil questo nnallzzalore Per poter trasferireI'immagine su di un normale TV. ll segnalevideo che preleveremo dall'usclta dell'lnteqn-to TEAJm. lo utilizzeremo per modulare unmlnitrasmettltore in gamma UHF.
ll segnale di BF applicato sull'ingresso, giunge-rà. tramite il condensatore 61. sul trimmer R2. ne-cessario per regolare le senllbllltl del circuito.cioè perlar si che le barre luminose raggiungano. enon superino, il massimo livello consentito perqualsiasi tipo di segnale, sia che il circuito vengaapplicato sull'uscita di un amplificatore da 100 +100 Watt, sia ad una radio con una potenza inuscita di 0,8 + 0,8 Watt.
ll primo operazioni-ile. siglato lCl -A. viene utiliz-zato come stadio preamplílicetore-separalore.L'uscite dl lCl/A. come vedesi nello schema elet-trico. iarà capo ai dieci iiliri “passa-banda". ottenu-ti con dieci operazione"` indicati nello schemeelettrico con le sigle de ICZ a lCS.
Come si può notare, esistono quattro operazio-nali siglati IC2/A-iC2/B-lCZ/C402/D, questo per-chè sono quattro gli operazionuli contenuti all'in-terno dell'integrato TL.084. Nella lista componentitroveremo infatti un solo IC2 = TLÀOiMÀ
Variando i soli valori delle due resistenze e deldue condensatori presenti su ognuno di questioperazioneli (vedi R6-Fl7-C2-63 per lCZ-A. R10-R11-CS-CE per lCZ-C eccl). sull'uscite di questisarà presente la sole lrequenza che a nol interessa.cioè quella centrata sul 32 - 63 - 125 - 250 Hz ecc..che dovremo ora traslormere in una tensione con-tinua.
Atale scopo. utilizzeremo altri dieci operazionaliper realizzare dei nddrlmton ideali. in grado cioedi reddrizzare segnali di BF partendo da un minimodi 0volt e non da 0.7 voit.comeierebbe un normalediodo rnddrizzatore.
Fig. 4 SchemaIntorno dall'lnte-grlío TEAJOOZ,cioe del generato-«video-coloni:sllndlrd PAL. tum.
f 1%'mmm ..vm 'ww-f mmmm m tm um5 “Il
"Vu" . llIIlll..3. u I l .1.“'325” I I l. | n Gill"| u i '“gm J ì 'ru-lumi:
'mi l um trm r m s; uma Imm in." i. alle: :aj-H mm ma?~ I * il h - J
m mi. tm. mmmm .- mm
23
24
Flg. 5 Schema elettricadal Illlm d'lngmw del co-ml. slnlltro che In prlìlcnrhum almllnu a quello rh-um vlulbllo In flg. 6. In qu'-ul flllrl non game Munntrimmer dl un" I non u-londo lo :cham- critico.Iunxlomrù sublìo. l num-rlche appaiono sulla uscita,(vldl 1-2-3 Oca). mm Ilqulll sono riportato I. In-quenze dl ogni Illím, vannoI conglungml augll ln-gnßl doll'lnlngulo Icflvlolbllo In Ilg. 1.
Tutfllnlulddcompomn-Il una Ilpovhfl I pug. 2.-II.
Flg. 6 Schuml olmllcodol flliro d'lngrmo dal cl-nlln destro. Con un mio ln-ìegmo 11.004 abbiamo lapoulhlllfl dl nlllmnI fll-'rl (vldl IC 7-A-l-c-Dcom). Negli schemi .Mifiddl Ilq. 5 o ß non nbbhmulnlfl'lío l condmllßrl. hml.@1t32 a da 100.000 pF,wlloallmenlulonl. lnumn-rl ch. lppllonc sulla uwlhmal 11-12-13 ecc.) unmI conglunginl lugll In-gmal doll'lnlogmo ICHvluuu In ng, 1.
'l'unl l ulorl dnl compoun-fl ma Ilporllll I pag. 20-29.
i..f5
28
ILENOOOOIPOIEIITILWR1-_ 1.0Uohh1/4I011
R5 _ 10.000 ohm 1/4 '011R0 : 3.300 ohm 1/4 '011R1 : 100.000ohm 1/40'011R0 : 4,1 moglohm 1140011R9 : 10.0oøohm 1/4'011R10 : 3.900 ohm 1/4 0011R11 : 100.000 ohm 1140011R12 : 4.1 mcg-ohm 1/4 '011R10 : 10.000 ohm 1/4 0011R14 : mohm 1140011R15 : "n.000 ohm 1/4-011R10 : 4,1 mmohm 1/4'011R11 : 10m ohm 1/4 '011R10 : 3.00001001/4 mlR10 : 100.000 ohm 1/4 0011R20 = 4,1 mogoohm 1/4-l1R21 : 10.000 ohm 1/4'011
: 5.000 ohm 1/4 '011: "htm ohm 1/4'01!
R34 : 4.1M oIIIl 1/4 '011R85 : 1M” ohm 1/4'011RSI : 4.1 moooohm1/4U011R31 : 10.000 ohm 1/4 0011RSI : 3.900 ohm 1/40011Ra-- 1M.m ohm 1/4U011R40: 4,1 mooohm 1/4mltR41-- 10.000 ohm 1/4 '011R42: 4.M ohm 1/401011R43 = 100.1!)0 ohm 1I4U011R44 : 4.1 mmohm 1/40011R45 : 10.1!)0 ohm 1/4 '011R40 : 1.000 ohm 1140011R41 : 50.000 ohm 111mm"R40 : 41.1!10 ohm 1/4 '011R40 : 1 molohm 1/40011R50 : 10.M0 ohm 1/4 '011R51 : 3.310 ohm 1/4 '01|R52 : 1W.000 ohm 1/4 '011R53 : 4,1 meglohm 1/4'011RH :10.000011m1/4 0011R55 : 8.000 olln 1/4 '011R50 :1W.0W ohm 1/4 '0111151 : 4,7 mglohm 11410011R50 : 10.0Nohm 1/4'011R60 : 3.31!) ohm 1/4 '011R” = iam ohm 1/4 'm1
u=1molh1l4fll
11-"-
M : 4,1mopohn1/4-t 5 :Wan lv:
Vagg,-
lmolln1/400111M.0Uohm 114001141 mogaohm1/4M10.N0 ohm 1/4 '0115.600 ohm 1/4 0011100.000 ohm 1/4 '01141 mmohm 1/4 001110.000 ohm 1/4 '011
..ãšãšš
šššššš
| a 1. a "4 Q- mogoohR14 : 10.0000hm 1/401011R15-_ 3.000010111/4'011
:1M.000 ohm 1/4 '0111111 4,1 mogaohm1/4 0011
10.m0 ohm 1/4 "011.100 ohm 1/4 '01100.000 ohm 1/4'0111 moglohm 1/4 '0110.000 ohm 1/4 '1011W oNn 1/4 '011M.000 o'ln 1/4'01!,1 moquohm 1/4 '0110.000 ohm 1/4 01011.100 ohm 1/4 n.11W.000 oIIn 1/4'011,1 mogaohm 1/4 'dl0.000 ohm 1/4 '0110M ohm 1/4'0110.000 ohm 1/4 '011.000ohm 1/4010110.1!!! ohm 1/4 '011.0000hm 1/4vnl111.000 ohm 1/4 '0111.000 ohm 1/4 00111.M ohm 1/4 '0110.M0 ohm 1/4 '011
R11» 00.0M ohm 1/4 '011
..9
...
p.0
grn
qid
-..n
9-.
P-.
.dll
IlIl
llIl
Illl
Illl
IlIl
Illl
llIl
IlIl
IlIl
IlIl
IlII
Iši
šiãì
šãšš
iìšië
ëššë
šãã
.a
~ hm Mmmor15.0M ohn 1/4 M0.000 ohm 1/4 01011
.00Oohm1/4vm11R122 : 50.” o'ln 1/411011RUS :1mohm1/4U011R1” = 1mo1001/4flR18 :1M01-1/40d
lfllzflflndfiìßlflIfl1:lfifldm1ßiflR12. = "LWOM 1/4 'IllR12! : 3.” øhm 1/4 Mma = 11m Ohm 1/4 Mlil! : m Ohm 1/4 MIna : 1.200 ohm 1/4 I!!!R1” : *lO-m Ohm 1/4 'Ill
ššä ì?
MIN*id
-b5 1|..
i
8989
2288
9
â É 3ššåšå šššìš
°Pap
a
šåšfi
2% ì? i?šš
ãäãã
§lgg
t
šñš3
xìì
šììa š
ëåãšš” :ššãìš
šššš ì:
'w .¬ '11,3
polluhnmpøllOfl-NmpOlm
*a**§§
-***
åa
ìšäå
äägååa
fisìšš
åšš ššš
lIIl
IlIl
IlIl
IlIl
IlIl
IlIl
llII
Il
šå i 'i
äšå sv; 2%:
llIl
IlIl
IlIl
IlIl
l|Il
IlIl
IlIl
šš' *E 11 šš
ßß åãšš ìššš ššššš š-â
ã-.
2% Il šš
gg22
Sågã
åfiåß
äßflä
ëäëQ
ßßßß
ßüßä
ßššgfim
ggfifi
ãåi. â i? E? ..
Osservando lo schema di tig. 5. potremo notareche. pur utilizzando un diodo raddrizzatore. (daDSS a 0812). risultando questo inserito in serie tral'uscita e I'ingresso invenente di questo secondooperazionale. la tensione di polarizzazione dell'in-grosso invertente. terrà conto della caduta di ten-sione provocata dal diodo ed automaticamentecompenserà questi 0.7 volt.
All'uscita di questi stadi raddrlzzatorl. sara dispo-nibile una tensione continua. il cui valore. parten-do da un minimo di 0 volt. sara proporzionale al-l'ampiezza delle Irequenze presenti nel brano chestiamo ascoltando. Pertanto. II suonodi un tambu-ro. lara apparire sullo schermo più barre sulle Ire-quenze balla. mentre il suono di un violino. taraapparire più barre sulle acute.
Facciamo presente che nello schema elettrico dltig. 5. 6 e 7. per non renderlo ancora più caotico.non appaiono tutti i necessari condensatori di disac-copplamento applicati sui piedini di alimentazionedl ogni operazionale. Comunque, comee riportatonella schema pratico di montaggio di tlg. 9. talicondensatori. tutti da 100.000 pF. sono presenti edandranno percio montati sullo stampato.
Per non creare equivoci nella numerazione deicomponenti. Ii abbiamo tutti siglati 062 e. comepossiamo notare. il loro numero e rilevante inquanto ne occorrono in totale ben 42.
A questo punto possiamo passare alla tig. 7. do-ve troveremo tutti gli altri stadi necessari percorn-platare il nostro analizzatore grafico.
Tutte le tensioni prelevate in uscita dai venti tillridi ingresso. (vedi i numeri da 1 a 20 presenti sulleuscita degli operazionali di tig. 5 e 6). verrannoapplicate sugli ingressi dei due multiplexer60.4067. indicati nello schema elettrico con le sl-gle ICI3 e IC14.. L'integrato lClì. un 00.4029. viene utilizzatocome oscillatore di scansione per questi due mul-tlplexer ICIG - ICH.
Sul piedino di uscita 1 di IC13 edi ICH. preleva-remo sequenzialmente i 20 segnali che ci necessi-tano. per riprodurre sullo schermo TV le 10 barrecolorate relative al canale sinistro e le 10 barrerelativa al canale destro e li applicheremo suli'in-gresso non invertente di ICZB (posto sulla destradello schema di tig. 7) che, assieme a IC27 - l025eai nand siglati lCZô-A-B-C-D. ci permetterà di con-vertire queste tensioni in segnali digitali. cioè inlivelli logici 1 e 0. per ottenere in uscita un segnalevideo RGB. Applicando ora sui piedini di ingresso2. 3e4 del modulatore PAL (vedl IC24) questi llveilllogici. otterremo le 20 barre a 3 colori. che costitui-scono il risultato tinale del nostro circuito.
Questo Integrato IC24. un TEAJOOZ. è un generatore del segnala VlDEO-COLOR-PAL quindi.senza questo. sarebbe impossibile riportare sullo
3)
schermo di una qualsiasi TV le ligure delle nostrebarre.
ll quarzo XTAL1 da IJGTZSO Miu. pari al doppiodella trequenza di CROMINANZA (4.433649 MHz).applicato in serie al condensatore variabile C75,sui piedini 13-14 di l024. ci servire per ottenere,con successive divisioni. la frequenza di RIGAOFIIZZONTALE. il segnale di ALTERNANZA PALe la trequenza di QUADRO.
Dal piedino 17 di l024 prelevaremo la trequenzadel quarzo divisa x 2.5 volte. quindi una trequenzapari a:mmm.: = 154001sche applicheremo sulla base del transistor TR1lutilizzato esclusivamente per adattare ll livello lo-gico presente sull'usclta di l624. in modo che risul-ti compatibile con i'ingresso dei C/MOS 60.4029.Indicato nello schema elettrico con la sigla IC16.
Quest'ultlmo Integrato viene utilizzato per divi-dare x 14 la Irequenza di 3.546919 MHz: pertanto.sul piedino di uscita 2. avremo disponibile unatrequanza pari a:1546919214 : 0.253351 IH:vale a dire 253.351 Hertz. Questa trequenza giun-gera poi sull'ingresso di l023 (piedino 10). un se-condo 60.4029. che utilizziamo per ricavare tuttele traquenze necessarie alla temporizzazione delsegnale video.
Sull'uscita del piedino 7. prelevaremo la tre-quenza applicata in ingresso divisa x 16:
51351210 : 15.034 HI
cioe la trequanza di RIGA ORIZZONTALE.Sul piedino 5 prelevaremo la frequenza di ln-
gresso divisa x 32:
53.351 :32 : 7.911che utilizzeremo per ll segnale di altemanzn PAL.
Intine sul piedino 2. la frequenza applicata iningresso divisa x 5.068 volte:
311.3512511" :4430":che utilizzeremo per la Irequenza di QUADROVERTICALE.
Anche se le trequenze di scansione di RIGA e diQUADRO non corrispondono esattamente allostandard europeo. visto che l'asatto valore dellatrequenza di riga orizzontale dovrebbe risultare di15.625 Hz. mentre noi abbiamo 15.834 Hz. cioè unvalore maggiore di circa 200 Hz. quella del QUA-DRO VERTICALE dovrebbe risultare di 50 HI.mentre noi abbiamo 49.99 Hz. possiamo assicurar-vi che questo non pregiudica minimamente il rego-lare tunzlonamento della TV.
lntattl. queste tolleranze vengono automatica-mente corrette dai rivelatori dl slncronisml a PLL
`slll
ul
`ll
Mflmnm-mlfiflnmmlwmmbm;tsunaummflpuoommufloonmttoudmdhddnmhtonwddquflammollugnaledalppllcaronllaW.Aleonmnonovlsblllleduapnoo'lnomaougmlewperlduoconalleadutnlnulbllsdlnto.
presenti all'interno dei televisori. tutti progettatiper "agganciare" frequenze con tolleranza benmaggiori rispetto quelle da noi utilizzate.
Per completare il segnale video composito. oltreallelrequenze sopracitata. ci occorrono gli impulsidi SINCRONISMO ORIZZONTALE. che preleve-remo sull'uscita del Nor lC19-B, quello di BURST.che preleveremo suil'uscita del Nor ICi 9-0. e quel-lo del BLANK, che preleveremo sull'uscita del NorlClQ-D.
Sul piedino di uscita 6 dell'integrato IC24. avre-mo disponibile un segnale video composito. chepotremmo collegare sull'ingresso di un qualsiasiMONITOR a colori` ma poichè a noi interessa unsegnale UHF da poter inserire sull'ingresso d'an-tenna di qualsiasi televisore. praleveremo daltrimmer R134 il segnale video e lo utilizzeremo per
SluotlInhannolancmdadetruunonlltondudoLXAøloompletodalhflolmltonnfiAl. WWWWIHIM
modulare I'oscillatore UHF che. nello schema elet-trico, e rappresentato da quel rettangolo posto inbasso a destra con la scritta MODULO UHF.
A proposito delle lunzioni che gli integrati (pre¬senti sulla parte sinistra dalla llg. 7). assolvono nelcircuito e di cui non abbiamo ancora specificatonulla` diremo che:
- ll llip-llop siglato lC18-B, viene sfruttato percommutare alternativamente sul TV i segnali cana-le sinistro - canale destro.
- II flip-flop, che porta la sigla lCtB-A. collegatoall'osciilatore ricavato con l'inverter siglato ICI7B.ci è indispensabile per definire le "dimensioni" delquadro orizzontale, cioe per determinare il puntodi inizio. sullo schermo TV. della prima barra veni-cale, ela larghezza che vogliamo far assumere alle20 barre verticnll.
31
- L'lntegrato lC2O ed i 4 translator TRZ-TR3~TR4-TRS servono per ottenere un'amplezza verticaleloqarltmica. cioe per lar si che più il segnaleaumenta d'ampiezza più si riduca la variazione inaltezza delle barre.
in pratica i 4 transistorcostituiscono il generato~radi rampa agradini. mentre l'operazionale lC20èutilizzato come amplificatore-separatore. per non"caricare" i'uscita del generatore stesso.
- l due comparatori ICZ1 e |022 ci servono perdelinire sullo schermo la posizione d'inizio e dimassima ampiezza venicaie delle 20 barre a colori.
- Il NOR-Esciusivo lC19-A el'inverterIC17-D llutilizziamo per sincronizzare la rampa con la scan-sione verticale del video.
Facciamo presente. che il reticolo verticale so-vrapposto alle barre e tarato in dB (decibel) e cheId ogni tacca corrispondono circa 2 dB. quindidisponendo el un totale di 15 righe orizzontali.l'ultima riga in alto corrisponderà ad un segnale di30 dB.
Precisiamo chela variazione espressa in dB. co-inciderà ad un aumento di tensione e di potenzapari a:
TENSIONE POTENZA
Oon l'aìuto di questa tabella. potremo subito va-lutare la potenza in watt di tutte le irequenze acu-stiche della gamma audio.
Ad esempio. se abbiamo un amplificatore da 50watt ed abbiamo tarato I'ampiezza verticale in m0-do che alla massima potenza la barra verticale rag-giunga i 30 dB. dividendo per 1.000. etterremo lapotenza erogata a 0 dB, vale a dire:50 i 1m : 0,05 WIN
Se. ascoltando un brano noteremo che:la barra del 63 Hz raggiunge i 10 dila barra del 250 Hz raggiunge i 20 dlla barra del 1.000 Hz raggiunga l 20 dBla barra del LM Hz raggiunge l 20 dlla barra del 16.000 Hz raggiunge! 12 di
32
potremo atlerrnare che questa lrequenze vengonodiffuse dall'altopariante con la seguente potenza:
. 0,05 l 10 : 0,5 Wa"0,05 l 100 : 5 Watt
,05 a 630.0 : 31,54 WI".05 l 251,1:1255 WI"
. 0,05 l 15,! : 0,19 Wall
Tutti i rimanenti inverter presenti nel circuito`servono solo per invertire dei livelli logici ed adat-tare cosi i segnali digitali. al tipo di porta logica acui devono essere applicati.
Per alimentare questo circuito ci occorre unatensione duale di 12 + 12 volt. 100 mA e, a talescopo. noi abbiamo utilizzato l'allmentatore sigla-to LX.408. descritto sul n.71 di Nuova Elettronica.
Prima di passare alla descrizione dello schemapratico. indichiamo quali lunzioni esplicano tutti Itrimmer riportati nei vari punti dello schema elet-trico.
= Serve per dosare il livello del segnale dlBF sull'ingresso canale sinistro.
= Serve per dosare il livello del segnale diBF sull'lngresso canale destro.
_ = AMPlEzzA vERTicALE - serve perda-linire il massimo livello cui desideriamo largiungere le barre in verticale
_ = cENTaATuaA vEFlTcLE - serve percentrare l'immagine sullo schermo TV in po-sizione verticale cioe. in pratica. sposta tuttal'imrnagine ottenuta. In modo che risulti po~sizionata esattamente al centro dello scher-mo in senso verticale
_ = cENTRATUaA oRlzzoNTALE - serveper centrare l'immagine sullo schermo TV inposizione orizzontale cioè. in pratica. spostatutta l'immagine ottenuta in modo che risultiposizionata esattamente al centro delloschermo in senso orizzontale.
= LARGHEZZA ORIZZONTALE - Serveper restringere o allargare orizzontalmentel'immaglne sullo schermo TVÀ
= TEMPO Dl RILASCIO - Serve per accel-Ierare o rallentare il movimento di salita eritorno delle barre verticali.
_ = BARRA COLORI - Allarga o restringe.proporzionalmente. la divisione dei tre coloripresenti su ogni barra.
= compensatore da tarare lino a quandosulla TV tutte le barre non appaiono colora-te.Non tarando in modo corretto questocompansatore. tutte le barre appariranno inbianco e nero.
.eonoEEøo89.¦
...SE
-:8.5
.25
.2.0..eta
..oItaco-
...n..3321.5
sanga
:ne
io
etnica-_0:8..
__ ...Bu-:ì
:_2-55:
_›.SEE-u
=25:2:
2.3le:
._:u:_
:__-:E3352
..ER-..un2-1
:iE. .teu
2...-.›
:e:...o
22.228.u
o 05.2.2325:0
21-.2
3°...
ì232:...
2925:cabrio-._
oso05.00
E.:u
eEaìâE
oouac.un
..neue_...
Pr..._-...È
qu2
2a
:20-:
.v.vanno
uz::2.02
.52
25
:...2-
Eø
==
oëøl=
£ë2:8
..._-32aoE-.anø
_o..2.0
de
i(2
5:5
e_cuoi__
22
....:-e=øu
2.02.n
2.-:.
:o:.m
..Sunia-.E:2
_ E...:eo
..oo-_.inca
E.22.¦...-
2==šu__ even...
.lc-.asia
8.:...:o:
.2.2.-cãìqN
š-o..._ ..Ecco-.Eau
.seiEåce.:
:Buon22.58-
2.250..i
S2.25
.Sui-:a
2.2253".n
8:32.._.
-Eøu..eu
sei..:un
...su...eu
_ = RETICOLO - Serve per tar apparire sututto lo schermo TV Il reticolo di divisione indB (Interruttore aperto). oppure sulle solebarre verticali (interruttore chiuso).
_ = REVERSE - Serve per invertire sulloscheme i colori delle barre. Con i'lnterruto-re chiuso. partendo dal basso verso I'altoavremo BLU-GIALLO-ROSSO; aprendo l'in-terruttore le barre appariranno nei coloriGIALLO - BLU - ROSSO.
_ - Serve per dosare II segnale di modula-zione video. Se il segnale è in eccesso sulloscheme otterremo un'immagine seturata edistorta con le barre ripiegate verso destra overso sinistra. mentrese II livello del segnalee scarso. l'immagine apparirà siumata e pri-va di contorni.
REALIZZAZIONE PRATICAPer potercollocare tutti gli Integrati necessari alla
realizzazione di questo analizzatore grafico. ab-biamo disegnato II circuito stampato siglatoLX.660. che risulta lungo cm. 84 e largo cm. 23. Epercio un "maxiclrcuito". owiamente a lori metal-.Ilzzati. per rendere più agevole il montaggio deiv componenti. '
La prima nostra preoccupazione, quando ab-biamo preperato questo stem pato, e stata quella disapere se il lettore avrebbe incontrato qualche dll›licoltå nella realizzazione e per saperlo abbiamoadottato una soluzione gia sperimentata positive~mente in altre analoghe occasioni.
Abbiamo richiesto a due Istituti di AvviamentoProtessionale cinque allievi di età compresatra I 15ed i 18 anni ed a costoro abbiamo consegnato Ilcircuito stampato, il relativo schema elettrico epratico e tutti i componenti necessari.
Seguendo i nostri consigii. tutti sono riusciti aportare e termine il proprio montaggio e. congrande soddislazione. anche a vederlo Iunzìonare.
Prima di Iniziare il montaggio abbiamo. comesempre. precisato quanto segue:
1 controllare. con una lente d'ingrandimento. lopiste del circuito stampato. Anche se non dovreb-be mai verificarsi. può accadere che. in lese diincisione. una pista si tranci per un granello dipolvereoperuncapelloinvolontariamentecadutosulla matrice.2 Utilizzare stagno di ottima qualita . Se lo stagnocontiene un disossidante catramoso. non utilizzar-lo. perchè lascerà sempre sullo stampato un depo-sito nero e vlschloso. quasi sempre conduttore.che ettenuera o addirittura cortocircultera I segnalisulle diverse piste.
34
3 Eseguire saldature perlette e. dicendo questo.vorremmo nuovamente ricordare a quanti saldanoin modo errato che. per ottenere una buona sta-gnatura. occorre appoggiare la punta del saldatoresul punto da saldare. tenendolo in verticale, e polawicinare alla punta il lilo di stagno. Dopo avernesciolto una sola goccia. bisognerà tenere ancora inposizione il saldatore, tino a quando non si vedrà lostagno spandersi unilorrnemente sul bollino e sva-nire il lumo provocato dal disossidante.4 Prima di stagnare un terminale di una resistenza.se questo risulta ossidato. pulirio con carta smerl-glio line. per evitare una saldatura “lredda”.5 Controllare sempre il valore di ogni componenteprima di inserirlo sul circuito stampato e. se sussi-stono dubbi. controllarlo sempre con un ohmme-tro o un capaclmetro; lo stesso dicasi perla polari-tà del dlodl e dei condensatori elettrolitici.e Non utilizzare mai transistor o integrati venduti aprezzo dì “stock”. Per risparmiare poche migliaiadì lire. oltre a perdere tempo per scoprire. dopo,"perchè ll circuito non funziona". sarete semprecostretti ad acquistare un nuovo integrato. oppureed Inviarci per la riparazione il vostro circuito.quindi. quel risparmio che pensavate di ottenere, sltramutera in una doppia spesa.
Ricordatevi. che nessuno e nato per "regalare" eche pertanto, quando. ad esempio in un autogrill oall'angoio della piazze. qualcuno vorra vendervl unorologio di marca a meta prezzo. anche se questoha due bel le lancette e sopra al quad rante c'e scrit-to ROLEX. potrete essere certi che è un “lalso”.
Chi ingenuemente lo acquisterà. convinto diaver concluso un buon altare. quando. dopo pochimesi. questo non lunzionera più. portandolo dal-I'oretice per la riparazione. avra da quest'ultimol'amara conierme che I'orologlo non dispone dinessun rubino. che la cassa non e d'oro e nondispone dl nessuna delle caratteristiche posseduteda un vero ROLEX; quindi. risultando irriparabile.dovrete acquisterne un altro.
Per gli integrati. solo inserendoli nel circuito sene possono scoprire i diletti e. se il pregano nonfunziona subito. si sentenzia che "la colpa e dellarivista". mai dell'integrato.
Se soltanto si pensasse che di ogni progetto. nevengono montati. nel nostro laboratorio. un mini-mo di dieci prototipi. le frase “E lL PROGETTOCHE NON FUNZIONA" Ia dovremo subito scarta-re. II mancato funzionamento di un nostro circuitopuò dipendere solo da un errore di montaggio o daun componente che non possiede le caratteristi-che richieste o da un errore tipogralico.
Se cosi non tosse. non avremmo certamente isti-tuito un aervlflo di assistenza e riparazione. perchesarebbe assurdo cercare di riparare centinaia ecentinaia di montaggi se non avessimo la matema-
CDIIII!
á» :uè-BIIZII BCJZI ECZO!
Flg. l Connmlonl degli lnlogml ullllmll In quam progetto vm. dall'nlto o dl tum ltrauma' vllfl lnvocc dal lama. cloò dal Mo In cul l tonnlnlll Iuorimono dal corpo.
.30
.20
.30
..S-28.2.8
o:_ ...__-._
.2508.__cu
.._-_...--_.¬¦
ø2.22
2.8...i
2......__-_. .5.8
...i235....
2.55-.2555...
:Eu..2.5.
-2.2....
...2....E
:i.._
2.8:...8.3.2...
2:2
2-
.__.a_uo_=:S
ic-...ì
u.Eur-__.
0.3:..E
53..:o:
in.un
.øou=¦u
..cinzia-___...o
iìšu
8......-Eozum
a.ai
..MWWWHWWWW.N _ ma:un
.ma..un
unaun.
ìè
lìâiå
.ìâlå
ìl.šsfå
is
.WWW..2%
â-
fill-
f.
tica certezza che questi pol potranno veramentefunzionare.
Detto questo. potremo prendere Il nostro clrcul-to stampato siglato LX.660 ed iniziare il montaggioInserendo tutti gli zoccoli. Dopo averli saldati. con-trolleremo, con una lente d'ingrandimenio. cheuna goccia di stagno in eccesso non abbia corto-circuitato fra loro due bollini adiacenti e verifiche-remo anche di aver eseguito tutte le saldature ne-cesearie.
Troviamo spesso nelle riparazioni che ci giun-gono. qualche piedino non saldato. una pista incorto per una goccia di stagno. malgrado il lettoreci assicuri di aver controllato il tutto accuratamen-te più volte.
Effettuato questo controllo. proseguiremo inse-rendo tutte le resistenze: consigliamo di controlla-recon un ohmmetro tutte quelle che applicheremosul filtri passa-banda (vedi in tig. 5-6). perchè senel canale sinistro per R7<R6 collegate due resi-stenze con tolleranza eccessiva rispetto alle resi›stenze H52-R51 applicate sul canale destro. potraverificarsi che un filtro rlsulti tarato sui 32 Hz. men-tri.` quello dell'opposto canale su 20 Hz o 35 Hz.
Diciamo questo perche. se in fase di controllo ldue ingressi verranno collegati in parallelo. con-statando che le due barra. a 32 Hz. non raggiungo-no la stessa identica altezza. subito vi "scaglierete"contro di noi. affermando che il progetto e Imper-fetto.
In pratica. avere un canale con centre bandatarata sui 32 Hz ed il canale opposto tarato inveceaui 28 o 35 Hz, non comporta alcun inconveniente.perchè entrambi lavoreranno entro la banda pas›sante del filtro. quindi visivamente. ed anche acu-sticamente. risulterà estremamente difficile valuta-re questa irrisoria ditferenza di qualche Hertz.
Solo per i più "pignoli". che cercano sempre laperfezione assoluta in ogni loro realizzazione e chequindi subito controlleranno con un generatore diBF se. applicando 3263425250 ecc Hz. su en-trambi i canali. le due barre risultino equivalenti.diremo che una leggera differenza esisterà semprefra i due canali perchè. a causa delle tolleranzedelle resistenze. puo verificarsi che i filtri del cana-le sinistro risultino tarati su 30-65-124-255 Hz.mentrequelli del canaledestrosu 32-62-127-50 Hz.
Saranno comunque tolleranze sempre moltocontenute e le lievi differenze esistenti fra i duecanali. potranno essere rivelate solo con una prove"strumentale" del circuito. non certo all'uso pratico.
A conoscenza di questo particolare, potremoconsigliare anche di inserire le resistenze per i filtrisenza controllarne esattamente il valore ohmmicoin quanto il risultato finale non varierâlV
Dopo le resistenze. potremo montare tutti I diodi.controllando che la fascia che contorna il corpo
30
risulti rivolta come vedesl nello schema pratico difig. 9.
Se sull'involucro troviamo più fascie colorate enon siamo certi delle polarità del diodo. prima diInserirli potremo facilmente individuare. con unohmmetrc. quale è il catodo e l'anodoA
Un solo diodo applicato in senso opposto. nonpermettere al circuito di funzionare. per cui ì pochiminuti spesi per questa verifica. ci risparmierannoIn seguito ore di ricerca e di controlli.
Di seguito applicheremo tutti i trimmer. pol ltransistor plastici. collocando la parte piatta delcorpo come vedesi nello schema pratico. ed infineli transistor TFii . rivolgendo la tacca metallica pre-sente sul corpo In direzione della resistenza R95.
Poichè siamo in zona. potremo inserire il com-pensatore 075. l'irnpedenza JAFI ed Il quarzo si›glato XTALi.
Terminata questa operazione. inizieremo ad ap~plicare tutti i condensatori al poliestere in miniatu-ra. ricordandoci che le capacità impresse sull'invo-lucro possono essere espresse in microfarad o innanofarad.
Se esiste un “punta'l prima del numero, adesempio .1 - .002 - .15. significa che le capacitasono In microfarnd. quindi leggeremo 0.1 mF, paria 100.000 pF - 0,082 mF, pari a 62.000 pF - 0.15 mF.pari a 150.000 pF.
Se esiste invece una “n”. i valori sono espressi innanofarad (moltiplicando x 1.000si otterrà llvaiorein pioofarad). quindi nn- tion-10a equivalgonoa02.000 pr - 150.000 pF - 10.000 pr.
Se Ia “n” è inserita tra due numeri. equivale aduna virgola e pertanto 2n2 - In! - M1 vanno Iettlcome 2.2 - 1,2 - 4.1 nanafarad. che corrispondono.come gia accennato. a 2.200pF-1200pF-4100pF.
Per gli elettrolitici. quando non e presente il se-gno + in corrispondenza del terminale positivo,sarà bene ricordarsi che questo terminale risultasempre più lungo dei negativoÀ
Perterminare il circuito. dovremo solo collocarela LINEA DI RITARDO posta vicino all'integratcl024. indicata nello schema elettrico con la siglaLRi. Peril MODULO UHF. oltre ai tre terminali chefuoriescono dal contenitore, in questa scatola so-no presenti altri due tanninali collegati direttamen-te all'involucro metallico che dovremo saldare sot-to al circuito stampato per collegare a massa que-sto schermo metallico.
Giunti a questo punto. prenderemo tutti gli inte-grati stringendone leggermente i terminali . perpoterll più facilmente innestare nel rispettivi zoc-coli. Inserendoli dovremo ricordarci di collocare latacca di riferimento. o Il piccolo punto presentesull'involucro. come visibile sullo schema pratico.
Sara bene controllare sempre che tutti i piedini
degli integrati s'ìnnestlno nel vano dello zoccolo.perchè capita sovente. senza accorgarsena. cheun piedino si ripieghi a L oppure fuoriaaca dallozoccolo. invece di inserirsi correttamente.
A questo punto non ci rimarrà che montare lisolo alimentatore sopra al circuito stampatoLXAOS, pubblicato sul n. 71 di Nuova Elettronica.Vi ricordiamo che dei due integrati presenti. iluaJOtì serve per stabilizzare la tensione positiva.mentre il ua.7912 per la tensione negativa.
Collegando I'uscita di questo alimentatore allatre prese ingresso del circuito stampato. dovremosolo fare attenzione a non invertire il positivo con ilnegativo e a verificare che fama risulti collegatasul tennínaie centrale.
Sui due terminali posti in prossimità di LRt. col-legheremo poi I due tili per i'interruttore REVERSE82. mentre su quelli posti in prossimità dei duetrimmer R102 e R1 töandrenno saldati i due fili perl'interruttore del RETICOLO St.
Se non disponete di un mobile metallico nel qua-le inserire il circuito. potrete acquistare il mobile ditipo professionale da noi predisposto in serieSLIM.
Nell'inserirequestocircuitoequeiiodell'alimen-tatore. come visibile nelle foto. occorrerà ricordar-si dl tenerli distanziati dalla base per evitare che lepiste sottostanti o qualche terminale un pò piùlungo del richiesto . vadano in cortocircuito con ilmetallo del mobile.
Posteriormente` applicheremo le due prese BFper I'ingresso del segnale dei due canali quindi.utilizzando un corto spezzone di cavetto scheme-to. coilegheremo queste prese sui terminali d'in-gresso del circuito stampato.
Sempre sul retro dei mobile. innesteremo poi lapresa TV, che andra collegata all'uscita dei "_modu-Io UHF" con una spezzone di cavo coassiale di AF.alla cui estremità avremo collegato lo spinotto ma-schio da innestare sulla boccola di uscita di questomodulo.
li segnale di BF da inviare a questo analizzatore.potra essere prelevato sia dall'uscita del preamp|i~ficatore che dalla presa cuffia. oppure dalla presaaltoparlante e Io stesso dicasi se prelevaremo ilsegnale da una radio. da un sintonizzatore FM o daun mangianastri.
l due trimmer R2 ed R47. presenti sull'ingreseo.ci permetteranno dl dosare correttamente il livellosegnale di ingresso. qualunque sia la sua ampiezza.
Non bisognerà preoccuparsi se il segnale. per unerrore. entrerà con un livello esageratamente ele-vato perche` sui due ingressi del circuito dei filtri.abbiamo previsto una protezione elettronica. co-stituita dai duediodi DS1-DSZe DSM-0815. ondeevitare di mettere tuori uso i due amplificatori ope-razionali ICt-A e lCt-B.
OOLLAUDO E TARATURAUna volta terminato il montaggio. ll circuito tun-
zlonera immediatamente in quanto le tarature daetfattuare serviranno principalmente per centrarel'immagine nel televisore e per stabilire l'eaattaspaziatura e la dimensione delle colonne colorate,
Le operazioni da eseguire saranno perciò moltosemplici e la sola "strumentazione" necessaria aa-ra un cacciavite e un televisore a colori.
Per prima cosa ruotaremo tutti i trimmera metacorsa in modo da "preregolare" ii circuito; pol col-legheremo l'uscita dell'analizzatore audio alla pre-sa d'antenna del televisore regolando quest'ultlmosul canale 36 della gamma UHF fino a centrare lafrequenza del nostro minitrasmettitore. Per chiavesse un televisore a colori sprowisto della scalagraduata della sintonia o nel quale non siano spevciticati. su tale scala. i numeri dei canali. una voltaacceso il televisoree fornito tensione al clrcuito,sldovrà semplicemente ricercare il canale di tra-smissione fino ad ottenere. sullo schema, le scalagraduata dei dB che appare agendo su S1.
Applicando un qualsiasi segnale di BF all'in-gresso del circuito. prelevato ad esempio dall'usci-ta di un preamplificatore o da un mangianaatrl.potremo ora passare alle operazioni di taraturavere e proprie.
Come potremo notare osservando il circuitostampato. sulla serigratia riportata accanto ad ognitrimmer. oltre alla normale numerazione di tallcomponenti, troveremo anche la funzione chequesto svolge, per cui sara molto semplice, anchea lavoro ultimato. ritoccarne la posizione per mi-gliorare o modificare la taratura.
il primo trimmer da tarare e quello del "LIVELLODI MODULAZIONE" (R138) il quale stabilisce ilcorretto valore del segnale di modulazione dellaponente video. per ottenere un'immagine ben oe-finlta ed indistorta sullo schermo della TV.
Se il segnale di modulazione è troppo debole. sulvideo appariranno delle barre molto scure e l'lrn~magine risulterà "tremolanta" e indefinita. mentrese tale trimmer è regolato per una modulazione ineccesso` l'ìmmagine presenterà delle distorsioni.
in pratica questo è l'unico trimmer la cui taraturapotrebbe influenzare negativamente il risultato il-nale dei nostro lavoro ma ia sua esatta regolazioneè comunque immediata e molto sempliceÀ
Terminata questa prima operazione. passeremosubito alla taratura del compensatore C75v postoaccanto al quarzo (XTAL). fino ad ottenere sulloschermo della TV un'immagina a colori. Se talecompensatore non risulta tarato in modo idoneo.sullo schermo appariranno solo delle barre inbianco e nero.
Dopo queste due prima taratura. sul video avre-mo glà un'lmrnagina a colori. ma le barre potrannoessere tutte accese. oppure appena accennata. in
quanto i due trimmer della sensibilità di Ingresso(vedi R2 ad R47). non sono ancora stati regolati.
A seconda dell'ampiezza del segnale di BF ap-plioato sugli ingressi di questo analizzatore` do~vremo regolare questi due trimmer per otteneredelle barre la cui ampiezza sia leggermente interio-re al massimo livello, corrispondente all'ultimatacca della scala graduata.
ln questa prima lese. non bisognerà preoccu-parsi eccessivamente deli'esatta taratura dellasensibilità di ingresso in quanto. al termine. po-tremo riaggiustarla con maggior precisione. sulAl'immagine delinitiva ottenuta.
A questo punto, sulla nostra TV avremo giàun'immagine composta da 20 barre verticall colo-rate, su di uno slondo scuro, complete di 15 divi-sioni verticali. contraddistinte da dei trattini bian-chi che rappresentano la suddivisione in dB dellescala.
Owiamente. non avendo ancora regolato alcuntrimmer. tale immagine potrà risultare non centra-ta sullo scheme. nè in senso orizzontale ne inquello verticale
A questo punto. ruoteremo il trimmer R10: dellaLARGHEZZA ORIZZONTALE in senso orario, ecosi lacendo vedremo aumentare l'ampielza oriz-zontale di tutta l'immagine mentre. ruotandolo insenso antiorario. l'immagine si restringerà. Questotrlmmer andrà quindi regolato in modo da ottenereun'immagine tutta contenuta all'interno delloschermo della vostra TV.
Una volta “dimensionata” correttamente l'im-maglne, potremo regolare il trimmer MM dellaCENTRATURA ORIZZONTALE` per portare tuttaI'immaglne esattamente al centro del vldeo. Ruo~tando ìlcursore di R10! in senso orario. I'immagineai sposterà verso destra, mentre ruotandolo in sen-so antiorario. si sposterà verso sinistra.
Ruoteremo ora il trimmer RHO della CENTRA-TURA VERTICALE. per posizionare, anche verti~calmente. I'immagine al centro del video. Ruotan-do il cursore di RHO in senso orario, le barre sisposteranno verso il basso. mentre viceversa. ruo-tandole in senso antiorario. si sposteranno versol'alto.
ll trimmer Rtß della AMPIEZZA VERTICALE.serve Invece per regolare l'ampiezza delle barre, inrelaziona alla scala graduata in dB riportata sulloschermo. Pertarerequesto trimmer dovremo sem-plicemente controllare sullo schermo che l'iniziodelle barre coincida con il primo gradino in bassodella scala graduata. Agendo in senso orario. ilpunto di inizio delle barre si sposterà verso l'allo e.viceversa in senso antiorario. si sposterà verso Ilbasso.
A questo punto, agendo sul trimmer R13¦l dellaBARRA COLORE, potremo modllicare le ampiez-ze delle aree colorate. all'intarno delle varie barre.
40
Tale regolazione è soggettiva in quanto serve sol-tanto a modificare il punto d'inizio della suddivi-sione delle tre aree di cui sono composte tutte lebarre.
Rimane da regolare i| trimmer R11a dei TEMPODI RILASCIO. con il quale si moditica la "velocitadi variazione" dell'ampiezza delle barre: anche inquesto caso la taratura e soggettiva e perciò po-tremo stabilire. a nostro piacimento, la taraturadefinitiva dl questo trimmer.
Terminate tutte le operazioni descritte. potremoregolare con maggior precisione. i due trimmerdella sensibilità di ingresso (vedi R2 ed R41). coniquali ora` utilizzando lo stesso segnale per en-trambi i canali. dovremo regolare I'ampiezza dellebarre atlinchè, con il massimo livello di segnalepossibile, si ottenga l'accensione di tutta la barracolorata.
Came vi abbiamo gia anticipato nella descrizio-ne dello schema elettrico, esisteranno sicuramen-te delle piccole dillerenze ira un canale e I'altro,valea dire che. purapplicandc lo stesso segnale adentrambi i canali dell'analizzatore. I'ampiezza dialcune barre del canale sinistro potra essere leg-germente ditlerente da quella corrispondente nelcanale destro. Questa dillerenza, come gia vl ab-biamo accennato. e dovuta solamente alle tolle-ranze dei componenti presenti negli stadi dei liltridl ingresso.
COSTO DI REALIZZAZIONETutto il materiale necessario per la realizzazione
dl questo progetto. cioe circuito stampato a lorimetallizzati LX.660. integrati completi di zoccoli,trimmer, transistor, diodi, linea di ritardo LRl, llmodulo UHF. translstor, ecc. cioe tutto quanto ap-pare a pag. 36-37 (quindi escluso mobile e stadioalimentatore) L. 237.000
Tutto lo stadio alimentatore duale LXAOBcompleto trasformatore n. 13 pubbllcato suln.71.. ..L18300
Un mobile LX.660 serie Avion come visibile nellatoto di testa a pag. 21 e a pag. 31 completo dipannello forato eserigralato L. 38.000
ll solo circuito stampato LX.660 ............ L. 40.000Nel prezzo non sono incluse le spese postali di
spedizione a domicilio.
DIVENTA UN TECNICO INELETTRONICA FONDAMENTALE E TCI FCOMUNICAZIONI.
mumbmxvanpuampumu-nu-u-lMW. swap-I wmmømmwmømn'm aqua.
*ma pf -Mxm i .a a m ma»"mm-..mmnuum
MIHI-IùnåhMamnmpammcmmm.
mmm Doni»mammfliwumlmtur-h-nflfiipimdw.wumßwudm.nuwwmimowpmrm*hnucuudimumuu.hùH-unannmhmwkkmu. mmmlmnüwnmhymhmwu. Somma-.iamammenmumwmUnmlnmhuvflflòmflhlümuinH-lnuimmhmufl'mena-um Seummmmnammhm-umimiivmiaiwuhmpuiwmnmwwmulmlmmcawduimanmmflmmlmmhmnmmwlmi-pnrum-.innumaWn-nmuommmln-mmam
mmmm-nm
“mummia-MWmmm. *maalam
Oltre II Corso Eloflroniu Fondamenulc l Tllmnunkzxíofli(un Small hdioeletuz puoi neglien altre 1° cppofluniu pmieniomli:
"Im .fw-IW :Yfifllfdfflil I 1'”nun-_m .WI- im. .mi:mu-u .mmm unum-'nm. Human-n*M Win* mm.,WW mm :sam-imma”.W m ›WM|-w .Munn-mul- oiumm r-mhwum.fm-...m .mq-mmm «M :nq-.m:Mu-üw ..q-mu' I.. :war-mu. “Qual-luna
"mu-.unum num I ` ..n-u. ›<eu|›«›v|u
fi-flmflmfiwhmulm.
mmimim=mucwnrnumwmmumøßammn.mmmm
' mmmmmmmuumunm
bmw-idmwmnm mama-ma“mmm-num;m.“mura-.Ima-mim-nwaml“Minimumwmmduwmmam
umfi.bm¢i¢bm.mwum|ouvmmumum.
nsScuola RadiocloflravI-- f m†-aa;n.-_-r_'~l mi ›I mmm-*lnìùl l
I una ...km _._._._._,_~_.._H.|.__..H~In: ..dda-'li
`unumun-mllulwl]'Im-:Jåß!L________
L'lneiallazlone di questo semplice circuito viconsentirà non soltanto di modemizzare l'impian-to elettrico della vostra casa, ma anche di suscitarela curiosità di amici e conoscenti vostri ospitiquando noteranno che. per accendere le luci dicasa. non pigerete i consueti interruttori. ma elio-rerete semplicemente una piccola placca metallica.
Ancor più grande sara le loro sorpresa nel con-statare che. tenendo il dito appoggiato su taleplaccnetta. la luce aumenterà e diminuirà di inten-sità.
Infatti. nei progettare questo sensore. abbiamopensato di completano con un variatore automati-co di luminosità. cioè con un comando che vi con-sentirà dl variare la luminosità de un massimo adun minimo, senza utilizzare, come nei comuni vari-light. un potenziometro. bensi utilizzando lo stessoed unico sensore di accensione e di spegnimento.
ln pratica. sfiorando questa placchetta di metal-lo` se la lampada sara spenta automaticamente si
re. la lampade si spegnerà e. ogni qualvolta i'ac-canderete. questa lo tera sempre con le stessa pre-cedente intensltà luminosa. A questo punto, seanzichè sliorare il sensore con li dito lo terrateappoggiato sulla placca. noterete che i'intensitàluminosa non diminuirà ulteriormente. ma inverti-rà la sua condizione. cioè da luce dimezzata elporterà lentamente al suo massimo livellot
Se vorrete invece ridurre la luminosità. dovretetenere li dito ancore appoggiato sulla placcnettametallica e. come consiaterete. le lampada giuntaalle massima luminosità. proseguendo automati-camente nel suo ciclo. lentamente si ettenuerà e.raggiunto il suo minimol ritornerà ed aumentare dilivello. e cosi ell'inlinltoA
Un etietto veramente insolito e stupendo chepotrete ottenere realizzando questo progetto cheutilizza un solo integrato. l'S.576/B. costruito dallaSiemens.
Installare un simile "sensore" nei proprio im-
I' MAGICO sensoreaccendera; se poi lascerete appoggiato il dito perqualche secondo in più. constatarete che le lucevariera d'intensità. e, togliendo il dito dalla plac-chetta. sarà il livello de voi prescelto ad esserememorizzato. Vale a dire che. sfiorando nuove-mente la piecehetta. la lampada si spegnerà. e rl-silorandole. questa si riaccendere sul livello di in-tensità precedentemente memorizzato
Per modilicere il livello luminoso. oper cancella-re la precedente memorizzazione. sarà suttlcientetenere appoggiato il dito per un tempo maggiore e.cosi facendo, la lampada varierà la sue luminositàin senso opposto a quello precedentemente me-morlzzato.
Riteniamo che l'esempio che ore vl proporremopossa lacilmente dissipare qualsiasi dubbio.
Supponete di voler accendere una lampada edintensità dimezzata. Come constatarete. appenaappoggerete il dito sulla placcnetta metallica. ot-terrete l'immediata accensione della lampada allemassima luminosità.
A questo punto. se lascerete ancora il dito ap-poggiato sulla placchetta. le luce lentamente siattenuare.
Raggiunto il livello luminoso desiderato, saràsutliciente togliere ll dito dalla placchette per otte-nere la sua completa memorizzazione.
Sfiorando nuovamente la placchetta del senso-
42
godeeruoreperhlclleeeermentelngm“Lemoreettleredlelnlmclaervlràperevemeli estensioni. mentre quelle di deetreper collegare lampada e tensione di rete. SlMmdmml'impedenu entldietmbe
am.
piccoli teatri, per simulare sul palcoscenico ll so-praggiungere della sera. oppure per ottenere degliefletti di dissolvenza con riflettori a diversi colori.
Negli alberghi o condomini dove di notte vengo-no tenute perennemente accese le lampade delcorridoi delle scale, potrete memorizzare un livellodi luce` ottenendo cosi un elevato risparmio dlenergia. AI momento richiesto potrete sempre econ estrema semplicità, riportare Il livello di lucealla sua massima intensità.
Lo potrete inline utilizzare nelle vostre teste pri-vate. come valido alleato per creare un'atmosteradi intimità sempre apprezzata dall'elemenlo tem-minlle.
Potremmo qui proseguire con tante altre suelnnumerevoli applicazioni: ad esempio, per atte-nuare ed accendere le luci gradualmente, quandoproiettorete le vostre pellicole a passo ridono, op-pure per ottenere delle insegne pubblicitarie a piùcolori di cui una gradualmente si spegneY mentre
Con I'lnlegralo 5.516/5 potrete realizzare Il più semplice e perlettoaenaore per lampade a lllamenlo. Stlorando con un dito una piccolaplacca metallica, potrete automaticamente accendere o spegnerequalalaal lampada ed anche ridurne ed aumentarne l'lntenalta luml-noaa Disponendo l'lntegralo dl una memoria, noterete, rlaccenden-do la lampada, che questa avra aempre la stessa lntenalla luminosaprecedentemente prescelta.
pianto elettrico. sarà utilissimo, perche. oltre adaccendere. spegnere e modificare I'intensilà lumi-nosa di qualsiasi lampada ad incandescenza. condue soli tilil potrete accendere la stessa lampadada 3 - 5 - 10 posti diversi.
Poter variare a vostro piacimento l'intenslta lu›mlnosa oi una lampada potrà risultare utilissimoquando guarderete la TV` per illuminare la stanzacon una debole luce soffusaÀ
Se avete un liglio che non vuole dormire al buio.installando questo sensore avrete la possibilita diregolare al giusto livello la lampada della sua stan-za e riavere per tutti i giorni successivi la stessaintensità luminosa` perche. come gia precisato.questa rimarrà sempre memorizzate; lo stesso di-casi se avete qualche inlermo da vegliare di notte4
Questo stesso impianto potra servire anche per
una seconda gradualmente si accende. e. raggiun-to il livello minimo a massimo. vederle automati-camente invertire la propria luminosità.
Come avrete intuito le possibilità di impiego dlquesto accessorio sono molteplici, sempre che siutilizzino lampade a filamento e non lluorescentl.
SCHEMA ELETTRICOCome vedasi in tig. 1, per realizzare questo "ma-
gica" sensore vi occorrerà solo l'integrato 5.576/8.un triac da 400 volt 4-5 amper e pochi componenllpassivi.
In pratica, all'interno di questo integrato sonocontenuti gli stadi necessari per ottenere tutte lefunzioni precedentemente descritte. cioè: uno sta-dlo dl commutazione collegato al sensore. una
43
:fé-'n
HH
''1
3:1
UtFigi Scmohflfleoddmwneunmmofla. Loduculcihpmhnthilirl, Indiani. con A-B, umno por calici-ml lil. nicmlcnl riporti' In05.5.6.
ELENCO GOMPONENTI LX.-
R4: 410.000 ohm 1/4 WI!!R5_- 120.000 ohm 1/2 vllflR0 : 500 ohm 1/2 'unR1 : 1.5 mmohm 1/4 'InC1 : 47.000 pF poilnhfl62 : 41 mF dom. 16 voli
q. 2 Dlugno l grlndom nllurliodol circuito lumpaio 'Igino n.605. dluilllmn per Il montaggio di guaiomagico ed lui-mania mio".
63 : 470 pF I dløcoC4 :1111000 pF polini-ro 250V.CS : 150.000 DF pollon." 250V.031 : dlodo 1N4001082 : diodo 1N4007011 : :onor 15 voli 1/2 wlii.IAF1 : lmpudona lniidlmlbo pl' TubeTam = True «po tamIC1 : 3.5160
I ..n-..-
^' E s smA:mm
.m'-
Flg. :i Connmlønl dol ma: a doll'ln-iuqnio 8.516/8. Ounto lnlogfaio, loli-iørunu chile vonlonl tipo A-C-D, dl:-pono. come :Maglio mil'lniooio, dlmomofil.
W'.` R
memoria per il livello di luminosità. uno stadio peril riierimento di lase. un generatore di impulsi pereccitare il triac. un contatore avanti-indietro peraumentare o ridurre la luminosità.
Non possiamo riportare. come nostra consuetu-dine. lo schema a blocchi degli stadi presenti intale Integrato. poiche la Casa Cosiruttrlce non ioripone in nessun catalogo; quindi tutto cio chesappiamo sono le poche notizie. condensato. checi sono state iornite assieme agli integrati.
Quello che possiamo dirvi e che. di questo inte-grato. ne vengono costruite quattro diverse ver-sioni così siglate 8.576A - 85768 - 8.5766 -5.5760. Tra queste. abbiamo scelto I'S.5763. per-che ii piú perfezionato e completo di memoria.
Gli altri modelli essendo sprowisti di memoria,servono solo per impianti in cui si richieda la sem-plice funzione di accendere o spegnere una lam-pada oppure di attenuare o aumentare la luminosità.
Ritornando al nostro schema elettrico. notereteche la placchetta metallica dei sensore risulta coi-Iegata. tramite due resistenze Fil-R2 da 4.7 mega-ohm, ei piedino 5 dell'integrato 5.576/84
Tele piedino risulta poi unito ad un capo della`linea dei 220 volt tramite una terza resistenza. vediR3. sempre da 4.7 megaohm.
Sulla placchetta metallica. considerando la ca-duta di tensione introdotta dalla resistenza delcorpo umano. sara presente una tensione compre-sa tra gli B - 12 volt, cioe quella di una normale pilache qualsiasi bambino potra toccare senza mlni~mamente awertirla.
Ogni qualvolta silorerete questa piacchetta me-tallica. l'integrato prowedera a iomire. in uscitadal piedino 8. degli impulsi negativi che. attraversoIi diodo al silicio D82. raggiungeranno ii gate deltriac che cosi potra eccitarsi.
Per poter ottenere la graduale atten uaziono dellaluminosità. ali'intemo deii'integrato e presente unrivelatore di fase. precisamente dl l*zero crossing".che. ad ogni inversione dalla semionda positiva aquella negativa o viceversa. sincronizza ll contato-re avanti-indietro che regola ii ritardo neii'innescodei trìac.
Sapendo che un impianto elettrico risulta diver-so in ogni abitazione. sia come lunghezza di till diallacciamento che come potenza delle lampade.per compensare il diverso slasamento che potreb-be impedire alla lampada o alle lampade di rag-giungere la loro massima luminosità. il "riferimen-to dl fase" da applicare ai piedino 4 di ICl vieneprelevato direttamente. tramite la resistenza R7.sull'anodo A2 dei triac.
Così iacendo verrà automaticamente compen-sata la lunghezza deli'impianto elettrico ed Il diver-so valore ohmmlco della lampada utilizzata. per-tanto il triac si ecciterà sempre in fase.
Tenendo ii dito appoggiato sulla placchetta deisensore. un circuito interno prowedera a siasaregli impulsi di eccitazione dei triac. quindi a modiii-care ia luminosità della lampada. e, contempora-neamente. a tenerli memorizzati per tutte le suc-cessive accensioniA
Solo se verra a mancare la tensione di rete. lamemoria si cancellerà; per ripristinarla. sara suffi-
monottlora.
Flg. l Schema pratloo di montaggio dol sensore. Ouandoai collegherà a questocircuitorosi-neon di tig. e. bisognerà ian attendono a non Invorttro l due IlII A-B tn uscita dalla
45
Fl'. 5 In .annullano dell'uumlom con Inn- "I-"I"amor rlporml In Ilg. 6. poínmo collegare nulloulcllc A-B delli mamme", (vodl ug. l), del pul-unfl, oppure un Interruttore u Mdofllmo ufl-llznrn qunlø promo per acopl pubblicitari.
ELENCO COHPONENTI LX."
"1 = 4.7 mmm 1/4 "I" Flg. ß Schnm olmrlco doll'nlomon da colle-": ' 4.7 mmm" 1/4 'in gara Iulll ulcllc A-B dll clrcullo bau vlllblk In
,2 moglohm 1/4 mi! "_ ._3 moçlohm 1/4 vufl `mmomn 1]. I." Sulla dum In IM, Il '01° dll! "umori MO-zo ohm 1/2 un WW" 'Wh-20 ohm 1/2 rtl"
C1 : 10.000 pF pollmlr!081 : dlodø 1N4007DZ1 : :onor 6,0 vol! 1/2 m022-- mer 1B roll 1/2 'miTRI-- PNP flpo BC mTRZ: PNP lipø BC.SII
RL? i... E?Flg. I Oul :cpr: lo .ch-rm prim dl mom-lulu doll'uhmorlllgllín LX.608.
lAlu'llß
E è c Flg. 1 Sulla alnbtra, I. roll! dimmi dol clrwllo lhrnpmLX." da uflllmro por questomno lo eonnlulonl dol trln-
80300 llllor 50.300.
ciente riportare la luminosita al valore desideratoe. una volte raggiunto. togliere ll dito dal sensore.
Facciamo presente. che ll circuito e immune datutti i disturbi spuri. quindi mai accadrà che lalampada si accende improwisamente senza alcunmotivo.
Per tar funzionare I'integrato occorre alimentar-lo con una tensione negativa di circa 15 volt e.poiche il suo consumo e veramente irrisorio. 1 mll-llamper circa, questa tensione si riceverà diretta-mente da quella di rete. tramite il condensatore C4.la resistenza R6, il diodo zener DZ1 da l5 volt. Ildiodo al silicio D$1 prowedera poi a raddrlzzarlaed il condensatore eiettrolitico 02 a livellaria.
Ltlmpedenza JAFi, che troviamo posta in serieall'anodo A2 del triac. a una impedenza antidistur-bo, necessaria per eliminare i disturbi generati daltrieo durante il suo funzionamento. che potrebberoln molti casi disturbare la ricezione ln norrnall ap-parecchi radio.
ll triac da noi utilizzato in questo circuito puosopportare un carico massimo di 800 watt. vale adire 0|empadeda100vvatt.16lampade da 50watt o20 lampade da 40 watt.
Precisiamo che il trlac andrà scelto con una sen-sibilità di gate adatta a tale circuito. quindi. se loecqulsterete a parte. se questo non avra le stesseidentiche caratteristiche di quello da noi utilizzatoed Inserito nel kit. il circuito non potra funzionare.
Riteniamo comunque che per un impianto nor'male. un triac da BOOwatt sia gia un eccesso; quin-di chi per accendere una soia lampada da 50 wattinserirà un triac da 2000 watt. risultando nonne!-mente questo più duro dl gate. non avra la soddi-stazione di vederlo tunzionare ed owiamente in-colpera dell'insuccesso la sola rivista.
Per evitarvi altre delusioni, vi anticipiamo che nelcollegare la rete dei 220volt aull'lngresso dl questointegrato. dovrete necessariamente congiungere Iltlle dl tua ai piedini 1-2-3 ed ll tiio del neutro allalampada.
Pertanto se. toccando la piastrine del sensore. lalampada non si accendere sarà sufticiente con-giungere il tiio dei 220 volt. che avrete preceden-temente collegato ai piedini 1-2-3. alla lampada equello delle lampada al piedini sopra citati.
ESTENSIONI SUPPLEMENTARI
Se una stenza dispone di più porte ed Ingressi eowio che. per ognuno di essi, risulti necessarioapplicare un sensore.
Teoricamente potrebbe risultare possibile col-legare sempre sul piedino 5 dl lCi altre due resi-stenze da 4.7 megaohm (poste In parallelo conFit-R2) e congiungere questa con un lungo tilo edaltrettante placchette metalliche tissate su ogniporta d'ingresso.
Poichè in tale integrato e preunte. per questaspecitica tunzione. un ingresso ausiliario (piedino6). risulta più conveniente realizzare un "sensore"supplementare. insensibile a qualsiasi disturbo.che potrà essere collegato anche a notevole dis-tanza dal posto principale.
Come vedesi in tig. 1. sul lato sinistro delloschema elettrico esistono due prese indicate A-Bche. se cortocircuitate. ecciteranno l'integ ratoallostesso modo del sensore collegato al piedino 5 diIC1.
Pertanto potremo:1 - applicare ai cepl A~B un cavetto bltilare ecolle-gare su questi uno o più pulsanti (vedi tig. 5). Pre-mendo e lasciando uno di questi pulsanti si avràI'accensione o lo spegnimento della lampada: te-nendoli premutl. si potrà variare la luminosità dallalampada e memorizzare. come gia spiegato in pre-cedenza, Ii livello della luminosità.
ll pulsante è una soluzione consigliabile in tuttiquei casi in cui si vorrà installare questo circuitosul comodino della camera da letto. perche. nonsempre, toccando le placchetta metallica quandosi è coricati. I'integrato potra eccitarsi. risultando llnostro corpo elettricamente isolato dal pavimento.2- realizzare il circuito elettronico riportato in tig. 6e collegare le uscite A~B agli stessi ingressi delcircuito principale.3 - solo nei casi ìn cui si volesse utilizzare questoaccessorio per scopi pubblicitari. si potra collega-re tra gli ingressi A-B un Interruttore. Cortoclrcul-tando questi due tili la lampada o le lampade varie-ranno la loro luminosità dal massimo al minimo edal minimo al massimo In continuità. Se utilizzere-te due o tre file di lampade di diverso colore apiloterete ogni tiia con uno di questi circuiti, potre-te ottenere degli ettetti pubblicitari molto attraenti.
Per realizzare l'estensore elettronico riportato Intigura 6 vi serviranno due soli transistor PNP alsilicio. due diodi zener. un diodo al silicio e cinqueresistenze.
Sempre in serie alla placchetta metallica delsensore. come per lo schema principale, trovereteancora le due resistenze R1-R2 da 4.7 megaohm.Toccando con un dito tale placchetta, la semiondenegativa del 50 Hz giungerà sulla base del transl-stor TRI.
Risultando TRt collegato in Dariington con TR2.questo si porterà in conduzione. cortocircultandoR6-R7 su B. Cosi tacendo. l'integreto 8.570/8 slecclterà e, automaticamente. la lampade sl accen-dera, o si spegnere se gia accesa.
Tenendo pigiato il dito sulla placchetta. otterre-te. anche in questo caso, le variazioni deil'intensltaluminosa della lampada e la loro memorizzazione.
I due diodi zener D21 e D22 presenti ln talecircuito. serviranno solo per proteggere i due tran-sistor da eventuali sovratensioni.
41
REALIZZAZIONE PRATICA
L0 stampato siglato LX.685. come potete vedereIn fig. 2. ha dimensioni veramente ridotte, tanto dapoterlo facilmente inserire direttamente ali'internodella scatola plastica dove. attualmente. e presenteil normale interruttore meccanico.
Una volta in possesso di questo stampato. potra-te subito iniziare la realizzazione stagnando. comeprimo componente, lo zoccolo per I'integrato ICt.
Fatto questo, inserirete tutte le resistenze. i duediodi ai silicio DSi-DSZ e il diodo zener DZl con-trollando che la fascia che circonda il corpo risultirivolta come visibile nello schema pratico di tig. 4.
Proseguendo. inserirete i tre condensatori po-liesteri, il ceramico CS e l'elettrolitico C2. rispet-tando logicamente per quest'ultlmo le polarità deiterminali.
A questo punto potrete inserire Il triac. siglatonello scheme elettrico TRCi. rivolgendo la partemetallica dall'lnvolucro verso C4. poi l'impedenzaantidisturbo JAF1 e le due morsettiere.
Le morsettlara posta e sinistra vi servire peri duefill A-B da portare ei sensori supplementari, mentrequella di destra per applicare, nel foro posto Inbasso. il filo di FASE della 220 volt. e nel secondoforo in alto. Il filo da collegare ella lampadine efilamento.
Terminato ii montaggio potrete inserire nellozoccolo i'integrato 8.578/3 controllando che letacca di riferimento risulti rivolta verso il conden-satore elettrolitico C2.
Completate anche questa operazione. potretesubito controllarne il funzionamento.
Sul filo che parte dalla resistenza R1 etagnerateun ritaglio di lemierlno. in ferro, oppure di ottone orame; In uscita coileghereta poi una qualsiasi lem-pada a filamento. inserendo i due iili indicati "220volt" in una qualsiasi presa di rete rispettando letese. Se disponete di un tester, individuare ll filo dlfase. sarà molto semplice. Infatti sara sufficientecommutare il tester sulla portate "300 volt AC" edinfilare un puntale in uno dei due fori delle presa el'altro ad una presa di terra (ruhinatto, acqua-tennoeifone. ecc); nel foro dove rileverete unatensione di 220 volt dovrete inserire il filo di faae.
Comunque anche senza ricercarlo con il tester.potrete inserire i due fili nella prese dei 220 voli acaso: se inserirete la spina in senso errato. ogniqualvolta toccherete con un dito la piastrina metal-lica le lampada non si accendere. Constatendo cheil circuito non funziona sara sufficiente invertire laspine e. cosi facendo, questo funzionerà immedia-tamenteA
Anche quando lo inserirete nella scatola e muroin sostituzione dell'interruttore meccanico. se lalampade non si accendere. dovrete semplicementelnvertlre i due fili della rete elettrica.
48
REALIZZAZIONE DELL'ESTENSOREPer ogni posto supplementare da aggiungere al
circuito principale dovrete montare sul circuitostampato. siglato LX.686, tutti i componenti ripor-tati nello schema elettrico di tig. 6.
Come vedesi in fig. 8. su tale circuito montereteprima di tutto le resistenze. poi i due diodi zenerDZi e DZ? cercando di non invertire quello da 18volt con quello da 6.8 volt; inserirete quindi Il diodoal silicio DSi cercando per ogni diodo. di collocaresempre la fascia poste ed un lato del corpo chedistingue ll terminale cetodo. come riportato nelloschema pratico. Se avete dei dubbi controllate conun tester la polarità, perche. inserendo anche unsolo diodo alla rovescia. il circuito non potra fun-zionare.
Dopo i diodi inserire II condensatore Ct. la mor-sattiere e i due transistorcollocando la parte pianasempre verso Ct.
Collegando le due uscite A-B e quelle corri-spondenti della morsettiere del circuito principale.toccando la placchetta metallica dei sensore. lalampada si dovrà accendere e spegnere e dovràpure variare la sua luminosità.
Se ciò non dovesse verificarsi. molto probabil-menteavrate invertito qualchediodo, o le due usci-te A-B.
A questo punto possiamo lasciarvi. perche quan-to detto risulta più che sufficiente per portare atannine questo montaggio. che. come sempre. su-bito vi funzionerà.
COSTO DI REALIZZAZIONETutto il necessario per le realizzazione del circui-
to base di flg. i. cioè il circuito stampato LX.685.I'integrato 5.576/3 completo di zoccolo. le resi-stenze. idiodi, I condensatori, il Triec. l'impedenzaantidisturbo JAFt. le due morsettiere ...... L. 15.500
Tutto il necessario per la realizzazione deli'e-stensora visibile in fig. 6. cioe circuito stampatoLX.886. i due transistor. diodi resistenze. un con-densatore,una morsettiera... L. 2.800
.950
.500
Nel prezzo non sono incluse la spese posmll dispedizione a domicilio.
Il solo circuito stampato LX.685ll solo circuito stampato LX.686
TUTTA L' ELETTRONICAPER TELE E RADIO
in 18 tappe'Ilm
WIII. m.II eleIIIIclIn e le :In III IIII.gII e'eIIIoIII e In mucIoIIIa@I miIeIIaII-mIIuIev IQIISIW IesIsImn
EnnIIIII ll mIn Inn-mlnmk!- Imma “IlillculI/Iì i DON!.lmßh'lçllßfleokgunm III ~= I mm -IIYII'IISIMII inl-IIsI ø unum»:Item «I na-øIII WI
.WII ulrI'IIIl-IIII emImgump." ..1 .Immaimam-wauuu ceImIaIII -aIm-Iwa II. m. gmmIIII-II-' :e III Io-ona :InnoI-.;;¬.I›cnc u«om IIIQI null-IeIecomumn-
W In-IiIlIlI I'IHIIIID-*bobine e II.sim::Om-nona-IIIzI-II unIm Yv
ZIflIlmIoImc a mmmum ml'al»mamma
Un mundo uclullvo dl In:III. In 1! Iuclcall lnlco
mmm I.-eIIImIIIIII :usmmm, uIIeIIcanaII .Il mò. w
m'm'šä'flw I äI I I IIIIIIIIWI IEWIIISID ldesflllm I “Vi-"lldI Im "cum". In bilfltfl I "III'I mltmIø/'I 0.1 HI›FI
un». mm...II-III IIIIWIICI wu wIII. .Imma cm mIIIIIeIIII mIIcI -u IIIIIzm :mmm'Il SINHIJII ß"ll! NWI
-9II mmm-«III III IIII Inaesmmm u'a'IaIIsIIcrIeImDII-qq .I cIIcIIIII a :quem: :I-lnInuIa -Ia II - x
sem-unum
'come IIoIeIIIII`nm Il IefIsmecosuucnøo IIIImIImeIIo -I uInIIII: cum.ec -I
-aII-uIIIcaII unmIIDrumlmll *I cwmll RCnm. alla con. IIIIIo
III -I radumwn
- e .menu mmm eIIIIIwIIummo .mmm «II:III;IIIII mIIIuIII n. IIIII nu Iaum IIuII.
Cm al'ù l|mmm?-I- IuImfIzevaIIanIlIII pam-:me øI "name-cosIIIIzIone III.II mIIIIIIIIqIo-fe a IIaIIsIsIoII.aImuaII-IIII emIçIqIII: uu:Iawe n'flfyum.
LI MIN- FI-Ia lunzIoe sul-mn:-IIIce ceI IIII nI nana; -II
L'INIIcIMnNmondo “Ill"IMI-III-II mmipn uegII :puma-:IIIDeI alu «anni«come mmmIa Iegunumsmm su uImIIe IIuIII mognrIIcI 'Ia IM-Iusxmo muo-mmc;
Chieda subitoun lascicoloin prova gralultaNon c'è niente di più concre-lo er convincersi della vali-dit del meIodo e della serie-là del corso Spedisca subitooggi stiesso il tagliando di ri-
Ies a
IUN FASCICOLOSdIemI in IIIWI SUID Der
un F CULO del nucvlpsgIsmo corso TV RADIOuocumnlanono relativa (scrrvo una Iena/a nel case
monto u distanza, Rodeo. "cubo-IMM7 mundo '6 ncnoln dl mnuhII pIrIIM
mon" Ioltr. 90 alpedmon dl "1"c 'mfclzl I correzioni pumallnlbdol eompltl con commnmo -onnlflcflo Ilmlo.
I :cam nm ml wo IIIIIIIo.Imma lIna Imma maligna..'Amm a IIne mm mm n pIum
.mm .I :mg “I wwIIIwI-«IIIIII “I 00,"s-
___--832-1A41F
IN PROVA GRATISIi SBHHSDGISQ
agiLEiRAD'qO)p-Io III
VII210158 LUINO (VI)IST slulllulo“iam dl Tomica
IHJHIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIlIÂIPIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI'ÈIIIIIIIIIIIIIWII"I'“I"'I°'II"I'"I"'IIIIIIIIIIIIII
III. 033215104."(dIllI 0M Ill. ITM
Qualsiasi motore a scoppio. se gira a basso re›glme genera una bassa potenza. comportando unconsumo di carburante leggermente superiore alvalore medio e se. Invece. ruota ad un elevato nu-mero di giri. fornisce la sua massima potenza, pre-tendendo in cambio una maggior quantità di car-burante.
Come abbiamo spiegato esaurientemente sul n.95 (pagA 42). ad ogni motore corrisponde. pero. unparticolare numero dì giri. che consente di ottene-re la massima potenza con un minor consumo dlcarburante.
Esiste. cioe. tra Il minimo ed il massimo. un bendeterminato numero di girl a cui Il motore lavora incondizioni ottlmall` vale a dire con una potenzamedia ed un elevato rendimento. che corrispon-
Ie puntine dello spinterogeno sl aprono o sl chiu-dono nell'arco di un secondo.
La lorrnula per determinare il numero dl glri delmotore, conoscendo la frequenza di commutazio-ne delle puntine. è la seguente:
n/glri = F x so: (munari = z)ammettendo che la lrequenxa di commutazionedelle puntine risulti pari a 50 Hz al secondo echeilmotore disponga di 4 cilindri. questo ruotera a:501 60 : (4:2) : 1.500 glrl ll minuto
pertanto. applicando sull'ingresso del lrequenzl-metro una lrequenza di 50 Hz. sui display dovrebbeapparire il numero 1.500.
Come si può tacilmente intuire. è alquanto dilli-
n GUNTAGIHI economico??dono. in pratica. ad un minor consumo di carbu-rante.
Potremo lacllmente determinare questo numerodi giri ideale. controllando, sul Iibrettodi manuten-zione. le caratteristiche del motore: inlatti. accantoal valore della potenza massima. viene riportato ilnumero di girl corrispondente.
Supponendo. ad esempio. che questi due valoricorrispondano a:POTENZA MASSIMA CV 120REGIME CORRISPONDENTE . girl/mln. Emmoltiplicando questo numero d I massimi per ilnumero lisso 0,86. conosceremo immediatamente.con una buona approssimazione. il numero dl giriottimale:300 x 0.06 : 4.150 ølll/mln
quindi. lacendo girare il motore su valori compresientro un 10% in più o in meno del valore Indicata(vale a dire. per l'esempio riportato. da un minimodi 3.700 ad un massimo di 0.600 giri al minuta).constataremo che con un pieno dl benzina riusci-remo alare più chilometri di quanti, normalmente.siamo abituati a percorrerne.
Per verilicare il numero di giri ottimale del nostromotore ci occorre però uno strumento chiamatocontagiri. che potremo lacilmente costmire se-guendo io schema riportato qui dl seguito.
SCHEMA ELETTRICOUn contagiri digitale. non a altro che un semplice
lrequenzimetro. utilizzato per contare quante volte
50
Foto della plaatra bau dl quello contagiri. 8|noti In basso Il connettore per lnnutara ll clr-culto atampato dal dlaplay vlalblla a pag. 51.
cile per un lrequenzimetro contare 1.500 impulsi inun secondo. presentandone suli'ingresso solo 50.Per contarne 1500 ci vorrebbero ben 30 secondi.intatti:1.500 : 50 : 30 aecondl
cioe un tempo troppo elevato per un contagiri.Anche volendo contare solo 150 impulal. anzl~
che 1.500. sarebbero sempre necessari:150:50 : :incendi
Per poter risolvere questo problema. occorre so-lo ridurre la irequenza dl lettura in modo da riuscirea contare, nella trazione di tempo corrispondente.15 impulsi e. una volta ottenuto tale numero. ag-giungere al contagiri altri due display "bloccati"
plamo. si compone di:
-ungeneratoredlclockperricevareiabeeedeitempi:- un contatore per contare gli Impulsi o la tre-quenza applicata sull'lngressc;- una memoria che memorizza. nel tempo preiis-sato dal generatore di clock. gli impulsi conteggiati;_ una serie di display per visualizzare numerica-mente la frequenza applicata sull'ingresso.
Pertanto. questi stessi stadi, li ritroveremo anchenel nostro contagiri e più precisamente avremo:
lCt = un integrato tipo NE.555 utilizzato comegeneratore di clock:lCZ = un integrato tipo 746926 che svolge la tun-
per AUTU 'Con aoll tre Integrati potrete realizzare un completo contagiri digitaleper auto. che vl indichera immediatamente a quanti girl ai minutoruota ll voatro motore. Dolando le voalra auto dl oueeto utlliaalmoacceaaorlo. riuscirete a risparmiare del carburante lacendo lavorare llmotore a regime ottimale.
aul numero 00. in modo da leggere 1.500. Percen-tare 15 impulsi. applicandogiiene in ingresso 50 in1 eecondo. ci occorrono solo:15:50 : 0,3 aecondl
vaieedire, in 1 secondo. eflettueremo ben trelettu-reeciò consentirà una misura "veloce"del numerodi giri dei nostro motore.
Per sapere quale frequenza dovremo utilizzarenel generatore di clock. per ottenere una misuraogni 0,3 secondi. dovremo eseguire questa sem-plice operazione:
1:0,3 :3,3":
E owio che ia precisione di lettura risulterà sem-pre di +1- 100 girl: questo valore potrebbe sem-brare eccessivo. ma basterà controllare la scalagraduata di un qualsiasi contagiri meccanico. perconstatare che quest'ultimo non riesce ad apprez-zare più di +l- 500 giri e che quindi. anche sequello digitaledisponediduesolecilresigniticati~ve. risulterà comunque sempre più preciso del cor~rispondente strumento meccanico.
Un irequenzimetro digitale. come ormai sap-
zione di contatore e di memoria digitale.Anche se il costo dell'lntegrato 740926 e abba-
stanza elevato. scegliendolo, abbiamo ridotto ledimensioni finali del circuito ed assicurato al pro-getto una maggior ailidabilità; intatti. in sostitu-zione di questo integrato. avremmo dovuto servircldl due divisori decimali. di due memorie e dl quat-tro zoccoli. quindi. considerando l'aumento dìprezzo del circuito stampato ed il costo dei quattrointegrati. avremmo risparmiato in totale non più di4.000 lire. una cilra non determinante per i vantag-gi ottenuti.
A questo punto vi consigliamo dl osservare at-tentamente Io schema elettrico riportato in tig. 1.per poter seguire assieme a noi la descrizionecompleta del nostro contagiri.
Gli impulsi da conteggiare. verranno prelevatidirettamente sul morsetto delio spinterogeno op-pure sul terminale D della bobina di alta tensioneche. come saprete. risulta sempre collegato allepuntine.
Questi impulsi. primadi raggiungere ii contatoredigitale. dovranno essere limitati in ampiezza, perevitare di danneggiare l'integrato 746926. ed an-
51
ELEN
COG
OM
PONE
NTI
LX-fi
lR1
=39
ohm
1/4wa
ttche "puliti" da tutte le oscillazione spurie e di rim-balzo. per evitare letture errate.
Per questo motivo. il segnale. prima dl raggiumgere l'ingresso dell'inverter siglato lCâ/A passeràattraverso il partitore resistivo R 10 R 11 che neIlmiterà l'ampiezza. ldue diodi DS2-DSS. presentisu tale ingresso. “toseranno'l gli impulsi positivi sudi un valore massimo di 9,7 volt e cortocircuiteran-no a massa eventuali picchi negativi.
Anche se abbiamo cosi protetto l'ingresso del›l'inverter ICS/A sull'uscita non avremo ancora unapertetta onda quadra. ma un segnale "sporco".composto da un treno di onde quadre (vedi tig. 2)che il contatore non ignorera. iacendo cosi appari-re sui display un numero erratov
Per evitare tutti questi inconvenienti. utilizzere-mo iI secondo inverter siglato ICQ/B. per ricavaredall'impulso "sporco" presente in uscita di ICS/A,
000
ohm
1/4Wa
tt00
0oh
m1/4
watt
000
ohm
1/4wa
tt00
0oh
m1/4
watt
000
ohm
1/4W
itt00
0oh
m1/4
watt
000
ohm
1/4wa
tt00
0oh
m1/4
watthI
EEEE.zoeeo
10 47 1047 10mF
elettr
.25
volt
39oh
m1/4
watt
30oh
m1/4
watt
JOoh
m1/4
Watt
39oh
m1/4
watt
22oh
m1/4
watt
39oh
m1/4
w
ìi2._E.=oaa°.o.-Ilo..t: R2
1:
150.0
00Oh
m1/4
ltllfl
R20
:10
0.000
ohm
trim
mer
C1R7:
39Oh
m1/4
watt i
ii_Ei:ooa,_tioa:R3 R4 R5 R6 R1
1R1
2:
10R1
3:
10R1
4:
10R1
5:
10R1
0:
10R1
1R1
0R1
0
un impulso periettamente pulito come vedesi intig. 3.
Come sl riesca ad ottenere questa condizione epresto detto.
Poichè l'ingresso dall'inverter ICS/A viene man-tenuto a livello logico Odalle resistenza R12 ed R11collegate a massa. owiarnente sull'uscita risulteràpresente una condizione logica opposta. cioe 1,vale a dire una tensione positiva di circa 9 volt.
Ogni qualvolta su tale ingresso giungerà . dallepuntine dello spinterogeno. I'impulso positivo(condizione logica 1). l'uscita si porterà al livellologico 0. che corrisponde ed un'uscìta cortocircui-tata a massa.
Poichè il segnale applicato in ingresso presentadelle autoscillazioni causale dei carico lnduttivodella bobina e dal rimbalzo delle puntinev sull'usci-ta non avremo un l“solo” lmpulso. ma. come giàsappiamo. un treno d'onde composto da più im-pulsl (vedi tig. 2).
C2:
100.
000
pFpo
liest
ere
C3
Per ottenerne "uno" solo, privo di lmpulal apuril.utilizzeremo il condensatore 010 da 220.000 pF. edil diodo al silicio DS4.
Come potremo constatare. ll condensatore C10viene mantenuto carico. con une tensione positivadi 9volt. dalla resistenza R13equesto signllica chel`ingresso del secondo inverter ICS/B vlene torzatosul livello logico 1. ottenendo sulla sua uscita urllivello logico opposto. cioe 0.
Quando l'uscita del primo inverter lCã/A si por-terà a livello logico 0. il condensatore C10v tramiteII diodo D54, si scaricherà immediatamente a mas-sa su questo inverter: cosi facendo. I'ingresso delsecondo inverter ICS/B si troverà ora sul livellologico 0 e. di conseguenza. la sue uscita sul livellologico 1.
Anche se I'uscila del primo inverter. per la pre-senza di impulsi spurii. si porterà sul livello logico
dlotle
1N41
4l
NPN
tipo
ICW
0mF
elettr
.10
volt
10mF
elettr
.10
volt
NESS
G4m
= im
ma-
nutuo
mel
t4
dlapla
ytip
eLT
300/A
Ci_
220.0
00pF
pol.
250
Volt
C0 C14
:10
0.00
0pF
po
lluti"
C15
:1
mFpo
liest
ere
DS1
:dio
do1N
4001
052
-DS
SDZ
1:
zene
r9.1
volt
1/2v
ntt
C4:
100.
000
pFpo
lete
re
01:
100.
000
pFpo
len
ter.
Cl:
10.0
00pF
poal
tera
CS:
100.
000
pFpo
lIte
r.
C12
=10
0pi'
attl
cco
C13
:10
.000
pFpa
llute
rl
TR1
-Tm
IC2MM
7409
26IC
J_
0040
106
|C1
:"A
7005
IC4
1, per poi passare nuovamente sul livello logico 0.questo segnale di "disturbo" non riuscirà più adintluenzare l'impulso ad onda quadra fornito Inuscita dall'inverter iCG/B. perche questo e legato altempo che occorre alla resistenza R13 a ricaricareil condensatore C10.
lntatti. per le presenza del diodo 034. gli impulsipositivi eventualmente presenti sull'uscita del pri-mo inverter lC3/A non potranno giungere sul con-densatore C10 per ricaricarlo. e pertanto. a questo.prowedera solo Ia resistenza R13.
Raggiunti i 9 volt positivi ingresso di ICS/B siporterà nuovamente sul livello logico 1 e l'uscita alivello logico 0. ottenendo cosi un'onda quadrapertetta (vedi tig. 3). priva di qualsiasi autoscilla-zione spuria.
Come avrete intuito. questo semplice circuito diIngresso. ottenuto con due soli inverter, cl permet-terà di avere sempre una lettura precisa ed insen-sibile a qualsiasi rimbalzo di puntine odi autoscil-lazioni.
53
Flg. 2 Dalle puntine dello spin-teroqeno esce un segnale chenon puo neuro applicato diret-tamente sull'lngresso di un conta-tore digitale, perchè troppo"lporco". Se non ai ellmlnauerotutte le autooclliazlonl apurie do-vute al rimbalzi lui contatto dellepuntine. Il nostro contagiri rllevc~rebbe una frequenza maggiore diquella reale. Indio-rido cool unnumero di giri ben superiore aquello a cui ruota li motore.
Flg. 3 Per evitare questo lncon~venlente. comune e molti conto-glrl. dovremo prima toure ll u-gnale su dl un valore massimo di9.7 volt. pol. risultando ancorapruentl euli'ulclta dl ICS/A tutti iplocfil positivi delle lutoocfllazlo-nl epurle delle puntine, dovremoetlmlnartl utilizzando semplice-mente un diodo, un condenutoree una relistenza. (vedi 054 - CIO -R13). più un secondo Inverter si-glato ICS/B.
A questo punto. potremo applicare il nostro sa-gnale sul piedino d'ingresso 12 del 740926 (vediICZ). che prowederà a misurarne la lrequenza. perpol convertirla in numero sui display.
Per contare quanti impulsi entrano. in un tempodl 0.3 secondi. nel 746926. occorre seguire unaprecisa sequenza di operazioni. cioè comandarealle memoria di "caricare", ogni 0.3 secondi. il datocontenuto nel contatori per trasferirlo sui displaye. subito dopo. resettare tutti i contatori periniziareun nuovo conteggio.
A tele funzione prowede I'Integrato siglato ICAche. come sappiamo. e un normale NE4555.
Con i valori riportati nello schema elettrico. ruo-tando da un estremo all'altro il trimmer R20. questoIntegrato genererà un'onda quadra con una fre-quenza minima di 2 Hz ed una massime di 4 H1.
Questa frequenza servirà solo per tutte le autoche dispongono di un motore a 4 CILINDRI. mapoichè esistono motori con 2 o 6 CILINDFll. perpoter adattare il circuito ancheaquesti tipi di auto.sera sufficente modificare la capacità del conden-satore 615 come qui sotto riportato:
l CILINDRI : 1 mF Frequenza di 3,3 HzVariazione de 2 a 4 Hz2 CILINDRI : 2 mF Frequenza dl1.6 H:Variazione dn 1 e 2 HzI clLINDRI : o." mF Frequenza dl 5.0 HzVariazione da 3.5 a 6.5 Hz
54
Come potrete constatare, il circuito stampato èstato predisposto per ricevere due condensatoriCi 5. per cui. se il nostro mutoreèaquattro cillndri.inseriremo un solo condensatore da 1 mF, se :duecilindri. inseriremo due condono-tori da 1 mF otte-nendo cosi un totale dl 2 mF e. inline. se a 6cilindri.Inseriremo nel circuito un solo condensatore da"0.000 pFA
La frequenza generata da IC4. prelevata sul pie-dino di uscita 3, raggiungerà, tramite il condensa-tore C12, I'ingresso 3 dell'ínverter ICß/D.
Sull'uscita di questo inverter. sara disponibilel'impulso di LATCH. che prowedera a "caricare"nella memoria il numero di Impulsi contato ed atrasferirlo sui display.
Con un leggero ritardo. dovuto al condensatore011 ed alla resistenza R17. questo stesso impulsogiungerà anche sull'inverter ICQ/C e. dalla suauscita. prelevererno I'lmpulso dl RESET. che verràutilizzato per azzerrare i contatori ed abilitarli aisuccessivo conteggio.
Come e possibile intuire. all'lntegrato 746926giungerà per primo l'impulso di LATCH e succes-sivamente quello di RESET.
Anche se tale ritardo risulta di pochl mlcrose-condl. sarà comunque più che sufficiente per otte-nere un perfetto funzionamento di tutto il "fre-quenzimetro".
Se i due impulsi di LACTH e RESET glungeesero
ma
hi
Fammmmma-:Mnarripato bano una la scheda dal “lay 'siglata LX.097 come rlelblle In quella loto. VIricordiamo che la scheda del dlaplay LXJW, ~uilllzzata per questa oonlaglrl. serva anche lper ll contagiri a PLL presentato a pag. 00. IPrllnadllomlratenalomalclrcultomonlrolla- _ 1tesornpraclraunaqoceladlehwmedula 1
contemporaneamente. o se giungesse prima I'lm-pulso dl RESET e pol l'impulso dl LATCH. sul dls-play apparirebbe owiamente sempre il numero0000. perchè. reeattando i contatori. e trasferendopoi quanto contenuto nella memoria, sui displaypotremo solo trasferire degli O.
Per completare la descrizione di questo circuito.dobbiamo aggiungere che l'inteq rato 740926 a unmultiplexer, cioe i sette segmenti di ogni displaynon vengono pilotati singolarmente, ma tutti con-temporaneamente, risultando questi tutti collegatiin parallelo.
ln teoria quindi, si dovrebbe accendere su tutti lquattro display lo stesso identico numero. ma. co-me invece conetaterete, questo in realta non slvarlllca.
lnlaltl. I quattro transistor TRL TFt2. TFl3 e TRI.le cui basl risultano pilotate dalle uscite 10-1 1<1~Bdell'integrato 740926, prowederanno a lomlretensione al display solo quando l'intagrato presen-tara in uscita il numero ad esso indirizzato.
Cosi, se sull'uscita del 746926 si presenta il nu-mero 3. che deve apparlra ad esempio sul primodisplay di sinistra. lo stesso integrato provvederà alornire alle base del transistor TRI. tramite il piedi-no 10. la necessaria tensione di polarizzazione peraccendere tale display.
Quando sull'uscita sara presente il numero 8che deve apparire sul secondo display, automatl-camente l'integrato togliera la tensione sul piedlno10 e la presenterà sul piedino 11. quindl. risultantopolarizzato il transistor TR2l tale numero appariràsoltanto sul secondo display.
La velocita di scansione, cioe la commutazionetra transistor e transistor. e cosl veloce. (clrca1.000 volta al secondo). che il nostro occhio nonriuscirà mai a vedere i quattro display accendersi aspegnersi, ma II vedrà sempre accesi sul numero3%!)À
A questo punto qualcuno ci chiederà perchemultiplexiamo anche gli ultimi due display di de-stra. che. come gia sappiamo, rimangono liasl sulnumero 00; intatti. a rigor di logica, si potrebberotogliere i due transistor TFlS-TR4 ed alimentare lsoli segmenti dello 0 con della semplici resistenza.
ll motivo di questa nostra scelta e presto spiega-to: alimentando questi ultimi display in multiple-xar. avremo il vantaggio di ottenere un'idanticalumlnoslta per tutti i quattro display, condlzlonequesta che. a causa delle tolleranze della resisten-ze. difficilmente riusciremmo a raggiungere.
Giunti a questo punto. non ci rlmane che parlaredell'alimentazione.
Corna tutti sapranno, la tensione delle batteriaauto, e standardizzate a 12,6 volt a poiche al no-stro circuito occorre una tensione di 9 volt perl'integrato NE.555ed II CD.40106 (lnvertera triqqerdl Scnmltt) e di 5 volt per I'Integrato 740926 e l
55
"9-4 Schoma pratico L"dl montaqqlo dallalcheda bue olqllu k*LX.696. Il clrcullo :hm-plío, come Indicata nel-l'anloolo. i un doppialaccio con lori moulllz-utl.
I l- vu...m m...m" mill
E-è-c -w m...sum ui ssa
CD 40106
Flg. 5 connoulonl dl tum l umbondulwll Imploglfl mln rullmflom d quemprogotlo. Rleovdnøvl cho 91| lmogml sono umpn vlad dall'nllo o I hummer dalbono, clol dal Iaia del Iermlnlll.
display. otterremo la prima tensione utilizzando unsemplice diodo xener da 9 volt (vedi DZt) e laseconda. inserendo nel circuito un integrato stabi-lizzatore tipo uAJBOS. indicato nello schema elet-trico con la sigla IC1.
Abbiamo inserito il dioooal silicio DSt in serie alpositivo di alimentazione. per impedire cite al cir-cuito giunga una tensione inversa. nell'eventuailtùln cui la batteria risulti collegata con il "positivo" amassa ed ancora per proteggere gii integrali daeventuali impulsi spurii negativi generali dall'al-ternetore.
Poichè. quando presentiamo un progetto parti-colarmente semplice ed economico siamo pun-tualmente sommersi da lettere di protesta che re-clamano soluzioni più sofisticate. anche se costo~se e quando invece presentiamo "il meglio delmeglio", ne riceviamo altrettante in cui ci si lamen-ta dell'eccessiva com plessità a del costo. abbiamocercato. per questo progetto. di accontentare ledue opposte lazioni. presentando in questo stessonumero un secondo circuito. più sollsticato. inmodo che possiate scegliere tra i due. quello piùconsono alle vostre esigenze
Detto questo. possiamo ora passare alla descri-zione pratica per darvi la possibilita di poterlo subi-to montare ed installare sulla vostra auto.
REALIZZAZIONE PRATICA
Per questo contagiri digitale, abbiamo previstodue stampati a doppia faccia. a lorl matalllzzati.uno per la parte "digitale". siglato LX.696. ed unoper i soli display. siglato LX.6974
Come e possibile osservare nel disegno delloschema pratico, le dimensioni di questi due stam-pati sono molto contenute. in modo da poter poiriporre tutto il circuito in un contenitore abbastan-za piccolo. che si adatti senza diilicolta "all'esteti-ca" del cruscotto di qualunque modello di autoA
Una volta in possesso dei due stampati. inizie-remo il montaggio dallo stampato LXÀGQT. quellocioè relativo ai quattro display.
Prenderemo il piccolo connettore iemmina a 12poli e lo inseriremo dal lato dello stampato dove eriportata la sigla LX.697. poi. dal lato opposto. sal-deremo i terminali alle piste del circuito stampato.iacendo attenzione a non provocare dai corti trapista e pista.
Sullo stesso lato dove abbiamo eseguito questasaldature dovremo inserire i quattro display .ma.prima di lario. dovremo controllare che non risulti-no disposti in senso inverso al dovuto.
Purtroppo in tall display non esista nessun puntodi rilerimento affidabile. per cui ia soluzione piùvalida rimane soltanto quella che ora vi indicheremo.
Prendiamo una pila da 9 volt ed una resistenzada 1.000 ohm 1/4 01/2 watt. e rivolgiamo il displayverso di noi. come riportato in lig. 7; colleghiamo
In queata loto e visibile il circuito :tam-pllo LX.697 vlato dal lato ln cui blaøglle-ra inserire II connettore lammlna. I ter-minali dl questo connettore andrannoaaiútl dal lato opposto (ved loto sotto).
Foto dello stesso circuito visto dal tatodal display. Per non inserire un dlaptayIn senso opposto al richiesto. controlla-te la pledlnatura come riportato ln llg. 7.
m" M12 mi! ml
IHKèIšláììšlšll i:
Flg. 6 Schema pratico dl montaggiodel display aul circuito stampato a lorlmetallizzatl alglato LXJI'L
57
le sul circuito stampato come visibile ln tig. 6
Fig. 1 Falchi nel display L'I'Jtß/A non e pre-lanlo un punto dl rlierimenio amdablle, prima diinserirli e saldaril sul circuito stampato. vl consi-gliamo dl prendere una pila da 9 volt. dl collegareII negativo dl questa sul primo terminale posto inbano a destra e dl applicare la tensione positiva.tramite una resistenza da 1.000 ohm. sul secondopiedino. Se lui display non ai accende alcunsegmento. lneerlielo senza motorio. direttamen-
- ¢
iammusv '
ora il terminale negativo della pila sul primo pledl-no posto in basso a destra ed il positivo con laresistenza posta in serie. sul secondo pledlno.
Cosi lacendo. se li display è rivolto correttamen-te. non si dom accendere alcun segmento (inqualche display questo piedino ia capo al puntodecimale. quindi. al massimo. potrebbe eccendersiil solo punto). se invece dovesse accendersi. signi-iica che il display e girato alla rovescia. per cuidovremo ruotarlo. ricontrollandn che. in questaposizione, nessun segmento si accenda.
Tenendo Il display cosi rivolto. lo inserirerno di-rettamente sul circuito siampato e tale operazionela effettueremo pertutti e quattro i display. E owioche. inserendo anche un solo display alla rovescia.non appariranno dei numeri. ma dei simboli ano~mali.
Per l'ennesima volta ripeteremo di ricontrollarecon una lente d'lngrandimento le saldature. peressere certi che non esistano del cortocirculti trapista e pista.
Terminato il montaggio della scheda siglataLX.697. prenderemo il circuito stampato siglatoLX.696 e. sopra a questa. monteremo tutti i com-ponenti come visibile in ilg. 4.
Comesempre. consigliamo di iniziare montandoitre zoccoli per gli integrati ICZ. lCâ ed IC4 e dlproseguire poi. inserendo tutte le resistenze ed idiodi. E owio che ogni diodo andrà rivolto con laiascla colorata riportata da un lato del corpo. checontraddistingue il catodo.come risulta disegnatonello schema pratico.
Poichè tra I diodi esiste anche uno zener. consi-derando che non sempre suli'involucro appare lasigla. se non disponiamo di un provadiodipotremolntuitlvamente riconoscerio. perche avremo sem-pre tre diodi al silicio (082- DSS- DS4) con identi-ca lascia colorata (questa lascia potrebbe risultarerossa oppure blu) ed uno solo con lascia nera.
58
Peril diodo DSi. un normalediodo raddrizzatore1N4004. oppure 1N4007. o similare. non ci sarannoproblemi. in quanto II suo corpo ha dimensionimaggiori rispetto agli altri diodi e I'involucro non ein vetro, ma in plastica nera. con una fascetta bianca.
Salderemo di seguito i due trimmer R11 e R20.poi i due condensatori ceramici Cli e €12 e tuttiicondensatori al poliestere. ad esclusione del solocondensatore 615.
Infatti. osservando io schema elettrico riportatoin iig. 1 ed il circuito stampaio. si potrà notare cheesistono due condensatori, entrambi siglati 015.
Come abbiamo precedentemente spiegato.questo condensatore siglato 615 determina la ire-quenza di clock (vedi IC4). quindi la sua capacitaand ra scelta in iunzione del numero dl cilindri pre-senti nella nostra auto:
Per 4 GILINDRI dovremo inserire un nolo conden-satore da 1 mlcroland .FerzclLlNDnl dovremo inserireduecondansato-ri da 1 microiaradPer e CILINDRI dovremo inserire un solo conden-satore da 0.68 mlcmlarad
Perciò. anche se nel kit saranno presenti duecondensatori da 1 microlarad ed uno da 0,68 rnl-croiarad. bimnera utilizzare solo la capacita ri-chieste in iunzione al numero dei cilindri della no-stre auto.
Risolto il problema del condensatore 015. po-tremo inserire nel circuito stampato i tre condensa-tori elettrolitici 61.03 e CG. rivolgendo il terminalepositivo come vedasi in iig. 4. e. vicino al conden-satore (35` I'lmpedenza siglata JAF1.
l quattro transistor siglati TRi - TR2 - TR3 - TR4dovranno essere tutti collocati con la parte pianadel loro involucro rivolta verso il connettore deidisplay. mentre l'lntegrate stabilizzatore ICI. con
la parte metallica del corpo rivolta verso i due con-densatori eiettrolitici 03 - Ci.
Per ultimo monteremo II connettore maschio a12 poli ripiegato a L. necessario per innestare. Inseguito. il circuito stampato dei display siglatoLX.607.
Ovviamente. non dovremo dimenticarci di inse-rire I terminali capicorda per l due lili di alimenta-zione e per I'ingresso del segnale. che preleveremodalle puntine dello spinterogeno.
Terminata la realizzazione. inseri remo nei rispet-tivi zoccoli i tre integrati collocando ia tacca dirlierlmento come visibile in iig. 4 ed lnnesteremosu tale stampato quello del display. quindi passe-remo all'operazione di taratura.
COLLAUDO E TARATURA
Anche se il circuito e periettamente iunzlonanta.non lo potremo ancora Installare sulla nostra autoperche. prima dl lario. dovremo tarare il trimmerR20.
Collegheremo i terminali positivo e negativo.posti sulla sinistra del circuito base. ad un qualsiasialimentatore in grado dl erogare una tensionecompresa tra I 12 ed i 18 volt e. se non a statocommesso alcun errore. su tutti i display dovràapparire il numero 0.
A questo punto. ruoteremo a meta corsa sia iltrimmer R20. che il trimmer R11; poi ci procurare-mc un qualsiasi trasiormatore che disponga di unsecondario in grado di erogare una tensione alter-nata compresa tra i 12 ai 40 volt.
Questa tensione ci servirà per prelevare una tre-quenza di 50 Hz, utile per tarare la base dei tempidel nostro lrequenzimetro. aiiinchè sul display ap-paia l'esatto numero dl giri del motore.
Coliegharemo questa tensione alternata tra IIterminale "entrata". posto sulla destra del circuitostampato. e la massa chela capo al terminale NE-GATIVO della tensione di alimentazione dei 12volt.
Subito sui display apparirà un numero; se cosinon tosse. bisognerà ruotare il trimmer della sen-sibilità d'ingreeso R11 iino a quando non appariràun qualsiasi numero. Ottenutolo. dovremo ruotarelentamente il trimmer Fl20linoa leggeresuidispiayIl seguente numero:1.500 per un motore a I cilindri0M per un motore a 2 cilindri1.000 per un motore a 6 cilindri
Tarata ia base del tempi del irequenzlmetro. po-tremo installare il contagiri nella nostra auto. col-legandoidueterrninalidi alimentazioneel positivodella batteria ed alla massa. e il terminale "EN-TRATA IMPULSI" al morsetto puntine dello spin-teroøeno.
Par quest'uitlmo collegamento. consigliamo di
utilizzare del cavetto schermate. onde evitare chequesto illo si comporti come un'antenna e captl gliimpulsi spuriì. molto potenti. generati dalle cande-le e dall'alternatore.
E ovvio. che dovremo collegare la calza metallicadi questo cavetto a massa perche diversamente. illilo interno non risulterà achermato.
Ora potremo mettere in moto la nostra auto. eruotare con un cacciavite il solo trimmer H11 dellasensibilità.
Per lar questo. converra ruotare tale trimmer.prima. in modo da iar apparire sui display solo0.000. poi. in senso inverso. lino a quando nonapparira un numero che corrisponderà esattamen-te al numero di giri al minuto del nostro motore;Infatti. se proveremo a pigiare il pedale dell'acceie-ratore. vedremo subito aumentare il numero delgiri e quando lo lasceremo. automaticamente an-che lI numero dei giri scenderà al suo minimo.
Conatatato chetulto iunziona regolarmente. po-tremo installare il contagiri definitivamente sullanostra auto. e. nel caso vi siano diiiicolta a trovareun contenitore in cui alloggiarlo, noi ne abbiamopreparato uno che riteniamo possa soddisiaroqualsiasi esigenza.
Inserendo questo contagiri entro un qualsiasicontenitore metallico. dovremo ricordarci dl tene-ra leggermente distanziato. con delle rondelle. ilcircuito base LX.696 dal piano sottostante dei mo-bile. onde evitare cortocircuiti con qualche termi-nale lascìato un po più lungo del solito.
Sara bene ricordare di collegare il illo positivo dialimentazione ad un qualsiasi punto dell'implantoelettrico. dove la tensione. nel togliere la chiavedalcruscotto. venga a mancare. perche e logico che.spegnendo l'auto. automaticamente dovremo ewu-dere i 12 volt anche dal nostro contagiri.
COSTO DI REALIZZAZIONEIl circuito base LX.696 completo di circuito
stampato. i tre integrati e i relativi zoccoli, più lostabilizzatore ici. l transistor. tutte le resistenze. idue trimmer. i diodi. i condensatori (sia per 2 -4-6cilindri). il connettore maschio e l'impedertzaJAF1. (vediiig. 4) ....... ..L 33.000
Il circuito display LX.697 compiet di circuitostampato. quattrod play LT.SOS/A. p llconnet-toralemmina L. 13.000
Un mobile a a o a riceve ques o contagiri,verniciato di nero. completo dl mascherina plexi-glass colorrosso. ..L. 9.000
Il solo circuito stampato a iori metallizzatl com-pleto dl serigrafia LX.696 ........ .L. 5.000
II solo circuito stampato a ion metallizzati com-pletodiserigraiiaLX.697.. ...L 1.300
l prezzi sopraindicati. non includono le speseper la spedizione postale.
59
Poiche ll contagiri digitale "economico". presen-tato su questo Stesso numero, consente la lettura.sui quattrodisplay presenti. di due sole cilre signi-licative e cioe quella delle migliaia e quella dellecentinaia di giri. abbiamo pensato di esaudire inanticipo le richieste di quei lettori che subito cichiederanno quali modifiche apportare a tale cir-cuito per leggere anche le decina di giri.
Non essendo possibile raggiungere tale condi-zione con il contagiri "economico". abbiamo pr0~gettato un modello più solisticato che utilizza uncircuito PLLA
Con questo nuovo circuito sarebbe possibileleggere anche le unite dl girl. ma in pratica. varian-
tlnala. mentre le altre due. cioe le decine e le unite.risulteranno sempre fisse sul numero 00 e quindiserviranno sul contagiri solo per avere un numerocompleto equivalente a 15004
Volendo rendere significativa un'altra cílra. cioequella delle DECINE di giri, dovremmo aumentareartificialmente la lrequenza d'ingresso, cioè quellaproveniente dalle puntine dello spinterogeno. Inmodo che il nostro lrequenzimetro possa contare,in un secondo. 1.500 impulsi e non 50. come real-mente lorniti dallo spinterogenoV
A questo punto spiegheremo come sia possibileaumentare una lrequenla. utilizzando semplice-mente un circuito PLL.
GUNTAGIRIa 3 cifrecon PLI.
do molto velocemente tale numero. ll nostro oc-chio. per la persistenza dell'immaglne. vedrebbesempre e solo un 8: per questo motivo abbiamopreterito limitare la portata alle sole decine dl giri.lasciando llsso l'ultlrno display delle unità sul nu-mero 0.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTONel precedente articolo abbiamo visto che.
quando un motore a quattro cilindri ruota a 1500glrl al minuto. le puntine delio spinterogeno siaprono e chiudono 50 volte in un secondo.
Poichè un contagiri altre non e che un frequen-zimetro è ovvio che. applicando sul suo ingressouna lrequenza di 50 Hz. al massimo potrà ler appa-rire sui display il numero 50 e non 1.500 come danoi richiesto.
Per ottenere questo numero. si adotta un sem-plice artilicio. cioe si ettettuano in un secondo 3.3letture. ottenendo cosi il numero 15. intatti:
50:13:15
Cosi tacendo. avremo però due sole cilre signifi-cative. cioè quella delle migliaia equella delle can-
60
Se ricorderete. sul n. 94. nella rubrica "Trasmet-titori e Transistor". vi abbiamo spiegato. parlandodei PLL. come. applicando due frequenze sull'in-grosso di un Or Esclusivo. si possa ottenere. suli'u-scite di questo. una tensione utile a pilotare i diodivaricap di un oscillatore variabile. chiamato VCO.
Per coloro che non disponessero di tale riviste.riporteremo una spiegazione condensato del fun-zionamento di un circuito PLL. in modo da larcomprendere ugualmente come. da una irequenzadi pochi hertz. se ne possa ottenere una di qualchemigliaia di hertz, cioe eseguire con estrema sem-plicità una moltiplicazione di mquanu4
Come vedesi in tig. 1. se su uno dei due ingressidi un Or Esclusivo viene applicata la lrequenza diun quarzo XTAL da 0.1 MHZ (pari a 100.000 Hz). esull'altro ingresso la lrequenza del VCO. cioèdeli'osclllatore variabile controllato dalla tensionefornita in uscita dall'Or (vedi diodi varicap collegatisu tale uscita). si verilichera quanto segue:suli'uscita dell'Or. (come spiegato sul n. 94 a pag.69-70). avremo degli lmpulsi positivi. che verrannoconvertiti dal condensatore posto dopo la resi-stenza (filtro Pessa<Basso). in una tensione conti-nua. che da 0 volt lentamente aumenterà lino a
Foto del coniaglricontrollato I PLL.Con questo contagiriavrete tre clfre signi-flcatfve.qulrtdlpotre-te conoscere anchele decine dl ølrl deimotore.
Un'lulovotlure dl valore «Igo un contagiri altamente loilclicllo ed Oper quello motivo che ebblamo progettato un clrcullo controllato IPLL. che concentlrl dl leggere oltre alle mlgllele ed alle cenilnoll.anche le decine dl glrl del voltro motore.
raggiungere un valore massimo pari a quello dialimentazione.
Questa tensione. raggiungendo I dlodl varicep.modifichere le frequenze del VCO e quando questesara esattamente di 100.000 Hz. peri cioe alla stes~sa ed identica frequenza del quarzo, l`0r Esclusivoprowederà a mantenere costante la tensione suidiodi varicap (tensione che potrebbe risultare aseconda del montaggio di 3 ~ 3,2 ~ 4,1 ecc, voli) inmodo che il VCO oacilli sempre e stabilmente sui1W.000 Hz.
Se per un qualsiasi motivo la frequenza del VCOdovesse variare anche di pochi hertz. e cioè passa-re da 100.000 Hz a 100.001 oppure a 999.999 Hz.I'Or Esclusivo prowederà a variare leggermente. inpiù o in meno` la tensione in uscita applicata suidiodi varicep, in modo da riportare il VCO nuova-mente sulla frequenza di 100.000 Hz4 Come avreteintuito. se le frequenza del VCO. che entra sull'in-grasso dell'Or Esclusivo. non è perfettamenteidentica a quella del quarzo. I'Or Esclusivo prowe-darà a modificare la tensione in uscita da un mini-mo ad un massimo e viceversa. lino a quando nonriuscirà e far oscillare il VCO sulla stessa identicafrequenza del Xtal.
A questo punto. avendo un VCO che rleultn por-
iettamente "agganciato". cioè che oscilla esatta-mente aui100.000 Hz (pari a 0.1 MHz). se appliche-remo tra la sua uscita e l'ingreeeo dell'OR un dvi-eore x 512. su tale Ingresso non giungeranno più100.000 Hz, bensi una frequenza di soli:
100.000 ¦ 512 : 105,31
L'Or Esclualvo ritrovandosi eu un Ingresso con100.000 Hz (lrequenza Xtal) e sull'altro con 195.31Hz (lrequenze VCO). prowedera subito a modifl-care la tensione sui diodi vericap del VCO. pervedere se sia possibile riportarlo sul 100.000 Hz.ma. risultando troppo elevata la differenza tra ledue irequenze. non riuscirà ad aggartoiarloV
SolosostituendoilVCO precedente,cheoscille-va in gamma 0.1 MHz, con uno che oscilla su 51.2MHz (v i figt 2), cioe 512 volte maggiore di 0,1MHz. si riuscirà ad ottenere sul secondo ingressodell'Or la stessa frequenze del quarzo. cioè 0.1MHz.
lnlatti, dividendo la lrequenza del VCO per llfattore di divisione introdotto. parl a 512. avremo:51,2:512 : 0,1 MHZ
Quindi, utillzzando un quarzo da 0,1 MHz. poe-slamo realizzare un VCO che oecllll ad urta ire-
61
Flg. 1 Un PLL, (leggere apeg. Il del n. M), controlla Inlrequenu un VCO lino aquando aul "condo Ingmaodell'08 giunge una lvequenlapari a quella del quam.
Flg. 2 Se dlvldlarno per 512volte la lrequenza dulolh delVCO, prima dl lnaeflria aull'ln-'mao dell'OR, i ovvio che Ilcircuito PLL funzionari eolo Iaettanto ae la lrequlnu delVCO Ilaulterl Slìvolte più libdl quella generata dell' XTALpreeente aull'altro lngnaao. r
quenza notevolmente superiore. sempre che, conuno o più divisori, si riesca a presentare sul secon-do piedino dell'Or una lrequenza perlettlnanhldentiea a quella del quarzo.
Se la frequenza dl rilerimento generata da unquarzo risulta valida per realizzare dei VCO moltoatabill da utilizzare in trasmettitori o ricevitori. In uncontagiri ci interessa ottenere una condizione op-posta, cioe un VCO che vari in lrequenza al variaredella frequenza di riferimento. Per spiegarci me-glio, passeremo alla tig. 3 e qui vedremo come aulpiedino dell'Or. sul quale precedentemente risul-tava inserito il quarzo XTAL, abbiam collegato unoecillatoredi BF. aintonizzatosulla trequenza di 20 HL
Sapendo che sull'altro ingreeao dell'Or Esclusi-vo deve necessariamente giungere una lrequenzaperfettamente identica. cioé di 20 Hz. trovandosiancora interposto tra VCO e l'ingresso dell'Or undivlsore x 512, ee desideriamo che il VCO risulti"agganciato" (cioe stabilizzato In lrequenza dalcircuito PLL) è owlo che queai'ultimo dovrà Oscil-lare sulla lrequenza di:
eum: = 10:40 mSe ora modifichiamo la lrequenza dell'oeclllato-
redi BF. portandolo da 20 Hz a50 Hz, I'Or Esclusivomodillcherà la tensione sui diodi varicap, in modoche ll VCO oacilli ad una irequenza tale che. divisax 512. ripreeenti aull'altro piedino dell'Or non più
62
20 Hz. bensi 50 Hz. pari cioe e quella di rilerimento'e pertanto questo dovrl oacillare a:
501512: 25.800":
Se modiilclliamo ancora la frequenza dell'oaciklatore di BF sul 100 Hz, nuovamente la tensione luidiodi varicap verra variata dall'Or in modo che ilVCO oacilli su:
1M! S12 : 512W H3
ln pratica vi abbiamo dimostrato come. variandole lrequenza sull'ingreseo delI'Or da 20-50-1m Hz.in uscita del VCO otterremo 10240-25500-51200Hz. cioè siamo riusciti ad aumentare artilicialmen-te dl 512 volte la frequenza dell'osclllatore di BF.
A questo punto e iaclle Intulre che. collegandosull'ingresso dell'OR non più un quarzo nè unoscilletore di BF. ma. come vedasi in iig. 4. la lre-quenza delle puntine dello splnlerogeno. riceve-remo in uscita una lrequenza moltiplicata per 512volte.
intatti, se lo spinterogeno genera una lrequenzadi 33 Hz, sull'uscita del VCO otterremo:
33 l 512 : 16.0” Hzquindi. sapendo che ll numero di girl del motore
ai ricava dalla seguente lormula:
Il/G :FllO:(olllndll:2)
per un motore a 4 cilindri. una trequenza dl 33 Hzcorrisponderà a:flxwzflú) : mgtrl
Pertanto disponendo dl una trequenza di 18.0”Hz. riusciremo facilmente a contare. nel tempo vo-luto. solo 090 Impulsl, condizione questa che aa-rebbe risultata praticamente impossibile se nonavessimo moltiplicato x 512 la lrequenza delle pun-tine.
Compreso come si possa. con un circuito PLL."moltiplicare una frequenza". aggiungeremo che.per questo contagiri. come PLL abbiamo sceltol`integrato 004046 perche gia completo deII'ORESCLUSIVO e del relativo VCO. che non abblamomal utilizzato nei RICETRASM ETTITORI ATRANSISTOR solo perche lavora lino ad un mas-almo di 1 MHz. una trequenza cioe troppo bassaper poter realizzare qualsiasi trasmettitore. ma cherisulta eccedente per l'uso che ora ne tacciamo.
lntatti anche se il vostro motore raggiungerà unnumero massimo di 9.000 giri, il VCO dovrà oscllla-re su di una frequenza di 153.600 Hz, quindi beninteriore al suo limite massimo di 1 MHzA
Come vedeei in tigA 5, sul piedino 14 del (2004046.cui la capo uno del due Ingressi dell'OFt dl compa-razione, viene applicata la trequenza provenientedalle puntine. mentre sul secondo ingresso (piedi-no 3). viene applicata la trequenza del VCO. prele-vata eul piedino 4 e divisa per 512 dal divieore.
L'uscita dell'OFl (piedino 13) vlane applicata sultiltro passa-basso costitultoda R15. R16eC13edaquesto prelevata per alimentare Il “diodo varlcap"(piedino d'ingresso 9).
Abbiamo messo tra virgolette la parola "diodovarìcap". perchè la variazione di trequenza In taleVCO. viene ottenuta appllcendo la tensione dl ein-tonia non su dei varioap. ma su un GATE dl un tet,utilizzato come elemento variabile.
Per far osclllare ll VCO nella gamma dl trequenzarichiesta. cioe da 0 Hz a 150.000 Hz circa, dovremoappllcare sui piedini 6-7 una capacita dl 1.000 pF(vedi C12) e una resistenza R14 da 10.000 ohm, trall piedino 11 e la massa.
La frequenza dl uscita del VCO. prelevata dalpiedino 4, oltre a rientrare sul piedino 3 dall'ORESCLUSIVO divisa per 512 volte. la utilizzeremoanche per pilotare il nostro trequanzimetro.
Pertanto. se il nostro motore a 4 cilindri ruoteraalla velocità di 3.000 glrl al minuto. la frequenzadelle puntine risulterà pari a:
Hz : a:001(Clllndrt:2)valeadlre:
aaoazeoxunuionuxSapendo che la lrequenza del VCO e 512 volte
maggiore della trequenza della puntine, aulla nuauscita ora avremo:
1MIS12 : 511W":
Flg. 3 Se, tn Ioetltu-.m ,, alone dal quarzo, appli-
chtamo autl'OR un ge-neratore dl BF. quandona modltleharemo laIraquanu, Il VCO paell-lerì au dl una traquenlasempre 512 voiteptùalhdl quella det generatore.
Ftp. 4 Colleeande aut-l'lngroaeo deiI'OIl la IN-quenza prelevata dallapuntine detto aplntaro-gono, otterremo. conqueato etreulto PLL, unmoltlpllcatora dl tro-qalanza.
Flg. 5 L'lnlognlo 60.4046 da nel nano por quanto conhglfl, è un compiutoclmulío PLL perché Inlommome nono gli pruantl I'OR ucludvo o I'owìllltonurlabllc, (vodl VCO), pur module-n la Inquum gomma dalla lplnllrøqomIn modo che qunh rllulll amp'. 512 volle plù .Ionio dl quella della punllm.Tn I'ulelh dll VCO c l'lngnuo doll'OR abbiamo lnudto. com dvlm po'512. un normale Chloe flpo CDAMO.
Foto della nchodablu del contagiri IPLL duumo In que-m amwlo.
Partendo da tale valore. dovremo percio iar ap-parire sui display la cilra 3.000. risultando questoi'esatto numero di girl del motore e a tale conver-sione prowedera un normale integrato NE.555.
A questo punto. avendo ormai detinlto le princi-pali iunzioni svolte dal PLL. possiamo passare alladescrizione delloaohema elettrico. riportato in tig. 6.
SCHEMA ELETTRICOCome potrete notare. lo schema elettrico di que-
sto contagiri digitale a PLL non si diiterenzia note›volmente da quello in versione "economica" pre-sentato in questo stesso numero.
Ad esempio Il circuito di ingresso. sempre costi-tuito dai due inverter siglati ICS/A ed IGG/B. e per-lettamente identico a quello impiegato nel primocircuito. per cui. perla sua descrizione. vi riman-diamo direttamente al precedente articolo.
Sul piedino di uscita e di ICS/B. saranno presen-tl. come già abbiamo descritto. degli impulsi posi-tivi pertettamente squadrati e rlpulltl dal rimbalzisempre presenti sulle puntine.
Dall'uscita di questo circuito. gli lmpulal giunge-ranno sul piedino di ingresso 14 dl iC4. il PLL tipo60.4046 che. unitamente all'integrato un CIMOStipo CD.4040 riportato nello schema elettrico conie sigla ICS. provvedere a moltiplicare x 512 voltetale irequenza.
La lrequenza cosi ottenuta. prelevata, come giaabbiamo visto in tig. 5. sul piedino di uscita 4 dl IC4,viene applicata. tramite la resistenza R17. sul pie-dino dl ingresso 12 dell'integrato ICZ. un 740926. ilquale provvedere a svolgere tutte le operazioni diconteggio. memorizzazione e visualizzazione inmultiplexer sul quattro display ad esso collegati.
Come gia sappiamo. per poter funzionare datrequenzimetro dovremo tar giungere a questo in-tegrato oltre alla trequenza da conteggiare. anchegli impulsi di LATCH e di RESET sul piedini 5 e 13.
La temporizzazione con cui vengono generatitali comandi dovra risultare diversa rispetto al cir-cuito precedente. in quanto abbiamo. ln questocaso, l“moltiplicato” la lrequenza delle puntine dl512 volte.
Per ottenere questo. mantenendo la stessa con-tigurazione circuitale dell'N5.555 (vedi ICS). e aut-ticiente modificare I aoil valori dei componenti adesso collegati. lnlatti. il valore da assegnare alcondensatore 022. a seconda del numero dl cilin-dri del vostro motore. dovrà ora risultare:
4 CILINDRI : 0.22 mF Frequenza di 11,06 HzVariazione da 14 a 20 Hz '2 CILINDRI : 0.44 InF Frequenza di 8.35 H!Variazione da 6 a 9 Hze CILINDRI : 0.15 mF Frequenza di 25.0 tt:Variazione da 21 a 29 Hz
Per ottenere tali capacita. come vedremo anche
nella descrizione della realizzazione pratica. do-vremo utilizzare uno o due condensatori posti Inparallelo.
Supponendo quindi di voler collegare il contagi-ri ad un motore a 4 cilindri. inserendo per 022 uncondensatore da 0.22 mF. regolando Il trimmerR21. otterremo In uscita, sul pledínoâdi IOS. comeabbiamo riportato nella tabella precedente. unatrequenza che variera da un minimo dl 14 ad unmassimo di 20 Hz.
Sapendo che a 1.500 giri la frequenza delle pun-tine dello spinterogano per un motore a 4 cilindri edi 50 Hz, la lrequenza dl uscita sul piedino 4 dei'PLL risultera pari a:501512: BJWHI
Dividendo 25.800 Hz per il numero di giri delmotore. ottenerne la treouenn dl "ciocli":müjw : 11.”"2
in pratica. analogamente a quanto abbiamo de-scritto nell'artlcolo del contagiri “economico”. altrequenzimatro dovra giungere un impulso dl resetogni 0.058 secondi. Ricordiamo che tale valoreviene ricavato dalla formula:t :Frequenza cioe:1 : 11,00 Hz = 0.050 secondiche corrispondono al tempo necessario al tre-quenzlmetro percontareesattamente 1.500 impul-si ei secondo presentandone al suo ingresso25.600.
Stabilita la lrequenza di clock. per ottenere daquesto segnale i due impulsi di LATCH edi RESEYnecessari al nostro trequenzimetro. utilizzeremo llcircuito costituito da ICS/F. ICS/E. ICS/Dad ICS/C.
I prlml due Inverter. cioe ICQ/F ed ICS/E. sonocollegati in modo del tutto analogo e quanto ab-biamo visio nel precedente circuito. più precisa-mente la lreouenza di 17.06 Hz presente sul piedi-no di uscita3 di ICS. giungerà, tramite 019. suli'ln-gresao del primo inverter ICS/F. dalla cui uscita.sul piedino 2. preieveremo i'impulso di LATCH daapplicare, attraverso ia resistenza R22. sul piedino5 di IC2.
Con un ritardo di pochi microsecondi. introdottodal condensatore C18. questo stesso impulsogiungerà anche sul piedino di ingresso 5 dei se-condo inverter (vedi lCa/E). la cui uscita (piedino6). oollegatatramite la resistenza R21 al piedino 13dl ICZ. provvederà a RESETTARE i contatori deltrequenzimetro.
Gli altri due inverter presenti in questo circuito.siglati rispettivamente ICS/D ed lC3/C. li utilizze-remo per variare a nostro piacere la velocita dllettura del contagiri.
Come potrete notare osservando lo schema ditig. 6. l'uscita 6 dell'inverter lCâ/E. sulla qualesonoprelevati gli impulsi dl RESET. risulta collegata.
_. _._»..È
in. __. ...31.
im._
_..É
fih
vp
nzk
`__
...EL
..__rvT.3.5
.unau
225m:
..E-:v
..._-55.¦:-è.
._È
EH
_..._
to!!!
2:8....Ba-x.
:Bn-E
H!
s n .53
.28
._ .i.5....5
.8.2... _
..åš
...3:8._ .2.29.-
2155...2. .i
83...23....:-
2...2.°..a
_...ãs25...... .5.8
. `.._- _._5.2...
5%...2.:... _ ...i
- ...a-...8_...
2.......33......-
-s-..åo a...
siiåtëšššššäšëgšssåäšëšššãäääšäš
i:ëš agšši ,iafiiìäìšããšå.
*Èìì*ìa°`ašìš.ešäägéšmšgeešëfiäfigjgj;ëáääåßasäsäša
nmø
hm11
4!!!
.1|
:1
0m
m11
4101
1I"
:1
0m
m11
4'!!!
I":
1U.0
Uohm
114'
!!!
l1l
ILDI
OO6
0m
mLm
'-I
500.0
00oh
mtri
mm
er1.0
00ohm
1/4'a
lt
47.00
0oh
m1/4
'att
41.00
0oh
m1/4
watt
41.M
0oh
m1/4
il!!
10.00
0oh
m1/4
mR2
1:
100W
Ohm
1/4'Il
H1!
R20
1122
I” M4 IIS
Il ll Il Il ll Il Il Il
R20
:10
.000
0hm
1/4
Il”
10.00
0oh
m1/
4Ilfl
10.0
000h
mtrl
mm
cr.10 I"
100.0
00oh
mtri
nmar
100.0
00oh
m1/4
1111
ö
III
:1
0d
1/4m
I":
10
mm
1/4'Il
M4=
1m
oh
m1/4
M
-1
mFpo
llam
e
a§Éâ
100W
edlc
oeO10
tramite Il diodo DS1. aull'ingreoso dl iCS/D e aulI'u-scita dl ICS/C. Attraverso tale diodo. il segnala diRESET. che in pratica è un breve impulso a livellologico 1. glungera sul piedino dl ingresso 3 diICS/D. il quale. invertendolo. presenterà sulla suauscita un livello logico opposto. cioè O. vele a direuscita cortocircuìtata a massa e in tale condizioneverra mantenuta grazie al ritardo introdotto dalcondensatore C16 ed alla retroazlcne ottenutaconl'inverter 103/0.
Cosi iacendo. il diodo D86 cortocircuitera amassa l'lngresso di LATCH di ICZ (vedi piadlnoS) epertanto gli Impulsi relativi a tale comando. prove-nienti dal piedino di uscita 2 di lCS/F. non potrannopiù giungere al lrequenzlmetro, quindi il numeroche appare sui display, rimarrà hloccato. Soloquando il condensatore C16 si sara completamen-te caricato. sul piedino dl uscita 4 dl ICS/D. risulte-rà presente un livello logico 1 ed il diodo DSG.polarizzato inversamente. non potra più iorzare amassa I'ingresso dl LATCH (vedi piedino 5 dl lC2):conseguentemente gli impulsi nel trattempo con-teggiati potranno giungere sul display.
Pertanto. se nella versione "economica" la velo-cita di lettura era vincolata a 3 letture al secondocon una precisione di +/- 100gIri. In questo con-tagiri a PLL. la potremo variare. ruotando il trimmerR19, da un minimo di 3 ad url massimo di 10 lettureal secondo con una precisione dl +/- 10 girl.
Per quanto riguarda le due tensioni di alimenta›zione necessarie al circuito. cioè la tensione a 5volt per II lrequenzimetro ed l display. e la tensionea 9.1 volt per tutto Il resto del circuito abbiamoutilizzato. anche in questo contagiri. un integratostabilizzatore tipo ùAJoOS. (vedi IC1). In grado dilomire l 5 volt richiesti con una corrente massimadi 500 rnA (l'assorbimento dell'integrato 746928 edei display non supera i 120 mA), mentre per i 9.1volt. un semplice diodo zener da 9.1 volt lndlcatonello schema elettrico con la sigla Dll.
ll diodo al silicio tipo 1N.4007. siglato D51. postoin serie al positivo di alimentazione. serve perbloccare eventuali impulsi negativi presenti sullatensione di alimentazione a 12 volt dell'auto.
Inline. l'impedenza JAF1 ed il condensatore C1,collegati in serie all'ingresso dell'integrato stabi-lizzatore lCi. servono a bloccare il ritorno. sullaIineadl alimentazione. della frequenza di multlple›xar generata da ICZ. Tale segnale intatti. potrebbeinlluenzare ll VCO contenuto all'lnterno dl IC4.creando disturbi nell'aggancio del PLL.
REALIZZAZIONE PRATICAAnche per questo contagiri a PLL abbiamo pre-
visto due circuiti stampati doppia laccia. il piùgrande dei quali. necessario a ricevere tutti i com-ponenti del circuito. porta la sigla LX.698 e ll piùpiccolo. sul quale verranno inseriti l quattro dis-
61
Flg. 1 Schemapratico di mon-taggio dei conto-girl o PLi. e lotodel circuito bacocon gli innuiataironialmento lascheda del dle-PliY-
nu m2 i
m" lllSFllV
pley. porto le sigla LX.697. cioe lo stesso numero dlsigla utilizzato per il contagiri economico, in quan-to questo circuito serve ad entrambi l modelli.
Precisiemo subito che. risultando I due circuiti a“tori metallizzati". non dovrete collegare nessunapista sottostante con quelle superiori, in quanto lametallizzazione presente ell'interno di ogni torocollega già tre di loro tutte le piaie interessate;quindi le uniche operazioni da compiere sarannoquelle dl inserire i vari componenti nelle posizionirichieste e quelle dl seidarne i rispettivi terminaliV
Per quanto riguarda il montaggio dei display sulcircuito stampato LX<697. vl consigliamo di legge-re la realizzazione pratica relativa al progetto delcontagiri economico. soltermendovi. in particolarmodo. sul sistema da noi adottato per individuarel'eeetto verso di inserimento
Sul circuito stampato LX 598 potrete iniziare au-blto il montaggio. lnserendol cinque zoccoli per gliIntegratiA
Dopo gli zoccoli potrete inserire tutte le resi-stenze, e poichè i terminali di queste sono quasisempre ossidati. sarà bene pulirii con carta ameri-glia iine, dopodichè potrete saldarli, tenendo ilsaldatore appoggiato qualche secondo in più. perdare la possibilità ai disossidante di bruciare com-pletamente i residui di ossido che risultaseero an~core presenti.
Proseguendo. potrete montare tutti i diodi al eili-cio rispettando la polarità dei terminali. e come giaprecisato per ll contagiri economico. non risulteràdifficile individuare. tra gli altri. il diodo zener D21.
A questo punto potrete passare ai componenti didimensioni maggiori. cioè ai tre trimmer. ai con-densatori al poliestere. ai ceramici ed agli elettroli-ticl. controllando per questi ultlmi. che il tenninelepositivo risulti correttamente inserito sulla piatacontrassegnata con un +A
Sia neiio scheme elettrico che in quello pratico.troverete due condensatori siglati 622. e questoperchè le capacita variera a seconda del numero diclllndrl di cui dispone la vostra auto. e poiche nonesistono condensatori dotati della capacità richie-sta. ne dovrete necessariamente utilizzaredue. po-sti In parallelo. come qui sotto riportato:
e cilindri = dovrete inserire in eeie condensatoredl 0.22 IIIF2 cilindri = dovrete inserire due condensatori da0.22 mFlciilndtt = dovrete inaerire ill eeio condensatoreda 0.15 mF
Poichè la maggioranza delle euto aono a 4 cilin-dri. normalmente aerve una soia capacita da 0,2lrltomtered; quindi non dovrete inserire gli altricondensatori in eccedenza presenti nel kit. anchese nel circuito stampato esiste lo spazio apposito.
Dopo questa premessa. proseguirete nel mon-taggio inserendo i quattro transistor Tm - TFi2 -TFi3 - TR4. rivolgendo la parte piana del corpoverso destra (vedi schema pratico di tig. 7). quindii'lntegrato stabilizzatore iCl . coliocando Il lato me-telllcovereo i due condensatori elettrolitici 62 C4 einserendo vicino a questo. anche l'impedenza diAF siglata JAF 1. Per ultimo monierete il connetto-re maschio a 12 poli ripiegato a L. che vi servireperl'lnneato del circuito stampato dei display. siglatoLX.697.
Terminato il montaggio, controllerete con unalente d'ingrandimento che una goccia di stagnonon abbia cortocircuitato due piste. In particolarmodo eui terminali del connettore e degli zoccolidegli integrati. e. appurato che tutto risulta regola~re. potrete inserire negli zoccoli i cinque integrati.rispettando la posizione della tacca dl riterlmento(tutte rivolte verso l trimmer).
t. I connessioni degli integrati vtett detratto e det treneletor Dtm etato dei beeeo.Per le conneeeionl del dlepiay vedere a pag. 56-5166.NOTA : Net primi prototipi da not realizzati e eublto toiegretett per emeterere I tempi detempe. noterete sempre qualche lieve dltterenn riepetto allo echerna pratico.Ad eeempto. nella tig. 7 noterete una eota impedenza JAF1 anziche le due preeentt nettetoto, perche ln teu dl collaudo lt circuito e etato tecnicamente migliorato.
E 'I llpl'lllli
CD “JIM
Per il solo integrato NE.555. in sostituzionedellatacca di rlierimento` posta al centro del corpo. po-trete trovare invece una piccola "o" stampigllata inprossimità del piedino 1.
A questo punto non vi resterà che innestare ae-alerne i due circuiti stampati LX.696 e LX.697 elomire una tensionedi 12-13volt al circuito: senonsono stati commessi errori, vedrete subito accen-dersi tutti l quattro display sul numero 0.
Constetata questa condizione. potrete procede-re alla taratura del tretrimmer presenti sul circuitostampato.
cOLLAUDO E TMATURADapprima dovrete ruotare a meta corsa tutti l tre
trimmer; poi preleverete dal secondario di un qual-siasi trasformatore, una tensione alternata com-presa tra i 12 e 40 volt e la applicherete tra il termi-nale d'ingreaso (iilo che poi dovrete collegare allepuntine dello spinterogeno) e la massa dei circuito.
Come noto. questa tensione vi servire solo peravere una trequenu di 50 Hz, utile per tarare conestrema precisione le base di tempi del lrequenzi-metro. in modo da poter leggere il corrispondentenumero di giri del motore sui display.
Sapendo che la iormula per ricavare i'esatto nu-mero di giri motore in iunzione della irequenzadelle puntine e la seguente:
n10 :Flß:(0lllndri:2)
dovrete ruotare il trimmer R27 lino a tar appariresui display questo esatto numero:
1.500 per un motore a 4 cilindri8.000 per un motore a 2 cilindri1.000 per un motore a 0 cilindri
Se non riuscirete a lar apparire alcun numero.puo darsi che il trasiormatore da cui prelevate l 50Hz fornisca in uscita una tensione interiore a 12volt; questo lnconveniente lo risolverete immedia-tamente ruotando il trimmer della sensibilità d'in-grasso R11.
ln questo contagiri. a ditterenza di quello eco-nomico. esiste un terzo trimmer siglato R19 la cuitaratura a soggettive. In quanto modilica solo ilnumero di letture che il irequenzimetro esegue inun secondo.
Ruotandolo da un estremo all'altro. potrete otte-nere da un minimo di 3 letture al secondo. ad unmassimo di 101etture al secondo. perciotenendoloa meta corsa avrete circa 6 letture al secondo
Se preterirete vedere più terme le ciire delle de-cine dl giri, dovrete regolarlo in modo da otteneresolo 3 letture al secondo. se. invece. vi interesseràstabilire immediatamente se il numero di giri subi~sca della variazioni. lo regolerete per 10 letture alsecondo.
70
Tarata le base del tempi. potreteaubito collauda-re ll contagiri sulla vostra vettura collegandone ilillo negativo ad una qualsiasi masse dell'auto. ed ilillo positivo ad un qualsiasi punto dell'irnpianto.scegliendo possibilmente un iilo in cui questa ten-sione dei 12 volt venga a mancare togliendo lachiave di accensione.
Collegherete ora Il lilo "ingresso segnale" allepuntine dello spinterogeno. utilizzando un cavettoschermata, senza dimenticare di congiungere lacalza esterna alla massa del circuito stampato. Énecessario utilizzare per questo collegamento untllo schermate. onde evitare che questo cavettocapti impulsi spurii generati dalla candele o dalrale dei Iampeggiatori o delle trombe.
A questo punto, mettendo in moto la vostra auto.subito sui display apparirà l'esatto numero di giridel motore.
Onde evitare che sull'ingresso del contagirigiungano impulsi di ampiezza troppo elevata. ruo~terete con un cacciavite il trimmer R11 lino a tarsparire sui display il relativo numero. poi. lenta-mente. in senso inverso. lino a quando questo nonriapparira.
Anche per questo contagiri abbiamo realizzatoun piccolo mobile metallico. Inserendovi questoapparecchio. dovrete applicare sotto al circuito
- base delle rondelle distanziatrici (si possono utiliz-zare come spessori anche dei dadi), onde evitareche le piste dello stampato o qualche tilo dl unterminaletenuto eccessivamentelungo,venganoecontatto con il metallo del mobile.
Sulla parete lrontale di tale mobile inserireta Ilpiccolo ritaglio di plexiglass di color rosso. chepotrete lissare al mobile con delle piccole viti, op~pure incollare con cementatutto, (lacile da trovareln ogni mesticheria o cartoleria), sulla due squa-drette poste lateralmente ail'interno dei mobile.
COSTO DI REALIZZAZIONEll circuito base LX.688. completo di circuito
stampato. tutti gli integrati completi di zoccolo. itransistor. tutte le resistenze. i diodi. i condensatori(sia per 24-6 cilindri). il connettore maschio. ltrlmmerecc. (veditlg. 7). .... L. 44000
li circuito display LX.697 completo di circuitostampato. quattrodisplay LT.SUB/A ù il connet-torelemmin L. 13.000
Un mobile a a o a ricevere ques o contagiri,verniciato di nero completo di mascherina plexi-glass color rosso ................ ... .i.. 9.000
ll solo circuito stampato a lori metallizzati corn- .pletodiserigrafia LX.698.. ..L 7.000
ll solo circuito stampato a lorr metallizzati corn-pleto di serigretia LX.697 ........ L. 1.300
l prezzi sopraindicati, non lncludono ie speseper la spedizione postale.
E!Vado ad Hangar,all'anteprima dei prodotti “011,1
d'lvanmfdhnellatcullcadelllmimoflzhwl'lnwkmdallmiu'oclomnkapfilhmufluudkhcnlcheplùrneonflperblfrllhmntoedlmneulodlflu-dmleuun'llù'aflonåhlndoldhivlhnflinpuhluuflvlplrhvlnù'flmpnu.llpodnplmleJhnnm/lrvllinmmlfllaipinmflMW.«lamenta
Mercato_mondialeElettromca _Elettrotecnlca
Memkdl l7-mercoledì 24 and.
Hannover.mas
STUDICIOCHEHIUNFUTUROCEI'I'O!
Il nunvo corso per :Orflspondanza ISTO dlwerø :IIlclce e DIBIISIIOniIgELETTRONICA E IICIOELETTIO-NIC! 8 Il vìi Hiù di "i 95( Inumliin qufilß Impflfll ü mm'. dllllIlenica ai ogm.LO SUB 2! dllflßflu COHIBIIIOIIO UI!
'Il locossc llllimril;isucì100a p mmm-mi rendono la mmieun'lflucinanln
mamma lo :mmm al nuevo nuovocome ui am rwponumu a. u-quim una lemma". ucc- mcomma, una. 1 mmm. wu.DIIIiCI-:mama s ulcnoflsmßma L. mamma gn "imma pinmami ø le mmm pm Wu vedell'eleflronìcß mødêml Grlli! Il» `la Imcmeìeflwfllcl Lei SCODIi'I Ilucnica del mlcroumcesson'
UN METODO VIVOED EFFICÃCE!Fin dalla puma puma La. 5| -im-women' neu'mmmniu.PDI'. viflllcirl sublIo. spammin-ulmame. 'e nouøni annua namdopo naso. con il mami-l. m mrmmm .I com Lei cøumim. inmmm cnmnuumnme :mm-uma.mami ø mmm-mi olemonici; nu-minm a mnøa numenw :unum m-mquu!STA A LEI DECIDERE!Duulo nuovo conc rlonrmnuun animo mvesmhenlo per il suo Iu-Iuw llulflnile. A cønlirlnl dll _sw wccuw nullo studio oltwlInch. un clflilicìln Iinlll.
o seems” mmm 1| agli-mm n-w/m - m 'mm mn. e soloW ma. mmm-nam _ I. 1' aa-;punu a 1- “mmm-non- mm-nlm na' un. m al nua-a.
Mwmmøuuunnumummmm-mummia*umOomph quam mimo palco nmun Iulum dlt!
ISTITUTOSVIZZERO DITECNICA` LUINO
u magno :um mu-gnnmn w con.I ww a umana u mm 11 mm. una un. :1'Imma nu. wwe n nun-cum
______8452 A ~ 41 EYeI 0337530169
.nano n.00 a": nam'
_______Da compvla'e. “uguale e :penne m busu a.'~ ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICAvu s. mm u A :ml Lumo vASl', «slam mmm › m vlsmu: eumm. w mu u mu 1|-I m .mmm ~ I. pm. ma.. pv m non m sruulo e la :mu-IMnlllwflt COMPIE!! “I S!!`
|...4I.........I.....|'Nm Elll|...À.............. .|v.. NlI.....I..........| lllI|n||I||<II||››|||
Nei n. 98 di Nuova Elettronica abbiamo gia con-siderato come. utilizzando un semplice circuito. sipossano controllare e “selezionare” con i'oscilio-acopiotutti i tipi di diodi. sia al silicio che al germa-nio, ed ottenere inoltre, sullo scheme dell'oscilio-scopio. degli splendidi disegni grafici (le tigure diLissajous).
ll circuito che ora vi presentiamo serve a control-lare la DISTORSIONE di un qualsiasi amplificatoreo preamplificatore di BF, una misura che, normal-mente. viene eseguita con uno strumento chiama-to DISTORSIMETRO. _
Pur sapendo che tale strumento si può facilmen-te reperire, considerato il suo costo elevato ed sn-otie l'uso saltuario che se ne fa, pochi sono coloroche i'acquistano.
Chi possiede un oscilioscopio potra ora. e conmodica spesa. costruirsi questo semplicissimocircuito che gli consentire di stabilire la percentua-
le di distorsione di qualsiasi amplificatore o preamplificatore di BF. mono, stereo. Hi-Fi.
Prima di presentarvi questo nuovo accessorioper il vostro oscilioscopio, sara utile spiegare checosa significa "distorsione" per poter capire piùfacilmente come viene eseguita tale misura sul-l'ampllficatore.
CHE COS'È LA DISTORSIONE
Applicando sull'ingresso di un qualsiasi amplifi-catore o preamplificatore di BF, un segnale dl unadeterminata frequenza. la sola operazione che."teoricamente", tale apparato dovrebbe eseguire,sarebbe quella dl ripresentare sulla sua uscita iostesso segnale, notevolmente amplificato.
in realta, sull'uscita, tale segnale risulta sempreleggermente "diverso". In quanto, amplificandoio.vengono modificate non solo l'ampiezza ma anche
Sul numero precedente vi abbiamo spiegato come sia possibile con-trollare con l'osclllosooplo la polarlta e le caratteristiche di un diodo ecome ottenere le più strane ed Interessanti figure di Llssalous. Oggivogliamo proporvi un semplice accessorio che vl consentire dl con-trollare ia distorsione dl qualsiasi amplificatore Hl-Fi.
IIOSGILLOSGOPIO f
Flg.1 Se un amplificatore none perfetto, in uscita. oltre ellatreouenas fondamentale, pos-siamo trovare sovrapposte sn-che una lntlnlta dl frequenzeannonlchs che, riprodotte dal-i'eltoparfsnta. modificheranno,ll l“suono” originale. In questatlgura, abbiamo aooentuato sul-la frequenu fondamentale oue-sta tipo dl distorsione.
72
Flg. Z Un'allra distorsione fa-cilmente riscontrabile se la po-larizzazione dello stadio finaleIn classe AB non e ben tarata, ela cosiddetta distorsione d'ln-croolo, che sl presenta sull'o-scllloscoplo come un'onda"spezzata" al centro cioe sullagiunzione tra la aemlonda nega-tivaequeilaposltlva.oorneohla-ramente visibile In questa foto.
Flg. 3 Se l'onda anzichè esserespezzata al centro risulta “toss-ta" sulle due estremità, avremouna distorsione per saturazione.Questo tipo dl distorsione sipresenta quando l'emplazza deisegnale che applichiamo sul-I'lngnsso dl un qualsiasi pre-ampllficatore o finale dl BF, ri-sulta superiore el livelli massimiconsentiti.
IL .mi Www Un
la lorrna dell'onda. ed aggiunte delle armoniche.Le fedeltà di un amplificatore di BF, si verifica
misurando quale percentuale di frequenze indesi-derate è stata aggiunta a quella originale e che.rlprodotta dell'eltoparlante. produrrà un suono dl-verso dall'originale. La distorsione generata da unclrcuito amplificatore può essere suddlvlaa In tre"categorie" fondamenta":
- DISTORSIONE ARMONICA- DISTORSIONE DI INCROCIO- DISTORSIONE PER SATURAZIONE
Vediamo subito in che con consistono. nellapratica. tall distorsioni. anallzzandole seplrltl-mente:- BMW AI'IIIOI'IIQI -
Come lascia intuire il nome stesso, la distorsloneARMONICA si riferisce alla presenxa. nel segnaledi uscita. di frequenze armoniche. cloe di frequen-ze pari el doppio, al triplo. al quadrupla. o plù. dellafrequenza applicata in ingresso.
in LABBRATORIOFacciamo un esempio: applicando sull'ingresso
dl un qualsiasi amplificatore o preampliflcatoreuna frequenza dl 1.000 Hz. se questo fosse "perfet-to". in usclta dall'altopar'lentel dovremmo ascolte-re la stessa e sola frequenza di 1.000 Hz. notevol-mente amplificata.
Se l'amplificatore non e perfetto. In uscita. som-mute alla frequenze fondamentale. troveremoun'lnfinita dl "armoniche". che risultano multipledlquest'ultlma` cloè segnali di 2.000 Hz, 3.000 Hz`4.000 Hz, 5.000 Hz. ecc, come visibile In llg. 1.
In tale figura, per poter rendere più evidente Ilpresenza di queste armoniche. il difetto e statonotevolmente accentuato.
In realtà, se misuressimo la distorsione armonl-ca di questo segnale, rileveremmo valori sull'ordl-ne del 15% o 20%À
Ovviamente, più l'amplilicatore risulterà fedele.minoreserà l'ampiezza di tali frequenzearmonichee quindi dal nostro altoparlante uscirà un segnaleampllflcato di 1.000 Hz e non altre frequenze estra-nee al segnale applicato sull'ingreeso.
73
'EL'
Fig.. Settemeisttrieodsttlitmchsvlpsr-mettevi. utilizzando un oscilloeoopio. d misu-rsrl la percentuale di distorsione.
-Dtltonionedlncreeio-
Questo tipo dl distorsione si riscontra solltemen~te quando la "polarizzazione" dei transistor neglistadi di finali di potenza non è perfetta.
Infatti. nella coniigurazione circuitaie di un arn-plliicatore in classe AB. sono sempre presenti duetransistor dei quali uno è utilizzato per amplliicarela semionda positiva e l'altro, per amplificare lacorrispondente semionde negativa.
Poiche qualsiasi transistor inizia a condurre. epercio ad ampliiicare. solo quando ira la sue base ei'emettitore e presente una tensione superiore ai0.6 volt. occorre polarizzere le basi di questi flnalicorrettamente. In modo da eliminare questa "so~glia" dl conduzione.
Se cosi non tosse. iino a quando Il segnale diingresso non supererà l 0.6 volt. ali'usclte non ot-terrerno alcun segnale e percio l'onde slnusoldalerisulterebbe "spezzata" ai centro. come vedasi intig. 2.
-Dlstonlonldlslturmom-Ogni amplliicetore o preampllticatore di BF. V
presenta una sua particolare "sensibilità di ingres-so" e questo dato. sempre riportato nella dascrl›zione delle caratteristiche tecniche. indica il valoremassimo dell'ampiezza del segnale applicabile sul-l'ingresso. per ottenere in uscita la massime am-piezza senza alcuna distorsione.
Ad esempio. se un preempiiiicstore ha una sen-sibilità d'ingresso di 15 millivoit con un'emplezzlmassime di uscite lndistorta di 2.5 volt, applicando
74
ELENCO COMPONENTI 11.010
R1 : 22.000 ohm pot. lln.R2 : 41.000 ohm 1/4 vllllR3 : 10.000 Ohm 1/4 vrlltIl. : 10.000 ohm 1/4 vllflR5 : 01.000 ohm 1/4010"H0 : 15.000 ohm 1/4 waltR1 - 15.000 ohm 1/4 vlalt
15.000 ohm 1/4 vrstt15.000 ohm 1/4 vvilt
100 ohm 1/4 watt00.000 Ohm 1/4 "811
10 mF elettr. 35 volt02 : 470.000 pF poliestere63 : 10 mF elettr. 35 volt'Cl : 10.000 pF poliestereCS : 10.000 pF poliestere06 = 10.000 pF poliesterec1 = 10.000 pr pollameC0 1 mF poliestereIC1 TL002S Internmore
deviatore
Fig.5 Connessioni detriti-tegreto 11.002 vists da w-prs. Ls tacca di riierimentovisibile sulla parte sinistridel corpo I volte viene so-stituite ds un piccolo puntostampato in prossimità deipiedino n. 1.
a tale circuito un segnale di 30 millivolt. risultandoeccessive. la parte "eccedente" di questo segnale.verra drasticamente eliminata e l'onda sinusoidaleche potremo rilevare sull'usclta dei circuito. risul-terà "appiattita". come visibile In ligure 3A
Proprio per questo motivo. su quasi tutti i pre-ampliiicatori di BF troviamo degli ingressi "ausilia-ri" su cui risultano inseriti degli atlenuatori resistivicalcolati per differenti sensibilità.
Ii termine "distorsione". così come lo troviamonella descrizione delle note tecniche di qualunqueampliiicatoreo preampliiicatoredi BF. e sempre lasomma di tutti questi vari tipidi distorsione appenadescritti ed intatti. in diverse percentuali. tall ie-nomeni possono essere tutti contemporaneamen-te presenti
Foto del progetto ultimato. Facciamo pmlo che nel prototipi che lotogrliiame per larivista. non e riportata la stampa uflgrallcedel componenti. presente Invece nel clmiltlstampati dennltM.
Il valore in percentuale della distorsionee perciòun "parametro" strettamente legato alla qualita edalla resa iinale di un impianto di BF e descrive"numericamente" l'accuratezza con cui e statostudiato il progetto. per renderlo il più “ledale”possibile.
Normalmente. un amplilicatore di BF può consi-derarsi Hi-Fi. quando la sua distorsione non supe-ra lo 0.05%. ma oggi si costruiscono amplliicatorlcon distorsione anche minore allo 0.01%.
Come tare a stabilire questa caratteristiche di unamplificatore. se non si dispone di un “dlatoraime-tro"7
La risposta e molto semplice: costruendo unFlLTFlO molto efficiente che elimini TOTALMEN-TE del segnale ampliiicato la frequenza londamon-tale. ln questo modo. tutto cio che risulterà ancorapresente in uscita sara solo a semplicemente cioeche l'arnplilìcatore ha aggiunto a tale segnale, cioela distorsione.
Su questo principio si basa il lunzionamento ditutti l distorsimetri proleaslonall od anche di quellomolto più semplice. che ora vl presentiamo.
SCHEMA ELETTRICO
Parlando dl liltri molto elficienti in grado di esclu-dere da un segnale amplilicato la lrequenza ion-damentale. tutti immaginerannodi trovarsi di iron-te ad uno schema elettrico molto complesso. conun'inlinita di integrati o transistor e quindi, osser-vando lo scheme di iig. 2 ci si domandera subitocome. con un circuito cosi semplice. costituito daun solo integrato TL.002. alcuni condensatori epoche resistenze. si possa conseguire lo stessorisultato.
A costruzione ultimata. collaudando questopregano potrete subito rendervi conto di comeanche con un circuito cosi semplice sl possa misu-rare con assoluta precisione le distorsione di qual-siasi amplificatore di BF.
lnizieremo la descrizione di questo circuito dì-cendo subito che abbiamo utilizzato il primo ope-razionale. siglato lC1/A. solo ed esclusivamentecome stadio separatore per rendere insensibile illiltro a "doppio T" ai diversi “carichi”. che verrannoapplicati al suo ingresso e che potrebbero modifi-care la caratteristiche di selettività.
Così lacendo. potrete applicare sull'ingresso delcircuito il segnale prelevato da qualsiasi preampll-ticatore. la cul Impedenza potrebbe risultare da47.000 oppure 10.000 ohm ed anche 600 ohm. co-me anche un qualsiasi llnale. con impedenza va-riabile da un minimo di 2 ohm ad un massimo di 16ohm.
La condizione ideale. per ottenere da un qualsia-si tlitro una attenuazione costante ed una lrequen-za dl taglio stabile. e proprio quella di presentaresul suo ingresso una impedenza costante di valoremolto basse. (250 ohm circa). e di caricarlo in usci-ta con una impedenza di carico notevolmente ele-vata. superiore ai 10 megaohm. Ed iniatti. il secon-do operazionale presente nel circuito. siglatolCi /B, viene utilizzato come "carico di uscita".perche presenta un'impedenza di circa 100 mega-ohm. i
Poichè oltre all'impedenza. anche l`ampiezza delsegnale applicato in ingresso può variare notevol-mente a seconde che venga prelevato da un pre-ampllticatore o da uno stadio tinalo. abbiamo pre-
75
disposto un potenziometro. (vedl H1)A per regolarela sensibilità.
ll flltro a doppio T necessario ad eliminare lafrequenza fondamentale. e costituito dalle resi-stenze R6 - R7 - R8 - R9 e dai condensatori C4 - 05-CS - C7.
Con i valori da nel riportati. questo filtro si ac-corda sulla frequenza di circa 1.061 Hz, con unaattenuazione di 55 dB. cioè questa frequenza vieneattenuata in tensione di ben 562 volte.
Come potrete notare osservando la lista deicomponenti. tutti i condensatori risultano da10.000 pF e tutte le resistenze da 15.000 ohm. que-sto perchè un filtro a "doppio T". per poter funzio-nare correttamente, deve essere realizzato in mo-do che il valore delle due resistenze poste in serieal segnale, (vedi Rôed R7). sia esattamente ugualeal doppio del valore della resistenza collegata amassa sull'altro lato del liltro. (vedi R8 ed R9). edanalogamente. per i condensatori, ìl valore dei duecondensatori posti in serie al segnale` (vedl 06 e(37)` deve risultare esattamente la meta del valoredei condensatore collegato a massa sull'altro latodel llltro. (vedi 04 e 05).
Utilizzando delle resistenze e dei condensatoridl valore standard. collegando" In parallelo ed inserie, si otterrà automaticamente tale rapportosenza dover necessariamente impiegare dei com-ponenti dl precisione che risultano. owiarnente. didifficile reperibilità: infatti. sarebbe alquanto pro-blematico ricercare delle resistenze da 7.500 ohm edei condensatorl da 5.000 pF.
Questa soluzione inoltre. presenta un altro van-taggio, infatti. volendo modificare la frequenza ditaglio del flltro, sarà sufficiente calcolare Il valoredl Il e C0. e utilizzare poi lo stesso valore perRT -R8- R9eperC7-C4-05.
Pertanto. chi volesse realizzare un liltro tarato sudl una frequenza diversa dai 1.061 Hz. da nel pre-scelta. potra farlo utilizzando la semplice formula:
Hz : 1.0N.000 : (0,20 a Kohm l nF)
Kettm : equivale a Kllolun. Se avete delle resi-stenze espresse in ohm le dovrete divi-dere per 1.000. ad esempio:33.000 ohm : 33.00011 .000 : 30 Kflohn
equivale a nanefarad. Se avete delle ca-pacita espresse in picofarad sarà suttl-clente dividere il valore per 1.000. adesempio:12.000 pF : 1m1.0m :12 nF
Nel nostro esempio. avendo utilizzato per le resi-stenze ll valore di 15.000 ohm. pari e 15 Konm. e pericondensatorl Il valore dl10.000 pF, pari a 10nF. lafrequenza di taglio del flltro risulta la seguente:
1.M.m:(0,20 115 l10):1.ß1,51 HI
76
Considerando la tolleranza dei componenti,possiamo affermare che il filtro lavora sui 1.000 Hzcirca.
Coloro che volessero realizzare questo filtro suuna diversa frequenza. conoscendo il valore deicondensatori o delle resistenze. potranno servirsidi una delle seguenti formule:
Kilohm : 1.000.000 : (0.20 l nF x Hz)nanofarad : 1.000.m0 : (0,20 x Kohm x Hz)
Ad esempio, per realizzare un flltro a 100 H2.utilizzando per tale circuito dei condensatori da41.000 pF. potrete subito stabilire qual è Il valoredelle resistenze da applicare in tale filtro, Infatti:
1.M0.000 : (0,20 l 41 i 1M) : 33,01 KIIONII
Owiamente. in questo caso, potrete utilizzareper ie resistenze. il valore standard di 00 Kllohm e.cosi facendo. la frequenza del filtro risulterà inteoria dl:
mmoooqua :41 x ss) = tozeeuxCome abbiamo precisato. il valore ottenuto e
teorico. In quanto non dovrete dimenticare cñe leresistenzaed i condensatori hanno una certa tolle-ranza che. inevitabilmente. modifica. In pratica. llnostro calcolo.
Flg. I Disegno a grandezza natura-le del circuito stampato alqletoLX.010. necessario per la nellzza-zione dl questo flltro, con ll qualepotrete misurare I'entlta della dialer'alone su quafslaal amplificatore epmmpirfleatm ai aF.
Asaegnando alla resistenze un determinatovalo-re, ad esempio 10.000 ohm (pari a 10 Kohai) evolendo realizzare un iiltro per una frequenza di5.000 Hz. utilizzando la seconda iormule prece-dentemente riportata. potrete ricavare la capacitada assegnare ai condensatori:
"mmm ¦ (0,2. I 10 l im) : 3,10 nlnehl'ltl
Anche In questo caso ll risultato ottenuto con laiormule non e un valore standard, percio, volendoutilizzare dei condensatori normalmente reperibili,sl dovrà impiegare un valore di 3.300 pF (pari a 3,3nanoiarad) ed iI iiltre rleulterà taratosulla frequen-za teorica:
1M.m¦(l,2.l1°l3,3) :4325":
Proseguiamo ora nella descrizione del nostroschema elettrico dicendo che Il secondo operazio-nale lCt/B collegato in uscita. come gla vl abbiamoaccennato. serve per avere una impedenza di cari-co molto elevate. nel nostro caso sul 100 megohmcirca.
Sull'uscita di questo operazionale. preleveretepoi il segnale da applicare suli'tngreaeo verticale.dell'oeciiloscopio. come verra spiegato dettaglia-tamente nel capitolo l'misura della distorsione".
il deviatore St , applicato su tale uscita. serviràper valutare l'amplezza del segnale tondamentale.
mentre spostandolo eull'uscita del tiltro. potretevalutare l'ampiezza delle frequenze armoniche:pertanto. con questi due dati. rlcaverete subito lapercentuale di distorsione.
Tutto il circuito dovra essereallmentato con unatensione stabilizzata che puo variareda un minimodi 12 volt ad un massimo di 30 volt.
Poichè il consumo di questocircuito ai aggira sui4-5 mllllamper. potrete anche utilizzare a tal line,due nonnall pile radio da 9 volt, coltegandoie Inserie, in modo da ottenere una tensione di 'le volt.
REALIZZAZIONE PRATICAConsiderata la semplicità di tale realizzazione.
gia Il solo disegno dei circuito pratico riportato inilg. 1 potrebbe risultare suificiente per ll montag-glo; riteniamo comunque che qualche altro conal-glio possa essere utile ai lettori meno esperti, perevitare banali errori.
Sul circuito stampato LX.676. monterete comeprirno componente lo zoccolo per l'integrato e,successivamente. tutte le resistenze ed I conden-salori4
Perle resistenzedelilltroadopploT,cioe quellesiglateda R6a R9. se non aoqulsterete il nostro Kit,consigliamo di eceglierie con tolleranza minimadei 5%, mentre per l condensatori (vedi da CA aC1). risultando dliflclle reperime con coel buea
Fig.1 mpnflwdlmmwmneeedeteegnaledßfedanoinperruedtadaifoeelloeoopieebenautillmdelcevelbecherma-mperevitaredcaptan renaiodtaiternata.
17
r - Flg. I Por Inliurlrc Il dlmnlone d un qulklul ammo Hl-Fl. olm lll'olello-† mphòmoflufløpouodmungummndlìficumnbbllnølm
nal'lmeoloJ-pflmloporuhmdnwnpknmquohdcontrdhnllmmddngndflorflbhuaelhdalmnlrogommonßh
' i H9., VolondooonhollanudmlomdlmmlflalmHLHJMmmll-. mmruudhddpmnmflflumocmddroudwmpol_< _ Wormphznddugmhlnhmlnmododnmnnhmn,mmo
J ` fidblchflçllllonmdøll'ondllhuwldlh.
. Flg. 10 Volmdo lnvcc' controllare la mmm dl uno Mo flmlødl polini.- " ' potnmo pnhvuu Il ugual. dlnmnunhsul duo IIII d'uldh pu In manuale..
Ricomìovl ch. la dmnlom dl una nhdlo Ilmlo nonnalmlnh vhmeommlllhad' -V › mdlpmmperlnnllsø'hflqudlnmmm
tolleranza. sara suiticiente sceglierll con tolleranzadel 10%.
Di questa tolleranze non dovrete comunquepreoccuparVi. perche. anche se il filtro risulteràtareto a 999 Hz oppure a 1.100 Hz. potrete ugual-mente misurare con identica precisione la dlatonsione di qualsiasi amplificatore o preemialilicatore4
Se non racchiuderete tutto il circuito entro unpiccolo mobile metallico. non dovrete dimenticaredi collegare la carcassa del potenziometro d'in-grasso R1 alla massa del circuito. utilizzando unospezzone di illo di rame lsolato In plasticaÀ
Quando inserirete l'lntegrato TL.082 nello zoc-colo. dovrete controllare che il lato in cui risultapresente il piccolo punto in prossimità del piedino1. risulti rivolto come visibile nello schema praticoai tig. 1.
Dopo aver Innestato a tondo i'integrato nellozoccolo. controllerete che tutti i piedini risultinoinseriti correttamente nello zoccolo. Infatti. a volte.troviamo delle riparazioni il cui solo diletto è unpiedino ripiegato sotto al corpo o addirittura iuoridalla sue sede.
Inline quando collegherete la pile sui terminali+ e -. dovrete lare attenzione a non lnvertira lapolenta. perche. cosi facendo. l'integrato TL.082diventerà un TL.00. equivalente ad un WC.00. esapendo cosa eignilica questa sigla. sarà megliosostituirlo.
'MISURA DELLA DISTORSIONEPer misurare le distorsione di un qualsiasi appa-
rato Hi-Fi. occorre. oltre ail'oscillosoopio. ancheun generatore di BF in grado di iomire in uscitaun'onde slnusoidaie.
Una volta in possesso di questi due strumenti.oollegherete I'uscita del generatore BF sull'ingressodel circuito e I'uscita di questo eull'lngressovertlcaledeil'oscllloscopio. come vedasi in figura. B.
Fer ottenere delle misure molto precise. e ne-cessario che il segnale di BF tomlto dal nostrogeneratore non risulti interiore a 2 volt. (valorepicco-picco). nè maggiore di 10 volt.
Alimentando ll circuito. dovrete spostare ll de-viatore SZ sulla posizione distorsione. quindi. do-po aver regolato la sintonia del generatore dl BFsui 1.500 Hz circa. ruoterete la manopole del TIME/-DIV dell'oscilloscopio fino a tar apparire sulloschermo 8-10 sinusoidi, (il numero non ha alcunaimportanza). poi regolerete il potenziometro R1. inmodo da ottenere un segnale con un'ampiezzamassime di 8 - 9 volt.
A questo punto ruoterete le sintonia del genera-tore di BF scendendo da 1.500 Hz verso 1.000 Hz equando la lrequenza del generatore sarà identica aquella su cui risulta tarato Il illtro presente nelnostro circuito. vedrete ie slnusoidl attenuanl bru-scamente, tanto che dovrete agire sulla manopola
Flg. 11 Dopo aver spostato lldeviatore SZ in posizione “dietet-slone" ruotate la elntonla dei grneraton di BF ilno ad ott-nerosullo schermo ddroacilioaeoplola rnlnirna ampiena del aegndo.
Flg. 12 Centrando con ll geno-ratora dl BF la lrequenza del 'Il`tro, lara necessario aumentarela sensibilità dell'oeclllooooplo.passando da 1 volt/divisione e20 - 10 mllllvolt/dlvlsione.
Flg. 13 Preso nota dell'am-ploxza del segnale spurlo. ripor-MI Il lonllbllltl ddl'øldllo-:copio lu 1 volt/divisione, polspostate il deviatore SZ In “call-brazlone" e leggete ll valere del-l'amploxza della tondamentale.
q. 14 Se, regolando la ira-quenza del generatore dl BF, llminimo segnale che riuscite adottenere e una riga molto plana,come visibile In tura, significache sul vostro apparato sonopresenti una lnllnlta dl armoni-che. oppure che queet'ultlrno rl-aulta molto numeroso.
Flg. 15 La lorrna d'onda chevedete qui sopra riportata e lapiù comune, perchè cio che ap-pare sono tutto le lrequenxa ar-moniche che rtlultano presentisulla londamentale. Minore rl-aultera la percentuale dl questoarmoniche, maggiore sara la te-detta dl riproduzione.
della sensibilità d'lngresso dell'oscllloacopio pas-sando da 1 volt/divisione a valori Interiori, cioe 0.5 -0.1 volt/divisione. per poter vedere ancora sulloschermo un segnale di BF (vedi tig. 12).
Fatto questo. ruoterete lentamente e di pochiHertz. la sintonia del generatore di BF lino ad otte-nere sullo schermo la minima amplexu possibile.
Ottenuta questa condizione. dovrete misurarel'ampiezza di tale segnale che` ad esempio, po-trebbe risultare di 10 millivolt.
SENZA PIU MUOVERE le sintonia del generato-re di BF. sposterete ore il deviatore 52 dalla posi-zione "distorsione" alla posizione calibrazioneV
Cosi lacendo. dovrete necessariamente ruotarele sensibilità d'ingresso verticale dell'oscilloscopìosu valori più elevati. ad esempio 1 o 2 volt/divisio›ne. e potrete cosi controllare l'emplezza massimadel segnale
Ammettendo ad esempio. che questo risulti di 5volt` avendo a disposizione sia il valore dell'em-piazza dei eegnalemuelrno. che di quello rnlnlmo.utilizzando la lormula qui sotto riportata, potretesubito conoscere le percentuale della distorsione:
0% = (millivoltmlnlmozvottmasalrne):10
quindi avremo:
(10:5):10 = 0.2%Pertanto. il generatore di BF da nol preso come
esempio. presenta gia una distorsione dello 0.2%.che. owiamente. dovrete tener presente quandoeffettuerete le misure sui preamplliicatorl o llnall dipotenza.
80
NOTA - Abbiamo volutamente semplltlcato la tor-mula sopra riportata, per rendere più spedito Iicalcolo: in pratica si sarebbero dovuti convertireivolt del segnale massimo. in millivolt e poi moltipli-care Il tutto x100.cioè:
(1°:5.000)l100 :0,2
Occorrera sempre ricordare, prima dl controlla-re la distorsione di un preamplliicetore o stadiofinale di potenza. di stabilire la percentuale di distor-sione del generatore di BF, perche questo valoreandrà poi necessariamente "sottratto" ai valore to-tale deila distorsione che in seguito riieverete.
Sapendo che il nostro generatore di BF disponedi una distorsione dello 0.2%, volendo controllarele caratteristiche del preamplitlcatore, che da pocoabbiamo realizzato. procederete come segue:
1 - collegherete sull'ingresso del preamplilicatoreil segnale di 1.000 Hz del vostro generatore di BF.dopo averne regolato I'amplaza in uscita In mododa non saturare gli stadi d'ingresso.
Ammettendo che tale preampliiicatore richiedaun segnale massimo d'ingresso di 2 millivolt. ov-viamente carcherete di applicare suli'ìngresso unsegnale dl1,6 -1,8 millivolt.
2 - prima di applicare In uscita II misuratore dldistorsione. controllerete con l'osciiiosoopio che lisegnale presente sull'uscita del preamplitlcatorerisulti periettamentesinusoidale e non come visibi-le in lig. 3.
Occorrera sempre attenuare questo controllo.
Flg. 16 Se sulle schermo nole-te una tonno d'onda con del plc-chl molto accentuatl, come ve-deal in questa loto llgnltica chel'arnplezza applica a sull'ln-greeeo e troppo elevata. quindi llsegnale llnusoldale prelevate lnuscita risulta telato come pete-te osservare In tig. 3.
Al.
Flg. 17 Se ponendo la sensibi-lità dell'olcilleecople aul 10 - 20mV/divlllone. II segnale ll pre-eanta come In questa toto, el'll-tica che la calze dl un cavettoschermate non risulta collegataarnaeeaequlndlll pnamplltlca-tore o ll dlatorslrnetro capi. delrendo dl alternata a 50 Hz.
perchè puo accadere. per aver mel regolato la ma-nopole di uscita del generatore o per un errorenella lettura della scala graduata dell'attenuatoredi uscita. di applicare 16 - 15 miliivoit, anziche 1.64.8 millivolt.3 - A questo punto potrete collegare sull'uscita delpreamplllicatore il nostro circuito con il deviatoreSZ posto in posizione "distorsione".4 - Ruotando leggermente la manopola di sintoniadel generatore da 990 a 1100 Hz. dovrete cercaredlottenere sullo schermo dell'oscilloecopio un ee-gnale la cui ampiezza risulti minima.5 - Ammettendo per ipotesi che si riesca ed ottene-re un segnale minimo di 15 millivolt. sposterete ildeviatore SZ sulla posizione calibrazione e lq*rete il valore dell'empiezze massima. Per potercompletare il nostro esempio. supponiamo chel'ampiezza di tale segnale risulti di 4 volt.6- Con la lormula che già conosciamo. potrete oracalcolare la percentuale della distorsione. che ri-sulterà. con i numeri riportati nel nostro esempio.pari a:(12:4):10 = 0.11.7 - Da tele percentuale. dobbiamo ora sottrarre ladistorsione del generatore di BF che. come giosappiamo. risulta dello 0,2%, quindi avremo:
0.3 - 0,2 : 0,1%Pertanto la distorsione l'reale" del nostro pre-
smpiilicatore. risulterà pari allo 0,1% e non allo0.3%.
Giunti a questo punto. e necessario tare una
piccola precisazione: poiche questo filtro a doppiaT dispone di una attenuazione dl soli 55 dB. ilpercentuale totale di distorsione ricavata dallalormulev risulterà sempre leggermente superiorealla realtà . in quanto una piccola parte del segnalefondamentale sara sempre presente ali'uscita deliiltro.
Perciò nel nostro esempio. diremo che le distor-sione misurata e interiore allo 0,1%.
Non e possibile. come qualcuno potrebbe pen-sare, collegare due filtri in serie, perche. a causadelle immancabili tolleranze dei componenti, unodi questi potrebbe risultare accordato su 1.030 Hze i'eitro su 999 Hz. quindi la misure che ricavorem-mo avrebbe un "errore" superiore a quello cheotterremmo utilizzando un solo filtro.
Con questo semplice accessorio senza doveracquistare un costoso DlSTORSlMETFlO. da oggipotrete quindi controllare con il vostro oscillosoo-plo le caratteristiche di qualsiasi Impianto Hl-Fl.
COSTO DI REALIZZAZIONETutto il necessario per le realizzazione di questo
progetto. cioe circuito stampato LX.676. integraton.082 più zoccolo. condensatori poliesteri minia-ture, resistenze. i due deviatorl a levetta. un poten-ziometro e lilo schermato ...... L. 10.500
llsolo circuitostampato LX.676 L. 1.100Nel prezzo non sono incluse ie spese postali di
spedizione a domicilio.
81
Anche se il VIC.20 dà la possibilità di entrare inpossesso di un computer con una modica spesa.ben presto ci si accorge delle sue limitazioni. iniet-ti. essendo un computer"didattico". serve soltantoa chl. digiuno dl informatica. vuole imparare leistruzioni del linguaggio Basic. ma. non appena sicerca di sviluppare programmi anche di poco piùcomplessi dl quelli riportati come esempio sul ma~nuale. subito il computer va In "tilt" per mancanzadi memoria e. a questo punto. non rimane altrasoluzione che abbandonare l'lmpresa. oppure car-care di venderlo per acquistare un 064.
Facendo questo. dovremmo owiamente rasse-gnarci a "perdere" una certa somma. perchè l'usa-to ci verra subito deprazzato e. poiche questa solu-zione non e certo piacevole, vi spieghiamo oracome sia possibile. con una modica spesa, dupli-care o quadruplicare I'area dl memoria di unVIC.20, e. seciò non bastasse. anche sestuplicarla.cioè passare dagli attuali 3 K a 6 K. oppure a 11 K oa 19 K.
In questo modo. senzasostituire il vostroC.20.avrete a disposizione un computer più "potente".che vi permetterà di sviluppare qualsiasi maxi-programma e di utilizzare tutte quelle cassette per igiochi. che richiedono una maggiore capacità dimemoria.
La realizzazione pratica di questa schede. comepotrete constatare. è molto semplice. per cui. una
volta montata ed inserita nel computer. funzioneràimmediatamente. salvo che non abbiate commes-so qualche grossolano errore. ma anche di questonon dovrete preoccuparvl. perchè il nostro labora-torio è sempre a vostra disposizione per controlla-re la scheda e restituirvela perfettamente lunzlo-nante e. owiamente. questo e una garanzia pertutti coloro che affrontano per la prima volta llmontaggio pratico di un circuito elettronico.
SCHEMA ELETTRICO
In questo circuito. il cui schema elettricoè ripor›tato in fig. 1, abbiamo utilizzato una nuova memo-ria RAM STATICA C/MOS. da 8 Kilobyte. tipoHM6264. che, durante le prove eseguite nel nostrolaboratorio. si e dimostrata la più valida in assolutoper lo scopo che volevamo raggiungere.
Inlatti. per verificare le caratteristiche di questicomponenti. abbiamo messo a confronto questotipo di circuito con altri progetti che gia preceden-temente avevamo approntato. utilizzando sia altritipi di RAM STATICHE. owiamente con più bassacapacità di memoria. sia delle RAM DlNAMICHEÀ
Utilizzando delle normali RAM STATICHE;-perottenere la stessa capacita di memoria. risultavanecessario inserire nel circuito 8 memorie e. cosifacendo. ci siamo subito accorti che il consumototale del circuito risultava troppo elevato per I'a-
Foto dalla acheda dl mamo-ria pu vic.zu. su que-uscheda abbiamo lnurltoanche un pulsante dl “re-aet" (vedi a alnlatra lopral'lnloqrato `HLSlll). nonpresente nel computerCommodore. Nel kit e lnae-rita UNA SOLA RAM ItalicaHILGW e, chl lo decidere,potra rlcevara la seconda aparte.
Chl acquista un VIC.20 al accorgerà subito, che coni 3 K dl memoriedl cul uso dispone si la poca cose. Per eumenterll, sera sulflclentelnnestere sul retro del computer questa noltre schede supplementaree, immediatamente, sl avranno e disposizione 6 - 1 1 - 19 K dl memorie.
“_ '_U ._g“““_g_ _ r;Ouula schede. come vedul ln quale toto, en-oralmente nel connettore proeenb internamen-te sul lato elnlatro dei computer.
Iimentatore del VIC,20. (circa 350 milliamper), che`come ci è già accaduto di consistere. non e ingrado di sostenere ulteriori carichi
Utilizzando invece delle RAM DINAMICHE, an-che se queste presentano un consumo di correntemolto interiore` per utilizzare tali memorie era ne-cessario aggiungere degli integrati TTL e. nuove-mente. iI consumo totale tornava a livelli quasi ane-loghi e quelli delle RAM STATICHE.
lmpiegendo invece una o due memorie STATI-CHE C/MOS. tipo HM.6264. l'essorbimento di cor-rente si riduce in totalee circa 20 mA, una correnteIrrisoria che I'alirnentelore in pratica non ewertirå.
Detto questo, passiamo alla descrizione vera epropria del circuito dicendo subito, che tutti i nu-meri e le lettere, riportati sui due lati esterni delloschema elettrico. sono riferiti alla piedìnatura delconnettore del computer. sul quale andrà innesta-ta la scheda di espansione.
Anche se i numeri riportati sulla sinistra del disegno
non risultano disposti in ordine crescente da 1 a 22,sul lato superiore dello stampato le piste risulte-ranno in ordine progressivoe lo stessodicasi perlelettere, riportate sulla destra dello schema elettri›co, che ritroveremo in ordine aliabetico dellaAalleZ. sul lato Interiore dello stesso stampatoV
Tramite questo connettore e doppia taccie. ven-gono prelevati tutti i segnali necessari el circuito.cioè:
- gli otto segnali relativi ei DATI, (vedi i terminalinumerati del 2 al 9. sulla sinistra dello schemaelettrico);- le tredici connessioni relative agli lNDlRIZZl (ve-di i terminali contraddistinti delle lettere dalla Balla Fl. sulla destra dello schema elettrico):- í segnali per I'lndlrlzzlmento della schede lcon-nessioni10,12,14.15,16e11);- il segnale per il comando di scrittura o di letturadei detl (vedi la connessione 18);
83
..N
om
au
nu
mi lemmdollnmumflnocanna-Ion! dodl lnh'lll vlall dlfi'dlø.
“315
JELENCO COMPONENTI LX.700R1 : 3.300 ohm 1/4 Il!! l¬R2 : 3.300 0hm1/4 WI" TR3 : 22.000 ohm 1/4 'mi .C1 : 10 mF elenr. 16 voli [fca = 100.000 pF pollon-n ICS : 100.000 pF pollnlmC4 : 100.000 pF pollini!!ß : 100.000 pF pollon."CG : 100.000 pF90lIC1 : SNHLSOUICZ : HM8264ICS : "MWS1 : ponllclllo82 : ponticello
` NMSZH SN14l$lll P1 : pulumo
If"-¬ Tg: Www.- 'Ewa-*z* fa???li
- leconneeeioni perl'ailmentelione. cioela lune.tramite i contatti 1 e22ed AeZ. ed Il poeltivoa!'di 1ramite il contatto 21.
Su tale scheda. come vedremo anche nella de-ecrizione dalla realizzazione pratica. al poeeonoineerlre indifferentemente una o due memoria ad.ovviamente, a seconda dei casi. el otterranno delleeepaneionl di dlflerente capacità totale.
Anche l'lndlrizzamento della scheda all'lntemodell'area di memoria del computer può eeeere ve-riata ela programmazione di tale Indirizzo, nei n0-stro circuito, awiene tremite due porte nand (vedilC1/A ed IC1/B) ed i due ponticelli che. neiloecheme elettrico di iig. 1. sono siglati Sl per iamemoria ICZ ed S2 per la memoria lCS.
Vediamo subito. nelle pratica. come program-mare l'indirizzamento della memorie e leoondedalla capacita totale che el vuole ottenere con telaacheda di espansione.
Per maggior chiarezza. abbiamo riportato in iiq. 2ia "mappa di memoria" dei VIC.20 dove sono benevidenti gli I blocchi da 8 Kiiobyte ciascuno. (vedida BLKO a BLKT), nei quali risulta suddivisa l'areedi memoria all'lnterno dl tale computer.
Supponiamo dl inserire un solo Integrato tipoHM.6264 a di montarlo nello zoccolo corrispon-dente ad lC2; coei facendo. a seconda della poei-zione au cui viene cortocircuiiato il ponticello 81,avremo:
In questo modo ai aggiungono al computer IKliobyte di memoria. che vengono posti all'intemodei blocco da 8 Kilobyte indicato con la sigla lLlfl.Pertanto. essendo gia presenti 3 Kiiobytedi memo-ria RAM all'lntemo del VIC.20. avremo a diaposi-zlone un totale di l + 3 = 11Kiloby1e di memoriae. all'accenelone del computer, con la echeda'coallndlrlzzata. noli'inteetazionedi Inizio sare preeenteia acritta:“mmmcioe, 11.775 celle dl memoria libere. a dlepoelzionedal programmatore.
in questa condizione. le memoria aggiuntivaviene posizionata all'lnterno dei blocco BLKS.mentre i due blocchi precedenti. cioe BLK1 eBLK2, rimangono inutilizzati. Il computer, in que-sto cano. all'atto deli'accensione. non riscontrarela presenza di tele memoria in quanto, per poterla"vedere". le espansioni devono essere poste dl se-guito una all'altra. partendo dal blocco 1. Tale areadl memoria aggiunta. rimane comunqueadlapoel-zione dei programmatore e può eeeere alruttetaper Immapazzinare dal dati, utillnando. ad eeem-
all
“Il
SIII
Fl'. I Disposizione dell'eree dlnumerladelvlcmlemnehoolo-re reppteaenleno le aree d memoriarieenele al computer mentre quellein chiaro iono diaponiblll per I'e-apeneione e tono le wie lndlrlmbllllrlnltel ponticelli S1 ed 82. Aoc-n10ed ogni blocco sono riporteli, auleelnlelre In dedmeieeeulledeelfl heeedeolmeiefllllndrldd Inizloedllnedognlblocoo.
plo. le istruzioni di POKE seguite dall'lndlrizzo dltali celle, che vanno. come vedesi in tig. 2. da24.576 a 32.767. vale a dire ad esempio:
POKE 24002 oppure POKE 30031 loc.Questo indirizzamento della memoria può anche
risultare utile quando si inseriscono delle cassettedl espansione per I giochi o llnguaggl da 16 kllotry-toluoprom. nel caso in cui questi ultimi richiedanouna ulteriore espansione dl memoria da posizlone-re, appunto, nell'area relativa a BLKS.
Sempre utilizzando una sola memoria. se lainse-riremo nello zoccolo indicato con ICS. (togliendoladallo zoccolo IC2). a seconda della posizione in cuirisulta inserito il ponticello SZ, avremo le seguentlconfigurazioni di memoria:_, A _. 1.,Mn_ , ,2a m
In questo modo si aggiungono al computer 3kllobyte di memoria, che verranno postl nelle trearee di memoria del prima blocco, (vedi BLKO).indicate in ligÀ 2 con le sigle RAM1-RAM2-RAM3.che sono le sole aree libere all'interno di questoprimo blocco.
Questa possibilita di indirizzamento. riempiendocompletamente la prima area di memoria, e utileper appllcazionl particolari. ad esempio per pro-grammi in linguaggio macchina. che utilizzano.per comodità o per esigenze di stesura del pro-gramma. tutte queste prime locazioni dell'area dimemoria del computer.
All'atto di accensione del computer. nell'inteata-zione apparirà la scritta:8650 Wta tra.cioè. saranno ore disponiblll 6.650 bytes llberl peril programmatore.
86
Fly. 8 Schema pratlco dlmontaggio. Sl noti ll condon-utm ci pato In punizioneorizzontale o l duo connettoriS1 -52 per programmare I'lndl-rino delle Ram.
In banco nulla della, Il scho-do completamente lnnutatanel suo connettore.
ma. m . ai;La memorie risulta così posizionata all'interno
del blocco 2. (vedi BLKZ). ed occupa perciòtutte lecelle di memoria dall'indirizzo 16.384 all'indirizzo24.5754 Tale espansione. non essendo posta subitodi seguito al blocco O, non sara "vista" dal Basicche. perciò. all'atto dell'accenaione, avrà disponi-bill i soli 3 Kilobyte già presenti all'interno delcomputer. Come abbiamo spiegato precedente-mente. tele espansione e pero utilizzabile sia permemorizzare dei dati. ad esempio con l'Istruzlonedi POKE. sla per aggiungere della memoria, quan-do si utilizzano delle cassette di espansione per delgiochi c dei linguaggi da I Kllohyto su eprom.
Passiamo ora alla seconde possibilità di espan-sione. utilizzando duelntegrltltipo HM.6264, postievidentemente nei due zoccoli relativi ad IOZ edlC3, per ottenere il massimodi espansione possibi-le. cioé 18 Kllobyte. Anche in questo caso. e se-conda di come verranno cortocircuitati i ponticelliS1 ed 82. si otterranno diversi Indirizzamenti dellaschede nell'area di memoria del computer e, per-ciò. descriviamo anche queste possibilita detta-gliatamente.
ln questo caso vengono occupati i blocchi Oed 1dell'area di memoria del computer. Il blocco 0 daràuna espanslone pari a 3 Kilobyte. ma essendo pre-sente Ia memoria anche nel blocco 1, ll computerinizialmente "leggerà" solo tale zona di memoria,fornendo percio gli 8 Kilobyte di questa area. più i 3Kllobyte gia presenti al suo interno. per un totale dl11 KllobyteA Le memoria posta nel blocco D. all'in-terno delle tre aree RAM1-RAM2›RAM3. sara
quindi disponibile per memorizzare dei datl o delprogrammi in linguaggio macchina poeti all'eeter-no della memoria dedicata al Basic.
E le configurazione di espansione massima dellamemoria. in quanto rende disponibile una espan-sione totale pari a 1G Kllobyte. Il computer sarainoltre in 'grado di "vedere" completamente telememoria in quantoe poste tutta di seguito a parti-re dal blocco 1 All atto dell'accensione del compu-ter. nell' intestazione apparirà la scritta:1m bym imvale a dire 19.967 bytes liberi a disposizione delprogrammatore.
È una configurazione di memoria poco utilizza-ta. in quanto vengono occupati i blocchi 1 e 3. percui. rimanendo inutilizzate il blocco centrale. cioèBLK2. al basic verra destinata soltanto la primamemoria. posta in BLK1. mentre la seconda puoessere utilizzata. per porvi dei programmi in lin-guaggio macchina. che siano al di fuori dell'area dimemoria dedicata al basic4
Analogamente alla configurazione di memoriaprecedente. anche questa non e molto utilizzata. inquanto vengono occupati if Blocco 0. (vedi le trearee RAM1-RAM2-RAM3). ed il blocco 2. per cui lamemoria disponibile per il Basic sarà soltanto laprima parte relativa afl'espansione del blocco 0.che. come gia abbiamo detto. darà una disponibili-tà totale di memoria di soli 6 Kltobyte. ›
La rimanente memoria dell'espansione, come dìconsueto. sarà comunque disponibile per memo-rizzare dei dati o dei programmi scritti in ilnguag`gio macchina e residenti al di fuori dell'area dimemoria dedicata al Basic.
Pertanto. le configurazioni consigliate sono leseguenti:
+ 11 Kllobyto = 1 sola memoria Inserita nellozoccolo ICZ e S1 cortocircultato su A:+ 19 Kllobytc : 2 memorie Inserite negli zoocollIC2 ed IC3. Sl cortocircuitato su A ed SZ. Invece.su B.
Terminiamo la descrizione dello schema elettri-co di fig. 1. osservando che. posto In basso e de-stra. e presente un pulsante collegato. tramite laresistenza R3 ed il condensatore 66. al terminale"X" del connettore di innesto
Abbiamo utilizzato questo pulsante per aggiun-gere al Vl 0.20 il comando di RESET. che non risul-ta presente su tale computer4 In questo modo. se. acausadi un errore nella stesura di un programme. ilcomputer si blocca e non risponde più a nessuncomando. sare sufficiente premere tale pulsanteper riattivarne il normale funzionamento senza ee-sere costretti, come normalmente avviene. a spe-gnere e riaccendere il computer. agendo sull'inter-ruttore generale.
REALIZZAZIONE PRATICA
ll circuito stampato da utilizzare per questaespansione dl memoria per VIC.20 porta la siglaLXJGJ. Poichè questo stampato è un doppia facciacon fori metallizzati. tutte le piste poste sulla faociainteriore risultano già elettricamente collegate conquelle soprastanti. mediante una metallizzazlonegalvanica presente all'interno di ogni foroA
Per questo motivo. non dovrete. come qualcunoinvece erroneamente fa. riempire di stagno tuttiquesti lori. perchè non serve a nulla. e nemmenocercare di allargarli con una punta da trapano.poiche. cosi facendo. si togliere lo strato di ramecollocato internamente.
Potrete iniziare il montaggio inserendo nellostampato i tre zoccoli. facendo attenzione. quandone stagnerete i piedini. a non provocare dei corti.
Dopo questi componenti potrete inserire le treresistenze. i quattro condensatori al poliestere eI'elettrolitico. collocandoquest'ultlmo In posizioneorizzontale. come vedesi in fig. :iA
Proseguendo nei montaggio. inserirete il pul-sanle P1 di Reset e l due connettori a tre tennlnali(vediSl-SZ ), che serviranno ad indirizzare. tramitele due prese di cortocircuito. le due memorie. co~me abbiamo precedentemente precisato.
Collocando la presa di 52 verso destra. comevedeal in lig. 3. conoclrcuiterete SZ su B. se Invecela sposterete a sinistra. come vedesi per Si. corto-circuiterete Sl su A.
Non cercate dl depositare dello stagno sul petti-ne del connettore da Innestare nei VIC.20. perchequesto puo lacilmente ossidarei. Se notate. toc-candole con mani grasse. che queste pista tendo-no a diventare opache. pulltele solo con un pò dialcool.
Terminato ll montaggio potrete inserire nei suozoccolo I'integrato 74L808. rivolgendo la tacca dirllerimento verso 62. poi una della due memorieHM.6264 nello zoccolo indicato ICZ. per ottenereun totale di 11.775 K dl memorial (il ponticello Slva cortocircuitato su A). senza dimenticare di ri-volgere la tacca di riferimento comevisibile inlig.3.
Facciamo presente che nel kit risulta presenteUNA SOLA RAM .sia per contenere il prezzo. siaperche una tele capacita di memoria, nella mag-gior parte dei casi. risulta più che sutliciente. Seperò non vi basta evorrete raggiungere i 19.967 K`sarà sufliciente acquistare un'altra HM.6264 ed in-serirla nello zoccolo indicato 103,
Consigliamo di prendere la Ram, dall'intemo delblister. dai due lati più stretti. dove non risultanopresenti i piedini nletti. anche se queste RamC/Mos sono internamente protette. non e mal con-eidlablle toccarne i piedini con le mani.
Anche se spesso non ne teniamo conto. il nostrocorpo risulta carico di tensioni elettrostatiche chepossono raggiungere anche diverse centlnala divolt. che si scaricheranno sul primo corpo metalli-co con cui veniamo a contatto. (vi sara capitato avolte di ricevere una torte scosse toccando la car-rozzeria dl un'auto o un rubinetto dell'acqua). e sequesto sara rappresentato dai piedini della Ram.quest'ulfima potrà lacilmente esserne danneggiate.
ll nostro corpo si carica elettrostaticamente secamminiarno su tappeti sintetici,se abbiamo scar-pa con suole in gomma. se indossiamo maglie ocamicie sempre di materiale sintetico. se ci petti-nlamo ecc ecc.: quindi. se non volete "distruggere"qualsiasi integrato C/Mos. prima di toccerlo saArebbe consigliabile appoggiare le manl ad un lilocollegato a terra. o meglio, mettersi al polso unbracciale metallico collegato ad un tubo dell'acqua.
Se ritenete esagerate questa nostre affermazio-ni, la prima volta che avrete in mano un display acristalli liquidi. provate a toccare i diversi terminali:con grande sorpresa vedrete subito i numeri ac-cendersi. (il display non si rovina). il che dimostrachiaramente la presenza. nel nostro corpo. di ten-sioni anche elevate.
` marie e legato al Dollaro ed aggiungendo l'lVA.L WO
COME UTILIZZARE LA SCHEDA DI ESPANSIONEPer essere certi che l'il tutto" sia assolutamente
perfetto. prima di inserire la scheda. mludele dalcircuito i due ponticelli Si ed 82. Dopo aver inseri-to tale scheda potrete accendere il computer edanche se l'espansione di memoria risulta inserita.sarà totalmente ignorata dal computer in quanto.con I'esclusione dei due ponticelli Si ed S2. ven-gono a mancare l segnali di indirizzamento. Que-sta semplice prova serve a verilicare l'assenze nellascheda di piste in corto.
Se tutto e corretto. sullo scheme dovra apparirela scritta:
:saabyturmA questo punto. provate a premere II pulsante di
RESET. (vedi P1), presenta sulla scheda a, ooeilacendo. il video dovra cancellare! completamentee. dopo qualche istante. dovre riapparlre la atenescritta iniziale vista precedentemente.
Appurato tutto ciò. dopo aver spento Il compu-ter. disinnestate la scheda e. utilizzando una eoiamemoria posta sullo zoccolo dl IC? con 81 corto-clrcuitato su A. riaccendeteio. eul video apparire:
11115 bymrmUtilizzando. Invece, due memorie e cortocircui-
tando 82 su B. sul video apparire:
10002 bytea tree
Facciamo presente. che per eatrarra con mag-gior laciltà tale scheda dal retro del computer. ab-biamo previsto sullo stampato due lori In cui an-dranno inseriti due piccoli ganci metallici eu cullare lorza._ Ricordatevi sempre. prima di Inneatare o dialn-nestere la scheda di memoria dl apegnere ll com-puter, per non creare condizioni anomale di lun-zionamento.
COSTO DI REALIZZAZIONETutto il necessario perqueeta memoria, cloo clr-
culto stampato LXJOO. tre zoccoli. un pulsante.due connettori Sl›82 più le aplne temmine per lponticelli, I'integrato 74L808 e UNA SOLA ramHM.6264.. L. 72.000
II solo circuito stampato LXJOO . L. 5.200IMPORTANTE = Per chl desidera un kit con
due RAM (Kit siglato LX.700/B) poulamo lareun'OFFERTA SPECIALEaaole...,........... L. 120.000
Facciamo presenta che il prezzo di queate me-
una aola RAM conta attualmente ben.| prezzi sopra riportati non includono le epeee
per la apedlzlone postale.
UNA ECONOMICASTAMPANTEPER IL VOSTRO COMPUTER
CARATTERISTICHE TECNICHE'WMx m x u un _ ›V
“MMICmZEN-NATIONALidIaponIbIkhduønwddllm-Ib.una promo:
MODELLO 560 CDflmploiodwuhcdqldfllopwmlmcmmmom
MODELLO 560 CNyieunplmdlhlmpuuadhpuikbcmwnlcudnbpuquddldcompml.
Nøgll ordlnl bisogna proclurc ll modello vI occorre, perchè quello provlIn dllnIorIaccla Commodore, una solo per quell! computer, mentre ll modello 560 CNal adam a qualllul altro computer provvlnlo dl uscita PARALLELA Ilpo Conìronla.
Entrambi I modelli sono reperlblll presso “NUOVA ELETTRONICA" epresso I nostri più Iornltl CONCESSIONARI.
Pmegulilmo Il "rie degli lrtlcOll dßdlcfltl III!cura di alcune tra le più dlituee allezlonl deli'orga-nlerno umano. puntualizzando ancora una volta lemodalità d'uso di uno del due elettroatimolatori danoi progettati. l'uno, proiessionale, presentato suln. 90. l'altro, portatile. sul nA 98.
Entrambi questi elettrostimoiatorl agiscono conla stessa incìelvlta. provocando un'eccltazlone lor-zata eu punti ben determinati del corpo umano,con impulsi di bassa trequenza. con un'onda diterme particolare. chiamata "onda cinese".
Quello professionale consente di eccitare con-temporaneamente più "punti". dl dosare l'intenaìtadlogni lmpulso edi variame la larghezza, insommadi ricercare “sperimentalmente” la migliore moda-
lltå dl Intervento al tlne dl lenire un determinatodolore. il secondo. portatile. è molto più sempliceepratico neil'uso. poiche dotato di un numero mino-re di comandi da azionare.
A proposito di quest'ultimo stimolatore. alcunilettori ci hanno inviato il loro montaggio. effer~mando che non funziona e questo solo perche.misurando latensione in uscita con un tester. han›no rilevato 2.5 - Svolt. anzichè gli 80 da noi indicati.
In realtà tutti gli stimolatorl Inviati funzionanoperfettamente ed erogano in uscita la tensione ri-chiesta: questa tensione, però, non si può rilevarecon il tester, perche essendo gli impulsi moltostretti in rapporto al tempo, la lancetta dello stru-mento per la sua lnerzla non riesce a misurarli.
In questo numero llluctrlamo quali punti dal corpo umano occorraelattroatlrnoiare, per curare due malattie dell'apparato reaplratorlomolto dilluse. cioè l'asma ela bronchlte.
_ PER GUARIRE con
Flg. 1 Percurara l'aama aarebba neceaaarlo alet-treatimolare contemporaneamente due punti; poi-che al tratta dl un'operazlona cha può pruentarequalche dlttlcolta dl uscuzlona, praclalamo che apeuiblle ettanara le atauo Identleo rlauitato, accl-tando altamatlvamente, per J minuti. ala ll punteaupertcre che quello Interiore per un totale di 12minuti.
Poicha aul corpo l merldlanl cone dlapoati Incoppia pertettamente almmatricine, aa acepliareteIl alnlatra dovrete ricordami dl “non una placche!-ta metallica, collegata al terminale positivo, con lamano alniatra. ae Invece eccitante il meridiano dldutrl. dovrete tenera la placcbetta metallica delpoaltlvo con la mano deatra.Dopo aver lnumldlto ll patto ad appoggiato ll pun-tale positive, aocmdereta lo atimotatore portandoai minimo li livello della tenaiona in uscita. potIentalnania aumenterete queato livello lino ad av-vertire gli lmpulal.
Solo chl possiede un oscilloscopio puo consta-tare che I picchi dl tensione di questi impulsi rag-giungono il valore indicato ed intatti se appoggere-te il puntale esattamente sul “punto cinese" l'ìm-pulso di tensione verrà awertito.
ln pratica. uno stimolatore non serve e "fareI'elettro-shock". ma ad eccitare il "punto" interes-sato con dei picchi di tensione molto veloci. e nonfastidiosi. quindi se il puntale non si trova vicinis-`timo al punto interessato. I'Impuiso non e avverti-bile.
lnfatti, il "cercapunti cinese" LX.559. presentatosul n. 89.tun1iona perchè questi punti presentano.rispetto alla luna adiacente. una resistenza ohm-mica notevolmente inferiore. quindi soltanto sevengono centrati esattamente l'impulso e awertibi-le. poiche nel corpo scorre una maggiore quantitàdi corrente
Chi possiede pellesecca o grassa. dovrà sempreinumìdire la zona da eccitare. per favorire il pas-saggio di questa tensione impulsiva.
L”EI.ETI'ROST MOLAZIUNE ~*
Oome abbiamo gia acoen nato.non esistono con-troindicazioni all'uao di tale apparecchio. quinditutti possono utilizzarlo. ad eccezione di coloroche portano il PACE-MAKER. cioe quel piccoloapparecchio elettronico generatore d'impulsi che,posto all'interno della cavità toracica. controlla ilbattito cardiaco.
A dissipare le ultime perplessità circa la bontà diquesto nuovo metodo terapeutico concorre il fattodi sapere che. se anche dovessimo "sbagliare".eccitando un altro punto non interessato. a ditte-renza di una medicina. che può ledere altri organi ocausare irritazioni o allergie. non si avranno effetticollaterali in quanto non esistono ne dosi nè orarida rispettare. ed anche il fatto che se non useremola frequenza più appropriata l'unico inconvenientesarà quello di dover prolungare il trattamento.
Perquanto riguarda la polarità dei puntali. anchese i nostri disegni lo evidenziano chiaramente, ri-peteremo quanto segue:
Applicando il puntale negativo sul punto da noi
Flg. 2 Pu curare i'aama ealetono. al centro deicorpo. altri due punti che potrete eiattreatlmoianalternativamente pera minuti. fino ad un maulmodi 12-15 minuti. Il primo di queatl punti al trova acirca 12 centimetri lotte ai manto ed il secondosubito sotto al diaframma.In queato caso. potrete tenera la placchetta colle-gata ai poaltlvo dall'elaltroatlmolatora. ala con iamano destra che con ia alnlatra. È anche poealbileappoggiare la placchetta poaitlva vicino all'ombe-Ilco.Coma sempre ei partlra con una tensione minima.poi lentamente la al aievera fino a quando ll paflen-te non martiri il pfmcore degli lmpuiel dl eccito-zione.
91
indicato al otterrà un'azione diaperdente. che po-tremo utilizzare per lenire tutti i dolori e curare.oervicaigie. coilche. trecneiti. uretriti. asma. Iarin- Igitl. gutriti. ulcere. ecc. f'
In questi cui il puntale positivo. o una placcnet-ta metallica collegata all'uaclta positiva dello eti-molatore. andre posto a una certa distanza dalpuntale negativo. quindi potremo collocano aduna dietanle di 10 - 20 - 30 e più centimetri otenerlo anche in mano. scegliendo la mano poetaauiio stesso lato del corpo au cui verra applicato ilpuntale, cioè se applicheremo il puntale negativosul piede sinistro, terremo la placca metallica poni-tiva con la mano sinistra.
E cwio che. applicando Ia piastra positiva a circa10-20 centimetri dal puntale negativo, I'impuieosara più efficace risultando minore la resistenzatotale dal corpo.
Applicando li puntale poeltlvo sul punto da nolindicato. sl otterrà. invece, un'azione tonificante.che potremo utilizzare per tutte quello disfunzionidell'organlemo, quali ad esempio depressione fial-oa1 digestione difticile, ecleme, aritmie, ecc
Ovviamente Il puntale negativo. o ie piaochettametallica. sempre collegato ell'uaclta negative.andre posto. come nei calo precedente. a 10 - 20-30 o più centimetri oppure tenuto in mano. ace-gllendo la mano poeta sullo steeao lato dei corpoau cui risulta applicato l'altro puntale.
Se, per un'errafa interpretazione. applicheremoil puntale positivo. anzichè il negativo, c viceversa.ripetiamo ancora una volta. che l'unlco inconve-niente che rileveremo sarà quello dl non ottenerealcun pratico beneficio; li noetro organismo. infat-tl. non subirà alterazioni o lesioni di alcun genere. "0- 3 'num 'll' 4m IMI"m "Um
Un'altra precisazione che riteniamo opportuno m' ° 'Mah' wr." 'WI' :I:fare e che sul corpo umano sono presenti "meri- qua": 7:” pun". . Pu": . Mu*dlanl" disposti in coppie perfettamente slmmetri- una."Pd kuhccumml °° 'çnår" 9;”che. vale a dire a ciascun meridiano presenta sulla m ' 'm' 'um' 'M 'parte destra del corpo, ne corrisponde un altro 'mawwl'wu'u'k'm'umidentico sulla ainietra: chiaramente gli ateeai riaul- M "un" Humax”. 'mmm' u 'un'tati ai ottengono tanto stimolando l punti dell'uno. b"lm'"9"" m°'u mquanto deli'aitro.
†›munmrawuuetmnmpmummunmuåaàawuh" "A mm-Mlimm-wwmcm-LaDlIlIlEcomunical'apenumdiunnuwopuntodlvmdltaddKltlwvaBetmflca.DIEHME- Via Maochiaveili. 28/3)- HAPOLI(FI)LamoGAMIA
É oornunlca che il nuovo lndlrlnodellapmprlaeedeeøttlm-mgmacalß ._
92
ma Tumumnlgmemvnmmpunto da oodhn pu llnln l Murbl lmllel. luquuio punto lppllchomo Il punhlo nmtlvø Ibruta con Il mano path sullo m llß «Illmb.. un Mo mfldllco. (omne. Inno, nm. aalluminio), colloquio. ammonio. oul'ulelh pod-flvl dd mmm olmo-melma.
Flg. I Com. lanmunh o qulndl per Il pmun-:lam degli attacchi amatlcl. O miglhbllolppfl-un Il puntale palmo, Interim-nic, nu una domdu. gamba. In proulmlß della rotula a pol lppllcl-n Il pllltrl mlllel lnumldltl, 00".q Il Illgl-lho dflrolmrontlmolalon. :Im 10-12 conllmutllIl dl .cpu dl hl. punh. una pnoecuplrvldnfla
.› p_øllllom che nadlm.
Fl'. 5 Puattacchi lam dunummoedhn,con Il 'ormlull mgatlvo. I punto dum pmvlelno lll'unghll do! dho Mille. o pol pom In.Mn!mmlllca, colloglh ll polo poohlvo doll'.-Iimøøflmolllorl, viclnø ll pollo o loggørmlnl' pùIn .maY Antichi appoggia" Il plutmn mat-Illa-døn Indicata, i poulblln pnndon un tubo moti-llcc,collogltnmnpnnlpodflvo.unondoleeonhmano pm dllo mulo Into dal come.
Flg. 1 La bronchlle i un'lnlezlone dell'albero re-eplrelorlo che al manlleela In occaelone dl cam-
alaglone (pflnclpalmenla InInverno e prlmlve el cul alnloml sl accenluancd malllno ed alla url. Coma vedeal In queela llgu-la. due sono I punll da lrallau, Il pdmc, Il "o"eopra Il pollo ed Il "condo lollo alla secondacellula. Su quull due punll blaognarù applleen llpunlale negativo, tenendo ll poalllvo con la manopoale eullø 'lasso lelo del corpo.
Flg.. Perellmlnanloalalndeoelllflønalunel-ca oeeom elallmallmolare Il punlo lndlealc eulrelm delle echlena con ll punlale negallvo, tenen-do. con la mano poala sullo nleuo lalo del come.una Ianlra o un lubo melalllco collegalo, owla-manle, Il uaclla poalllva dell'elemoallmolalole.Trallando quello punlo al rlaeee ad elllnlnln Illoue e al lavarlaoe rupulelone del celano.
Fl; 1o Hammam da pm» mmmwquuhfigumchoslmuqulmodmlomllginocchio, O uillø por un 'ammonio pmnnflvolílqlonlle, cloù, In lmunno ed lll'lnlzlo dalla pli-mvm. Per una" una riuduu. Il Mmflmoln-riqunhpumoeonllpunhlumgaflvoJomndollpodflvo MMila mano poni allamIdodd corpo.
Flg. i Pocuna bronchlh può dummlnarc I'ln-mgonu dl cumpllukl mandarlo. qual! dm!-ooflå dl ruplrlxlonl, dllturbl dlgflflvl lardldgk,o non 0 da mludm un enflumn secondario. ùulllø ogni du.. 'n gloml .Icnroallmolan pudm10 mlnull I In pun!! riporti! In figuu. Sl lnlfllråefllndo par 3 mlmm Il puma lupcrlon, pol pu 3mlnull qulllo con". , pu lltrl 3 mlnutl, quolloInlorloro. Comi umpn collaqhml. ll punlalt n.-gaflvo :ul punt! lndlcafl. unendo Il palmo .tuttomill mano.
Tutte le telecamere portatlll per video-registratori vengono alimentate con plle ai nichel-cadmlo o con batterie a secco da 12 volt, tutti iradiocomandl per aeraomoclelli con pile da 4,8 o0.6 volt, i ricetrasmettitori portatili con pile alnichel-cadmlo da 12 volt.
Per ciascuna di queste diverse apparecchiature,edlsponibile un apposito carica-batterie che. però,iunzlona solo ed esclusivamente. se collegato aduna prese dl rete e 220 volt, in quanto nessunosembra aver pensato al tatto che un aereomodelli-ata possa trovarsi nella necessità di ricaricare leproprie pile In un campo di gara. dove chiaramentenon esiste alcuna presa dl corrente elettrica. oppu-re al caso In cui un "cameraman". dopo aver tattodiversi chilometri In auto per trovare un bel pae-
La resistenza R3 ed il diodo D82. inseriti fra lterminali 1 e 2 del trasformatore, servono per pro-teggere Il transistor TR1, durante Il lunzlonamen-to. dai picchi di estratenaicne positivi presenti alcapi di tale awolgimento.
La tensione alternata presente sul terminale d'u-sclta 3, varrà raddrlzzata dal diodo D53 ed ln segui-to illtrata. tramite II condensatore elettrolltlco C3de 100 mltzrolarad4
Ouestatensione inline, verra limitata ad un mae-simo dl 15 volt, tramite la rete di reazione costituitadei transistor TR2 e dal diodo zener D21.
ll transistor TFl2. un NPN tipo 86231. viene uti-lizzato per "bloccare" la basa del Darllngton TR1,controllando la tensione di retroazione e dimi<nuendone la corrente di base. lino alla condizione
Un circuito che vl consentire dl ricaricare qualsiasi pila al nichel-cadmio da 4,0 - 9,6 - 12 - 14,4 con la tensione iornlla dalla batteriadelle voatra auto. Tutti I modellistl potranno coal ricaricare subito, nelcampi di gara, le proprie pile ed l video-amatori non correranno più lIrischio dl trovarsi, durante una ripresa al mare o ln montagna. con lepile lrrlrnediabllmente scariche.
saggio da immortalare su nastro. si accorga di ave~re le pile totalmente scariche.
Per l'appunto a queste circostanze particolariabbiamo pensato noi` progettando un carica-pileche. anzichè richiedere una tensione di rete a 220volt. lunziona solo se collegato ad una normalebatteria a 12 volt dl qualsiasi auto.
Cosi, se ci accorgeremo che le nostre pile risul-tano scariche, e non avremo la possibilità di colle-garci ad una presa di rete a 220 volt. per ricaricarle.sara sufficiente ritornare nella propria auto e col-legare il carica pile alla batteria a 12 volt: in pochiistanti potremo nuovamente disporre di un radio~comando. o dl una telecamera o dl un ricetrasmet-titore perlettamente iunxionanti.
SCHEMA ELETTRICOOome vedesi in tig. 1, ll transistor Till. un Dar-
iington tipo BDX53. viene utilizzato. assieme altrastormatore T1 e all'avvolgimento di retroazione(presa 4~5 dl T1), par ottenere un oscillatore bloc-cato. che lavora con una frequenza di circa 30.000 Hz.
Cosi iacendo. sul terminale 3 di tale trasformato-re rlsultera disponibile una tensione alternata dlcirca 20-22 volt a 30.000 Hz.
'f-f cAc PILE Ni-cuELENCO COMPONENTI Lljl'lR1 : 47.000 ohm 1/4 wattR2 : 10.000 ohm 1/4 vrlttR3 : 10 ohm 1/2wattR4 : 47 ohm 1/4 wattH5 : 100 0hm1/4wlttR0 : 1.800 ohm1/4 waltR1 : 1.000 ohm 1/4 wattlil : lOohm 1 wattR0 : 10 ohm 1 wattR10 : 470 ohm 1/4 Witt61 : 41 mF elettr. 25 voltcz = 1.000 pr poli-mnCS : 100 mF elettr. ß voltCl : 100.000 pF poliestereD81 : dlodo 1N4148D52 : dlodo 1N4001D53 : diodo 1N4001034 : diodo 1N400'IDZ1 : zener 15 volt 1/2 wattTR1 : NPN tipo 50X53TH! - NPN tlpe BC.2311113 _ PN? tipo 50.2120 56.32!T1 : vedi tolto
m'.limite di spegnimento dell'oscillatora, in modo daooetrlngerlo ad erogare la sola potenza necessariaa mantenere costante la corrente dl ricarica dellepile al nichel-cadmio.
Pertanto sull'usclta di questo alimentatore. po~tremo collegare qualsiasi tipo di pila al nichel-cadmío da 1.2 ~ 4.8 - 9.6 - 12 -14.4 volt. batterie asecco da 12 volt ed. automaticamente. I'alimenta-tore provvederà ad autoregolarai sul valore di ten-sione richiesta ad a tornire una corrente costantedl 60 0120 milllamper.
Per mantenere la corrente in uscita costante suivalori di 00 o 120 milllamper. onde evitare che, apila scarica, l'alimentatore fornisce una correntemaggiore tale da danneggiarla. oppure che. a pilaquasi carica. tornisca una corrente minore. impe-dendone così una completa ricarica. ci occorre'unterzo transistor PNP, indicato nello schema elettri-co con la sigla TRS.
Poichè la base e i'emettltore del transistor TR3
É? ,Nè
Flo. 2 Disegno a grandezza na-turale del clrculto stampato ne-cessario per la realizzazione dtquesto canoa pile per nichel -oadmlo o batteria a uoco.
NUOVAELETTRONICA
risultano collegati. attraverso la resistenza Ft10. aicapi delle resistenza R9,da100hm1 watt. il tranel-stor TR3 inizierà a condurre quando. ai capi di taleresistenza. Ia tensione raggiungerà gli 0,6 volt ne-cessari a polarizzarne la base.
Pertanto. sapendo che, in base alla legge di Ohm:
V¦H:I
la corrente I, che dovrà scorrere nella resistenzaRS, perche ai euoi capi siano presenti 0,6 volt. sara:
ceva": to eum = o.oe Amp" cioè eo miluariipuIn questo modo. quando collegheremo al circui-
to una pile completamente scarica. se la correntein uscita sara maggiore dl 60 milliamper, ai capidella resistenza R9 sarà presente una tensione su-periorea0.6 volt. quindi il transistor TRS si porteraimmediatamente in conduzione. polarizzando.tramite la resistenza R6. la base del transistor TFi2.
LaFlg. 3 Schema pratico dl montaggio del carica pila. Per evitare lnvenlonl dl polentautilizzata sempre per il podtlvo un tllo color ROSSO e une NERO per Il negativo.
Portandosl anche queat'uitlmo transistor inconduzione. si ridurra i'amplezza del segnale diretroazlone che. tramite Fit-C2, giunge sulla basedei transistor TRI; pertanto. la potenza erogatadiminuirà. lino a raggiungere in uscita un valoremassimo di 60 milllamper.
Nel caso inverso` quando cioe la pila collegata inuscita risulterà quasi carica. la corrente in uscitatenderaa diminuire, ma subito. diminuendo la ten-sione ai capi della resistenza R9. il transistor TR3risulterà interdeho (cioe non condurrà più): diconseguenza sulla base dei transistor TR2, nongiungere più alcune poiarizzazloneequindi Il tran-sistor osciiiatore TRt aumenterà la sua potenza.riportando Ii valore di corrente in uscita a 60 mii-AIiamper richiesti per la totale ricarica della pila.
Con la sole resistenze R9 potremo prelevare inuscita una corrente costante di 60 milllamper,mentre collegando in parallelo a questa. tramite iiponticello P1, una seconda resistenze, sempre da100hm 1 watt (vedi R8), raddoppiaremo ilvaioredltale corrente. passando da 00 miiiiamper a 120mliliamper4
Queste due correnti sono di valore standard perpoter ricaricare qualsiasi pila, con tempi medi (60mA). o veloci (120 mA).
Non e consigliabile ridurre li valore delle dueresistenze RB-RQ per aumentare la corrente ero-gabiie, mentre e possibile aumentano e 15 ohm 1watt. per ottenere correnti di carica di 40 o di 100mA.
il diodo DSd, collegato in serie ai terminale diuscita positivo, serve da "interruttore elettronico".per Impedire che. staccando I'alimentatore dallabatteria a 12 volt deli'auto, la pila collegata in uscitaposaa scaricarsi su TR2-TR3.
Prima di passare alle descrizione dello schemapratico, vorremmo aggiungere che una qualsiasipila el nichel-cadmio va caricata. solo e soltanto,quando è totalmente scarica. (le pile secche aipiombo, si possono ricaricare anche se non sonocompletamente scariche); quindi è buona normascaricarla completamente, cortocircuitandole conuna resistenza da 4-5 ohm 2 watt. oppure colle-gandola ad una lampadina.
Ii tempo di carica sara calcolato in iunzione dellacapacitadella pila, percui,seabbiamo una pilaaulcui involucro sono riportati 500 mA/h. oppure0,!A/h, velea dire 500 milliamper/ora, ricaricando-la con una corrente dl 60 milliamper. la dovremolasciare inserita per:
se la ricaricheremo Invece con 120 milliamper. ledovremo lasciare collegata per un tempo pari a:
5M:120:4,1lon
c sczizlnxs: nczar sum
Flg. Q Oonnesdonl del Oarllng-ton 50X58 o dei transistor Mdll basso, cloì al lato ln cui Ihmlnlll E-D-C luolleacono daleorpopiasttoo.
Fio. 5 come potuta constatare,dal Irlatorrnatore T1 non ecconetra till per parte, ma solo due trac-ciola con l tre Ilil lttorclgllotl; por-tanto. dovrete separare questi ul-timl e pol lndlviduartl come Indi-cato nella tig. l. Se nel montaggiolnverttreteun solo moiglmento Icircuito non lundeneri.
avvolglrnenti.
Fly. 0 Dopo aver separato I tra llll delle due trecciole. con untester cercheremo di Individuare l'lnlzio e la line dei tra singoli
Sul lato vlnlstroavremo I'Inlzlo degli molgimanli 1-54 I sul latodestro dei corrispondenti 2M. Sul circuito stampato abbi-noriportato vicino ad ogni loro questi stessi numeri.
Lasciandoia inserita per un tempo minore. nonriusciremo ovviamente a completare la sua caricatotale. ma per una emergenza. anche una piccolacarica potra risolvere Immediatamente non pochiproblemi.
neauzzazroue PrumcaLa realizzazione pratica dei circuito non presen-
ta alcuna difficolta. In quanto il trasformatore T1.che e I'unlco componente "critico" di tutto ii pro-getto, si trova già promo ed awolto all'lnterno delKit assieme al circuito stampato monofaccia. danoi siglato LXtSBY.
Una volta in possesso di tale stampato, potremosubito iniziare Il montaggio. Inserendo prima dltutto le resistenze. poi I 4dlodi al slllcio, tutti siglati1N4007 tranne D81. peri quali dovremo rispettareIl verso dl inserzione, cioe rivolgere la lascia biancapresente sul loro involucro. come riportato nei disregno di tig. 3; Io stesso dicasi anche per il diodo:ener D11. da 15 volt.
Dopo questi. inseriremo i due condensatori aipollestere C2 e C4. rispettivamente da 1.000 pF eda 100.000 pF.
100
Precisiarno che II valore dl questi due condensa-tori potrà essere riportato eull'involucrocomesegue:
1.000 pr = in ma" .001100.000 pF = .1 oppure 100n
Peri due condensatori eiettrolitici 01 e 03. nonci saranno Invece problemi dl sigla. ma bisogneràrispettare la polarità dei due terminali. come chia-ramente visibile nel disegno dl fig. 3.
Se il terminale positivo non risultasse contraddi-stinto da alcun simbolo, potremo facilmente rico-noscerlo In quanto quest'ultimo risultera semprepiù lungo del terminale negativo.
A questo punto potremo inserire i due transito(TR2 e TFl3. facendo attenzione a non scambiare fraloro il transistor NPN e quello PNP. perche. cosifacendo. il circuito non potrà mai funzionare.
Il transistorTR2e un NPN. tipo 56.237, mentre Iltransistor TRJ è un PNP. tipo 80.328.
Seguendo ie indicazioni riportate sulla serigrafiadei circuito stampato. rivolgeremo la parte pianadei loro involucro come chiaramente indicato e.successivamente. lnserirerno nel circuito il transi-stordi potenza TR1. montandolo sulla piccola alet›ta dl ratlreddamento. che troveremo all'intemo deiKlt.
Dopo aver montato le due morsettlere a 2 pollpar l'lnqreeao e l'usclta della tensione e i due tar-mlnali per il ponticello P1. occorrerà montare iltrastormatore T1, per ll quale dovremo Individuarel tre awolqimenti e i loro rispettivi terrninall.
NOTA BENE: Il numero delle spire ed il diametrodel illo. sono identici per tutti e tre gli avvoipimenti.percui. una volta riconosciuti i terminali di ciascunavvoiglmento. potremo utilinare indlllerentemen-te uno dei tre. per i'awolgimento primario e gli altridue. per i due secondari.
Come connateremo. da tale trasformatore nonescono Still. ma solo due treccloleivedl lig.5)ditreiill cadauno collegati tra di loro.
Con il saldatore dovremo separare questi tre lllie. latto questo. prenderemo il nostro tester com-mutato sulla portata in ohm x 10 e. come chiara-mente visibile nei disegno di tig. 6. coliegheremcun puntale su uno dei 3 terminali che luorieeconoda un lato deli'avvoipimento. mentre. con l'altropuntale. cercheremo. sul late opposto dei traslor-matore. quale illo corrisponde all'altro capo dellostesso avvolgimento.
Trovato il primo awoioimento. coliegheremc suldue tiii un'etìchetta adesiva In modo da poter rico-noscere il terminale 1 e il tenninaie 2.
Collegheremo ora il tester ad un altro tenninaiedel trasformatore e ricerchererno il suo corrispon-dente dall'altro latov Una volta trovati. li indichere-mo con 5 e 6; owlarnente l due terminali rimasticorrisponderanno al 3 e al 4.
Oomevedesl In tig. 6, da un lato avremo I termina-ll1-5-3edellatooppost02-6-4.
Squendo questa numerazione e quella presentesulla serigrafia. lrieeriremo nello smmpato il trastor-malore. e saideremo i 6 lili alle rispettive plate sotto-stanti.
Fatto questo. avremo concluso il montaggio. maprima di lomire tensione al circuito. sare bene rl-controllare attentamente tutte le saldature esegui-te. per veritlcare che non esistano tra le piste deicorti, provocati accidentalmente da un eccesso distagno. oppure delle saldature "fredde". dovute, adesempio. all'ossidazione di un terminale che il disce-aidante dello stagno non e riuscito ad eliminare
Terminata questa verliica. potremo passare adun rapido collaudo dei nostro circuito. per accer-tarci del suo corretto funzionamento.
COLLAUDO “MALE
Perqueat'ultima operazionee necessario disporredi un tester, per misure in tensione ein corrente. dluna batteria a 12 volto di un qualsiasi alimentatoreda laboratorio che disponga in uscita di tale ten-sione. e di una pila al nichel cadmio o a secco. con
qualunque tensione. ad esempio da 1.2 - 4.0 - 9.6 -12 0 14.4 volt.
Coileghereme pertantoi 12volt sulla morsettlerad'ingresso rispettando la polarità positiva e negati-va. ponendo il tester commutato per misure in ten-sione su 20-30 volt iondc scala. sull'usclta del cir-cuitc.
Se In uscita non risultasse presente una tensionedl 14 - 15 volt. potremmo solo aver invertito l termi-nali del tre avvolgimenti dal trasformatore T1. op-pure ll diodo DSl olo zener DZ1.
Per controllare la corrente erogata in uscita. do-vremo collegare in uscita la pila da ricaricare, pre-occupandoci. prima di tutto. come gia abbiamoaccennato. di scaricarla completamente collegan-dola ad una lampadina o ad una resistenza da 4-5ohm 2 watt.
Oollegheremo poi il terminale negativo della pilaali'uacita negativa dell'alimentatore ed inseriremoii tester commutato sulla portata 100-150 milliam-per tondo scale. con ìi puntale positivo rivolto ver-so l'uscita positiva dell'allmentatore ed Il puntalenegativo verso Il positivo della pila.
Fatto questo. iomiremo tensione al circuito e lalancetta del tester. come abbiamo gia accennato,cl indicherà una corrente di assorbimento di circa60 milliamper.
ll valore letto sul tester potra risultare anche leg-germente diverso. ad esempio 56 o milliamper.per l'inevltablle tolleranza del valoredella resistan-za R9. che stabilisce la corrente di uscita. oppuredella soglia di conduzione del transistor TRS che.invece di essere esattamente 0.6 volt. potrebbe ri-sultare di 0.58 o 0.62 volt.
In ogni caso. si tratterà sempre dl un margine dlerrore molto ristretto. clio abbiamo voluto sottoli-neare per evitare le tante lettere e telelonate diconsulenza che tall piccole variazioni di valore eo-Iitamente creano.
A questo punto proviamo a cortocircultare l dueterrnlnall P1. collegando cosi in parallelo alla resi-stenza R9 la seconda resistenza RB e subito va-dremo aumentare la corrente da 60 milliamper a120 milliamper circa.
OOSTO DI REALIZZAZIONETutto Il necessario per ia realizzazione di questo
progetto. cioe ll circuito stampato LX.687. i transi-stor. Il Darlingtun completo di aletta di railredda-mento. le resistenze. i condensatori. l diodi, le duemorsattiere ed il traslonnatoreTl . L. 14.0m
ll solo circuito stampato LX.687 L. LSMNei prezzo non sono incluse le spese postali dl
spedizione a domicilio.
101
Da tempo le Rai pubblicizza ll servizio TELEVI-DEO, che rappresenta non solo una novità nell'ambi-todellecomunicazionídimassa,maencheunotra ' :me- :Tim ai leI più utili servizi di inlormazione a disposizione I' "a",dell'utente.
Potremmo intatti paragonare il televideo ad un"giornale televisivo" diviso in tenta rubriche di di-verso argomento. ciascuna delle quali, a seconda "uffa '°del nostro personale interesse, potrà essere ripro- "una v .dotle e lette sullo schermo televisivo. come la pa-gina di un qualsiasi quotidiano.
Se, ad esempio. ci interessa l`argomento lpofl,potremo chiamare sul video tele pagina e conosce-re cosi. anticipatamente, la schedina del totccal-cio, i nominativi degli arbitri chesaranno assegnati
alle squadre che giocheranno la prossima dome- Wu u .un :É:nica e. in generale, le notizie riguardanti tutti glialtri sport. ul xs gun-.u
Se dobbiamo, invece, intraprendere un viaggio.potremo chiamare la pagina riguardante la vilhllllådelle 'trade e venire cosi a conoscenza di eventualiinterruzioni, deviazioni. di valichi chiusi pertrane oper neve.
Volendo sapere gli orari dei treni o degli aerei,potremo chiamare la pagina dei trapani e trovaresu questa le informazioni desiderate; ugualmentesoci interessa il calendario delle tlere, delle moetre0 degli IMMIL _'__
Se. Invece. giochiamo al lotto potremo verificare mi”. .~.† __ › ›i numeri usciti sulle varie ruote e, se siamo interes›
Flg. 1 Il convertitore da noi costruito per rione" TELE-VIDEO, andrà collegato ln urlo tn Il dleom d'entenne el'lnqrem TV, come vedul nel diuqno.
WIWITITOIE rairn:` `mr:`
102
Chl dispone di una qualaiul TV ln blanco/nero o a colori potra, conutrornl lacillta` captare tutti I programmi televideo, senza doveracquistare un nuovo e coltoso televisore idoneo a tale lunxlone esenza apportare. a quello gia ln suo possesso, alcuna modlilca interna.
sati alle informazioni iinanziarie. potremo trovare.sulla pagina relativa, tutte le quotazioni di borsa e icambi valutarl.
Per conoscere le ultimo notlde di cronaca italia-na ed estera. basterà piglare la pagina dedicata atale servizio ed avremo in casa un giomala “appenauscito" di stampa.
Numerose sono poi le rubriche da cui potremo
Con TELEVIDEO potremo in ogni Istan-ta conoscere le previsioni dei tempo, qllorari degli urol, ed avere numero" li-tn lnionnazlonl utill per viaggiare.
trarre indicazioni utili nell`ambito domestico: adesempio, quella dedicata alla rloetta dei giorno.oppure la pagina dei giochi e dei pamtampl.
Non mancano la pagina medica. la pagina dedi-cata all'aroomento vacanze. alla scuole, oltre amolte altre, che sarebbe troppo lungo elencare.
ln pratica. con il servizio del televideo molti pic-coli problemi della nostra vita quotidiana potrannoessere agevolmente superati, pur rimanendo all'in-temo della propria abitazione.
Inoltre. come è facilmente intuíbile. col passare T'. 'e 'ame Plglfle CM Pm'eml) 0°.-del tempo, la siera degliargomenti trattati daltele- ill." 9|°ml|m0flt0. "OWYIMO IMvideo si amplierà ulteriormente. iinoad investiregli WW! 5.". 'Nm' 40| ibm 0 WO".Interessi regionali e locali. rendendo cosi sempre “I COMMI' P9' mlflleflßfll flfll-più prezioso ed insostituibile tale servizio di intor-mazione.
L'unico problema che ora si pone e dato dal tattoche tutte questa informazioni sono codificata:quindi. per riceverle dovremmo "buttare" la TV acolori. acquistata soltanto da pochi mesi. ecompe-rarne una nuova predisposta alla ricezione TELE-VIDEO. per iarvi poi inserire una scheda supple›mentare di decodifica: un'operazione. quest'ulti-ma. non certo allettante e. soprattutto. decisamen-te costosa. '
Proprio per risolvere questo problema. i nostritecnici sono da mesi al lavoro. per realizzare un Abbiamo anche la pagina dedicata ai-uecoaificatore TELEvlceo che, come vedasi in "'U'WWIIIW ° qu."- Mlfltl Ill'ligv... andrà inserito in serie alla discesa d'antenna 'Wu' W" lumi'- MO'- "WMdella nostra TV. non importa sein bianco/nero o a nq'colori. se di recente o remota costruzione.
103
II vantaggio che presenta questo circuito consi-ste proprio In questo e cioe nel poter utilizzarequalsiasi televisore, senza apportarvi alcuna modi-tica e pertanto riteniamo che proprio per questomotivo incontrerà. come ogni nostro progetto. unlargo consenso tra i nostri lettori.
In teoria. questo circuito sarebbe gia pronto peressere pubblicato. se non ci fossimo accorti. cheun integrato presentava una piccola anomalia.
Di conseguenza. abbiamo "bloccato" ii progettoe comunicato alla Casa Oostruttrice quanto ave-vamo riscontrato; siamo cosi venuti a conoscenzache questo integrato. anche se viene venduto rego-larmente. non risulta perfetto. per cui ci e statoconsigliato di attendere la nuova produzione. cherisulterà priva dei diletti da noi riscontrati.
Pensiamo quindi di trovarvi d'eccordo con noinel ritenere vantaggioso entrare in possesso di unprogetto perietto e pienamente affidabile. anchese cio richiederà ancora alcune settimane dl atte-sa. È owio, intatti. che quando ci giungeranno inuovi campioni. tutto il nostro lavoro ecioè il disegnodei circuito stampato. il montaggio. Ii collaudo, letoto. gli articoli. dovrà essere rifatto totalmente.ri partendo da "zero". perche oltre alle caratteristi-che. cambieranno pure le funzioni del nostro cir-cuito.
li nostro principale siorzo. intatti. e oueiio dipresentare progetti sempre pertettamente funzio-nanti. anche se ciò va a scapito della celerità dellepubblicazioni. cioè non abbiamo e non vogliamoadottare il sistema comune a tutte le altre riviste.che hanno il solo pregio di essere tempestive nellepubblicazioni, solo perchè non fanno altro che tra-durre interamente i deplianta tecnici inviati dalleCase Costruttrici. riponando schemi e loto in easicontenuti. senza minimamente provarli e collau-darli.
Possiamo iin d'ora anticiparvi. che la realizza-zione pratica del progetto non presenterà grandidliiicoltà. In quanto. trattandosi di un circuito tuttodigitale, pilotato da un microprocessore, non sidovranno effettuare taratura. Non possiamo inve-ce encore prevedere il suo costo. perchè soltantoquando riceveremo le letture di costo degli inte-grati (legate alle tluttuazioni del dollaro). e dei cir-cuiti stampati lo potremo conoscere e comunquepossiamo gia dirvi che risulterà contenuto ed allaportata di tutti.
Quindi. anche sala vostra TV non e predispostaai nuovo servizio dei TELEVIDEO. non preoccupa-tevi perche. tra breve. lo potrete acquisire anchevoi. applicando il circuito che presto troverete suNuova Elettronica.
104
Non manca ovviamente la pagina dedi-cata agli spettacoli. alle ultime novitàdlacograilche e alla ciaaaitioa giornalie-ra delle Hit-Parade.
Chl desidera conoscere qualche nuovopassatempo troverà anche della paginadedicate ai picchi più vari. con la poael-bliita dl saperne subito la soluzione.
|._U oggt_
El
Se volata conoscere i programmi TV deigiorno. la schedina del totocalclo o inumeri dei lotto. lora autflciente eee-gliere la pagina relative a tali argomenti.
MODIFICHE perMIGLIORARE inostri PROGETTIANTIFURTO RADAR - LXJNIRIV. ß
Nella lieta dei componenti. riportata a pag. 43. Ivalori di H17 ed R19 risultano Invertltl tra loro. Lalista corretta e la seguente:
R11 : 2.200 Ohm 1/4 Il!!R10 : 4.700 ohm 1/4 Ilt!
Non invertendo questi duevalori. la correntechegiunge sulla base del translator TR1. risulta lnauI-fìclente; pertanto. quest'ultlmo non riuscire ad ec-citare il relè di uscita, collegato sul suo collettore.
Se ll guadagno di questo transistor risulta eleva-to, il circuito potrebbe ugualmente Iunzionare,comunque. per essere sempre certi del suo Iunzio-namento. consigliamo di utilizzare:R17 = 2.200 ohm e R19 - 4.700 ohm.
A proposito di questo antiturto ci sono giunti 3montaggi in cui. anche se tale correzione era stataeseguita. il rete dl uscita non si eccitava. Su questiabbiamo scopano che i lettori. per tar entrare ledue morsettiere nel circuito stampato. avevano al-largato l Iori con una punta da trapano. asportandocosi la metallizzazione interna: conseguentemen-te. la tensione di alimentazione che giungeva sulrelè tramite la pista posta sulla Iaccia superioredello stampato. non poteva più giungere sulla pistasottostante Pertanto. se vi accadrà di riscontrareche I t'erminali di queste moreettiere. a causa dlqualche piccola sbavatura` non riescono ad inne-atarsi nei lori dello stampato, non allargatall. maassottigliate leggermente i loro piedini con unapiccola lima.
Su di un solo circuito abbiamo constatato un'a-nomalia un pò insolita. cioe . pur non esistendoalcun segnale di eccitazione. l'antiturto scattava incontinuità . Dopo averlo accuratamente controlla-to. abbiamo riscontrato una autoscillazione a bas-sissima Irequenza (OJ-0,2 Hz) Ira Io stadio di in-gresso a let e I'ingrasso non invertente del primooperazionaie ICt/A. Abbiamo subito eliminatoquesto inconveniente sostituendo il condensatore03. che attualmente risulta da 1 mF al poliestere.
con un condensatore elettrolitlco da 10 rnF. rivol-gendo il terminale positivo verso Il drain del let FT1e R3. ed il negativo verso ii piedino 5 di ICI/A.
Riportiamo questa nota. che potrebbe risultareutlla nell'eventuallta in cui a qualche lettore capi-tasse lo stesso lnconveniente.
INTERFACCIA STANPAN'I'E PER “0.20 o CM -LXJIZ/Riv. 00
ll circuito e perfetto e non esistono errori, quindieventuali anomalie di Iunzionamento devono ad-debitarsi al modello di stampante utilizzato. Adesempio. abbiamo trovato critiche stampanti co-struite dalla STAR e dalla SYCOM. Tell stampanti.infatti. non hanno alcun buflar di Ilnaa sulla portaparallela di comunicazione e le linee dl STROBE edi BUSY quindi risultano spesso disturbato da im-pulsi spuri di ampiezza notevole. che. interpretatidal computer come comandi normali. perturbanola temporizzazione dei comandi di stampa.
Pertanto, utilizzando questi modelli di stampan-te durante la scrittura di un testo, e lacile “perde-re" del caratteri oppure stamparedelle lettere arra-le.
Pur non esistendo alcuna soluzione per risolverequesto problema. non essendo possibile owia-mente l'manofnettere" la stampante per inserire unintegrato amplilicatore sull'ingreeso parallelo.siamo riusciti a conseguire un risultato abbastanzasoddisfacente. abbassando Il valore delle due resi-stenze RO ed R0. portandole degli attuali 10.000ohm a 3.300 ohm.
Con questa semplice moditica. abbiamo com~pensato la mancanza di un amplificatore squadra-tore. presente sugli altri modelli dl stampante.
PENNA OTTICA WVICJO e 6.64 - LX.050/Riv. .1
Ultimamente abbiamo scoperto che sul sistemaoperativo inserito nei computer Commodore 064.la Casa Costruttrice esegue delle modltiche senzache di esse sia data alcuna comunicazione.
105
Flg. 1 Per renderci Indipendenti dalla cella dl memorie56320 e condelleblle :collegare ll lllo, che ore Il collegesul piedino 3 del connettore.e collegarlo al pledlnoì.utlllnendo pol l quattro programmi qul selle riportati.
,W'l'll'll
Flg. I ln sostituzione del lololrenelllorTlLM, nel ore Inaerle-mo nel kll ll lotolrenelllor TILJG perche. eeeendo dl dlmenalenlridotte, riesce più leclle lnurlrle nll'lnteme dl une biro. Comevedeel nella llq. 1 Il lermlnale più corto C andrà collegno Il Illoche parte dal punto C presente lul clrculto elempelo, ll llnnlnalepiù lungo E andre eollegeto alla cain metallica.
Siamo giunti e questa scopone dopo che. daparte dl diversi lettori, ci erano state invlate dellepenne ottlche delle quali venlve lamentato I'irnper-letto lunzionamentc. ma che. collaudata in labora-torio sui tre Commodore CS4 dl cui disponiamo.sono risultate tutte perfettamente lunzionantl; nonsapendo a cosa attribuire questo diletto, ci siamoletti inviare assieme alla penna. anche i computeresu questi abbiamo rilevato che I'índirizzo della Io~cazione Interessata dal lennredella penna ottica.che nel nostrl tre computer risultava 56320. eramodlllcato.
Il umore della penna ottica su tali computermodificava il contenuto di una diverse celle e perquesto motivo il programma non rispondeva a talecomando.
Avendo trovato l'lnconvenlanle, I'unlca soluzio-ne era quelle di renderci lndlpendentl da tale cellaeseguendo questa semplice modlficl:
106
1 - Dletaccare del connettore femmina Il illo che lacapo al piedino 3 e collegano al piedino 9, comechiaramente visiblle in ligurttV2 - Modillcere l programmi 3-4-7-8, da nol prece-dentemente consigliati. con ì seguenti:
10 K-DEEKCSBG72)20 IF K(200 THEN 1030 PRINT "DKGV'WRAO GOTO 10
10 KIDEEK(542§7)20 lF K(2OO THEN 1030 PRINT "DKRV'gHIO RDTD lO
5 PRINY CHRSUAD10 K-PEEK(36872)20 IF K(200 THEN 1030 RIØEEKGSBflìi-ùìAO B-PEEKGSG7H-3750 XIINTGVÀ)SO VIINTiB/A)70 X-RDSfX) IVIGBS(V)BO DIVOìZa-X90 FDKE SBAOOH',0100 PCKE 7580.53.81110 GDTD 10
5 PRINT CHROUÀ7)1^0 K-PEEKGMZSD20 IF K(200 THEN 1030 QIDEEK(532$7)-3§A0 B-PEEK(53268)-4050 XIINTM/å)60 VIINT(B/B)70 XIGBSQ) IVIQBSW)BO Piveùool50 9CRE 5529509,0100 DUKE lOZåQP' DlHO GOTO 10
Cosi facendo. comunque sia configurato il si-stema operativo sul vostro computer. ll circuitofunzionerà sempre perfettamente.
Sulla destra del disegno sono riponate anche leconnessioni del fototrensistor. (il piedino più cortoe quello che dovrete collegare al filo che fa capo alterminale C. mentre quello più lungo andrà colle-gato alla calza metallica di schermatura del filo).ultimamente inserito nel kit perchè. essendo di d'mansioni ridotte. risulterà più facile inserirlo all'in-terno del contenitore di una qualsiasi biro.
Nel programmi 7 ed B. nelle iinee30e40. i numeri-49 -37 e -39 -40 dovranno essere variati con nume-ri maggiori o minori, per centrare il punto Indivi-duato dalla penna sullo schermo del TV.
INTERFACCIA STAMPANTE per SINCLAIH -LXJ'H/RIVJI
Nella lista del componenti riportata a pag. 78. epresente un errora nella sigla di un integrato eprecisamente in quella dell'lCS. Questo integrato.come a precisato anche neil'articolo relativo a taleprogetto, (vedi 4' capoverso a pag. 78). deve risul-tare un 74LS123 e non un 74L8132. come appareinvece nella lista dei componenti.
Inoltre è necessario apportare una correzione elprogramma 4. riportato a pag. 82. variando un nu-mero nella lista dei "D/UA": esattamente nellalinea 105. dove appare il numero 177. ln sostituzio-ne di 177 dovrete scrivere il numero 117.
Questa nota non aerve a coloro che acquistano,o hanno acquistato. ll nostro kit perche` all'lntemodei blistefitroveretegia inserito un foglietto con talicorrezioni.
Sempre a proposito dl questa interfaccia soo-priamo che a sbagliare non siamo solo noi. maanche le Industrie che ci hanno fornito la piattinagia cablata e completa dei due connettori.
Infatti, le piattina che abbiamo ricevuto con laprima fornitura era atata cablata come il campioneda noi fornito; ultimamente invece. anziche cabla-re i due connettori con una piattina a 25 fili. ne estata utilizzata una a 26 fili e, poichè non ce nesiamo accorti. questa piattino I'abbiamo spedita atutti coloro che ne hanno fatto richiesta.
Questo filo in molte stampanti corrisponde al-I'ingreseo di "reset". quindi collegandolo a mam.questa non puo assolutamente funzionare.
inconvenienti di questo genere non dovrebberomai verificarsi. ma non potevamo certo supporreche perla seconda fornitura si fosse utilizzata unadiversa piattina, quindi nessuno ha pensato di con-tare se i fili fossero 25 o 26.
Comunque l'importante e sapere che noi risol-viamo qualsiasi problema. quindi se la vostrastampante non funziona. contate quanti fili sonopresenti sulla piattina: se ne contate 26. occorreràtagliare il primo filo posto eulla sinistra del connet-tore. come visibile in figura.
Nel tagliare questo fiio fate attenlione a nontagliare il accendo filo posto nella piattina.
'a "ml-IE
m ll UI
Fig. 3 .e la atampante collegata al Sin-dalroiltflufldfunziomrealapiottlnadepone d I. fll. dovrete tagliare, comevedealnetmllprimfllepoatowlaaiutata.
1 07
ELENCO COMPONENTI
R1 : "0 ohm 1/2 vrlìtC1 :100 mF elettrolltloo 10 voltDZ1 : diodo mer 9 volt tlìvnttTR1 : translator NPN llpo 80243
RIDUTTOIIE DI TENSIONE PER AUTO 12 - 0 VccSly. SIMIM Lo Vetro - 'AOSCIANO SA. (TE)
Talvolta capita di voler ascoltare in auto radioportatili, mangianastri o piccoli ampliticatori chelunzlonano con una tensione di 9 volt e. per nondovere continuamente sostituire le pile` si deside-rerabbe strutture i 12 volt della batteria dell'auto-mobileA
Questo sampllce circuito risolve in modo moltoeconomico il problema: si tratta intatti di un ridut-toredi tensione che partendo dai 12 - 15 volt appll_catl all'ingresso, stabilizza la tensione in uscita acirca 9 volt. Lo scopo si ottiene collegando allabase del transistor TFl1, un BD243. uno zener da 9volt cha fornisce il giusto rilerimento di tensione. eR1 che limita la corrente su [1121À TR1 amplifica incorrente la tensione di riferimento presenta sullabase e mantiene in uscita una tensione costanteanche in presenza di variazioni sull'ingresso; lacorrente massima che potremo prelevaree di circa800 mA.
NOTE REDAZIONALIEssendo il Tm un transistor dipotenza a basso
guadagno, ll valore della resistenza R1 ci sembratroppo elevato. visto che in uscita la corrente è di600 mA. Consigliamo pertanto di ridurre il valoredella H1 a 100 - 150 ohm a di inserire ai capidiD21un condensatore elettrolitico da 4,7 microFarad.
È ancora consigliabile inserire un diodo raddriz-zatora 1N4004 o 1N4007 in serie al positivo dl all-mentazione, per proteggere il translator da even-tuall plcchi negativi.
100
JROGETTISEMPLICE OHMMETHO LINEARESl.. Wtcc Genøml M.dl PIETRASANTA (Lucci)
ll circuito che vi propongo e utile a tutti coloroche possiedono un mllllvoltmotro digitale o elet-tronloo o un tester ad alta impedenza e desideranorealizzare un semplice ohmmatro a scala LINEA-RE.
Come vedasi nello schema elettrico. il circuito eun normale generatore di corrente costante che hoottenuto utilizzando un comune let ed un transi-storal silicio NPN. Una volta ruotato ll commutato-re S1 sulletre posizioni (X1-X10-X100). sl dovran~no regolare i trimmer R1-R2-RS in modo che, sulcollettore del transistor TFl1. scorre una correntedi 1mA nella posizione X1. di 0,1 mA nella posizio-ne X10 e di 0,01 mA nella posiziona X100.
Cosi lacendo, utilizzando il millivoltmetro sullaportata 100 millivolt tondo scala. sara possibilemisurare, sulle tre posizioni del commutatore S1.resistenze da 0 a 100 ohm. da 100 a 1.000 ohm, da1.000 a 10.000 ohm, mentre. commutando ll milli-voltmatro sulla portata di 1.000 millivolt (cioe 1volt) tondo scala. sulla tra posizioni del commuta~tore S1, sl potranno misurare resistenze da 100 l1.000 ohm, dl 1.000 a 10.000 ohm, da 10.000 a100.000 ohmt
Infatti la lormula da utlllzzare per ricavare la ten-sione presente ai capi della resistenza incognitaRX. in lunzione della corrente applicata ai suoi capie la seguente:
milllvolt : ohm x mA
quindi:
1U.m l 0.1 :1N Illlllvofl"KLM l 0,01 : 1.000 millioncon la lormula lnversa. cioe:
ohm : mltlvott : mA
In questo rubrica presentiamo scheml chegiornalmente molil lettori ci Inviano. sce-gliendo tra questi I più validi ed Interessanti.Per ovvl metivl dl tempo e reperibilità delmateriali non possiamo “provare” questischemi` quindi per lI loro iunzlonumento clltlldlerno elle lerietù dell'Autore. Do portenoltro, controlllemo solo se Il circuito teo-rloemente puo risultare iunzlonlnie. com-pletendolo, dove e necessario, dl uno notaredazionale.
ELENCO COIPONENTIm : 5.00 ohm trimmerR2 = 50.000 ohm trimmerlt! = 500.000 ohm trimmer021 : menor 8 volt 1/4 vrllt1111 = trlneiltor NPN tipo “1FT1 = let tipe 248010P1 = puleente norm. ehlueo
` "ml
Come strumento di mleurlpotrete utlllmre lndllle-rentemenle un tester one-ledoø a difltlle.
si potrà conoscere il valore delle resistenza inco-gnita. lnleiti supponendo di leggere sullo strumen-to una tensione (1150 e 100 mlllivolt e sapendo chele corrente che scorre in queste due resistenze e di1 mA. Il valore ohmmico risulterà perl e:
50:1 :500hm10011 : 1000hm
Se le corrente fosse di 0.1 mA (portate x 10) ilvalore di queste due resistenze risulterebbe pari e:
50:0.1 : 5000!!!!100:0.1 : 1.0000hm
Come avrete giù intuito, non e possibile estende-re Ie portate dello strumento su ve lori molto eievstl(cioe 100.000 ohm o 1 megahom iondo scala), por-che in pratica occorre accettare come limite mes-simo di letture 1/100 della resistenza interna delmilllvoltmetro utilizzato.
109
Per le taratura bisognerà collocare, in sostitu-zione della resistenza RX. iI nostro tester commu-teto in miliiamper e regolare il trimmer R1 lino aleggere una corrente di 1 milliamper, il trimmer F12tino a leggere una corrente di 0.1 mA e il trimmerR3 tlno a leggere una corrente di 0.01 millllmpercioè 10 microemper.
NOTE REDAZIONALI
La descrizione dal progetto 0 stato condenseta,pertanto diremo che il pulsante P1 (o contntti chiu-si) serve solo per non lor sblttoro lo strumento afondo scala.
Une volte inserite la resistenze RX sl pio/ere ilpulsante. partendo sempre delle portate più alta,cioe X 100.
Questo circuito è valido ai Iini dl una letturalineare sulla scala dello strumento. quindi per mi-sure molto precise con valori ohmmicimolto bassi.
Precisiamo che il transistor 2N697. alquanto dil-Iicile da reperire, può essere soslituito dl un qual-siasi altro transistor NPN al silicio dl media poten-za. come i12N1711 - BD135 - DB137. ecc.
Per R1~R2~R3 si consiglio di utilizzare dei trim-mer di ottima qualità possibilmente I 10 girl per-che, cosi facendo, potrete tere/e le tn porllto conmaggior precisione.
ALLARME TEMPORIZZATOSig. Oiuuopo Tuilrioilo MILANO
Vorrei proporre. per la Vs. morto. 'Progetti InSlntonla". questo schema dl allarme temporizzatol sol transistor.
Come è possibile notare dello ochoml elettrico.vi eun primo temporlzzatore costituito dl TR1,cheservirà In uscita e che. dopo un olrto lasso di
ELENCO COMPONENTI
R1 = 100 ohmR2 : 100 ohmR3 = 100.000 ohm trio-1.*M : 100.000 ohmR5 : 41.000 ohm
' R0 : 3.000 ohmR1 : 1.000 ohmR0 : 100.000 ohmR0 : 33.000 ohmR0 : 100.000 ohmR10 56.000 ohmR11 10.000 ohmR12R13R14R15 33.000 ohmTutti I rumori sono dl 1llirdlci = 470 mF elettrolitloo 101°!!62 : 1 mF poliestere
diodo 1Nl1dldiodo leddiodo ledtransistor PNP tipo INNtnnsistor NPN tipo ZN*transistor PNP tipo 2N2004tnnsistor NPN tipo 06200transistor NPN tipo 80200transistor NPN tipo 841711
Relè 12 volt o uno selmhloP1 : pulsanteS1A-S1B : deviltore doppio
110
tempo determinato de RS-FN-Ct. entreri In con~duzlone accendendo lentamente il diodo led DL1.Iomendo cosi. tensione e tutto il circuito.
A questo punto piqiendo P1 (el possono utilizze-re anche più P1 posti in perellelo) TR2 e TFiS ciporteranno in conduzione. Una volte entrlti inconduzione, prima che il reie_ei acciti. trascorre-renno circa 15-30 secondi.
Questo tempo di ritardo. determinato da File-R15~03. permette al proprietario di poter tranquil-lamente disinnescere l'ailerme, nel ceso in cuiquesta operazione non venisse eseguite entro iltempo determinato. i transistor TRS e THG. entre-ranno in conduzione eccitendo il rele e di conse-guenza larennc scattare l'alierme.
ll traneistorTFN he le lunzione esclusiva di vieul-llzzare. per mezzo del diodo led DL2, l'ewenutoinizio della temporizzazione di l'entra
l tempi in uscite e in entrata sono regolabili permezzo dei trimmer R3 e R13 dl un minimo di15edun massimo di 30 secontfl circa.
l transistor Impiegati nel progetto possono esse-re soetltuitl con altri purchè egualmente di tipoNPN o PNP.
li doppio devietore S1A-StB ha le triplice iun-zione dl attivare o disattivare l'lilerme e scaricare icondensatori Ci e 63 attraverso le resistenze R4 eR2. per avere la certezza che. ai momento dell'ec-censlone. le tomporizzezioni riportano da zero.
il condensatore C2. applicato sulla base di TRZ.eerve ed eliminare eventuali tolse eccitlzioni.
B
E I:a B
1.1111
ZIHIZlla" lc!!!
ELENCO COMPONENTI
lt : 1.0Wøhm 1/lvrettR2 : 1.0Wohm "lentiIl! = 41.000 ohm 1/0 wattle : 41.000 ohm `Ill viettIS : JIM ohm 1/0 'ottIci = imma unaDL! = dodo led verdeDL! = dodo led roeeo
ECONOMICA SONDA PER cllOlIl.. Mme Cennehlnl OHEONA (NO)
Sono uno studente di elettronica el quinto annoed avendo avuto la necessità di veriilcere l'idoneitldi elcuni integrati delle serie CMOS, ho reeiimtoqueste semplice ed eflicece sonde.
ll mio progetto utilizza l'integrato LM356. lun-zionente con alimentazione singola e contenentedue applicatori operazioneli che conirontano letensioni prelevate dei pertitori R1-R2 e R3-R4-R5.
Ouendo sul CMOS in prove e presente un livellologico O, corrispondente n 1/3 dellaÀ tensione di
alimentazione. ei accendere il diodo led rosso DL2.Se Invece risulta presente un livello logico 1.
corrispondente ai 2/3 delle tensione di alimenta-zione. si accendere iI diodo led verde DLl. Se iduelivelli logici cambiano di stato. e bassissima ire-quenu. i due diodi led si accenderenno aitemati-vamente.
Nei caso in cui il livello logico e incerto. cioe nointeriore e 1/3 ne superiore a 2/3. entrambi l dlodlled risulteranno spenti. «
NOTE REDAZIONALIII termina/e d'ingreuo indicato con Vcc, ve coi-
Iegeio el posiiivo di alimentazione dei C/Mos Inprova, il terminale GND alla messe del circulto e ilterminale TESTsulpiedino su cui deve esserecon-lloilelo il livello logico. Infine, per proteggere I'ìn-leg/aio LM358 consigliamo di inserire, lre i duediodi led e le messa, una resistenze di 470 ohm.
H1
88
::n
5Se.:
...E:Eu-..._
u8.
FIS
.2...
822....u
uu.83...
.la829....
u5.
Brunun..
:az552....
u:F
.Sunun..
:uz.8
:22
-u
un...85m
a::a:
.8:2
2-
uE...
09:2'a:
0-0:-_l
80!n
š.3
v2....
n.9..-_-
25...u
3a3
3:.
.la22..-
.-Se!
u«un
033:.E...
n.2.._.
se!u
'un
..guai-..2.81%f u
:o225.2.
“aSea.
u«ö
8:1. L..
8°.8Fu
:o8....
. u... ..8.9:n
So..2.
â82.2%
..u...
Eu
8..._-...2.
ß..8°...
u.o
225.8k
85u
5..2
..a82.2%
..“E
_:n
.o:22.8
“___ ..8.8u
358......
à..8.8.
u.o
8.!.
ì08.8.
u8
8.... -i
..8.8.u
«o
ãa
øo
ššu
ß:
u'O
il!wltš
lnå
ìfllø
=¦h
Ei
so.,E
issd
Ego8
.:..:2°
08.8w
SEOa
si.
:EQse
i'Etc
andESO
2...i
.282...lo
03.2.1.i-
gß
BIOgag
nal
nval
Heuß
u:i
n:8
H:I
n:C
un:-
u:I
"2:
_
..loec...
u«2.
.5308
u:I
Ego08.'
n28
..inS..
u.E
Exe08.2"
u.I
..ze-EE«a
nE
:Enia-E
Fu
al.___-
šE
8082:N."
Hnl
E508
0.2
.u
QI:2°
08.:u
nlEgo
csi'
u«I
.5-0288'
u:-
Ela
n-O
OOOZHJN
112
*AA-WM AUTOIATIOOIg. Luciano Iurflooe "AMATA
Ho realizzato un progetto di wee-vraa automati-co, particolarmente adatto per chitarra elettrica.che spero venga pubblicato sulla vostre riviste.deto che esiste un certo interesse da parte delmusicotlli per ettetti di questo genere e che unosimile non credo sia apparso sulle riviste dl elettro-nica almeno negli ultimi quattro anni.
Il circuito de me realizzato, per tunzionare, nonhe bisogno del tipico pedale, che non sempre l'au-tocoatruttore riesce e procurarsi e che, per ottene-re gli ettetti desiderati. richiede una perizia nonlnditterente. inoltre. al posto di un oscillatore abassissima trequenza, che renderebbe monotonol'ettetto, strutta l'intenaita con cui si esegue la pen-nata per generare un inviluppo di tensione checontrolla un tlltro passe-bende.
L'Inviluppo si ottiene da un generatore di tlpoattacco-rilascio innescato da un trigger "elastico".che genera. cioe. lmpulsi le cui lntenelte a propor-zlonele alla lorza con cui si plzzicano le corde.
Passo ora ad illustrarvi Ii tunzlonemento del cir-culto.
Il segnale delle chitarre viene applicato sul ple-dlno 2 dl lC1/A, che tunzlone da adattatore per gliatadl successivi.
Del piedino 1 di lC1/A il segnale giunge al tiltropassa-banda (piedino 3 di ICS) e el piedino 6 dilC1/Bl utilizzato come ampliticatore ad elto gue-dagno per "squadrere" il segnale stesso.
Dal piedino 7 di IC'l/B, Il segnale squadreto vie-ne reddrizzeto da DS1, trastormato in breve lmpul-so della rete Ctô-CS-m ed inline applicato alpiedino 3 di IC2. che tunzlona da comparatore._
Quando le corde non sono plzzlcete, la base diTR1, per le presenze di D82, non risulta polarizza-ta, pertanto TR1, non conducendo Il generatore diinviluppo che segue. riaultere bloccato.
Eseguendo una nota. sul piedino 3 di ICZ giun-gere un impulso che superando la tensione d e-rimento presente al piedino 2, porterà l'usci diIC2 e livello logico 1, indicante le presenza di unatensione posltlva che portare in conduzione TR1'.
Sull'emettitore dl quest'ultlmo, sara ore presenteuna tensione positiva che attraverso R12-H13-DSe. giungere sul condensatore elettrolitico 06 llquale, cericendosi. porterà in conduzione TR2 eTRS.
Il tempo di carica di 66 (attacco) dipende ovvia-mente dalla posizione dal cursore di R13. Il valoredl questo potenziometro e di 220.000 ohm e nonconviene aumenterlo perche si rischierebbe di nonottenere l'inviluppoÀ
Que ndo l`impulso della nota generata si eflievo-lisce, l'uscite di IC2 sl porterà e livello negativo eTR1 non conducendo più. permettere a CB dl sce-ricarsi tramite DS4-R14-R12-R11.
Dato che ll valore dl R14 e maggiore dl R18. alpossono ottenere ternpi dl rilascio più lunghi dlquelli :faticosoÀ
Sembrerebbe e questo punto che. per ottenere lepartenza di un nuovo inviluppo per la nota succes-sive, debba tinire quello della nota precedente.
ln realta non e cosi. perche se le sensibilite (tre-mite RS) e ben regolata. si ottiene un nuovo invi-luppo ad ogni pennata. anche se l'intervello tem-porale tre le note e brevissimo.
Questo perche le carica e le scarica di 06 nondipendono solo dalla posizione di R13 e R14, meanche dall'intensità dell'impulso ottenuto.
In altre parole. a diverse intensità dl pennatecorrispondono inviluppi diversi. dipendenti ln per-te delle posizioni di R13 e R14. ln questo modol'esecuzione acquista una dinamicità paragonabilesolo a quelle ottenibile con un'abile azione aul pe-dale tradizionale.
Ovviamente I'ettecco corrisponde ad un colpo dipedale in giù ed iI rilascio ed un ritorno in alto delmedesimo.
L'inviluppo generato arriva. tramite TFl2-TR3-CS. el llltro bassa-bende. Il cul guadagno puòeese-re regolato tramite R19, potenziometro che per-mette di variare il tono del segnale tiltrato.
L'alimentazlone di questo circuito. puo variareda un minimo di 9+9 volt ad un massimo di 15+15volt.
ll circuito e subito lunzionente. ma per le primeprove e consigliabile porre R5 al massimoe R13alminimo.
Una volta accertata la generazione dell'lnvllup-po. l'andemento puo essere regolato e piacere.
NOTE IEDAZIONALISu tale circuito e consigliabile attuare le seguentimodifiche:1) aumentare il valore di 810 e 10.000 ohm;2) collegare direttamente 810 el pledlno 6 di ICZ:3) collegare il diodo 082. precedentemente eIImI-nato. tre le base del transistor Tñt e le massa.owiamente con il positivo rivolto verso le basa diTR1;4) aumentare ìI valore di C5. portandolo ed unmassimo di 100.000 pF:5) diminuire II velore di 06. portandolo da 10a 4,5mF;6) collegare direttamente iI collettore di TRS suC7-C12, eliminando 09.
Intelti, esso lunga de "ponte" tre il collettore diTR3 ed ilpunto comune a CT e 012. per cui le suepresenza e Inutile.
113
deneaa'rone ol mnal; Aim-nam Lua- - ALaese (co)
Sono uno studente dell'lsiituto Ripamonti diComo. e oltre a montare i progetti pubblicati dallavostra rivista. che hanno lunzionato sempre al pri-mo colpo. mi diletto anche a progettame altri dimia Ideazione. Il circuito che vorrei proporvi e unsemplice generatore di rampa, molto economico,che può servire a carattere sperimentale o. comenel mio caso. per pilotare la scansione orizzontaledi un vecchio oscilloscopio.
ll lunzionamento del circuito è abbastanza sem-plice: tramite lCl. un NE.555, vengono generatidegli impulsi ad onda quadra la cui irequenza puòessere variata agendo sul potenziometro R2: que-sti impulsi. prelevati dal piedino 3 di IC1, vengonoapplicati sull'ingresso (piedino 5) di lCZ. un conta-tore"up-down" (cioe avanti-indietro) tipo 004029.IC2 e dotato di 4 uscite binaria che ianno caporispettivamente ai piedini 6. 11, 14, 2; questa uscitecambiano il loro livello logico quando all'ingreasogiungono gli impulsi ad onda quadra di lCl . Se una(o più dl una) dl queste uscite binaria si porta alivello logico “1" signiiica che In uscita risulta pre-sente la tensione di alimentazione, quando inveceuna (o più di una) delle uscite binaria è a livellologico "0". signiiice che internamente questa usci-ta risulta cortocircuitata a massa4 Pertanto dallecombinazioni binaria 1-0 si possono ottenere inuscita un totale dl 4 x 4 = 16 stati loglci diversi.Poichè sulle uscite 6. 11. 4. 2 sono presenti resi-stenze da:la : tm OIIIIIl : *ID-m OllllNS : 22m dinRI : SENO ohm
ogni volta che le uscite binaria di lCZ cambianolivello logico si iorma un diverso partitora rasiativo
(vedi R7 da 4.700 ohm collegata a massa) e sull'u-sclta risulterà presente una successione di “gradi-nl" di tensione. Questi "gradini" iormano appuntouna rampe. La tabella seguente mostra con chia-rezza come. variando gli stati logici della uscitabinaria di lC2. varie contemporaneamente la ten-sione della rampe (con una alimentazione a 12volt)
volt inuscita
Agendo su St si puo lare procedere la rempa"lnsalita"o"ìn discesa". cioe daßvolta12voltoppurada 12 volt lino a 0 volt.
Naturalmente a seconda della tolleranza delleresistenze H3. R4, R5. R6, R7 avremo una rampacon dei gradini di tensione più o meno uguali, chepotrebbero anche non corrispondere a quelli indi-cali nella tabella.
Dato che il circuito e stato progettato per usosperimentale. all'uscita non devono essere con-nessi carichi che assorbano più di 0.5 mllliAmper.
iløallll
ELENCO COMPONENTIR1 : 1.000 ohm 1/01."R2 : 41.000 ohm pot. lln.R3 : 4.100 ohm 1/0 WaltIN : 10.000 ohm 1/1 wattNS : 22.000 ohm1/l WI"NS : 39.000 ohm 1/6 WII!R1 : 4.100 ohm 1/4 wattci = 100.000 pr peu-umcz = 100.000 pF polini-uCS : 10 mF eletlr. 16 vol!IC1 : Integrato tipo NE.555ICZ : Integrate tipo (20.4029S1 : deviato"
o “Il
114
.- v..ma. mi»mi. ma..mu :mu
CIMIIZQ NE555
Con la speranza che questo mIo pregano vengada Voi valutato positivamente. esprimo I mlel corn-plimenti a tutta la redazione per il lavoro svolto intuttl questi anni a lavora dei lettori e porgo i mieisaluti.
NOTE REDAZIONALIPer ottenere in uscita una rampa più "simmetri-
ca ". cioe con gradini il piùpossibile uguali tra loro,vi consigliamo di sostituire H3, R4. R5, R6, R7 conle seguenti combinazioni serieparallelo:
113 : due resistenze da 10.000 ohm in paralleloR0 : 111m ohmR5 : due resistenze da 10.000 ohm in serieR0 : una resistenza da 22000 ohm con In serieuna resistenza da 10.000 ohm oppure quattro resl-stenze da 10.000 ohm in serieR1 : due resistenze da 10.000 ohm in parallelo
Slgfièo Vetro Stollno - HOSCIANO SANT'ANGE-LO (TE)PULSANTE ANTIRIIIBALIO
lI circuito da me progettato e molto utile in tuttequelle epplicazloni nelle quall, tramite un pulsante
esterno. sl vogliono Inviare degli lmpulsi ad unqualsiasi circuito elettronico digitale.
Ad esempio. volendo realizzare un contapezzl.capita spesso che, e causa dei "rimbalzi" sul con-tatto del pulsante, il segnale dl comando che giun-ge al circuito elettronlco` sia interpretato come unimpulso doppio o triplo ed in questo modo il conta-tore non potrà lunzionare correttamente.
ll circuito antirimbalzo consiste essenzialmentein un iiltro per la soppressione degli impulsi spuri,seguito di un circuito a trigger.
ll segnale del pulsante giunge sulla base deltransistor TRi attraverso la resistenza R1, ai capidella quale è presente il condensatore elettroliticoC1 di liltro. Dal collettore di questo transistor. tra-míte il condensatore CZ. ii segnale del pulsante.gia lIItrato, glunge sulla base del transistor TR!che, assieme al transistor THG costituisce il circui-to di trigger.
ln questo modo. eventuali rimbalzi che. per Illoro elevate ampiezza sono riusciti ad oltrepassareil primo stadlo di illtro. vengono ellrnlnati da que-sto secondo stadio.
Sul collettore del transistor TR2, ai capi dellaresistenze R6, e presente un segnale squadrato e'ripulito' che può essere percio applicato. in tuttasicurezze. all'ingreeso dei circuiti digitali di con-tegglo.
NOTE REDAZIONALIPer poter rendere iI pulsante pronto e ricevere
une successione veloce di comandi. vi consiglia-mo di aggiungere. in parallelo aI condensatoreelettrolitico Ci, una resistenza dn 1 megaoltm.
Per i transistor, potrete usare qualunque altrotipo di transistor NPN, come ad esempio i 86237.
ELENCO COMPONENTI
R1 : 100.000 ohm 1/4 watt82 : 1200 ohm 1/4 vrlttR3 : 1.500 ohm 114m!!114 : 330 ohm 1/4 wattR5 : 4.100 ohm 1/4 vraltR0 : 7.200 ohm 1/4 wattC1 : 4,1 mF elettr. 16 voltC2 : 4,7 mF llttr. 16 volt1111 _ transistor NPN tipo 862001112 : translator NPN tipo 56200TR! : trlnelltor NPN flpo BCI!!P1 = puru-m
115
ELENCO COMPONENTI
R1 : 10.000 ohm hlmmerR2 : 410.000 ohm 1/4 'l'11R3 = 1 Mugeohm 1/4 mltR4 : 1 Meglohm 1/4 'litR5 : 5.600 ohm 1/4 waltR0 : 100.000 ohm pot. lln.R1 : 41.000 ohm 1/4 wellR0 : 15.000 ohm 1/4 mitR0 : 020 ohm 1/4 wattR10 : 10.M0 ohm 1/4 'mltR11 : 2.200 ohm 1/4 mltR12 : 3.000 ohm 1/4 wattR13 : 41.000 ohm pol. lln.C1 :1mFIlellLZSvoltC2 : 47.000 pF polloetenC3 : 100.000 pF polintenC4 : 1 mF elettr. 25 voltcs = 100.000 pr poli-um00 : 2,2 IIIF IM". 2511011C1 :10mF0lettr.25volt00 : 100.000 pF polieetereFr1 = Fu tipe mseeIC1 : LM 141ici : Lll 35081 : hhnufloloSZ : MM
EFFETTO TREHOLO CON PSEUDO-RING PERCHITARRA ELETTRICASio. Luciano Iuruwe - MACERATA
Vorrei sottoporre elle Vs. gentile attenzione unprogetto di tremolo per chitarra elettrica che ha ilpregio di ottenere suoni simili el "RING MODULA-TOFl" o el "CHOPPEH VOX" dl vostre pubbllcazio-ne. II mio progetto e differenze di questi. non intro-duce lorti veneziani di lrøquenza. che possonorendere particolarmente diilicile l`esecuzìonedi unbrano. me lascia inalterate le lrequenza fondamen-tale conlerendo alle nota una piacevole colorazio-ne metallica. Questo etletto che ho chiamato“pseudo rlng" sl ottiene modulendo la note in InAgrosso con une lrequenu al limite dell'udlbilo.
Il let FT1 applicato in serio el segnale che daltenninlle d'ingreseo raggiungerà il piedino inver-tente (piedino 2) di lC1, si comporta in praticacome un potenziometro di volume, perchè modilì-ca Il sul resistenza interna secondo la polarizza-zione date da R1 e R6. Se S1 e aperto (tremolodisinserito) le R1, che polerizze negativamente il
116
IFZSI
gate dl FT1. "obbliga" lCt ad avere un guadagnouguale ad1circa.seínvece St e "chiuso" (tremoloinserito), il guadagno dell'ampliiicatore operazio-nele e continuamente modificato dal segnale tri-angolare dell'oscillatore IC2A-lC2B prelevato dalpotenziometro R6 da 100.000 ohm. lCZA-IC2B co-stituisce. nel suo complesso, un classicooscillato-rea bassa frequenza, nel qualeè poaibile sceglie-re 2 diverse frequenze di oscillazione agendo suldeviatore SZ. che collega alternativamente 06 o C7al pin Sdi iCZ-B4 Ho inserito tra la R12 e il deviatore82 un potenziometro che consente di variare in unarco preciso la ireq uenza di oscillazione a secondache sia collegato 66 o C7; cio permette di avere,con C7 inserito. una variazione che va da 1 Hz a 15Hz circa, e con CE. una irequenza più aim di 20-60Hz circa. E da notare il tatto che l'inclusione ol'esclusione dell'eifetto. tramite S2. avviene in mo-do silenzioso, senza cioè provocare i tastidioai“clik” dalla commutazione. spesso presenti in cir-cuiti simili. Per utilizzare il circuito è necessariooollegareall'ingresso la chitarra elettricaeall'uscl-ta un amplificatore; successivamente si ruota RG(protondità di modulazione) quasi tutto versomassa. agendo su P1 fintanto che non si sente inaltoparlante ll suono della chitarra leggermentemodulato. A questo punto ruotando R6 verso ilpiedino 7 di IC2 si dovrà avvertire un gradualeaumento della modulazione. che potremo variaresecondo i nostri gusti personali. Per quanto ri-guarda i'a 'mentazione dovremo utilizzare perquesto circuito una tensione duale di 15+ 15 volt.
NOTE REDAZIONALI
SUaccomenda di scherma/e tutto il circuito ln-serendolo in un mobile metallico, edlutilizzareperIlsegrrele in ingresso e uscite del cavetto schermeto. '
GONTAGIRI ANÀLOGIOOSig. Glovennl Bleello - 8.8EBÃSI1ÀNO (NA)
Sono uno studente appassionato di elettronica evorrai proporre ai lettori di “NUOVA ELETTRONI-CA" un progetto di contagiri analogico da utilizza-re su auto o moto con motore a quattro tempi.
I pregi di questo progetto sono la semplicità el'economicità, che penso saranno apprezzate so-prattutto dagli studenti, che. come me. sono spee-so souattrinati.
ll funzionamento dei circuito è estremamentesemplice: all'ingresso il tiltro formato da R1 e C1"pulisce" gli impulsi provenienti delle puntine pri-ma di applicarli alla base del transistor TR1. unECHO. Taletransístorva ln conduzione quando lepuntine sono aperte, entra invece in interdizionequando le puntine sl portano a masse. Sul colletto-re del TR1 c'e un diodo zener che limita l'ampiezzadegli impulsi ad un valore di 10 volt. prima chequesti giungano al successivo duplicatore di ten-sione lormato da 02. D1 e D2; a valle di tale dupli-catore è collegato uno strumentino da 1 mA checonsente di leggere la corrente che lo attraversaistante per istante. La deviazione dell'ago ci intor-ma cosi del numero di giri raggiunto del motore.Per tarare con precisione io strumentlno possiamoprocedere in questo modo: si collega ell'ingressodel contagiri il secondario di un traslonnatore ingrado di erogare 9-12 volt. si regola R5 fino a leg-gere un valore corrispondente e 3.000 giri/min. peri motori a 4 cilindri.
NOTE REPAZIONALIConsigliamo di Inserire tra le base del translator
ed il pos/tivo dl alimentazione un qua/eine] diodoraddrizzetore (1N4004-1N4007), onde evitare cheI'extretanslonegenerate dallapuntineposseprimao poi perforare il transistor.
ELENCO COMPONENTI
I" : 15.0000bm1/0'attR2 : 220 ohm 1/4 mltNS : 2.700 m1" VIII
R4 : molin! 1/0 'oilR5 : 1.50000t1n 1/0001!H0 : 1.000 ohm 1/4 wattCt : 1mF poliestereC2 : 500.000 pF polleeten
081 : diodo ei silicio "44002082 : dodo al silicio "44002021 : dodo zener 10 volt 1/2 IettTm = run-iaia NPN tipo acuomA = mllllamperometro da 1 mA Le.
111
PREAIIPLIFICATORE DI BFSig. Alessandro Vucotto - Muggia (T8)
Sono uno studente appassionato di elettronica evi spedisco questo semplice circuito che ho recen-temente sperimentato. allinchè venga pubblicatonella rubrica "Progetti in Sintonia". Lo schemaelettrico che vi invlo mi e stato molto utlle quandoml sl è presentata l'eslgenza dl amplificare il segna-le dl un microfono con elevata impedenza d'ln-grasso.
lnlattl questo preampllllcatore, che utlllzza unsolo translatortlpo BC14B. presenta una impeden-za d'lngresso di circa 2 megaohm. qulndi si adattaa qualsiasi tipo di mlcrolono o pick-up piezcelet-trlco a poiche la sua uscita presenta una impeden-za di circa 10.000 ohm. sl collega perlettamentesull'lngresso di qualsiasi preamplilicatore.
L'allmentazione di questo circuito non e aflattocrltlca e puo variare da 9 a 18 volt senza alcunavariazione di rendimento: il consumo che ho potu-to riscontrare e molto basso e varia leggermente aseconda della alimentazione, comunque non su-pera mai 1 rrlAA Peri collegamenti dl ingresso e diuscita ho utilizzato sempre del cavetto schermato.al line dl non captare induttivamente disturbi spurie ronzii a 50 Hz.
ELENCO COMPONENTI
Ill : 220.000 ohm 1/4 wattR2 : 600.000 ohm 1/4 vrattRS : 210.000 ohm 1/4 wattM : 150.000 Ohm 1/4 'lattR5 : 10.000 ohm pot. ltn.Ct : 100.000 pF poliestere02 : 10 mF elettr. 25 voltCS : 100 mF elattr. 25 voltC0 : 10 mF eletti. 25110"TI" : translator NPN tipo 8614!
BC".
118
NOTE REDAZIONALIPrecisiamo che il circuito presentato dal lettera,
non serve per preamplilicare alcun segnale di BF,ma solo ed esclusivamente come "adattatore d'lrrr-pedenza " in quanto il guadagno di tensione euguale a 1.
Ouesto circuilo è quindi utilissimo per collegaremicrofoni ad alla impedenza ad un qualsiasi pre-emplilicalore con ingresso e basse impedenza.
Poichè II transistor 56148 non risulta più Iacll-mente reperibile, possiamo assicurare che e pos-siblle sostituirlo con qualsiasl altro translator NPNal silicio preampllllcatore dl BF.
TIIEN PIN LUCI SCALAOli. DI Nleøll Carte WBUCETO (Ctttetl)
Ho realizzato questo timer per luci scala in quan-to. nel mIo condominio. quello elettromeccanica eandato più volte in "lume" a causa di espedientipocoprtodosei, ellettuati per owiare alla scomodaaccensione manuale tramite un pulsante. Pensan-do che qualcun'altro potesse avere lo stesso pro-blema, ho deciso di inviarvi il progetto. sperandoche venga pubblicato nella rubrica "progetti in sin-tonia'i
Il circuito come vedesi dallo schema elettricoutilizza componenti di recupero di cui ogni hobby-sta e sempre prowisto.
Dal secondario a 12 volt`del traslormatore T1. latensione alternata dopo essere stata raddrizzatadal ponte adiodi(vedlDS1e DSA), viene stabilizza-ta a 12 volt da TFt1 e poi utilizzata per alimentaretutto il trimmer.
Pigiando il pulsante P1 si polarizza la base diTR2. il quale si porterà in conduzione ed ecciterà ilrelè. ottenendo così la carica Immediata del con-densatore di temporizzazione Cd.
Nel corso della realizzazione, sono stato costret>to a collegare il pulsante P1 alla tensione di rete ead utilizzare TR2 e un relè a 12 volt. in quanto ipulsanti del mio condominio risultavano tutti col-legati alla linea a 220 volt.
Chi non ha questo problema. può eliminare dalcircuito P1-R2-D55-TR2-Ft3 e RELE ed applicaretutti i pulsanti della scala, in parallelo a P2.
Pigiando P1 o P2 il condensatore elettrolitico C4al carichera. portando in conduzione i due transi-stor TR3-TR4 ed eccitando il triac TRC1. lI quale asua volta. lomirà tensione alle lampadine della scala.
ll trimmer R4. presente nel circuito. serve perdeterminare il tempo di accensione delle lampadi-ne quindi. per raggiungere tempi maggiori di quelliscelti. si dovrà aumentare il valore del trimmer dalmegaohm a 4.7 megaohm.
L'lnterruttore Sl posto in paralleloa P2permettedi tenere accese costantemente le lampade della
p-ZIllZOLEOOOUZIll.aul
scala. per cul. evitando dl dover plglare li pulsanteogni 5-10 minull. questo circuito risulta panlco-lnnneme uiilo in caso di feste o traslochi.
Perquanio riguarda I iranslsior. sl può utilizzarequalsiasi PNP al silicio che abbia un guadagno dialmeno 00-100 volle. ad esempio BCIOT-Bcflß-2N706 od allri equivalenti.
NOTE REDAZIONALIAI poslo diquattro diodi ala/licia 1N4148, Indico-
ll nello schema alollrlco con DS1-DS2-DSä-Dsd.vl conc/qlllmo dl utlllzzlru un normal. pome ud-drizzaloro.
Pu i pulunli della sella, anche utilizzando P2tnx/che P1, I'Impllnlo risa/lori umpn col/.gnodlremmenle alla lina I 220 volt.
O A:n
O _. ^' 'i E-gc
O numro
llllco
10vo
li
dod
o1N
4140
pulu
nin
:ono
r13
.2vo
il- 1
/2M
2.000
ohm
- 1/0
VIII!
diodo
1N40
01
TIM
-THE
:NP
N'Ip
o56
101
n01
=lri
ll:400
voil
0Am
per
.200
ohm
50mF
om
ollilc
o10
voi!
150
InFel
C4220
mFom
oilc
o10
'oil
lrule
rmni
ore
prim
mve
ll-lo
cond
.iiv
oll
100mA
'1-7
2
500
mFøl
øflm
lllleø
1GVù
ll
0.200
ohm
RS:
1.500
ohm
`l/H
uil
Il:
1m
ogle
hmM
mm
.
Lpi
=lam
pada
mvd
S,_.E.Eß
Nu._c He
ll12
voi!
1m
mbl
o
R0:
1.000
Ohm
S1=
Inle
rnm
oro
C1 C2 N DSSl
-DS
G02
1
T1H2 R5 R7
119
ELENCO COMPONENTIR1 : 1.000 ohm 1/4 Il"R2 : 1.000 ohm 1/4 mi!R3 : 330 ohm 1/4 vllflR4 : 330 ohm 1/4 'unH5 : 330 ohm 1/4 vuflH0 : 1.000 ohm 1/4 '1.11R7 : 300 ohm1l4 v1.1!G1 : 47.” pOlkflm
02 :10mFQlIIIr0L10'0flDL1, DLZ, DLS : diodo lcd maoDL! : diodo led um1111 : translator NPN .I lllldø flpc 2901111IC1 : SN'MC"IC2 : $N7473IC3 : SN1400Altopuianlc l ohm - 0.5 “IlP1A-P1B : Whlmdøpplø
m nun iln n
v.. mm u
m1 mn m
SII 1473
TOTOOALCIO ELETTRONICO“Sandmßñfloio-SoahåfllelJII)
Sono abbonato alla rivista da 3 anni e ho decieedi cercare anch'io un piccolo spazio nella rubrica"Progetti in Sintonia" con un simpatico congegnoche potrebbe rivelarsi molto utlle per giocare laschedina.
Molte persone. oorne me. pur non essendo tiioeldl calcio o continuamente al corrente delle classi-llca, sfidano la iortuna con una successione disimboli del tutto casuale. nella speranza che la"dea bendata" si ricordi un podi loro. Talvolta perola scelta del simbolo puo provocare ripensamentl orimorsi; perchè allora non atiidare questa sceltacruciale a un "consigliere" imparziale come il"TOTOCALCIO ELETI'RONICOWI Proprio perquesto motivo ho ideato il progetto che ora vl de-acrivero brevemente: due inverterv contenuti all'in-terno di lCt. sono utllluati come oscillatori adonda quadra per iniettare. attraverso il doppio pul-aante Pt-A e Pt-B. una frequenze di clock sugliIngressi del doppio "ilip-ilop" 7473 denominatolCZt Sui piedini 8. 9. 12. 13 dl ICZ e presente unaauooeaelone dl impulsi che viene applicata agli in-
:srrons oi melone oa ev. A 12v. PencicLouoromsu. AmmTW - mmm (ro)
A molti proprietari di ciclomotore potrà Interes-eare questo semplice progetto che consente dialimentare autoradio. piccoli radiotrasmettitori osirene ampllticate che normalmente funzionano e12 yolt. partendo dal 6 volt a corrente alternatalornìti dall'elternatore presente sul ciclomotore.Comesi può vedere dallo schema elettrico, si trattadi un progetto estremamente semplice che utilizzasolo 4 condensatori. 3 diodi. 1 resistenza e 1 inte-grato per stabilizzare le tensione ll circuito e lor-mato da due stadi: Il primo e un triplìcatore dltensione, costituito dai condensatori Ci. C2. 03 edal diodi DS1. DSZ. DS3. che eleva I 6 volt ACprovenienti dall'altematore. a circa 1B volt CC. La
pressi dl 4 porte AND contenute all'lntemo di im.un SN7408. La uscite di |03 sonocollegatefl LEDrispettivamente equivalenti a "t, X. 2" e. per man-tenere un po di suspense. un "Repeet". ci indica dleseguire un'altra selezione. Appena si alimenta ilcircuito subito si accendere il diodo LED del "Re-peat". il DL4, e questo resta acceso anche quandosi tiene pigiato il doppio tasto P1-A e Pt-B pereffettuare la selezione; sull'anodo del DL4 ho pre-levato il simpatico suono che risulta della modula-zione reciproca dei due oscillatori IC1-A e IC1-B,per poterlo ascoltare. amplificato da TFlt. dirette-mente su un piccolo altoparlante da 8 ohm.
NOTE NEDAZIONALIIl circuito teoricamente e perfettamente lunzlo-
nente, se desiderate modificare le frequenze diclock, potrete renderla più lenta o più veloce al-zando o abbassando rispettivamente Il valoredi C1e C2.
Precisiamo che P1 -A e Pl-B e un doppiopulean-to e poiche questo non risulta lacilmente reperibi-le, si potrebbero utilizzare duepulsanti, incollandoassieme idue cappucci con un pezzetto diplastica.
resistenza R1. di basso valore ohmmico. serve alimitare la corrente quando il motore va "su di girl".Il secondo stadio. formato da IC1 e C4, serve perstabilizzare la tensione in uscite sul valore di 12volt. La corrente massima che sl puo prelevare lnuscita da questo elevatore è di circa 1 Amper.
NOTE HEDAZIONALIPreclaiamo che questo circuito puo essere Im'-
Iizzalo su ciclomotori o motocicli sprowisti di bet-leria perche funziona solo con tensione altemell.cioe non e possibile slruttare questo elevatore ditensione applicando ei suo Ingresso una tensionecontinua. Vi consigliamo di dotare IC1 di una pic-cola eletta di rallreddamentoperdissipare il caloregenerato nei/integrato. qualora la radio assorbeuna corrente elevata.
ELENCO COMPONENTIi'tt : 1.5 ohm 2 wattC1 : 4.700 elettrol. 10 volt62 : 4.100 eiettrol. 10 volt63 : 4.100 elattrol. 10 voli64 : 50 mF alettrol.10 volt081 : diodo al silicio 1N4001082 : diodo al silicio 1N4001DS! : diodo al elliclo 1N4001IC1 : Integrato tipo uATll!
121
PREAIIPLIFICATORE PER STRUMENTI IIUSI-CALISig. Morto Town! - LOANO (sv)
Vi invio uno schema di preempliiicetore perstrumenti musicali che ho progettato e realizzatopersonalmente e che mi ha procurato molta soddi-siazlone per gll etietti sonori che genera.
Come si vede dallo schema elettrico, questosemplice preampliiicatore la uso di due translatorNPN al silicio per bassa irequenza. Le particolaritàdel clrculto consiste nel tatto che il segnale musi-cale applicato all'entrata non solo viene preampli-ticeto. ma anche squadreto dai diodi D81. DSZ,D83. D84. conierendo alla melodia una tonalitàmetallica. Ho inserito due trimmer. R11 e 812, perconsentire un buon controllo sugli eitetti generatidal preempliiicatore; più in particolare agendo orosull'uno ora sull'altro. si può variare le tonalità erenderla cavernosa o graliilante4 Il potenziometroF113 che ho inserito in uscita serve per dosare ilvolume del segnale musicale che potremo diretta-mente applicare ad un ampli/icetore di potenze.Naturalmente per collegare sia l'ingresso sia l'usci-ta di questo preampliiicatore si dovrà usarecavettoschermata
NOTE REDAZIONALICame glå precisato dall'autore, questo circuito e
un proaml/ícatore-squadralore quindi può servi-re egregiamente per modificare il `mono di unachitarra elettrica, ma non come normale preempli-iicatore. sempre che non si desideri ricavare `ruonìdistorti.
122
ELENCO cOIPONEIiITlR1 - 41.000 ohm 1/4 IMIR2 00.000 ohm 1/4 '01|
Meglohm 1/4 urli!R4 0.000 ohm 1/4 vllttR5 - 10.000 ohm 1/4 vvlll
0.000 ohm 1/4 vIlIt.100 ohm 1/4 vuttMegaohm 1/4 walt
R10 _ 10.000 ohm 1/4 vrlflR11 : 10.000 trimmerR12 : 10.000 trimmerR13 : 10.000 ohm pot. log.G1 : 100.000 pF poliestere
00.000 pF oollectm0 mF elettr. 18 voltmF elettr. 16 volt
0.000 oF pollestore0 mF elettr. 16 voltmF elettr. 1G voli
0 mF etettr. 10 volt
DS1 diodo al slliclo 1N4140082 : dlodo al slllclo 1N414!083 : diodo al silicio 1N4140DS4 : diodo Il slliclo 1N4148m1 : trlnsleìor NPN 861091112 : Irlmlltor NPN 0610!
OWIJJTORE T'I'L con DUTY CICLEmSig. Ilanoocnl Giancarlo ROMA
Credo che qualsiasi sperimentatore elettronicoalle prime armi desideri entrare in possesso dl ungeneratore d'impulsl ad onda quadra. semplice.economico. di lacile uso, affidabile In vogni suecaratteristica elettrica. che abble. insomma. tuttele carte in regola per poter essere impiegato consuccesso nel collaudo di qualsiasi circuito logicodigitale TTL o C/Mos o nelle verllica del funziona-mento delle apparecchiature di basea lrequenza.
Ebbene. che lo crediate o no, con un eelguonumero dl componenti ho letto el che. nell'lnteree-ee dl tutti i lettori dl Nuova Elettronica. quellodealderlo loeee aoddlalatto.
ll circuito la uso dell'arcinoto Integrato a loqlcaTTL tipo SN 7400, le cul porte NAND sono collega-te in modo da realizzare un multivlbratore astablledove ìl duty cicle del segnale, owero il rapportotrela durata In cul l'usclte rimane a livello alto ed Ilperiodo del treno d'impulsi in uscita. può essereregolato. per mezzo del potenziometro R2. lre il10% ed ll 80% e la frequenza di lunzlonamentovarlala. agendo semplicemente sul commutatoreSl.
Lo stadio formato dal transistor NPN 502375costituisce. invece. I'interlacole logico C/Moe.
Se volete collaudere degli apparati di bassa lre-quenza, il segnale potrà essere prelevato dalla pre-sa CMoe. tramite un condensatore da 100.000 pFpoliestere.
Per alimentare il circuito. si lmpleghera una co-mune batteria da 9 Volt; la resistenza limitatrice R4.insieme al diodo zener DZ1. rldurranno pol taletensione a 5.1 Volt per una corretta alimentazionedell'lntegrato SN 7400.
NOTE REDAZIONALIlI progetto ci sembra lnrereaaante ma I'Aulon al
e dimenticato dl Indicare] quali sono la frequenzeottenute ruotando nelle quattro poalzlonl lI com-mutatore Sl.
Pensiamo ala url/esepara che, allepos/zioni 1-2-3- 4 del commutatore S1. corrispondono rlspettl-vamente Ie lrequenze dl clrca 250-1.100-2.500-25t000 H1.
ciamc "c/rca" perche, come al al. occorresempre considerare la tolleranza del condensatorlimpiegati.
"Ill
I! I" IImi
ELENCO OOUPONENTIR1 : IUdIIH/OWR2 : LMoIInpotenzlln.I" :1Udlll1/IWR4 :HMI/.VIR5 :LmdlIH/ÂVIH6 : ImohrnfilwC1 :l,1raFdettrolltloo10V
c: = 1 mr mutu» 10 vce = 410.000 pF peli-mnca = 41.000 pr palmnei = dim "maos: = dim mmrm = unum' NPN ecwici = int-quia su.1400si = commi-mn mm a 4 mi. Slfllßll
123
0010! MICRO
ADATTATORE MICROFONICO PER 11204Sig. Gluuppo Bllincli TOLVE (PZ)
Vi invio questo circuito che ho progettato perrendere plù prolessionale le centraline dl lucl pal-chedeliche (LX.264 apparsa sul n. 56 dl N.5.) chegià da tempo ho realizzato.
lo ho utilizzate una capsula microlonica pream-plilicata siglata KUC 1215, ma anche una di mlnorpregio può andare bene, persino una recuperatida un registratore in disuso.
Il circuito può essere impiegato in molteplici oc~casìoni. ma a coloro che, come me. lo utilizzerannoper comandare le centraline di luci paichedellcheLX264, raccomando dl prelevare i 12 Volt dirette-monte dall'alimentulonel messa isolata presentenel kit stesso.
NOTE REDAZIONALIIn hse di collaudo regolare lI trimmer R8, in mododa ottenere il massimo segnale con la minore dis-torsione.
ELENCO COMPONENTI
R1 : 4.100 ohm 1/4 WillR2 4.700 ohm 1/4 WillR3 1.000 Ohm 1/4 WillH4 : 02.000 ehm 1/4 uittH5 : 60.000 ollm 1/4WitlR6 : 100 olun 1/4 willR1 : 1.000 ohm 1/4 WillR8 : 10.000 ohm trimmerH9 : 56.000 ohm 1/4 Will
15.000 ohm 1/4 watt.600 ohm 1/4 will
1.500 ohm 1/4 wall100 ohm 1/4 watt
C1 = 10 mF elettrolltloo 25 volt62 : 100 mF elettrollllco 25 volt63 : 10 mF eletlrnlltleo 25 voltC4 : 47 mF elettrolltlco 25 vollCS : 10 mF eletlrolltlco 25 voltCG : 41 mF elettrolltlco 25 voltTR transistor NPN tlpo 50109TR2 lranslslor NPN llpo 2N1111MICRO : capsula preampllllcala
SIT/41080200
SIP/4121
124
PRECISO GAFACIIIETRO FEI FREQUENZIIIE-TROSig. Lorenzo Fiocco - VERONA
Questo progetto di capaciinatro potra certamen-te interessare tutti coloro che dispongono di unlrequenzimetro digitale dotato di "Ingresso cro-nometro". infatti con due soll integrati, un transi-stor e poche altri componentl potrete facilmentetrasformare il vostro frequenzimetro in un precisoed affidabile capacimetro digitale.
Il funzionamento del circuitoè il seguente: all'ln-terno di ICZ. un SN74121, è presente un monosta-blle che fornisce sulle uscite (piedini 1 e 6) unimpulso che ha un periodo proporzionale al valoredella capacità (CX) collegata tra il piedino iodi IC2ela base del TR1 un 86206; il periodo dell'impulaofornito da questo monostabile e del tutto indipen-dente dalla lunghezza dell'impulso di comando (oSTART) che viene applicato agli ingressi (pledlnl 3e 4) di ICZ. ln tal modo applicando un condensato-re di capacita incognita al posto di CX otterremoeull'uscita di ICZ un "tempo" la cui lunghezza èmisuraoile collegando agli ingressi START eSTOP del frequenlimetro rispettivamente Il piedi-n01 e il piadlno 6 di ICZ.
Il compito del transistor TRl e quello di elevarel'impedenza d'ingresso dl ICZ, infatti collegando Ilcondensatore sotto prova direttamente sul piedini11 e 10 dei monostebile. questo avrebbe fornito inueclta "tempi" troppo brevi. giacche il valore com-pleoelvo che sl puo usare per R5 e H6 in un circuitodel genere` non avrebbe potuto superare i 40.000ohm. Con il TRl. che introduce un alto guadagno.si possono usare invece per R5 e R6 elevati valoriohmmici (rispettivamente 500.000 ohm e 680.000ohm). ad otteneredei "tempi" in uscita a 102 ragio-nevolmente lunghi per essere misurati.
I pulsanti P1 e P2 servono rispettivamente perdare il RESET e lo START al capacimetro e agisco-no su un “flip-flop" costituito da IC1A e IC1 B. duedelle tre porte NAND a tre ingressi. che sono con-tenute in un SN7410 (il terzo NAND e inutilizzate).Questo "flip-flop" quando vlene premuto ll pulsan-te P2 di START applica un fronte discendente sulpiedini 3 e 4 di ICE e fa partire Il monostablle, llpulsante P1 dl RESET ripone un Ilvello logico 1sugll Ingressi di IC2.
Per la taratura occorre soltanto disporre dI uncondensatore a bassa tolleranza dl valore noto ecollegarlo al posto dl CX: si collega poi I'uecita 1 diICZ all'ingresso “START CRONOMETRO" dal fre`quanzimetro e l'usclta 6 all'ingreseo "STOP CRO-NOMETRO". si agisce su P2 (START) e si regola IItrimmer R5 fino a leggere sul display del frequen-zimetro l'esatto valore del condensatore. Una voltaeffettuata la misura bisogna resettare il capacime-tro agendo su P1 e merare la lettura del frequen-zimetro con l'epposito reset. La capacita più picco'la che possiamo leggere dipende dal tempo mini-mo che Il vostro frequenzimetro riesce e misurare:comunque è meglio non cercare di misurare con-densatori con valori inferiori a 10 pF. poichè lecapacità parassita del montaggio potrebbero lal-sare la lettura.
NOTE REDAZIONALIOueato progetto serve solo ed esclusivamente
pari fraquanzimetn' che dispongono dldue Ing/ea»si aualliari S TAHT-STOPper la lunzlone cronome~troÀ
Sa dovesse risultare difficile la taralura del capa-cimefro vi consigliamo di aumentare il valore deltrimmer R5 portandolo degli attuali 500.000 ohm a2.2 Megaohm.
ELENCO COMPONENTIR1 : 1.0fIJ ohm illlrettR2 : .0m ohm 1/4 wattla : .0M ohm ill vrellR0 : 33.” ohm 1/0 Il"R5 : 500.000 ohm trimmer mult.RG : 020.000 ohm 1/0 WittC1 : 100.000 pF polleetmCi : 100.000 pF poliestereTR1 : translator NPN 8mIC1 : Integrato tlpo 8041410lcz = Int-ema tipe sunmP1 : pulsante apertol'2 : pulaente aperto
125
Fra le tante Iettereche glomalmenta pervengono alla noatra redazione. moltis-sime hanno come unico scopo la richiesta di uno o più numeri arretrati lnomaggio. oppure la richiesta di sconti eccezionali, sempre per l'acquisto dlnumeri arretrati della rivista.Un giovanissimo amico, studente di elettronica in un Istituto Proiessionale diPisa ci scrive:
"...Ho tanta passione per I'elettronica e desiderarei ampliare le mie cono-scenze attuali acquistando numeri arrelrati della vostra intaresaente rivista.consigli-temi non solo dal rnio proieeet'rrov ma anche dal rniei amici. Inutiledirvi, paro che la rnle tasche distudente sono sempre vuote e che 3.0001lre perogni numero rappresentano per me una spesa eccessive* non potreste larmiuno sconto. oppure raga/armi qualche numero? Ve ne sarei eternamenteprato”.Un operaio dl Genova In cassa Integrazione ci dice invece:
“...devo innanzitutto ringraziare le vostra rivista per avermi permesso ditemponere una situazionev che per me e Ia mia famiglie stava diventando
tragica. Trovandoml improvvisamente senza lavoro, lio provalo e sbarcare il Iunarid montando a riven-dendo alcunivostriprogetti. Mi sono cosi creato una certa lama di “esperio"in elettronica e ben presto horicevuto una valida offerte di lavoro da un laboratorio di riparazioni radio TV dal mio quartiere. Ora.essendo stato assunto in prove, vorrei aggiornarmi ulteriormente leggendo dei numeri arretrati che nonpossiedo, ma poiche le mia linanze attuali non sono ancora del tutto rosee, gradirei sapere se eslíte'lapossibilita di avere qualche sconto”.Per ultimo. la scolaresca di un Istituto di Napoli, ci scrive:
"_..Siamo un gruppo di amici iscritti al corso di elettronica a poiche quasi tutti i progetti che I nostriprofessori ci lanno montare ln laboratorio sonopralevatidalla vostra rivista, vorremmo poter rlcevere i n.46-64-70-73-77-81-86-88-95-98, che mancano alla noslra collezione, ad un prezzo da "studenti". Incambio, vi promettiamo di pubblicizzare sempre più la vostra rivista presso i nostri amici. anche esoprattutto perche e ellettivamante Ia rivista più qualificata che il mercato attualmente possa ollrlre".Come vedete sono tutte richieste degne della massima attenzione e che noi vorremmo con tutto il cuorepoter soddisfare e. nei Iimitl dei possibile` cerchiamo sempre di lario,Quando, pero di richieste ne arrivano più di mille in un mese, come ste accadendo negli ultimi tempi.aoddlslarle tutte diventa un problema veramente serio. oltre che un onere insostenibile per le rivista.Come saprete. intatti. allo Stato non interessa se la rivista viene regalata e I'IVA la pretende in ogni caso ecosi pure la Posta non accetta il pacco senza lrancobollo, anzi più il paccoe grosso. più trancobolli vuole.Le ditta che ci tornisce i canoni per I'imballaggio; I'operaio che conieziona II pacco vuole a sua voltaessere pagato e così dicasi per iI lattorino che deve trasportare i pacchi all'utlicio postaieed attendere Inilla. (a volte anche per ore), che questi vengano accettatiComplessivamente abbiamo calcolato chela spedizione dl un pacco del peso di soli 2,5 chilogrammi clcosta un qualcosa come 5-6000 lire che moltiplicati per 1.000 diventano diversi milioni.Cio owlamente non e compatibile con le esigenze amministrativedella rivista, ma nelloateseo tempo nonci distoglie dal desiderio di aiutare coloro che ce lo chiedono.Vi lasciamo pertanto una proposta che riteniamo molto valida.Noi vi spediamo in regalo 20 rMate arretrate in un unico pacco del peso complessivo dl circa 5chilogrammi e voi in cambio ci corrispondete la clira di L. 11.000 (undicimila) a copertura dell'lVA. dellespese di confezione. imballaggio. trasporto e postali.Chl vorrà approfittare di questa ottena. non ci richieda determinati numeri arretrati. in quanto i pacchisono già preconlezionati in modo da contenere ciascuno 20 diverse riviste scelte a caso tra quelladisponibili. che vanno dal n. 46 al n. 90. (sono esaurite le n. 50-54-55-63-67).Resta sottinteso che questa è un'ettem apechte rivolta soprattutto ai giovani con tanta passione perl'elettronica e scarse risorse llnanziarie. quindi, per chi richiederà un solo numero arretrato. il prezzorimarra invariato a 3.000 lire per copia.Per ricevere questo pacco omaggio. si può utilinare ll CCP qui allegato.
LA DIREZIONE
128
Nuovi orari del Meteosat pcf Il manina
EE(.5m
u8
22523022
n8
8.5:;Eoz
n›m_
mm
oo=cm=<ocw
w00
"m0
ma
oä
wlw
ucì
Eoz"N
Om
mou::m
=<
u..cz“N
EW
m2
55
19
35
«25:5uaw
"NO
ou=cmzm952
na
w.m
omzuonläašm
oucoëH
POÈW
L5
mìë
uto
uo
tzozcm
uH
8w=nñú>u=a=
“n°0
LS
om
wo
äxšìo
uco
šH
HO
ÈQ
mm
Em
EoB
ouomutìošuO
unoo:
“Sucuåm
flmoo
nm
25_›_w
on=oEH
.rOÈ
o0
O22:25.?6:
mucm
Eanzwhvn
mozm
cìuzmn
:E0
0autuncm
ìcìmu
"Ém
š
_m
:MM
MW
==
==
MW
MH
QM
__
A=
=IM
NH
=..=
mM
NH
B
DrD
ZìQ
DD
18
92
2JD
D2
13
21
30
00
0_
_:_
_::
__
:w
ub
ccß
mn
nn
nccm
m_
;:DD
D_
DD
D3
3D
.__..m
mw
mm
mm
mm
mw
mm
___.mm
mm
ßumm
mm
mm
=2
32
a_
_:M
ww
m::::m
wm
mH
EM
MM
W::::M
MM
:_:
D.
.___mm
mm
mm
mm
mm
muw
.__
_m
mm
nm
-Hu
mm
mu
n2
32
1.D
Dfl__m
mm
mm
mm
mm
wm
mm
fi__mm
mm
mm
,mm
_mm
mm
í_.
D.
HE
NM
MW
:==
=M
MM
HH
IHW
_.M
WM
W=
::=M
MM
HH
gD
D2
3D
D2
3D
D_
__
_m
mm
mu
mu
üm
mm
äa
mm
um
mw
ßm
mp
mm
wwflu
11
wz
a1
an
.___mnm
mm
mm
mm
mnm
__m___.m
wm
nmm
wm
wm
me
,_
2a
__
:M
mm
m::::M
mm
::W
m,:M
mm
mñ
::::m
wm
::
`M
D¬D
I3
:_
_m
mm
:=
==
=m
wfl=
:m
mu
mm
mm
mwflm
mm
hw
mw
.1,
,“
d2
3,2
,3D
Dü
fmá
mm
mm
mm
mm
wm
=fl
nfww
wm
mm
mm
mw
mm
ma
_.:EEim
.SEEW
..uvN