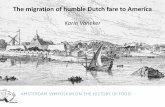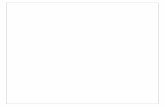Native plants fare better against an introduced competitor with ...
Fare Elettronica 212
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Fare Elettronica 212
REALIZZAZIONI PRATICHE • TUTORIALS • RADIANTISTICA • COMPUTER HARDWARE
TUTORIAL
• LE INTERFACCE SERIALIRS-422 E RS-485
HARDWARE
• INTRODUZIONE AI CCD (IIa parte)
• RABBIT BY EXAMPLE
• GENERARE SEGNALI VIDEOIN REAL-TIME UTILIZZANDOUN PIC16F84
AUTOMAZIONE
• RECS 101
€ 4,13 - Frs 8,00N° 212 - FEBBRAIO 2003 - ANNO 19
ALL’INTERNO LE PAGINE DI:
Sped
izio
ne in
A.P
. - 4
5% -
ART
. 2 C
OMM
A 20
/B L
EGGE
662
/96
- Fi
liale
di M
ilano
. In
caso
di m
anca
ta c
onse
gna
rest
itui
re a
ll‘ed
itore
che
si i
mpe
gna
a pa
gare
la r
elat
iva
tass
a pr
esso
il C
MP
di R
oser
io -
Mila
no
ELETTRONICA GENERALE
• ANTIUMIDITÁ PER MURATURE
• AMPLIFICATORE PER MICROFONOAD ELEVATA SENSIBILITÁ
• TERMOMETRO ELETTRONICO A COLONNINA
• CIRCUITO ELETTRONICO ANTIBALBUZIE
INTERRUTTORECREPUSCOLARE A 4 LIVELLIINTERRUTTORECREPUSCOLARE A 4 LIVELLI
TERMOMETRO AQUATTRO CIFRETERMOMETRO A QUATTRO CIFRE
Tiziano [email protected]
reda
ziona
le Di questi tempi è sempre più di moda abbandonare il vecchio sistema numerico,utilizzato come numero progressivo delle diverse versioni di software, in favore disuffissi più esotici come X, XP, MX e via discorrendo.Bene, andando controcorrente come nostro solito, vogliamo riportare in auge il buoncaro vecchio numero di versione, quindi ecco a voi, cari lettori, “Fare Elettronica 3.0”.Vi presentiamo il nuovo layout grafico e alcune delle nuove rubriche (altre arriverannoin futuro), ma soprattutto iniziamo il giro di boa che porterà Fare Elettronica ad offrirecontenuti sempre più interessanti e istruttivi. E’ nostra intenzione proporre sì dei pro-getti da realizzare, ma anche aiutarvi a capire quello che state costruendo, affinchépossiate imparare divertendovi.
Prima di illustrarvi i contenuti di questo numero, lasciatemi introdurre un nuovo auto-re che da questo mese inizia a collaborare con Fare Elettronica:
Cristian Randieri, PHD student in Informatica e Telecomunicazioni presso l'Università degli studi di Catania, nonché ricercatore presso l'Istituto Nazionale di fisica Nucleare.
Come al solito, un numero ricco di progetti ed informazioni! Cominciamo con l’ultimaparte di “Introduzione ai CCD” di Riccardo Ricci ed una nuova puntata di “Rabbit ByExample” di Sergio Tanzilli. Dopo il tutorial sui dissipatori del numero scorso, VincenzoVilla presenta la prima parte di un tutorial sulle porte seriali RS485 e RS422. I lettori piùaffezionati sicuramente ricorderanno il progetto “PIC-PONG” presentato nel numero diGennaio 2000, bene, Rickard Gunèe ritorna con un interessante articolo che illustracome generare il segnale video in real-time utilizzando un PIC16F84, l’articolo di fattospiega la tecnologia che c’è dietro i due progetti (Pic-Pong e Tetris) che saranno pre-sentati nel prossimo numero.I due termometri presentati da Giulio Buseghin non mancheranno di soddisfare levostre esigenze di controllo della temperatura; Andrea Marani, come suo solito, pre-senta due progetti originali: “Antiumidità per murature” e “Circuito elettronico anti-balbuzie”. Sul fronte dell’automazione industriale, Cristian Randieri presenta “RECS101” un interessante dispositivo per il controllo remoto.Infine, molto interessante anche MHz che questo mese riporta due articoli: “SpecialeAntenne” e “I primi passi della modulazione di frequenza in Italia”.
Prima di terminare, vorrei ringraziare personalmente tutti i collaboratori di FareElettronica che hanno lavorato duramente all’implementazione del nuovo layout, sop-portando pazientemente le mie continue e pressanti richieste, un grazie a Monica,Ilaria, Stefania. Un sentito ringraziamento a Piera Loddo e Angelo Cattaneo per la lorofiducia e a Ivano, Mattia e Vinicio della GRAFICONSULT, i quali si sono occupati dellostudio grafico e della prima impaginazione.Infine ringrazio sopratutto voi, cari lettori, che ci avete seguito in tutti questi anni anchenei momenti difficili, speriamo di contraccambiare la vostra dedizione offrendovi unarivista che vi faccia passare ore liete di lettura, sperimentazione e apprendimento.
Il numero di Marzo si annuncia ancora più ricco, vi rinnovo quindi l’appuntamento inedicola e l’invito a scrivermi per farmi conoscere le vostre impressioni su FareElettronica 3.0.
Buona lettura.
RICOMINCIAMO DA 3.0
3
elenco inserzionisti
DIRETTORE RESPONSABILE:Angelo Cattaneo ([email protected])
DIRETTORE TECNICO:Tiziano Galizia ([email protected])
REDAZIONE - SEGRETERIA:Stefania Cucchi ([email protected])
GRAFICA E IMPAGINAZIONE:Progetto grafico: Graficonsult - Milano ([email protected])Impaginazione: Piera Loddo ([email protected])Monica Ambrogi ([email protected])Ilaria Borghese ([email protected])
HANNO COLLABORATO:Andrea Marani, Cristian Randieri, Fabrizio Fazio, Giulio Buseghin,Giuseppe Signoris, Riccardo Ricci, Gianpiero Filella, Sergio Tanzilli,Rickard Gunée, Vincenzo Villa, Carlo Pria.
DIREZIONE - REDAZIONE - SEDE LEGALEDTP Studio Editrice srlVia Matteotti, 8 - 28043 Bellinzago N.se (NO)Tel. 0321/927287 - Fax 0321/927042E-mail [email protected]
PUBBLICITÀ:DTP Studio O321/927287 (Redazione)
STAMPA:SATE - Zingonia - Verdellino (BG)
DISTRIBUZIONE:Parrini & C. S.r.l. piazza Colonna, 361 - 00187 Roma.Il periodico Fare Elettronica è in attesa del numero diiscrizione al Registro Nazionale della stampa.
UFFICIO ABBONAMENTIPARRINI & C. S.r.l. Servizio abbonamenti Via Tucidide, 56/ bis/Torre 1Per informazioni, sottoscrizione o rinnovo dell’abbonamento:Telelefono: 02/76119009 - Fax: 02/76119012.
Una copia € 4,13 (arretrati: € Euro 8,26; non vengono evase richieste di numeri arre-trati antecedenti un anno dal numero in corso). Abbonamento annuo € 33,00 estero€ 95,03. Spedizione in abbonamento postale 45% art. 2 comma 20/B legge 662/96 -Milano. Per sottoscrizione abbonamenti utilizzare il c/c postale 12767281 intestato aDTP Studio Editrice - Casella Postale n° 100 Bellinzago Novarese (NO)
Autorizzazione alla pubblicazione del Tribunale di Novara n. 24/97 del 17/6/1997 © Tutti i diritti diriproduzione o di traduzione degli articoli pubblicati sono riservati. Manoscritti, disegnie fotografie sono di proprietà di DTP Studio e non si restituiscono. © Diritti d’autore: Laprotezione del diritto d’autore è estesa non solamente al contenuto redazionale di FareElettronica ma anche alle illustrazioni e ai circuiti stampati. Conformemente alla leggesui Brevetti n.1127 del 29-6-39, i circuiti e gli schemi pubblicati su Fare Elettronica pos-sono essere realizzati solo ed esclusivamente per scopi privati o scientifici e comunquenon commerciali. L'utilizzazione degli schemi non comporta alcuna responsabilità daparte della Società editrice. La Società editrice è in diritto di tradurre e/o fare tradurreun articolo e di utilizzarlo per le sue diverse edizioni e attività dietro compenso con-forme alle tariffe in uso presso la società stessa. Alcuni circuiti, dispositivi, componentiecc. descritti in questa rivista possono beneficiare dei diritti propri ai brevetti: la So-cietà editrice non assume alcuna responsabilità per il fatto che ciò possa non esseremenzionato. Domande tecniche: Per ragioni redazionali, non formulare richieste cheesulino da argomenti trattati su questa rivista. Per chiarimenti di natura tecnica riguar-danti i kit elencati nel listino generale oppure gli articoli pubblicati, scrivere a: DTP Stu-dio Editrice srl, Via Matteotti, 8 - 28043 Bellinzago N.se (NO).
contatti
Artek 71-87Electro Services 13Elettroshop 11Europart 23Futura 9-57GPE kit 43GRIFO II cop.Graficonsult 81HSA III copPianeta elettronica 31Sandit 90Twintec 29
collaborazioneLa redazione di Fare Elettronica è alla continuaricerca di collaboratori per la stesura di articoli,progetti, tutorials e rubriche.Alla rivista possono collaborare tutti i lettori.Gli articoli tecnici riguardanti i progetti realizzatidovranno essere accompagnati possibilmente confoto a colori, schema elettrico, circuito stampatoed elenco componenti.Per richieste di collaborazione scrivere [email protected] o telefonare al numero0321-927287.
Richieste arretrati, libri o abbonamenti:[email protected]
Commenti sulla rivista:[email protected]
Segnalazione errori:[email protected]
Richieste di tipo generico:[email protected]
Richieste telefoniche:0321-927287
Richieste a mezzo fax:0321-927042
Richieste a mezzo posta:Redazione di Fare ElettronicaDTP Studio EditriceVia Matteotti, 828043 Bellinzago Novarese (NO)
SOMMARIOelettronica generaleAntiumidità per murature 10
Amplificatore per microfono 24ad elevata sensibilità
Interruttore crepuscolare a 4 livelli 32
Termometro elettronico a colonnina 38
Circuito elettronico antibalbuzie 44
Termometro a quattro cifre da -55 a +125 °C 60
tutorialLe interfacce seriali RS-422 e RS-485 74
automazioneRECS 101: un web server embedded 14per applicazioni di controllo remototramite TCP/IP
hardwareIntroduzione ai CCD: seconda parte 48
Rabbit By Example 54
Generare segnali video in real-time 66utilizzando un PIC16F84
mhzTop Project: speciale antenne 92
Old Radio: i primi passi della 98modulazione di frequenza in Italia
rubriche
Antiumidità per murature pag. 10
Termometro elettronico a colonnina pag. 38
Interruttore crepuscolare a 4 livelli pag. 32
News 6
Fatti conoscere 30
E.C.D.L. European Computer 82Driving Licence: tredicesima parte
Mailbox: la posta dei lettori 88
Tutte le fiere del 2003 104
In Vetrina:
Amplificatori Monacor hi-fi car 106serie Wanted
GMM 5115 107
NAD: arriva il sistema audio-video 108più premiato dell’anno
Al Mercato: gli annunci dei lettori 110
Electronic shop 112
Pagine di servizio 113
Rabbit By Example pag. 38
DR BOX 1: RADIO DIGITALE PER TUTTI ( DAB )Con DR Box 1, TerraTecElectronic presenta il primoricevitore radiofonico digi-tale universale USB. Il DRBox 1 può essere collegatovia USB al PC o a un appa-recchio stereo senza com-puter. Il DR Box 1 TerraTec è sem-plice e facile da utilizzarecome le radio standard.Naturalmente, sono dispo-nibili la ricerca automaticadelle emittenti, il controlloaudio, l'output analogico edigitale e 24 memorie perle emittenti. Il vantaggio offerto dallatrasmissione digitale sono :audio di chiarezza cristalli-na e libero da tutte le inter-
ferenze. Aggiungete a que-sto le ulteriori informazionie i servizi dalle emittentiche non possono esserericevuti su FM.Queste informazioni sonoirradiate in parallelo al pro-gramma radiofonico utiliz-zando immagini e suono eoffrono non solo il titolo el'artista, ma anche le datedei tour, informazioni suiCD correnti o sui program-mi. Questi servizi - datiassociati al programma(PAD - Program-AssociatedData ) - sono utilizzati com-pletamente da DR Box 1. E, naturalmente, un colle-gamento al PC offre unaserie di opzioni aggiuntive:sia le informazioni relativeal programma che quelleindipendenti sono presen-tate in formato HTML. Ilcollegamento a un PC per-mette all'utente di riceverevarie stazioni contempora-neamente.Questo consente di regi-strare una stazione diversada quella che si sta ascol-tando. Non solo si possonoregistrare nel normalemodo analogico i pro-grammi ricevuti, TerraTecDR Box 1 li può anche regi-strare in tempo reale comefile WAV o MP2 e memoriz-
zare sul disco fisso. La regi-strazione dei programmiradiofonici può anche esse-re iniziata automaticamen-te utilizzando la comodafunzione di timer del soft-ware DR Box 1.Il programma radiofonicopuò inoltre essere registra-to in formato compressoMP3 utilizzando il pacchet-to software MusicMatchJukebox e immediatamen-te editato utilizzandoWavelab Lite - per esempioper effettuare tagli.Utilizzando i dati aggiuntiviche sono irradiati diretta-mente con il programmaradiofonico, è possibile rea-lizzare una "viewing radio".I moduli supplementaripossono essere formati dagrafica (per esempio dauna web cam nello studiodi un'emittente), etichettadinamica (simile al testodella ben nota radio RDS) eda dati multimedialiaggiuntivi come contenutiHTML. Infine, i contenutidati non associati al pro-gramma (NPAD) sono rice-vuti e visualizzati comepagine HTML - come guidea eventi regionali, a previ-sione o dati di borsa intempo reale.
COME TI PROTEGGO ILCOMPUTERLa massa crescente diinformazioni richiede ade-guate soluzioni per la pro-tezione dei dati e la dispo-nibilità dei sistemi.Sicurezza e protezione,due termini consideratiimportanti ma in fondonon “vitali”, hanno acqui-
stato una rilevanza decisa-mente maggiore dopo“l’11 Settembre”.Protezione, sicurezza, dis-ponibilità sono le tre paro-le cui i responsabili deisistemi informativi guarda-no con sempre maggioreattenzione e che, in defini-tiva, anche se a livelli bendiversi, riguardano anchela piccola impresa e perfi-no l’utente domestico. Unprimo problema è quellodell’attacco da parte divirus sempre più numero-si. La risposta sta in mezzidi difesa di vario tipo (soft-ware antivirus, firewall chefiltrano la posta in arrivoecc.) e in procedure ade-guate. Si tenga conto chel’e-mail è diventata oggi laforma più comune di con-tagio (pochi anni fa loerano i dischetti). Attenzione quindi ai mes-saggi inattesi e, anche seprovengono da nominativia voi noti (probabilmenteinconsapevoli e a lorovolta contagiati), agli alle-gati che contengono fileeseguibili (.exe, .com,ecc.). Le possibilità diattacco sono ulteriormen-te aumentate con i com-puter in rete in modalità“always on”, come nelcaso dell’ADSL. Un firewall, anche nellasola versione software, è inquesti casi la soluzioneconsigliata. Anche perridurre le probabilità, senon di virus, dell’accessonon desiderato di hacker ecuriosi che frugano tra levostre informazioni. Negliambiti aziendali, il proble-ma non è solo quello dellaprotezione della informa-
news
rubriche
RUBRICHE6
Electronic shop 01
RUBRICHE 7
MONACOR il settore loud-speaker siano essi per auto-mobile, hi fi , PA o discote-ca: molti prodotti delleserie top sono da tempo
considerati ilmust in
fatto di
prezzo equalità, a
questo proposi-to possiamo ricor-
dare la serie RAPTOR perauto, woofers capaci diaccettare potenze superiorial kiloWatt, accoppiati aiblasonati finali di potenzacar della serie Wanted odella serie Digitale PWMmosfet D-REX. I diffusori per uso pubbli-co e discoteca unisconoad un ottimo rapportocaratteristiche prezzonotevole affidabilità erobustezza.
PICBASIC PRO:NUOVA RELEASEE' appena uscita la nuovaversione del popolare com-pilatore basic per i micro-controllori PIC distribuitoormai da anni con successoda Elettroshop.PICBASIC è una linea dicompilatori Basic apposita-mente realizzata per sem-plificare e velocizzare lo svi-luppo. A differenza di prodottianaloghi (per esempio ilBASIC STAMP), non neces-sita di hardware dedicato,
rubriche
CATALOGO MONACOR2003Come tutti gli anni, pun-tuale come sempre è uscitoil nuovocatalogo
MONACOR Italia,ricchissimo di novità nelcampo dell’hi fi domesticoe professionale, amplifica-zione P.A., videosorveglian-za e sicurezza, oltre a pro-porre moltissimi articoli perlaboratorio, utensileria eutilità.Da anni leader nel settorecommercializzazione elet-tronica, la MONACOR haulteriormente ampliato lasua gamma di compactdisc player singoli e doppiper uso discoteca con uninteressantissimo lettoreMP3 professionale, incre-mentato ancora la produ-zione di amplificatori P.A. edisco con potenze sempremaggiori, nel segno, però,della massima affidabilità.Molti altri sono i settori incui la ditta tedesca consede italiana a Bolognaeccelle, tra cui la cavetteriae spinotteria audio profes-sionale, radiomicrofonioperanti su frequenzeWHF, UHF da 190 a800MHz anche con l’op-zione diversità, microfonida tavolo e dj, illuminotec-nica professionale control-lata DMX.Particolarmente caro a
zione, ma anche quellodella sua disponibilità.Esigenze del tipo 24X7,ovvero informazioni e ser-vizi disponibili 24 ore algiorno per tutti i giornidella settimana, sonodiventate uno standard, enon più caratteristichesolo di ambienti moltospecializzati. A questo hanno contribui-to le nuove modalità ope-rative introdotte con ilweb e i servizi on-line.Per questo, le proceduredi sicurezza sono diventa-te molto più “protettive”.Il semplice backup off-linedei dati è utile ma nonsempre sufficiente, perchénon consente un pienoallineamento delle infor-mazioni e le procedure diripristino rischiano indiversi casi di essere trop-po lunghe. Si va così dagli schemi diprotezione RAID conduplicazione dei dati sualtri dischi locali alle solu-zioni più complesse di dis-aster recovery che posso-no prevedere un secondosistema di archiviazionefunzionante in parallelo,nello stesso sito o, per lamassima sicurezza, in loca-lità remote.Applicazioni di questotipo, oggi rese più interes-santi dalla disponibilità dicanali di comunicazionead altissima velocità chesono messi a disposizionedagli operatori telefonici,sono ora offerte anche daterze parti, ovvero societàdi servizi di facility mana-gement e outsourcing.
in quanto è in grado digenerare direttamente ilcodice da programmarenel microprocessore. Il PicBasic è disponibilenella versione base(PicBasic) e in quella pro-fessionale (PicBasic Pro),entrambi si utilizzano alinea di comando o conMPLAB della Microchip.Utilizzano un set di istruzio-ni semplici ed efficaci esono provvisti di tutte lelibrerie necessarie all'inter-facciamento con i dispositi-vi esterni più diffusi (lcd,SPI, I2C, Microwire, X10,RS232, RS485, ecc.) ed uti-lizzano la sintassi standarddel BASIC. Le due versionisi differenziano per l'otti-mizzazione del codicegenerato, il set di istruzionie i microprocessori suppor-tati. L'ultima release, la 2.43,appena uscita, implementatra le novità principali:
• supporto per PIC16C557,16F627A, 628A, 630,648A, 676, 818, 819,18F1220, 1320, 2220,2320, 4220 e 4320.
• HSERIN2 e HSEROUT2. • Eliminati i warning per
PULSIN_MAX ed alcuniregistri.
• Modificato ADCIN cheElectronic shop 02
Electronic shop 03
RUBRICHE8
resettava VREF con alcunidevices.
• Modificata la selezione dialcuni bank preferenceper 18Fxxxx.
• Modificato USBIN eUSBOUT per lavorarecon la lunghezza dellavariabile.
• Modificato il supportoPICStic 5.
BASICX-24 UN CLONEDEL BASIC STAMP CONQUALCHE MARCIA IN PIÙSulla scia dell'enorme suc-
cesso ottenuto da Parallaxcon la famiglia di micro-controllori Basic Stampcaratterizzati dalla loro completa programmabilitàin linguaggio BASIC,NetMedia propone la fami-
glia BasicX tracui il
BX-24, pin topin compatibile con Basic Stamp ed il BX-35 un chip a 40 pin dual inline di costo più contenuto.
BX-24 si programma conun linguaggio molto simi-le, ed in alcuni casi addirit-tura compatibile, al VisualBasic di casa Microsoft.E' in grado di eseguire circa65.000 istruzioni al secon-do, dispone di 16 linee di
I/O di cui 8 configurabilicome ingressi A/D con riso-luzione pari a 10 bit ed unsample rate massimo di6000 campioni al secondo,32 Kbyte di memoriaEEPROM, 400 byte dimemoria RAM e due porteseriali. Ma la cosa più sor-prentende è la possibilità dieseguire più routine BASICin multitasking con gestio-ne delle code di messaggitra task, semafori e prioritàdi accesso alle periferiche.
TERRATEC PHONOPREAMP STUDIO USB: PREAMPLIFICATORE INDI-PENDENTELo abbiamo sperimentatotutti: le buone vecchieregistrazioni di gomma-lacca sono state messenella fila posteriore delrack. Alcune sono scom-parse completamente dalripiano. Ma adesso basta!TerraTec presenta ora almercato il preamplificato-
re audio Phono PreAmpStudio USB. Il phonoPreAm Studio USBTerraTec è una combi-
nazione perfetta di hard-ware e software. Con unadimensione inferiore aquella di un mazzo dicarte, il phono PreAmpStudio USB vi permette dieseguire il montaggio didischi e cassette sulvostro computer a unlivello professionale diqualità e quindi immorta-larli su CD, tutto senza lanecessità di una schedaaudio!Semplicemente attraver-so una porta USB. Il
phono PreAmp StudioUSB sarà disponibile dametà Febbraio. Quandole registrazioni di viniledevono essere elaboratesul computer, normal-mente è necessario unamplificatore ad altafedeltà per trasferire ibrani al PC. I lettori e leschede audio di recordutilizzano segnali audiodiversi. Il phono PreAmpTerraTec offre una validaalternativa che, per quan-to riguarda la qualitàaudio, batte molti ampli-ficatori ad alta fedeltà.Con il contenitore ester-no, protetto completa-mente dalle eventuali dis-torsioni, evita di aprire ilcabinet del PC. Collegatesemplicemente il lettoredi dischi al vostro PC tra-mite il phono PreAmp edè tutto fatto! Non avetebisogno di driver supple-mentari e nemmeno diuna presa elettrica: l’ali-mentazione è presa diret-tamente dalla porta USB.Il pick-up del giradischi èfacile da configurare. Lecapacità di ingresso piùcomuni sono regolabili intre stadi. Per ottenere ilgiusto "oompf", il segnaledi output può essereregolato in due stadi.L’equalizzatore RIAA inte-grato garantisce un’ ela-borazione ottimizzata delsegnale del pick-up, for-nendo così un suonopuro come l'originale.Oltre all'hardware PreAmp,il phono PreAmp StudioUSB include un potentestrumento software pro-dotto da Algorithmix chepermette di ridurre signifi-
cativamente o eliminarecompletamente in temporeale i disturbi indesideraticome scricchiolii e scari-che statiche mantenendol’autentica qualità origina-le del suono.Sound Rescue TerraTec èstato sviluppato special-mente per l'utente multi-mediale che non vuolespendere ore per appren-dere complicati processidi editing o utilizzare lamoltitudine di imposta-zioni di parametri neces-sarie negli altri softwareprofessionali.Il prezzo del PhonoPreamp USB è di Euro:119,00 utente finale IVAinclusa.
Caratteristiche chiave• Per tutti i giradischi con
cartucce a magnetemobile (MM).
• Alloggiamento esterno,schermato in modo affi-dabile contro le interfe-renze.
• Non è richiesta alcunascheda audio.
• Registrazione audio ealimentazione elettricavia USB.
• Capacità di ingressoregolabile in tre stadi(100 pF, 250 pF and430 pF).
• Equalizzazione RIAA peruna riproduzione fedele(20 Hz-20 kHz / ± 0.3dB).
rubriche
Electronic shop 04
Electronic shop 05
Electronic shop 06
ELETTRONICA GENERALE10
di Andrea [email protected]
Basta con questa stramaledettaumidità nei muri, non si fa atempo a tinteggiare che subito lavernice si stacca formando placchedi salnitro. Questo accade nonsolo nei muri delle cantine, dovespesso, anche per il vino, l’umiditàmalissimo non fa, ma in camere daletto, sale e cucine. Si è provato a tagliare i muri, pra-ticare delle camere d’aria entro glistessi ma talvolta i risultati sonostati davvero deludenti, allora per-ché non provare con l’elettronica? Il circuito è molto semplice, sitratta di un doppio alimentatore acorrente costante di tipo negativoovvero che genera una tensionepiù negativa rispetto la massa chepoi è pure la terra dell’apparta-mento; in questo modo si fa si chele particelle di umidità si dispon-gano in modo da trasferirsi pressola zona più positiva, in questocaso la terra. È facile capire che in questo modo
si inverte il nor-male campo pre-sente quantomeno bloc-cando ulteriore umidità. Il circui-to funziona a tensione di rete quin-di occorre utilizzare come trasfor-matore principale un tipo a doppioisolamento e ben resinato, in que-sto modo saremo davvero sicuri dinon avere nulla a che fare tra ten-sione di rete e muro trattato.È inoltre necessario praticare nelmuro fori in cui infileremo deichiodi da tetto per carpentieri inferro e li collegheremo tra loro edalle uscite del circuito. Il comune andrà posto a terra.
SCHEMA ELETTRICOLa Figura 1 propone lo schemaelettrico del circuito che a primavista potrebbe essere scambiatoper un comune alimentatoreduale stabilizzato però occorrericordare che in questo casoabbiamo un trasformatore con
uscite distinte,due raddrizzatori ed una massacomune “positiva”. Gli integratiIC1 e IC2 operano come genera-tori di corrente , come se si trat-tasse di caricabatteria per nickelcadmio ma a tensione negativa,infatti R2 e R3 limitano la massimacorrente.La luminosità dei led in serie adesse dipende dalla quantità diumidità presente nel muro.All’atto dell’accensione i due led siaccenderanno per un istante almassimo dovendosi caricare i con-densatori in uscita. Due parole circa il trasformatoreche deve essere doppio isolamen-to a norme CE resinato e scatola-to, questo in particolare perché sipresume il lavoro del circuito in
ELETTRONICA GENERALE
L’umidità è uno dei difetti più difficilmente debellabilinelle nostre abitazioni ebbene, questo circuitosfruttando l’applicazione di una correntecontinua lungo il muro, permette il trasferimentodelle minuscole gocce di acqua verso il basso,favorendo l’essicazione e l’asciugatura di muriumidi e infioriti. Il consumo è minimo, il costopure e l’utilità indubbia.
ANTIUMIDITÀPER MURATUREANTIUMIDITÀPER MURATURE
ELETTRONICA GENERALE 11
ELETTRONICA GENERALE
to ad applicazioni corrente alter-nata con diodo inverso alla giun-zione del led integrato. Nondimenticate il fusibile sulla rete.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIOLa Figura 2 mostra il circuitostampato da adottare per questoprogetto mentre la Figura 3 svela
zona umida e non è il caso diavere perdite di tensione di retesul muro. Il led spia sulla tensionedi rete è un particolare tipo, adat-
Schema elettrico Figura 1
ELETTRONICA GENERALE12
Con un comune tester misureretela tensione in uscita tra comune,out1 poi out2, dovrete leggerecirca 8V negativi. Il gioco è fatto.
MONTAGGIO DEGLI ELETTRODI A MUROArmatevi di santa pazienza quindicon un trapano con punta da 6mmpraticate dei fori nel muro umidodistanti tra loro circa 10 cm adun’altezza di 30 cm da terra ben inlinea tra loro poi infilate nei fori deichiodi da carpentiere lunghi alme-no 10 cm e di diametro 5 mm,bagnate il muro con acqua e salepoi cementate i chiodi. Con unasingola uscita potremo trattarefino a 2 mt di muro (Figura 4).Ancor meglio sarà trattare il murocon reagente chimico elettroliticoantiumidità. Molti prodotti posso-no essere spruzzati sopra l’intona-co ma i migliori risultati si otter-ranno scalpellando il muro fino allapietra viva, affondando i chiodi eammantando di intonaco trattatocon prodotti chimici, in questomodo si sommano le positivecaratteristiche chimiche dei pro-
ELETTRONICA GENERALE
il piano dei componenti che inquattro e quattr’otto potrannoessere montati. Nessun compo-nente è critico ne di difficile repe-ribilità, però, per chi non trovasseil particolare diodo led 1 basteràconnettere in anti parallelo ad unnormalissimo led un diodo 1N4007.Dopo avere montato tutti i com-
ponenti ed il trasformatore al cuiproposito diremo che la foraturaasimmetrica è ottimale per questotipo adottato ma non è standardper altri costruttori, potremo daretensione. Subito il led1 si accende-rà poi per un attimo gli altri dueled, per poi affievolire la proprialuminosità.
Circuito stampato scala 1:1.Figura 2
Piano di montaggio dei componenti.Figura 3
ELETTRONICA GENERALE 13
dotti oltre a garantire elettrolisiinversa tramite il circuito.Questi sistemi sono utilizzati perbonificare i pilastri di opere mae-stre quali gallerie e dighe. Se nonfoste colpiti dall’umidità in casaricordate che il circuito permetteuna più veloce essiccazione delcemento e limita l’insorgenza nel
cotto del salnitro, molto brutto avedersi e di difficile pulizia.Qualora vi accingeste a edificare enon si trattasse di restauro potreteaffiancare sottoterra le muraturecon una piattella di rame lungatutto il muro e larga circa 10Cm econnetterla alla terra del nostrodispositivo. L’apparecchio è nato
per restare sempre alimentato,durante il funzionamento, speciese i muri sono molto umidi potre-mo avere riscaldamento sia dei cir-cuiti integrati, dei resistori e deltrasformatore.Se vorrete realizzare gruppi a piùunità ricordo che un trasformatoreda 1A può comandare fino a 5uscite differenti. La tensione appli-cata al muro di 8V è totalmenteinnocua e non avvertibile ne dal-l’uomo ne da animali.
ELETTRONICA GENERALE
• R1: resistore da 82 kΩ _ 1/8W• R2-3: resistori da 120 Ω 2W• C1-2: condensatori elettrolitici
da 1000 µF/16 Vl• C3-4: condensatori elettrolitici da 47 µF/10 Vl• LED1: LED con diodo reverse per corrente
alternata, qualsiasi tipo• LED2-3: LED rossi• IC1-2: 79P08• BR1-2: ponti 50 V 1 A
Utilizzo del dispositivo e fissaggio dei chiodi a muro Figura 4
Electronic shop 07
LISTA COMPONENTI
AUTOMAZIONE14
RECS 101: UN WEB SERVEREMBEDDED PER APPLICAZIONIDI CONTROLLO REMOTOTRAMITE TCP/IP
RECS 101: UN WEB SERVEREMBEDDED PER APPLICAZIONIDI CONTROLLO REMOTOTRAMITE TCP/IP
di Cristian [email protected]
Un web server embedded è un web server gestito all’interno di un sistema embeddedcaratterizzato da risorse di calcolo limitate capace di gestire documenti ed applicazioniweb. L’integrazione di un web server all’interno di un dispositivo di rete fornisceun’interfaccia utente grafica costruita tramite il linguaggio HTML. L’applicazione dellatecnologia Web ad un sistema embedded permette la creazione di interfacce utente chesono user friendly, a basso costo, cross platform, e network ready. Aggiungendo allepotenzialità di un web server embedded la tecnologia Java si ottiene un sistema capace digestire vere e proprie applicazioni che possono essere programmate con un linguaggio adalto livello quale il Java. Scopo di questo articolo è quello di presentare una soluzione webserver embedded capace di gestire la Java Virtual Machine. Viene presentata l’architetturadi un web server embedded che può fornire un’interfaccia API (Application ProgramInterface) semplice e al tempo stesso potente. In particolare si discute la progettazione el’implementazione di RECS 101, che è un web server embedded (prodotto da IntellisystemTechnologies) sviluppato al fine di poter gestire piccole applicazioni di controllo remoto. Inconclusione vengono presentate alcune applicazioni pratiche del dispositivo, cheprevedono la realizzazione di circuiti elettronici d’interfaccia, uno studio riguardante deitest di performance di RECS 101 ed un’analisi delle problematiche di protezione daattacchi alla sicurezza da parte di hacker.
I SISTEMI WEB SERVEREMBEDDED ED INTERNETIl World Wide Web (o Web) è in con-tinua evoluzione. Appare chiaro edevidente che tale tecnologia assumedelle nuove funzionalità che vannomolto oltre la semplice visualizzazio-ne delle pagine Web. Per molteapplicazioni commerciali e scientifi-
che il browser web è diventato unostandard per lo sviluppo di interfac-ce utente di numerose applicazioni.Questo perché i browsers web sonocapaci di fornire interfacce GUI avarie applicazioni client/server senzail bisogno di andare ad implementa-re del software per il lato client.Negli ultimi anni è sempre più cre-
sciuto il numero di tecnologie webche possono essere applicate ad ele-menti gestibili dalla rete.Come ben noto la maggioranzadelle reti di computer viene gestitamediante il protocollo TCP/IP.In realtà TCP e IP sono due proto-colli utilizzati per interconnettere lereti. TCP sta per Transport Control
AUTOMAZIONE
prima parte
AUTOMAZIONE 15
pensa di aggiungere alle funzionali-tà ormai consolidate di un web ser-ver embedded la capacità di potergestire applicazioni Java ecco chequesti sistemi aprono le frontiere acapacità inesplorate, che rendonoessi capaci di eseguire i più varie-gati compiti quali, ad esempio,quelli di controllo remoto, supervi-sione e gestione di sistemi elettro-nici (fig. 1).
Nelle applicazioni di controllo remo-to si fa sempre più presente l’esi-genza di interconnettere apparec-chiature e strumentazioni tramiteweb server embedded al fine diavere una gestione quanto piùdecentralizzata possibile delle lorofunzionalità [2]. Ognuno di questicontroller programmato opportuna-mente diviene capace di eseguiredifferenti algoritmi di controllo.
APPROCCIO MEDIANTEL’UTILIZZO DELLATECNOLOGIA JAVAIl concetto della Virtual Machine diJava è particolarmente indicato perquesto approccio permettendo l’uso
di una strategia di controllo indi-pendente dalla piattaforma hardwa-re del sistema in cui viene gestita.Questa metodologia è stata datempo adoperata nelle applicazioniInternet dove non sono richiestistringenti vincoli di real-time. L’usodel linguaggio di programmazioneJava per le applicazioni di controlloremoto fornisce il vantaggio di inte-grare sistemi general purpose con
internet permettendo la supervisio-ne ed il controllo di sistemi.Oggigiorno i sistemi che si basanosu web server embedded richiedonosempre applicazioni più complesse,facili da programmare, al fine di ese-guire i compiti di supervisione egestione. Per realizzare il concetto dinetwork computing viene presenta-ta la tecnologia Java al fine di otte-nere la combinazione sinergica disistemi di controllo realtime distri-buiti che siano gestibili tramite larete Internet.Con l’incessante sviluppo dellamicroelettronica i sistemi embed-ded sono stati applicati a moltepliciprodotti industriali ed elettronici,
Protocol e IP sta per InternetProtocol. Per essere più precisiquando si parla di protocollo TCP/IPsi intende una suite di protocolli cheè stata promossa come standard diInternet dall’Unites States Secretaryof Defence. Obiettivo della suite diprotocolli TCP/IP è quello di consen-tire la comunicazione di reti simili oeterogenee. Mediante i protocolli iprogettisti possono specificare i pro-cessi di comunicazione senza esserea conoscenza dei dettagli delle enti-tà che compongono la rete. I sistemidi comunicazione più complessi uti-lizzano una suite di protocolli per lagestione dello scambio dei dati. Sipuò pensare che la suite dei proto-colli sia stratificata nel sistema direte del computer dell’utente.Sebbene più protocolli possanocoesistere all’interno di un unicostrato di rete, tutti i protocolli checompongono la suite devonocooperare tra di essi. Una suite diprotocolli può essere anche definitacome “famiglia di protocolli”. Lasuite dei protocolli TCP/IP ha ilcompito di gestire lo scambio deidati su Internet e quindi fornire solu-zioni a problemi che si verificanoquando si presentano errori dicomunicazione durante la trasmis-sione dei dati (ad esempio dovuti aguasti generici delle unità hardwareo difficoltà connesse alla banda pas-sante offerta dalla rete).La gestione di apparati elettronici
tramite web fornisce all’utente l’a-bilità di configurare e monitorarevariegati dispositivi tramite Internetmediante l’uso di un comune brow-ser. La soluzione migliore a questotipo di esigenze è sicuramente datadall’utilizzo di server web embed-ded connesso ad un infrastruttura direte al fine di fornire un interfacciautente basata su web costruitamediante l’utilizzo dell’ormai notolinguaggio HTML [1] unitamente agrafici e ad altre caratteristichecomuni ai web browsers [2]. Se si
AUTOMAZIONE
Architettura di un web server embedded Figura 1
AUTOMAZIONE16
poiché presentano le caratteristichedi essere economici, affidabili conbuone performance se comparaticon il software utilizzato neiPersonal Computers [3].Il vantaggio delle tecnologieInternet permette di interconnetteretra loro dispositivi e sistemi all’inter-no della rete internet. Tutto questofacilita l’accesso ai dispositivi per-mettendo di effettuare operazioni dimonitoraggio, di controllo, di repor-ting, start up, shutdown di qualsiasidispositivo semplicemente premen-do dei tasti all’interno di un interfac-cia GUI gestita da un comune brow-ser [4].Il nuovo concetto che intendiamointrodurre si basa sull’esecuzione diApplet Java per eseguire operazionidi controllo o di monitoraggio didispositivi remoti . In questo tipo disistemi il controllo distribuito siottiene mediante il trasferimento dipagine HTML e l’esecuzione diapplet Java (fig. 2).
Questo nuovo concetto permettedi espandere le comuni capacità deisistemi di controllo fornendo unsistema remoto distribuito per ilcontrollo di sistemi elettronici. La progettazione di sistemi embed-ded richiede l’integrazione e lo svi-luppo di componenti hardware esoftware: spesse volte queste sonoparticolarmente difficili da realizzarepoiché ogni controller possiede lasua piattaforma hardware e softwa-
re. Anziché adoperare linguaggi dif-ferenti e non standard per l’imple-mentazione del software nella mag-gior parte dei casi è preferibile ado-perare un linguaggio comune [5]. IlJava rappresenta una scelta ottimaleper differenti motivi: è un linguag-gio standard completo di librerie, èun linguaggio molto semplice cheriduce le problematiche inerenti l’a-nalisi dei programmi, la loro ottimiz-zazione e trasformazione [5],[6].
I VANTAGGI DELL’UTILIZZODI JAVAIl linguaggio di programmazioneJava si sta diffondendo sempre piùall’interno dell’industria dell’infor-mation technology particolarmenteper le applicazioni che prevedonol’utilizzo di database. Il Java è un lin-guaggio di programmazione chepermette di installare un’applicazio-ne all’interno di un server ed esserequindi eseguita su diverse piattafor-me hardware. Questi vantaggi pos-
sono essere brevemente riassunti neiseguenti punti:
- Indipendenza dalla piattaforma:diversamente dai comuni compila-tori che producono codice per CPUspecifiche, il Java produce del codi-ce per una CPU virtuale. Al fine dirimanere indipendente da specifichepiattaforme hardware il sistema run-time di Java fornisce un’interfacciauniversale per qualsiasi applicazione
che si desidera sviluppare. Tale inter-faccia denominata JVM (Java VirtualMachine) è una sorta di processorevirtuale che si interpone tra il pro-cessore fisico del PC e l’applicazionescritta in Java. Tuttavia, l’indipen-denza dalla piattaforma non è suffi-ciente per assicurare il successo diun linguaggio di programmazione.La JVM è da diverso tempo inclusaall’interno dei browser più popolariquali, ad esempio, MicrosoftExplorer e Netscape. Alcuni sistemioperativi real-time includono al lorointerno la tecnologie Java e tutto ciòpermette di giungere alla seguenteconclusione “la JVM è una risorsauniversale” [5,7];• Potenza: Il Java racchiude in se
nuove caratteristiche che includonola gestione dei database, l’invoca-zione dei metodi remoti ed altrecaratteristiche inerenti la gestionedella sicurezza.
• Networking: Il Java nasce come lin-guaggio di programmazione distri-buito, il che si traduce nel fatto chela sua progettazione includeva sindall’inizio la gestione di particolarifunzioni inerenti il networking. IlJava ha una libreria vastissima diroutine per la gestione dei protocol-li quali, ad esempio, il TCP/IP,l’HTTP, l’FTP. Le applicazioni Javapossono avere accesso ad oggettiattraverso la rete Internet per mezzodi URL (Universal Resource Locator,più comunemente noto come indi-rizzo del sito web) in un modomolto simile all’accesso ad uncomune file system locale. Unendola tecnologia Java alle potenzialitàdei sistemi basati su web serverembedded si possono ottenere deisistemi molto potenti per la gestio-ne di applicazioni di controllo.
• Efficienza: Le moderne JVM supera-no la forte limitazione delle passatedove veniva evidenziata la proble-matiche dell’estrema lentezza diesecuzione dei programmi.
Attualmente grazie all’utilizzo della
AUTOMAZIONE
Esecuzione di Applet Java per eseguire operazioni di controllo o di monitoraggio di dispositivi remotiFigura 2
AUTOMAZIONE 17
tecnologia Just in Time (JIT) compi-ler le performance d’esecuzionedelle applet sono state fortementemigliorate [7].
L’UTILIZZO DI JAVAALL’INTERNO DI SISTEMIWEB SERVER EMBEDDEDL’uso di linguaggi object-orientedassieme alle loro tecniche di pro-gettazione permettono di ottenereun codice che risulta essere facil-mente riutilizzabile e mantenibile.Normalmente, un’applicazioneche va trasferita ad un controller sicompone di un file binario esegui-bile che viene direttamente esegui-to dalla CPU. Il vantaggio principa-le di un approccio di questo tipo sitraduce in una maggiore velocitàd’esecuzione.Il Java permette di ottenere la fun-zionalità “compila una sola volta eutilizza più volte”. E’ virtualmentepossibile utilizzare lo stesso codicecompilato in piattaforme differentie, quindi, eseguire il codice su dif-ferenti Sistemi Operativi per fare itest ed il debugging del softwareper poi trasferire il tutto all’internodi un dispositivo di controllo [3].Il Java si presenta come un lin-guaggio di programmazione forte-mente adottato per la programma-zione applicazioni che fanno diinternet un punto di forza. I vantaggi principali inerenti l’uti-lizzo delle applet Java all’interno diun web server embedded possonoessere riassunte nei seguenti punti:
• Non occorre sviluppare unaGraphical User Interface (GUI) poi-ché i browser web di per se suppli-scono a tale funzionalità;
• Le dimensioni del codice Java sonominori rispetto alle istruzioni dicodice macchina rendendo parti-colarmente attrattivo l’utilizzo ditale tecnologia all’interno di webserver embedded dove, sicuramen-te, la dimensioni della RAM messa
a disposizione per le applicazioni èlimitata;
• Essendo l’esecuzione delle applet inlocale, e quindi non all’interno delsistema embedded, l’efficienza e lacomplessità d’esecuzione deglialgoritmi da eseguire sono a caricodel client e non del sistema embed-ded che, sicuramente, avrà risorsedi calcolo molto più limitate rispet-to a quelle di un comune PC;
• Molti costruttori di microprocessoriper sistemi embedded hanno inve-stito nell’implementazione dellaJVM all’interno dei loro dispositivi:di conseguenza gran parte del soft-ware è già disponibile;
• E’ intuitivo prevedere che in unimmediato futuro la maggior partedei kernel dei microcontrolloriincluderà la JVM.
LA JAVA VIRTUAL MACHINE Attualmente esistono diversi modidi implementare la JVM. La fig. 3mostra due possibili implementa-zioni.
Nella prima la JVM viene integrataall’interno di un ambiente di svi-luppo software. L’altra incorporaun Sistema Operativo Java cheviene particolarmente indicata perquelle applicazioni che prevedonol’utilizzo di un unico ambiente disviluppo sia per i programmatoriche per gli utilizzatori [3]. Unavolta disponibile l’interfaccia JVM èpossibile includerla all’interno di
un sistema di sviluppo embeddedintegrandola con le librerie delcodice nativo. Ciò può essere otte-nuto utilizzando qualsiasi linguag-gio di programmazione quale, adesempio, il Java bitcode interpre-ter e, quindi, compilare il tutto inaccordo ai vincoli hardware delsistema in cui la si vuole integrare.L’utilizzo della JVM all’interno diun web server embedded presentail vantaggio che coloro che svilup-peranno il codice per la program-mazione dell’applicazione all’in-terno del sistema embedded utiliz-zeranno istruzioni Java e nondovranno tener contro delle rela-zioni che intercorrono tra la JVM ela microprogrammazione del siste-ma embedded. In più si può forni-re all’utente finale un’interfacciatipo applet parametrica che richie-de semplicemente il setup di alcu-ni parametri. In quest’ultimo casol’utente finale non necessita diavere alcuna conoscenza riguardoil linguaggio di programmazioneJava.
IMPLEMENTAZIONE DELLAJVM ALL’INTERNO DI UN WEBSERVER EMBEDDEDL’applicazione che viene presenta-ta in questo articolo, pur essendostata implementata all’interno diun architettura basata su proces-sore UBICOM, può essere virtual-mente implementata all’interno diqualsiasi microprocessore o micro-controllore che dir si voglia. La fig.4 mostra lo schema architetturalesemplificato di un possibile scena-rio d’applicazione in cui sonorichiesti dei sistemi per il controllodi 16 ingressi digitali e 16 uscitedigitali. In particolare ci si riferisceal dispositivo RECS 101 prodottoda Intellisystem Technologies.
L’architettura presentata permette lasimulazione e lo studio di proceduretipiche dei sistemi di controllo quali,
AUTOMAZIONE
Possibili implementazioni della JVM Figura 3
AUTOMAZIONE18
ad esempio: acquisizione di segna-li, azioni di controllo per mezzo diattuatori, l’elaborazione e la pre-sentazione delle informazioniacquisite o manipolate.Il sistema embedded presentato sibasa su un software di svilupposcritto in C. Tale programma puòfar eseguire dei task preprogram-mati all’interno della ROM o fareseguire delle applicazioni Java.La capacità di far eseguire applica-zioni Java viene fornita dai seguen-ti componenti software che devo-no essere prevaricati nella ROM deldispositivo mediante il su citatosoftware di sviluppo [6]:- Il file loader .class, che permettedi fare il downloads del codice Javada eseguire nella RAM del disposi-tivo;• L’implementazione della JVM
stessa;• Implementazioni di classi per la
gestione dell’hardware locale;• Classi Java riferite al sistema
embedded.
La JVM è stata implementate in
accordo alle specifiche dettatedallo standard [7], fig. 5.
Il programma monitor che risiedeall’interno del sistema embedded sca-rica il file .class che deve essere ese-
guito all’interno della memoria RAM;dopodiché l’informazione viene pro-cessata e si provvede alla costruzionedella Constant Pool Table. LaConstant Pool è quindi risolta ed ilprogramma passa alla ricerca delmetodo d’inizializzazione del pro-gramma main che dovrà essere ese-guito. Dopo aver trovato questimetodi, la JVM ricerca il Byte Codeche deve essere eseguito e, di conse-guenza, invoca l’interprete di byteco-de. Quando i metodi delle classi Javasono stati invocati la JVM richiamadelle subroutine del firmware delmicroprocessore che provvederannoall’implementazione del metodo spe-cifico.La JVM di per se stessa non comunicadirettamente con l’hardware del siste-ma ma usa delle classi per fare ciò. Unfattore molto limitante di questi siste-mi è dovuto alla scarsità della memo-ria che si ha a disposizione. Di conse-guenza ciò porta a fare delle scelte suquali metodi e classi devono essereimplementati all’interno del sistema.
UN IMPLEMENTAZIONEPRATICA RECS 101RECS 101 rappresenta una realizza-zione pratica di quanto appena espo-sto [8]. La tab. 1 riporta le principalicaratteristiche e specifiche del sistemaproposto.
RECS 101 integra al suo interno unnetwork processor dotato di interfac-cia di rete Ethernet per connettersidirettamente a qualsiasi rete locale siaessa Internet che Intranet. Ciò per-mette agli integratori di sistemi e alleaziende produttrici di connettere iloro dispositivi direttamente adInternet attraverso una rete Lan e, diconseguenza, di gestire da remoto ilcontrollo totale dei loro dispositiviattraverso interfacce grafiche utentepersonalizzabili, direttamente accessi-bili mediante i comuni browser quali,ad esempio, Microsoft InternetExplorer e Netscape Navigator.
AUTOMAZIONE
Architettura della JVM implementataFigura 5
Scenario d’applicazione del dispositivo RECS 101Figura 4
ni del tipo JPG, GIF, BMP, file videotipo SWF di Flash e qualsiasi altro filesi ritenga opportuno che l’HTTP ser-ver di RECS 101 debba gestire.Selezionando il link “RECS 101
Home page personalizzabile
del dispositivo RECS 101
AUTOMAZIONE 19
RECS 101 si basa sullo schema hard-ware presentato in fig. 6.RECS 101 viene fornito con unapagina web precaricata all’internodella memoria flash del dispositivoche può essere modificata a piaci-mento in modo da personalizzarnele applicazioni.RECS 101 contiene un web serverintegrato capace di gestire fino a512k di documenti ed applicazioniweb: tali risorse sono precaricateall’interno della memoria flash deldispositivo. La fig. 7 è un esempio diuna pagina web gestita da RECS101 che può essere utilizzata perfornire informazioni statiche sul dis-positivo quali, ad esempio, immagi-ni, testi, files etc. La pagina visualizzata può essere per-sonalizzata a piacimento mediantel’uso dei più comuni editor di pagineHTML. Le pagine web possono con-tenere al loro interno file di immagi-
Control Panel” si accederà alla pagi-na web dedicata al controllo dell’ap-plicazione. La caratteristica che rende unico taledispositivo consiste nell’utilizzare unweb server all’interno di un’applica-zione embedded con la possibilità dieseguire del codice Java per lagestione dell’interfaccia relativa alcontrollo delle 16 porte di input edelle 16 porte di output (fig. 8).Tale caratteristica permette di potergestire l’interfaccia utente tramiteun’Applet Java parametrica: in que-sto modo l’utente finale può svilup-pare la propria applicazione di con-trollo in modo molto veloce e sicurosenza dover essere in grado di pro-
grammare in Java.All’interno del pannello di controllo(fig. 8) si può notare un LEDaggiuntivo specificato “Network”.La sua funzionalità è quella di forni-re all’utente lo stato della rete: unaconnessione senza problemi provo-ca il suo continuo lampeggiare. Nelcaso di perdita momentanea delcollegamento il LED non lampegge-rà e, se la connessione non si ristabi-lisce entro qualche minuto il sistemachiuderà la connessione con RECS
AUTOMAZIONE
Specifiche del diapositivo RECS 101 Tabella 1
Schema funzionale di RECS 101 Figura 6
Figura 7
Esempio di una possibile interfaccia
GUI implementata in RECS 101Figura 8
AUTOMAZIONE20
101. Problematiche di questo tipo nor-malmente non sorgono in reti Intranetma possono capitare se si collega RECS101 alla rete Internet .
PERSONALIZZAZIONEDELL’INTERFACCIA UTENTERECS 101 è un dispositivo totalmentepersonalizzabile. Viene fornito contutto il software necessario allo svilup-patore per poter sviluppare rapidissi-mamente la propria applicazione inmaniera facile e sicura. Il software indotazione contiene alcuni files edun’APPLET (RECS.jar) di controllo chepossono essere personalizzati median-te i parametri riportati di seguito:• PDFOOK: Stringa d’inizializzazione
Applet. Non è possibile effettuarenessuna modifica
• host: Indirizzo IP associato a RECS101(Es. hostvalue="172.16.10.103" vuol direche l’indirizzo IP di RECS è172.16.10.103
• port: Porta TCP adoperata dall’applicazione per comunicare conRECS 101. Il valore di tale porta èfisso e pertanto non modificabile(Es. port value=6001)
• polling: Intervallo di Polling. Ha unarisoluzione di 10 ms e può esseresettato in funzione dell’applicazio-ne. Per es. “polling value=1” signifi-ca che il check dello stato d’ I/O deldispositivo verrà controllato ogni10 ms
• NumLed: Numero ingressi damonitorare mediante LED bicolore(Es. NumLed value=16, verrannovisualizzati 16 LED indicatori distato)
• NumB: Numero di pulsanti dicomando per la modifica dellostato delle uscite (Es. NumBvalue=16, verranno visualizzati 16pulsanti)
Per comodità del lettore la Tab. 2riassume tutti i parametri gestitidall’applet in questione.Di seguito si riporta il frammento delcodice HTML del file index.html rela-
tivo alla personalizzazione dell’Appletin cui si evidenzia il setup dei para-metri di inizializzazione.L’esempio in questione prevede l’uti-lizzo di tutte le 16 uscite e di tutti i 16ingressi messi a disposizione dall’-hardware di RECS 101.
<APPLET CODE=Applicazione.class
ARCHIVE=RECS.jar WIDTH=850
HEIGHT=500>
<param name=PDFOOK
value="Intellisystem
Technologies Device">
<param name=host
value="172.16.10.103">
<param name=port value=6001>
<param name=polling value=1>
<param name=NumLed value=16>
<param name=NumBot value=16>
</APPLET>
La fig. 8 rappresenta l’interfacciautente che si ottiene applicando ilcodice appena esposto. Le limitazionidi quest’Applet consistono nel fattoche non è possibile modificare i testied i colori dei vari componenti che for-mano l’interfaccia utente.Per gli utenti più esperti viene messa adisposizione un’ Applet più elaboratache permette di personalizzare ulte-riormente l’interfaccia grafica utentemediante altri parametri che permet-tono di definirne colori e testi (fig. 9). Di seguito si riassumono i parametriche permettono la personalizzazionedell’Applet in questione (RECS.jar ver-sione avanzata):• PDFOOK : Stringa d’inizializzazio-
ne Applet. Non è possibile effet-
tuare nessuna modifica • host: Indirizzo IP associato a RECS 101
(Es. host value= "172.16.10.103". Vuoldire che l’indirizzo IP di RECS è172.16.10.103
• port: Porta TCP adoperata dall’applicazione per comunicare conRECS 101. Il valore di tale porta èfisso e pertanto non modificabile (Es.port value=6001)
• polling: Intervallo di Polling. Ha unarisoluzione di 10 ms e può essere set-tato in funzione dell’applicazione.Per es. “polling value=1” significache il controllo dello stato d’ I/O deldispositivo verrà controllato ogni 10ms
• Title: Stringa intestazione applicazio-ne. (Es. Title value="RECS I/O DEMO")
• ColTit: Colore da associare alla strin-
AUTOMAZIONE
Parametri di configurazione dell’AppletTabella 2
Interfaccia GUI avanzata
implementata in RECS 101Figura 9
AUTOMAZIONE 21
ga impostata nel parametro“Titolo”. (Es. ColTit value="green" , iltesto verrà stampato in verde)
• CAPL: Colore di sfondo Applet. (ES.CAPL value="yellow", lo sfondo saràgiallo)
• NumLed: Numero ingressi da moni-torare mediante LED bicolore (Es.NumLed value=16, verranno visua-lizzati 16 LED indicatori di stato)
• NumB: Numero di pulsanti dicomando per la modifica dello statodelle uscite (Es. NumB value=16,verranno visualizzati 16 pulsanti)
• TBT*: Testo da associare al pulsante *relativo all’uscita * (Es. TBT1value="Comando 10" è il testo daassociare al pulsante 10 per modifi-care lo stato dell’ uscita 10)
• CTBT*: Colore del testo associato altitolo del pulsante *. (Es. CTBT10value="red", il colore associato altesto relativo al pulsante 10 è rosso)
• CLBF*: Colore associato al LED di
stato dell’ uscita * quando quest’ulti-ma è nello stato “OFF” (Es. CLBF10value="gray", il colore del LED asso-ciato allo stato “OFF” dell’ uscita 10sarà grigio)
• CLBT*: Colore associato al LED distato dell’ uscita * quando quest’ulti-ma è nello stato “ON” (Es. CLBT10value= "blue", il colore del LED asso-ciato allo stato “ON” dell’ uscitan.10 sarà blu)
• TLD*: Testo da associare al LED *relativo all’ ingresso *. (Es. TLD1value="Luce Camera" è il testo daassociare al LED 1 per effettuare lalettura dello stato dell’ ingresso 1)
• CTLD*: Colore del testo associato altitolo del LED * relativo all’ingresso *.(Es. CTLD1 value="black", il coloreassociato al testo relativo al LED 1sarà nero)
• CLIF*: Colore associato al LED distato dell’ ingresso * quando que-st’ultimo è nello stato “OFF” (Es.
CLIF10 value="green", il colore delLED associato allo stato “OFF” dell’ingresso 10 sarà verde)
• CLIT*: Colore associato al LED distato dell’ ingresso * quando que-st’ultimo è nello stato “ON” (Es.CLIT10 value="red", il colore del LEDassociato allo stato “ON” dell’ingresso 10 sarà rosso)
Per comodità del lettore la tab. 3 rias-sume in forma tabulare i parametripersonalizzabili dell’Applet per lagestione avanzata di RECS 101.Di seguito si riporta il frammento delcodice HTML del file index.html relati-vo alla personalizzazione dell’Applet incui si evidenzia il setup dei parametri diinizializzazione.
<APPLET CODE=Applicazione.class
ARCHIVE=RECS.jar WIDTH=850
HEIGHT=500>
<param name=PDFOOK
value="Intellisystem
Technologies Device">
<param name=host
value="172.16.10.103">
<param name=port value=6001>
<param name=polling value=1>
<param name=Title value="RECS
101 I/O Demo">
<param name=ColTit
value="black">
<param name=CAPL value="white">
<param name=NumLed value=16>
<param name=NumBot value=16>
Un esempio di personalizzazione
dei pulsanti e degli indicatori
LED è rappresentato dal seguen-
te codice contenuto all’interno
del file index.html:
<param name=TBT1 value="Comando
1">
<param name=CTBT1 value="red">
<param name=CLBF1 value="gray">
<param name=CLBT1 value="blue">
<param name=TLD1 value="Ingresso
1">
<param name=CTLD1 value="black">
<param name=CLIF1 value="green">
<param name=CLIT1 value="red">
AUTOMAZIONE
Parametri di configurazione dell’Applet per la gestione avanzata di RECS 101 Tabella 3
AUTOMAZIONE22
Poiché non occorre RECS 101 persimularne il suo funzionamento,collegandosi al seguente indirizzohttp://www.intellisystem.it/recs/Interfaccia.htm si possono provarele due interfacce proposte.Per chi invece volesse dilettarsi asperimentare la personalizzazionedelle interfacce, IntellisystemTechnologies mette a disposizionenel proprio sito tutto il softwarenecessario. Per fare ciò occorre:• scaricare una delle versioni delle
interfacce proposte dal seguenteindirizzo http://www.intellisy-stem.it/recs/download.htm;
• decompattare i file in una cartel-la;
• modificare i parametri dell'inter-faccia agendo sul file index.htmlutilizzando un qualsiasi editorweb;
• richiamare la pagina 101.htmlmediante un qualsiasi WebBrowser.
I files necessari per la personalizza-zione dell'interfaccia utente diRECS 101 sono essenzialmente tre(a parte tutti quelli necessari per ilcontenuto grafico delle pagineweb): 101.html, index.html,RECS.jar.
La fig. 10 riassume quanto detto inprecedenza, ovvero:
1. La pagina 101.html rappresentala home page del sito web conte-nuto in RECS 101. Al suo interno èpresente un collegamento allapagina Index.html;
2. La pagina Index.html contieneal suo interno i parametri di setupdell’Applet per la gestione degliingressi e delle uscite di RECS 101;
3. Tramite l’applet RECS.jar si inter-viene sulle porte d’input e di out-put per la gestione dell’hardwareche si intende controllare.
NEL PROSSIMO NUMERO SI DIS-CUTERÀ DEI SEGUENTI ARGO-MENTI RIGUARDANTI RECS 101:
1) Configurazione dei parametri direte
2) Upload dell’interfaccia utentepersonalizzata
3) Implementazione delle interfac-ce hardware sulle porte diInput/Output
AUTOMAZIONE
[1] McCombie, B.,”Embedded Web server now and in the future,” Real-TimeMagazine, no.1 March 1998, pp. 82-83.
[2] Wilson, A.,”The Challenge of embedded Internet”, Electronic ProductDesign, January 1998, pp. 31-2,34.
[3] D. Mulchandani, “Java for Embedded Systems”, in IEEE ComputerMagazine, pp. 30-39, May June 1998.
[4] Aptronix, “Bring Embedded System to the Internet”, http://www.aptro-nix.com.
[5] J. Gosling, B. Joy, G. Steele,”The Java Laguage Specification”,http://java.sun.com
[6] J.S. Young et All., “Design and specification of embedded system in javausing Successive, formal Refinement”, Proceedings of DAC’98, 1998Design Automation Conference. San Francisco, C.A.,june 15-19.
[7] T. Lindholm, F. Yellin “The Java Virtual Machine Specification”, 1996.http://java.sun.com
[8] Intellisystem Technologies. http://www.intellisystem.it
Electronic shop 08
Files necessari per la personalizzazione dell'interfaccia utente di RECS 101Tabella 2
BIBLIOGRAFIA
ELETTRONICA GENERALE24
AMPLIFICATORE PERMICROFONO AD ELEVATASENSIBILITA’
AMPLIFICATORE PERMICROFONO AD ELEVATASENSIBILITA’
Questo silenzioso amplificatore a batteriaamplifica i segnali provenienti da un microfonoad esso collegato e li trasmette con un adegua-to volume ad una cuffia. Sono disponibili due
livelli di filtraggio (alto e basso) per un con-trollo mirato dell’andamento in frequenza.
La regolazione automatica del volumemantiene il volume costante, proteggendole orecchie da rumori improvvisi.L’amplificatore può essere collegato avariate tipologie di microfoni a secondadelle vostre esigenze di impiego.
ELETTRONICA GENERALE
macchine rumo-ri di disturbo provo-
cati da cuscinetti difettosi. L’utilizzodi un microfono con stetoscopiopermette inoltre di ascoltare il batti-to cardiaco ed i polmoni, mentrecon un microfono a contatto potre-te percepire suoni attraverso le pare-ti ed i vetri. I campi di applicazionedi questo amplificatore sono nume-rosi quanto le possibilità che abbia-mo di percepire i suoni. Esso è ditipo universale (ossia consente il col-legamento di diverse tipologie dimicrofoni) grazie ad una adeguatacalibrazione del circuito e presentaalcune interessanti caratteristiche. In
primo luogo permette un ascoltoprivo di rumori esterni: infatti i duefiltri (uno per le alte frequenze, l’al-tro per le basse) permettono di eli-minare i disturbi. L’andamento infrequenza a seconda della scelta deifiltri è mostrato in Figura 1. Il filtropassa alto permette un’efficace eli-minazione del frastuono dovuto alvento; il filtro passa basso, invece,può essere impiegato per diminuireil rumore di fondo. I livelli di filtrag-gio vengono commutati in modoelettronico, affinché non venganoavvertiti quegli scricchiolii che risul-tano dannosi per le orecchie soprat-tutto quando l’amplificazione è ele-
ESPERIMENTI ACUSTICIE NON ACUSTICIA cosa potrebbe servire questoamplificatore? Uno strumento cosìsensibile è in grado di amplificare di5000 volte anche i più piccoli rumo-ri e di renderli percepibili al nostroorecchio attraverso una cuffia, risul-tando estremamente utile in molte-plici occasioni. Per tale motivo l’am-plificatore è dotato di batterie, chepermettono il suo trasporto ed il suoutilizzo in qualsiasi luogo. È possibi-le impiegarlo in applicazioni di tipotecnico ed esperimenti acustici: gra-zie all’amplificatore qui descrittopotrete ad esempio scoprire nelle
di M. Carelli e G. [email protected]
ELETTRONICA GENERALE 25
limite di circa 150 Hz. Attraversol’interruttore elettronico IC3 A sirealizza un collegamento a pontecon tale filtro; l’interruttore S1, inve-ce, consente l’esclusione di questolivello di filtraggio. Allo stesso modofunziona il filtro successivo, realizza-to per mezzo di IC2 A ed avente unafrequenza limite di circa 5 kHz, allacui attivazione è preposto l’interrut-tore S2. L’elemento successivoincontrato dal segnale lungo il suopercorso all’interno del circuito è lostadio di amplificazione IC2 D cheha la funzione di regolare automati-camente il volume. Il valore dell’am-plificazione è controllato attraversole due resistenze R13 e R14, mentrele resistenze R12 e R15 formano unpartitore di tensione. In parallelo aR15 si trova il FET T1, grazie al qualeè possibile modificare il rapporto delpartitore di tensione e con cui vieneattenuato il segnale. Il tutto avviene secondo il seguentemeccanismo. Dall’uscita dell’ampli-ficatore operazionale IC2 D (con-trassegnata dal pin 14) la tensionedel segnale giunge, attraverso ilcondensatore di collegamento C13,ai diodi D1 e D2. Questi diodi rad-drizzano il segnale in alternata cosic-ché nel condensatore C12 passauna tensione continua, la cuiampiezza risulta proporzionale alvalore della tensione alternata delsegnale stesso. Il gate del transistorT1 è regolato dalla tensione conti-nua così prodotta e modifica conse-guentemente la propria resistenza didrain, modificando a sua voltaanche l’amplificazione complessiva.Si crea così un circuito ad anellochiuso che mantiene ad un livellocostante di ampiezza il segnale inuscita da IC2 D. La regolazionedipenderà dalla costante di tempodeterminata da R16 e C12. Unimprovviso aumento dell’ampiezzadel segnale azionerà immediata-mente il meccanismo di regolazio-ne: l’amplificazione complessiva cre-
vata. Allo stesso modo la protezionedell’udito è garantita dalla regola-zione automatica dell’amplificazio-ne che, in caso di sbalzi di volume,limita i livelli del suono riportandolia valori inoffensivi. In aggiunta ilvolume è controllato in modo auto-matico per evitare la presenza diulteriori rumori (come i fruscii) cau-sati dal potenziometro di regolazio-ne del volume stesso.
CIRCUITOLo schema elettrico dell’amplificato-re per microfono è mostrato inFigura 2. Il collegamento con ilmicrofono esterno avviene graziealla presa BU2. Il circuito è predispo-
sto sia per microfoni attivi ad elet-trete sia per microfoni dinamici pas-sivi. Attraverso le due resistenze R1 eR2 la tensione di alimentazione, fil-trata dai condensatori C1 e C2,giunge al contatto centrale dellapresa a jack BU2. Il segnale prove-niente dal microfono transita attra-verso il condensatore di collega-mento C3 ed arriva al primo stadiodi amplificazione IC2 C; il fattore diamplificazione di questo stadio èdeterminato dalle resistenze R3 e R5ed è pari a circa 47 volte il segnaledi partenza (33dB). Il segnale amplificato passa poiattraverso IC2 B, che funge da filtrodi alto livello con una frequenza
ELETTRONICA GENERALE
Figura 1Andamento in frequenza a seconda della scelta del filtro utilizzato.
ELETTRONICA GENERALE26
scerà quindi più lentamente grazieallo scaricamento di C12 attraversola resistenza R16.Attraverso la resistenza R17 ed ilcondensatore C14 il segnale amplifi-cato arriva allo stadio finale IC4.Questo amplificatore integrato lavo-ra con un collegamento a ponte,facendo a meno quindi di un even-tuale condensatore elettrolitico inuscita; inoltre non produce alcunrumore di inserimento, risultandoparticolarmente vantaggioso per ilfunzionamento con la cuffia. Il volu-me è regolato elettronicamente permezzo del trimmer R20, collegato alpin 4 di IC4.Per l’alimentazione del circuitoviene impiegata una batteria da 9 V,collegata a ST4 (polo +) e a ST5(polo -). Il regolatore di tensione
produce una tensione stabile pari a3.6V, utilizzata come tensione diriferimento per l’amplificatore ope-razionale.
COSTRUZIONE EDASSEMBLAGGIOL’amplificatore per microfono ècostituito da una basetta a strati(Figura 4) che garantisce una validaschermatura dai disturbi esterni. Èbene cominciare l’assemblaggiopartendo dai componenti di dimen-sioni minori (diodi, resistenze,…)per poi proseguire con i componen-ti di dimensioni superiori (come icircuiti integrati). Sul lato inferioredella basetta vengono saldati i colle-gamenti tra i vari componenti; i filisporgenti devono essere tagliati,prestando attenzione a non dan-
neggiare i punti di saldatura (vede-re Figura 5). È indispensabile instal-lare i semiconduttori ed il condensa-tore elettrolitico rispettando le giu-ste polarità: i diodi hanno il catodocontrassegnato con un cerchio, nelcondensatore elettrolitico invecerisulta evidenziato il polo negativo.Infine, i circuiti integrati (IC) devonoessere collocati in modo che le tac-che sulla loro custodia corrisponda-no con la serigrafia presente sullabasetta. Per ultimi si installano l’in-terruttore a scorrimento e le prese. Icavi di collegamento del clip dellabatteria devono essere condottiattraverso gli appositi fori dellabasetta (si veda la figura) e saldati aST4 (morsetto +) con il cavettorosso ed a ST5 (morsetto -) con ilcavetto nero. Segue poi l’installazio-
ELETTRONICA GENERALE
Schema elettrico dell’amplificatore per microfono.Figura 2
ELETTRONICA GENERALE 27
ne della basetta nel contenitore confermaglio per la cintura. La basettadeve quindi essere fissata con 4 viti alcontenitore. Dopo aver applicato laparte superiore del contenitore que-
sto viene fissato alla parte inferioreper mezzo delle viti del contenitorestesso. Nel vano batterie deve oraessere attaccato un pezzo autoadesi-vo di resina espansa, in modo da
impedire alla batteria di muoversiall’interno dell’alloggiamento.Infine,bisogna posizionare l’asse del poten-ziometro nell’apposito foro presentesulla parte superiore della custodia e,
Figura 3Schema del collegamento della spina jack e dei diversi tipi di microfoni ad elettrete.
Figura 4Circuito stampato della basetta visto dal lato rame in scala naturale.
ELETTRONICA GENERALE
ELETTRONICA GENERALE28
Figura 5 5- Disposizione dei componenti sul circuito stampato.
immediatamente dopo, una mano-pola deve essere installata su taleasse in modo che il contrassegno alineette indichi la scritta ‘Min’ nellaposizione di arresto a sinistra.La capsula del microfono a elettre-te serve per la messa a punto ed ilprimo funzionamento dell’appa-recchio e per i primi esperimentipersonali.Possono essere impiegati microfo-ni ad elettrete a 2 o 3 poli. Ilmicrofono verrà collegato all’am-plificatore con un conduttoreschermato a 2 fili. Uno schema
ELETTRONICA GENERALE
Figura 6-7 Costruzione del microfono a parabola- Microfono come stetoscopio.
ELETTRONICA GENERALE 29
alto rendimento per i più svariaticampi di applicazione. Per esempiol’amplificatore può essere collegatoad un potente microfono direziona-le come può esserlo un microfono aparabola per percepire suoni anchea notevole distanza. In alternativa,per rilevare le piccolissime variazionidi pressione dell’aria causate dalmovimento del cuore o altri suoniprovenienti dal corpo umano potetecollegare uno stetoscopio a questopotente sistema di amplificazione.Oppure potete associare l’amplifica-
preciso del collegamento dellaspina e dei diversi microfoni adelettrete è illustrato in Figura 3.Infine, dopo aver inserito la batteria,l’apparecchio sarà finalmente pron-to per l’uso.
CAMPI D’APPLICAZIONEOltre al microfono ad elettrete indotazione, questo amplificatore puòessere impiegato con altri tipi dimicrofoni che ne ampliano le possi-bilità di utilizzo. In commercio esisteuna certa varietà di microfoni ad
tore ad un microfono a contatto percaptare le vibrazioni meccaniche eascoltare suoni che si propaganoattraverso pareti o lastre di vetro. Imicrofoni qui elencati hanno deiprezzi relativamente elevati; tuttavianon è difficile realizzare tali microfo-ni con materiali e strumenti pococostosi, soprattutto se si lascia spa-zio alla propria creatività…
ELETTRONICA GENERALE
Electronic shop 09
RESISTENZE• R1-2: resistori da 2,2 kΩ
• R3-14: resistori da 4,7 kΩ
• R6: resistore da 6,8 kΩ
• R4-8-11-17-18: resistori da 10 kΩ
• R5: resistore da 220 kΩ
• R7-9-10: resistori da 15 kΩ
• R12-15: resistori da 100 kΩ
• R13: resistore da 470 kΩ
• R16: resistore da 2,2 MΩ
• R20: potenziometro PT15, orizzontale, 100 kΩ
• R21: resistore da 470 Ω• C1-5-15: condensatori elettrolitici
da 10 µF/25 Vl• C2-16-17-19: condensatori ceramici da 100 nF• C3-14: 1 µF/63 Vl/MKT
• C4: condensatore ceramico da 100 pF• C6-7-13: 100 nF/63 Vl/MKT• C8: condensatore da 3,3 nF/400 V• C9: condensatore da 1,5 nF/400 V• C10: condensatore ceramico da 10 pF• C11-20: condensatori elettrolitici
da 1 µF/100 Vl• C12: condensatore elettrolitico
da 2,2 µF/63 Vl• C18: condensatore elettrolitico da 100 µF/16 Vl• IC1: HT1036 (HT7136)• IC2: TL084• IC3: CD4053• IC4: TDA7052A• T1: BF245B• D1-2: IN4148
ACCESSORI• BU1-2: presa jack, 3.5 mm, stereo, stampata• S1-2: interruttori a scorrimento, alto, stampato• S3: interruttore a scorrimento, angolare,
stampato• ST4-5: clip per batteria a 9 V• 1: asse trimmer, 11,7mm• 1: manopola da inserire,
diametro 16.5mm, nera• 4: viti, 2.2 x 6.5mm• 1 pezzo autoadesivo di resina espansa• 1: fermaglio a cintura, Typ894, nero, completo• 1: contenitore forato e serigrafato• 1: spina jack, 3.5mm, stereo• 1: capsula ad elettrete• 100: cm di conduttore schermato a 2 fili
ELENCO COMPONENTI
)
ABBIAMO BISOGNO DEI TUOI CONSIGLI!È per questo che ti invitiamo a compilare questa scheda,ci aiuterai a rendere Fare Elettronica più vicina alletue esigenze.
)
FATTI CONOSCEREFATTI CONOSCERE
Invia questa pagina, adeguatamente compilata,via fax allo 0321/927042 o via posta a:
DTP Studio EditriceVia Matteotti, 8 - 28043 Bellinzago (NO)
Tutte le schede pervenute
ENTRO IL 31 MARZO 2003parteciperanno all’estrazione di
((33
>>
ABBONAMENTI AFARE ELETTRONICAIN OMAGGIO
Nome e CognomeIndirizzo LocalitàCap Prov Telefono email
A Quanti anni hai?
1 Meno di 18
2 Tra 18 e 30
3 Tra 31 e 40
4 Tra 41 e 50
5 Oltre 50
B Qual'è il tuo titolo di studio?
6 Licenza media
7 Diploma scuola professionale
8 Diploma media superiore
9 Laurea o diploma scuola universitaria
C Quale attività svolgi?
10 Studente
11 Insegnante
12 Operaio
13 Impiegato, dirigente
14 Libero professionista, imprenditore
15 Altro
E Con quale frequenza leggi FE?
16 Sono abbonato.
17 L'acquisto regolarmente ogni mese.
18 Acquisto in media 5-6 numeri all'anno.
19 Acquisto non più di un paio di numeri all'anno.
F Da quanto tempo conosci FE?
20 Dal primo numero
21 Da più di 5 anni
22 Da più di 2 anni
23 Da meno di 2 anni
G Come giudichi la qualità complessiva di FE così com'è oggi?
24 Eccellente
25 Buona
26 Passabile
27 Scarsa
H Quali dei seguenti argomenti ti interessano maggiormente e ti spingono
ad acquistare una rivista di elettronica applicata?
28 Apparecchi in alta frequenza (radio).
29 Apparecchiature audio, TV, video, hi-fi.
30 Apparecchi per la casa e l'auto.
31 Strumenti di misura.
32 Piccoli progetti di utilità.
33 Articoli di teoria, didattica, tecnologia di base.
34 Altro
I Quali rubriche vorresti veder trattate?
35
L Quali kit ti interessano di più?
36
M Tra le rubriche di FE quella che preferisci è:
37 News
38 In vetrina
39 Al mercato: gli annunci dei lettori
40 Internet in Pr@tica
O La nuova veste grafica di FE ti sembra soddisfacente?
41 Sì
42 No
43 Ecco come la modificherei:
P Rispetto all'attuale, la "mia" FE dovrebbe essere così:
44 Più tecnica, superspecializzata, rigorosamente per
"addetti ai lavori".
45 Più divulgativa, ad ampio spettro di contenuti, di lettura
facile e immediata anche per i meno esperti.
46 Dedicata esclusivamente ai progetti da costruire.
47 Dedicata anche all'informazione e ricca di riferimenti al
mercato dell'elettronica di consumo (prodotti finiti).
48 Più elegante e sofisticata, con tante pagine a colori su
carta di ottima qualità.
49 Essenziale e spartana, purché ricca di contenuti tecnici
e a basso prezzo di copertina.
50 La lascerei esattamente così com'è.
51 La cambierei così:
Q Quali di queste riviste leggi più spesso?
52 Nessuna
53 Elettronica In
54 Nuova Elettronica
55 Altro
R Possiedi un Personal Computer?
56 Si
57 No
S Disponi di una connessione a Internet?
58 Si
59 No
Invia questa pagina, adeguatamente compilata, via fax (0321/927042) o via posta a: DTP Studio Editrice Via Matteotti, 8 - 28043 Bellinzago Novarese (NO)
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI. In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali DTP Studio Editrice garantisce la massima riservatezza dei dati da te comunicati e la possibilità di richiederela verifica, rettifica o cancellazione, scrivendo al Responsabile Dati di DTP Studio Editrice Via Matteotti, 8 - 28043 Bellinzago Novarese (NO). I tuoi dati sranno da noi utilizzati esclusivamente ai fini statistici.
FATTI CONOSCERE FEBBRAIO 2003FATTI CONOSCERE FEBBRAIO 2003
ELETTRONICA GENERALE32
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE A 4 LIVELLI
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE A 4 LIVELLIdi Fabrizio [email protected]
Il progetto che presentiamo ha una caratteristica che lo differenzia dai classici interruttori crepuscolari: ha la possibilità di impostare fino a un massimo di 4 livelli di luminosità, oltrepassati i quali si attivano altrettanti relè, in grado di comandare carichi fino a 8A. Può essere utile per illuminare un ambiente in modo graduale, o in tutti quei casi in cui si renda necessario discriminare differenti intensità luminose dell'ambiente.
IL CIRCUITOIn Figura 1 trovate i componentipolarizzati, mentre in Figura 2 pre-sentiamo lo schema elettrico del-l'interruttore crepuscolare.Come si può vedere, il circuito è diuna semplicità estrema. Iniziamola nostra descrizione dal partitoreformato da R1, FR1, R2; la fotoresi-stenza FR1 ha la caratteristica dipresentare una resistenza moltobassa se sottoposta ad una forteintensità luminosa, e molto alta albuio.Abbiamo scelto i valori di R1 ed R2,in modo che la tensione ai capi diR2, possa variare da un minimo dicirca 1V (al buio) fino a poco menodella tensione di alimentazione (in"piena" luce).Nella gamma delle diverse intensitàdi illuminazione, la tensione ai capidi R2 esplora la gamma 1... 12 V inmodo pressochè lineare.Tale tensione è applicata sugli
ingressi invertenti (-) dei quattroamplificatori operazionali, conte-nuti all'interno di U1.Tali operazionali, collegati in confi-gurazione di comparatori con iste-resi, costituiscono quattro stadi, tra
loro assolutamente identici, ciascu-no dei quali è relativo a ciascunodei quattro relè.Parleremo tra poco dell'isteresi. Perora diciamo che sull'ingresso noninvertente (+) di ciascun compara-
ELETTRONICA GENERALE
ELETTRONICA GENERALE 33
ELETTRONICA GENERALE
Supponiamo, quindi, che a uncerto punto l'illuminazione a cui èsottoposta la fotoresistenza inizigradualmente a diminuire. In talecondizione, il valore ohmmicodella fotoresistenza inizia adaumentare, e di conseguenza latensione ai capi di R2 a diminuire.
Tale tensione, applicata sull'in-gresso invertente di tutti i compa-ratori, viene appunto confrontatada ciascun comparatore con latensione impostata dal relativotrimmer (vedere Figura 3 eFigura 4).Di conseguenza:
tore è applicata una tensione, chepuò essere regolata agendo sultrimmer del relativo stadio.L'uscita di ciascun comparatore assu-me livello logico 1 quando la tensio-ne ai capi di R2 scende sotto il livelloimpostato dal relativo trimmer. A tito-lo di esempio, supponiamo di trovar-ci in condizioni di piena luminosità,tale da misurare, ai capi di R2, unatensione di 11V. Supponiamo anchedi aver regolato i trimmer da RV1 aRV4, in modo da ottenere le seguentitensioni sugli ingressi non invertentidei comparatori:
• pin 3 U1A: 9V• pin 5 U1B: 7V• pin 10 U1C: 6V• pin 12 U1D: 4V
Schema elettrico dell'interruttore crepuscolare. Figura 2
Componenti polarizzati. Figura 1
ELETTRONICA GENERALE34
• quando la tensione ai capi di R2scende sotto i 9V, l'uscita di U1A(pin 1) va a livello alto, provocan-do l'accensione del led DL1 e l'ec-citazione del relè RL1.
• quando la tensione ai capi di R2scende sotto i 7V, anche l'uscitadi U1B (pin 7) si porta a livelloalto, provocando l'accensione delled DL2 e l'eccitazione del relèRL2.
• quando la tensione ai capi di R2scende sotto i 6V, anche l'uscita
di U1C (pin 8) si porta a livelloalto, provocando l'accensione delled DL3 e l'eccitazione del relèRL3.
• quando la tensione ai capi di R2scende sotto i 4V, anche l'uscitadi U1D (pin 14) si porta a livelloalto, provocando l'accensione delled DL4 e l'eccitazione del relèRL4.
In conclusione, parliamo del fun-zionamento dell'isteresi.
La lentezza con cui normalmentevaria l'illuminazione a cui sottopo-niamo la fotoresistenza, può causa-re che durante il passaggio di cia-scuna delle quattro soglie, il relati-vo relè non si ecciti in modo netto,ma ad intermittenza.Per ovviare a questo inconveniente,abbiamo fatto in modo che, supe-rata una certa soglia partendo daluce alta a luce bassa, durante ilritorno (da luce bassa a luce alta) lastessa soglia sia leggermente diver-sa, come spieghiamo meglio qui diseguito.Prendendo come riferimento l'e-sempio precedente, quando la ten-sione ai capi di R2 è superiore ai9V, e di conseguenza l'uscita diU1A (pin 1) è a livello basso, la resi-stenza R3 viene a trovarsi in paral-lelo alla "parte inferiore" del trim-mer RV1, ossia tra il pin 3 e massa.Questo comporta che la tensionerealmente presente sul pin 3 è leg-germente inferiore a quella che simisurerebbe in assenza di R3, conRV1 regolato in modo identico(abbiamo detto "leggermente" infe-riore, perchè R6 è "molto" maggioredi RV1).Non appena la tensione su R2 scen-de sotto i 9V, il pin 1 va a livelloalto, e di conseguenza R3 viene atrovarsi in parallelo alla "parte
ELETTRONICA GENERALE
Caratteristica di una fotoresistenza.Figura 3
Condizioni dell’interruttore crepuscolare.Figura 4
ELETTRONICA GENERALE 35
ELETTRONICA GENERALE
superiore" di RV1, ossia tra il pin 3e il positivo di alimentazione.Questo comporta che la tensionerealmente presente sul pin 3 è leg-germente inferiore a quella che simisurerebbe in assenza di R3, conRV1 regolato nello stesso modo. Inaltre parole, grazie alle resistenzeda R3 a R6, la tensione di riferi-mento impostata dai trimmer èleggermente diversa, in base alla
condizione in cui si trova l'uscitadel comparatore.
PARLIAMO DELL'ISTERESI…Il grafico che trovate in Figura 5,mostra il funzionamento dell'istere-si e partiamo dalla condizione incui è presente la massima tensionesul pin 2, e di conseguenza livellobasso sul pin 1 (punto A).Riducendo gradualmente la tensio-
ne al pin 2, a un certo punto ilcomparatore commuterà a livelloalto (linea blu).Se poi aumentiamo gradualmentela tensione al pin 2, facendo quindiil percorso inverso (linea rossa)vedremo che il comparatore com-muterà nel momento in cui la ten-sione sul pin 2 raggiunge un livelloleggermente superiore a quello incui precedentemente aveva com-mutato.Quindi, partendo dalla condizionedi pin1 basso (led spento) la sogliadi commutazione sarà leggermentesuperiore, rispetto a quella che siha partendo dalla condizione dipin1 alto (led acceso).
REALIZZAZIONE PRATICAInnanzitutto è necessario reperire ilmateriale riportato nell'elencocomponenti, e realizzare il circuitostampato presentato in Figura 6.Dopodichè i componenti dovrannoessere saldati sul circuito stampato;fate riferimento alla Figura 7 che visemplificherà notevolmente il lavo-ro. Per i principianti segnaliamo nelsito www.pianetaelettronica.it, delleutili guide per realizzare i circuitistampati e per saldare i componen-ti sulla scheda.Se vogliamo utilizzare questo pro-getto sfruttando soltanto due o trelivelli, possiamo farlo tranquilla-mente. In questo caso non dovre-mo montare i componenti relativiallo stadio (o agli stadi) non utiliz-zati.Una volta in possesso del circuitostampato, per la saldatura dei com-ponenti consigliamo di procederecon questo ordine: si procede allarealizzazione dei 3 ponticelli previ-sti, dopodiché procedete con le 14resistenze previste facendo atten-zione ai colori giusti; quindi monta-te i 5 diodi 1N4007 facendo atten-zione alla polarità; lo zoccolo da 14pin stando attenti a posizionarlorispettando la tacca di riferimento
Grafico dell’isteresi. Figura 5
Circuito stampato della basetta visto dal lato rame in scala 1:1. Figura 6
ELETTRONICA GENERALE36
ed il condensatore multistrato.Tocca ora ai 4 transistor BC337che vanno inseriti nel giusto verso,i 4 trimmer e al condensatore elet-trolitico facendo attenzione allapolarità; proseguite con i 4 diodiled facendo attenzione alla taccadi riferimento; i 4 relè o i fili adessa collegati, se posta in altroluogo; la fotoresistenza ed, infine,i 4 connettori.
PROVA DI FUNZIONAMENTOTerminato il montaggio della sche-da, possiamo alimentarla con unalimentatore in tensione continuadi 12...13V in grado di erogarealmeno:
• 200mA, se utilizzato a 2 livelli• 300mA, se utilizzato a 3 livelli• 400mA, se utilizzato a 4 livelli
Inizialmente non colleghiamoalcun carico ai relè.É necessario effettuare la regola-zione dei trimmer, secondo unodei due seguenti casi:
CASO 1Se vogliamo effettuare le regola-
ELETTRONICA GENERALE
• R1: resistenza 1 KΩ 1/8W (marrone - nero - rosso - oro)
• R2: resistenza 100 KΩ 1/8W marrone - nero - giallo - oro)
• R3÷6: resistenza 220 KΩ 1/8W (rosso - rosso - giallo - oro)
• R7÷10: resistenza 10 KΩ 1/8W (marrone - nero - arancio - oro)
• R11÷14: resistenza 1 KΩ 1/8W (giallo - viola - rosso - oro) (*)
• RV1÷4: trimmer piccolo verticale 100 KΩ
• FR1: Fotoresistenza• C1: condensatore multistrato 100nF
(codice 104)• C2 : condensatore elettrolitico 100µF
16V o più• RL1÷4: Relè 12V uno scambio 8A (*)• D1÷5: Diodo 1N4007 (corpo nero)• DL1÷4: Diodo led qualsiasi (max. 10mm.)• T1÷4: Transistor BC337• U1: Integrato LM324
ALTRO MATERIALE NECESSARIO
• N.1 zoccolo DIP 14• N.4 connettori 3 pin passo 5,08mm.• N.1 circuito stampato PE209
(*)Vedi al capitolo "Realizzazione" per alimentazio-ne a 6...7V.
LISTA COMPONENTI
Disposizione dei componenti sulla basetta.Figura 7
Ecco come collegare le lampade.Figura 8
ELETTRONICA GENERALE 37
zioni, nel passaggio da luce abuio, dobbiamo regolare tutti itrimmer completamente in sensoantiorario.A questo punto, nel luogo e nelmomento in cui è presente l'illu-minazione a cui vogliamo far com-mutare il nostro dispositivo, rego-liamo lentamente ciascun trim-mer, finché il relativo led si accen-de.Iniziamo dal trimmer RV1, e prose-guiamo nell'ordine fino a RV4.
CASO 2Se vogliamo effettuare le regola-zioni, nel passaggio da buio aluce, dobbiamo regolare tutti i
trimmer completamente in sensoorario.A questo punto, nel luogo e nelmomento in cui è presente l'illumi-nazione a cui vogliamo far commu-tare il nostro dispositivo, regoliamolentamente ciascun trimmer, finchéil relativo led si spegne.Iniziamo dal trimmer RV4, e prose-guiamo nell'ordine fino a RV1.Nella regolazione dei trimmer, difatto, non è necessario seguire unordine, in quanto i quattro stadisono identici, ma noi consigliamodi seguire l'ordine indicato perchèin questo modo, si stabilisce ilseguente ordine d'accensione, cheresta invariato, qualora si decida dipassare dal CASO1 al CASO2:
• DL1• DL1 + DL2• DL1 + DL2 + DL3• DL1 + DL2 + DL3 + DL4
Collegamento delle lampade
Le lampade vanno collegate airelè, semplicemente come con unnormale interruttore come poteteosservare in Figura 8, dove vedia-mo lo schema di collegamentoriferito, per semplicità, ad una solauscita. Nello schema elettricoabbiamo utilizzato il seguentecodice, per i connettori:CO = ComuneNC = Normalmente chiusoNA = Normalmente aperto
Tale codice è seguito dal numerodell'uscita, ad esempio: CO1 =comune uscita 1, NC3 =Normalmente chiuso uscita 3, ecc.
PER ALIMENTAZIONE A 6V...Il nostro dispositivo può essere ali-mentato con diverse tensioni di ali-mentazione, in funzione della ten-sione richiesta dalla bobina del relè,che generalmente, il modello da noiutilizzato è reperibile a 6V e 12V.Se utilizziamo un relè da 6V, pos-
siamo alimentare il circuito conuna tensione di 6...7VIn questo caso occorre ridurre ilvalore delle resistenze R11, 12, 13,14 a 330Ω 1/8W.
NOTA SULLA RESISTENZA R2Diverse fotoresistenze non presen-tano sempre gli stessi valori ohm-mici a parità di intensità luminose.Quindi, tenendo presente che perun funzionamento ottimale i trim-mer dovrebbero essere regolatipiù al centro possibile, evitandoquindi di regolarli verso inizio ofine corsa, qualora la fotoresisten-za utilizzata non consenta la rego-lazione ottimale dei trimmer comeappena detto, consigliamo didiminuire il valore di R2. Perprova, è anche possibile collegaretale resistenza, direttamente sullato piste, oppure collegarne unain parallelo, sempre sul lato piste,se si presenta la necessità.Normalmente non è necessarioscendere al di sotto dei 47 - 22KΩ.
Attenzione alla luce!
La fotoresistenza deve essere postalontano dalla luce emessa dallelampade che accendiamo con ilnostro dispositivo (quelle collega-te ai relè).Questo perchè, se la fotoresistenza"vede" la luce emessa da tali lam-pade, questa modificherebbe lasua resistenza, facendo tornare ildispositivo allo stato precedente, ilquale di conseguenza spegnereb-be la lampada che farebbe ricom-mutare ancora il circuito... In definitiva si otterrebbe un lam-peggio continuo.
ELETTRONICA GENERALE
Electronic shop 10
ELETTRONICA GENERALE38
TERMOMETRO ELETTRONICOA COLONNINATERMOMETRO ELETTRONICOA COLONNINAdi Giulio [email protected]
Il termometro più classico, che da sempre vediamo in ogni casa, è sicuramente quelloa colonna di mercurio o alcool. Così come il barometro a mercurio di Torricelli, non è solamente uno strumento che ci indica la temperatura,ma un vero e proprio oggetto d’arredamento, soprattutto quando lo vediamo in forme eleganti e slanciate,magari montato su legno e con scala termometrica che in rari e preziosi modelli viene incisasu cristallo. La versione di questo termometro che vi proponiamo, pur essendo total-mente elettronica,con tanto di sonda ad alta tecnologia e controllo a microprocessore,rispecchia forme e modo d’indicazione dei suoi nobili antenati con colonna di mercu-rio,rendendolo allo stesso tempo moderno, tecnologico,ma anche tradizionale. Unacolonna formata da 41 led, indica con eccellente precisione temperature da –5°C a +35°C. Unico vantaggio, rispetto ai modelli tradizionali, è che può, mediantel’aggiunta di altre sonde, misurare temperature di vari ambienti sia interni che esterni.L’alimentazione tipica è a 5 volt (da 3,5 a 5,5 volt) tensione continua, con un assor-bimento medio di soli 60 mA.
Ogni tanto capita anche ad un pro-gettista elettronico,solitamente nonincline a forme “artistiche”, ma piut-tosto a far tornare calcoli teorici inapparati elettronici dei più disparatitipi, di voler realizzare qualcosa disimpatico, a prescindere dalle circui-teria più o meno complesse. Magariqualche volta potrà capitare che, oltrealla “simpatia” dell’oggetto, ci siaanche una sorta di piacevolezza este-tica, ovviamente dipendente dai sin-goli gusti. Pensiamo che l’ MK3955faccia parte di questi oggetti chequalcuno penserà di appendere almuro di casa e magari lo troveràanche bello perché “particolare”! Unabarra di 41 led rossi, simula perfetta-
ELETTRONICA GENERALE
Tutto il lavoro è svolto dal micropro-cessore U1,un Pic 16C63. Ogni circa5 secondi U1 chiama la sonda di tem-peratura U2 “chiedendogli” qualevalore binario di temperatura sta“sentendo” nell’ambiente in cui sitrova. La sonda U2 invia la risposta incodice binario, U1 la interpreta e diconseguenza accende la barra dei ledperché visualizzino l’esatta tempera-tura sentita da U2. L’accensione deiled viene comandata da U1 con unsistema a matrice 5 X 8 multiplexato,ovvero vengono accesi indipendente-mente 40 led con sole 13 linee (5 X8 = 40). Il led DL1,che indica unatemperatura uguale o inferiore ai–5°C, rimane ovviamente sempreacceso, mentre i rimanenti 40 ledDL2÷DL41, formano una colonnacostantemente accesa di lunghezzadirettamente proporzionale al valoredella temperatura. L’alimentazionedel circuito può variare, senza mini-mamente incidere sul corretto fun-zionamento e precisione del termo-metro tra 3,5 e 5,5 Volt tensione con-tinua. Ovviamente a 3,5 volt, la lumi-nosità dei led sarà leggermente infe-riore rispetto ad una alimentazione di5 o 5,5 Volt. È molto importantericordare che alimentando l’MK3955ad una tensione maggiore di 5,5Volt, anche per pochi secondi, si correil serio rischio di danneggiare irrepa-rabilmente U1 ed U2!
ASSEMBLAGGIO E COLLAUDOL’assemblaggio dell’ MK3955 noncomporta eccessive difficoltà e puòessere effettuato anche da chi non haancora molta esperienza con l’assem-blaggio di circuiti elettronici. Questograzie anche al circuito stampato deltipo a doppia faccia con fori metalliz-zati. Va da se che non lo suggeriamocome primo montaggio in assoluto,ameno che non si abbia un amicoesperto che ci suggerisca le cose fon-damentali seguendoci durante le fasidi assemblaggio. Come al solito fac-ciamo alcune importanti raccoman-dazioni: utilizzate un saldatore apunta sottile di bassa potenza (25Watt o meno) e stagno di piccolo dia-metro (max 1 mm, meglio se 0,7mm) con anima interna disossidante.Non utilizzate per nessun motivopasta salda, andreste incontro ad unsicuro insuccesso! In Figura 2 trovatecome sempre il circuito stampatodella basetta visto dal lato rame, men-tre, in Figura 3, che dovrete seguirecon la massima attenzione, troverete,oltre alla serigrafia presente anche sulcircuito stampato, anche i disegni deicomponenti polarizzati. Questi com-ponenti dovranno essere montatirispettando il giusto verso d’inserzio-ne nel circuito stampato, pena unnon funzionamento e probabile dan-neggiamento del circuito quandotenterete di metterlo in funzione. In
mente la colonnina di mercurio. Circaogni 5 secondi,un brevissimo e quasiimpercettibile lampeggio dellabarra, avvisa che lo strumento stacampionando i dati provenienti dallasonda elettronica digitale. La sonda,contrariamente al comportamentodella maggior parte di quelle elettro-niche attive (LM35, AD590 ecc.) opassive (NTC, PTC, PT100 ecc.) cheforniscono un segnale analogico pro-porzionale alla temperatura rilevata,trasmette un segnale digitale, cioèuna serie di bit 1/0, equivalente allatemperatura misurata, e questo lo facon un solo filo grazie alla tecnologiadi trasmissione one wire che utilizzaun solo filo (più ovviamente la massa)per alimentare, interrogare e riceverei segnali di temperatura dalla sonda. Ilcontrollo dei dati e la loro interpreta-zione come temperatura è ovvia-mente affidato ad un microprocesso-re che interroga la sonda ogni 5secondi e poi provvede ad accenderela barra di led visualizzatori in base aidati digitali di risposta della sondastessa. Ogni led rappresenta un valo-re di temperatura in gradi centigradied una chiara serigrafia sul circuitostampato rende immediata la letturadella temperatura.
CIRCUITO ELETTRICOIn Figura 1 vediamo la circuiteriaelettronica del termometro MK3955.
ELETTRONICA GENERALE
Il volume tratta il principio di funzionamento e la realizzazione di circuiti elettronici dedicati allemicrospie. I vari argomenti sono raggruppati in 7 capitoli:• oscillatori liberi; • oscillatori quarzati; • microspie telefoniche; • microspie video;• rivelatori di microspie; • microspie optoelettroniche a laser; • circuiti vari.Sotto quest’ultima voce troviamo altri circuiti interessanti come una microspia stereofonica, uno scrambler, un microfono selettivo, un captatore da parete, un ricevitore sui 900 MHz per itelefonini cellulari e così via.
cod. 20-1006-06
G. MORONI - A. CATTANEO
MICROTRASMETTITORI SPY
A soli € 11,36
I volumi possono essere richiesti via lettera o fax a: DTP Studio Editrice S.r.l. - via Matteotti, 8 28043 Bellinzago (NO) - Tel. 0321/927287 - Fax 0321/927042
o via email: [email protected] - La spedizione viene effettuata da Sandit srl - esclusivamente in contrassegno (spese di spedizione € 2,5).
ELETTRONICA GENERALE40
Figura 1
ELETTRONICA GENERALE
Schema elettrico del termometro MK3955Figura 1Figura 1
ELETTRONICA GENERALE 41
questo caso i componenti polarizzatisono: DL1÷DL41, C4, T1÷T5, U1 edU2. Tutti i rimanenti potrete inserirlinel circuito stampato senza badare alverso. La sonda U2 andrà cablata
come in figura, il piedino centrale èquello di segnale, quello cioè cheandrà a collegarsi con la resistenzaR21 ed il piedino 15 di U1, i due late-rali sono entrambi a massa. Per colle-gare la sonda distante dal circuitostampato (non più di 8/10 metri!)dovrete utilizzare due normali con-duttori intrecciati tra loro (doppinotelefonico o semplici fili sottili intrec-ciati) e collegarli come in Figura 4.Se la sonda dovrà stare esposta alleintemperie o immersa in acqua, saràbene proteggerla con un sottile stratodi collante siliconico oppure epossidi-co bicomponente. Non esageratecon le quantità, altrimenti l’inerziatermica della sonda, ovvero la veloci-tà con cui sarà in grado di avvertirecambiamenti di temperatura diminui-rà notevolmente. Volendo potreteanche isolarla con uno strato di collaa caldo, quella che viene applicatacon i dispenser a pistola elettrica.L’alta temperatura della colla nonarrecherà alcun danno alla sondastessa. Probabilmente avrete notatoche U2 ha i piedini simmetrici (cen-trale = segnale, laterali = massa), perquesto motivo potrete inserirla indif-ferentemente con la sua faccia piattarivolta verso l’interno o l’esterno delcircuito stampato. Terminato il mon-taggio passeremo al collaudo. Nonsarà necessaria alcuna taratura. Perl’alimentazione vi suggeriamo un pic-colo alimentatore universale anchenon stabilizzato, di quelli che normal-mente si utilizzano per piccole calco-latrici, segreterie telefoniche ecc. contensioni da circa 3 a 12 volt selezio-nabili. La potenza dell’alimentatoredi 200/300 mA sarà più che sufficien-te. L’uscita dell’alimentatore dovràessere selezionata indifferentementetra 3,5 e 5,5 volt, non di più!Attenzione alla polarità dello spinotto,che dovrà avere il polo positivo (+)centrale! Se già avete a disposizioneun alimentatore stabilizzato da 5 volt,andrà benissimo anche quello.Volendo potrete anche scegliere il
ELETTRONICA GENERALE
Circuito stampato della basettavista dal lato rame in scala naturale
Figura 2
ELETTRONICA GENERALE42
ai 35°C , tutti i led rimarrebbero acce-si. Volendo aggiungere altre sonde,per misurare temperature in luoghidiversi (interno, esterno ecc.) baste-rà che vi procuriate un selettorerotativo a due vie con due, tre, quat-tro, cinque o sei posizioni e commu-tiate le sonde interessate. In Figura 4facciamo l’esempio di collegamentodi due sonde (esterno-interno) ser-vendoci di un semplice deviatore alevetta a 6 piedini.
ELETTRONICA GENERALE
• R1÷R10: resistori da 1 kΩ
• R11: resistore da 10 kΩ
• R12÷R20: resistori da 220 Ω• R21: resistore da 4,7 kΩ
• C1-2: condensatori ceramici da 22 pF• C3: condensatore poliestere da 100 nF• C4: condensatore elettrolitico da 100 µF• Q1: quarzo 4,000 MHz• T1÷T5: transistor PNP BC557• U1: PIC16C63 programmato per MK3955• U2: DS1820S sonda di temperatura digitale• DL1÷DL41: Led rossi 5 mm• J1: connettore femmina coassiale per
alimentazione• N°1: circuito stampato MK3955/CS• N°1: zoccolo 28 pin dip
LISTA COMPONENTI
Disposizione dei componenti sulla basettaFigura 3
CablaggioFigura 4
Electronic shop 11
nostro alimentatore stabilizzato GPEmodello MK175/A5 e relativo trasfor-matore MK175/T. Una volta data alimentazione, perqualche secondo si accenderannotutti i led, dopo si accenderanno soloquelli relativi alla temperatura misura-ta dalla sonda U2. Ovviamente, se latemperatura dovesse essere superiore
ELETTRONICA GENERALE44
CIRCUITO ELETTRONICOANTIBALBUZIECIRCUITO ELETTRONICOANTIBALBUZIEdi Andrea [email protected]
Questo circuito non molto dissimile da un comune metronomo permetterà a coloroche sono balbuzienti di scandire le sillabe in un ben certo ambito temporale comese si trattasse di una canzone, in questo modo dopo un certo tempo di esercizio ildifetto potrà essere dimenticato o limitato fino ad essere impercettibile.
La realizzazione di questo circuitomi è stata proposta da un amicoche, non me ne voglia, “tartaglia”in modo davvero imbarazzante, alpunto da far perdere il lume dellaragione a chi lo ascolta: c’è chi sida un contegno e chi, come me,cade nello stesso difetto iniziandoin modo irriverente a intaccare…..Seccato e convinto che lo pren-dessi in giro, l’amico mi chiese seavessi potuto realizzare uno scan-ditore di battute tutto da provare:in commercio esistono apparecchidi questo tipo ma i costi sonoabbastanza alti. In realtà si trattadi un circuito non molto differen-te da un comune metronomo maa differenza del circuito musicalein questo caso dobbiamo control-lare sia la frequenza della battutache il ciclo utile dell’onda (dutycycle). Sono stati scelti per la realizzazio-ne due circuiti integrati comunicome il 555 perché possiamodemandare al primo integrato lagestione della frequenza dellabattuta ed al secondo la nota daudire nell’auricolare, il 555 inoltreha potenza in uscita al pin 3 taleda pilotare un auricolare da 32
ohm. Il circuito funziona con una comu-ne piletta da 12V tipo telecoman-do e, se tenuto a volumi bassi ladurata è notevole.
SCHEMA ELETTRICOCome possiamo vedere in Figura1 il circuito non è complicato, usadue soli integrati otto piedini tipo555, entrambi utilizzati comeoscillatori astabili, IC2 a frequenzamolto bassa per generare le battu-te, l’altro IC1 a frequenza udibileper generare la nota in auricolare. Partiamo dalla sorgente di ener-gia, cioè la piccola pila; tramite S1accendiamo l’apparecchio e attra-verso il diodo di protezione inserie alla linea positiva alimentia-mo il circuito. D1 evita, se inver-tiamo il senso della polarità di ali-mentazione, di combinare guai alcircuito.C1 livella l’alimentazione genera-le. Parleremo per primo dell’inte-grato IC2 che è connesso comeoscillatore astabile con controlloseparato della durata della perma-nenza alta e bassa della onda qua-dra generata, in questo modoagendo sui potenziometri P2 e P3
potremo variare la lunghezzadella nota emessa, oppure la per-manenza del silenzio, operandosu entrambi i controlli varieremonon il duty cycle ma la frequenza
ELETTRONICA GENERALE
ELETTRONICA GENERALE 45
ELETTRONICA GENERALE
a livello alto, sblocca il pin 4 diRESET di IC1 permettendo all’in-tegrato di generare la nota dibile.Modificando i valori di R1, R2 eC3 potremo variare la nota emes-sa da grave ad acuta.
Nel nostro caso i componentisono stati ottimizzati in modo daavere nota ben udibile con il mini-mo consumo. Tramite il trimmerP1 potremo regolare il volume inauricolare. Un jack mono miniatu-
di oscillazione modificando iltempo di battuta.Il condensatore C5 unitamente aigià menzionati componenti gene-ra l’oscillazione quadra disponibi-le in uscita al pin 3 di IC2 che, se
Schema elettrico circuito antibalbuzie. Figura 1
ELETTRONICA GENERALE46
ELETTRONICA GENERALE
ra permetterà il collegamento trastampato e auricolare.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIOCome sempre potete trovare il cir-cuito stampato della basetta inFigura 2 mentre, in Figura 3, pre-sentiamo la disposizione dei com-ponenti. Montare un apparecchietto diquesto tipo, collocarlo nella suascatoletta non è cosa difficile madate le minime dimensioni dellostampato occorre lavorare concura e ordine, i resistori verrannomontati per primi ed in verticalecome i diodi, i condensatoriminiatura di tipo verticale, inseguito poi i trimmer ed i circuitiintegrati senza zoccolo per motividi spazio. Il jack di connessione, l’interrutto-re di accensione verranno da Voiposti dove più comodo, in modoche la piletta stilo abbia un buonalloggiamento. Esistono allo scopo piccole scato-lette con portellino per la pila chenon sono più grandi di un pac-
chetto di fiammiferi.Dopo aver montato il circuito,prima di chiuderlo nella scatolaeffettuate un bel controllo dellavoro in modo da evitare erroriche potrebbero non far funziona-re l’apparecchio. Chi preferisce potrà aggiungereuna piccola spia led, del tipo abasso consumo, con resistore dilimitazione della corrente in serie.Se tutto il lavoro si è svolto inmodo giusto potrete connetterel’auricolare, del tipo a 32 Ohmmagnetodinamico, la pila eaccendere l’interruttore.Udrete una nota intervallata:regolando P1 se ne varierà il volu-me a vostro piacimento, con P2 eP3 potrete allungare la nota o ilsilenzio d’intervallo. Si consigliaun range di 0,5 Hz con una notache duri circa 0,25 secondi.
UTILIZZO DELL’APPARECCHIOAccendete l’apparecchio, poneteall’orecchio l’auricolare quindiprovate a parlare scandendo le sil-labe nell’intertempo tra una nota
e l’altra, proprio come se si trat-tasse di una filastrocca o canzone. Non preoccupatevi se sentirete lavostra cadenza un poco cantile-nante e ritmica, anzi! Cio significache inserite in modo corretto lesillabe nell’intervallo temporale.Esercitatevi fino a che non impa-rerete voi stessi ad imporvi untempo di spaziatura delle sillabe.In questo modo molti hannodimenticato il loro problema didizione.Molti altri potranno essere gli uti-lizzi del circuito ma lascio a Voiscoprirli.
Circuito stampato scala 1:1Figura 2
Piano di montaggio dei componenti e cablaggi.
Figura 3
• R1: resistore da 3,3 kΩ
• R2: resistore da 100 kΩ
• R3: resistore da 4,7 kΩ
• R4-5: resistori da 10 kΩ
• R6: resistore da 22 Ω• P1: trimmer da 100 Ω• P2-3: trimmer da 2,2 MΩ
• C1: condensatore elettrolitico da 47 µF/16 Vl
• C2-3-4: condensatori da 10 nF • C5: condensatore elettrolitico
da 1 µF/16 Vl• C6: condensatore elettrolitico
da 100 µF/16 Vl• D1-2-3: 1N4148• IC1-2 : NE555• S1: interruttore a slitta• 1: auricolare 32 Ω• 1: jack femmina mono 3,5 mm• 1: jack maschio mono 3,5 mm• 1: piletta 12V stilo• 1: scatoletta plastica tipo telecomando
con portapila
LISTA COMPONENTI
Electronic shop 12
HARDWARE48
INTRODUZIONE AI CCDINTRODUZIONE AI CCDseconda parte di Riccardo [email protected]
Nella scorsa puntata abbiamo introdotto il funzionamento del CCD, illustrandone le ancheprincipali caratteristiche e le potenzialità in termini di dimensione, risoluzione e sensibilità.Inizieremo ora a valutare aspetti un po’ più pratici e, se vogliamo, un po’ più divertenti…!Ma prima di iniziare ecco un paio di nozioni utili che completeranno il nostro percorso.
HARDWARE
I CCD “STRARIPANTI”E L’INFRAROSSO…Il titolo di questo punto sembre-rebbe più adatto ad un film di fan-tascienza e, probabilmente, le coseche vedremo richiameranno allamente qualcuna delle vostre scenepreferite. Lo “straripamento” è inrealtà un effetto che nel mondodei CCD è noto come “blooming”,una situazione che si verifica quan-do uno o più pixel del sensore si“riempiono” con una quantità difotoni maggiore di quella che sonocapaci di contenere.Questo accade quando l’immagi-ne reale rilevata dal CCD contieneuna forte sorgente luminosa checausa quindi il riempimento totaledi uno o più pixel, saturandolo.Immaginate di dover riempire unanormale vaschetta per il ghiaccio,di quelle formate da tanti scom-parti l’uno vicino all’altro.Continuando a versare acqua inuno degli scomparti, questo siriempirà fino all’orlo dopodichél’acqua strariperà e verrà travasataagli scomparti vicini. Allo stessomodo se la quantità di luce checolpisce un pixel è maggiore dellasua capienza, la “luce” in ecceden-za fluirà agli scomparti vicini.A livello pratico questo effettoindesiderato causa una saturazionedi tutti i pixel disposti nelle vici-nanze del punto di luce rilevato ela conseguente immagine memo-
rizzata presenterà una vera e pro-pria macchia bianca diffusa, moltopiù grande di quella realmentepercepita. E questo si tradurrà inuna perdita di realtà, di dettaglio edi precisione nella riproduzionedell’immagine.Fortunatamente alcuni costruttoriadottano sui loro CCD appositi cir-cuiti capaci di arginare gli effettidel blooming, rendendoli partico-larmente adatti per utilizzi televisi-vi e fotografici. Lo straripamento ècomunque riscontrabile ancoraoggi su molte minitelecamere,specialmente quelle a basso costoe quelle in bianco e nero utilizzateper la sorveglianza, per i citofoni,ecc.L’infrarosso è la radiazione lumino-sa che costituisce nello spettro unaparte di luce non visibile dai nostriocchi. Ad esempio, la maggiorparte dei telecomandi di casa, pre-senta alla propria estremità un’a-pertura che consente la trasmissio-ne di dati per mezzo di un apposi-to led che emette luce con questalunghezza d’onda. Abbiamo intro-dotto questa parte per anticipareun piccolo esperimento che consi-sterà nel puntare una telecameraproprio verso uno dei telecomandidi casa. Premendone un qualsiasitasto noteremo, attraverso il moni-tor o l’oculare della telecamera,che il led (o i led) posti all’estremi-tà dello stesso telecomando si
accenderanno diventando visibili.Questo fatto è dovuto alla capaci-tà del CCD di riconoscere anchefrequenze luminose che oltrepas-sano la soglia del visibile.E proprio per questo motivo,molte telecamere usate per il con-trollo a distanza o per altre appli-cazioni notturne sono spesso dota-te di “illuminatori”, cioè di alcuniled a luce infrarossa che illumina-no la parte inquadrata senza tutta-via renderla visibile all’occhioumano. La capacità di poter percepiretutte le radiazioni è, in questocaso, un vantaggio, ma solo se loscopo per cui si usa il CCD è quel-lo di rilevare immagini notturne.Infatti, l’infrarosso diventa fastidio-so in normali condizioni in quantoil suo “punto di fuoco” è diversoda quello della luce visibile.Sappiamo che ogni fonte emetteinfatti radiazioni luminose checoinvolgono sia lo spettro visibileche le radiazioni infrarosse; met-tendo a fuoco l’immagine visibile,si otterrà un alone sfocato di infra-rosso e, al contrario, mettendo afuoco l’infrarosso si otterrà unaimmagine visibile sfocata. Per que-sto motivo, alcune telecamere,web-cam e fotocamere digitali,utilizzano un filtro “taglia IR” cheblocca tale radiazione permetten-do alla sola luce visibile di giunge-re alla superficie del CCD.
HARDWARE 49
Figure
1 3
cariche accumulate da ogni pixel. Alcuni sensori CMOS sono attual-mente sfruttati da alcune recentiweb-cam e da diverse fotocameredigitali.Ma la vera novità del settore èrappresentata da un’idea del tuttonuova al mondo dei sensori elettroni-ci. Una piccola azienda ha infatti rivo-luzionato il mercato presentando, tralo stupore dei grandi produttori, unsensore denominato “X3” che funzio-na con lo stesso principio della nor-male pellicola fotografica chimica: ilnuovo sensore dispone infatti di 3diversi strati sovrapposti, ciascuno deiquali è “sensibile” ad uno dei colori dibase (Red, Green, Blue). La luce attra-versa tutto il “sandwich” e ciascunostrato ne rileva l’esatta intensità riferi-ta al proprio colore sensibile.Se ben ricordate, nella scorsa puntataabbiamo visto come la percezione alcolore viene normalmente simulatacon la sovrapposizione di filtri colora-ti sui diversi pixel “monocromatici” diun CCD. Con il nuovo “X3”, questo
ALTRE TIPOLOGIE DI SENSORI Oltre ai CCD, ormai ampiamentedescritti, esiste un’altra grande fami-glia di sensori la cui sigla e nota aquanti conoscono l’elettronica digita-le: CMOS (Complementary MetalOxide Semiconductor). A differenzadei CCD, questi dispositivi utilizzanouna tecnologia diversa, largamentediffusa per la realizzazione di quasitutti i componenti logici presenti neicircuiti integrati e nei microprocesso-ri. Tuttavia, nonostante la grande dif-fusione e il basso costo di produzioneormai raggiunto, i sensori CMOSsono divenuti solo recentementedelle valide alternative capaci di con-correre, per qualità e caratteristiche,con i più noti CCD. I CMOS presentano infatti un’archi-tettura più complessa in quanto ognisingolo pixel risulta completamenteseparato e autonomo dagli altri, tantoda richiedere un indipendente circui-to di amplificazione e di gestione del-l’informazione. Saranno quindi neces-
sari tanti piccoli circuiti indipendentiquanti saranno i pixel del sensore equesto, oltre a rappresentare un pro-blema di spazio rende necessaria unaaccuratissima precisione nella costru-zione.A causa delle tolleranze costruttive, èinfatti possibile che non tutti i circuitirisultino tarati o funzionanti nello stes-so identico modo e questo dà luogoa una certa difficoltà nel riuscire agarantire uniformità nella percezionee sensibilità di ogni pixel.In ogni caso, come per il CCD, esisto-no vantaggi e svantaggi che ognicostruttore riesce a dosare opportu-namente in funzione delle applicazio-ni per le quali deve essere utilizzato ilsensore. Tra i vari vantaggi, c’è la pos-sibilità di leggere i contenuti dei pixelsenza dover ricorrere ai tempi di scor-rimento dei “nastri trasportatori”(visti nella scorsa puntata), l’assenzadell’effetto “blooming” e la possibilitàdi leggere i dati in modo non distrut-tivo cioè senza dover rimuovere le
HARDWARE
1 - Il rivoluzionario sensore "X3"sviluppato dalla Foveon.
2 - La luce attraversa i 3 stratisensibili di ogni pixel...
3 - ...con un principio similea quello della tradizionalepellicola fotografica.
4/5 - la prima Reflex digitaleequipaggiata con il nuovo sensore.
2
4 5
HARDWARE50
procedimento, dispendioso in terminidi costruzione e di risoluzione, non èpiù necessario, in quanto la luceattraversa gli strati di un singolo pixele viene convertita direttamente indati senza necessità di interpretazio-ne. E si parla già di rivoluzione“Foveon”, dal nome dell’aziendaideatrice del nuovo sensore. Una notacasa produttrice di strumentazioneottica ha subito creduto in questo“X3” ed è già in commercio unapotente macchina fotografica digitale(reflex) che dalle prove sul camposembra sbaragliare la concorrenzaper qualità e accuratezza nella ripro-duzione dell’immagine. Il vantaggio èdato non tanto dalla risoluzione madalla capacità di cogliere dettagli eparticolari con una nitidezza netta-mente superiore agli altri sensori gra-zie all’assenza della classica matrice difiltri e alla rilevazione di dati già pron-ti che non devono essere interpolati.In altre parole, è molto probabile cheil Foveon X3 diventi il nuovo punto diriferimento per l’acquisizioni delleimmagini. E gli altri costruttori?Staremo a vedere…
ADATTIAMO UN CCD PERVEDERE… LONTANO! Come avevamo già anticipato, vedre-mo ora come è possibile utilizzareuna minitelecamera o una web-camin abbinamento a diversi dispositiviottici che ci consentiranno di compie-re divertenti e interessanti esperienze.Prima di iniziare è bene ricordareche una immagine reale può esserepercepita dal CCD solo se vieneconcentrata e messa a fuoco sullasua superficie per mezzo di unobiettivo. In funzione delle caratteri-stiche di questo dispositivo otticoesterno si potranno ottenere imma-gini con diverso ingrandimento,contrasto e luminosità.Per la nostra esperienza potremo uti-lizzare obiettivi fotografici, binocoli,microscopi o potenti telescopi permezzo dei quali sarà possibile acquisi-
re immagini fotografiche e filmati. Bisogna subito distinguere tra i varimetodi e le diverse possibilità di utiliz-zo: sia la web-cam che una minitele-camera possono essere infatti sfrutta-
te con o senza il loro piccolo obietti-vo originale. Decidendo di conservarel’obiettivo saremmo costretti a limi-tarne l’utilizzo ai soli strumenti otticidotati di oculare, cioè solo a quelliche forniscono già al nostro occhiouna normale e corretta visione. Un
binocolo o un microscopio andrannobenissimo.In questo caso useremo un metododetto “afocale” che non richiede par-ticolari accorgimenti tecnici o mecca-nici e che consisterà nell’avvicinare ilnostro sensore, così com’è, all’ocularedell’ottica aggiunta.
Per poter procedere correttamente ènecessario ruotare il piccolo obiettivodel CCD fino a raggiungere la posi-zione di fuoco all’infinito, cioè la posi-zione estrema (generalmente di finecorsa) con la quale è possibile mette-re a fuoco oggetti situati a grandidistanze.
Utilizzando, ad esempio, un binocolo,sarà opportuno sistemare lo stesso suun cavalletto e puntarlo verso unluogo di possibile interesse. Il binoco-lo ci fornirà un certo ingrandimento(in funzione delle caratteristiche dellostrumento) che potrà essere facilmen-te ricavato considerando la sigla
HARDWARE
Una piccola minicamera in biancoe nero utile ai nostri scopi
Figura 1
Svitando il supporto, si può rimuovel'obiettivo...
Figura 2
... e liberare il CCD.Figura 3
Il circuito viene fissato in uncontenitore plasticoFigura 4
Ecco come si presenta laminicamera nel suo contenitore
Figura 5
HARDWARE 51
impressa in prossimità di uno deisuoi oculari. Ad esempio la dicitura“7x50” ci indicherà che il binocolooffre 7 ingrandimenti e che disponedi obiettivi (le lenti frontali) da50mm di diametro. Allo stessomodo un “10x50” ci fornirà, a pari-tà di dimensione degli obiettivi, 10ingrandimenti.
Procederemo quindi avvicinando ilCCD ad uno degli oculari, cercandodi fissarlo per mezzo di un supporto,
magari con un ulteriore cavalletto ocon dei semplici stratagemmi autoco-struiti. Da questo momento in poi,
l’operazione di messa a fuoco dovràessere effettuata solamente sul bino-colo, fino a quando l’immagine pro-dotta dal CCD non risulterà chiara eben contrastata.Questa esperienza può essere con-dotta anche utilizzando classiche tele-camere di qualsiasi formato, ma con-
siderando che normalmente questedispongono già di obiettivi “zoom” èmolto facile che si possano raggiun-gere o superare gli stessi ingrandi-menti prodotti dal binocolo.
Gli aspetti più interessanti di questo
esperimento si ottengono svitandol’obiettivo del CCD e utilizzandonequindi la sua superficie libera conpotenti obiettivi o telescopi. In questo
caso utilizzeremo il metodo denomi-nato “fuoco diretto” che consente diutilizzare il sensore come un oculareelettronico per ottenere il massimoingrandimento utile fornito dall’o-biettivo aggiunto.
Prima di compiere qualsiasi interventosulla vostra minitelecamera o sullaweb-cam, ricordate che la loro apertu-ra o modifica comporta il decadimen-to della garanzia offerta dal relativocostruttore. Gli interventi non saranno tuttaviadistruttivi in quanto tutte le operazioniche illustreremo sono reversibili e per-metteranno, salvo casi particolari, dipoter riassemblare il vostro sensorenella sua configurazione originale. L’operazione di rimozione dell’obietti-vo avviene di norma svitando lo stessoda un supporto fissato sul circuito
HARDWARE
I contenitori per rullini diventano utiliinnesti per il telescopio Figura 6
Il tappo viene forato al centro efissato al contenitore
Figura 7
Il rullino viene incastrato al tappodiventando un robusto supporto Figura 8
La prova di inserimento delrullino al telescopio Figura 9
Il telescopio pronto con laminicamera inserita Figura 10
Particolare della manopola checonsente la messa a fuoco
Figura 11
Una classica web-cam, anch'essautilizzabile per il nostro esperimento Figura 12
HARDWARE52
stampato che ospita il CCD. In alcunisensori, l’obiettivo si svita tranquilla-mente senza dover aprire la scatolache lo contiene, mentre altri dispositivipotrebbero richiedere l’uso di un cac-ciavite o di uno sbloccaggio manualedei loro incastri.
Ricordate che la superficie libera delCCD è molto delicata; fate attenzionea non toccarla e rimuovete l’eventualepolvere che vi si deposita soffiandolavia; in ogni caso, non strofinate mainulla sopra.
Se il sensore utilizzato è una minitele-camera montata su circuito stampato,si dovrà provvedere al suo inserimentoin un contenitore che dovrà consentir-ne sia il collegamento elettrico che ilmontaggio alla parte ottica. Le particonnesse dovranno prevedere un con-nettore per l’uscita video da collegareal televisore e un connettore per l’ali-mentazione.Ogni diverso modello di minicamera
dispone di relative istruzioni per il suocollegamento che avviene con soli 3 o4 fili.
Utilizzando un telescopio come obiet-tivo, si potrà semplicemente inserire ilsensore all’interno del portaoculari uti-lizzando come supporto un contenito-re vuoto per pellicola fotografica. Laprima operazione da compiere è quel-la di trovare e provare il portarullinoper verificare che il proprio strumentoaccetti perfettamente questo cilindrodi plastica, inserito con il tappo versol’alto. Normalmente il portaoculari diun telescopio ha un diametro di31,8mm e la maggior parte dei porta-rullini entra e combacia senza proble-mi. Se il vostro telescopio dovesseavere un diametro diverso potrannoessere trovate tante altre soluzionisimili utilizzando contenitori cilindricisimili sui quali potranno essere applica-ti strati di nastro adesivo per ottenere ildiametro esterno necessario.
Il portarullini dovrà essere aperto nellaparte inferiore in modo tale da con-sentire il completo passaggio di lucementre il tappo dovrà essere ritagliatocon cura nella sola parte centrale permantenere l’anello esterno che neconsente l’incastro con il cilindro.La rimanente parte superiore deltappo potrà a questo punto essere
incollata o fissata sulla scatola del CCD,facendo attenzione a posizionare ilforo con la superficie sensibile precisa-mente al centro del portarullino.
Si otterrà in questo modo un efficacesistema di visione a fuoco diretto,pronto per l’inserimento al telescopioe capace di fornire immagini con unaltissimo ingrandimento.
Per calcolare l’ingrandimento risultan-te è necessario conoscere due impor-tanti parametri: la lunghezza focale delproprio telescopio/obiettivo e la lun-ghezza in millimetri del lato maggioredel CCD utilizzato.Ingrandimento1 = focale del telesco-pio (in mm): 50Ingrandimento al CCD = Ingran-dimento 1 x 35: lato maggiore CCD(in mm)
La prima formula (ingrandimento 1)fornisce gli ingrandimenti offerti daltelescopio applicando al suo fuocodiretto una normale macchina foto-grafica reflex (privata dell’obiettivo)con la classica pellicola 35x24mm.La seconda formula (Ingrandimento alCCD) rapporta la dimensione del CCDa quella della pellicola fotografica e ne
HARDWARE
La prima fase di smontaggioFigura 13
Il corpo che contiene il sensoresi apre ad incastro
Figura 14
Ecco il circuito che ospita il CCDFigura 15
L'obiettivo viene svitato dalla sua sedeFigura 16
Il circuito e il CCD sono ora liberi... Figura 17
Il sistema di adattamento descrittopuò essere facilmente utilizzato perdiversi modelli di minicamere e diweb-cam. Con un po’ di ingegno equalche momento di sperimentazioneriuscirete ad ottenere buone immaginidi oggetti posti a grandi distanza. Ricordate di non puntare MAI il vostroobiettivo/telescopio verso il Sole o sor-
ricava l’ingrandimento apparente cheverrà visualizzato sul televisore.Indicativamente, il CCD di una minite-lecamera collegato ad un telescopiocon una focale di 1000 mm fornisceun ingrandimento di circa 180x (la “x”si legge “per” e identifica il fattore dimoltiplicazione dell’immagine origina-le: in questo caso il soggetto inquadra-to viene ingrandito di 180 volte).
genti troppo luminose. Una eventualevisione ad occhio nudo e ingrandita diluci così intense provoca gravi dannialla vista (e anche il sensore CCDpotrebbe danneggiarsi irreparabil-mente).Per quanti volessero dedicarsi all’os-servazione del Sole, esistono in com-mercio appositi filtri che permettonodi poter osservare in tutta sicurezzaanche la nostra stella.
Tenete sempre presente questaimportante raccomandazione edivertitevi in sicurezza con gliingrandimenti del vostro nuovosguardo “elettronico”!
HARDWARE
Il risultato finale, sul quale potràessere applicato il porta rullino
o riavvitato l'obiettivo originale. Figura 19
Electronic shop 12... pronti per essere montati in
un nuovo contenitoreFigura 18
I volumi possono essere richiesti via lettera o fax a: DTP Studio Editrice S.r.l. - via Matteotti, 8 28043 Bellinzago (NO)
Tel. 0321/927287 - Fax 0321/927042 o via email: [email protected] - La spedizione viene effettuata da Sandit srl
esclusivamente in contrassegno (spese di spedizione € 2,5).
... per sapere di più
PICKBOOK - volume 2 G. GALLETTI
Naturale proseguimento del primo volume, questo libro completa la
panoramica sui PIC, utilizzando anche il PIC16F876, il PIC12C508 ed
il PIC12CE674 (due 4+4 pin dalle caratteristiche a dir poco sorpren-
denti). Il libro è concepito in modo leggermente diverso dal prece-
dente. La novità principale è che si parla d’esperimenti oltre che di
progetti e si usa il basic oltre l'assembler come linguaggio di pro-
grammazione. Anche qui, come nel primo volume, tutti gli esem-
pi sono accompagnati da una spiegazione, un diagramma di flus-
so, il listato basic o assembler e, novità nella novità, il circuito
stampato è sostituito da una basetta prototipo di tipo universale.
Trattandosi di circuiti prevalentemente in corrente continua non
si ha la necessità di schermare o rispettare certi canoni propri
della radiofrequenza, inoltre in questo modo si può utilizzare lo
stesso circuito stampato per più progetti! In questo libro sono
trattati anche due argomenti un po’ particolari, nella speranza
di fare cosa gradita a chi poi ne potrà usufruire.
cod. 22-1008-09 - €. 23,50
PICKBOOK - volume 1 G. GALLETTI
In questo libro sono descritti alcuni progetti con il microcontroller
PIC16F84. Ogni lavoro comprende una sommaria descrizione del funzio-
namento, uno schema elettrico, un diagramma di flusso, il listato
assembler e la traccia rame del circuito stampato in scala 1:1. Il lettore
che vuole cimentarsi nella costruzione trova tutte le informazioni per
farlo e può anche modificare il software provando poi sull’hardware i
risultati. Al volume è allegato un floppy contenente sia i programmi
sorgente , completi e perfettamente funzionanti, riportati nel testo, sia
i file oggetto pronti per essere inseriti nei PIC. Chi dispone di una
stampane che lavori in DOS, può stamparsi su carta trasparente le
tracce rame e incidere direttamente la basetta.
cod. 20-1002-25 - €. 18,00
Volumii
HARDWARE54
RABBIT BY EXAMPLERABBIT BY EXAMPLEdi Sergio Tanzilli
Proseguiamo questo mese con le nozioni di base del linguaggio C con particolare riguar-do alla versione Dynamic C utilizzata per la programmazione del firmware sui modulidella Rabbit Semiconductor
BREVE RIASSUNTO DELLELEZIONI PRECEDENTIPer chi avesse perso le precedentilezioni del corso Rabbit By Examplericordiamo che in questa serie diarticoli viene illustrato come svilup-pare hardware e firmware utilizzan-do i core modules RCM2200 pro-dotti dalla Rabbit Semiconductor.Questi moduli, delle dimensioni dimezza carta di credito, contengonotutta l'elettronica necessaria per rea-lizzare un completo sistema a micro-controllore compatibile con gli stan-dard di rete più diffusi su Internet eprogrammabili con un completoambiente di sviluppo per il linguag-gio C. Informazioni di dettagliosono accessibili sui seguenti sitiinternet www.areasx.com ewww.tanzilli.com.
DYNAMIC CIL CONTROLLO DI FLUSSONel numero scorso abbiamo illustratocome iniziare a scrivere un codice sor-gente in linguaggio C, come definireuna variabile e come visualizzarne ilvalore sulla consolle stdio. Questomese analizziamo i costrutti del lin-guaggio per effettuare il cosidettocontrollo di flusso di un programma. Illinguaggio C è un linguaggio di tipoprocedurale, ovvero composto da una
serie di istruzioni eseguite in sequenzadal microprocessore al fine di effettua-re, appunto, una procedura. In molticasi, durante il regolare flusso del pro-gramma, è necessario poter sceglieretra diverse possibili opzioni all'internodella procedura o ripetere, per undeterminato numero di volte, la stessaserie di istruzioni ciclicamente. Perrisolvere questo problema il program-matore ha a disposizione una serie dicostrutti in grado di deviare il norma-le flusso sequenziale del microproces-sore, vediamo quali sono.
L'ISTRUZIONE IFL'istruzione if è la più classica delleistruzioni condizionali ed esiste prati-camente per qualsiasi linguaggio diprogrammazione. Il suo formato piùsemplice è il seguente:
if (espressione)
.. istruzioni da eseguire se
l'espressione è vera
In pratica se il risultato dell'espressio-ne all'interno delle parentesi è veroviene eseguito il blocco di istruzionitra parentesi graffe. In caso contrariose il risultato dell'espressione è falso ilblocco tra le parentesi non viene ese-guito. La distinzione tra un valorevero e falso viene effettuata in C nellaseguente maniera:- E' vero un valore diverso da zero- E' falso un valore pari a zero
Modulo Rabbit RCM2200Figura 1
Dynamic C l'ambiente di sviluppo
ufficiale della Rabbit Semiconductor Figura 2
HARDWARE
HARDWARE 55
dere un controllo per uno specificovalore di a. Ad esempio:
main()
int a;
a=54;
if (a==54)
printf("Vero\n");
else
printf("Falso\n");
In questo caso abbiamo usato l'o-peratore == (doppio uguale) chegenera appunto un valore vero ofalso dopo aver comparato duevalori. Da notare come sia diversol'uso dell'operatore di comparazio-ne == da quello di assegnazione =(singolo uguale). = assegna alla variabile sulla sini-stra il valore sulla destra== compara il valore di sinistra conquello di destra ma non effettuaalcuna assegnazione. La compara-zione può essere effettuata natural-mente anche tra due variabili. Adesempio:
main()
int a;
int b;
a=54;
b=53;
if (a==b)
printf("Vero\n");
else
printf("Falso\n");
Con questo esempio viene visualiz-zato il messaggio "Falso" in quanto aè diverso da b. E' possibile effettuarepiù controlli in cascata per aumen-tare il numero di derivazioni del pro-gramma. Ad esempio:
main()
int a;
int b;
a=54;
b=54;
if (a==b)
printf("A uguale a B\n");
else if (a>b)
printf("A maggiore di B\n");
else if (a<b)
printf("A minore di B\n");
Esiste anche la possibilità di effet-tuare dei salti in punti diversi delprogramma tramite l'istruzionegoto. Questo metodo è assoluta-mente sconsigliato in quantopotrebbe rendere un programmacomplesso assolutamente illeggibi-le, ma spesso può rappresentareuna valida soluzione per accellera-re i tempi di sviluppo di un pro-gramma. Vediamo come modifica-re l'esempio precedente usando l'i-struzione goto:
main()
int a;
int b;
a=54;
b=54;
if (a==b) goto Uguale;
if (a>b) goto Maggiore;
if (a<b) goto Minore;
Uguale:
printf("A uguale a B\n");
exit(0);
Maggiore:
printf("A maggiore di B\n");
exit(1);
Minore:
printf("A minore di B\n");
exit(2);
Vediamo un esempio pratico:
main()
int a;
a=1;
if (a)
printf("Vero\n");
if (!a)
printf("Falso\n");
Se eseguiamo il codice così come loabbiamo scritto otterremo sulla con-solle il messaggio "Vero" in quanto avale 1 che viene considerato comeun valore vero. Se assegniamo allavariabile a uno dei seguenti valori -1, 10, -500, ecc. otterremo sempreil messaggio "Vero". Assegnandoinvece ad a il valore 0 otterremo ilmessaggio "Falso". L'operatore !(punto esclamativo) è infatti unoperatore che nega il risultato dell'e-spressione alla sua destra per cui sea è falso !a è vero ed il codice tra laseconda coppia di parantesi graffeviene eseguito. Un modo molto piùelegante di scrivere lo stesso pro-gramma è il seguente:
main()
int a;
a=1;
if (a)
printf("Vero\n");
else
printf("Falso\n");
Ovvero "se" a è vero, esegui il primoblocco di istruzioni, "altrimenti" ese-gui il secondo blocco. Ovviamentel'espressione tra parentesi tonde puòessere anche più complessa e preve-
HARDWARE
HARDWARE56
In questo esempio ci sono una seriedi novità da comprendere. Anzituttoil formato della funzione goto. Lagoto consente di far saltare il pro-gramma in un punto diverso delsorgente. Il punto in cui andare èidentificato da una label (etichetta)costituita da un nome seguito dadue punti (:). Nell'esempio le labelsono Uguale:, Maggiore: e Minore:e vanno specificate (senza i duepunti) di seguito all'istruzione goto.In ognuna delle if utilizzate non èstata inserita la coppia di parentesigraffe. Questo perché l'istruzione daeseguire all'interno della if è unasola. Nel caso di debbano eseguirepiù istruzioni è obbligatorio inserirele parentesi graffe. La funzioneexit(0) consente di uscire immedia-tamente dal programma e ridare ilcontrollo al Dynamic C. Il numerotra parentesi è un codice di erroreche possiamo passare al Dynamic Cper indicare una eventuale condizio-ne d'errore. Il valore verrà visualizzatocon una message box come riportatoin figura 3.
L'ISTRUZIONE SWITCHL'istruzione switch consente sempredi selezionare porzioni di codice daeseguire in base al valore che assumeuna espressione in una forma legger-mente diversa. Vediamo un esempio:
main()
int a;
a=54;
switch(a)
case 0:
printf("A uguale a zero\n");
break;
case 1:
printf("A uguale a uno\n");
break;
case 2:
printf("A uguale a due\n");
break;
default:
printf("Altro valore\n");
break;
La switch valuta il valore dell'espres-sione tra parantesi tonde (in questocaso il valore della variabile a) e loconfronta con diverse costanti nume-riche tramite l'istruzione case.Quando trova una costante numericauguale al risultato dell'espressioneesegue il codice che segue la case.L'istruzione break serve ad uscire dallaswitch ed evitare che venga eseguitoil codice al di sotto delle case succes-sive. L'istruzione default è opzionale eil codice specificato dopo di essaviene eseguito solo se l'espressionenon è uguale a nessuno dei valori spe-cificati.
CONCLUSIONIPer questo mese ci fermiamo qui.Per chi avesse fretta di proseguireo volesse approfondire gli argo-menti accennati in queste pagine,consigliamo la lettura dello UserManual del Dynamic C disponibilein formato PDF e HTML (in inglese)all'interno del CD in dotazione alkit di sviluppo Rabbit o sul sitowww.rabbitsemiconductor.com.Ricordiamo che nel corso RabbitBy Example presentato in questepagine si fa riferimento al seguen-te materiale acquistabile diretta-mente dai sito http://www.tanzil-
li.com o http://www.areasx.com: • Un RCM2200 development Kit• Una scheda SX01• Un alimentatore a parete
Sul sito www.tanzilli.com è possibileinoltre accedere ad altro materialeinformativo, esempi di utilizzo, edaltro sui moduli Rabbit.
BMG2001UN HARDWARE PROFESSIONALEPER REALIZZARE LE PROPRIEAPPLICAZIONI DI CONTROLLOPer chi desidera realizzare una pro-pria applicazioni di controllo basatasu microprocessore Rabbit senzadover affrontare i costi di produzio-ne di un sistema hardware comple-to, è disponibile, da questo mesesul sito www.areasx.com il disposi-tivo BMG2001. Si tratta di un dis-positivo professionale già montatoe collaudato dotato delle seguenticaratteristiche tecniche:
• Contenitore a 9 moduli per barraDIN
• Core module Rabbit RCM2300 • Tastiera a membrana a quattro
tasti sul pannello frontale• Display LCD 16x2 retroilluminato• 8 uscite a relé• 4 uscite a collettore aperto• 9 ingressi con filtro LC• 1 RS485 half duplex
Il BMG2001 viene fornito comple-to di tutta la componentistica masenza alcun firmware di gestione.Al suo interno è montato unmodulo Rabbit RCM2300 (simileall'RCM2200 ma senza connessio-ne Ethernet) che può essere pro-grammato in C con il kit di svilup-po utilizzato in questa serie di arti-coli.
HARDWARE
Codice di erroreFigura 3
Electronic shop 14
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2002-2003
Abbonarsi a Fare Elettronica significa ricevere comodamente ogni mese
a casa tua, tante idee e consigli per rendere il tuo hobby una vera
passione. Perché Fare Elettronica
si diverte solo quando ti
diverti tu.
Abbonandoti potrai
ricevere la rivista
ad un prezzo molto
interessante, con uno
sconto del 30% rispetto
a quello di copertina.
Pagherai infatti solo
€ 33,00 invece di € 47,50 con un
risparmio di ben € 14,50, oltre a rice-
vere in omaggio il CD-ROM n° 3 di
Fare Elettronica. In più il prezzo
bloccato per un anno intero e una
segreteria abbonamenti sempre a
disposizione.
1 ANNO - 11 NUMERI
SCONTO 30%
invece che € 47,50 a soli
€ 33)(
Abbonarsi a Fare Elettronica conviene.Abbonarsi subito conviene ancora di più.
Inoltre (esibendo il codice abbonamento) avrete il
10%di sconto sui libri della nostra collana
Perchè? Oltre al prezzo di copertina scontato del 30%, riceverai
il CD N° 3 di Fare Elettronica e potrai partecipare
all’estrazione di 20 abbonamenti omaggio.
Infine, fino ad esaurimento scorte, potrai
ricevere anche il kit per realizzare
il Vu Meter più piccolo del mondo!
All’interno del CD:
la versione completa (schemi elettrici e sbrogliodei circuiti stampati) del potente CAD elettronico.
• PIC BY EXAMPLE: la versione completa del famoso corso sui PICmicro.• SOFTWARE: i migliori programmi dedicati all’elettronica.• DATA-SHEET: i data-sheet aggiornati dei circuiti integrati più importanti.• CIRCUITI STAMPATI: le ultime due annate dei circuiti stampati di Fare Elettronica.• UTILITIES: i programmi più utili per il vostro hobby.
()IN REGALO
ELETTRONICA GENERALE60
TERMOMETRO A QUATTROCIFRE DA –55 A +125 °CTERMOMETRO A QUATTROCIFRE DA –55 A +125 °Cdi Giulio [email protected]
Un preciso ed utile termometro con visualizzazione a display luminosi rossi a 4 cifre,in grado di misurare una o più temperature in un range che va da –55,0 a + 125,0°C con definizione di 0,5°C su tutta la scala ed una precisione di +/- 0,5°C da –10 a +85°C. Racchiuso in un piccolo contenitore in ABS con mascherina e filtro rosso,adatto ad essere sistemato sul cruscotto di un’auto,su un mobile o all’interno di una scatola elettrica a muro. L’alimentazione può variare tra 8 e 14 volt tensionecontinua (tipica 12 V) e l’assorbimento è inferiore ai 50 mA.
Recentemente vi abbiamo presen-tato un particolare termometroelettronico, l’MK3955, che ripro-duceva il classico termometro acolonna di mercurio medianteuna barra di led rossi.Questo nuovo modello MK3960,parente stretto dell’MK3955 perquanto riguarda l’elettronica, èinvece del tipo “moderno” condisplay a cifre luminose.L’MK3960 va a sostituire i duevecchi modelli GPE MK120 edMK120 S3, presentati quasi 15anni fa e fino al 2002 spesso intesta ai kit preferiti dai lettori perunicità del contenitore, affidabili-tà e precisione. Ovviamente, dopo tanto tempo, ilmodello MK3960 presenta carat-teristiche attuali e componenti alpasso coi tempi oltre prestazioninettamente superiori. Un solo cir-cuito integrato, un microproces-sore PIC16C63, realizza tutte lefunzioni necessarie allo strumen-to, il range di lettura è passato dai
–9/+99 °C degli MK120 ai–55,0/+125,0 °C dell’MK3960, lasonda è del tipo digitale e non ènecessario alcun tipo di taratura.Unico elemento mantenuto iden-tico è il contenitore GPE023(Figura 1), sia per la comoditàd’uso, per le piccole dimensioniche per l’esclusività del modello
non reperibile normalmente incommercio essendo di produzio-ne GPEkit. Visto e considerato che un termo-metro tutti sappiamo come si usae a che cosa serve, passeremosenza indugi alla descrizione delsuo circuito elettronico che pos-siamo vedere in Figura 1.
ELETTRONICA GENERALE
ELETTRONICA GENERALE 61
ELETTRONICA GENERALE
CIRCUITO ELETTRICO MK3960Come ben si può vedere lo schemaè estremamente semplice. Il circui-to integrato U1, riceve dalla sondadi temperatura DS18S20 le infor-mazioni sulla temperatura misuratain formato seriale. U1, dopo averleinterpretate, le converte in unagrandezza decimale che possiamoleggere direttamente sui 4 displayDG1, 2, 3, 4 e che rappresenta ilvalore della temperatura in gradicentigradi. Quando la temperatura
è negativa,cioè sotto lo zero termi-co, il primo display accende ilsegno meno e la lettura potrà arri-vare ad un minimo di –55,0 (°C),quando è sopra lo zero termico lamassima temperatura visualizzatasarà 125,0 (°C). Come vedremo inseguito, le temperature che potre-mo tenere sotto controllo sonoteoreticamente infinite, basteràinfatti aggiungere una sondaDS18S20 al connettore J2 per ognitemperatura che vogliamo rilevaree,commutandole con un normalecommutatore a levetta o rotativo,selezioneremo la sonda e quindi latemperatura che ci interessa sape-re. Il kit MK3960 viene fornito conuna sola sonda DS18S20. Il circui-to di alimentazione, anche se sem-plice,è particolarmente curato.Noterete infatti, oltre alla presenzadel regolatore stabilizzato U2 erelativi condensatori di filtro C4 eC5, i componenti D1, DZ1 e VDR1.Questi sono stati messi per rendereperfettamente “sicuro” il funziona-mento del termometro anchemontato su auto, moto o barche amotore, i cui circuiti elettrici sononotoriamente “sporchi”cioè spessogenerano alte extratensioni e pic-chi di tensioni con polarità inversarispetto al normale che facilmentedanneggerebbero la circuiteriadello strumento. I 4 transistor T1,2, 3 e 4, servono a comandarel’accensione dei display in manieramultiplexata, così da ottenere unnotevole risparmio in termini dicorrente assorbita dal circuito.
REALIZZAZIONE PRATICAIn Figura 2 vediamo il circuitostampato della basetta visto dallato rame, mentre in Figura 3 tro-vate i particolari di assemblaggiodella basetta dell’MK3960 cheospita tutti i componenti elettroni-ci del termometro ad eccezione dei4 display DG1, 2, 3, 4 che sonomontati in un’altra basetta apposi-
ELETTRONICA GENERALE 63
tamente realizzata il cui montag-gio è riportato in Figura 3. Primadi iniziare il montaggio, le soliteimportanti raccomandazioni.Utilizzate un saldatore di bassapotenza (Max 30 Watt) con puntasottile e stagno di piccolo diame-tro (ideale 0,7 mm, Max 1 mm)con anima interna disossidante.Non utilizzate per alcun motivopasta salda! Le saldature, essendo idue circuiti stampati del tipo adoppia faccia con fori metallizzati,andranno effettuate solamente daun lato, quello da dove fuoriesco-no i piedini dei vari componentiovviamente montati dal lato oppo-sto. Ponete la massima attenzioneal giusto verso di montaggio deicomponenti polarizzati: D1, DZ1,C4, C5, U2, U1, T1, T2, T3, T4,DG1, DG2, DG3 e DG4. Tutti glialtri componenti sono non polariz-zati, quindi potrete montarli indif-ferentemente in un verso o nell’al-tro. Terminato il montaggio deicomponenti e controllato moltoaccuratamente saldature (devonoessere lucide e prive di grumosità)e giusto posizionamento di ognicomponente, potremo passare alcollegamento meccanico delle duebasette (componenti + display)che possiamo vedere in Figura 4.Prima di sistemare il termometro
nel proprio contenitore GPE023,sarà opportuno collaudarlo. Nellevarie figure e foto (11, 12, 13)vediamo come cablare la sonda edeventualmente isolarla con tubettitermorestringenti o un sottile stra-to di collante siliconico. Ricordateche il piedino centrale della sondaè quello che porta il segnale allabasetta componenti (B di J2) men-tre i due laterali sono collegatiinsieme e portati indifferentemen-te ad A o C di J2. Il cavetto di col-legamento tra sonda e J2 nondovrà essere più lungo di 12 metrie dovrà essere, per eliminare i dis-turbi esterni elettrici eventuali,intrecciato. Potrete utilizzare duenormali fili elettrici isolati monopo-lari di piccolo diametro (1 mm puòandare benissimo) intrecciandolitra di loro aiutandosi magari conun trapano sul cui mandrino sarà
inserito un chiodo piegato ad U efissando i terminali dei due cavettidalla parte opposta a una morsa oad un punto ben fermo, oppureacquistando del normalissimo dop-pino telefonico (quello rosso ebianco utilizzato per tutti gliimpianti telefonici) che viene giàvenduto intrecciato. Collegataanche la sonda passeremo al col-laudo finale. Dovremo alimentare ilcircuito con una tensione conti-nua,anche non stabilizzata,con unvalore compreso tra 8 e 14 volt eduna disponibilità di corrente di 100o più mA. Non è richiesta alcunataratura, una volta data alimenta-zione, dopo brevissimo tempo iltermometro dovrà cominciare afunzionare, mostrandoci il valoredella temperatura in °C sul dis-play,questo a patto di non avercommesso errori di montaggio o
ELETTRONICA GENERALE
Circuito stampato della basetta vista dal lato rame in scala naturale
Figura 2
Disposizione dei componenti sulla basetta Figura 3
ELETTRONICA GENERALE64
che si vuole: interna, esterna, diliquidi, solidi e quant’altro (nel kitè compresa una sola sondaDS18S20).
Come già detto in apertura, ilrange di misurazione della tem-peratura va da –55 a +125°C conpassi di 0,5 °C e la precisionerisulta eccellente (max +/- 0,5 °C)nel range da –10 a + 85 °C. Per il montaggio del contenitoreGPE023 basterà un minimo di
ELETTRONICA GENERALE
• R1÷R8: resistori da 1 kΩ
• R9: resistore da 10 kΩ
• R10÷R17: resistori da 220 Ω• R18: resistore da 4,7 kΩ
• D1: diodo 1N4007• DZ1: diodo zener 18 Volt• C1-2: condensatore ceramico 22 pF • C3: condensatore poliestere 100 nF• C4: condensatore elettrolitico 220 µF• C5: condensatore elettrolitico 47 µF• Q1: quarzo 4,000 MHz• T1÷T4: transistor BC557• U1: PIC16C63 programmato per MK3960• U2: stabilizzatore a 5 volt 7805• DG1÷DG4: display rosso a catodo
comune SC39• J1: strip contatti a 90° a 12 poli• J2: strip contatti dritti a 3 poli• VDR1: variatore 25 volt• N° 2: ancoranti• N° 1: sonda digitale di temperatura DS18S20• N° 1: circuito stampato MK3960/CS• N° 1: circuito stampato MK4 display• N° 1: contenitore in ABS mod.GPE023• N° 1: filtro rosso
LISTA COMPONENTICollegamento meccanico del contenitore e del display.Figura 4
collegamenti. Nella Figura 5 vienemostrato come collegare piùsonde alla basetta MK3060 pervisualizzare tutte le temperature
nella figura) e relativo alimentato-re direttamente collegato alla rete220 volt.Come alimentatore potrete utiliz-zarne uno già in vostro possesso,oppure il modello MK175/A12con relativo trasformatore MKT12.
ELETTRONICA GENERALE 65
colla per modelli plastici o anchesolamente un po’ di diluente allanitro o acetone dato con un pen-nellino nelle parti da unire(mascherina, fondo e posteriore).Il coperchio non dovrà essereincollato per permettere eventualiispezioni. Grazie alle particolari protezioniutilizzate nella parte di alimenta-zione, potrete tranquillamentecollegare il termometro anchedirettamente ai circuiti elettrici di
auto, moto barche ecc., purchè a12 volt tensione continua. Nella Figura 7, mostriamo comesi possa utilizzare l’MK3960 incasa, ufficio o altri luoghi. In pra-tica utilizzando una scatola porta-frutti con relativa mascherinacieca e distanziale e sfruttando lospazio di incasso di una qualun-que scatola a muro per impiantielettrici, potremo sistemare il ter-mometro all’interno con un com-mutatore per varie sonde (tre
ELETTRONICA GENERALE
Collegamento delle sonde alla basetta.
Metodo di utilizzo del termometro a seconda delle esigenze.
Figura 5
Figura 7
Metodo di isolamento per evitare problemi di cortocircuito. Figura 6
Electronic shop 15
Il cannone ad elettroni disegna lo schermoFigura 1
HARDWARE66
GENERARE SEGNALI VIDEOIN REAL-TIME UTILIZZANDOUN PIC16F84
GENERARE SEGNALI VIDEOIN REAL-TIME UTILIZZANDOUN PIC16F84 di Rickard Gunée
Durante le vacanze di Natale 1997/98, iniziai un piccolo progetto: “Tentare lagenerazione di segnale video utilizzando un PIC16F84”. Avevo visto alcuni genera-tori video in software e, convinto che fosse un’idea originale, cercai di andare oltre.Non sapevo molto circa questo argomento, ma durante la primavera successiva hoimparato di più e sono quindi riuscito a realizzare il gioco PONG (in uscita nelnumero di Marzo 2003), utilizzando un microprocessore PIC16F84 dellaMicrochip. Mi sono così divertito che in seguito ho creato anche TETRIS (in uscitanel numero di Marzo 2003). Molte persone che hanno realizzato i due giochi mihanno scritto per farmi i complimenti e chiedere alcuni dettagli tecnici, ma iparticolare molti mi hanno chiesto dettagli riguardo il segnale video e su come
questi due giochi potessero generarlo in real-time e in software (senza l’aggiuntadi hardware esterno). Spero che questo tutorial vi aiuti a capire i segnali video ecome i giochi da me realizzati funzionano.
INFORMAZIONI SUI SEGNALIVIDEOPer comprendere come funzionala generazione dei segnali video inreal-time, è necessario conoscerein dettaglio come funzionano isegnali video. Pertanto, prima dianalizzare qualsiasi codice parle-remo di questo argomento.
Come funziona un apparato TVstandardUn apparato TV standard utilizzaun tubo a vuoto (cinescopio)dotato di uno schermo a fosforisul quale “spara” un cannone adelettroni. Quando gli elettroni
“sparati” dal cannone elettronicoreggiungono lo schermo, il fosfo-ro colpito emette una luce pertutto il tempo d’emissione deglielettroni (e anche per un brevetempo successivo). Il raggio elet-tronico emesso dal cannone puòessere curvato utilizzando deimagneti così da direzionarlo suparti differenti dello schermo. Selo si direziona in modo da dise-gnare, ripetutamente delle lineeorizzontali (per tutta la larghezzadello schermo), mentre se ne con-trolla l’intensità, è possibile dise-gnare un’immagine sullo scher-mo.
HARDWARE
segna-le visualizzato è nero.
Unire le linee di scansione inun’immagine.Un’immagine è formata da 625 lineedi scansione che però non appaionotutte sul televisore. Alcune di essesono utilizzate come impulsi di sincro-nizzazione ed altre sono invisibili, nonso esattamente di quanti impulsi sitratta, ma i primi televisori richiedeva-no un certo tempo per spostare il rag-gio degli elettroni dal basso delloschermo (oggi queste linee invisibili
sono utilizzate per altri scopi, comeper esempio il televideo).
Gli impulsi di sincronizzazioneverticali.Per trasmettere al televisore l’arrivo diuna nuova immagine si invia uno spe-ciale pattern di sincronizzazione.Considerando che l’immagine ècostruita da due semi-immagini, neconsegue che il pattern è diverso perimmagini pari e dispari. L’impulso di
HARDWARE 67
elettroni sulla linea successiva(simile al tasto <Invio> nella video-scrittura). Per riconoscere l’arrivo diuna nuova immagine, il televisorericeve un apposito pattern di sincro-nizzazione (simile alla funzione“nuovo documento”).L’immagine, aggiornata 25 volte persecondo, potrebbe generare del tre-molio, quindi per risolvere questoproblema, il raggio disegna prima lelinee pari e successivamente quelledispari, in modo da ottenere 50semi-immagini per secondo.L’informazione sulla presenza dilinee pari o dispari all’interno diun’immagine è inviata con patterndi sincronizzazione differenti perentrambe. La gamma di tensionedel segnale video varia da 0 a 1V,dove 0.3V rappresenta il nero e 1.0Vil bianco (i livelli di grigio si trovanotra questi due valori limite). I livelliprossimi allo zero, invece, sono con-siderati impulsi di sincronizzazione.
La linea di scansioneUn’immagine è divisa in linee di scan-sione che rappresentano anche la suaparte più importante perché conten-gono i dati dell’immagine stessa. Tuttele linee di scansione hanno una lun-ghezza di 64µs. Prima è inviato unimpulso di sincronizzazione da 4µs,impostando il livello del segnale a 0V,per avvisare il televisore dell’arrivo diuna nuova linea (i primi televisoririchiedevano, invece, un impulso di8µs per posizionare il raggio degli elet-troni). Durante questo tempo il
I diversi standards TVEsistono tre principali standard TV:• NTSC (abbreviazione per
“National Television SystemCommitte) è lo standard TVAmericano che utilizza solo 525linee con ha una frequenza diaggiornamento dello schermo di30Hz.
• SECAM (abbreviazione per“SEquential Color And Memory”)è lo standard TV francese, ha unamaggiore stabilità dei colori,un’intensità dell’immagine miglio-re, ma la risoluzione dei colori èpiù bassa.
• PAL (abbreviazione per “PhaseAlternatine Lines”) è lo standardEuropeo, utilizza 625 linee perframe e 25 frames per secondo.Questo standard è derivatodall’NTSC, ma la codifica dei colo-ri è stata migliorata. In questotutorial mi focalizzerò sullo stan-dard PAL.
Le informazioni nel segnale videoL’immagine che vediamo sulloschermo del televisore ha diverseintensità, quando il raggio di elet-troni percorre lo schermo, l’inten-sità nel punto colpito è inviatacome livello di tensione integratonel segnale video. Questa informa-zione sull’intensità non indica peròla posizione del raggio sullo scher-mo, pertanto viene inviato unimpulso di sincronizzazione all’ini-zio d’ogni linea, per indicare altelevisore di spostare il raggio di
HARDWARE
Le due parti dell’immagine diventano una. Figura 2
Immagine sull’oscilloscopio diuna linea di scansione.
Figura 3
Immagine sull’oscilloscopio di diverselinee di scansione in un segnale video.
Figura 4
Questa imagine mostra I differenti impulsi di scansione verticale per le due parti dell’immagine.I livelli sono, naturalmente, 0V e 3V.
Figura 5
HARDWARE68
sincronizzazione verticale si presentacome segue:LA CREAZIONE DI SEGNALIVIDEO IN SOFTWARE.La parte seguente descrive la crea-zione del segnale video in softwa-re, pertanto è necessario aver-compreso i concetti base delsegnale video, come descritto inprecedenza.Gli esempi di codice che seguonoutilizzano le seguenti macro:• DNOP - Questa macro inserisce
un ritardo da due cicli di clock. • DELAY – Questa macro inserisce
un ritardo, in cicli di clock, equi-valente a 3 volte il valorememorizzato nel registro W.
L’hardwareAl fine di generare un segnale video dilivello compreso tra 0 e 1V, occorronoalcune resistenze esterne (un immagi-ne richiede almeno 3 livelli). Il televiso-re necessita sia del livello di sincroni-smo che del nero per poter aggancia-re il segnale video. Nel caso volessimoottenere di più di un immagine nera,abbiamo bisogno anche di qualchelivello di grigio e del bianco. In questocaso è necessaria la creazione di unconvertitore digitale-analogo conalmeno 2 bit, per ottenere un numerosufficiente di livelli. L’impedenza del-l’ingresso video-composito di un tele-visore standard è di 75Ω e utilizzandodue resistenze, grazie alla divisionedella tensione, possiamo creare unsemplice convertitore digitale-analogi-co da 2-bit (vedi immagini a fianco).
Con questo semplice circuito è possi-bile creare quattro livelli di segnale dif-ferenti (le immagini a fianco mostranoi circuiti equivalenti per i diversi livelli).I valori delle resistenza non sono critici,potremmo usare i valori standard da470Ω e 1KΩ invece di 450Ω e 900Ω,garantendone comunque il funziona-mento (ci sarà soltanto una lieve diffe-renza di intensità).A questo punto siamo in grado di crea-
HARDWARE
Portando D0 e D1 a 0, la tensione all’ingresso del TV sarà 0V (livello di sincronismo).Figura 6
Portando D0 a 5V e D1 a 0, la tensione all’ingresso del TV sarà 0,33V, questocorrisponde ad un “quasi nero” (0,3V è il livello reale del nero).Figura 7
Portando D0 a 0 e D1 a 5V, la tensione all’ingresso del TV sarà 0,67V (grigio).Figura 8
Portando D0 e D1 a 5V, la tensione all’ingresso del TV sarà 1V (bianco).Figura 9
re i livelli per il sincronismo, nero, gri-gio e bianco, i quali sono sufficienti perimmagini semplici come quelle utiliz-zate per i gioci Pong e Tetris (presenta-ti sul prossimo numero). È possibilecreare altri livelli utilizzando un conver-titore DA più complesso. Se invecevolessimo aumentare la risoluzione,dovremmo utilizzare un vero converti-tore DA al posto di quello basato sulleresistenze che ho utilizzato, ma ènecessario un processore più veloce.
I segnali video generati dalSoftware verso quelli generatidall’HardwareNel caso di un sistema video standard,come la scheda grafica del PC, l’infor-mazione da scrivere sullo schermo èprelevata dalla memoria, questo vienegestito automaticamente dall’hardwa-re, il quale si occupa di creare anche gliimpulsi di sincronizzazione. Compitodel Software è soltanto quello di tra-smettere all’hardware, attraverso lamemoria, l’immagine da visualizzaresullo schermo. Il problema è che nonsolo questo richiede molto hardwarema anche molta memoria. La schedagrafica del PC dispone solitamente didiversi megabyte di memoria grafica,mentre un PIC16F84 è dotato soltantodi 68 byte di memoria, i quali devonoessere utilizzati anche per altri scopi.Non è possibile salvare l’intera imma-gine in memoria, cosi come avviene inuna scheda grafica, l’immagine deveessere generata in real-timementre ilsegnale video scorre lo schermo.Generare dei segnali video in softwarecon un processore talmente sempliceè piuttosto difficile ed è quindi possibi-le creare soltanto delle immaginimolto semplici.
Creare una linea verticaleAll’inizio della mia sperimentazioneper generare segnale video dal soft-ware ho cercato di produrre dellebarre verticali sullo schermo, crean-do una linea di scansione contenen-te le informazioni dei colori grigio-
nero-bianco-nero-grigio.Ripetendola senza fine, sono riuscitoad inviare la mia prima immagine altelevisore. Il segnale conteneva l’im-pulso di sincronismo orizzontale,seguito da un ritardo e di seguitodall’informazione del colore, inmodo che il televisore potesseagganciare il segnale orizzontal-mente (non verticalmente perchénon vi era alcun impulso di sincroni-
smo verticale). L’immagine ottenutasullo schermo è la seguente:Come abbiamo visto nel codice pre-cedente, il numero totale dei cicli diclock è 192 per ogni loop, renden-do la linea di scansione lunga 64µs.La temporizzazione è molto impor-tante, il segreto sta nel contare esat-tamente i cicli di clock necessari.
Il problema della bassa risoluzioneUn PIC16F84 a 12MHz può eseguire3 milioni d’istruzioni al secondo, quin-di durante i 64µs della parte “invisibi-le” di una linea di scansione è in gradodi eseguire 192 istruzioni, mentredurante i 52µs della parte “visibile”può eseguire 156 istruzioni. Se il valo-re del convertitore DA viene impostatoper ogni istruzione durante la linea da52µs, potremmo ottenere una risolu-zione di 156 pixel orizzontali, il cherisulta piuttosto scarso. Peggio ancora,non tutti i 156 pixel possono essereutilizzati a piacimento perchè non èpossibile calcolarne il valore in un ciclodi clock, a meno che non sia sempre lo
HARDWARE
HARDWARE 69
main:movlw COLOR_SYNC ;get sync level (1)
;**** 4us sync ****movwf VIDEO_PORT ;set port value (1)movlw 3 ;setup delay time (1)DELAY ;delay for 3us (9)
;**** 8us delay ****movlw COLOR_BLACK ;get black level (1)movwf VIDEO_PORT ;set port value (1)movlw 7 ;setup delay time (1)DELAY ;delay for 7us (21)
;*** 52us image data ***movlw COLOR_GRAY ;get gray color (1)movwf VIDEO_PORT ;set port value (1)movlw 3 ;setup delay time (1)DELAY ;delay for 3us (9)movlw COLOR_BLACK ;get black color (1)movwf VIDEO_PORT ;set port value (1)movlw 19 ;setup delay time (1)DELAY ;delay for 19us (57)movlw COLOR_WHITE ;get white color (1)movwf VIDEO_PORT ;set port value (1)movlw 3 ;setup delay time (1)DELAY ;delay for 3us (9)Movlw COLOR_BLACK ;get black color (1)movwf VIDEO_PORT ;set port value (1)movlw 19 ;setup delay time (1)DELAY ;delay for 19us (57)movlw COLOR_GRAY ;get gray color (1)movwf VIDEO_PORT ;set port value (1)movlw 2 ;setup delay time (1)DELAY ;delay for 2us (6)DNOP ;delay for two clocksgoto main ;once again (2)
Il segnale video generato dal codice seguen-
te è visualizzato così dall’oscilloscopioFigura 10
stesso e pertanto può essere generatoda un istruzione “set bit”.Ottenere una risoluzione maggioreNel caso in cui volessimo visualizza-re 8 pixel in bianco e nero salvati in
un byte in memoria, potremmo uti-lizzare il codice seguente: Questo esempio utilizza 8 cicli diclock per bit. A questa velocità pos-siamo ottenere soltanto 19 pixel dirisoluzione orizzontale, il che non èproprio il massimo, ma c’è una solu-zione interessante a questo proble-ma. Si tratta di utilizzare un’interaporta come shift-register, inviandoin uscita un bit per ciclo di clock, mail rovescio della medaglia è che dob-biamo rinunciare alla possibilità diusare questa porta per qualcos’altro.Inoltre questo sistema funziona soloper il bianco e nero e non per i livel-li di grigio.
Se volessimo utilizzare un converti-tore DA esterno, connettiamo il pinMSB del convertitore al bit 0 dellaPORTB ed il pin LSB ad un qualsiasipin della PORTA. Per usare la PORTBcome shift register, tutti i pin devo-no essere impostati come output(per questo è impossibile utilizzarlaper qualcos’altro). Il pin dove è con-nesso l’LSB deve essere impostatoad alto, quindi bisogna memorizza-re il byte da inviare nella PORTB. La
routine che segue mostra comeinviare il byte memorizzato:Questo esempio, nonostante ese-gua la stessa funzione del prece-dente, è molto più veloce perchè
richiede un tempo di setup moltominore.Utilizzando un ciclo di clock per bit siotterrebbe una risoluzione di 156pixel, se non fosse necessario untempo di setup. In realtà è necessarioun po’ di tempo prima di eseguire leroutine, quindi proprio prima e dopogli 8 bit di grafica, vengono visualizza-ti casualmente alcuni pixels bianchi oneri. Nel gioco “Pong” che ho realiz-zato, ho risolto questo problema visua-lizzando degli spazi neri tra un caratte-re e l’altro.Le stringhe sono lunghe 8 caratteri(ma è possibile anche arrivare a 10)ogni dei quali largo 8 pixel, quindiogni pixel utilizza 1.5 cicli di clock,compreso il setup. I bit da inviare inuscita provengono da una locazione dimemoria che contiene 8*8 bits, vale adire 8 bytes. Per ogni linea gli 8 bytesvanno calcolati leggendo la stringadalla memoria eeprom (contenuta nelPIC16F84) dove sono memorizzati,ottenendo quindi l’immagine correttada una tavola di lookup nella memoriadel codice, alla fine sono memorizzatinella memoria dati. Fare tutto questoper soli 8 caratteri, richiede molto
tempo, quindi viene fatto durante l’in-tera linea di scansione. La ragione percui il testo è visualizzato ogni secondalinea di scansione è che, durante que-sto tempo, il processore sta calcolandola linea successiva da visualizzare
durante le linee nere (inmezzo alle linee di scansione grafiche).
In questo modo è possibile visualizza-re la grafica con risoluzione più alta,occupando però l’intera PORTBdurante l’operazione di shifting.A prima vista (e come accennato pre-cedentemente) potrebbe sembrareimpossibile usare la PORTB per altro,ma di fatto, non lo è. La porta puòessere utilizzata come uscita se unodei pin della PORTA è utilizzato perdisabilitare l’hardware attaccato allaPORTB, durante l’operazione di shif-ting. Allo stesso modo è anche possi-bile utilizzarla come ingressi. Nei mieigiochi, per esempio, ho avuto biso-gno di utilizzare molti pin per con-netterci i joysticks. Ma questa è un’o-perazione pericolosa, perché, mentrela porta è utilizzata come uscita, il joy-stick potrebbe bruciarne il buffer (iljoystick dispone di switchs che si col-legano a massa se premuti). Io horisolto questo problema utilizzandodelle resistenze di pull-up da 100KΩ euna resistenza di protezione da 1KΩ.Questa soluzione fornisce una tensio-ne vicina allo zero, quando lo switchdel joystick è chiuso, proteggendo laporta contro i corto circuiti a massa.
La sincronizzazione verticalePer sincronizzare il televisore con ilsegnale video, occorre generare l’im-
HARDWARE
HARDWARE70
movlw 8 ;number of pixels is 8 (1)movwf counter ;set counter to number of pixels (1)
shiftloop:movlw COLOR_BLACK ;set default color to black (1)rrf thedata,f ;rotate data right, make put bit in carry (1)skpnc ; check if carry, if not pixel remains black (1/2)movlw COLOR_WITE ;carry was set, set color to white (1)movwf VIDEO_PORT ;set color to DA (1)decfsz counter ;decrease counter, check for zero (1 or 2)goto shiftloop ;if more pixels, keep looping (2)
movfw thedata ;set up the byte to be shifted outmovwf PORTB,f ;now the first bit becomes visible (1 clock)rrf PORTB,f ;second bit is shifted out (1 clock)rrf PORTB,f ;third bit is shifted out (1 clock)rrf PORTB,f ;fourth bit is shifted out (1 clock)rrf PORTB,f ;fifth bit is shifted out (1 clock)rrf PORTB,f ;sixth bit is shifted out (1 clock)rrf PORTB,f ;sevenths bit is shifted out (1 clock)rrf PORTB,f ;eighth bit is shifted out (1 clock)
I caratteri sono disegnati solo sullaseconda linea di scansione.
Figura 12
pulso verticale. Questo può esserefatto con il seguente codice:Come descritto in precedenza,questo codice genera l’impulso disincronismo necessario. La labelvertsync è quella da chiamare. La routine prima chiamashortsync , poi salta a longsynce quindi torna indietro sushortsync . È un codice un po’contorto ma consente il risparmioun pò di memoria.
Sovrapporre due segnali videoÈ abbastanza complicato sovrap-porre due segnali video perchérichiederebbe dell’altro hardwareesterno, ma è molto più sempliceinserire la grafica, da voi generata,
in un segnale video esistente.Per fare questo invece di generaregli impulsi di sincronismo li andiamoa leggere dal segnale video esisten-te, agganciando la temporizzazionenel codice con gli impulsi letti. Unsistema semplice è quello di utilizza-re il LM1881, un circuito integratoin grado di separare il sincronismoorizzontale e verticale dal segnalevideo. Poniamo il caso di voleraggiungere una piccola immaginenell’angolo inferiore destro di unsegnale video esistente, in questocaso aspettiamo l’impulso di sincro-nismo verticale e quindi leggiamogli impulsi di sincronismo orizzonta-le fino a raggiungere la linea dallaquale vogliamo che la nostra imma-
gine venga aggiunta. Supponiamoche l’immagine da aggiungereabbia una dimensione di 8x8 pixels,dovremo quindi aggiungerla alle 8linee seguenti. Aggiungiamo lanostra immagine semplicementeinterrompendo il segnale video esi-stente ed inviando quindi le nostreinformazioni. La commutazione tra idue segnali va fatta alla fine d’ognilinea dell’immagine che stiamoaggiungendo, quando abbiamofatto questo per tutte le linee dellanostra immagine, torniamo indietroe ripetiamo l’operazione per ogniimpulso di sincronismo verticalesuccessivo.Questo procedimento diventamolto complesso se le informazioni
HARDWARE
HARDWARE 71
Shortsync: ; label "Shortsync", entry for short sync generatorMovwf counter1 ; set counter1 to number of shortsyncs
Shortsync_l0: ; label "Shortsync_l0", short sync count loop entryBcf porta,0 ; set level to synclevel (bit 1)Bcf portb,0 ; set level to synclevel (bit 0)nopMovlw 0x1D ; set counter2 to "30us"Movwf counter2NopBsf porta,0 ; set level to black
Shortsync_l1: ; label "Shortsync_l1", short sync delay loopDecfsz counter2 ; do delay countingGoto shortsync_l1 ; loop if not finished with delayDecfsz counter1 ; count number of shortsyncsGoto shortsync_l0 ; if more shortsyncs, keep loopingRetlw 5 ; return and set w to number of longsyncs (5 longsyncs)
Vertsync: ; label "vertsync", this is the label to call from mainMovlw 5 ; set number of shortsyncs to 5btfss videostuff,0 ; check if first fieldmovlw 6 ; yes, change number of short syncs to 6call shortsync ; do those short syncsincf videostuff ; update field for the new frame
longsync: ; label "longsync", just to make it easy to understandmovwf counter1 ; set synccounter to number of longsyncs
longsync_l0: ; label "longsync_l0", long sync count loop entrmovlw 0x1D ; set synccounter to number of longsyncsmovwf counter2 ; set counter to 30usbcf porta,0 ; set level to sync (bit 1)bcf portb,0 ; set level to sync (bit 0)
longsync_l1: ; label "Shortsync_l1", long sync delay loopdecfsz counter2 ; do delay countinggoto longsync_l1 ; loop if not finished with delaynopbsf portb,0 ; set level to blacknopdecfsz counter1 ; count number of shortsyncsgoto longsync_l0 ; if more shortsyncs, keep loopingmovlw 5 ; set number of shortsyncs to 5btfss videostuff,0 ; count number of shortsyncsmovlw 4 ; yes, do 4 shortsyncs insteadgoto shortsync ; do those short syncs
da inviare sono molte, per via dellamemoria limitata del PIC.PERCHÉ IL PIC16F84 NONPUÒ GENERARE SEGNALEVIDEO A COLORIIn questa parte cercherò di spiega-re come viene aggiunto il coloread un segnale video, essendo unargomento abbastanza complica-to, farò solo una breve introduzio-ne, quindi vi consiglio di leggereun libro sull’argomento se voleteapprofondirlo.
Il segnale video a colori Quando fu introdotta la televisione acolori, si rese necessario mantenere lacompatibilità con i vecchi televisori inbianco e nero, per via della loro grandiffusione. Era necessario far sì chefosse possibile visualizzare l’immaginecorrettamente, sia con il segnale videoa colori che in bianco e nero. Per que-sto l’informazione sui colori fu aggiun-ta al segnale video, modulandola inampiezza con una portante a 4.43MHz. Di fatto, la portante a coloriaggiunse un po’ di rumore videoall’immagine, si rese quindi necessarioaggiungere una “trappola” per elimi-nare la portante, in tutti i televisori inbianco e nero costruiti in seguito.
Combinando i segnali Rosso-Verde-Blu, possiamo in pratica generare tuttele tonalità di colore, quindi il segnalevideo deve contenere le informazionisulla loro intensità e, come poteteimmaginare, questo significa moltepiù informazioni da inviare rispetto aun segnale video in bianco e nero. Lasomma delle tre componenti di coloreè di fatto già inviata come intensità delbianco e nero, quindi inviando anchela differenza dei segnali Rosso-Verde eBlue-Verde, tutti i tre colori possonoessere estratti.Ma è possibile inviare due componen-ti colore utilizzando una sola portante?Si, può essere fatto se si generano duediverse versioni della stessa portante,se la fase viene cambiata di 90 gradi.
La differenza Rosso-Verde è inviata conla portante originale mentre la diffe-renza Blue-Verde è inviata con la fase
cambiata. Per semplificare, il segnalevideo si calcola in questo modo:Per poter separare le due compo-nenti colore, il televisore ha biso-gno di un oscillatore che sia in sin-cronismo con l’oscillatore delsegnale video, aggiungendo i pic-chi del colore con quelli del segna-le video è possibile farlo.Negli 8µs di ritardo, quando il can-none elettronico si sta muovendoalla linea successiva, nel segnalevideo bianco e nero non succedeniente, invece, in un segnale videoa colori, vengono inviati circa 10segnali di clock (chiamati impulsicolore), così da effettuare la sincro-nizzazione; diversamente nonsarebbe possibile visualizzare cor-rettamente i colori. Nei primi tele-visori a colori, l’oscillatore non erasufficientemente stabile generandoquindi colori falsati, per esempio lapelle umana aveva una tonalitàverdastra. Questo era un problemaparticolarmente evidente dellostandard NTSC, quindi quandovenne creato lo standard PAL, fuaggiunto uno spostamento dellafase di 180 gradi ad ogni linea, in
modo che i gli errori della fase siannullassero a vicenda.Generazione software dei coloriVisto che il segnale video è analo-gico e richiede una portante di4,43MHz, a prima vista sembrarealmente impossibile generarlo insoftware, di fatto questo non èvero, perché all’ingresso del televi-sore c’è un filtro che rimuove lefrequenze più alte della banda pas-sante del segnale video (all’incirca4-5MHz). Se un’onda quadra fosseinviata al posto di una sinusoidale,sarebbe interpretata comunquecome sinusoidale dal televisore,perché la maggior parte delle com-ponenti alte del segnale verrebbe-ro rimosse, quindi non abbiamorealmente necessità di creare unvero segnale analogico.Per creare un segnale da 4,43MHz,il PIC16F84 dovrebbe fornire alme-no 2*4,43 MIPS, questo significache il PIC dovrebbe “girare” aduna frequenza di 4*4*4,43, vale adire 70,88MHz, in realtà questo èimpossibile, per via delle caratteri-stiche del PIC stesso. Assumendoche lo si possa fare, questo genere-rebbe un segnale a colori costante,ma non sarebbe possibile cambiarepiù di un bit alla volta nelle infor-mazioni. Per impostare un interobyte colore, sono richiesti due ciclidi clock, quindi il PIC dovrebbe
HARDWARE
HARDWARE72
Rappresentazione sull’oscilloscopio di una linea di scansione in un segnale video a colori.Figura 13
(R+G+B) + (R-G)*sin(w*t) + (B-G)*cos(w*t)
Maggi presentato su FareElettronica di Gennaio 2003. I GIOCHI “PONG” E “TETRIS”Nel prossimo numero metteremoin pratica quanto spiegato in que-sto articolo, realizzando due sem-plici video game: Pong e Tetris.Entrambi i giochi generano ilsegnale video in software e quindiutilizzano un circuito molto sem-plice ed economico da realizzare,ma che non mancheranno di farvipassare alcune ore in allegria con ivostri amici, ricordando i vecchitempi in cui i video game andava-no a 50 Lire.
“girare” a 141,76MHz.Questo, potrebbe essere fatto conuno dei microprocessori dellaserie SX della UBICOM (ex SCE-NIX), i quali sono uguali ai PIC main grado di performances notevol-mente maggiori (da 50 a 100MIPS). In passato ho fatto qualcheesperimento con questi micropro-cessori ma senza successo, per viad’alcuni problemi che affliggeva-no le prime versioni del silicio, laUBICOM dovrebbe aver risoltoquesti problemi nelle nuove ver-sioni.Se desiderate generare video acolori con un PIC, avete bisognodi utilizzare un circuito integratoesterno che si preoccupi di que-sto. Un valido esempio per questasoluzione lo trovate nel progetto del“Generatore video” di Marcelo
HARDWARE
HARDWARE 73
”Pong” in azione. Figura 14
“Tetris” in azione. Figura 16
Electronic shop 16
Ralph H. Baer (a destra), inventoredel gioco “Pong”, mentre gioca con
il suo primo prototipo (1966)
TUTORIAL74
LE INTERFACCE SERIALIRS-422 E RS-485LE INTERFACCE SERIALIRS-422 E RS-485di Vincenzo [email protected]
Questo tutorial illustra gli aspetti principali degli standard di trasmissione digitaledifferenziale EIA/TIA-422 ed EIA/TIA-485, nel seguito indicati semplicemente comeRS422 e RS485, spesso utilizzati per trasmissioni seriali in ambiente industrialee/o a grande distanza. La scelta di descrivere contemporaneamente queste dueinterfacce deriva dal fatto che sono molto simili tra loro ed in alcune applicazionisostanzialmente intercambiabili.
Prima di cominciare, una premessa:questi standard si riferiscono esclusiva-mente agli aspetti elettrici del segnale(il cosiddetto livello 1 o physical layerdello standard ISO/OSI), ignorandocompletamente ogni definizione delsignificato delle tensioni trasmesse. Nelseguito violerò per alcuni aspetti questapremessa, accennando in particolarealla trasmissione seriale asincrona sulunghe distanze in ambienti industriali,ambito che a rigore dovrà essere rite-nuto solo un esempio applicativoanche se consolidato.A puro titolo informativo, accenno adaltre due applicazioni in cui tali stan-dard sono utilizzati:
• bus SCSI differenziali: la trasmissioneè sincrona ed avviene in parallelo, uti-lizzando molte decine di fili, a veloci-tà e distanze medie (decine diMbyte/s, pochi metri).
• reti locali di computer 10baseTX:sono utilizzate due coppie di cavi, sudistanze fino a 100 m e velocità di 10Mbit/s; ciascun bit ha generalmenteuna codifica di tipo Manchester ed èinserito in un frame composto damigliaia di bit,trasmessi serialmente.
I SEGNALII segnali digitali con cui normalmente siha a che fare sono del tipo singleended o sbilanciato: la tensione èmisurata rispetto ad un riferimentocomune indicato come massa (o piùpropriamente come reference o signalground). Due esempi di tali segnalisono, per rimanere nel campo dei siste-mi di comunicazione:
• la porta parallela Centronics: tensio-ni maggiori di 2 V indicano l’unologico, tensioni minori di 0.8 V iden-tificano lo zero logico, definizionicoincidenti con quelle utilizzate per isegnali TTL
• la porta seriale RS232: l'uno logico èidentificato da una tensione negativacompresa, in modulo, tra 3 e 15 V elo zero da una tensione positiva mag-giore di 3 V.
Per trasmettere un singolo bitusando un segnale sbilanciato èevidentemente necessario usare unsolo filo oltre alla massa che èunica e comune a tutti i segnali.I limiti nell'uso di segnali nonbilanciati nella trasmissione di
informazioni derivano da due con-siderazioni:
• Se è vero, almeno in prima approssi-mazione, che il potenziale di riferi-mento è univocamente definito in uncircuito di piccole dimensioni, taleconcetto diventa una illusione quan-do le distanze sono elevate; infatti lacorrente, scorrendo nel filo di riferi-mento, produce differenze di poten-ziali a causa dell'impedenza elettricadel collegamento. Questo fatto è giàabbastanza rilevante in corrente con-tinua (quando occorre tener contodella resistenza del cavo) ma è fon-damentale quando, usando segnaliad alta velocità, l'induttanza del cavoassume la predominanza.
• Lungo un filo di lunghezza non tra-scurabile la tensione subisce l'influssocasuale e continuamente variabiledei disturbi esterni: il ricevitore quin-di osserva un segnale digitale sovrap-posto a "rumore" che, se elevato,potrebbe portare ad interpretazionierrate del valore logico.
Tale effetto si verifica in modo casualesia nei confronti del segnale sia nei con-
TUTORIAL
TUTORIAL 75
Esistono ovviamente anche degli svan-taggi:
• È necessario prevedere un numerodoppio di conduttori: per ogni sin-golo segnale servono due fili, oltre lamassa comune a tutti i segnali.
• Sono richiesti driver e ricevitori piùcomplessi. Utilizzando circuiti inte-grati appositamente studiati e larga-mente diffusi, questo problema èperò facilmente superabile.
LO STANDARD RS422Questo standard è stato originariamen-te proposto per la trasmissione disegnali digitali fino a 10 Mbit/s (milionidi bit al secondo) su distanze fino a4000 piedi (circa 1200 m). Usandointegrati moderni è inoltre possibilesuperare i limiti imposti dallo standardsia in termini di velocità che di distanza.Lo standard RS422 prevede che ciascu-na linea differenziale sia pilotata da unsingolo driver. I ricevitori possono esse-re fino a 10 ma è più comune l'utilizzodi questo standard nelle comunicazionipunto-punto, cioè per collegare un tra-smettitore ad un singolo ricevitore,come rappresentato nello schemaseguente.I due stati di ciascuna linea sono defini-ti nel seguente modo:
• Quando il terminale A è negativorispetto a B, la linea rappresenta ununo binario. Tale stato rappresentaanche l'assenza di segnale (idle state)
• Quando il terminale A è positivorispetto a B, la linea rappresenta unozero binario
Nella figura seguente viene mostrato
l'andamento idealizzato dei segnali suidue fili A (in rosso) e B (in blu): comesi vede si tratta di due segnali tra loroin opposizione di fase. Nell'immaginesono mostrati come variabili tra zeroed una tensione positiva (come delresto avviene il più delle volte anchenei sistemi reali) anche se questo nonè richiesto dallo standard. La tensionedifferenziale è quella che effettivamen-te trasmette l'informazione ed è positi-va o negativa in funzione del livellologico trasmesso.
Da notare che in molte realizzazioni ilterminale A è identificato come - ed ilterminale B come + oppure con altrinomi in cui però è evidenziato, anchegraficamente, che hanno sempre valo-ri logici opposti.All'uscita del trasmettitore la differenzadi potenziale tra le linee A e B deveessere di almeno 4 V e la tensione dimodo comune deve essere minore di 7
V (normalmente una linea vale 0 V el'altra circa 5 V). Il ricevitore deve esse-re in grado di interpretare corretta-mente lo stato della linea quando la dif-ferenza di potenziale è superiore inmodulo a 200 mV. In appendice horiportato una tabella con tutti i valorielettrici definiti dallo standard.Nel caso di realizzazioni industriali, latopologia più frequente prevede due
fronti del riferimento, per di più condiversa intensità considerando che l'im-pedenza equivalente verso massa èdiversa. Una soluzione ad entrambi iproblemi è quella di adottare elevateescursioni del segnale al fine di aumen-tare il rapporto tra segnale e disturbo(p.e. la RS232 prevede escursioni tipi-che di 24 V) oppure mantenere corti icavi (soluzione ovviamente improponi-bile se i due oggetti da collegare sonofisicamente distanti) oppure ancorausare, almeno per il segnale di riferi-mento, cavi di elevata sezione (opzionecon evidenti impatti negativi).Il secondo dei due problemi accennatiè inoltre parzialmente risolvibile utiliz-zando cavi schermati.Nei sistemi bilanciati differenziali latensione associata alla trasmissione diun singolo bit è misurata come diffe-renza di potenziale tra due fili, tra loroidentici e pilotati da trasmettitori con lastessa impedenza di uscita: se la tensio-ne è maggiore su uno dei fili il valorelogico è associato ad uno zero, se èminore ad un uno. Non ha invece nes-suna importanza la tensione dei due filirispetto a massa.Questo metodo permette di superare idue problemi prima detti:
• Il valore logico è associati alla diffe-renza di potenziale tra due fili: ilpotenziale di massa è quindi inin-fluente. In questo modo, anche se sulfilo di massa scorrono correnti equindi si creano differenze di poten-ziale, non si hanno impatti sui valorilogici. Si usa dire che un sistema ditrasmissione differenziale non è sensi-bile alla tensione di modo comuneVcm, definita come media della ten-sione dei due fili che trasportano ilsegnale rispetto alla massa locale.
• Visto che la coppia di fili su cui ilsegnale viaggia è costituita in genereda un doppino pilotato da trasmetti-tori con la stessa impedenza di usci-ta, i disturbi sono fortemente atte-nuati, come descritto in uno deiseguenti paragrafi.
TUTORIAL
TUTORIAL76
soli dispositivi collegati tra loro attraver-so due coppie di cavi (oltre la massa),una per ciascun verso di trasmissionedel segnale; in questo caso è possibilerealizzare una comunicazione full-duplex: ciascuno dei due dispositivipuò contemporaneamente ricevere etrasmettere dati.
LO STANDARD RS485Lo standard RS485 è dal punto di vistaelettrico molto simile all'RS422: alcunedifferenze minori sono riportate nelletabelle in appendice. La differenzasostanziale è il supporto delle lineemulti-drop, cioè linee che presentanola coesistenza di più ricevitori e tra-smettitori sulla stessa coppia di fili. Alfine di evitare conflitti è ovviamentenecessario che un solo trasmettitorealla volta sia attivo. Questo implical'uso di trasmettitori che, oltre alleuscite corrispondenti allo zero e all'u-no, possano gestire anche un "terzostato" in cui l'elettronica appare comefisicamente non collegata alla linea(stato detto ad alta impedenza o Hi-Z). I ricevitori possono invece esseretutti attivi contemporaneamente ed ingenere lo sono. La topologia più usatacon questo protocollo è quella a duefili (oltre alla massa) rappresentatanello schema seguente. Questa con-nessione permette la trasmissionebidirezionale (ma ovviamente noncontemporanea) tra due o più nodiche, dal punto di vista elettrico, sonotra loro equivalenti.
La sezione rice-trasmittente di ciascu-no dei nodi è evidenziato nella figurada un rettangolo blu. Le connessioniverso la linea sono costituite sempli-cemente dai due terminali A e Bcomuni sia alla sezione di ricezioneche a quella di trasmissione e dallamassa. Possono essere ovviamentepresenti dei moduli dotati del soloricevitore o, caso meno probabile, delsolo trasmettitore.Ciascun modulo trasmettitore possie-de, oltre un ingresso dati, anche uningresso di abilitazione alla trasmissio-ne, pilotato localmente, che permettedi disabilitare il trasmettitore quandonon serve: al fine di evitare conflitti ènecessario prevedere un qualchemeccanismo che impedisca l'attiva-zione contemporanea di più trasmet-titori oppure sia in grado rilevare taliconflitti ed intervenire opportuna-mente. I driver RS485 sono comun-que progettati per non riportaredanni anche in caso di corto circuitopermanente, limitando la correntemassima a 250 mA.Nello schema disegnato è previstoanche un segnale di abilitazione delricevitore, sebbene spesso non neces-sario: è infatti possibile lasciare tutti iricevitori sempre attivi oppure colle-gare insieme i due ingressi di abilita-zione essendo normalmente attivi sulivelli logici opposti.Lo standard originario permette laconnessione di massimo 32 ricevitorima utilizzando integrati a basso assor-
bimento tale limite può essere abbon-dantemente superato.
ADATTAMENTO D’IMPEDENZAIn prima approssimazione, in unsistema digitale il concetto di “lineadi trasmissione” deve essere applica-to ogni volta in cui la durata di unbit è minore di 10 volte il temponecessario al segnale a percorrere ladistanza tra trasmettitore e ricevito-re oppure il tempo di salita deisegnali è maggiore di 5 volte iltempo di trasmissione.La descrizione dei fenomeni associa-ti alle linee di trasmissione vannooltre gli scopi di questo tutorial ma,per una comprensione almenoapprossimativa è necessario tenerepresente che:
• Il segnale elettrico si propaga neiconduttori ad una velocità finita,prossima a 2/3 di quella della luce.
• Ciascun cavo è caratterizzato daparametri elettrici di tipo distribui-to sintetizzabili con l'impedenzacaratteristica Zo, un valore resisti-vo indipendente dalla lunghezzadel cavo, dato dal produttore enon misurabile con strumentihobbistici.
• Se la resistenza di uscita di un tra-smettitore e la resistenza di ingres-so di un ricevitore non sono ugua-li all'impedenza caratteristica dellalinea usata, si generano riflessionidel segnale cioè, mi si scusi il
TUTORIAL
TUTORIAL 77
paragone poco preciso, il segnale"torna indietro" quando raggiun-ge la fine del cavo, causandointerferenze non trascurabili. Siusa dire, per indicare l'uguaglian-za delle tre resistenze, che le lineedi trasmissione devono essere"adattate" oppure "terminate",operazione che si riduce a volteall'aggiunta di uno o più resistori.
Purtroppo non sempre è comodoterminare le linee (non tanto per icosti quanto per il maggior assor-bimento di corrente, una certaattenuazione del segnale, la diffi-coltà di manutenzione e/o esten-sione della rete) per cui è primaopportuno chiedersi se tale opera-zione sia effettivamente necessa-ria in una specifica applicazione.I due parametri fondamentali daconsiderare sono ovviamente lalunghezza del cavo e la velocità ditrasmissione. Una buona regolaempirica che si rifà a quantodetto nell'introduzione al paragra-fo afferma che la terminazionenon è necessaria nel caso in cui ladurata di un singolo bit è moltomaggiore del tempo impiegatodal segnale per percorrere l'interalinea. Normalmente per "moltomaggiore" si intende almeno diecivolte più grande. Questa regolatrae origine dal fatto che le even-tuali riflessioni vengono attenuatedalla resistenza del cavo stesso enel volgere di poco tempo diven-gono trascurabili. Siccome lamisura della tensione viene nor-malmente effettuata dal ricevitoreal centro del bit, è possibile tra-scurare gli effetti delle riflessionise è trascorso un tempo sufficien-te rispetto al fronte del segnale.Come esempio pratico, si conside-ri una linea di 1200 metri, il mas-simo previsto dallo standardRS485. Sapendo che un segnaleelettrico si propaga in un cavotipico a circa 2/3 della velocità
della luce, il tempo impiegato perpercorrere tale distanza è appros-simativamente:
Se la trasmissione avviene a 9600bit/s la durata di un singolo bit è 104us, valore decisamente maggiore di6, e quindi è possibile non terminarela linea senza effetti negativi sullaqualità del segnale. Se sulla stessalinea la trasmissione fosse effettuata a115.000 bit/s la terminazione sareb-be invece indispensabile in quanto ilsingolo bit dura circa 8 us. Infine, se lalinea fosse di soli 10 metri, anche a230.000 bit/s la terminazione potreb-be essere evitata in quanto il tempoimpiegato per percorrere il tratto dilinea è dell'ordine dai 50 ns e la dura-ta del bit circa 4000 ns.Chi fosse interessato alla valutazio-ne rigorosa delle riflessioni deisegnali digitali lungo linee di tra-smissione, può per esempio con-sultare le AN 806, AN 807 ed AN808 pubblicate da NationalSemiconductor e disponibili sulsito http://www.national.com.
Terminazione parallelaIl metodo di terminazione che offre lemigliori prestazioni è quello cosiddet-to parallelo. Nel caso di trasmissionipunto-punto, in parallelo al ricevitoreed il più possibile vicino ad esso ènecessario inserire tra i terminali A e Bun resistore di valore pari all'impe-denza caratteristica della linea Zo.I valori del resistore, usando i cavinormalmente impiegati per questoscopo, sono compresi tra 100 e 120ohm. Nelle trasmissioni ad alta velo-cità è opportuno usare resistori ditipo non induttivo (per esempio acarbone).Nel caso un solo trasmettitore e piùricevitori sulla stessa linea è necessa-rio mettere il trasmettitore ad un
estremo della linea e l'unica resisten-za di terminazione all'estremo oppo-sto. I ricevitori intermedi non vannoconnessi a resistenze aggiuntive.Nel caso di connessioni multi-drop, leresistenze da inserire sono due, anchein questo caso pari ciascuna a Zo.Queste due resistenze vanno posteagli estremi fisici della linea, nonnecessariamente in corrispondenza diun ricevitore o di un trasmettitore.Le prestazioni di questo tipo di termi-nazione sono molte buone dal puntodi vista elettrico ma hanno il proble-ma di richiedere un elevato assorbi-mento di corrente: considerando lasituazione normale con una resisten-za di 100 ohm ed una tensione diffe-renziale di 5 V, il trasmettitore devegenerare una corrente di 50 mA oltrea quella assorbita dai ricevitori. Talevalore deve essere raddoppiato nellelinee multi-drop in quanto le resisten-ze sono due.Un secondo problema legato allelinee multi-drop deriva dal fatto chele connessioni tra i nodi centrali ed ilbus (i cosiddetti stub) devono esseremantenuti il più breve possibile inquanto non è possibile inserire su cia-scuno di essi un resistore di termina-zione
Terminazione serieLa terminazione serie è utilizzata nelcaso di trasmissioni punto-punto. Inquesto caso due resistori pari a metàdell'impedenza di linea meno l'impe-denza di uscita del trasmettitore sonoposte in serie alle due uscite del tra-smettitore: in questo modo le rifles-sioni create dal segnale in corrispon-denza del ricevitore sono assorbiteappena tornano al trasmettitore.Da notare che molti trasmettitorihanno l'impedenza di uscita prossi-ma a 100 ohm e quindi la termina-zione serie è "automaticamente" pre-sente.Il metodo non è applicabile ai sistemimulti-drop in quanto i ricevitori inter-medi osservano i segnali riflessi.
TUTORIAL
TUTORIAL78
Terminazione ACLa terminazione di tipo AC cerca dirisolvere i problemi di assorbimentodi corrente della terminazione paralle-la, particolarmente sentiti per esem-pio in applicazioni alimentate a batte-ria. L'idea è quella di inserire in serie alresistore di terminazione un conden-satore che ha lo scopo di annullarel'assorbimento di corrente in assenzadi trasmissione; il valore può esserecalcolato con la formula:
Dove Td è il tempo impiegato dalsegnale a percorrere il cavo e Zo èl'impedenza caratteristica della linea.Le caratteristiche di questo tipo diterminazione sono di poco inferiori aquelle della terminazione parallelacome qualità del segnale ma sonoutili solo alle velocità più basse inquanto, salendo in frequenza, l'impe-denza del condensatore diviene tra-scurabile.
VALUTARE LA QUALITÀDELLA TRASMISSIONEUna valutazione complessiva delsistema di trasmissione deve tenerconto di tutti i componenti e dellaloro interazione:
• L'algoritmo usato in ricezionedalla UART per riconoscere se unbit è zero oppure uno: è possibi-le per esempio effettuare un solocampionamento al "centro" delbit oppure un certo numero dicampionamenti (3, 5, o più) equindi decidere "a maggioranza"
• La precisione del clock del tra-smettitore e del ricevitore
• La capacità del ricevitore diimpostare correttamente lasoglia di discriminazione tra idue valori logici
• La qualità del segnale elettrico
trasmesso, aspetto che coinvolgesia il trasmettitore che il cavo ditrasmissione
Ho ovviamente tralasciato inten-zionalmente le tecniche meno"elettroniche" quali la rilevazionedegli errori attraverso CRC e lerichieste di ri-trasmissione delleinformazioni errate.In genere viene usata come unitàdi misura il BER% (tasso percentua-le di errori di trasmissione, riferitoal singolo bit). Esistono appositistrumenti di misura che inviano altrasmettitore stringhe semi-casualied effettuano il conteggio deglierrori commessi dal ricevitore; nonè ovviamente difficile, anche perl'hobbista, realizzare un simile dis-positivo utilizzando, per esempio,un personal computer sia comesorgente di dati casuali che come"controllore" della ricezione.
L'eye diagramUna valutazione qualitativa più speci-fica della sola sezione di trasmissionedifferenziale può essere fatta osser-vando con un oscilloscopio dotato diingresso differenziale il cosiddetto eyediagram (diagramma ad occhio). Ilnome deriva dal fatto che, con un po'di fantasia, si intravede la forma di unocchio la cui apertura è indice dellachiarezza con cui è possibile indivi-duare correttamente il livello logico.Per utilizzarlo è necessario un tra-smettitore che invia dati in modocasuale o comunque abbastanzavariabile ed un oscilloscopio coningresso differenziale. Occorre impo-stare il trigger dell'oscilloscopio coin-cidente con la soglia di discriminazio-ne tra 0 e 1 e la base dei tempi sullalunghezza di due o tre bit.Sullo schermo dell'oscilloscopio deveapparire un'immagine simile alleseguenti, la prima riferita ad unsegnale "pulito" e la seconda ad unsegnale al limite della possibilità diriconoscimento. Nella prima figura
sono chiaramente visibili al centrodue "occhi" completi; nella secon-da i segnali appaiono molto piùconfusi, indice di peggiore qualitàdel segnale.
LA POLARIZZAZIONEQuesto aspetto riguarda i sistemidi trasmissione in cui è possibiledisattivare i driver: in particolaredeve quindi sempre essere tenutopresente nelle reti RS485.Quando tutti i driver sono scon-nessi dal bus il livello logico èindeterminato e questo può cau-sare falsi segnali sui ricevitori acausa della fluttuazione casualedella tensione indotta, per esem-pio, da disturbi esterni. In sistemireali questa situazione è moltofrequente in quanto è necessariolasciar trascorrere un certo lassodi tempo tra la disconnessione diun trasmettitore e la connessionedi un altro, al fine di evitare con-flitti.La soluzione normalmente adottataè quella rappresentata nello schemaseguente: vengono aggiunte dueresistenze di polarizzazione Rb inmodo tale che formino un partito-re resistivo che mantenga la diffe-
TUTORIAL
renza di potenziale tra i terminaliA e B ad un valore di 200 mV nelcaso in cui tutti i trasmettitorelungo la linea siano disattivati.
Le connessioni rappresentatesono tali che il terminale A è apotenziale minore cioè il valorelogico corrisponde allo stato diriposo. Questa connessione èspesso indicata come fail-safe.La scelta del valore di Rb dipendedalla configurazione della rete e
dal numero di nodi connessi. Siconsideri il seguente caso: al bussono collegati 32 ricevitori (cia-scuno con un'impedenza diingresso di 12 kohm); sono inoltrepresenti i due resistori di termina-zione Zo di 120 ohm. La resisten-za complessiva tra le linee A e B èquindi di 120//120//(32 x 12k)cioè circa 52 ohm. Per mantenere200 mV ai capi di tale resistenzaoccorre una corrente di pocomeno di 4 mA. Considerando unatensione di alimentazione di 5 V,le due resistenze Rb devono alloraessere ciascuna di circa:
Al fine di evitare fraintendimentirelativamente allo schema rappre-sentato è opportuno chiarire che:• In una rete RS485 il resistore Zo
di terminazione va posto solosui due nodi agli estremi dellarete
• Le resistenze di polarizzazionevanno poste solo in punto dellarete. Il nodo nel quale sonoinserite è irrilevante anche sepotrebbe essere comodo farlosul primo nodo, in corrispon-denza di uno dei resistori di ter-minazione.
Si consideri come altro esempiouna rete senza le due resistenze diterminazione. In questo caso laresistenza tra le linee A e B causa-ta dalla sola resistenza di ingressodei ricevitori è di circa 375 ohm,la corrente necessaria è di circa0.53 mA e quindi le due resisten-ze di polarizzazione devono esseredi circa 4.5 kohm.Molti dispositivi commercialihanno resistori di polarizzazionegià integrati (indicativamente
TUTORIAL
TUTORIAL80
qualche decina di kohm per cia-scun nodo) e ciò potrebbe rende-re inutile l'aggiunta d resistoriesterni nel caso frequente in cuinon si usino resistenze di termina-zione.
LA PROTEZIONELe linee che trasportano segnaliRS485 si trovano spesso ad essereusate in ambienti industriali graziealla loro ottima immunità ai disturbidi origine esterna. In questi ambien-ti è possibile che accidentalmente icircuiti vengano a contatto con ten-sioni e/o correnti molto elevate e talida mettere a rischio la funzionalitàdei dispositivi che costituiscono larete. In genere sono due i problemipresenti:
• Tensioni molto elevate (diversi kV)caratterizzate da una durata estre-mamente breve (ordine di gran-dezza del millesimo di secondo).In genere sono conseguenza dicariche elettrostatiche, della com-mutazione di grossi carichi indut-tivi, di fenomeni atmosferici o"scintille" in genere.
• Tensione minori (centinaia di volt)ma con durata molto lunga, tipi-camente generate da guasti checausano un corto circuito tra i caviche trasportano dati e quelli di ali-mentazione.
Inoltre i disturbi possono essere clas-sificati in due grosse categorie:
• Disturbi di modo comune, cioèpresenti su tutti i fili e misuratirispetto alla massa locale del cir-cuito. In genere la prima causa diquesto tipo di tensioni deriva dal-l'impossibilità pratica di ottenerecollegamenti di massa a bassaimpedenza lunghi centinaia dimetri, in particolare durante itransitori.
• Disturbi differenziali, cioè presen-ti tra le due linee di dati. Questa
situazione si ha per esempio nelcaso di un corto circuito tra unodei fili e un cavo di alimentazionead alta tensione.
L'isolamento galvanicoQuesto approccio è quello più effi-cace ed universalmente adottatocontro le grosse differenze dipotenziale di modo comune. Èimportante capire che quando si haa che fare con distanze elevate èimpossibile garantire collegamentia bassa impedenza sia per la resi-stenza associata al cavi sia, soprat-tutto, per l'induttanza, decisamen-te preponderante alle frequenzepiù elevate. In queste condizioni èsbagliato ritenere che due punticollegati da un cavo siano allo stes-so potenziale: in particolare questoè vero per la terra o in genere lamassa. Su linee di molte centinaiadi metri non è impossibile trovaredifferenze di potenziale di moltecentinaia di volt anche se dalladurata di frazioni di msIl metodo più usato per garantirel'isolamento in sistemi di trasmis-sione digitale è l'utilizzo di fotoac-coppiatori cioè di dispositivi checonvertono i segnali elettrici insegnali ottici e quindi ancora insegnali elettrici.Le tensioni di modo comune chequesti componenti sono in gradodi gestire sono dell'ordine di qual-che kV, anche per tempi molto lun-ghi. Anche se non è consigliabile,utilizzando dispositivi optoisolati lelinee di trasmissione e il riferimentopossono essere di tipo floating,cioè senza alcun riferimento apotenziali esterni alla linea stessa.I principali svantaggi di questometodo sono:
• La relativa lentezza della trasmis-sione: in funzione dei componentiusati, le velocità difficilmente rag-giunge i 10 Mbit/s.
• La necessità di disporre di alimen-
tazioni isolate per i due lati del cir-cuito, impedendo la possibilità diun'alimentazione unica per abbat-tere i costi.
• L'efficacia nulla contro tensionidifferenziali (anche se vienecomunque garantita la sicurezzadei dispositivi collegati alla reteanche nel caso di eventi "catastro-fici")
Le tecniche di shuntQueste tecniche si basano sull'usodi componenti che riescono abloccare la tensione ai loro capi avalori predefiniti, assorbendoanche migliaia di ampere; disposi-tivi di questo tipo sono i MOV, iTranzorb®, gli scaricatori a gas e,con qualche limitazione, i diodizener generici.Nei casi più complessi possonoessere associati in parallelo disposi-tivi di tipo diverso, collegando uncomponente di potenza elevatama non particolarmente veloce(quale uno scaricatore a gas) ad unaltro più veloce. I due dispositividevono essere connessi tra loroattraverso una resistenza di pochedecine di ohm.Le tensioni di soglia dei componen-ti di protezione devono essere sceltenell'ordine dei 6-8 V e la capacitàparassita la più piccola possibile,soprattutto se sono richieste veloci-tà di trasmissione elevate.
TUTORIAL
TUTORIAL 81
Pur trattandosi di dispositivi ingrado di gestire potenze istanta-nee di migliaia di watt, gli scarica-tori sono poco efficaci nel con-fronto di differenze di potenzialeapplicate per lungo tempo, qualiquelle causate da un corto circui-to con le linea di alimentazione.In questo caso è opportuno colle-gare su ciascuna linee un fusibile(tipicamente 125 mA, non indica-to nello schema), possibilmentedel tipo auto-ripristinante. Il mon-taggio di questi dispositivi richie-de che siano installati presso cia-scun trasmettitore e ricevitore, eche siano connessi alla terra loca-le di protezione attraverso un per-corso breve ed a bassa impeden-za. Un problema legato al collega-mento diretto con la terra deriva
dal fatto che in questo modo il filodi riferimento della linea RS485 sicomporta a sua volta come "colle-gamento di terra" tra i vari nodisenza essere dimensionato corret-tamente per questo scopo: èquindi consigliata la connessionedei dispositivi di trasmissione allaterra locale attraverso un resistoreda 100 ohm - 1/2 W.
La combinazione di shunt edisolamentoSi tratta ovviamente dell'insiemedei due sistemi precedentementedescritti.La soluzione in assoluto più sicuraè costituita dalla presenza dell'iso-lamento ottico e di tre scaricatoriper ciascun nodo, uno per ciascu-na delle due linee di dati ed una
per la connessione di riferimento.È richiesta la connessione all'im-pianto di terra.Una soluzione alternativa, daapplicare solo qualora non fossedisponibile un'adeguata connes-sione di terra, prevede sempre lapresenza di tre scaricatori, uno traciascun filo.
TUTORIAL
Electronic shop 17
Progettazione
Impaginazione
web design
Uniamo l’idea al progetto trasformandolo in supporto cartaceo o video, dando alla Vostra Azienda
un servizio completo ed unico con ottimi risultati come la “serietà” e la “qualità”.
QUANDO LA QUALITÀ E LA SERIETÀ COSTANO CARO, COSA VI RIMANE?
stampa
ProgettazioneImpaginazioneStampaWeb Design
ELETTRONICA GENERALErubriche
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCEdi G. FILELLA - F. CIPOLLA – P. BORRELLI [email protected]
Corso di preparazione all’esame della patente europea perl’uso del computer
Modulo 5
DATABASEPreparatevi, state per intraprenderela costruzione del vostro primo data-base. Dopo aver seguito la lezioneprecedente, non dovreste averealcun problema! Da dove si inizia?Dalla costruzione della tabella. Buonlavoro!
CREARE UNA TABELLA CONCAMPI E ATTRIBUTIIn Microsoft Access è possibile creareuna tabella in due modi: si può creareuna tabella vuota per immettere i datioppure una tabella utilizzando i datiesistenti in un’altra origine.L’operazione di creazione di una tabel-la avviene selezionando il tipo ogget-to TABELLA dalla finestra del databa-se attivo e cliccando sul pulsanteNUOVO. Il sistema visualizza la fine-stra NUOVA TABELLA che compren-de le seguenti modalità di creazione:
• VISUALIZZAZIONE FOGLIO DATI:consente di creare la tabella effet-tuando contemporaneamente ladefinizione dei campi che la com-pongono e l’inserimento dei dati;
• VISUALIZZAZIONE STRUTTURA:consente di creare la struttura dellatabella, definendo i campi che nefanno parte e la natura dei dati chequesti dovranno contenere;
• CREAZIONE GUIDATA TABELLA:è l’autocomposizione che guidal’u-tente più inesperto nelle operazionidi definizione della struttura;
• IMPORTA TABELLA: consente dicreare una nuova tabella importan-do i dati da un file esterno;
• COLLEGA TABELLA: crea unatabella i cui dati derivano da uncollegamento con un file
esterno.La differenza tra IMPORTAe COLLEGA è la seguente:
• con l’operazione IMPORTA creia-mo un oggetto all’interno delnostro database i cui dati sono staticopiati da un altro oggetto, dopo-diché le relazioni tra i due file siinterrompono;
• al contrario, con l’operazione COL-LEGA creiamo una tabella “conte-nitore” i cui dati vengono attinti daun altro file ogni volta che la tabel-la viene aperta.
Il collegamento tra i due oggetti per-tanto è permanente e consente l’ag-giornamento in tempo reale tra i datidel file origine e la tabella del data-base. Se optiamo per l’opzione VISUALIZ-
e.c.
d.l. EUROPEAN COMPUTER
DRIVING LICENCEdodicesima parte
RUBRICHE82
rubriche
lunghezza, tipo dati e controlli daapplicare in fase di inserimento.
Nella definizione del campo, è neces-sario definire il tipo di dati che questodovrà definire.I tipi di dati ammessi da Access sono:testo, memo, numerico, data/ora,valuta (per i numeri che rappresenta-no importi), contatore, Sì/No (campibooleani), oggetto OLE. Si tratta ditipi normali, utilizzabili in quasi tutti isistemi per la gestione dei dati.Osserviamo solo che i campi memonon contengono dati, ma solo pun-tatori a porzioni di testo collegate;mentre i campi OLE sono oggettiche, richiamati cliccandovi sopra,avviano l’applicazione che li ha crea-ti e che ne consente pertanto lagestione. I campi delle tabelle dis-pongono inoltre di alcune proprietàche servono per controllare come idati vengono utilizzati. Facendo unprimo clic con il mouse su una casel-la che identifica un campo e unsecondo clic sulla casella delle pro-prietà, si può accedere alla tavola
delle proprietà.Le proprietà dei campi riguardano:
• le dimensioni,• il formato,• la maschera di input,• l’etichetta,• i decimali,• l’eventuale valore predefinito,• la validità dei dati immessi e il mes-
saggio di errore,• la proprietà RICHIESTO e l’even-
tuale indicizzazione.
Molte di queste proprietà sono utiliin fase di inserimento dei dati, comeguida per l’introduzione e il controllodei valori immessi.La modalità CREAZIONE GUIDATAvisualizza la maschera CREAZIONEGUIDATA TABELLA che consenteall’utente di definire una tabella par-tendo da alcune tabelle-tipo predefi-nite.L’utente può scegliere i campi chefaranno parte della tabella attingen-do tra quelli proposti:
• per un determinato tipo di tabella;• per più tabelle-tipo, mixando quin-
di campi di diversa provenienza.
Una volta terminata la selezione deicampi, cliccando sul pulsante FINE siottiene la creazione della tabella, allaquale l’utente può attribuire il nomeche desidera. L’utente può inoltre definire la chiaveprimaria per la tabella: torneremo suquesto argomento in un momentosuccessivo.Proseguendo con la creazione, il siste-ma consente di collegare la nostratabella ad altre tabelle già presenti neldatabase.Una volta terminata la creazione dellastruttura, possiamo procedere all’in-serimento dei suoi dati.L’inserimento iniziale dei dati serveper riempire le tabelle del database ditutte le informazioni già conosciute almomento della creazione del sistema.
ZA FOGLIO DATI, il sistema presentauna tabella dati le cui colonne sonointestate con i nomi genericiCAMPO1, CAMPO2, CAMPO3, etc.La creazione di una tabella RUBRICAavviene:
• dapprima modificando l’intestazio-ne delle colonne, facendo doppioclic con il mouse sulla casella e inse-rendo per esempio NOME, INDI-RIZZO, TELEFONO, CELLULARE;
• quindi inserendo riga per riga i datidella rubrica. Se optiamo per laVISUALIZZAZIONE STRUTTURA,il sistema visualizza una mascheracomposta da due parti:
• la parte in alto comprende l’elencodei campi della tabella, il loro tipoe la descrizione (facoltativa) chefornisce indicazioni generali sulsignificato del campo e del suocontenuto;
• la parte in basso si chiamaPROPRIETÀ CAMPO e consentedidefinire e visualizzare le caratteri-stiche dei dati immessi nel campo:
rubriche
RUBRICHE 83
ELETTRONICA GENERALErubriche
RUBRICHE84
Nella maggior parte dei casi, infatti,l’automazione di una proceduraavviene quando questa è già avviata efunzionante, per cui è necessario farein modo che i file riportino esatta-mente la situazione dalla quale siintende partire.L’inserimento dei dati nelle tabelledel database è possibile sia almomento della creazione della strut-tura, che in qualsiasi momento suc-cessivo.Ricordiamo le due diverse modalitàdi lavoro sulle tabelle previste daAccess:
• STRUTTURA;• FOGLIO DATI.
Nel paragrafo precedente abbiamoillustrato le operazioni relative alladefinizione, creazione, modifica dellastruttura, lavorando quindi in quellamodalità; ora invece ci occuperemoesclusivamente del contenuto cheviene inserito in una struttura già esi-stente: lavoreremo quindi in modali-tà FOGLIO DATI.Per effettuare l’inserimento è neces-sario dapprima aprire la tabella inte-ressata dalla finestra del database,oppure dalla barra dei menu.Al momento della prima apertura, ilfoglio dei dati, che presenta tantecolonne quanti sono i campi dellatabella con ciascuna colonna intesta-ta ovviamente ad un campo, saràvuoto. Per riempirlo è sufficienteposizionarsi sulle celle e digitare idati. La scrittura su disco avviene unrecord alla volta, per cui al terminedell’inserimento non è necessariorichiedere un salvataggio specificodella tabella comprendente i nuovidati immessi.La visualizzazione del foglio dati diuna tabella presenta tutte le righe etutte le colonne che lo schermo puòcontenere. Basta operare con i pul-santi di scorrimento orizzontale overticale per passare alle successiveinformazioni.
Per raggiungere in inserimento lafine della tabella, ovvero posizionarsidopo l’ultimo record, è sufficientecliccare sul pulsante con la freccia el’asterisco.
Ciò consente di inserirenuovi record in coda allatabella. Lo stesso risultato siottiene mediante il
comando INSERISCI NUOVORECORD della barra dei menu, o tra-mite il pulsante NUOVO RECORDpresente nella barra degli strumenti. Per “navigare” velocemente su unatabella, in particolare quando con-tenga molti record, è bene, oltre aisoliti tasti di scorrimento, al tabulato-re, ai tasti di direzione, ricorrere allabarra posta in fondo allo schermo.I diversi bottoni permettono rispetti-vamente di:
• raggiungere direttamente il primorecord;
• portarsi sul record precedente;• immettere il numero di record scel-
to;• avanzare di un record;• raggiungere l’ultimo record;• inserire un nuovo record in fondo
alla tabella.
DEFINIRE LE CHIAVII record che vengono inseriti in unatabella presentano un proprio ordinenaturale, costituito dalla sequenza diinserimento. Tuttavia, molto spesso l’utente neces-sita di accedere ai record secondo uncriterio diverso da quello temporale.In questo caso, è possibile procederein due modi:
• con un ordinamento• con un accesso mediante indice.
La procedura di ordinamento presen-ta alcuni limiti: si tratta di creare unanuova tabella a partire da quella sor-gente, per cui si ha una effettivaduplicazione dei dati.
Le due tabelle, inoltre, sono oggettidel tutto indipendenti, per cui unaqualsiasi modifica intervenuta in unanon viene automaticamente riporta-ta anche sull’altra. Perciò, è utilericorrere all’ordinamento solo quan-do sia necessario disporre di duetabelle separate. Al contrario, l’indicizzazione non pro-duce una nuova tabella, ma effettuasolo una disposizione logica deirecord secondo l’ordine richiesto. Sitratta cioè di accedere alla tabellasecondo una sequenza diversa rispet-to all’ordine naturale derivante dal-l’inserimento.Un indice non è altro che un’associa-zione tra una chiave di accesso/ordi-namento e un puntatore al recordcorrispondente.La definizione degli indici deve avve-nire tenendo presenti le esigenze dielaborazione, accesso e ricerca deidati. Ciascuna tabella può avere piùindici, a seconda delle modalità diaccesso previste. Ciascun indice, generato su una chia-ve della tabella, serve per definire unordine logico dei record diversorispetto all’ordine naturale; tale ordi-ne può essere ascendente o discen-dente: per i campi di testo, ad esem-pio, l’ordine è dato dal codice ASCII.Gli indici agiscono sull’ordine di pre-sentazione dei record, perciò consen-tono agli utenti di aggiornare e ritro-vare più rapidamente i dati.In Access, la creazione degli indiciavviene in visualizzazione strutturamediante la finestra PROPRIETÀINDICE; se la proprietà INDICIZZA-TO viene attivata, Access creerà unindice per quella tabella sui dati con-tenuti nel campo, secondo l’ordineascendente o discendente, così comeindicato in fase di definizione.L’utente deve inoltre specificare se sitratta di chiave univoca, oppure sesono ammessi valori duplicati. Suuna tabella è inoltre possibile definireuna chiave primaria; anche se Accessnon ne richiede obbligatoriamente la
rubriche
rubriche
RUBRICHE 85
definizione, è bene impostarla ugual-mente.La chiave primaria di una tabella èquel campo o insieme di campi chedefinisce univocamente ciascuno deirecord della tabella.La chiave primaria deve essere defini-ta mediante la cascata di comandiMODIFICA CHIAVE PRIMARIA dallabarra dei menu, oppure cliccandosull’icona corrispondente nella barradegli strumenti, dopo aver seleziona-to dalla finestra STRUTTURA DELLATABELLA il campo sul quale si inten-de operare.Possiamo definire un campo comechiave primaria anche dalla modalitàSTRUTTURA, cliccando con il pul-sante destro del mouse sulla riga rela-tiva al campo che vogliamo definirecome chiave: compare il menu dicontrollo. Se la chiave primaria è composta dapiù campi, la selezione deve avveniretenendo premuto il tasto CTRL percampi non adiacenti mentre perquelli adiacenti è necessario premereSHIFT.Qualora l’utente decida di prevedereuna chiave primaria, ma non vogliadefinirla, può demandarne la creazio-ne al sistema, che:
• utilizza un campo di tipo CONTA-TORE, se presente;
• crea un campo di tipo CONTATO-RE, se la tabella ne è priva (ma ognitabella può avere un solo campo diquesto tipo).
Il campo così creato viene chiamatoID e impostato con la proprietàDUPLICATI AMMESSI: NO ciò signi-fica che il valore della chiave primariaè certamente univoco.
IMPOSTARE UNA TABELLAAbbiamo visto che definire la struttu-ra di una tabella e in generale dellabase di dati è un compito molto deli-cato, in quanto solo se la definizioneavviene in modo efficace, è possibile
poi sfruttare i dati memorizzati neldatabase per interrogazioni e ricer-che di informazioni mirate. Tuttavia,Access, come la maggior parte deisistemi di gestione delle basi di dati,consente di apportare modificheanche a tabelle già esistenti, non solorelativamente al contenuto, maanche alla struttura della tabella.Le modifiche non riguardano però ilcontenuto, ovvero i dati: in questosecondo caso si parla infatti di opera-zioni di aggiornamento.Le operazioni di modifica della tabel-la possono riguardare:
• gli attributi che formano la tabella,ovvero i campi che compongono isuoi record;
• le proprietà di ciascuno degli attri-buti o campi.
In Access, le modifiche alla strutturadelle tabelle avvengono sia in moda-lità STRUTTURA che in modalitàFOGLIO DATI.In modalità FOGLIO DATI, si operamediante comandi eseguibili sullecolonne che compongono la tabella.Possiamo per esempio inserire unanuova colonna mediante il comandoCOLONNA del menu INSERISCI e ilsistema inserirà una nuova colonnacon il nome CAMPO1 a sinistra dellacolonna sulla quale eravamo posizio-nati. A questo punto dovremo passa-re in modalità STRUTTURA per defi-nire le proprietà del nuovo campo.Sempre in modalità FOGLIO DATI, èpossibile anche cancellare un campo,ovvero una colonna della tabella,mediante il comando ELIMINACOLONNE del menu MODIFICA. Lacolonna o le colonne da eliminaredevono prima essere selezionate conil mouse.Siccome l’eliminazione della colonnaproduce anche la cancellazione ditutti i dati inseriti nei campi ad essacorrispondenti, il sistema non proce-de immediatamente alla rimozione,ma chiede conferma mediante una
finestra alla quale possiamo rispon-dere SÌ - se intendiamo eliminare lacolonna o le colonne e tutti i dati inesse contenuti, NO - in caso contra-rio.Le stesse operazioni possono essereeffettuate anche in modalità STRUT-TURA. In questo caso, per l’inseri-mento di un campo, utilizzeremo ilcomando INSERISCI RIGHE, il cheprodurrà l’inserimento di una riganuova al di sopra di quella nella qualeeravamo posizionati con il mouse.Potremo così digitare immediata-mente il nome del campo e definirele sue proprietà. Per eliminare uncampo, utilizziamo il comando ELI-MINA del menu MODIFICA, chevisualizza la stessa richiesta di confer-ma che appare quando operiamo inmodalità FOGLIO DATI.Oltre alle modifiche apportate allatabella, il sistema consente di opera-re per modificarne l’aspetto, ovvero ilformato così come appare all’utentenel momento in cui la tabella è visua-lizzata in modalità FOGLIO DATI.Mediante il menu FORMATO, pos-siamo pertanto:
• modificare l’ampiezza della colon-na visualizzata mediante il coman-do LARGHEZZA COLONNE;
• nascondere una o più colonnemediante il comando NASCONDICOLONNA: in questo caso essanon apparirà a video;
• ottenere la visualizzazione dellecolonne nascoste mediante ilcomando SCOPRI COLONNE,annullando così l’effetto delcomando NASCONDI;
• mantenere ferme una o più colon-ne che vogliamo visualizzareanche quando effettuiamo uno
rubriche
ELETTRONICA GENERALErubriche
RUBRICHE86
una tabella in modalità FOGLIODATI. Le stesse operazioni possonoessere svolte anche su una relazionetra tabelle, purché la modalità divisualizzazione sia sempre FOGLIODATI e la relazione non sia aperta insola lettura. Per operare sui dati diuna tabella, è necessario dapprima:
• aprire il database cui la tabellaappartiene, mediante il comandoAPRI del menu FILE o direttamen-te dalla maschera iniziale, dopoaver avviato l’applicazione;
• aprire la tabella, selezionandoladalla finestra del database e pre-mendo il pulsante APRI, oppurefacendo doppio clic sull’icona rela-tiva alla tabella stessa.
La tabella viene visualizzata in moda-lità FOGLIO DATI ed è possibile effet-tuare correzioni o cancellazioni delcontenuto di singoli campi semplice-mente posizionandosi sui dati edeffettuando le opportune digitazioni.Se il record sul quale si devono effet-tuare le modifiche non è visualizzato,si procederà con la navigazione all’in-terno della tabella come precedente-mente illustrato.La navigazione è inoltre facilitata, inmodalità FOGLIO DATI, dalle opzio-ni del comando VAI A del menuMODIFICA:
• PRIMO;• ULTIMO;• SUCCESSIVO;• PRECEDENTE;• NUOVO RECORD.
È anche possibile effettuare unaricerca all’interno dei campi dellatabella mediante il comandoTROVA, sempre del menu MODIFI-CA, inserendo il testo da cercare e ilcampo della tabella all’interno delquale effettuare la ricerca, che puòessere svolta:
• per campo intero, cioè la stringacercata e il contenuto del campodevono coincidere esattamente;
• per parte del campo, quindi è suf-ficiente che il contenuto delcampo contenga la stringa cerca-ta;
• per inizio campo, ovvero il conte-nuto del campo deve iniziare conla stringa cercata, ma può essereanche più esteso.
Le modifiche possono essere effet-tuate con il comando SOSTITUISCI,che funziona alla stregua delcomando TROVA, ma consente disostituire alla stringa cercata unanuova sequenza di caratteri. Ci sonodue opzioni particolarmente interes-santi:
scorrimento orizzontale dei campidella tabella: in questo caso utiliz-ziamo il comando BLOCCACOLONNE;
• inoltre, per rendere di nuovo mobi-li le colonne, utilizziamo il coman-do SBLOCCA TUTTE LE COLON-NE, che annulla l’effetto delcomando BLOCCA.
Per quanto riguarda le modifiche alleproprietà dei campi della tabella,possiamo operare anche in questocaso in modalità STRUTTURA oFOGLIO DATI.In modalità FOGLIO DATI, possiamomodificare il nome del campo,mediante il comando RINOMINACOLONNA del menu FORMATOpossiamo variarne l’ampiezza, etc. Ilsistema procede alla modifica eaggiorna il dizionario dei dati, permantenere la congruenza del data-base, ovvero la sua coerenza interna,soprattutto nel caso in cui altri ogget-ti utilizzino il campo modificato. Peroperare sulle proprietà dei campi,invece, è opportuno lavorare inmodalità STRUTTURA.La modifica avviene semplicementecambiando le impostazioni preesi-stenti. Il sistema, però, nel momentoin cui decidiamo di rendere perma-nenti tali modifiche memorizzandolenel database, effettua un controlloper verificare che:
• la modifica non comporti una pos-sibile perdita di dati;
• la modifica non comporti una per-dita di congruenza del database.
In entrambi i casi, il sistema ci avver-te del “pericolo”; sta all’utente deci-dere se la modifica va effettuataugualmente o meno.
AGGIORNARE UN DATABASELa modifica può avvenire su singolicampi o su uno o più record del data-base. Le operazioni di modifica cheora andiamo a illustrare riguardano
rubriche
rubriche
usciamo premendo sul pulsante dichiusura e il sistema automaticamen-te effettua il salvataggio dei dati.Inoltre, se per la tabella è stata defini-ta una chiave primaria, i record inseri-ti saranno automaticamente ordinatisecondo tale criterio.
Per cancellare un record,è sufficiente selezionare ilrecord con il mouse epremere il tasto CANC.Lo stesso risultato si può
ottenere mediante:
• il comando SELEZIONA RECORDdel menu MODIFICA;• il comando ELIMINA RECORDsempre dello stesso menu.
Si possono anche cancellare piùrecord, purché siano consecutivi epossano così esse selezionatiassieme.
• con SOSTITUISCI, il sistema effet-tua l’aggiornamento solo sul primocampo della tabella che rispondealle condizioni della ricerca;
• con SOSTITUISCI TUTTO, invece,l’aggiornamento avviene automati-camente su tutti i campi dellatabella che rispondono ai requisitiimpostati.
Se vogliamo operare a livello di interorecord, possiamo aggiungere nuovirecord in fondo alla tabella medianteil comando IMMISSIONE DATI delmenu RECORD: compare allora unagriglia predisposta per l’inserimentodi nuovi dati.Possiamo inserire quanti record desi-deriamo, al termine delle operazioni
Electronic shop 18
rubriche
Ricevitore per filodiffusioneMi hanno portato da ripa-
rare un ricevitore per filodif-
fusione sul quale risulta
interrotto il primario del
trasformatore d’ingresso,
probabilmente danneggiato
da una extratensione rac-
colta dalla linea telefonica
nel corso di un temporale
estivo. Questo trasformatore
è molto compatto ed ap-
pare chiaramente costruito
con una macchina automa-
tica ed il mio tentativo di
smontarlo per verificare la
possibilità di ripararlo ha
provocato lo sbriciolamento
del nucleo ad olla che lo
conteneva con conseguente
annullamento di ogni possi-
bilità di rifacimento. Essen-
dosi rivelati vani tutti i ten-
tativi di trovarne uno di
ricambio presso i miei abi-
tuali fornitori chiedo a voi se
potete indicarmi qualcuno
che ne abbia oppure se esi-
ste la possibilità di far fun-
zionare l’apparecchio anche
in mancanza del suddetto
trasformatore.
M.S. Roma
Il guasto da lei segnalato ètipico dei ricevitori per filo-diffusione. Durante i tem-porali è normale che le lineetelefoniche raccolgano delleextratensioni generate daifulmini che cadono neipressi di esse o addiritturasu di esse. Fortunatamentela maggior parte di questeextratensioni vengono neu-tralizzate dai dispositivi di si-curezza e solo una minimaparte di esse riesce a provo-care danni agli apparecchiconnessi. Nel suo caso ildanno è limitato al trasfor-matore d’ingresso che peròrisulta di non facile reperibi-lità come un po’ tutti i ri-cambi per i filodiffusori. Perposta le abbiamo mandatoun indirizzo al quale potràrivolgersi per trovare il tra-sformatore di ricambio, uni-tamente allo schema di unsemplice circuito che potràutilizzare in sua sostituzionenel caso anche questo forni-tore ne fosse sprovvisto.
Carlo Pria
False radio d’epocaUn mio cliente mi ha por-
tato per riparazione una
Radiobalilla da lui recente-
mente acquistata in una
delle tante fiere dell’elettro-
nica che si tengono nella no-
stra zona. Non appena tolto
il telaio dal mobile mi sono
accorto che si trattava di un
riproduzione ottenuta utiliz-
zando il telaio di un modello
similare oppurtunamente ri-
toccato. Anche il mobile mi
sembra rifatto anche se bene
e ben invecchiato. Il cliente
da me interpellato mi ha
detto avere acquistato l’ap-
parecchio per originale e di
non essersi accorto di nulla.
Ovviamente non è contento
di essere stato preso in giro
ed intende prendere provve-
dimenti anche per recupe-
rare la considerevole somma
dal lui sborsata per l’acqui-
sto ed assolutamente non
giustificata per una riprodu-
zione per quanto ben fatta.
Per questo ha chiesto il mio
appoggio oltre che la mia
consulenza ed io chiedo a
voi consiglio su cosa fare per
tutelare in un caso come
questo per rimediare al
danno subito. Vi chiedo an-
che se siete disposti a fornirci
aiuto e consulenza.
F.R.Brisighella
ercato dei falsi nel settoredelle radio d’epoca ha or-mai raggiunto livelli elevatis-simi e tali da rappresentareun pericolo per il correttofunzionamento di questosettore collezionistico. Que-sto fenomeno interessa or-mai tutte le marche ed imodelli più ricercati ed i casicome il suo stanno diven-tando pericolasamente fre-quenti. Per porre rimedio aldanno, se il venditore nonha chiaramente specificatoche si trattava di una re-plica, non resta che citare ingiudizio lo stesso chiedendoil rimborso di quanto pa-gato. Per le pratiche legaliconviene ovviamente sen-tire un avvocato mentre perparte nostra possiamo for-nire l’eventuale consulenzatecnica.
Carlo Pria
Il sito Internet di FESalve a tutti, sono a dir
poco ansioso di trovarvi
sul web a breve, anche se
immagino l'impegno neces-
sario per poter offrire un
servizio al passo con i tempi
sia grande . Sono affezio-
nato alla Vs rivista da sem-
pre e la scoperta del sito mi
ha fatto saltare di gioia,
purtroppo non ho riscon-
trato una così grande utilità
tra le sue pagine (link a
parte), sono rimasto in
attesa di qualche cambia-
mento che ora finalmente
sembra arrivare. Credo Vi
interessi sapere cosa mi
aspetto dal nuovo sito:
rubriche
Dubbi, perplessità, malfunzionamenti,
opinioni, commenti o delazioni?
Inviateli a:
Mailbox - Redazione di Fare Elettronica,Via Matteotti, 8 28043 Bellinzago (NO)
o anche a: [email protected]
Le lettere più utili a tutti e i commenti più
interessanti verranno pubblicati in queste
pagine. Per quanto possibile, inoltre,
cercheremo di dare una risposta privata a
chiunque ci scriverà via email.mail
box
RUBRICHE88
rubriche
• Spero di trovare unaraccolta dei progetti pub-blicati sui vecchi numeri.
• Proposta di progetti nontroppo conditi da uPpre-programmati daacquistare forzatamente.
• Vendere prodotti pronti edeventualmente renderedisponibile il software disupporto o i listati gratui-tamente.
• NIENTE BANNER PUBBLI-CITARI invadenti e pop-upa tradimento.
• Sezione dedicati ai siti nontroppo commerciali.
• Bacheca su cui renderedisponibile i propri lavorio le proprie conoscenze atitolo gratuito. Approfon-dimenti sui motori passo-passo.
Questo è ciò che mi è venutoin mente al "volo" e perso-nalmente sarei disposto apagare cifre (molto) popo-lari per un buon servizio eper una proficua naviga-zione alla ricerca di infor-mazioni. L'entusiasmo e lapazienza non mancano, hoaspettato un sito "definitivo"da molto tempo, il Vostropotrebbe essere quello cherisolve la questione unavolta per tutte. Confido divederVi presto a regime e dipoterVi inserire comepagina iniziale. In boccaal lupo.
Marco
Innanzi tutto per i tuoi pre-ziosi consigli. Sono consa-pevole del fatto che il sitoweb di Fare Elettronica siastato annunciato più voltecome disponibile ma, in ef-fetti, non e’ mai andato online. Questa volta però cisiamo sul serio, anzi,
quando leggerai questa let-tera molto probabilmentesarà disponibile.Il sito di FE e’ stato pensatoe realizzato come “puntod’incontro” per tutti I lettorie gli appassionati d’elettro-nica, non solo come un in-sieme di pagine statiche daconsultare. Al suo internotroverete un forum dovepotrete discutere d’argo-menti vari e magari ricevereaiuto nelle vostre realizza-zioni, una sezione di down-load dove scaricare tutti I fi-les che accompagnano iprogetti presentati nella rivi-sta, una sezione per i vostriannunci, una sezione conte-nente i link ai siti d’elettro-nica più interessanti, le fiered’elettronica dell’anno incorso ed una bacheca con-tenente tutti i progetti in-viati dai lettori. Chiara-mente non mancherà la se-zione dedicata alla rivistadove troverete l’indice com-pleto degli articoli e dovepotrete acquistare libri edarretrati. Infine la sezionedelle news e la possibilità disottoscrivere la nostra news-letter (che vi terrà informatiriguardo al sito e la rivista),completano la struttura diquello che speriamo diventiil vostro sito d’elettronicapreferito.
Tiziano [email protected]
Consigli sulla rivistaSul numero di Dicembrenella pagina “Parlia-mone…” é apparso unbreve discorso da, me lettocon grande interesse, che miha fatto capire perché leuscite degli ultimi mesi fos-sero un po’ povere di conte-
nuti. Con l’occasione porgoal vostro collaboratore edamico Angelo l’augurio diuna pronta guarigione.Sono un vostro lettore dapiù di dieci anni e nonperdo neanche un numerodi FE. Spero che con l’arrivodel nuovo anno, FE ritorniad essere quella rivista perla quale mi sono entusia-smato tanti numeri or sono.A mio parere, dovreste per-mettere anche a chi ha pocaesperienza, soprattutto coni microcontrollori, di vedereil programma com’é com-posto e quali modifiche sipossono apportare per mi-gliorarlo, poi non dare mainiente di scontato perché illettore non può conosceresempre tutto. Pensate che ilettori del domani sonoquelli che oggi hanno 13-14anni, quindi bisogna darloro la possibilità di vedere ilmondo dell’elettronica inmaniera diversa (non tuttain KIT). Un altro argomentoda trattare potrebbe essere iconcorsi di ROBOT, conmagari la possibilità dicostruirne uno in base alleproprie esigenze. Lo specialeMHz, a mio parere, e’ moltointeressante spero che loportiate avanti così comeavete fatto fino ad ora. Inogni caso ci sarebbero tantealtre idee, io ne ho indicatealcune, spero che altri lettorifacciano lo stesso.Finisco augurandovi un INBOCCA AL LUPO enorme.
Marco
Grazie mille per gli auguridiretti ad Angelo Cattaneoche, di fatto, non e’ un col-laboratore ma il direttore diFare Elettronica. Proprio
perché e’ venuta a mancarela sua insostituibile figura,che Fare Elettronica ha at-traversato un periodo diffi-cile e come te anche altrilettori se ne sono accorti. Ilmio contributo alla rivista,con l’incarico di direttoretecnico, e’ volto a riorganiz-zarne la struttura in mododa renderne I contenuti piùvicini alle vostre esigenze.Sono d’accordo con tequando affermi che moltigiovani lettori stanno muo-vendo I primi passi nelmondo dell’elettronica, perquesto, come avrete potutonotare già dal numero diGennaio 2003, abbiamodato a FE un taglio di tipoeducativo, lasciando spaziosia agli articoli mirati allarealizzazione di un kit chealla pura teoria. In merito alfatto di pubblicare il codicesorgente dei progetti a mi-crocontrollore, dovete te-nere conto che alcune voltesono protetti da copyright,quindi non possono esserepubblicati, ma se possibilesicuramente lo faremo. Giànel prossimo numero pre-senteremo due progetti,con il PIC16F84, completidi codice sorgente. Infinestiamo seriamente valu-tando la possibilità di dedi-care una piccola sezionedella rivista alla robotica, unpo’ come la rubrica MHz,includendo progetti e tuto-rial sull’argomento. FareElettronica sta cambiandocercando di incontrare sem-pre più i vostri gusti, perquesto commenti come ituoi sono per noi vera-mente preziosi.
Tiziano [email protected]
RUBRICHE 89
TUTTE LE FIERE 2003
TOP PROJECT:speciale antenne
OLD RADIO: i primi passidella modulazionedi frequenza in Italia
TOP PROJECT92
ANTENNE PER ALTE EALTISSIME FREQUENZEANTENNE PER ALTE EALTISSIME FREQUENZEdi Giuseppe [email protected]
Già in passato sono state citate varie possibilità di raggruppamento di antenne sullepagine di questa stessa rivista. Essendo un argomento di grande interesse per gliappassionati di radiantistica abbiamo deciso di presentarvi, questo mese, tutte quelleantenne che hanno il loro campo di applicazione nelle frequenze alte e molto alte.In questa prima parte parleremo in predominanza delle antenne Yagi e delle variepossibilità di guadagno a seconda degli elementi.
Tutti gli appassionati di questa parti-colare materia sanno già che laregione delle frequenze molto altecomincia verso i 30 MHz per arriva-re ai 300 MHz; mentre, le frequenzeultra alte, corrispondono alla fasciache va tra i 300 MHz e i 3.000 MHz.Poiché le misure fisiche delle anten-ne sono inversamente proporzionalialla frequenza, è possibile realizzareun nuovo studio di queste finaliz-zandolo, all’interno delle bandecitate, a delle dimensioni realizzabi-li, cosa che nelle altre gamme di fre-quenza risulta difficile da ottenere ecostruire meccanicamente. D’altraparte, molti dei modelli di base delleantenne utilizzate in HF possonoanche essere utilizzati per la VHF eper l’UHF, con le opportune modifi-che, e questo è il fine di questo spe-ciale antenne che presentiamo inquesto numero.
ASPETTI GENERALISono molti i radioamatori che sicostruiscono le loro antenne peroperare in queste gamme di fre-
quenza; altri, invece, le acquistano,ma tutti convengono su un punto:in nessuno dei due casi hanno a lorodisposizione una antenna ottimaleche permetta loro di lavorare sullediverse modulazioni che queste fre-quenze consentono, e che non èpossible conseguire contempora-neamente in una sola antenna unelevato guadagno, una bassa diretti-vità, la polarizzazione nei due sensi,una buona larghezza di banda, ecc.,perché ciascun modello di antennasoddisfa solo alcune di queste carat-teristiche a scapito delle altre. È nello spirito del radioamatorecompilare sempre una lista dellecaratteristiche prioritarie che richie-de a una antenna, per trovare, tra lediverse a disposizione in commer-cio, quella che maggiormente losoddisfa. Nel progettare l’antennadi cui si ha necessità, bisogna consi-derare la grandezza della stessa; unaantenna a 144 MHz capta il 66% dienergia in più rispetto a qualsiasiantenna progettata per i 432 MHz,pur avendo entrambe lo stesso gua-
dagno. Pertanto, per ottenere lostesso rendimento sui 432 MHz,occorrerà moltiplicare per tre ilnumero degli elementi che com-pongono una antenna per i 144MHz. In fase costruttiva è, comun-que, sempre opportuno montarequalche elemento in più, questo,per supplire agli altri effetti. Il gua-dagno dell’antenna è rapportato aldiagramma d’irradiazione; quantopiù concentrata è l’energia versouna determinata direzione, maggio-re sarà il guadagno dell’antenna. L’antenna isotropica irradia nellostesso modo in tutte le direzioni,ragione per cui un dipolo fornisce sudi questa un guadagno di 2,1 dB;per ottenere valori di guadagnosuperiori rispetto al dipolo, possonoessere utilizzate antenne di tipolineare, Yagi, ecc. Al radioamatoreche si dedica al CB in queste fre-quenze, interessa ottenere un altoguadagno, e un angolo di irradia-zione basso, mentre se si desiderauna antenna per realizzare il QSO abreve distanza, è preferibile utilizza-
TOP PROJECT
prima parte
TOP PROJECT 93
TOP PROJECT
poiché con la polarizzazione vertica-le si ricevono più rumori e interfe-renze. Nonostante ciò, le antennecon polarizzazione verticale sonopiù semplici per l’irradiazione omni-direzionale. Anche se la linea apertalimita notevolmente le perdite, lasua realizzazione risulta molto com-plessa, per via del fatto che ha I con-duttori molto grossi e poco separatitra di loro, per evitare l’irradiazione.Inoltre, bisogna evitare di realizzareangoli molto bruschi, e porre lalinea nelle vicinanze di oggettimetallici. Molte volte i risultati che siottengono compensano tutte que-ste attenzioni, poichè i valori di per-dita che ne risultano sono moltomolto piccoli, ed equivalgono almiglior coassiale. Per esempio 30metri di linea realizzata con rame di2 mm di diametro, separata di circa19 mm con un buon isolatore(teflon), presenta, alla frequenza di144 MHz, delle perdite di 1 dB, eper I 432 Mhz, di 1 o 2 dB. Bisognaevitare di utilizzare cavi coassiali dipiccolo diametro, come potrebberoessere i cavi RG58U o RG59U, tran-ne che per la realizzazione di lineemolto brevi; cavi del tipo RG8 eRG11 possono essere utilizzati finoai 15 o 20 metri, pur sapendo disubire delle perdite notevoli.Attualmente, esistono cavi coassiali
speciali, con isolamento semiaereo,che presentano in queste frequenzeperdite molto basse per notevolidistanze.
ANTENNE YAGY PER I 144 MHZSono molte le possibili combinazio-ni per ottenere una antenna di que-sto tipo; dal variarne il numero deglielementi, fino al modificarne lacostituzione fisica, il suo adattamen-to alla linea, lo spaziamento tra glielementi, le dimensioni, ecc.Malgrado l’antenna Yagi abbia unnumero inferiore di elementi (alMassimo cinque), le equazioni clas-siche per il calcolo della loro lun-ghezza sono sufficienti per ottenereuna antenna che forse non saràquella ottimale, ma il cui risultatocoinciderà con quello che si era cal-colato. A partire da questo numerodi elementi, è molto difficile che unaantenna progettata secondo certerelazioni determinate fornisca unrendimento ottimo, e, normalmen-te, si regolano sperimentalmente inbase alle misurazioni effettuate perciascun caso reale.
ANTENNE A TRE ELEMENTICome si è visto in precedenza, l’an-tenna Yagi a tre elementi si proget-ta partendo dale tre equazioni pre-senti in Formula 1.
re una antenna omnidirezionale,malgrado si ricevano maggiori dis-turbi e interferenze. È inoltre moltointeressante per il radioamatore,conoscere la larghezza di banda del-l’antenna, poiché per alcuni sonosufficienti pochi Khertz, mentre altridesiderano spaziare su tutta labanda; nella banda dei 2 metri sono2 MHz, ma nella banda dei 70 cmrisultano 10 MHz, e risulta realmen-te difficile ottenere una antenna conuna risposta piana per tutta labanda. La Larghezza fisica del dipo-lo per queste frequenze risulta deci-samente ridotta, in quanto è possi-ble aumentare il suo diametro perottenere caratteristiche di bandalarga. Anche l’altezza rispetto al ter-reno influisce sul rendimento di unaantenna, ma se si ha a disposizioneuno spazio libero, è sufficiente unaminima altezza; viceversa, bisogne-rebbe ricorrere a differenze notevolidi altezza per ottenere un effettoapprezzabile. Un’alto fattore moltoimportante è la polarizzazione;attualmente questo concetto è statosufficientemente ben definito per lediverse applicazioni all’interno diquesta banda, ed è consigliabileseguire dette indicazioni, poichè sesi opera con un corrispondente cheutilizza un diverso tipo di polazza-zione, si può avere una perdita di 21o di più dB. La parte inferiore delprimo Mhertz della banda dei duemetri, viene utilizzato nel BP, nor-malmente con polarizzazione oriz-zontale, per via della maggior facili-tà di installazione per grandi gruppidi antenne di tipo Yagi; praticamen-te non si hanno vantaggi nell’utiliz-zare altri tipi di polarizzazione percomunicazioni a lunga distanza.Viceversa, nel secondo Mhertz (da145 a 146 Mhz), si utilizza prevalen-temente la polarizzazione verticale,soprattutto per le automobili e Iripetitori, malgrado che per brevitragitti si ottengano segnali miglioricon la polarizzazione orizzontale,
Antenna Yagi a tre elementi. Figura 1
TOP PROJECT94
TOP PROJECT
Come nel caso delle frequenze nor-mali, è necessario fissare la separa-zione tra gli elementi, che risultaessere, nel caso da noi preso inesame, di 0,15 volte la lunghezzad’onda (vedere Figura 1).
ANTENNA A QUATTRO ELEMENTIIn questo caso, le equazioni chedefiniscono le rispettive lunghezzein funzione della frequenza sonoquelle che si riportano in Formula 2.Per quello che riguarda le separazio-ne tra gli elementi che costituisconol’antenna, risulta essere di 0,15 volte
la lunghezza d’onda per ciascuno diloro (vedere Figura 2).
ANTENNE A CINQUE O PIU’ELEMENTISe alle antenne a quattro elementi siaggiunge un terzo elemento diretti-vo, la cui lunghezza risulti pari a120/f, separato dal secondo diretto-re di 0,2 volte la lunghezza di que-sto elemento a 130/f, si ottengonodelle antenne Yagi a cinque elemen-ti (vedere Figura 3).Se si utilizza per i tre tipi di antennesinora analizzate (a tre, quattro, ecinque elementi) un dipolo piegato
di ugual diametro in tutta la suaestensione, sarà possibile alimentar-le tutte con un cavo coassiale da 75Ω. Con la relazione L = 124/ƒ è pos-sible progettare antenne fino a ventielementi, calcolandone la lunghezzadi tutti i direttori, e mantenendo peril dipolo e il riflettore la stessa lar-ghezza dei casi precedenti. La separazione tra gli elementi inquesto caso, sono di 0,15 λ daldipolo al primo direttore, di 0,18 λdal primo al secondo direttore, e apartire da questo si pongono tutti isuccessivi a una distanza 0,24 λ,tranne l’ultimo, che viene separatodi 0,30 λ. L’impedenza di un dipolosemplice va dai 30 ai 40 ohm, ed ilgrande vantaggio di questo tipo diantenna è proprio quello di poteraggiungere o togliere elementi,senza che l’impedenza subisca dellevariazioni sensibili. Il guadagno diquesta antenna è compreso tra i 12e I 18 dB, partendo da 10 elementifino ai 20. Nella Figura 5 viene pre-sentata una entenna Yagi a tre ele-menti con una impedenza di 300 Ω;il suo guadagno è di 5 dB e il suorapporto anteriore-posteriore è di15 dB. Nella Figura 6 successiva, èillustrata una antenna a quattro ele-menti con accoppiamento gammamach, che ne permette l’alimenta-zione con cavo coassiale da 75 Ω.Gli elementi dell’antenna sono rea-lizzati con tubo da 6 a 10 mm didiametro, presenta un guadagno di± 7 dB, e l’apertura dei lobi d’irra-diazione orizzondale e verticale èrispettivamente di 65° e 75°. Nell’antenna a sei elementi riportatain Figura 7, tutti i direttori hanno lastessa lunghezza, e presentano unaimpedenza di 75 Ω simmetrici, checostringe ad inserire nel circuito untrasformatore con rapporto 1:1 perle discese coassiali, con passo dasimmetrico ad asimmetrico. Il gua-dagno di questa antenna è di circa8,5 dB; l’angolo del lobo orizzonda-le è di 55°, e 70 ° quello del lobo
Figura 3 Antenna Yagi a cinque elementi.
TOP PROJECT 95
verticale; gli elementi sono costruiticon tubi o stilo da 5 a 8 mm di dia-metro. Proseguendo con le antennea direttori di ugual lunghezza, nellaFigura 8 è riportata un’antenna chefornisce 10 dB di guadagno con 9elementi, e una relazione anteriore-posteriore di 15 dB, con angolo dellobo di irradiazione orizzontale di48° e di quello verticale di 58° (manmano che il guadagno aumenta, gliangoli dei lobi d’irradiazione vannorestringendosi, poiché l’energia risul-ta più concentrata).Gli elementi di questa antenna sonocalcolati con un diametro compresotra 10 e 20 mm; la loro impedenzaè di circa 240 Ω. Una antenna a 11elementi e guadagno di 12 dB,come quella presentata in Figura 9,copre in modo ottimale la gammada 142 a 148 MHz; il diametro deglielementi è di 12 mm; l’impedenza èdi 240 Ω e il lobo di irradiazioneorizzontale è di 38°, mentre quelloverticale è di 42°.
CONSIDERAZIONI PRATICHESULLE ANTENNE YAGI A 144MHZTutte queste antenne possono esse-re completamente metalliche, e iloro elementi possono essere fabbri-
TOP PROJECT
Antenna Yagi da 10 a 20 elementi. Figura 4
Dimensioni di una antenna Yagi a tre elementi. Figura 5
Figura 6Antenna Yagi a quattro elementi con adattamento di gamma per una linea coassiale da 75 Ω.
Il condensatore variabile ha una capacità da 3 a 50 pF.
TOP PROJECT96
te; l’unione di questi con la lineadeve essere effettuata con moltacura. Se possibile, è opportunoeffettuare l’unione tramite delle sal-dature, tenendo presente che, se nelrealizzare la connessione si utilizza-no metalli diversi (per esempio allu-minio e rame), con l’umidità dannoorigine ad un accoppiamento galva-nico, che con il passare del tempoorigina fenomeni di corrosione cheinfluenzano la conduttività dellaconnessione.È inoltre consigliabile proteggere
questa connessione dalle intempe-rie; nel caso si utilizzino condensato-ri o trasformatori di impedenza, saràopportuno proteggerli dall’umidità,dalla polvere, ecc. Attualmente sonodisponibili degli ottimi materiali iso-lanti con alto potere dielettrico, checonsentono di realizzare questeopportune protezioni.Il supporto metallico degli elementipuò essere di qualsiasi materiale, dalsemplice legno, al ferro e all’allumi-nio. Normalmente per antennemolto grosse si utilizza tubo diduralluminio, che permette, conpiccole sezioni (20x20), una buonarigidità. Nel caso ci siano problemidi flessione, si utilizzano dei tendito-ri o degli estensori, poiché perantenne di sei o più metri si dovreb-be utilizzare un tubo di supporto diconsiderevole diametro e, quindi,influenzerebbe notevolmente il lororapporto con la lunghezza d’onda.
ACCOPPIAMENTO DI ANTENNEAnche se teoricamente risulta possi-bile procedere aumentando ilnumero degli elementi di unaantenna Yagi, è evidente che si arri-va ad un punto in cui un ulterioreaumento del numero dei direttoridiventa complesso per via dei pro-
TOP PROJECT
cati con tubi di alluminio, latta orame. Per via delle loro dimensioni(approssimativamente un metro),vengono supportate nel loro centroe non necessitano di appoggi alleestremità; il punto medio degli ele-menti è a zero come valore di ten-sione, per cui possono essere colle-gati direttamente a massa.Una precauzione da prendere rispet-to agli isolanti che si utilizzano nellarealizzazione dei dipoli, è che devo-no essere di ottima qualità (altopotere dielettrico) per evitare perdi-
Dimensioni dell’antenna Yagi a sei elementi per una discesa a 75 Ω.Figura 7
Antenna Yagi a 11 elementi. Il guadagno è di 12 dB, e le misure sono espresse in millimetri.Figura 9
Antenna Yagi a 9 elementi. Il guadagno è di 10 dB, e le misure sono espresse in millimetri.Figura 8
TOP PROJECT 97
blemi meccanici (lunghezza del-l’antenna), ed elettrici (supportomolto grosso in rapporto alla lun-ghezza d’onda e agli stessi elemen-ti) che si presenterebbero. Quandoè necessario, si pongono due o piùantenne in parellelo per ottenereguadagni più elevati, partendo dalpresupposto che, raddoppiandoun’antenna si ottiene un aumentodel guadagno di quasi 3 dB (2,8dB), ossia, che se si ha un’antennadi 10 dB di guadagno, posizionan-do due antenne convenientementeaccoppiate, si otterranno 13 dB. Sesi installano due antenne in più(quattro in totale) di 10 dB ciascu-na, si otterrà un guadagno totalepari a 10 + 3 + 3= 16 dB; volendonuovamente raddoppiare il nume-ro delle antenne, si raggiungerà unguadagno di 16 + 3= 19 dB. Peraccoppiare due o più antenne auna sola discesa, occorre tener pre-sente la fase, l’impedenza e laseparazione. Nel riferirci alla fase siricorda che tutte le antenne delgruppo ricevono un’onda in fase, ela corrente circola in tutte nellostesso verso; pertanto, dovrannoessere connesse in modo tale chele correnti si sommino. Nel caso di connessioni simmetri-
che, tutti i conduttori centrali deicoassiali andranno sullo stesso latodei dipoli, poiché in caso contrariole correnti si sottrarrebbero e, inve-ce di aumentare il guadagno, man-cherebbe la trasmissione o la rice-zione. Nell’accoppiare più anten-ne, è conveniente ricordare l’equa-zione delle resistenze in parallelo, iprincipi e le equazioni degli adat-tatori a un quarto di onda e i lobid’irradiazione delle antenne.Il caso più semplice di accoppia-mento è quello di due antennesovrapposte, con il quale di otten-gono 3 dB o più di guadagnorispetto ad una sola. Questo guadagno si ottiene con lariduzione del lobo verticale; il loboorizzontale non subisce variazionirispetto a quello che si avrebbecon una sola antenna. Per questonumero è tutto, il prossimo mesefiniremo la trattazione sulle anten-ne parlando degli accoppiamentipossibili tra loro e del migliormodo per ottimizzare la resa.
TOP PROJECT
Electronic shop 19
Figura 10Messa in fase di quattro antenne,
per ottenerne l’accoppiamento.
Figura 11
Figura 13
Accoppiamento di due antennesovrapposte.
Figura 12Accoppiamento di due antenne con
discesa della stessa impedenza.
Accoppiamento di quattro antenne Yagi con linee aperte.
I PRIMI PASSI DELLA MODULAZIONE DI FREQUENZA IN ITALIA
OLD RADIO98
I PRIMI PASSI DELLA MODULAZIONE DI FREQUENZA IN ITALIAdi Carlo [email protected]
Sono passati ormai cinquantadue annidall’inizio ufficiale delle trasmissioni radio inmodulazione di frequenza da parte della RAI,allora unico ente autorizzato ad irradiare pro-grammi destinati al pubblico generico. I primiesperimenti di radiotrasmissioni con questo nuovotipo di modulazione che consentiva di raggiungereuna fedeltà musicale impensabile con i sistemi prece-denti, risalivano agli anni immediatamente precedentil’inizio della seconda guerra mondiale e furono daquesta interrotti per poi essere ripresi fra il 1947 ed il 1948.
A partire da questi anni tutte le indu-strie radiotecniche, italiane e stranie-re, avevano iniziato a progettare eda produrre ricevitori dotati di questanuova gamma, anche se in quantitàtrascurabili rispetto a quelle dei nor-mali apparecchi in modulazione diampiezza allora normalmente in uso. Negli anni immediatamente succes-sivi alla guerra e nonostante le diffi-coltà del momento, la vendita deiradioricevitori aveva avuto una note-vole espansione ed il mercato erapieno di apparecchi di recentecostruzione che difficilmente sareb-bero stati sostituiti con altri nuovidopo così breve tempo dal loroacquisto e questo riduceva lo spaziocommerciale dei nuovi ricevitori
dotati di modulazione di frequenza.Per ovviare a questo inconvenientemolti produttori misero in commer-cio dei sintonizzatori che consentiva-no di utilizzare il vecchio apparec-chio radio per ricevere la nuovagamma. Si trattava in pratica di rice-vitori privi della sezione di bassa fre-quenza la cui funzione veniva svoltada quella di un normale ricevitore alquale il sintonizzatore veniva colle-gato tramite la presa fono in origineprevista per il collegamento di ungiradischi. In questo modo si mette-va a disposizione della potenzialeclientela un dispositivo che aveva uncosto ridotto rispetto ad un apparec-chio completo e si sperava così diaumentare i volumi di vendita.
Nella realtà le cose non andarononella direzione sperata, un po’ per-ché il risparmio ottenuto con questidispositivi non era molto significati-vo, ed un po’ per la diffidenza delpubblico verso questo nuovo meto-do di trasmissione che oltretuttoall’epoca funzionava solo per pocheore al giorno. Fu così che la vendita di questi sinto-nizzatori rimase limitata a pochissimiesemplari che rappresentano oggiun ghiotto oggetto per i radiocolle-zionisti oltre che una interessantetestimonianza storica dell’evoluzionetecnica del settore radiofonico com-merciale. Approfittiamo della richiesta di infor-mazioni fattaci da un nostro lettore e
OLD RADIO
OLD RADIO 99
OLD RADIO
ma elettrico è racchiuso da una pun-teggiata, nella vista inferiore dellochassis di Fig. 2 chiaramente visibilea destra. Esso comprende, oltre allabobine di accordo dei circuiti diantenna di radio frequenza e dell’o-scillatore, il relativo condensatorevariabile di sintonia, i trimmers etutto il circuito a radio frequenza. Ilsegnale è applicato a una presa abassa impedenza della bobina diantenna e dopo essere elevato dicirca 3 volte dal circuito risonante,viene applicato alla griglia dell’am-plificatrice 6BA6.Il circuito risonante di antenna èaccordato con una sezione del con-densatore variabile n. 2783, e lagamma coperta da tale circuito èregolata mediante un microcom-pensatore da 10 pF. e medianteregolazione del nucleo sulla bobina;entrambi questi organi sono accessi-bili dall’alto del telaio.La valvola 6BA6 è polarizzata con
una resistenza sul catodo di 100ohm, ed ha sul filamento una picco-la impedenza a radio frequenza edue condensatori di filtro in cerami-ca, per proteggerla dalla radio fre-quenza generata dall’oscillatore. Il circuito di placca di tale valvola èalimentato attraverso una impeden-za a radio frequenza ed è accoppiatacapacitivamente alla griglia della6BE6. Il circuito risonante di griglia della6BE6 è accordato mediante un’altrasezione del condensatore variabile n.2783 ed è regolabile semplicementemediante il nucleo sulla bobina,senza regolazione della capacità ,allo scopo di ridurre al minimo lacapacità residua di tale circuito; laconnessione alla griglia della 6BE6 èottenuta attraverso una resistenza dibasso valore che ha lo scopo di eli-minare le oscillazioni parassitarie afrequenze altissime. Il circuito dell’o-scillatore locale è inserito tra catodoe griglia oscillatrice della 6BE6 nelmodo convenzionale per tale tipo divalvola: ad evitare l’effetto nocivodella capacità tra filamento e catodo(instabilità di frequenza dell’oscilla-tore dovuta alla variazione di talecapacità) il filamento è collegatodirettamente al catodo ed è alimen-tato attraverso una piccola impeden-za a radio frequenza. Anche il circui-to dell’oscillatore viene regolatomediante un microcompensatore enucleo sulla bobina, e viene accorda-to mediante una sezione del con-densatore variabile n. 2783.L’alimentazione di placca e schermodella 6BA6 è ottenuta dal positivogenerale (+110V.) attraverso unaresistenza di disaccoppiamento e uncondensatore ceramico di by-pass.L’alimentazione di placca e schermodella 6BE6 è ottenuta dal positivogenerale dopo una seconda sezionedi filtro per ridurre ulteriormente ilronzio su tale valvola, e attraversouna resistenza di disaccoppiamentoe condensatore ceramico di by-pass.
riguardante proprio uno di qiesti sin-tonizzatori, per mettere a disposizio-ne di tutti gli appassionati le caratte-ristiche del Mod. G. 530 costruitodalla Geloso nel 1950.
IL CIRCUITO ELETTRICOLa Figura 1 rappresenta lo schemaelettrico del Sintonizzatore G. 530.Esso comprende 5 valvole del tipominiatura, e cioè:
• una 6BA6 = amplificatrice accordataa radio frequenza
• una 6BE6 = Convertitrice• una 6BA6 = 1° Amplificatrice di M.F.• una 6AU6 = 2° Amplificatrice di M.F.• una 6AL5 = Rivelatore discriminatore
di frequenza del tipo «Rivelatore arapporto»
La valvola amplificatrice a radio fre-quenza e la convertitrice sonoentrambe montate sul gruppo adalta frequenza 2693, che nello sche-
OLD RADIO100
OLD RADIO
Sul circuito anodico della convertitri-ce 6BE6 è inserito il primario delprimo trasformatore di M.F. a 10,7Mc (n. 2701 A), il cui secondario ali-menta la griglia della prima amplifi-catrice di M.F. 6BA6; sul ritorno digriglia di tale valvola è inserito il con-trollo automatico di sensibilità, chefornisce una piccola polarizzazionebase di circa 0,3 Volt. Tale valvola, adevitare reazioni catodiche, ha il cato-do direttamente collegato a massa. Segue attraverso un secondo trasfor-matore di M. F. 2701 A una secondaamplificatrice del tipo 6AU6. Questavalvola è ad amplificazione fissa(senza controllo automatico di sensi-bilità) allo scopo di fornire maggiorepotenza al discriminatore, ed è pola-rizzata sul catodo mediante una resi-stenza di 120 ohm ed un condensa-tore ceramico di by-pass. I due tra-sformatori di M.F. 2701 A sono statiperfezionati rispetto al precedentemodello 2701, apportando un sensi-bile aumento sia al guadagno comealla larghezza di banda. La 6AU6 èaccoppiata al discriminatore a rap-porto (ratio detector) mediante l’ap-posito trasformatore di media fre-quenza 2702/A a tre avvolgimenti.Tale trasformatore è fortemente indiscesa ed è il risultato di lungheprove tendenti a migliorare la linea-rità di rivelazione e la insensibilitàalla modulazione di ampiezza,man-tenendo una buona sensibilità eduna sufficiente larghezza di banda; irisultati ottenuti sono stati più chelusinghieri e perfettamente confron-tabili con quelli ottenuti con un dis-criminatore bilanciato del tipo classi-co Seeley-Forster, naturalmente colvantaggio della maggiore semplicitàed economia. Il circuito del rivelatore a rapportoimpiegato è del tipo bilanciatorispetto a massa, che fornisce certa-mente una migliore insensibilità allamodulazione di ampiezza; la tensio-ne continua rivelata è parzialmentestabilizzata mediante un condensa-Figura 1 Lo schema elettrico
OLD RADIO 101
OLD RADIO
tore elettrolitico da 10 µF. avente inserie una piccola resistenza da 1500ohm: la stabilizzazione parziale unitaalle caratteristiche del trasformatore2702/A permette un migliore bilan-ciamento e riduzione della modula-zione di ampiezza, il che significa lamassima insensibilità ai disturbi.Dal lato negativo del circuito di rive-lazione viene ricavata la tensione dicontrollo automatico di sensibilità,che viene inviata, attraverso una resi-stenza di 1 Megaohm, al ritorno digriglia della prima amplificatrice diM.F. 6BA6.Il segnale rivelato è inviato attraversoun circuito di deenfasi avente la
costante di tempo di 75 microsecon-di (corrispondente perciò alle carat-teristiche delle trasmissioni a modu-lazione di frequenza) al controllo divolume che è collegato al cavettoschermato di uscita. Il segnale abassa frequenza all’uscita del sinto-nizzatore è generalmente più chesufficiente per alimentare l’amplifica-tore di bassa frequenza di un norma-le ricevitore; esso fornisce infatti un’uscita di 0,2 V. efficaci con un segna-le di radio frequenza in antenna disoli 100µV., modulati al 100%.L’alimentazione anodica è ottenutamediante un rettificatore al selenio auna sola semionda, seguito da due
cellule di filtro. Dalla prima cellula èricavata l’alimentazione anodica e dischermo della 6BA6 amplificatrice aradio frequenza e della 6BU6 secon-da amplificatrice di media frequen-za, mentre l’amplificatrice 6BE6 e laprima valvola di media frequenza6BA6 che hanno bisogno di una ten-sione d’alimentazione maggiormen-te filtrata, sono alimentate dallaseconda cellula di filtro.
ALLINEAM. E MESSA A PUNTOLe operazioni di allineamento emessa a punto differiscono sensibil-mente a seconda degli strumenti adisposizione. L’allineamento miglio-re e più rapido si ottiene certamentemediante un generatore modulatodi frequenza e un oscilloscopio, peròè possibile ottenere un ottimo alli-neamento anche impiegando unnormale oscillatore modulato diampiezza e, come rivelatore, un nor-male tester a basso consumo, su unaportata di 2÷3 V. Servendoci di questi ultimi strumen-ti, l’oscillatore verrà usato normal-mente senza modulazione, il voltme-tro sarà inserito fra la massa e il pie-dino n.7 della 6AL5 in modo damisurare la tensione rettificata da undiodo. Il generatore dovrà esseresempre mantenuto con una uscitaridotta al minimo, per non far azio-nare il controllo automatico di sensi-bilità; in ogni operazione l’uscita delgeneratore sarà ridotta perciò inmodo che la tensione rettificata siacompresa tra 0,7 e 1 V. Tenere pre-sente che le viti di regolazione deiprimari dei trasformatori di mediafrequenza sono accessibili dal bassodello chassis. Nella tabella di taratu-ra sono riportate, nel giusto ordinedi successione, le operazioni neces-sarie ad effettuare l’allineamento. Durante la taratura della media fre-quenza, sarà bene bloccare l’oscilla-tore, mettendo in corto circuito, conun filo cortissimo, griglia e catododell’oscillatrice 6BE6; sarà bene inol-
Veduta dei collegamenti e degli organi interni col particolare del gruppo A.F. Figura 2
Il G. 530 F.M. visto dal retro con l’ubicazione degli organi di maggior mole. Figura 3
OLD RADIO102
OLD RADIO
ferro. Questo tipo di antenna saràcostituito da un filo isolato della lun-ghezza di circa mt. 1,40, collegato almorsetto antenna, e sarà dispostoorizzontalmente lungo una pareteche sia possibilmente perpendicolarealla direzione della stazione, o conun angolo non inferiore a 45 gradi.
Dipolo internoPer le distanze superiori a 8 ÷10 Km.o nei casi in cui il campo sia piùdebole potrà essere utilmente impie-gata un’antenna interna a V di cui vene sono in commercio diversi tipi.Queste antenne sono facilmenteorientabili essendo montate su unapiccola base da appoggiare sulmobile stesso dell’apparecchio, evengono collegate al ricevitoremediante uno spezzone di circa unmetro di piattina da 300 ohm.I due capi della piattina vanno colle-gati rispettivamente ai morsettiantenna – terra del sintonizzatore.Tale tipo di antenna è certamente ilpiù adatto ai casi generali e presentaanche il vantaggio , quando sia pos-
sibile ricevere più di una stazione, diessere facilmente orientabile nelladirezione della stazione che si vogliaricevere.
Antenna esternaNelle località molto lontane dallastazione trasmittente (da 50 a 100km.) o quando per condizioni localiil segnale arrivi molto debole, sarànecessaria l’installazione di un’an-tenna esterna. Questa sarà preferibilmente del tipoa dipolo ripiegato (folded dipole)che è l’antenna esterna più semplice,economica, di più facile installazionee che presenta una impedenza carat-teristica di circa 300 ohm; oppurenel caso di ricezione molto criticaun’antenna del tipo Yagi, che dovràessere costruita per un impedenza diuscita di circa 250/300 ohm.
tre non toccare la sintonia del gene-ratore, ad evitare, durante l’allinea-mento di tutta la M.F., una variazio-ne anche piccola di frequenza.
INSTALLAZIONE E ANTENNAL’antenna necessaria per il sintonizz-tore G. 530 F.M., può essere del tipopiù disparato a seconda della localitàin cui viene installato l’apparecchio edelle condizioni relative di ricezione,in relazione alla distanza della stazio-ne trasmittente e degli eventualiostacoli alla propagazione fra tra-smittente e ricevitore. Possiamo sud-dividere le antenne adattabili al sin-tonizzatore G. 530 F.M. in tre tipi:
Semplice filo di antennaQuesto tipo di antenna è certamen-te il più semplice ma è adatto solonei casi in cui il segnale in arrivo siamolto forte, cioè a una distanza dallastazione non superiore a 8 ÷10 Km.e in buona condizione di propaga-zione, cioè quando il ricevitore nonsia circondato da alti fabbricati incemento armato o con strutture in
Le tensioni sono misurate, tra massa e i puntiindicati, con Voltmetro 20.000 Ohm per Volt. I numeri a fianco dei nomi degli elettrodi indicano il numero del piedino corrispondente.Sintonia a 88 Mc., senza segnale in antenna.
Electronic shop 20
ANNATA 1998 DI FARE ELETTRINCA A. CATTANEO
Si tratta della raccolta di 11 numeri della rivista di elettronica pratica Fare Elettronica su CD-ROM. Nell’opera
sono compresi: • il sommario dettagliato di ogni numero; • tutti gli articoli riguardanti le realizzazioni pratiche,
le rubriche Linea diretta, Idee di progetto, Kit service e gli inserti di MHz; • tutte le illustrazioni con fotocolor,
scansioni dei circuiti stampati, esplosi, tabelle ed altro. Gli articoli sono completi come appaiono sulla rivista
originale con titoli, cappelli, disegni, elenchi componenti e così via...
cod. 20-CD01-02 - € 34,10
E.C.D.L. G. FILELLA
Un passaporto per il mondo del lavoro: la patente europea del computer. Questo testo costituisce una guida pratica alla
preparazione dei singoli esami per la Patente Europea del Computer (ECDL). Si articola in sette Moduli i cui contenuti
seguono la versione più aggiornata del Syllabus ECDL:
Modulo 1 - Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione; Modulo 2 - Usare il computer e gestire i file; Modulo 3 -
Elaborazione testi; Modulo 4 - Foglio elettronico; Modulo 5 - Le basi dati; Modulo 6 - strumenti di presentazione; Modulo 7 - Reti
informatiche. Alla fine di ogni modulo, il candidato può verificare il suo livello di preparazione grazie ad una serie di test sul
modello di quelli che dovrà affrontare durante le sette prove d’esame.
cod. E.C.D.L. - € 15,00
I volumi possono essere richiesti via lettera o fax a: DTP Studio Editrice S.r.l. - via Matteotti, 8 28043 Bellinzago (NO)
Tel. 0321/927287 - Fax 0321/927042 o via e-mail: [email protected] - La spedizione viene effettuata da Sandit srl
esclusivamente in contrassegno (spese di spedizione € 2,5).
TAGLIO LASER - Prontuario per il taglio dei metalli G. LUONI
Due parole per spiegare quali sono i contenuti di questo volume, peraltro ben anticipati dal titolo stesso, e
soprattutto i motivi che hanno portato alla sua realizzazione. Questo lavoro non vuole assolutamente avere la
pretesa di essere considerato un trattato sul taglio laser di materiali metallici, ma vuole essere un aiuto a tutti
coloro i quali utilizzano o desiderano utilizzare questa sorgente di energia. A fronte di questa impostazione, la
lettura e la consultazione di questo volume possono risultare utili ai progettisti, ai management di una azienda,
ai tecnici dei reparti di produzione, ma anche agli studenti dei corsi di indirizzo meccanico.
... per sapere di più
LabVIEW M. FERRARI e G. FILELLA
LabVIEW è un rivoluzionario ambiente di programmazione la cui struttura grafica ad oggetti consente di controllare
dei dispositivi esterni, siano essi strumenti commerciali o schede di interfaccia. Questo volume propone una serie
di moduli che consentono di approfondire gli aspetti teorici e applicativi correlati all’utilizzo di LabVIEW. Per
questo motivo tutti gli argomenti trattati sono corredati da esempi ed esercizi che hanno anche lo scopo di
evidenziare i possibili tranelli legati ad un tipo di programmazione non tradizionale. La scelta dei contenuti
è limitata agli aspetti fondamentali, indispensabili per iniziare ad affrontare un ambito di progetto rivolto ad
applicazioni di interesse reale. In tale ottica, i moduli della seconda parte del testo forniscono alcuni esempi
significativi che offrono un'idea anche delle possibilità di sviluppo in termini interdisciplinari.
cod. 20-1006-06 - € 17,50
cod. 99-1011-03 - € 18,00
Volumii
ATTENZIONE!!!
Fiere eMostre MercatoFiere eMostre Mercato» Elettronica» Ricetrasmissioni» Computer» Surplus» Radio d’Epoca
Per informazioni e dubbi:
SANDIT S.r.l.Via Quarenghi, 42/C24122 BergamoTel. e Fax 035 32.16.37
DTP Studio S.r.l.Tel. 0321 92.72.87Fax 0321 92.70.42
IN OGNI FIERA,PRESSO LO STAND
DELLA SANDIT, ÈPOSSIBILE ABBONARSI A
FARE ELETTRONICA E
RITIRARE SUBITO IL
GADGETIN OMAGGIO
ATTENZIONE!!!
G E N N A I O
11 • 12 MODENA
25 • 26 NOVEGRO [MI]
08 • 09 FERRARA
08 • 09 SAN BENEDETTO [AP]15 • 16 SCANDIANO [RE]
22 • 23 MONTEROTONDO [RM]22 • 23 CITTÀ DI POMPEI [NA]
01 • 02 FAENZA [RA]08 • 09 MONTICHIARI [BS]15 • 16 BASTIA UMBRA [PG]
22 • 23 CIVITANOVA MARCHE [MC]29 • 30 GONZAGA [MN]
05 • 06 ERBA [CO]12 • 13 GENOVA
26 • 27 CIVITAVECCHIA [RM]
02 • 03 • 04 PORDENONE
10 • 11 FORLÌ
17 • 18 CASTELLANA GROTTE [BA]
24 • 25 EMPOLI
31/5 • 1/6 AMELIA [TR]
07 • 08 NOVEGRO [MI]21 • 22 ROSETO DEGLI ABRUZZI [TE]
26 • 27 • 28 FRIEDRICHSHAFEN
05 • 06 CECINA [LI]19 • 20 LOCRI [RC]
06 • 07 MONTICHIARI [BS]13 • 14 PIACENZA
20 • 21 MACERATA
20 • 21 RIMINI
20 • 21 MONTEROTONDO [RM]27 • 28 GONZAGA [MN]
02 • 03 • 04 VICENZA SAT
04 • 05 NOVEGRO [MI]11 • 12 POTENZA
11 • 12 BOLOGNA
18 • 19 FAENZA [RA]25 • 26 BARI
08 • 09 ERBA [CO]15 • 16 VERONA
22 • 23 PORDENONE
29 • 30 PESCARA
06 • 07 • 08 FORLÌ
13 • 14 CIVITANOVA MARCHE [MC]13 • 14 TERNI
20 • 21 GENOVA
F E B B R A I O
M A R Z O
A P R I L E
M A G G I O
G I U G N O
L U G L I O
S E T T E M B R E
O T T O B R E
N O V E M B R E
D I C E M B R E
LA SANDIT SRL SI RITIENE SOLLEVATA DA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI LE DATE VENGANO MODIFICATE O ANNULLATE
Tutte le fiere 2003
rubriche
Sistema integrato in gradodi essere utilizzato diretta-mente su una scheda disupporto dell'utente, comemacro componente. Piccolinodi intelligenti con funzio-nalita' locali come il con-trollo con algoritmi PID ditemperature, motori, val-vole, ecc. Teleacquisizione etelecontrollo su mediobrevi distanze. Automa-zione domestica: accen-sione e spegnimento luci,controllo riscaldamento econdizionamento, supervi-sione elettrodomestici e ser-vizi elettrici, sistemi di sor-veglianza e controllo ac-cesso. Settore automobili-stico: accensione e spegni-mento luci, controllo riscal-damento e condiziona-mento, supervisione servizielettrici, sistemi antifurto,diagnostica di funziona-mento. Didattica: GMM5115 offre la possibilita' diapprendere il Core 8051 adun cosso veramente basso.
A questo scopo si presta al-trettanto bene la scheda disupporto CAN GMT op-pure GMM TST. In tutti i casi di scarsotempo di sviluppo: l'utentepuo' avere il suo prototipoo addirittura il prodotto fi-nito nel giro di una setti-mana. Sistemi a logica dis-tribuita come robot, auto-mazioni su macchine diproduzione in linea, auto-mazioni di fabbriche digrosse dimensioni .
CARATTERISTICHE• Contenitore standard con
zoccolo maschio 28 pie-dini dual in line a passo100 mils, largo 600 mils.
• Ridottissimo ingombro:20 x 38 x 16 mm.
• Circuito stampato a 4strati per ottimizzare leimmunita' e le caratteri-stiche EMI.
• Necessita di una sola ali-mentazione a +5Vcc26mA (l'assorbimentopuò variare in base ai col-legamenti del modulo).
• Disponibilià di modalitàoperative a basso con-sumo come idle mode epower down mode.
• Microcontrollore AtmelT89C5115 (codice com-patibile 8051) con
quarzo da 14,74 Mhz.• Ciclo macchina program-
mabile a 12 o 6 periodi diclock.
• 16K FLASH per codice,2K FLASH per boot loa-der, 256 bytes RAM perdati, 256 bytes ERAM perdati, 2K EEPROM perdati.
• 8 canali di A/D convertercon 10 bit di risoluzione,20 µsec per ogni conver-sione.
• Tensione di riferimentosezione A/D riportata suconnettore.
• 14 sorgenti di interruptcon 4 livelli di priorita'.
• 3 Timer Counter a 16 bits• 2 canali PCA a 16 bit con
funzionalita' di PWM,comparazione, ecc.
• 18 linee di I/O digitalecollegate al connettore.Alcune di queste lineehanno funzionalità multi-ple.
• Linea seriale hardwarecon Baud Rate program-mabile fino a 115200Baud, bufferata in RS 232od a livello TTL.
• R i c e t r a s m e t t i t o r eMAX202 per linea serialeRS 232.
• Circuiteria di Reset e con-trollo alimentazione ba-sata su MAX825.
• Dip switch di configura-zione ad 8 vie.
• LED di segnalazione dellostato di RUN o DEBUGoppure gestito via soft-ware tramite una linea diI/O digitale.
• Possibilità di gestionedella FLASH ed EEPROMinterna in modalità InSystem Programming,ovvero con modulo giàmontato, sfruttando la li-nea di comunicazione se-riale .
• Software gratuito per PC,di supporto alla program-mazione ISP con cui sca-ricare il codice generatonella FLASH di bordo.
• Vasta disponibilità di soft-ware di sviluppo quali:Assemblatori (MCA51);compilatori C (MCC51,HTC-51, SYS51CW, DDSMicro C51); compilatoriBASIC (BASCOM 8051);compilatori PASCAL(SYS51PW); ecc.
• Ricca serie di programmidimostrativi ed esempi diutilizzo forniti sotto formadi sorgenti ampiamentecommentati, per i variambienti di sviluppo.
RUBRICHE 107
Il GMM 5115, che ha l'ingombro di
un DIP28 ed è equipaggiato con un
microcontrollore FLASH da 16K
Atmel T89C5115.
Electronic shop 22
in v
etrin
a GMM 5115GMM 5115
RUBRICHE108
rubriche
in v
etrin
a NAD: ARRIVA ILSISTEMA AUDIO-VIDEOPIÙ PREMIATODELL' ANNO
NAD: ARRIVA ILSISTEMA AUDIO-VIDEOPIÙ PREMIATODELL' ANNO
Sono questi i due nuovifiori all'occhiello del mer-cato inglese leader nell'altafedeltà che da circa 30 anniha fatto della qualità senzacompromessi la sua filosofiadi vita costituendo la rispo-sta europea ai prodottimade in japan. L'accop-piata lettore DVD T531 esintoamplificatore surroundT741 ne rappresenta oggila sintesi perfetta in terminidi prestazioni e semplicità,già premiata con il primopremio nella sua categoriada Essential Home Cinema
(Gran Bretagna-dicembre2001) e HI-Fi World (GranBretagna-febbraio 2002),due delle piu prestigiose te-state di settore riconosciutea livello internazionale.NAD è sinonimo di tecno-logia pura e semplice, dasempre in controtendenzanel settore dell'elettronicadi consumo, cioè, con imoderni apparecchi hi-fi,sempre alla riscossa nel pro-porre "inutili" soluzioni plu-riaccessoriate. riaffermandoquesta filosofia, NAD T531e NAD T741 sono stati
concepiti per offrire eccel-lenti prestazioni tecniche euna fruibilità d'uso facil-mente accessibile anche ainon esperti. Insieme for-mano un sistema audio-vi-deo compatto e multifun-zione che conferma la famadi prodotti di alta qualitàsonora degli apparecchiNAD. È stato, infatti, piena-mente equipaggiato e pro-gettato per offrire tre op-zioni di connessione audioe video, così come la pienacompatibilità con qualsiasiimpianto presente e futuro.NAD T741 è, invece, ilnuovo sintoamplificatoresurround della NAD, chetiene fede al motto "MusicFirst" della casa inglese, fa-cendone la scelta ideale perun impianto ad alte presta-zioni sia video sia audio, in-fatti è una combinazioneperfetta di sintonizzatore eamplificatore, che con-
ferma le qualità eccellentidelle soluzioni NAD.NADT531 non è solo unlettore DVD, è anche un ec-cellente lettore CD e, cosaveramente rara nei lettoridell'ultima generazione, hauna totale compatibilitàcon i cd registrabili (i CD-RW).Inoltre, equipaggiatocon un decoder per i piùdiffusi sorround, incorporaanche il decodificatore MP3per riprodurre questo po-polare formato, visualiz-zando i titoli sull'uscita vi-deo. I dischi MP3, capisci diben 10 ore di musica, sonoriprodotti con una qualitàsonica inavvicinabile da altrilettori DVD. La NAD è giu-stamente famosa per laqualità dei suoi prodotti au-dio, tuttavia anche le pre-stazioni video stabilisconostandard molto alti. Il DACvideo da 10 bit del NADT531 riproduce immagini
Design essenziale, pochi tasti, una perfezione tecnologica nascostain un involucro sobrio dal classico colore grigio scuro. E una qualitàin termini di suono e di immagine che si è conquistata i piùimportanti riconoscimenti del settore dell'anno. Si tratta del nuovosistema audio-video NAD T531 e NAD T741, il sogno di ogniamante del cinema e della musica.
a cura della Redazione
rubriche
con eccezzionale dettaglioe risoluzione cromatica. Maa questo si aggiunge un'in-solita gamma di facilitiesper un apparecchio NAD:Multi-Sound, Multi-Subtel,Zoom 4x e 16x e Repeat.Queste funzioni, richiama-bili da telecomando, fannodel NAD T531 un apparec-chio all'avanguardia per la
tecnologia e le prestazioni,ma anche facile da utiliz-zare ed accessibile ai menoasperti. NAD T741, come cisi aspetta da qualsiasi pro-dotto dell'azienda inglese,offre una grande flessibilitàe altre prestazioni, permet-tendo collegamenti ad unqualsiasi tipo di sorgenteaudio e video. Esso è do-
tato di 5 ingressi video, CDe Tape, tra cui uno sul pan-nello frontale che consenteuna veloce connessione dicamcorder o consolle vi-deogiochi, e di 3 ingressiaudio, invece, che permet-tono di collegare tutte lesorgenti con facilità. Tre diquesti ingressi video sonosia S-Video sia Composite.Ma la particolarità di NADT741, sta nella possibilità diunire ai normali ingressi deisintoamplificatori quelli delsistema 5.1 per garantire lacompatibilità con formatifuturi quali il DVD-AUDIO.NAD T741, infatti, oltre adessere uno straordinarioamplificatore, grazie anchealle uscite preamplificateper tutti i canali (sinistro,centrale, destro, sorrounddestro, subwoofer) che au-mentano lap otenza diuscita dell’impianto, è an-che un eccellente sintoniz-zatore che consente di pro-
grammare 30 preselezioniFM e 10 AM in manierarandom. Il T741, inoltre, of-fre le funzioni RDA PS - Pro-gram Service - che indicasul display del pannellofrontale la radio su cui si èsintonizzati e la funzione RT- Radio Text, che permettedi visualizzare informazionisul programma in ascolto.Il sintoamplificatore nellaNAD è, inoltre, dotato del si-stema Dolby Digital, aggiun-gendo alle normali presta-zioni di altri sintoampli,quelle del sistema modoEARS (Enhanced AmbienteRecovery System). Questa particolare facilityaggiunge un naturale ef-fetto ambienza alla musica(Church, Jazz, Stadium,ecc) estraendolo esclusiva-mente dal segnale origi-nale.
Electronic shop 18
I volumi possono essere richiesti via lettera o fax a: DTP Studio Editrice S.r.l. - via Matteotti, 8 28043 Bellinzago (NO)
Tel. 0321/927287 - Fax 0321/927042 o via email: [email protected] - La spedizione viene effettuata da Sandit srl
esclusivamente in contrassegno (spese di spedizione € 2,5).
... per sapere di piùVolumii
I DIODI LASER G. LUONI
Il diodo laser è un componente elettronico che va maneg-
giato con cura, il suo assorbimento è influenzato dalle varia-
zioni termiche e pochi mA in più possono danneggiarlo irre-
parabilmente. Questo volume, oltre a rispondere a quanto
sopra, sopperisce alla mancanza di documentazione che
possa essere di valido aiuto sia al progettista che all’hobbi-
sta. Gli argomenti trattati, oltre a spiegare cosa sia e come è
fatto un diodo laser, spaziano dagli alimentatori ai dissipatori
di calore fino alle ottiche necessarie per costruire un modulo
laser. Al volume è allegato un floppy per calcolare la densità
ottica dei filtri di protezione oculari da utilizzare in abbinamen-
to ai sistemi laser. Il dischetto richiede un PC IBM (o compatibi-
le) 486 o superiore, un drive da 3,5”, disco rigido e Windows 95
o superiore.
cod. 99-1010-02 - € 14,20
IL PLC G. FILELLA
Al volume è allegato un software, sviluppato in ambiente
Windows, che trasforma il vostro PC in un PLC virtuale, per
apprendere la logica Ladder attraverso l’animazione di alcu-
ni automatismi. Nel testo vengono messi a confronto i PLC
di più recente diffusione prodotti da Siemens, Omron e GE.
Il volume tratta:
• i principi di funzionamento del PLC;
• le memorie;
• i moduli di ingresso e di uscita;
• l’elaborazione di un programma all’interno del PLC;
• le tecniche di programmazione e la Normativa IEC1131-3;
• unità didattiche per la progettazione, realizzazione e
simulazione di automatismi, corredate da schede e tabelle
guida.
cod. 20-1007-07 - € 18,02
rubriche
Rubrica di annunci gratuiti dicompravendita e di scambio dimateriale elettronico.Utilizzate il modulo per inserzionigratuite in ultima pagina perinviare i vostri annunci.
CERCO telecomandi per TV anchenon funzionanti ma riparabile.Acquisto prezzo modico CalabresiPierino via Roma 30, 01020 –Lubriano(VT). 0761/780622.
VENDO ricevitore tv sat digitalehumax IRCI5400, con irdeto E 2slot, a € 450. Card ufficiale pay tvadulti SCT, usata 2 mesi, a € 170.Ricevitore Nokia 992 con viaccess,1 slot e hard disc 40GB, a € 590.Magic cam originale V 103, a €
200. Mario Villani via Parigi 11,66020 – S.Giovanni T. (CH). 348/7212615.
VENDO alimentatore switching0÷250 Vcc. 0÷2,5 A con displayseparati – professionale USA, €
200. Spognardi Chiaramondo viadei Larici 81, 04011 – Aprilia. 06/9281017.
VENDO schede di recupero indu-striale ottime condizioni € 7.Spognardi Chiarimondo via deiLarici 81, 04011 – Aprilia. 06/9281017.
VENDO monitor digitale per PC15 pollici target € 65. Vendodischi 33 giri ottimo stato anni60÷90. Spognardi Chiarimondovia dei Larici 81, 04011 – Aprilia. 06/9281017.
VENDO n°4 altoparlanti hi-fi RCFPRO L10P10 nuovi ancora da sbal-lare. Richiesto € 60 caduno valorecommerciale € 100. CianchiGiuliano via B. Sestini 100/A,51100 – Pistoia. 0573/964087.
VENDO a € 28 totali, gruppo 1 kitpreamplif. squadratore per effettiaudio, + 1 kit mixer mono a duevie, + 1 kit generatore di suoni erumori programmabile, +4 kitpreamplif. di super acuti per ver-sioni mono o stereo, +1 nuovissi-mo occhiale a sei lenti con messaa fuoco separata per lavori di pre-cisione. Regalo anche radioco-mandotrasmettit/ricevitori funzio-nanti. Carioni Pietro via Leonardoda Vinci 13, 26900 – Lodi. 0371/30418.
VENDO a € 10 Kit mini spia F.M.da 80 a 110MHz ricevibile da rice-vitori F.M. A € 13 kit sirena polizia,ambulanza, pompieri da 11 w al12 v. A € 13 kit variatore di ten-sione 2.000w ent. 220 v. usc. da 0a 220 v. A € 16 kit premontatoamplif. stereo 20 w al 220 V. A €29 kit amplif. stereo autoprotetto60W al 220 V. I kit sono completidi trasform., aliment., dissip., alto-parl, mobiletto, ecc. Carioni PietroVia Leonardo da Vinci 13, 26900 –Lodi. 0371/30418.
CERCO vecchie radio a valvole(meglio se per onde corte e nonfunzionanti) per recupero compo-nenti (M.F. - demoltipliche...).Braghetta Bruno Rot. Montiglio15, 25127 Brescia. 030/302876.
PROGETTO master per circuitistampati, prototipi e prove subanco, tempi di consegna brevi,preventivi gratuiti. Rucci RenzoV.le G. di Vittorio n°6, 71041-Carapelle. 339/7470324.
VENDEO parabola TV + ricevitorecompleto per ricezione program-
mi tivù satellitare a € 260 causainutilizzo. Casagrande Giacomo V.G. Marconi 31, 06026 - Pietralunga. 340/3294041.VENDO singolarmente per cessa-ta attività, oltre 3.000.000 dicomponenti nuovi a prezzi mini-mi. Libri di radiotecnica; prontua-ri di valvole; manuali ed equiva-lenze transistor; bollettini tecniciGeloso, Marelli, Grundig, Phonola,riviste e valvole. In perfettte ripro-duzioni laser o in originali,schemidi radio e non solo, dal 1930 al1980. Su richiesta, con bollo da €0,77, invio dettagliate liste. ArrigaGiuseppe Via F.lli Cervi 94,01038 - Soriano nel Cimino (VT). 0761/759444.
VENDO molti libri di radiotecni-ca: Ravalico “Il radio libro”,“L’audio libro”, “Radio riparazio-ni”,ecc. Montù “Radiotecnica”,Costa “Radioriparatore”, “Banfi““Radiotecnica”, Dilda “Radiotec-nica”, Angeletti “Il manuele delradiomeccanico”, De Sanctis“Radiomanuale” ecc. I volumivanno dal 1926 al 1967. Surichiesta, con bollo da € 0,77,invio dettagliate liste. SantiniBernardina Via F.lli Cervi 96,01038 - Soriano nel Cimino (VT). 0761/759444.
VENDO a € 6 lente 20X30 cm.con supporto. A € 6 macchinafotografica quadricamera a 4obiettivi con scatto a tempo diffe-renziato per 4 pose a effetto movi-mento sulla stessa foto. A € 8megafono da 5W con dispositivopreavviso di annuncio. A € 16equalizzatore stereo 5 vie amplif.50W per auto, a € 16 radiomicro-fono per ricevitori F.M. da 88 a108 MHz con mobiletto. CarioniPietro Via Leonardo da Vinci 13,26900 - Lodi . 0371/30418.
VENDO magnetoterapia pro-fessionale nuova doppia condue dischi irradianti prezzotrattabile. Iop Paolo Via Isonzo41, Campagna-Lupia (Venezia). 340/9085561.
COMPRO a prezzi contenuti leseguenti valvole nuove: 300B;
6336A/B; EL34; KT88; 6550;2A3; 45; 50; 26; 71A; VT52;6C33C; AD1; 6L6GC; 13E1; PX4;PX25; 6080/6A57; KT66; KT77;PT8; 6528; ECC32; ECC802;6072; 12A; E188CC; e altre.Mascazzini Riccardo, Via Pitagora,32 - 28100 Novara. 0321/620156.
SVILUPPO programmi in assem-bler per microst6XX, PIC84,PIC876 e realizzo prototipi.Gaburro Gianni Via Canova,n.°60, 46047 - Porto Mantovano(MN). 0376/396743.
CERCO telecomandi per tv anchenono funzionanti ma riparabili.Acquisto prezzo modico. CalabresiPierino Via Roma n.°30, 01020 -Lubriano (VT). 0761/780622.
VENDO microspia piccolissimaambientale completa di ricevitoree cuffiette consente un ascoltolimpido senza interferenze adoltre 300 mt di distanza kit com-pleto di cavetto registrazioni - bat-terie- istruzioni d’uso € 260.Presosa Gianni Via Ippocrate 51,00167 - Roma. 333/7819330.
CERCO bobine a nido d’ape varielunghezze d’onda e cristalli digalena. Pago il giusto. NastariMassimo via Bandinella 6, 40043 -Marzabotto (BO). 051/840408(ore pasti).
VENDO contacopie industrialeprofessionale della Hengstler a €
40 , con display a led a 6 cifre;vendo anche 2 v-meter con lam-pada a 12V (5 Euro cad.).Dispongo inoltre di una batteriaPP52 da 3,6V al NI-MH e di uncaricabatteria per il cellulare telit810E. Monesi Lorenzo viaMarchesi 10,40024 - Castel SanPietro Terme. 051/944490.
ACQUISTO annate dal 1991 inpoi, di “Selezione di elettronica”,“Cinescopio”, “FotoComputer”ed altre di elettronica. BellossiOlga, via Regol 11, 18010 -Cervo. 0183/400182.
VENDO riviste di “NuovaElettronica”n°90, 94, 98; 106,
al m
erca
to
RUBRICHE110
rubriche
108; 151, 153;182, 184;186,190, 191, 193; 197, 199, 201,202, 205, 207, 209.Fioritoni Corrado, via SuperiorePremanico, 16133 - Genova. 010/3450128.
COMPRO i primi 140 numeri diNuova Elettronica e scambio dal150 al 180. Zanardi Mauro, viaFronte 1° Tronco 25/A, 44020 -Pontelangorino (FE). 0347/7588542.
VENDO PLC C200H OMRON+moduli I/O varie confifurazioni,softw per PC in omaggio. Inverterper motori a sincroni 220 mono-220 trifase. Motori CC 140V 1,1Kw. Castelli Carlo, via Consol.Latina 11, 00034- Colleferro (RM). 06/9700576.
CERCO pagando schema elettricodell’oscilloscopio marca Telequip-ment Mod. Serviscope S.51.A.Giri Giulio, cas.post n.4, 00049 -Velletri. 06/9648048.
CERCO fotocopie dell’articolo“laser diodico da 300mW” appar-so sul numero 166 di Aprile 1999.Posso spedire francobolli. StorariFilippo Via Don Chendi, 44035 -Formignana (FE). 0349/5264594.
CEDO riviste,manuali,servicesmanuals, alimentatori yaesu FP28-FP757, FISSO 13,8 V/15A.Lineare VHF NAG 250W, accop-piatori4XVHF 4XUHF, cavità 10GHz, RTX PONY CB, RTXINTEK548/SX, ZGHP1000, filtro Comet,RXSAT WINSTEK RDS 2000, RXSAT ECHOSTASR AD3600IP, pro-grammatore multiprog 2, telaiettiVHF STE, UHF AE, rotatore 3 fili,giradischi + sinto anal.+ ampli60+60 watt. Giovanni Tumelero,viale Libertà 14 - 21015 LonatePozzolo (VA). 0331-669674(ore 18 in poi)
REALIZZO PCB da qualsiasi fonte(cartacea - elettronica) con metodofotoincisione + forti prezzi modici.E-mail [email protected] RenzoRucci viale G. di Vittorio, 6- 71041Carapelle (FG). 339-7470324(ore pasti)
VENDO valvole 6SN7 generalelectric marcate Baldwin originaliUSA nuove provenienti America eraddrizz. E28I nuove. DesimonePietro Via Provinciale, 52- 03040Ausonia (FR). 0776-952127(dopo le 20.00)
CERCO bollettini Geloso dal n.1 al21+23-30-31; schemari di appa-recchi radiovalvolari della SRE o dialtri. Comunicare disponibilità eprezzi. Bernardina Santini via F.lliCervi, 96 - 01038 Soriano nelCimino (VT). 0761-759444(dalle 20.00 alle 23.00)
CERCO i volumi: D.E. Ravalico “Ilradiolibro” dalla 9° alla 19° Ed. G.B.Angeletti “Il manuale del radiomec-canico” vol. 3°-4°. Comunicare dis-ponibilità e prezzi. Giuseppe Arrigavia F.lli Cervi, 94 - 01038 Sorianonel Cimino (VT). 0761-759444(dalle 20.00 alle 23.00)
VENDO a 8 Euro apparechio conaccordatore regolabile per riceve-re i segnali radio e televisivi dallapresa a 220V captati dall’impiantoelettrico, completo di cavetto eadattatori d’impedenza. A 16Euro minispia ambientale da 88 a108MHz alimentata a 220V e rice-vibile dai normali ricevitori F.M.Soddisfatto o rimborsato. CarioniPietro via Leonardo da Vinci 13,26900 Lodi. 0371-30418.
COMPRO a prezzi contenuti val-vole nuove: 2A3; 300B; 6336A/B;EL34; 71A; PT8; ECC802; ECC32;45; 6072; KT88; 6550; 26; e altre.Riccardo Mascazzini via Pitagora,32 - 28100 Novara. 0321-620156 (ore 12-22)
VENDO ricevitori zenit transocea-nic mod.super professional in per-fette condizioni ed alimentazioneoriginale a 115 V. Euro 600.Sergio Emaldi via Vittorio Veneto,33- 40015 S. Vincenzo di Galliera(BO). 335-375179 (sempre)
VENDO PLC omron C200H conmoduli I/O varie configurazioni +software omaggio motori CC140V + azionamenti per motoribrusmless. Carlo Castelli Via Cons.
Latina, 227- 00034 Colleferro(RM). 06-9700576.
EFFETTUO il montaggio e la salda-tura di schede elettroniche e/omontaggio di vari articoli elettro-nici presso il mio domicilio.Salvatore Cacciatore via DucaD’Aosta, 26- 73040 Supersano(LE). 0883-631540 (ore pasti)
VENDO a 20.000 anten. internaricev. a onde convogl. da rete 220v. con accordat. per radio e tv.Chiedere lista articoli finiti anchefotografica. Pietro Carione viaLeonardo da Vinci, 13 - 26900Lodi (Lo). 0371-30418 (orepasti)
CERCO volenteroso che possainviarmi il progetto di un “minicb” sono un radioamatore e dis-pongo di molta componentisticadi recupero, vorrei costruire deimini cb (portata 5-6 km) perappassionare i miei amici, con unaspesa irrisoria. Prego di inviare unsemplice progetto a: BellagambaIngris via Centro Ponte Maodinon° 109 Codigoro (FE) 44021.
DISEGNO e progetto PCB anchemulti-layer, realizzazione prototi-po con montaggio e prove subanco. Renzo Rucci viale G. diVittorio 6, 71041 Carapelle (FG)[email protected] - 339-7470324.
VENDO/SCAMBIO Radio tVE301DYN, Philips legionario, la vocedel padrone 510. 3000 valvole.Invio liste via e-mail. NervegnaFranco via Le Salzare,6 04011Aprilia (LT). 338/6155146 oreserali
VENDESI Riviste nuova elettronicadal N°116 al N° 194 e volumi 1, 2,4, 5, 6, 8, 9, 13, 16 a lire 300.000+ spese di spedizione. GianlucaOlivieri via Belluno 5, Colognola aiColli (VR). 0335/8051480.
CEDO CQ, N.EL.EL. flash, ondaquadra, radio el.el. hobby, el. gio-vane computer dal ‘71 al ‘96L.1000 cad. dal ‘97 L. 200. Inviogratis lista. Antonio La Rocca via
Roma, 1 - 04029 Sperlonga (LT). 0347/6885240 dalle 8:00 alle22:00
VENDO Ricevitore HF 100 KHz-30MM2 ICOM IC-R72 COMmanuale inglese e italiano tutto ori-ginali e funzionante lire 800.000non trattabili. Cerutti Gianni via A.Biffi, 34 - 20056 Trezzo S/Adda(MI). 02/90961414.
VENDO a 10.000 amplificatoreautoalimentato 220 V. per pressaantenna radio, tv. Chiedere lista arti-coli finiti anche fotografica. PietroCarioni via Leonardo Da Vinci, 1326900 - Lodi. 0371/30418.
PROGETTO master per circuitistampati, prototipi e prove subanco, tempi di consegna brevi,preventivi gratuiti. Renzo Rucciv.le G. di Vittorio, 6 71041Carapelle (FG). 339/7470324ore ufficio
COMPRO Le seguenti valvolenuove solo a prezzi convenienti:2A3; 6A3; 6B4; 71A; 45; 26; 10Y;6080 6AS7; EL34; EL84; 5V3; PT8;300B; E188 cc. RiccardoMascazzini via Pitagora, 32 -28100 Novara. 0321/62015612:00-22:00
VENDO Due lineari MicrosetVHF/UHF da 50W a L. 100.000l’uno, Alan 87 + acc. L. 250.000,frequ. digitale L. 150.000, tuttocome nuovo e altri accessori.Stefano Giambi via del Popolo, 12- 06010 Pistrino (PG). 075/8592073 ore pasti
RUBRICHE 111
VENDOpacchi batteria(due) PBI7 UH(6 volt - 2800 MILLIAMPERE/HI) con ricaricatore uno-mat NCL 505, cedo a 100.00.Francesco Capelleto P.O. Box193 - 13100 Vercelli. 0339/3629110
rubriche
elctro
nic sh
op
RUBRICHE112
04PICBASIC PRO: NUOVA RELEASEPer ulteriori informazioni contattare:Inware srlVia Cadorna, 27/31 - 20032 Cormano (MI)Tel. 02-66504794 - Fax [email protected] - www.elettroshop.it
05BASICX-24 UN CLONE DEL BASIC STAMP CON QUALCHE MARCIA IN PIÙPer ulteriori informazioni contattare:Area SX srlVia L. Robecchi Brichetti, 13 - 00154 RomaTel. 06-57172690 - Fax [email protected] - www.areasx.com
06TERRATEC PHONO PREAMP STUDIO USB:PREAMPLIFICATORE INDIPENDENTEIl prezzo del Phono Preamp USB è di €119,00 utente finale IVA inclusa.Per ulteriori informazioni contattare:Pasquale BarbarossaTerratec ItaliaTel. 02-33494052 [email protected]
07ANTIUMIDITÀ PER MURATUREPer ulteriori informazioni contattare:Marani AndreaTel/Fax [email protected]
08RECS 101: UN WEB SERVER EMBEDDED PER APPLICAZIONI DI CONTROLLO REMOTO TRA-MITE TCP/IPPer ulteriori informazioni contattare:Cristian RandieriIntellisystem TechnologiesVia Francicanava, 13 - 96100 SiracusaTel/Fax [email protected]
09AMPLIFICATORE PER MICROFONO ADELEVATA SENSIBILITA’Per ulteriori informazioni contattare:EUROPARTViale Allea, 39 - 27049 Stradella (PV)Tel. 0385-42192 Fax [email protected]
10INTERRUTTORE CREPUSCOLARE A 4 LIVELLIDisponibile in scatola di montaggio, com-pleta di tutti i componenti necessari, inclu-si il circuito stampato di qualità e l'assi-stenza telefonica gratuita. Può essere ordi-nata al prezzo di € 26,99 sul sito www.pia-netaelettronica.it, oppure inviando un Faxallo 06.5327.3063. Il kit sarà consegnato tra-mite i servizi postali, entro 5/10 giorni dal-l'ordine. L'importo dell'ordine, più la cifra di€ 4,50 per le spese di invio, dovranno esse-re pagati direttamente al postino.
11TERMOMETRO ELETTRONICO A COLONNINATutto il materiale necessario, al comple-to assemblaggio del termometroMK3955, come da lista componenti, €
63,80 IVA compresa. Per le zone non ser-vite dai concessionari GPE è possibileordinare i kit telefonando allo 0544-464059 o inviando un fax allo 0544-462742, oppure scrivendo a: GPE kit viaFaentina, 175/A - 48010 Fornace Zarattini(RA).
12CIRCUITO ELETTRONICO ANTIBALBUZIEPer ulteriori informazioni contattare:Marani AndreaTel/Fax [email protected]
13INTRODUZIONE AI CCDPer ulteriori informazioni contattare:Riccardo [email protected]
14RABBIT BY EXAMPLEPer ulteriori informazioni contattare:Sergio TanzilliArea SX srlVia L. Robecchi Brichetti, 13 - 00154 RomaTel. 06-57172690 - Fax [email protected] - www.tanzilli.com
15TERMOMETRO A QUATTRO CIFRE DA –55 A +125 °C Tutti i componenti necessari al completoassemblaggio del termometro MK3960,come da lista componenti € 48,85 IVAcompresa. Per le zone non servite daiconcessionari GPE è possibile ordinare ikit telefonando allo 0544-464059 oinviando un fax allo 0544-462742, oppurescrivendo a: GPE kit via Faentina, 175/A -48010 Fornace Zarattini (RA).
16GENERARE SEGNALI VIDEO IN REAL-TIME UTI-LIZZANDO UN PIC16F84Per ulteriori informazioni contattare(scrivere in inglese):Ricard Guné[email protected]
17LE INTERFACCE SERIALI RS-422 E RS-485Versione 2.1a ˆ Dicembre 2002 Copyright© 2001-2003, Vincenzo VillaPermission is granted to copy, distributeand/or modify this document under theterms of the GNU Free DocumentationLicense, Version 1.1 or any later versionpublished by the Free SoftwareFoundation; with no Invariant Sections,with no Front-Cover Texts and with noBack-Cover Texts.A copy of the license is included in thesection entitled "GNU Free DocumentationLicense".
GNU Free Documentation LicenseIl documento GNU FDL, disponibile sulsito http://www.gnu.org anche in versio-ne italiana, è parte integrante di questodocumento e ne contiene i termini di uti-lizzo. Per ulteriori informazioni contattare:Vincenzo [email protected]://www.vincenzov.net
18E.C.D.L. European Computer Driving LicenceCorso di preparazione all’esame dellapatente europea per l’uso del computer.Per ulteriori informazioni contattare:Giampiero FilellaTel. [email protected]
19ANTENNE PER ALTE E ALTISSIMEFREQUENZEPer una più approfondita consulenzatecnica , contattare:Giuseppe Signoris Tel. 0321/[email protected]
20I PRIMI PASSI DELLA MODULAZIONE DI FRE-QUENZA IN ITALIAPer ulteriori informazioni contattare:Carlo [email protected]
21MONACOR: AMPLIFICATORI HI-FI CAR SERIE“WANTED”Per ulteriori informazioni contattare:Monacor ItaliaVia Serenari, 33/G40013 Castelmaggiore (BO)Tel. 051-71356 - Fax [email protected] - www.monacor.it
22GMM 115Per ulteriori informazioni contattare:GrifoVia dell’Artigiano, 8/640016 S: Giorgio di Piano (BO)Tel. 051-892052 - Fax [email protected] - www.grifo.it
23NAD: ARRIVA IL SISTEMA AUDIO-VIDEO PIÙPREMIATO DELL'ANNOPrezzo indicativo del lettore DVD NADT531 € 590,00. Prezzo indicativo del sin-toamplificatore NAD T741 € 790,00. Il let-tore DVD NAD T531 e il sintoamplificato-re NAD T741 sono distribuiti da DefinitiveAudio nei migliori negozi di hi-fi.Per ulteriori informazioni contattare:Rossana Serafino Meta Comunicazione Tel. 02-20404212 - Fax [email protected]
Questa rubrica contienetutti i riferimenticommerciali riguardantigli articoli presentati nellarivista. Fate riferimento alnumero riportato alla finedi ogni articolo.
01DR BOX 1: RADIO DIGITALE PER TUTTI ( DAB )Il prezzo del DR Box 1 è di € 499,00 uten-te finale IVA inclusa.Per ulteriori informazioni contattare: Ufficio StampaMeridian Communications SrlTel. 02-48519553 - Fax 02-43319331www.meridiancommunications.it
02COME TI PROTEGGO IL COMPUTERPer ulteriori informazioni contattare:EUROPARTViale Allea, 39 - 27049 Stradella (PV).Tel. 0385/42975
03CATALOGO MONACOR 2003Per ulteriori informazioni contattare:Monacor ItaliaVia Serenari, 33/G40013 Castelmaggiore (BO)Tel. 051-71356 - Fax [email protected] - www.monacor.it
PER ABBONARVI ORINNOVARE L’ABBONAMENTOA FARE ELETTRONICA POTETE USARE QUESTOBOLLETTINO POSTALEPRECOMPILATO.
Compilate il bolletino in tutte le sue parti,specificando nella CAUSALE, se si trattadi un nuovo abbonamento o di un rinnovo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti,contattare la redazione al numero:
0321/927287
o inviare un messaggio a:
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI.In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, DTP Studio Editricegarantisce la massima riservatezza dei dati da te comunicati e la possibilità dirichiedere la verifica, rettifica o cancellazione, scrivendo a: Responsabile Dati, DTPStudio Editrice S.r.l. Via Matteotti, 8 - 28043 Bellinzago Novarese (NO).
Ques
to b
olle
ttin
o di
con
to c
orre
nte
post
ale
pres
tam
pato
è v
alid
o pe
r ef
fett
uare
il v
ersa
men
to p
ress
o un
qua
lunq
ue u
ffic
io p
osta
le
Come Abbonarsi
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
CAP LOCALITÀ
PROV. PREFISSO/NUMERO TELEFONICO
MODULO PER INSERZIONI GRATUITE
SCRIVERE IN STAMPATELLO COMPILANDO IL MODULO IN OGNI SUA PARTE,RISPETTANDO GLI APPOSITI SPAZI. INVIARE IL MODULO COMPILATO A:
DTP Studio Editrice Via Matteotti, 8 - 28043 Bellinzago Novarese (NO)
La Redazione di Fare Elettronica si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare
gli annunci, inoltre non si ritiene responsabile per eventuali ritardi nella pubblicazione, errori del
testo o della veridicità dei dati.
Questo bollettino di conto corrente postale prestampato è valido per effettuare il versam
ento presso un qualunque ufficio postale
TESTO DELL’ANNUNCIO
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI.In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, DTP Studio Editrice garantisce la massimariservatezza dei dati da te comunicati e la possibilità di richiedere la verifica, rettifica o cancellazione,scrivendo a: Responsabile Dati, DTP Studio Editrice S.r.l. Via Matteotti, 8 - 28043 Bellinzago Novarese (NO).