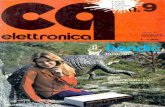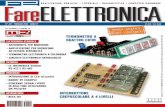Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile - 1997
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile - 1997
ARGOMENTI
567NOTARIATON. 6/1997
A
�
Atto notarile
DOCUMENTO INFORMATICO,CONTRATTO IN FORMAELETTRONICA E ATTO NOTARILEdi Gaetano Petrelli
La legge n. 59 del 1997nell’introdurre nelnostro ordinamentol’istituto del documentoelettronico, pone all’in-terprete una serie diproblemi attinentiall’ambito e alle moda-lità di applicazionedella nuova normativa eal rapporto intercor-rente tra essa e le prece-denti norme emanate sulpresupposto dellanatura cartacea del sup-porto materiale deldocumento giuridico.
L’art. 15, secondo comma, dellarecente legge 15 marzo 1997 n.59 ha introdotto nel diritto pri-vato italiano una norma di portatadirompente, ammettendo, a tuttigli effetti di legge, la rilevanza ela validità del c.d. documentoinformatico, o elettronico, e,soprattutto, del contratto in formaelettronica. Esso, infatti, dispone:«Gli atti, dati e documenti for-mati dalla pubblica amministra-zione e dai privati con strumentiinformatici o telematici, i con-tratti stipulati nelle medesimeforme, nonché la loro archivia-zione e trasmissione con stru-menti informatici, sono validi erilevanti a tutti gli effetti di legge.I criteri e le modalità di applica-zione del presente comma sonostabiliti, per la pubblica ammini-strazione e per i privati, con spe-cifici regolamenti da emanareentro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore dellapresente legge». In attuazione ditale delega, è stato avviato il pro-
cedimento per l’emanazione delsuddetto regolamento, ed a taluopo è stato approvato dal Consi-glio dei Ministri il relativoschema preliminare in data 5agosto 1997 (per cui le compe-tenti commissioni Affari Costitu-zionali della Camera e del Senatohanno già dato parere favorevole,e che dovrà ora essere sottopostoal parere del Consiglio diStato) (1). Detto regolamento(art. 3) rinvia, quindi, ad un suc-cessivo regolamento per fissarele regole tecniche per la forma-zione, la trasmissione, la conser-vazione, la duplicazione, la ripro-duzione e la validazione, anchetemporale, dei documenti infor-matici (2).Come si vedrà in prosieguo, ladottrina ha riconosciuto già datempo la rilevanza giuridica, nelnostro ordinamento, del docu-mento elettronico, e la stessa legi-slazione, sia pure episodicamenteed in modo frammentario, ne hadisciplinato specifici aspetti (3).La norma succitata, peraltro,nell’introdurre in via generalel’istituto del documento elettro-nico, da un lato elimina i dubbiesistenti circa la generale cittadi-nanza nell’ordinamento deldocumento elettronico stesso, ecirca la sua astratta idoneità asoddisfare i requisiti formalivolta per volta richiesti da speci-fiche norme di legge; d’altro latopone all’interprete una serie diproblemi attinenti all’ambito edalle modalità di applicazionedella nuova normativa ed al rap-porto intercorrente tra essa e leprecedenti norme, stratificatesinel tempo, ed emanate sul pre-supposto della natura cartacea delsupporto materiale del docu-mento giuridico. Al fine di evi-
denziare i problemi, i dubbi, lesoluzioni, appare opportunoinnanzitutto individuare alcuniconcetti giuridici fondamentali,quali quelli di documentazione,documento, scrittura privata, sot-toscrizione, nell’elaborazionefino ad oggi effettuata da dottrinae giurisprudenza prevalenti, per
Note:(1) Occorre pertanto tener conto dieventuali osservazioni che il Consigliodi Stato potrà effettuare. L’eventualedefinitiva approvazione del regola-mento in termini parzialmente diversida quelli presi in considerazione costi-tuirà oggetto di un successivo esame.
(2) Opportunamente il regolamentogovernativo demanda ad una succes-siva fonte l’emanazione di regole tecni-che, per loro natura suscettibili di un piùrapido aggiornamento, in conse-guenza della notevole velocità del-l’evoluzione delle conoscenze informa-tiche. Il secondo comma dell’art. 3 delregolamento governativo prevedeinfatti che: «Le regole tecniche indicateal comma 1 sono adeguate alle esi-genze dettate dall’evoluzione delleconoscenze scientifiche e tecnologi-che con cadenza almeno biennale adecorrere dall’entrata in vigore del pre-sente regolamento».Le suddette regole tecniche sono defi-nite dall’art. 1, lettera o) del regola-mento governativo come «le disposi-zioni di carattere applicativo dellenorme del presente regolamento ecomunque conformi a quest’ultimo, dicarattere informatico o telematico, checoncernono le caratteristiche dei pro-dotti e delle procedure, particolar-mente con riferimento alla qualità deiprocessi informatici e dei relativi risul-tati, all’efficacia delle forme di pubbli-cità degli elenchi e delle certificazioni,alla sicurezza ed integrità di sistemidati e procedure rilevanti nella forma-zione del documento informatico».
(3) Per anticipazioni di alcune linee didisciplina sul documento elettronico,contenute in fonti esterne all’ordina-mento statale (atti del Consiglio d’Eu-ropa, della Commissione delle NazioniUnite, della Commissione CEE), v.Orlandi, La paternità delle scritture,Milano 1997, 18 ss.
ARGOMENTI
568NOTARIATON. 6/1997
A
�
poi passare in rassegna le princi-pali problematiche e novità deri-vanti dalla nuova normativa.
I CONCETTIGIURIDICI DIDOCUMENTAZIONEE DI DOCUMENTOL’elaborazione dei concetti giuri-dici di documentazione e di docu-mento si avvale, principalmente,dell’autorevole contributo diFrancesco Carnelutti (4), al qualesono seguiti, nel tempo, una seriedi interventi dottrinali e giurispru-denziali (5), che non hanno,peraltro, alterato l’impostazionefondamentale dallo stesso fornita.Documento (da docere: inse-gnare, far conoscere) è statoquindi definito, volta per volta:— «cosa che fa conoscere unfatto» (6);— «res signata (un oggetto perce-pibile, recante segni), onde è datopronunciare il giudizio di esi-stenza di un fatto, che sia sussumi-bile sotto un tipo normativo» (7);— «cosa corporale, semplice ocomposta, idonea a ricevere, con-servare, trasmettere, la rappre-sentazione descrittiva o emble-matica o fonetica di un dato ente,giuridicamente rilevante» (8);— «cosa rappresentativa», i cuielementi essenziali sarebbero per-tanto «la cosa cui si riconosce talesignificato, la rappresentazioneche essa fornisce ed il fatto rap-presentato con quest’ultima» (9).— «qualsiasi supporto visivo,fonico, magnetico o cartaceo sulquale sono impressi segni comu-nicativi in grado di essere perce-piti dall’uomo direttamente oattraverso l’impiego di partico-lari strumenti» (10).Ciò che appare essenziale in cia-scuna delle surriportate defini-zioni del documento è da un latoil supporto fisico, materiale,destinato ad ospitare ed incorpo-rare la rappresentazione di unfatto, dall’altro lato l’esistenzadi segni che manifestano unadata realtà esterna giuridica-mente rilevante (segni che assu-mono, nell’ipotesi di documentografico, la veste di dichiara-zione, ovverossia di un fatto dilinguaggio) (11). Nessuno degli
autori che si è occupato dellamateria ha affermato che il sup-porto materiale del documentodebba necessariamente essereun supporto cartaceo: al contra-rio, è affermazione unanime edincontrastata che qualsiasi mate-ria può costituire la base deldocumento (12), e ciò è tanto piùsignificativo in quanto l’affer-mazione si riscontra anche neipiù antichi contributi, formati inepoche nelle quali sicuramentenon vi era neanche la possibilitàdi concepire l’evoluzione tecno-logica poi verificatasi. L’unicaspecificazione a tal uopo effet-tuata dalla dottrina è relativa alprofilo della durata: la res, costi-tuente il supporto materiale deldocumento, deve essere idonea aconservare la rappresentazionein esso incorporata, a differenzadi quanto avviene per la dichia-razione verbale o la manifesta-zione per gesti, che per loronatura si esauriscono nell’istantein cui sono effettuate (13); nelcontempo, peraltro, si riconosce
Note:
(4) Carnelutti, Documento (teoriamoderna), in Novissimo Dig. It., VI,Torino 1975, 85 ss. (ove sono citatialtresì i precedenti contributi dell’au-tore in materia). Questo contributo eraperaltro già apparso nel 1937 nelNuovo Digesto Italiano.
(5) Tra i principali interventi, v. in parti-colare: Irti, Sul concetto giuridico didocumento, in Studi sul formalismonegoziale, Padova 1997, 159 ss. (e giàin Riv. trim. dir. e proc. civ., 1969); Irti,Il contratto tra «faciendum» e «fac-tum», in Studi sul formalismo nego-ziale, cit., 95 ss. (e già in Rass. dir. civ.,1984, 938 ss.); Di Sabato, Il documentocontrattuale, Milano 1997; Irti, La ripeti-zione del negozio giuridico, Milano1970, 71 ss.; Verde, Prova documen-tale (diritto processuale civile), in Enc.giur. Treccani, XXV, Roma 1991; Denti,Prova documentale (diritto proces-suale civile), in Enc. dir., XXXVII,Milano 1989, 713 ss.; Angelici, Docu-mentazione e documento (dirittocivile), in Enc. giur. Treccani, Roma1989; Candian, Documentazione edocumento (teoria generale), in Enc.dir., XIII, Milano 1964, 579 ss.; Carraro,Il diritto sul documento, Padova 1941.
(6) Carnelutti, Documento (teoria(oderna), cit., 86.
(7) Irti, Sul concetto giuridico di docu-mento, cit., 196.
(8) Candian, Documentazione e docu-mento (teoria generale), cit., 579.
(9) Angelici, Documentazione e docu-mento (diritto civile), cit., 1.
(10) Di Sabato, Il documento contrat-tuale, cit., 35.(11) Sul concetto giuridico di dichiara-zione, in contrapposizione al concettodi manifestazione, v. Scalisi, Manife-stazione (in senso stretto), in Enc. dir.,XXV, Milano 1975, 476 ss..(12) Carnelutti, Documento (teoriamoderna), cit., 86 («Poiché il più anticoe ancora il più diffuso tra i mezzi docu-mentali è la scrittura e, oggi, la materiasulla quale si scrive è la carta, per lo piùil documento è cartaceo ... Ma il vero èche qualunque materia, atta a formareuna cosa rappresentativa, può entrarenel documento: tela, cera, metallo, pie-tra e via dicendo»); Candian, Docu-mentazione e documento (teoria gene-rale), cit., 579 («forma constainsolubilmente dell’elemento corporaleo materiale mediante il quale l’eventodiventerà percepibile – carta; pietra (adesempio, lavagna); nastro magnetico;pellicola cinematografica; disco digrammofono; lastra radiografica;“negativa” fotografica (e cartoni che neriprodurranno l’immagine); fonometro;ecc.») e 593 («Si tratta di una cosa,normalmente, mobile. Non è esclusoche un documento possa qualificarsibene immobiliare, se si pensa, adesempio, ad un documento lapideo,inserito in un muro o comunque in unelemento strutturale di un edificio»).Significativo è quanto affermato in dot-trina in tema di testamento olografo:«La scrittura ... può esser fatta su qua-lunque materia idonea e con qualun-que mezzo idoneo, quindi anche supergamena, sulla tela, sulla seta, sulcuoio, e non soltanto coll’inchiostro maanche col lapis o con un’altra materiacolorante qualsiasi. La scrittura puòanche eccezionalmente esser fatta suun muro o su una tavola di legno con unpezzo di carbone, o con una materiacolorante, ovvero col gesso su dei mat-toni o su una lavagna, ovvero medianteincisione, con una punta acuminata,sul legno, sul marmo, o su un metallo»(Gangi, La successione testamentaria,I, Milano 1964, 129–130).Un altro argomento significativo si traedall’art. 1 del R.D. 14 luglio 1937 n.1666, che disciplina la facoltà delnotaio di «ricevere in deposito atti pub-blici, in originale od in copia, scrittureprivate, carte e documenti», laddove lacontrapposizione delle «carte» ai«documenti» avvalora la tesi della nonidentità dei due concetti. In tal sensoCalò, Ammissibilità del deposito di soft-ware presso un notaio, in ConsiglioNazionale del Notariato, Studi e Mate-riali, I, Milano 1986, 418 ss..(13) Irti, Sul concetto giuridico di docu-mento, cit., 173: «Qui emerge unaprima nota, che è la durata: il suonovocale ed il gesto sono labili, e, subitoche siano emessi, tramontano dalnostro orizzonte; lo scritto o il discofonografico trascendono, invece, ilmomento della creazione, e perman-gono nel tempo. Il documento ha sem-pre un’età, uno spazio di vita, breve olungo che sia»; Giannantonio,Manuale di diritto dell’informatica, cit.,347 (che definisce il concetto di scrit-tura come «qualunque dichiarazioneincorporata in un supporto materialedestinato a durare nel tempo»).
ARGOMENTI
569NOTARIATON. 6/1997
A
�
che la durata della res signatapuò essere anche breve, nonessendovi alcuna disposizione dilegge che prescriva limiti didurata o, peggio, l’indistruttibi-lità del documento (14).Oltre al supporto documentale,altro elemento essenziale deldocumento è la rappresenta-zione, in esso contenuta edincorporata tramite segni: rap-presentazione che può essere divario tipo (grafica, fotografica,fonetica, ecc.), il che fa sì che ildocumento grafico (in cui ilsegno è rappresentato dalla scrit-tura) costituisca solo una speciesdel più ampio genus documen-tale (15). Documento e scrittura,generalmente identificati nelcomune linguaggio, in realtàquindi non coincidono (16).Altra distinzione fondamentale èpoi quella tra documento e docu-mentazione: come è stato chia-rito, mentre il documento è lacosa, la res signata, la documen-tazione è l’attività, il fare aseguito del quale la cosa divienesignata (17). Sotto questo pro-filo, ad esempio, è opportunorilevare come la vigente leggenotarile (legge 16 febbraio 1913n. 89), agli artt. 51 e seguenti,regoli essenzialmente l’attivitàdi documentazione, cioè l’atti-vità notarile diretta a far constarela dichiarazione del notaio, a suavolta relativa alle dichiarazionidelle parti ed ai fatti avvenuti inpresenza del notaio stesso (18):solo di riflesso, viene discipli-nato, in tali norme, il contenutodel documento notarile, cioèdell’atto pubblico notarile.
DOCUMENTO,FORMA DEL NEGOZIOGIURIDICO,SCRITTURA PRIVATA,SOTTOSCRIZIONEChiarito come sopra il concettogiuridico di documento, si evi-denzia di conseguenza la diffe-renza tra tale concetto e quello diforma del negozio giuridico:riprendendo la distinzione suaccennata tra documentazione edocumento, tra attività e res, ladottrina ha chiarito che la formacoincide, in realtà, con la docu-
mentazione (come è stato incisi-vamente affermato, nell’ipotesidi forma scritta, «la forma stanello scrivere» (19), cioènell’attività dello scrivere, e nonnello scritto inteso come risul-tato dell’attività). Vista la diffe-renza sotto un diverso angolovisuale, si potrebbe dire che,mentre il documento (factum)attiene al profilo della prova, laforma (faciendum) attiene almomento dell’attività.Nell’ambito della forma, unaparticolare importanza rivestenotoriamente la forma scritta,nell’ambito della quale occorreulteriormente distinguere (art.1350 c.c.) tra atto pubblico escrittura privata. Quest’ultima,disciplinata dal codice civile agliartt. 2702 e seguenti, non è tutta-via definita dallo stesso codice.La dottrina (20), definendo lascrittura privata come «il docu-mento sottoscritto da un privato,senza la partecipazione nel-l’esercizio delle sue funzioni diun pubblico ufficiale abilitato adare pubblica fede agli atti e aidocumenti» (21), individua con-cordemente alcuni elementiessenziali e caratterizzanti lascrittura privata:a) il documento, cioè una cosarecante un insieme di segni gra-fici in forma di linguaggio;b) la dichiarazione, cioè il fattorappresentato, documentato conespressioni linguistiche;c) la sottoscrizione, consistentenell’apposizione autografa delnome e del cognome dell’autoredello scritto in calce allo stesso;d) la provenienza, essendo lascrittura privata formata da unprivato, e non da un pubblicoufficiale nell’esercizio delle pro-prie funzioni.Nessuna norma disciplina il tipodi linguaggio che occorre utiliz-zare per potersi avere scritturaprivata: conseguentemente si èritenuto, in dottrina e giurispru-denza, che anche il critto-gramma, o messaggio segreto oin cifra, in quanto sottoscritto,sia scrittura privata, astratta-mente idonea ad essere oggettodi perizia per scoprirne la«chiave» (22), come pure ildocumento redatto medianteinchiostro simpatico, rilevabile
solo grazie ad apposito procedi-mento e con l’ausilio di appro-priata macchina.Soffermando, in particolare,l’attenzione sul requisito sub c)(sottoscrizione), essa è statadefinita «la scrittura autografadel proprio nome che una per-sona appone alla fine del testodella scrittura» (23). Anche perquanto riguarda il concetto giu-ridico di sottoscrizione, il puntodi riferimento obbligato sono, atutt’oggi, gli studi di Francesco
Note:(14) Borruso, Tre tesi di fondo dell’infor-matica giuridica, in Giur. it., 1986, IV,224 («La legge non prescrive mai l’indi-struttibilità del documento. Basti pen-sare a quanto il documento cartaceosia esposto al pericolo della lacera-zione, delle fiamme, dell’umidità, deiroditori e quanto il nastro o il disco, spe-cie a causa del ridottissimo volume alconfronto di un archivio cartaceo, pos-sano essere meglio protetti in appositiarmadi blindati che li pongono al sicuroda ogni sorta di aggressione e ne assi-curano quindi molto più efficacementela conservazione»).
(15) Sul punto v. Irti, Sul concetto giuri-dico di documento, cit., 177 ss..
(16) Rileva, stigmatizzandola, l’erro-nea identificazione tra documento escrittura Carnelutti, Documento (teoriamoderna), cit., 86: «come vi è nell’usouna sinonimia tra documento e scrit-tura, così vi è tra documento e carta,nel senso che scrittura o carta si ado-perano, per antonomasia, con signifi-cato di documento».
(17) Irti, Sul concetto giuridico di docu-mento, cit., 175; Angelici, Documenta-zione e documento, cit., 2. In altri ter-mini, si è affermato che mentre il docu-mento è «materialità», l’oggetto delladocumentazione, la documentazione è«spiritualità», è l’atto creatore(Morello–Ferrari–Sorgato, L’atto nota-rile, Milano 1977, 153).
(18) Sull’attività di documentazione delnotaio, v. Morello–Ferrari–Sorgato,L’atto notarile, cit., 153 ss..
(19) Irti, Il contratto tra «faciendum» e«factum», cit., 113: «Forma scritta è loscrivere, l’esprimersi scrivendo; scrittoè il documento, la cosa, labile o dura-tura, su cui si fissano i segni grafici».
(20) Marmocchi, Scrittura privata, inRiv. Not., 1987, 963 ss.; Carpino, Scrit-tura privata, in Enc. dir., XLI, 805 ss..
(21) Carpino, Scrittura privata, cit.,805.
(22) App. Perugia 3 dicembre 1952, inGiust. civ., 1953, 666; Marmocchi,Scrittura privata, cit., 967.
(23) Marmocchi, Scrittura privata, cit.,970; App. Perugia 3 dicembre 1952, inGiust. civ., 1953, 666.
ARGOMENTI
570NOTARIATON. 6/1997
A
�
Carnelutti (24). In essi sonolumeggiati le funzioni ed i requi-siti essenziali della sottoscri-zione; in particolare, la sottoscri-zione ha essenzialmente:— una funzione indicativa, con-sistente nell’identificare l’autoredel documento;— una funzione dichiarativa,consistente nell’assunzione dipaternità del documento da partedell’autore dello stesso;— una funzione probatoria, inquanto mezzo per provare l’au-tenticità del documento.In connessione con tali funzioni,la dottrina ha attribuito alla sot-toscrizione determinati requisiti,ritenendo cioè che la stessadebba essere autografa (scrittacioè di pugno dall’autore),nominativa (riportare quindiprenome e cognome dell’au-tore), leggibile (in modo quindida consentire l’identificazionedell’autore), non riproducibile(in quanto garanzia di autenticitàdella provenienza) (25).La legislazione speciale disci-plina peraltro alcune fattispeciein cui il requisito dell’autografiadella sottoscrizione può man-care. Basti ricordare, per tutti:— l’art. 807 c. p. c. nel testonovellato dalla legge 5 gennaio1994 n. 25, a proposito del com-promesso in arbitri, dispone che«la forma scritta s’intende rispet-tata anche quando la volontà delleparti è espressa per telegrafo e pertelescrivente»: ove, chiaramente,manca la sottoscrizione autografa;— l’art. 15–quinquies della legge28 febbraio 1990 n. 38, che, per lecertificazioni d’anagrafe e distato civile da parte di ammini-strazioni comunali, stabilisce che«è ammesso sostituire la firmaautografa dell’ufficiale d’ana-grafe o di stato civile con quellain formato grafico del sindaco odell’assessore delegato, appostaal momento dell’emissione auto-matica del certificato. I certificaticosì emessi sono validi ad ognieffetto di legge»;— l’art. 6–quater del D.L. 12gennaio 1991 n. 6, convertito inlegge 15 marzo 1991 n. 80, pre-vede l’emanazione di atti ammi-nistrativi mediante sistemi infor-matici, prevedendo che in essi lafirma autografa «è sostituita
dalla indicazione a stampa», ed ildocumento «è valido fino a que-rela di falso»;— l’art. 3 D. Lgs. 3 febbraio 1993n. 39 dispone che «gli atti ammi-nistrativi adottati da tutte le pub-bliche amministrazioni sono dinorma predisposti tramite isistemi informativi automatiz-zati»; se per la validità di tali attisia prevista l’apposizione di firmaautografa, «la stessa è sostituitadall’indicazione a stampa, suldocumento prodotto dal sistemaautomatizzato, del nominativo delsoggetto responsabile».Altre norme derogano, ad esem-pio, al requisito di nominativitàdella sottoscrizione: così l’art.602, secondo comma, c. c., intema di sottoscrizione del testa-mento olografo («La sottoscri-zione deve essere posta alla finedelle disposizioni. Se anche nonè fatta indicando nome ecognome è tuttavia validaquando designa con certezza lapersona del testatore»); l’art. 8della legge cambiaria (R.D. 14dicembre 1933 n. 1669, per cui«è valida la sottoscrizione nellaquale il nome sia abbreviato oindicato con la sola iniziale»;l’art. 51 n. 12 L. not. in tema difirme marginali dell’atto pub-blico (che possono essere appo-ste con il solo cognome); la legge3 febbraio 1975 n. 18 in tema dicrocesegno del cieco che non saapporre la propria sottoscri-zione. Altre norme eccezionaliriconoscono la validità del cro-cesegno in luogo della sottoscri-zione nominativa (26). L’art.2705 c.c., riconosce al tele-gramma, anche non sottoscritto,l’efficacia probatoria della scrit-tura privata, se l’originale è con-segnato o fatto consegnare dalmittente (27); parimenti, l’effi-cacia probatoria del documentoprescinde dalla sottoscrizionenelle ipotesi disciplinate dagliartt. 2707, 2708 e 2709 c.c.L’art. 2354 c.c., dichiara «valida
Note:(24) V. in particolare Carnelutti, Studisulla sottoscrizione, in Riv. dir. comm.,1929, 513. Sul concetto di sottoscri-zione, v. successivamente Marmocchi,Scrittura privata, cit., 969 ss.; Morello,Sottoscrizione, in Novissimo Dig. It.,
XVII, Torino 1970, 1004; Protettì–DiZenzo, La legge notarile, Milano 1985,241; Morello–Ferrari–Sorgato, L’attonotarile, cit., 473 ss.; Santarcangelo,La forma degli atti notarili, Roma 1994,148 ss.; Casu, L’atto notarile tra formae sostanza, Milano–Roma 1996, 260ss.; Boero, La legge notarile commen-tata, I, Torino 1993, 319.
(25) Sui requisiti della sottoscrizione v.Zagami, «Firme digitali», crittografia evalidità del documento elettronico, cit.;Boero, La legge notarile commentata,cit., 320; Casu, L’atto notarile tra formae sostanza, cit., 264 ss.; Santarcan-gelo, La forma degli atti notarili, cit.,150; Morello–Ferrari–Sorgato, L’attonotarile, cit., 474; Morello, Sottoscri-zione, cit., 1006 ss.; Marmocchi, Scrit-tura privata, cit., 971. Per una criticaalla dottrina tradizionale in tema direquisiti di autografia, nominatività eleggibilità della sottoscrizione, v.Orlandi, La paternità delle scritture, cit.,82 ss.. L’autore rileva innanzitutto chei suindicati requisiti non sono prescrittida alcuna norma di legge, e tanto menodalle norme in tema di validità del con-tratto e del negozio giuridico. Perquanto attiene specificamente all’auto-grafia, l’autore rileva come, in realtà, ildocumento scritto possa dirsi perfettoanche soltanto in presenza della chiro-grafia – cioè la manualità – della sotto-scrizione (tale da consentire, per illa-zione, una successiva verifica dellapaternità della scrittura). Quanto allanominatività e leggibilità, l’autore rileva(a pag. 95, note 178 e 179) come dot-trina e giurisprudenza oscillino tra chiconsidera sottoscrizione soltanto lafirma chirografa con prenome e nomeleggibili, e chi invece reputa sufficienteil simbolo, comunque identificabile, equindi anche lo pseudonimo o la siglaabbreviata, concludendo nel sensoche la sottoscrizione debba necessa-riamente riportare prenome ecognome leggibili «soltanto quando sipresenti come unico segno indicativodell’autore, cioè quando questi nonvenga espresso in nessun’altra partedel testo», e fatte salve, comunque, lenorme di legge (come l’art. 51 dellalegge notarile) che espressamenteprevedono la nominatività in terminirigorosi. La necessità che la sottoscri-zione sia comunque non riproducibilein serie (il che sarebbe possibile sia susupporti magnetici che supporti ottici)comporta in ogni caso la non idoneitàdelle tecniche informatiche di sottoscri-zione mediante «penne magnetiche» o«lavagne elettroniche», su cui v.Orlandi, op. ult. cit., p. 100.
(26) V. riferimenti in Marmocchi, Scrit-tura privata, cit., 973.
(27) Sull’art. 2705 c.c., e sulla suaeventuale applicabilità al telex ed altelefax, v. in dottrina Barreca, Telex etelefax nel sistema delle prove docu-mentali, in Riv. dir. proc., 1991, 907;Cardarelli, La conclusione del contrattomediante telefax, in Riv. Not., 1994,737; Pasquino, Aspetti problematicidella conclusione del contrattomediante telefax, in Dir. dell’in-formazione e dell’informatica, 1989,567; Id., Ancora sul valore giuridico dei
(segue)
ARGOMENTI
571NOTARIATON. 6/1997
A
�
la sottoscrizione mediante ripro-duzione meccanica della firma»sui titoli azionari, purché l’origi-nale sia depositato presso l’uffi-cio del registro delle imprese oveè iscritta la società (e analoga-mente dispone l’art. 5 del R.D.11 febbraio 1911 n. 298, relati-vamente alla firma dei titoli deldebito pubblico).Dal canto suo, la giurisprudenza,per costante indirizzo, ritienevalida la scrittura privata, inassenza di sottoscrizione (edanche ove la forma sia richiestaad substantiam), in caso di pro-duzione della scrittura in giudi-zio dalla parte che non l’ha sotto-scritta (28).Quanto sopra non toglie, peraltro,che, al di fuori delle eccezioni edelle situazioni particolari, man-tenga il proprio vigore il principiogenerale, in base al quale la sotto-scrizione autografa e nominativaè, nell’attuale situazione norma-tiva (e fatto salvo quanto successi-vamente specificato in ordine aldocumento elettronico), requisitoessenziale della scrittura privataredatta su supporto cartaceo (ed amaggior ragione dell’atto pub-blico) (29). Ciò non significa,peraltro, che la sottoscrizione siaun requisito logico indispensabiledella scrittura privata: ciò è com-provato, da un lato, dalle ecce-zioni normative al principio, e,dall’altro, dalla possibilità teoricache sussistano meccanismi alter-nativi in grado di assolvere conuguale efficacia alle funzioni indi-cativa, dichiarativa e probatoriasopra indicate.
IL DOCUMENTOCONTRATTUALENell’ambito del genus documen-to, una particolare importanzariveste la species qualificabilecome documento contrat-tuale (30). Esso è stato definitocome «qualsiasi strumentosemantico in grado di conservareo trasmettere informazioni affe-renti al contratto» (31), nonché,con maggior precisione, «quellacosa sulla quale sono impressisegni comunicativi comunqueattinenti al contratto, che ha lafunzione di conservare e di tra-smettere informazioni relative al
regolamento contrattuale» (32):tale definizione, da un lato, evital’affermazione più impegnativaper la quale il documento contrat-tuale è quel supporto il cui conte-nuto è rappresentato dal contratto(poiché il singolo documento puòincorporare solo alcune clausolee/o dichiarazioni), dall’altro evitadi prendere posizione sul punto sesia o meno documento contrat-tuale quello che non contiene ele-menti essenziali del contrattostesso.Sotto il profilo della disciplina,si è chiarito innanzitutto cheessenziale al concetto di docu-mento contrattuale è esclusiva-mente l’esistenza di un veicolocomunicativo in grado di con-servare e trasmettere messaggi.Pertanto, «non può escludersiche il documento contrattuale siacostituito da un nastro magne-tico sul quale è impressa la voce,dal nastro audiovisivo sul qualesono impresse le immagini, daltesto proiettato sul video delcomputer, ecc.» (33).Si è altresì chiarita la non neces-saria coincidenza, sotto il profilodella riconduzione ad unità, dicontenente e contenuto: cosìcome è ben possibile, e rispondead un’osservazione desumibiledalla comune esperienza, l’even-tualità che un unico documentocontenga più contratti, è altresìpossibile che un unico contrattosia contenuto in una pluralità didocumenti, ciascuno dei qualicustodisce e trasmette parte delleclausole e delle dichiarazionifacenti parte del complessivoregolamento contrattuale (34).L’affermazione è – sotto il profilo
Note:
(segue nota 27)
documenti trasmessi mediante telefax,in Dir. dell’informazione e dell’informa-tica, 1991, 919; Patti, Sull’efficacia pro-batoria del telefax, in Banca, borsa etitoli di credito, 1990, 432; Pescatori,Sul valore probatorio del telefax, in Riv.dir. impr., 1989, 313; Rubino–Sammar-tano, Efficacia probatoria di telex e fax,in Foro Pad., 1990, I, 2; Montesano, Suldocumento informatico come rappre-sentazione meccanica nella provacivile e nella forma negoziale, in Riv.dir. proc., 1987, 5. In giurisprudenza,Trib. Padova 7 aprile 1993, in Riv. Not.,1994, 1104; Cass. 13 febbraio 1989 n.886, in Riv. Not., 1989, 1162; Trib.Savona 26 marzo 1981, in Vita Not.,
1982, 766; Cass. 11 aprile 1980 n.2319, in Foro It., Rep., 1980, 1680;Trib. Ascoli Piceno 7 settembre 1980,in Riv. Not., 1980, 152. Sul valore pro-batorio del telefax, v. da ultimo le leggi30 dicembre 1991 n. 412 (art. 6) e 7 giu-gno 1993 n. 183.(28) Si tratta di giurisprudenzacostante: v. per riferimenti Sacco, Ilcontratto, Torino 1975, 445 ss., e, più direcente, Cass. 23 dicembre 1995 n.13103, in Mass. Foro It., 1995; Cass.17 giugno 1994 n. 5868, in Mass. ForoIt., 1994; Cass. 7 agosto 1992 n. 9374,in Giust. civ., 1993, I, 2197; Cass. 21maggio 1992 n. 6133, in Giur. it., 1993,I, 1, 1550, con nota di Cimei, In tema discrittura privata: «crocesegno»; gli«equipollenti» della sottoscrizione.(29) Nel senso che la sottoscrizione èrequisito essenziale della scrittura pri-vata sono dottrina e giurisprudenzaassolutamente prevalenti: v. per tuttiMarmocchi, Scrittura privata, cit., 970ss. (ed ivi riferimenti); Carpino, Scrit-tura privata, cit., 805. Va inteso per-tanto solo come una linea di tendenzail concetto di «crisi della sottoscri-zione», adombrato in dottrina da Irti, Ilcontratto tra «faciendum» e «factum»,cit., 135: «Questo processo, che chia-merei di crisi della sottoscrizione, èdestinato ad accelerarsi ed intensifi-carsi. I soggetti dell’economiamoderna non comunicano più con let-tere firmate dal mittente, ma attraversosegni trasmessi da apparati meccanici(telegramma su originale scritto, tele-gramma dettato per telefono, telex,telecopiert, ecc.). Il risultato dell’attivitàespressiva è sempre in un testo scritto,ma sprovvisto di firma autografa. Ilrequisito della sottoscrizione, storica-mente legato al contratto tra personepresenti ed all’uso sociale delle letteremissive, si scopre ormai incompatibilecon le moderne tecniche di fissazionee trasmissione della parola. I messaggiscritti vogliono liberarsi dal vincolodella firma, e perciò sollecitano nuovimetodi di imputazione, nuovi criteri diriferimento alla persona del dichia-rante. Metodi e criteri, non più legatialla firma autografa, ma all’uso esclu-sivo dell’apparato tecnico: codestaesclusività terrà il luogo della persona-lità della sottoscrizione. Una pronta edaccorta disciplina servirebbe a preve-nire le tortuose strade dell’analogia e learditezze della giurisprudenza».(30) Sul documento contrattuale, v. direcente la monografia di Di Sabato, Ildocumento contrattuale, Milano 1997.(31) Di Sabato, Il documento contrat-tuale, cit., 43.(32) Di Sabato, Il documento contrat-tuale, cit., 94.(33) Di Sabato, Il documento contrat-tuale, cit., 118.(34) Di Sabato, Il documento contrat-tuale, cit., 129 ss., ove l’affermazioneper cui «il documento costituisce unares che può presentarsi oltre che informa semplice anche in forma compo-sta: si può, infatti, ipotizzare che ildocumento possa essere costituito dauna pluralità di parti, ciascuna dellequali dotata di una qualche autonomia
(segue)
ARGOMENTI
572NOTARIATON. 6/1997
A
�
che ci riguarda – di notevoleimportanza: nell’ipotesi in cui siravvisi, nell’ambito della docu-mentazione elettronica, un’im-possibilità tecnica di associarepiù firme digitali ad un unicodocumento contrattuale, esisteràsempre la possibilità che le partidi un contratto (ed anche ilnotaio rogante o autenticante)contrassegnino più documentiinformatici, ciascuno dei qualiconcorrerà a costituire il con-tratto.
IL DOCUMENTOELETTRONICOPRIMA DELLA LEGGEN. 59/1997La dottrina ha avuto modo, giàda tempo, e quindi primadell’emanazione della legge n.59/1997, di approfondire letematiche del documento elet-tronico e dei problemi ad essoconnessi (35). Per documentoelettronico in senso stretto (36)si intende il documento formatodall’elaboratore elettronico,memorizzato in forma digitale econtenuto nella memoria cen-trale dell’elaboratore o nelle c.d.memorie di massa (principal-mente supporti magnetici edottici). In esso, «il linguaggioelettronico non costituisce sem-plice documentazione di unavolontà già espressa nelle formetradizionali, ma ne costituisce laforma, intesa come mezzoespressivo necessario di talevolontà» (37): unico mezzoespressivo, aggiungiamo, a pre-scindere da un’eventuale ripro-duzione su supporto diverso daquello informatico.È conclusione universalmentecondivisa in dottrina quella percui il documento elettronico èdocumento in senso giuridico,possiede cioè, non meno deldocumento cartaceo, tutte lecaratteristiche idonee a ricevere econservare i segni che manife-stano una determinata realtà giu-ridicamente rilevante. Infatti,come sopra chiarito, vi è, nelsistema, una sostanziale indiffe-renza normativa relativamente altipo di supporto materiale, cosìcome per il tipo di alfabeto o dilinguaggio da utilizzare per la
produzione di un documento giu-ridicamente rilevante. Da ciò si èricavata, già da tempo, la conse-guenza dell’ammissibilità dideposito di software presso il no-taio, facendo leva sull’ampio si-gnificato del termine documenti,che il notaio può ricevere indeposito ai sensi dell’art. 1 delR.D. 14 luglio 1937 n. 1666 (38).Altro risultato acquisito da partedella dottrina prevalente è l’iden-tificazione della c.d. forma elet-tronica con la forma scritta (39).
Note:(segue nota 34)
(...) Il documento contrattuale, dunque,può essere costituito da più documenti,ciascuno dei quali è in grado di assol-vere una propria funzione semantica»;Cass. 27 aprile 1995 n. 4645, in Rass.locazioni e condominio, 1995, 488 («uncontratto può essere unico anche sericavabile da più testi; un unico testopuò riunire più contratti»); Cass. 13 feb-braio 1992 n. 1751, in Giur. it., 1993, I,1076.
(35) Esiste già una corposa letteraturain tema di documento e contratto elet-tronico: Gallizia, Notariato, pubblicitàlegale e informatica, in questa Rivista,1997, 455; Orlandi, La paternità dellescritture, Milano 1997; Giaquinto–Ragozzo, Il sigillo informatico, in que-sta Rivista, 1997, 80; Miccoli, Cyberno-tary, in questa Rivista, 1996, 105;Zagami, Firme «digitali», crittografia evalidità del documento elettronico, inDir. dell’informazione e dell’informa-tica, 1996, 151 ss.; Scopacasa, Archi-viazione elettronica delle scritture con-tabili: profili normativi e operativi, inSocietà, 1995, 1399; Giannantonio,Manuale di diritto dell’informatica,Padova 1994; Finocchiaro, Docu-mento elettronico, in Contratto eImpresa, 1994, 433 ss.; Giacobbe,Spunti in tema di disciplina del con-tratto e tecniche informatiche, in Lega-lità e giustizia, 1993, 409; Di Giovanni,Il contratto concluso mediante compu-ter alla luce della convenzione di Romasulla legge applicabile alle obbligazionicontrattuali, in Dir. comm. internaz.,1993, 581; Gallizia, Il documento infor-matico e la sicurezza giuridica, in Riv.Not., 1992, 63 ss.; Del Vecchio, Rifles-sioni sul valore giuridico della sottoscri-zione elettronica, in Riv. Not., 1991,977 ss.; De Stefano, Documento elet-tronico – Notariato a rimorchio o a cas-setta?, in Federnotizie, 1991, 14; Irti,La memoria dell’impresa (dai quader-nacci di Francesco Datini ai nastrimagnetici), in Riv. dir. proc., 1991, 52;Devescovi, Titoli di credito ed informa-tica, Padova 1991; Paolucci–Ferra-rese, Il documento elettronico è docu-mento giuridico, in Federnotizie, 1990,23; Verde, Per la chiarezza di idee intema di documentazione informatica,in Riv. dir. proc., 1990, 715 ss.; Stal-lone, La forma dell’atto giuridico elet-
tronico, in Contratto e Impresa, 1990,756 ss.; Costa, Il credito documentarionell’area dei computers e della «smate-rializzazione» dei titoli rappresentatividelle merci nel commercio internazio-nale, in Banca, borsa e titoli di credito,1989, I, 601 ss.; Giannantonio, Il valoregiuridico del documento elettronico, inRiv. dir. comm., 1986, I, 261 ss.; Fran-ceschelli, Computer, documento elet-tronico e prova civile, in Giur. it., 1988,IV, 314; Borruso, Computer e diritto,Milano 1988; Parisi, Il contratto con-cluso mediante computer, Padova1987; Syx, La firma nei rapporti giuridicielettronici, in Dir. dell’informazione edell’informatica, 1987, 802 ss.; Bor-ruso, Tre tesi di fondo dell’informaticagiuridica, in Giur. it., 1986, IV, 219 ss.;Mirabelli, Contratto tra terminali edocumento elettronico, in Riv. Not.,1986, 769 ss.; Calò, Ammissibilità deldeposito di software presso un notaio,in Consiglio Nazionale del Notariato,Studi e Materiali, I, Milano 1986, 416ss.; Clarizia, Informatica e conclusionedel contratto, Milano 1985; Sys, Versde nouvelles formes de signature? Leproblème de la signature dans les rap-ports juridiques électroniques, in Droitde l’informatique, 1986, 133 ss..
(36) In dottrina si contrappone il docu-mento elettronico in senso stretto aldocumento elettronico in senso ampio,inteso quest’ultimo come quel docu-mento, formato con l’ausilio dell’elabo-ratore, ma successivamente stampatosu supporto tradizionale (quindi carta-ceo), come, ad esempio, i tabulati mec-canografici: v. in particolare, su taledistinzione, Giannantonio, Il valore giu-ridico del documento elettronico, cit.,265 ss. Di Sabato, Il documento con-trattuale, cit., 33, definisce il docu-mento informatico come il «supportosul quale sono impressi segni che sonopercepibili attraverso l’utilizzazione diparticolari strumenti meccanici».
(37) Giannantonio, Il valore giuridicodel documento elettronico, cit.,262–263.
(38) Calò, Ammissibilità del deposito disoftware presso un notaio, cit., 416 ss.
(39) La dottrina dominante affermal’identità tra forma scritta e documenta-zione su supporto elettronico: Gian-nantonio, Manuale di diritto dell’infor-matica, cit., 347; Borruso, Tre tesi difondo dell’informatica giuridica, cit.,224; Parisi, Il contratto conclusomediante computer, cit., 64. Nel senso,invece, che la «forma elettronica»costituirebbe un tertium genus rispettoalla forma scritta ed alla forma verbale,Clarizia, Informatica e conclusione delcontratto, cit., 100 (secondo il quale laforma elettronica è una forma demate-rializzata, né scritta né orale, pur parte-cipando maggiormente dei caratteridello scritto); Mirabelli, Contratto traterminali e documento elettronico, cit.,773 ss.; Stallone, La forma dell’atto giu-ridico elettronico, cit., 773 (secondo ilquale la c.d. forma elettronica sarebbeuna meta–forma, variabile in base almodo concreto in cui perviene al desti-natario). Le obiezioni effettuate allaricomprensione della forma elettronica
(segue)
ARGOMENTI
573NOTARIATON. 6/1997
A
�
È stato incisivamente affermatoche «con il computer, l’energiaelettrica – o più precisamente ilflusso degli elettroni – è diven-tato il nuovo mezzo di scritturadell’umanità: il nuovo inchiostrodi cui l’uomo si serve. Le memo-rie elettriche o elettroniche(quali che siano i supporti daiquali siano costituiti: interruttoriaperti o chiusi, transistors,chips, circuiti integrati, nastrimagnetici, ecc.) non sono altroche la nuova carta, cioè il nuovosupporto su cui l’uomo scrivecon il nuovo inchiostro. I bit(nella combinazione necessariaper rappresentare ogni caratterealfanumerico) non sono altroche il nuovo alfabeto, universalee internazionale, di cui l’uomopuò servirsi per esprimere qual-siasi opera del pensiero» (40).Ciò in quanto la legge, nel disci-plinare la forma scritta, non pre-scrive né quali debbano essere imezzi tecnici di registrazione deisegni, i supporti e gli alfabeti, néche i segni costituenti lo scrittodebbano poter essere letti in qua-lunque momento ad occhionudo, né che i segni attraverso iquali si estrinseca la scritturadebbano essere indelebili, né cheil supporto debba essere indi-struttibile (41). Ciò a prescin-dere dal fatto che, con l’attualeevoluzione tecnologica, alcunitipi di supporto informatico (inparticolare, i supporti ottici, nonriscrivibili, e le memorie ROM eWORM) (42) offrono garanziedi affidabilità, di durata e di inal-terabilità di gran lunga maggioridei supporti cartacei (43); d’al-tra parte, esistono tecniche diformazione e trasmissione deidocumenti elettronici cheoffrono garanzie di sicurezza (adesempio, contro i rischi di falsifi-cazione) sicuramente maggioririspetto ad analoghi documentiredatti su supporto cartaceo.Altro, e diverso discorso, unavolta inquadrata la c.d. formaelettronica nell’ambito dellaforma scritta, è quello relativoalla possibilità di formazione diuna scrittura privata elettronica.Prima dell’emanazione dellalegge 59/1997, la dottrina piùattenta segnalava, in assenza diun apposito intervento norma-
tivo che prevedesse un equipol-lente della firma autografa, l’im-possibilità di formare con lostrumento informatico una scrit-tura privata ai sensi degli artt.2702 e seguenti c.c., non poten-dosi apporre alla fine del docu-mento elettronico la sottoscri-zione di pugno dell’autore(quest’ultima considerata, comesi è visto, requisito essenzialedella scrittura privata) (44). Ciòportava a ridurre di molto la rile-vanza giuridica del documentoelettronico (essenzialmente aquelle fattispecie, e per queglieffetti per i quali la legge nonprevede la sottoscrizione).Al di là della situazione generalesopra descritta, esistevano tutta-via già prima della legge59/1997 una serie di norme, cheattribuivano rilevanza giuridica,sotto molteplici profili, al docu-mento ed alla documentazioneelettronica. Si può effettuare unarapida rassegna delle norme piùimportanti, alcune delle qualicontinuano a rivestire importan-za fondamentale nell’analisi del-la disciplina del documento elet-tronico (in senso stretto), anchesotto il profilo privatistico:— l’art. 491–bis c.p. (introdottodalla legge 23 dicembre 1993 n.
Note:
(segue nota 39)
nella forma scritta sembrano peraltroagevolmente superabili, in quanto:— non appare decisivo il requisito della«leggibilità ad occhio nudo», perchédiversamente dovrebbe negarsi carat-tere di scrittura al documento redatto incaratteri microscopici o in un linguag-gio cifrato o comunque non immediata-mente comprensibile, ma decifrabile;— il fatto che risulti necessario tradurrei segnali elettrici e/o magnetici insegnali visibili, attraverso il monitor o lastampante, non toglie che sia comun-que soddisfatta l’esigenza di conosci-bilità del messaggio contenuto nel sup-porto elettronico, al pari di quelloincorporato in un supporto cartaceo.Nel senso che l’esigenza di riconosci-bilità ed accessibilità, propria dellaforma, è soddisfatta anche dal docu-mento elettronico, Orlandi, La paternitàdelle scritture, cit., 501 («La memoriaelettronica conserva i segnali delle digi-tazioni sotto forma di impulsi magnetici,ridotti in unità informatiche (i bit): questiimpulsi non sono di per sé percepibilidirettamente dai sensi dell’uomo, ma sioffrono alla decodificazione della mac-china attraverso il codice binario, ilquale consente di convertire le lettere
ed i simboli di un alfabeto corrente inunità di senso, proprie del sistemabinario, e viceversa. La memoria elet-tronica, dunque, è già in sé un testointellegibile, giacché può essere lettoattraverso la decodificazione binaria:che il nudo senso umano sia insuffi-ciente alla lettura del testo non mutapunto la natura del fenomeno, perchénon esiste una modalità tipica ed esclu-siva della percezione sensoriale. L’os-servante sarà chiamato ad utilizzare lamacchina informatica, alla stregua diuna lente di ingrandimento»).
(40) Borruso, Tre tesi di fondo dell’infor-matica giuridica, cit., 224.
(41) Borruso, Tre tesi di fondo dell’infor-matica giuridica, cit., 224.
(42) Sulle memorie ROM (Read OnlyMemory) e WORM (Write Once ReadMany), vedi Zagami, «Firme digitali»,crittografia e validità del documentoelettronico, cit..
(43) Il livello di inalterabilità e di sicu-rezza della memorizzazione su sup-porto informatico (quest’ultimo definitocome «qualsiasi materiale idoneo adospitare la registrazione in bit dei dati,ad uso del computer, al quale vienesolitamente dato il nome di memoria»)dipende dalla concreta tipologia delsupporto adoperato (così come, delresto, esistono supporti cartacei più omeno resistenti, e inchiostri più o menoindelebili). È possibile, in particolare,distinguere:a) – supporti ottici (compact disks), osupporti di immagini, in cui i bit ven-gono registrati mediante incisione amezzo raggi laser; detti supporti nonsono riscrivibili, e sono in grado di rive-lare eventuali alterazioni; sono tuttaviariproducibili in più esemplari (ai sup-porti di immagini fa riferimento l’art.2220 c. c. nella sua attuale formula-zione, ai fini della conservazione dellescritture contabili);b) – supporti magnetici (nastri magne-tici, floppy disks, hard disks), ove laregistrazione dei bit avviene mediantemagnetizzazione o smagnetizzazionedi determinate parti del supporto; i daticosì memorizzati possono essere can-cellati o modificati senza che ciò sia inalcun modo rilevabile (in tal sensoCass. 10 dicembre 1987 n. 12676: «laregistrazione dei dati su nastro magne-tico o su disco a mezzo di computernon rende i dati immessi assoluta-mente intangibili, in quanto gli stessipossono sempre essere modificati oeliminati in qualsiasi momento median-te facili e semplicissimi comandi, senzalasciare traccia della precedente regi-strazione»);c) – supporti elettronici (in sensostretto), ove la registrazione dei bitavviene attraverso il passaggio delflusso degli elettroni attraverso appositiapparati meccanici.
(44) Nel senso che, prima della legge59/1997, non fosse concepibile unascrittura privata elettronica, Giannan-tonio, Manuale di diritto dell’informa-tica, cit., 354 ss.; Verde, Per la chiarez-za di idee in tema di documentazioneinformatica, cit., 721 (nota); Zagami,«Firme digitali», crittografia e validitàdel documento elettronico, cit.
ARGOMENTI
574NOTARIATON. 6/1997
A
�
547) definisce, ai fini penalisticie della falsità in atti, il documentoinformatico come «qualunquesupporto informatico contenentedati o informazioni aventi effica-cia probatoria o programmi spe-cificamente destinati ad elaborar-li»; lo stesso art. 491–bis disponeinoltre che: «Se alcuna delle fal-sità previste dal presente capo ri-guarda un documento informati-co pubblico o privato, siapplicano le disposizioni delcapo stesso concernenti rispetti-vamente gli atti pubblici e lescritture private» (45). La normariveste particolare importanza,tra l’altro, sia per la definizionedel documento elettronico, siaperché, attraverso essa, acquistacittadinanza nel nostro ordina-mento giuridico l’atto pubblicoelettronico. In altri termini, l’e-spressa applicabilità delle normein tema di falso documentale inatto pubblico al documento elet-tronico rende automaticamenteapplicabili, in caso di documentoredatto con le richieste formalitàda notaio o pubblico ufficialeautorizzato, ai sensi dell’art.2699 c.c., non solo le relativenorme penali, ma anche le altrenorme in tema di atto pubblico;— l’art. 2220 c.c. (come modifi-cato dall’art. 7–bis del D.L. 10giugno 1994 n. 357, convertitocon legge 8 agosto 1994 n. 489),al terzo comma, dispone, in temadi conservazione delle scritturecontabili, che: «Le scritture e idocumenti di cui al presente arti-colo possono essere conservatisotto forma di registrazioni susupporti di immagini, sempre chele registrazioni corrispondano aidocumenti e possano in ognimomento essere rese leggibilicon mezzi messi a disposizionedel soggetto che utilizza dettisupporti». Con successivodecreto ministeriale (a tutt’ogginon ancora emanato) dovrannoessere stabilite le modalità diconservazione dei detti supporti;— l’art. 7, comma 4–ter, del D.L.10 giugno 1994 n. 357, converti-to con legge 8 agosto 1994 n.489, dispone che: «A tutti gli ef-fetti di legge, la tenuta di qualsia-si registro contabile con sistemimeccanografici è considerata re-golare in difetto di trascrizione su
supporti cartacei, nei termini dilegge, dei dati relativi all’eserciziocorrente, allorquando anche insede di controlli ed ispezioni glistessi risultino aggiornati sugliappositi supporti magnetici e ven-gano stampati contestualmentealla richiesta avanzata dagliorgani competenti ed in loro pre-senza». La norma non consentequindi tout court la tenuta su sup-porto informatico della contabi-lità, e presuppone che comunquedebbano esistere dei registri carta-cei previdimati; riconosce tuttaviala rilevanza giuridica della tenuta(provvisoria) della contabilità susupporto magnetico;— l’art. 22 della legge 7 agosto1990 n. 241 dispone che: «È con-siderato documento amminini-strativo ogni rappresentazionegrafica, fotocinematografica, elet-tromagnetica o di qualunque altraspecie del contenuto di atti, ancheinterni, formati dalle pubblicheamministrazioni o, comunque,utilizzati ai fini dell’attività ammi-nistrativa». La norma, palese-mente, riconosce la rilevanza giu-ridica dell’atto amministrativoelettronico in senso stretto;— l’art. 3 D. Lgs. 3 febbraio 1993n. 39 sancisce che: «gli atti ammi-nistrativi adottati da tutte le pub-bliche amministrazioni sono dinorma predisposti tramite i si-stemi informativi automatizzati»;— l’art. 2, comma 15, della legge24 dicembre 1993 n. 537, stabili-sce che: «gli obblighi di conserva-zione e di esibizione di documen-ti, per finalità amministrative eprobatorie, previsti dalla legisla-zione vigente, si intendono soddi-sfatti anche se realizzati mediantesupporto ottico, purché le proce-dure utilizzate siano conformi aregole tecniche dettate, entro no-vanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge,dall’Autorità per l’Informaticadella Pubblica Amministrazionedi cui al D. Lgs. 12 febbraio 1993n. 39» (le relative regole tecnichesono poi state individuatedall’A.I.P.A. con deliberazione n.15 del 28 luglio 1994).
LA FIRMA DIGITALEPrima dell’emanazione della leg-ge 15 marzo 1997 n. 59 si discu-
teva in ordine alla sostituibilitàdella sottoscrizione autografa,nel documento elettronico, concongegni equipollenti, che fos-sero cioè in grado di realizzare, alpari della sottoscrizione, le fun-zioni fondamentali della stessa(indicativa, dichiarativa, proba-toria). Tra i vari strumenti astrat-tamente utilizzabili (firme «bio-metriche», PIN, ecc.) (46), ladottrina individuava il meccani-smo più sicuro nella firma digita-le (47) mediante crittografia (48)«a chiavi asimmetriche (49)»: ilsoggetto autore del documento(«Tizio») si munisce di unachiave «privata», segreta, me-diante la quale può criptare ilcontenuto di un documento (c.d.
Note:(45) Sulla rilevanza della nuova previ-sione normativa di reato in tema didocumento informatico, v. Padovani,Codice penale commentato, Milano1997 (sub. art. 491– bis); Petrone, Lerecenti modifiche del codice penale intema di documento informatico: pro-blemi e prospettive, in Dir. informa-zione e informatica, 1995, 259; Merli, Ilfalso nei documenti informatici, inGiust. pen., 1995, II, 182; Borruso–Buonomo–Corasaniti–D’Aietti, Profilipenali dell’informatica, Milano 1995;Sarzana, Informatica e diritto penale,Milano 1994; Trib. Como 21 settembre1995, in Informazione prev., 1995,1547, con nota di Marcelli, In materia difalsità del documento informatico.
(46) Sulle «firme biometriche», i PIN(Personal Identification Numbers), edanaloghe tecniche di riconoscimento,v. Zagami, op. ult. cit.; Giannantonio, Ilvalore giuridico del documento elettro-nico, cit., 263 ss..
(47) La firma digitale è definita dalladottrina come «un insieme di caratterialfanumerici risultante da complesseoperazioni matematiche di criptografiaeffettuate da un elaboratore su undocumento elettronico» (così Zagami,«Firme digitali», crittografia e validitàdel documento elettronico, cit., ed ivi,nota 11, ulteriori citazioni di dottrina).
(48) Crittografia, o attività del criptare,è quell’attività consistente nell’appli-care ad un dato testo un algoritmo che,in relazione ad una data variabile(chiave di criptazione), lo trasforma inun diverso testo, indecifrabile edincomprensibile da parte di chi nonpossiede la chiave.
(49) I sistemi crittografici si distinguonoin simmetrici (allorché una stessachiave (DES) viene utilizzata per crip-tare e decriptare) e asimmetrici(quando si utilizzano due chiavi (RSA),e cioè una chiave privata, o segreta,per la criptazione, e una chiave pub-blica per la decriptazione).
ARGOMENTI
575NOTARIATON. 6/1997
A
�
firma digitale), oppure, più sem-plicemente, apporre un’appen-dice crittografata al documentoche viene mantenuto in linguag-gio naturale (c.d. firma «inchiaro»). A tale chiave «privata»e segreta è associata una chiave«pubblica», che viene messa aconoscenza e a disposizione di unampio numero di persone, e cheserve per decodificare il docu-mento criptato con la chiave pri-vata. Conseguenza: solo chi è inpossesso della chiave privata diTizio può «firmare», e quindiassumersi la paternità del docu-mento; chiunque abbia la chiavepubblica di Tizio può leggere ildocumento, ma non potrà fir-marlo con la firma digitale diTizio, né modificarne il conte-nuto se l’intero testo è criptato.La sicurezza del sistema cosìcongegnato è accresciuta da ulte-riori cautele, per cui l’accessoalla chiave privata è in generesubordinato ad ulteriori chiavi(passwords), a conoscenza delsolo soggetto titolare della chiaveprivata. Il sistema richiede, per ilproprio funzionamento, l’esi-stenza di «Autorità di certifica-zione», incaricate di certificarel’autenticità delle chiavi attri-buite a «Tizio», in modo tale chesia garantita la provenienza dellachiave a lui intitolata (50). D’al-tra parte, è necessaria l’esistenzadi una normativa che sanzionil’uso illegittimo delle chiavi pri-vate altrui, di cui si sia venuti inpossesso accidentalmente, ovve-ro illecitamente.In costanza dei requisiti suindi-cati, la firma digitale è astratta-mente idonea a realizzare tutte etre le funzioni fondamentalidella sottoscrizione (51):— la funzione indicativa, inquanto in ogni firma digitale ènormalmente incluso un codicenumerico identificante la chiaveprivata e la corrispondentechiave pubblica, e porta quindiautomaticamente all’identifica-zione dell’autore del documento;— la funzione dichiarativa,quella cioè di assumere la pater-nità del documento;— la funzione probatoria,mediante la combinazione difirma digitale e certificato rela-tivo alla stessa.
A seguito di tali considerazioni,la migliore dottrina (52) ritenevache, in assenza di un interventonormativo che disciplinasse le«Autorità di certificazione» (equindi l’emissione delle coppiedi chiavi e la loro certificazione,vietandone l’uso ai non titolari),riconoscendo il valore legale(sostanziale e probatorio) dellafirma digitale, e prevedesse lesanzioni per l’uso illegittimodelle chiavi asimmetriche, lasottoscrizione autografa nonpotesse essere sostituita con la«firma digitale», se non previoaccordo contrattuale ai sensidell’art. 1352 c.c. (forma con-venzionale), e comunque relati-vamente a fattispecie che nonrichiedessero la forma scritta adsubstantiam. Un concreto esem-pio di accordo normativo sullafutura forma contrattuale daadottarsi tra gli aderenti all’ac-cordo stesso è l’E.D.I. (Electro-nic data interchange) (53).
LIMITIDELLA DISCIPLINAREGOLAMENTAREDEL DOCUMENTOELETTRONICOL’emanazione della legge 15marzo 1997 n. 59 ha sensibil-mente mutato il quadro norma-tivo preesistente. La norma,come già evidenziato, disponeche «Gli atti, dati e documentiformati dalla pubblica ammini-strazione e dai privati con stru-menti informatici o telematici, icontratti stipulati nelle medesimeforme, nonché la loro archivia-zione e trasmissione con stru-menti informatici, sono validi erilevanti a tutti gli effetti dilegge», rinviando peraltro a spe-cifici regolamenti da emanarsiper le modalità applicative. Ilprimo compito dell’interpreteconsiste, sotto il profilo metodo-logico, nell’individuare le novitàimmediatamente prodotte dal-l’emanazione della legge sud-detta; occorrerà quindi verificarequale può essere, tenuto contodella gerarchia delle fonti deldiritto, il contenuto degli ema-nandi regolamenti, vale a dire inquali limiti la fonte regolamen-
tare potrà derogare alle vigentinorme legislative in tema didocumentazione e documento.Occorre quindi preliminarmenteverificare quali siano i limitidella potestà regolamentare delGoverno in materia. Ai sensidell’art. 4 delle preleggi, «i rego-lamenti non possono contenerenorme contrarie alle disposi-zioni delle leggi». La norma vacoordinata con l’art. 17 dellalegge 23 agosto 1988 n. 400, chedisciplina in realtà diverse cate-gorie di regolamenti: al primocomma, sono previsti i regola-menti c.d. esecutivi o attuativi, diesecuzione delle leggi e deidecreti legislativi, nonché quelliche disciplinano l’attuazione el’integrazione delle leggi e deidecreti legislativi recanti normedi principio; al secondo comma,sono invece previsti i regola-menti c.d. delegati, per la disci-plina di materie non coperte dariserva assoluta di legge, e percui la legge, autorizzando l’eser-cizio della potestà regolamen-
Note:(50) L’Autorità di certificazione haessenzialmente il compito di associareuna chiave pubblica ad una certa iden-tità personale, previamente accertata;tale associazione viene effettuata in unapposito certificato, che non è altro cheun documento elettronico che effettual’associazione di cui sopra, e contieneinoltre informazioni sulle generalità deltitolare della chiave, sulla scadenza evalidità della stessa e sulla stessaAutorità certificante, il tutto suggellatodalla firma digitale dell’Autorità stessa.
(51) Così Zagami, «Firme digitali», crit-tografia e validità del documento elet-tronico, cit. (ove si chiarisce che, purrealizzando tutte le funzioni della sotto-scrizione, la firma digitale non ne pos-siede alcuni dei requisiti, che peròrispetto ad essa non hanno alcuna spe-cifica funzionalità: così per quanto con-cerne i requisiti dell’autografia, dellaleggibilità, dell’apposizione in calce aldocumento. La firma digitale possiede,invece, i requisiti essenziali della formascritta, della nominatività, della ricono-scibilità, della non riutilizzabilità).
(52) Zagami, «Firme digitali», crittogra-fia e validità del documento elettronico,cit..
(53) Sull’E.D.I., v. in particolare Fadda,L’ «electronic data interchange» nellanormativa italiana e straniera, in Dir.dell’informazione e dell’informatica,1994, 91 ss.; Zagami, «Firme digitali»,crittografia e validità del documentoelettronico, cit.; Finocchiaro, Docu-mento elettronico, cit..
ARGOMENTI
576NOTARIATON. 6/1997
A
�
tare del Governo, determina lenorme generali regolatrici dellamateria, e dispone l’abrogazionedelle norme vigenti, con effettodalla data di entrata in vigoredelle norme regolamentari (54).Sembra evidente che i regola-menti in oggetto non possanofarsi rientrare nella secondacategoria: la legge infatti nondispone in alcun modo l’abroga-zione di norme di legge a seguitodell’entrata in vigore dei regola-menti. Questi ultimi, quindi,potranno solo, nell’ambito dellenorme legislative vigenti, det-tare norme esecutive ed attua-tive, che specifichino le moda-lità di applicazione dell’art. 15secondo comma, ma che in nes-sun modo potranno dettarenorme incompatibili con quellelegislative previgenti. Occorreperaltro tener conto del dispostodell’art. 15 delle preleggi, anorma del quale l’abrogazionedi una legge può avvenire ancheimplicitamente, per incompati-bilità tra le nuove disposizioni ele precedenti: pertanto devonointendersi tacitamente abrogatedall’art. 15, secondo comma,legge 59/1997, tutte le prece-denti disposizioni legislativeincompatibili con il riconosci-mento dell’esistenza, rilevanza evalidità del documento elettro-nico. Per altro verso, deve rite-nersi che la nuova norma legisla-tiva influisca anchesull’interpretazione delle previ-genti disposizioni, le quali do-vranno, d’ora in avanti, essereintese nel senso che non pregiu-dichi il riconoscimento – a tuttigli effetti di legge – del docu-mento formato con tecnicheinformatiche. Nell’analisi chesegue, relativa ai singoli, speci-fici problemi della documenta-zione informatica, occorreràquindi verificare, volta per volta,i limiti della potestà regolamen-tare nella materia de qua.
LA SCRITTURAPRIVATAELETTRONICA DOPOLA LEGGE N. 59/1997Una prima evidente novità,risultante dall’art. 15, comma 2,
della legge n. 59/1997, è costi-tuita dall’espresso riconosci-mento legislativo, in via genera-lizzata, della stipulabilità informa elettronica dei contrattitra soggetti privati (55). Lamaggior parte delle norme finoad oggi emanate, infatti, puravendo dato cittadinanzanell’ordinamento giuridico aldocumento elettronico, si riferi-vano generalmente a documentiamministrativi, o comunque di-sciplinavano profili (come quel-lo penalistico) estranei all’am-bito del diritto privato (56). Lanorma, facendo riferimento agli«strumenti informatici o telema-tici», parla di «contratti stipulatinelle medesime forme», quasiche l’utilizzo dello strumento in-formatico costituisca una ulte-riore species del genus «forma»in contrapposizione alle tradi-zionali forme scritta e verbale. Èpreferibile, peraltro, anche inconsiderazione delle considera-zioni sopra riportate sulla equi-valenza tra forma scritta e«forma elettronica», ritenere cheil termine «forme» non sia statoutilizzato dal legislatore in sensotecnico, in contrapposizionequindi alla forma verbale o allaforma scritta, ma solamentecome sinonimo di «modalità» didocumentazione del contenutocontrattuale. In altri termini, illegislatore ha voluto sancireespressamente che la documen-tazione su supporto informaticodi un contratto è equiparabile aitipi tradizionali di documenta-zione, senza con ciò prendereposizione sul concetto di«forma» del negozio giuridico.La norma dispone che tali con-tratti «sono validi e rilevanti atutti gli effetti di legge». Si trattadi una disposizione di enormeimportanza: l’espresso riferi-mento al profilo della vali-dità (57), oltre a quello dellarilevanza, ed il riferimento a tuttigli effetti di legge induce a rite-nere che l’innovazione legisla-tiva attenga non solo e non tantoal profilo probatorio (già ante-riormente all’emanazione dellanorma, si riteneva applicabile aldocumento elettronico l’art.2712 c.c., e quindi si ricono-sceva la rilevanza probatoria
Note:(54) Sulle varie categorie di regola-menti, v. per tutti Guastini, Le fonti deldiritto e l’interpretazione, Milano 1993,194 ss.
(55) Il tema del contratto elettronico eraoggetto di studio già anteriormenteall’emanazione della legge 59/1997.V., in particolare, Sforza, Formazionedel consenso e strumenti informatici, inI Contratti, 1997, 89; Di Salvatore,Nascita e profili dei contratti informatici,in Nomos, 1996, 53; Franceschelli, Ilcontratto virtuale. Diritto nel cyberspa-zio, in I Contratti, 1995, 569; Cugini–Zulli, Affari con Internet: i problemi dellafirma virtuale, in Comm. Internaz.,1996, 721; Giacobbe, Spunti in tema didisciplina del contratto e tecniche infor-matiche, in Informatica e attività giuri-dica, 1993, 593; Franceschelli, Disci-plina generale del contratto ecomputer, in La civilistica italiana daglianni ‘50 ad oggi tra crisi dogmatica eriforme legislative, Milano 1991, 396;Clarizia, Informatica e conclusione delcontratto, Milano 1985.L’attenzione degli interpreti, peraltro, siconcentrava soprattutto sulla fattispe-cie in cui il computer, grazie ad un ido-neo programma, può determinare lafattispecie contrattuale secondo i criteridefiniti dall’algoritmo, in modo tale chelo stesso elaboratore, verificate le con-dizioni generali per la stipula, provvedeautonomamente ad inviare la propriaproposta o ad accettare quella dellacontroparte (ad esempio, macchineautomatiche per la distribuzione dibibite, benzina, ecc.). Ricorrendo talicircostanze, si contestava corretta-mente la possibilità di far ricorso alloschema giuridico della rappresen-tanza, che presuppone pur sempreuna capacità di intendere e di volere e,alla base, la capacità e soggettività giu-ridica del rappresentante. Altro, ediverso problema, è quello della con-clusione in via elettronica dei contrattiper i quali la legge richiede la formascritta ad substantiam. Sul tema v. inparticolare Clarizia, Informatica e con-clusione del contratto, cit., 24 ss.
(56) Nel settore specifico dei contrattinegoziati fuori dei locali commerciali,peraltro, già l’art. 9 del D. Lgs. 15 gen-naio 1992 n. 50 dichiarava applicabili ledisposizioni del decreto stesso «ai con-tratti conclusi mediante l’uso di stru-menti informatici o telematici».
(57) Sui concetti di validità ed invalidità,e sulla differenziazione rispetto ai con-cetti di rilevanza ed irrilevanza, v. Tom-masini, Invalidità, in Enc. dir., XXII,Milano 1971, 580–581 («Il giudizio in ter-mini di validità–invalidità e la qualifica dirilevanza–irrilevanza hanno un nessocon l’efficacia, ma operano su pianidiversi: il fatto è rilevante per ciò solo chel’interesse prospettato entra nell’ambitodegli interessi presi in considerazionedal diritto; il fatto è valido se l’interesseprospettato è giudicato conforme agliinteressi o ai valori del sistema ... Perchéun fatto sia valido o invalido deve essereprima un fatto rilevante: di un fatto irrile-vante non può mai dirsi che sia valido oinvalido»). Sul concetto di rilevanza giu-ridica, v. Falzea, Rilevanza, in Enc. dir.,XL, Milano 1989, 900 ss.
ARGOMENTI
577NOTARIATON. 6/1997
A
�
dello stesso) (58), quanto e so-prattutto al profilo della c.d.forma ad substantiam. Lanorma, cioè, non potendo evi-dentemente riferirsi ai contratti aforma libera (per i quali l’ido-neità dello strumento elettronicoera in re ipsa anche prima dellanovella) (59), non può che averriguardo ai contratti a forma vin-colata, e quindi alle fattispeciedisciplinate dall’art. 1350 c.c.,per le quali è prevista, a pena dinullità, la forma scritta. Ciòsignifica, quindi, che la docu-mentazione elettronica, inquanto forma scritta, è legislati-vamente equiparata, con lanorma in esame, alla documen-tazione su supporto cartaceo.Se ciò è vero, dalla norma inesame discende un’altra, impor-tante conseguenza: l’espressoriconoscimento della scritturaprivata elettronica, a prescin-dere dalla sottoscrizione auto-grafa dell’autore dello scritto.Se è vero, infatti, che la formaelettronica è forma scritta, e che,a norma dell’art. 15 comma 2della legge 59/1997, il contrattostipulato in forma elettronica è«valido e rilevante» a tutti glieffetti di legge, essendo impossi-bile l’apposizione della sotto-scrizione autografa al docu-mento elettronico ne deriva lapiena validità di quest’ultimoanche in assenza di sottoscri-zione. È evidente, peraltro, chetale validità è subordinataall’adozione degli accorgimentitecnici idonei a realizzare le trefunzioni fondamentali della sot-toscrizione (identificazione del-l’autore, assunzione di paternitàdel documento e probatorietà):ciò significa che, fino all’ado-zione dei regolamenti attuativi,la forma elettronica non saràconcretamente utilizzabile comeforma scritta ad substantiam.Allo stesso modo, l’efficacia diprova legale propria della scrit-tura privata (art. 2702 c.c.) nonpotrà essere attribuita al docu-mento elettronico fino a quandonon saranno stati emanati i rego-lamenti attuativi di cui sopra.Il regolamento governativo ope-ra una scelta di campo, adottan-do, per la firma digitale, il siste-ma di crittografia a chiavi
asimmetriche, e definisce, al-l’art. 1:— la firma digitale (art. 1, letterab) come «il risultato della proce-dura informatica (validazione)basata su un sistema di chiaviasimmetriche a coppia, una pub-blica ed una privata, che consenteal sottoscrittore tramite la chiaveprivata ed al destinatario tramitela chiave pubblica, rispettiva-mente, di rendere manifesta e diverificare la provenienza e l’inte-grità di un documento informa-tico o di un insieme di documentiinformatici»;— il sistema di validazione (art.1, lettera c) come «il sistemainformatico e crittografico ingrado di generare ed apporre lafirma digitale o di verificarne lavalidità»;— le chiavi asimmetriche (art. 1,lettera d) come «la coppia dichiavi crittografiche, una privatae una pubblica, in rapporto dicorrispondenza biunivoca, dautilizzarsi nell’ambito dei si-stemi di validazione o di cifra-tura di documenti informatici»;— la chiave privata (art. 1, let-tera e) come «l’elemento dellacoppia di chiavi asimmetriche,destinato ad essere conosciutosoltanto dal soggetto titolare;mediante il quale si appone lafirma digitale sul documentoinformatico o si decifra il docu-mento informatico in prece-denza cifrato mediante la corri-spondente chiave pubblica»;— la chiave pubblica (art. 1, let-tera f), come «l’elemento dellacoppia di chiavi asimmetrichedestinato ad essere reso pub-blico, con il quale si verifica lafirma digitale apposta sul docu-mento informatico dal titolaredelle chiavi asimmetriche o sicifrano i documenti informaticida trasmettere al titolare dellepredette chiavi»;— la certificazione (art. 1, letterah), come «il risultato della proce-dura informatica, applicata allachiave pubblica e rilevabile daisistemi di validazione, mediantela quale si garantisce la corri-spondenza biunivoca tra lachiave pubblica e il soggettotitolare cui essa appartiene, siidentifica quest’ultimo e si atte-sta il periodo di validità della
predetta chiave ed il termine discadenza del relativo certificato,in ogni caso non superiore a treanni»;— la validazione temporale (art.1, lettera i), «il risultato dellaprocedura di elaborazione infor-matica con cui si attribuisconoad uno o più documenti informa-tici una data ed un orario opponi-bili ai terzi»;— il certificatore (art. 1, letterak), «il soggetto pubblico o pri-vato, che effettua la certifica-zione, rilascia il certificato dellachiave pubblica, lo pubblica uni-tamente a quest’ultima, pubblicae aggiorna gli elenchi dei certifi-cati sospesi o revocati».Agli artt. 10 e seguenti vienequindi disciplinata la firma digi-tale; in particolare, l’art. 10,comma 2, espressamente disponeche: «L’apposizione o l’associa-zione della firma digitale al docu-mento informatico equivale allasottoscrizione prevista per gli attie documenti in forma scritta susupporto cartaceo»; l’art. 5,comma 1, chiarisce che: «Il docu-mento informatico sottoscrittocon firma digitale ai sensidell’art. 10, ha efficacia di scrit-tura privata ai sensi dell’art. 2702del codice civile», con ciò preci-sando ulteriormente quanto giàdisposto all’art. 4, comma 1 («Ildocumento informatico munitodei requisiti previsti dal presenteregolamento soddisfa il requisitolegale della forma scritta»).Il vero problema della firmadigitale è, come visto sopra, lanecessità della certificazionedelle chiavi asimmetriche daparte di una «Autorità di certifi-cazione», dotata di caratteristi-
Note:(58) Finocchiaro, Documento elettro-nico, cit.; Zagami, «Firme digitali», crit-tografia e validità del documento elet-tronico, cit.; Verde, Per la chiarezza diidee in tema di documentazione infor-matica, cit., p. 729 ss.; Stallone, Laforma dell’atto giuridico elettronico, cit.,777.
(59) Di Sabato, Il documento contrat-tuale, cit., 31, ove il rilievo che «nes-suno si sognerebbe di dubitare che uncontratto, per il quale non vi siano parti-colari prescrizioni formali, possaessere validamente concluso per tele-fono».
ARGOMENTI
578NOTARIATON. 6/1997
A
�
che di terzietà ed imparzialità(che gli statunitensi hanno defi-nito TTP, «Trusted ThirdParty»), oltre all’individuazionedi uno strumento idoneo a pro-vare che la chiave pubblica voltaper volta utilizzata sia valida,non revocata, non scaduta e nonsospesa ad opera del soggettoche l’ha certificata. Il regola-mento governativo definisce lafigura del certificatore, comesopra rilevato, all’art. 1, letterak); inoltre:— l’art. 8, comma 1, disponeche: «Chiunque intenda utiliz-zare un sistema di chiavi asim-metriche di cifratura con glieffetti di cui all’art. 2 devemunirsi di una idonea coppia dichiavi e rendere pubblica una diesse mediante la procedura dicertificazione effettuata da uncertificatore»;— lo stesso art. 8, al comma 3,prevede che l’attività di certifi-cazione – salvo quanto dispostodall’art. 17 per le chiavi di cifra-tura della pubblica amministra-zione – sia effettuata da certifica-tori inclusi in apposito elencopubblico, consultabile in viatelematica, predisposto, tenuto eaggiornato a cura dell’A.I.P.A., edotati di particolari requisiti(forma di società per azioni ecapitale sociale non inferiore aquello necessario per l’eserciziodell’attività bancaria da parte disoggetti privati, requisiti di ono-rabilità dei rappresentanti edamministratori, requisiti di com-petenza ed esperienza deiresponsabili tecnici; adozione distandards internazionali per iprocessi informatici utilizzati);— l’art. 9 disciplina gli obblighidel certificatore, che, in partico-lare, deve porre in essere tutte leattività necessarie per identifi-care con certezza il titolare dellechiavi, individuando a richiestaeventuali poteri di rappresen-tanza, rilasciare, revocare esospendere i certificati ricorren-done i presupposti, effettuan-done la dovuta pubblicità, atte-nersi alle regole tecniche ex art.3 ed alle norme di sicurezza deisistemi informatici e nel tratta-mento dei dati personali, nonrendersi depositario di chiaviprivate;
— l’art. 10, comma 5, disciplinala revoca, scadenza e sospen-sione delle chiavi, precisandoche in tal caso l’uso della chiavenon valida equivale a mancatasottoscrizione;— l’art. 17 disciplina la genera-zione, la conservazione, la certi-ficazione e l’utilizzo delle chiavipubbliche delle pubblicheamministrazioni, dei pubbliciufficiali non appartenenti allapubblica amministrazione edegli ordini ed albi professionalilegalmente riconosciuti;— l’art. 7 prevede che il titolaredella coppia di chiavi asimmetri-che può ottenere il deposito informa segreta della chiave pri-vata con le modalità e nelleforme di cui all’art. 605 c.c., inquanto applicabili.Il sistema delineato dall’ema-nando regolamento è quindi ilseguente: una o più Autorità dicertificazione (che possonoessere soggetti pubblici o pri-vati) effettuano la validazionedelle chiavi pubbliche, chedevono essere poi conservate epubblicate su apposito registro;la generazione delle chiavi asim-metriche avviene a cura di cia-scun soggetto interessato, chepuò poi o custodire in proprio lachiave privata, o depositarla informa segreta presso un notaio,utilizzando a tal uopo la proce-dura prevista dall’art. 605 c.c.per il deposito del testamentosegreto. L’uso illegittimodell’altrui chiave privata, ovverol’uso di una chiave privata la cuicorrispondente chiave pubblicanon sia validata e tuttora nonrevocata comporta l’obbligo dirisarcimento dei danni: il regola-mento, infatti, non potrebbe pre-vedere per tali comportamentisanzioni penali, in considera-zione della riserva assoluta dilegge in materia (art. 23 Cost.).Deve peraltro ritenersi che l’uti-lizzo di una chiave privata altruipossa ritenersi sanzionabile inbase alle norme sul falso docu-mentale (in atto pubblico o scrit-tura privata), espressamenterichiamate dall’art. 491–bis c.p.ed estensibili al documentoinformatico.A prescindere, poi, dal problemasanzionatorio, si pone il pro-
blema della imputazione deldocumento sottoscritto con lafirma digitale altrui, ovvero conuna firma digitale revocata, sca-duta o sospesa. Del problema sifa carico l’art. 10, comma 5, delregolamento, affermando che:«L’uso della firma digitale appo-sta o associata mediante unachiave revocata, scaduta osospesa equivale a mancata sot-toscrizione. La revoca o lasospensione, comunque moti-vate, hanno effetto dal momentodella pubblicazione, salvo che ilrevocante, o chi richiede lasospensione, non dimostri cheessa era già a conoscenza di tuttele parti interessate». La norma faapplicazione di due principi fon-damentali del nostro ordina-mento giuridico:— il principio di affidamento,per cui la firma digitale conservala propria efficacia – e quindidetermina l’imputazione deldocumento con essa contrasse-gnato al relativo titolare, pur seutilizzata da altri – fino a quandonon è data pubblicazione dellasospensione o revoca della rela-tiva chiave, ed i terzi non sonoposti, quindi, in grado di cono-scere l’inefficacia della chiavemedesima;— il principio di autoresponsa-bilità, per cui è fatto onere al sog-getto titolare della chiave privatadi denunciare alla competenteAutorità ogni evento (furto,smarrimento, ecc.) che possacomportare il pericolo di utilizzodella chiave stessa da parte dialtri, e quindi chiederne larevoca o sospensione. In man-canza di tale diligenza, verràimputata al soggetto titolare ogniattività documentale posta inessere utilizzando la chiave sud-detta (60).
Nota:(60) Per l’applicazione dei principi diaffidamento ed autoresponsabilitàalla fattispecie del documento e con-tratto elettronico, v. Mirabelli, Con-tratto tra terminali e documento elet-tronico, cit., 775; Di Giovanni, Il con-tratto concluso mediante computeralla luce della Convenzione di Romasulla legge applicabile alle obbliga-zioni contrattuali del 19 giugno 1980,cit., 598 e nota 59.
ARGOMENTI
579NOTARIATON. 6/1997
A
�
LUOGO DI STIPULAE CONCLUSIONEDEL CONTRATTOTRA ASSENTISono diverse le fattispecie, con-cretamente configurabili, chepossono dar luogo a problemi intema di luogo di conclusione delcontratto elettronico. Nulla quae-stio, ovviamente, nell’ipotesi incui la stipula avvenga tra soggetticontestualmente presenti, nelqual caso l’adozione della formaelettronica rileverà esclusiva-mente sotto il profilo del sup-porto prescelto per documentarel’accordo contrattuale, ma nonavrà rilievo nella individuazionedel luogo di stipula, che saràquello in cui le parti, contestual-mente presenti, apporranno lapropria firma digitale. Il pro-blema si pone, invece, nell’ipo-tesi di stipula del contratto interabsentes, che tra l’altro costituiràpresumibilmente una delle appli-cazioni più importanti ed utilidella contrattazione elettronica.Una volta approvate definitiva-mente le norme regolamentari diattuazione, sarà infatti possibilela trasmissione per via telematicadella proposta e dell’accettazionecontrattuali, con conseguenteconclusione del contratto nelmomento in cui, ai sensi degliartt. 1326 e 1335 c.c., l’accetta-zione giunge all’indirizzo delproponente. Il problema, in talicasi, consisterà evidentementenell’acquisizione della certezzain ordine al momento ed al luogodi ricezione dell’accettazione daparte del proponente (61). A taluopo, il regolamento governativoprevede (art. 12) che: «Il docu-mento informatico trasmesso pervia telematica si intende inviato epervenuto al destinatario se tra-smesso all’indirizzo elettronicoda questi dichiarato. La data el’ora di formazione, di trasmis-sione o di ricezione di un docu-mento informatico redatto inconformità alle disposizioni delpresente regolamento e alleregole tecniche di cui all’art. 3sono opponibili ai terzi. La tra-smissione del documento infor-matico per via telematica, conmodalità che assicurino l’avve-nuta ricezione, equivale alla noti-
ficazione a mezzo posta nei casiconsentiti dalla legge». Risultanocosì superate, grazie all’utilizzodella disposizione dell’art. 1335c.c., le discussioni in ordine aldestino del documento informa-tico spedito per posta elettronica,quando il ricevente non abbiamaterialmente acceso il propriocomputer e non abbia consultatoil contenuto della propria caselladi posta elettronica (62).La determinazione esatta delladata e dell’orario – opponibili aterzi – in cui è avvenuta la con-clusione del contratto, dipenderàdall’adozione di tecniche di «va-lidazione temporale», così comedefinita dall’art. 1, lettera i), delregolamento. Una volta risoltoquesto problema, il contrattopotrà senz’altro ritenersi con-cluso – ex artt. 1326 e 1335 c.c. –nel luogo in cui è individuabilel’indirizzo elettronico del propo-nente al quale è stata spedita ladichiarazione di accettazione(intendendosi per indirizzo elet-tronico, ai sensi dell’art. 1, letteraj), del regolamento, «l’identifica-tore di una risorsa fisica o logicain grado di ricevere e registraredocumenti informatici») (63).Lo sviluppo della contrattazionetra assenti, che potrà aver luogograzie ai nuovi strumenti infor-matici, renderà probabilmentemeno diffuso rispetto ad oggi ilricorso allo strumento della rap-presentanza. Sarà infatti possi-bile, oltre ad effettuare lo scam-bio di proposta ed accettazioneper via telematica, anche utiliz-zare strumenti evoluti quali lavideoconferenza (64), e sotto-scrivere da parte del riceventecon la «firma digitale» lo stessotesto contrattuale inviato dal mit-tente, decriptandolo in un primomomento, e quindi firmandolo einviandolo con la propria firmadigitale al mittente stesso.
CONTRATTOELETTRONICOE DIRITTOINTERNAZIONALEPRIVATOSi è visto sopra che l’adozionedel supporto informatico, qualeelemento materiale contenente
la rappresentazione immaterialedel contratto, rileva essenzial-mente sotto il profilo delle qua-lità e caratteristiche del docu-mento contrattuale (e quindi,essenzialmente, sotto il profiloprobatorio), mentre l’attività didocumentazione informatica insenso stretto investe il profilodella forma contrattuale. Èquindi alle norme internazional-privatistiche in tema di forma edi prova che occorre far riferi-mento per verificare la disciplinadi diritto internazionale privatodel contratto elettronico (65). A
Note:(61) Anteriormente all’emanazionedella legge 59/1997, si riteneva cheoccorresse individuare non tanto illuogo ove sono situati i terminali utiliz-zati per l’operazione contrattuale(poiché «il luogo in cui le volontà siincontrano, ed il contratto si perfe-ziona, tenendo conto che i collega-menti sono in tempo reale, è la reteelettronica – c.d. network»), ma piutto-sto il luogo ove è situata la gestionedella rete telematica, e quindi il serverdi rete: in tal senso Di Giovanni, Il con-tratto concluso mediante computer allaluce della convenzione di Roma sullalegge applicabile alle obbligazioni con-trattuali del 19 giugno 1980, cit., 605 ss.
(62) Miranda, «Surfing contracts»: lucenuova sulla conclusione del contrattomediante mezzi elettronici, in Vita Not.,1996, 665.
(63) Al «domicilio informatico» del pro-ponente fa riferimento, ai fini dell’indivi-duazione del luogo di conclusione delcontratto, Sforza, Formazione del con-senso e strumenti informatici, cit., 90.
(64) L’utilizzo dello strumento dellavideoconferenza è stato ritenuto ido-neo a realizzare la riunione del consi-glio di amministrazione della societàper azioni, già de iure condito, dal Tri-bunale di Milano (v. le Massime elabo-rate dalla VIII Sezione civile del Tribu-nale di Milano, in Le Società, 9, 1997,1091).
(65) Secondo Ballarino, Diritto interna-zionale privato, Padova 1996, 628, nelconcetto internazionalprivatistico diforma «rientrano le prescrizioni relativeal modo di redigere il documento richie-sto ... Poiché la forma, dilatandone ilconcetto, coincide con i mezzi attra-verso i quali la volontà viene manife-stata nel mondo esteriore, essa finisceper investire, come del resto si è giàaccennato, i mezzi “nuovi” di manife-stazione del consenso che general-mente interessano i rapporti contrat-tuali a distanza»; l’autore pertantoritiene che ove la legge di uno solo deicontraenti legittimi la conclusione delcontratto mediante telex, telefax esimili (e quindi anche con strumenti
(segue)
ARGOMENTI
580NOTARIATON. 6/1997
A
�
tal uopo, l’art. 57 della legge 31maggio 1995 n. 218 (Riformadel sistema italiano di dirittointernazionale privato) rinvia,per la disciplina del contratto edelle obbligazioni contrattuali,alla Convenzione di Roma sulleobbligazioni contrattuali del 19giugno 1980, che a sua voltacontiene delle specifiche dispo-sizioni in tema di forma e diprova (66).Sotto il profilo che interessa,viene quindi innanzitutto in con-siderazione l’art. 9 della Conven-zione di Roma, che distingue icontratti conclusi de praesenti daquelli inter absentes. Nel primocaso il contratto informatico èvalido se tale è considerato odalla legge che regola la sostanzadell’atto (quindi, principalmente,dalla legge scelta dalle parti o daquella con cui il contratto ha ilcollegamento più stretto), ovverodalla legge del luogo in cui il con-tratto è concluso. Nell’ipotesi,quindi, di intervento del notaioitaliano, trattandosi di contrattoconcluso in Italia è possibile, dimassima, affermare che il con-tratto concluso con strumentiinformatici è comunque valido,qualunque sia la cittadinanzadelle parti, in base alla lex lociactus. Trattandosi di contratto traassenti, il contratto informatico èvalido se previsto dalla lex sub-stantiae o, alternativamente,dalla legge del paese in cui sitrova una delle parti. Anche in talcaso, evidentemente, se il notaioautentica in via elettronica lafirma di una delle parti, evidente-mente questa parte si trova in Ita-lia, ed è possibile far riferimentoalla legge italiana sul contrattoelettronico.L’art. 9 della Convenzione pre-vede poi un regime speciale:— per i contratti dei consuma-tori, per i quali la forma è rego-lata sempre dalla legge del paesein cui gli stessi hanno la loro resi-denza abituale. Trattandosi,quindi, di consumatori residentiall’estero, il notaio avrà l’oneredi verificare che la legge dellaresidenza ammetta la conclu-sione del contratto con mezziinformatici;— per i contratti aventi adoggetto diritti reali o diritti di uti-
lizzazione su beni immobili: intale ipotesi sono applicabili leregole imperative sulla formadel paese in cui l’immobile èsituato, limitatamente alle ipo-tesi in cui tali regole, secondo lastessa legge, si applichino indi-pendentemente dal luogo di con-clusione del contratto e dalla lexsubstantiae (come avviene, adesempio, nell’ordinamento tede-sco). Pertanto, nulla quaestioove l’immobile sia sito in Italia;per immobili siti all’estero,occorrerà verificare se la lex reisitae pone delle regole inderoga-bili di forma che escludono laforma elettronica.Sotto il profilo specificamenteprobatorio (forse il più rilevantein tema di documento elettro-nico), l’art. 14, n. 2, della Con-venzione dispone che: «Gli attigiuridici possono essere provaticon ogni mezzo di provaammesso tanto dalla legge delforo quanto da quella tra le leggicontemplate dall’art. 9 secondola quale l’atto è valido quantoalla forma, sempreché il mezzodi prova di cui si tratta possaessere impiegato davanti al giu-dice adito». Il rinvio, quindi, èessenzialmente alle leggi richia-mate in tema di forma degli atti,salva la limitazione dell’applica-bilità della prova «elettronica»dinanzi al giudice concreta-mente adito per la fattispecie.Per concludere, occorre preci-sare che non si deve in nessuncaso tener conto, in tema didocumentazione elettronica, delrinvio operato dalle norme stra-niere di diritto internazionaleprivato alla legge di altro Stato:l’art. 13 della legge 218/1995esclude infatti l’applicazionedell’istituto del rinvio, in ognicaso, trattandosi di disposizioniconcernenti la forma degli atti.
TUTELADEL CONSUMATOREE CONDIZIONIGENERALIDI CONTRATTOL’art. 11, secondo comma, delregolamento governativo di-chiara applicabili al contrattoelettronico le disposizioni del D.
Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50 (con-tratti conclusi fuori dai localicommerciali) (67). L’esistenzadi un espresso rinvio non toglieche, anche in sua assenza, lenorme stesse avrebbero dovutoritenersi comunque applicabili,trattandosi di norme che discipli-nano la sostanza del contratto, enon investono in alcun modo lasua documentazione.Diverso discorso occorre fareper quanto concerne le disposi-zioni degli artt. 1341 e 1342 c.c.,relative alle condizioni generalidi contratto ed ai contratti con-clusi mediante moduli o formu-lari. Le disposizioni ivi conte-nute sono, in effetti, proprioattinenti al profilo della docu-mentazione, e stupisce il fattoche le stesse non siano state inalcun modo richiamate.Del problema si è già occupata ladottrina, anteriormente all’ema-nazione della legge 59/1997,quando pertanto la conclusionedel contratto elettronico potevaaver luogo solo nell’ambito di un
Note:(segue nota 65)
informatici), il contratto stesso saràvalido. Secondo Balladore–Pallieri,Diritto internazionale privato italiano,Milano 1974, 327, «appartengonocerto alla forma le prescrizioni ... per lequali si impongono determinati docu-menti ... per la validità di certe opera-zioni»: quindi, anche la problematicadella conclusione del contratto construmenti informatici.
(66) Per l’applicabilità delle norme dellaConvenzione di Roma ai fini della disci-plina del contratto elettronico, v.Sforza, Formazione del consenso estrumenti informatici, cit., 90; Di Gio-vanni, Il contratto concluso mediantecomputer alla luce della Convenzionedi Roma sulla legge applicabile alleobbligazioni contrattuali del 19 giugno1980, cit..
(67) L’art. 9 del D. Lgs. 50/1992, peral-tro, dichiara espressamente applicabilile disposizioni del decreto «ai contratticonclusi mediante l’uso di strumentiinformatici e telematici». Sui contratticonclusi fuori dei locali commerciali, v.Gorgoni, Contratti negoziati fuori deilocali commerciali, in Enc. giur. Trec-cani, IX, Roma 1994; Lipari (a cura di),Commentario al D. Lgs. 15 gennaio1992 n. 50 – Attuazione della direttivan. 85/577/CEE in materia di contrattinegoziati fuori dei locali commerciali, inNuove leggi civili commentate, 1993,176; Cartella, La disciplina dei contrattinegoziati fuori dei locali commerciali, inGiur. comm., 1992, I, 715.
ARGOMENTI
581NOTARIATON. 6/1997
A
�
previo accordo normativo sullaforma utilizzabile, ex art. 1352c.c.: la dottrina stessa ritenevanon valida la conclusione delcontratto elettronico, limitata-mente alle clausole vessatorie inesso contenute (68).Venendo all’analisi delle duedisposizioni, l’art. 1341 c.c.pone l’esigenza di specificaapprovazione per iscritto dialcune clausole, definite comevessatorie, specificamente indi-cate nella norma. Dottrina e giu-risprudenza ritengono concor-demente che il requisito dellaspecifica approvazione periscritto può ritenersi soddisfattosolo con una sottoscrizione auto-noma, apposta cioè ad unadichiarazione di accettazionedistinta da quella diretta allaconclusione del contratto (69).Mutatis mutandis, e sostituendoquindi il concetto di sottoscri-zione con quello di firma digi-tale, può ritenersi applicabile aldocumento elettronico la moda-lità della specifica sottoscri-zione, compatibilmente con lecaratteristiche tecniche di questoparticolare tipo di documento.Deve, cioè, ritenersi che possaessere associato al documentoprimario e principale, che incor-pora le dichiarazioni contrat-tuali, un documento accessorio,contenente le dichiarazioni diaccettazione delle clausole ves-satorie, sottoscritto con la firmadigitale del c.d. contraentedebole. Del resto, la normadell’art. 10, primo comma, delregolamento governativo pre-vede che una firma digitalepossa essere apposta, o associatacon separato documento, anchead un gruppo di documenti infor-matici, così come ad un singolodocumento informatico puòessere non solo apposta, maanche associata (con separatodocumento) una firma digitale.Per quanto attiene all’art. 1342c.c., che disciplina i contratticonclusi mediante moduli o for-mulari, predisposti per discipli-nare in maniera uniforme deter-minati rapporti contrattuali, lanorma rinvia al secondo commadell’art. 1341 c.c. quanto attienealla specifica approvazione periscritto delle clausole aggiunte,
ed inoltre dispone che tali clau-sole, qualora siano incompatibilicon quelle del modulo o formu-lario, prevalgono sulle altre.Anche nell’applicazione di taledisposizione occorre por mentealla peculiare natura del docu-mento elettronico, in particolarequello redatto su supportomagnetico, che consente, finoall’apposizione della firma digi-tale, la cancellazione e la sostitu-zione di parole e frasi senza cherisulti il tenore precedente allacorrezione. Ciò rende, quindi, ilpiù delle volte ultronea, rispettoal documento elettronico, la pre-visione dell’art. 1342 c.c..Nell’ipotesi, viceversa, in cui ilsupporto del documento elettro-nico non sia riscrivibile, occor-rerà applicare il detto art. 1342,e quindi, il più delle volte, asso-ciare un nuovo documento, spe-cificamente sottoscritto con lafirma digitale del contraentedebole, che contenga la corre-zione.
L’AUTENTICANOTARILEDEL CONTRATTOELETTRONICOLe procedure di certificazione erilascio delle chiavi asimmetri-che per l’apposizione della firmadigitale non sono sufficienti adeterminare con assoluta cer-tezza la provenienza del docu-mento elettronico dal soggettotitolare delle chiavi stesse: lachiave privata del soggettopotrebbe essere infatti venuta inpossesso di altri soggetti per lecause più svariate (negligenza,furto, ecc.); inoltre le chiavipotrebbero essere non valide, inquanto scadute o revocate. Ciòcomporta l’esigenza che peralcuni documenti – e segnata-mente, nell’ambito contrattuale,per quei contratti per i quali lalegge richiede, a svariati fini,l’autentica della sottoscrizione –venga verificata ad opera delnotaio o di altro pubblico uffi-ciale autorizzato ai sensi dell’art.2703 c.c. – come avviene per idocumenti cartacei di ugualecontenuto – l’autenticità e lavalidità della firma digitale
dell’autore del documento (70).A ciò occorre aggiungere l’esi-genza, per i documenti aventicontenuto negoziale, di con-trollo della legalità del negoziodocumentato, oltre che dellacapacità di agire dell’autore delnegozio e della volontarietàdell’atto; controllo di legalitàche la legge (art. 28, n. 1, L. not.)disciplina relativamente all’attopubblico notarile, ma che la pre-valente dottrina e giurispru-denza ritengono applicabileanche alla scrittura privata au-tenticata da notaio (71).Facendosi carico di tali esi-genze, l’art. 16 del regolamentogovernativo dispone, ai primidue commi, che: «Si ha per rico-nosciuta, ai sensi dell’art. 2703del codice civile, la firma digi-tale, la cui apposizione è autenti-
Note:(68) Finocchiaro, Documento elettro-nico, cit..
(69) Dottrina e giurisprudenza pratica-mente unanimi. V. comunque Bianca, Ilcontratto, Milano 1984, 364, e, tra la piùrecente giurisprudenza, Cass. 23 set-tembre 1996 n. 8405, in Mass. Foro It.,1996; Cass. 21 giugno 1995 n. 6976, inMass. Foro It., 1995.
(70) Secondo Zagami, «Firme digitali»,crittografia e validità del documentoelettronico, cit., «In realtà, ciò che vieneautenticata non è più la sottoscrizione– cioè la firma digitale – bensì è il certifi-cato, con il quale una certa chiave pub-blica viene abbinata ad una certa iden-tità personale accertata dal notaio o daaltro pubblico ufficiale autorizzato neimodi tradizionali (art. 2703, comma 2,c.c.). L’autenticazione si sposta in unafase diversa ed anteriore e si esauriscein un solo atto, valido poi per una molte-plicità di firme digitali». Sembra, inrealtà, che l’autore confonda il profilodella certificazione delle chiavi asim-metriche (che sicuramente deve esi-stere a monte, e che collega una deter-minata firma digitale ad una certa iden-tità personale) con l’autentica da effet-tuare volta per volta: requisito indi-spensabile, quest’ultimo, per verificarese nel caso concreto una certa firmadigitale sia tuttora valida e sia utilizzatadal suo legittimo titolare, piuttosto cheda un terzo che ne sia venuto abusiva-mente in possesso.
(71) Sull’applicabilità del controllo dilegalità, previsto dall’art. 28 n. 1 L. not.,alla scrittura privata autenticata, oltreche all’atto notarile pubblico, v. Petrelli,Atto pubblico e scrittura privata autenti-cata: funzione notarile e responsabi-lità, in Riv. Not., 1994, 1422 ss. (ed iviriferimenti di dottrina e giurispru-denza).
ARGOMENTI
582NOTARIATON. 6/1997
A
�
cata dal notaio o da altro pub-blico ufficiale autorizzato.L’autenticazione della firma di-gitale consiste nell’attestazione,da parte del pubblico ufficiale,che la firma digitale è stata appo-sta in sua presenza dal titolare,previo accertamento della suaidentità personale, della validitàdella chiave pubblica e del fattoche il documento sottoscrittorisponde alla volontà della partee non è in contrasto con l’ordina-mento giuridico ai sensi dell’art.28, numero 1, della legge 16 feb-braio 1913 n. 89».La norma fa menzione tout courtdell’art. 28 n. 1 L. not.: deveperaltro ritenersi che il riferi-mento sia effettuato esclusiva-mente alle autenticazioni effet-tuate da notaio o altro pubblicoufficiale tenuto all’osservanzadella legge notarile (ad esempio,console, segretario comunale,ufficiale rogante della P.A., ecc.);non avrebbe, infatti, alcun sensotale richiamo con riferimentoall’autentica di sottoscrizionieffettuata ai sensi e per gli effettidella legge n. 15/1968 su istanzealla pubblica amministrazione, osu dichiarazioni sostitutive di attonotorio o di certificazioni.L’autentica consiste innanzituttonell’attestazione che il pubblicoufficiale effettua che la firmadigitale è stata apposta in sua pre-senza. Ciò comporta l’esigenzache l’autore del documento elet-tronico effettui personalmente lacrittografia del documento (crit-tografia in cui consiste la firmadigitale) in presenza del notaio,utilizzando la propria chiave pri-vata (che consiste in un file conte-nente i relativi dati: questo filepotrà essere contenuto, material-mente, in un floppy disk che laparte può portare con sé e utiliz-zare con l’apparecchiatura har-dware propria, del notaio o diterzi). Rimane quindi escluso chel’operazione di apposizione dellafirma digitale possa essere effet-tuata dal notaio, o da altre per-sone diverse da colui che è l’au-tore del documento e la cui firmadigitale deve essere autenticata.Ciò comporterà, ovviamente,l’esigenza di un minimo di com-petenza informatica da parte dicoloro che vorranno utilizzare lo
strumento della contrattazioneelettronica, il che rappresentasicuramente una notevole diffe-renza rispetto ad oggi, essendoattualmente possibile che la partenegoziale che non sa neancheleggere, scrivere e sottoscriverepossa stipulare – con la formadell’atto pubblico notarile e conl’assistenza dei testimoni – qual-siasi negozio giuridico.Per quanto concerne gli altri pro-fili dell’autentica, e quindi l’ac-certamento dell’identità perso-nale della parte, il controllo dilegalità e di corrispondenza allavolontà di quanto documentato,nulla varia rispetto al sistemanormativo vigente ed applicabilein caso di autentica tradizionale.L’autentica consiste in una appo-sita dichiarazione del notaio:questa dichiarazione costituiràun documento elettronico a sestante, associato al documentoda autenticare, al quale vieneapposta la firma digitale delnotaio. Tale firma digitale faanche le veci del sigillo notarile,come espressamente dispone ilcomma 3 dell’art. 16 del regola-mento governativo.Lo stesso documento potrà pro-venire da più soggetti: in tal casoallo stesso documento dovrannoessere associate le firme di tuttele parti, firme che andrannoautenticate dal notaio nel modosopra descritto.Vi è poi il problema della conser-vazione della scrittura privataautenticata. L’art. 72, ultimocomma, L. not. prevede che lescritture private autenticate deb-bano essere restituite dal notaioalle parti, salvo contrario deside-rio delle stesse, nel quale ultimocaso il notaio dovrà custodirle, anorma dell’art. 61 L. not., unita-mente agli atti pubblici («A que-sto effetto li rilegherà in volumiper ordine cronologico, ponendosul margine di ciascun atto unnumero progressivo»). Bisognastabilire come questa disposi-zione possa essere applicata allascrittura privata elettronica, cheper sua natura è contenuta in unsupporto (nastro o disco) cui nonsono applicabili le disposizionisulla rilegatura in volumi. Si puòritenere peraltro che la norma siasuscettibile di un’interpreta-
zione evolutiva, che consentacioè di effettuare la conserva-zione con modalità compatibilicon la diversa natura del sup-porto: la disposizione suindi-cata, infatti, ha un senso solorispetto agli atti su supporto car-taceo, ma, una volta riconosciutaex lege la validità e rilevanza delcontratto elettronico, non si può,solo in ossequio ad una formali-stica e pedissequa lettura dellalegge del 1913, precludere ai pri-vati la possibilità di utilizzare lostrumento del contratto elettro-nico e di chiederne al notaio ildeposito presso il suo studio (eciò soprattutto alla luce dell’art.15, comma 2, della legge n.59/1997, che dichiara valida erilevante ad ogni effetto di legge,tra l’altro, l’archiviazione deldocumento elettronico con stru-menti informatici). D’altra parte,l’art. 2, comma 15, della legge24 dicembre 1993 n. 537, soprariportato, ha espressamente sta-bilito che: «gli obblighi di con-servazione e di esibizione didocumenti, per finalità ammini-strative e probatorie, previstidalla legislazione vigente, siintendono soddisfatti anche serealizzati mediante supportoottico, purché le procedure uti-lizzate siano conformi a regoletecniche dettate, entro novantagiorni dalla data di entrata invigore della presente legge,dall’Autorità per l’Informaticadella Pubblica Amministrazionedi cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993n. 39» (le relative regole tecni-che sono poi state individuatedall’A.I.P.A. con deliberazionen. 15 del 28 luglio 1994). Lanorma parla di finalità ammini-strative e probatorie, e se si con-corda con l’opinione prevalente,che definisce la funzione nota-rile come di amministrazionepubblica del diritto privato (72),
Nota:(72) Sull’inquadramento della funzionenotarile nell’ambito dell’amministra-zione pubblica del diritto privato, v.soprattutto Zanobini, L’amministra-zione pubblica nel diritto privato, inScritti vari di diritto pubblico, Milano1955, 19 ss.; Giuliani, Crisi del dirittosoggettivo e funzioni del notaio, in Riv.Not., 1973, 481 ss..
ARGOMENTI
583NOTARIATON. 6/1997
A
�
ed il notaio come esercente pri-vato di pubbliche funzioni, lastessa deve ritenersi automatica-mente applicabile al profilo inesame. In ogni caso, con normaregolamentare, attuativa del-l’art. 15, comma 2, della legge n.59/1997, deve ritenersi possibiledisciplinare quella che è unasemplice modalità di conserva-zione e di archiviazione con stru-menti informatici, espressamen-te prevista dalla stessa normalegislativa.
CONTRATTOELETTRONICOE ATTO PUBBLICONOTARILESi è visto che la forma scritta puòassumere, ai sensi dell’art. 1350c.c., le vesti della scrittura pri-vata o dell’atto pubblico (o, piùcorrettamente, del documentopubblico) (73). Quest’ultimaforma – richiesta ad substantiamper alcune tipologie di atti (qualiad esempio la donazione, lacostituzione di società di capi-tali, la convenzione matrimo-niale, ecc.) – consiste, come èstato autorevolmente rilevato, inuna dichiarazione del notaio chea sua volta dà atto delle dichiara-zioni delle parti dell’attostesso (74). Da ciò l’afferma-zione che l’atto pubblico notarileè documento notarile in sensoproprio, di cui unico autore è ilnotaio, e nel quale le sottoscri-zioni delle parti, dei testimoni efidefacienti, ha essenzialmenteuna funzione di garanzia (75).Se così è, la sottoscrizione delleparti nell’atto pubblico ha unavalenza minore di quella suapropria nella scrittura privata, e,una volta ammessa la scritturaprivata elettronica, non vidovrebbero essere, sotto questoprofilo, ostacoli per il riconosci-mento giuridico dell’atto pub-blico elettronico.D’altra parte, l’applicabilitàdella nuova normativa sul docu-mento elettronico all’atto pub-blico è comprovata da altrenorme legislative, precedentil’entrata in vigore della legge59/1997:— l’art. 491–bis c.p. parlaespressamente di «documento
informatico pubblico», dichia-rando applicabili allo stesso lenorme sul falso in atto pub-blico (76);— la legislazione speciale con-tiene una serie di previsionisull’emanazione dei documentiamministrativi in forma elettro-nica (77) – come del resto pre-vede anche l’art. 15, comma 2,della legge 59/1997 – e l’attoamministrativo è, per defini-zione, atto pubblico ex art. 2699c.c., in quanto redatto da pub-blico ufficiale autorizzato adattribuirgli pubblica fede nelluogo dove l’atto è formato.La disciplina «documentale»dell’atto pubblico in genere ècontenuta nell’art. 12 della legge4 gennaio 1968 n. 15, a normadel quale «gli atti ricevuti dainotai e tutti gli atti pubblici sonoredatti a stampa, o con scrittura
Note:
(73) Sulla maggior correttezzadell’espressione documento pubblico,in luogo di atto pubblico, v. Morello–Ferrari–Sorgato, L’atto notarile, cit.,153 ss.; Morello, Sottoscrizione, cit.,1007; Casu, L’atto notarile tra forma esostanza, cit., 7 ss..
(74) Montesano, Sull’efficacia probato-ria dell’atto pubblico convertito in scrit-tura privata, in Riv. dir. proc., 1954, I,105 («Il documento notarile rappre-senta immediatamente non l’atto delleparti, ma la dichiarazione del notaio,che a sua volta rappresenta quell’atto,percepito dal notaio»).
(75) Sul notaio quale unico autore deldocumento notarile, v. Morello–Fer-rari–Sorgato, L’atto notarile, cit., 236ss.; Montesano, Sull’efficacia probato-ria dell’atto pubblico convertito in scrit-tura privata, cit., 102 ss.; Lener, Attopubblico e sottoscrizione delle parti, inRiv. Not., 1978, 988 ss. (in quest’ul-timo, a p. 995, l’affermazione per cui lasottoscrizione della parte è «atto dicontrollo della parte sull’operato delnotaio»; ed a p. 996, «la sottoscrizionedelle parti, quando è inserita nel proce-dimento di formazione dell’atto nota-rile, è soltanto elemento di questo pro-cedimento (surrogabile nel suoambito); non fa il contratto, che nascecon la perfezione del procedimento ...L’atto notarile sottoscritto dalle parti ...resta atto del notaio, e del notaio sol-tanto»); Mariconda, Atto pubblico, inEnc. giur. Treccani («non può attribuirsialla sottoscrizione dell’atto pubblicoapposta dalle parti la stessa funzioneche ha la firma nella scrittura privata.Nel primo caso infatti la sottoscrizionedelle parti costituisce un elemento for-male, neppure indispensabile, del pro-cedimento dell’atto pubblico, che atte-sta la conformità di quanto
documentato dal pubblico ufficiale aquanto avvenuto in sua presenza,espresso dalle parti o da lui compiuto.Nella scrittura privata invece la sotto-scrizione significa appropriazione delcontenuto da parte di chi la sottoscriveed anzi appropriazione della documen-tazione stessa»); Casu, L’atto notariletra forma e sostanza, cit., 261 («sem-bra invece di poter affermare che la sot-toscrizione sia delle parti che degli altricomparenti nell’atto notarile si collochisullo stesso piano degli altri adempi-menti formali, tutti tesi ad attribuire ilmassimo di autorevolezza, anche sulpiano probatorio, al documento redattodal notaio. Questo documento è carat-terizzato dal fatto di avere un soloautore (il notaio) ... La sottoscrizionesta, sotto questo profilo, sullo stessopiano della lettura, della presenza deitestimoni, della scrittura del docu-mento da parte del notaio o di personadi sua fiducia»). Nel senso, invece, chele parti sono coautrici del documentonotarile pubblico, Di Sabato, Il docu-mento contrattuale, cit., 109 ss.;Orlandi, La paternità delle scritture, cit.,343 ss. (quest’ultimo distingue trapaternità della dichiarazione, riferitaalla parte, e paternità del documento,riferita al notaio; in realtà anche il notaioè autore di una sua propria dichiara-zione, avente ad oggetto le dichiara-zioni delle parti).
(76) Secondo Merli, Il falso nei docu-menti informatici, in Giust. pen., 1995,II, 188, nota 39, l’art. 491– bis c.p.assume una struttura analoga a quelladelle norme penali in bianco, in quantosi applica al documento elettronicoqualificabile – in base ad altre leggidiverse dalla norma penale incrimina-trice, come atto pubblico o scrittura pri-vata.
(77) Sul documento amministrativoelettronico, v. in dottrina Minerva, L’attoamministrativo in forma elettronica e lasicurezza dei sistemi informativi pub-blici, in Dir. dell’informazione e dell’in-formatica, 1995, 939 ss.; Masucci,L’atto amministrativo informatico. Primilineamenti di una ricostruzione, Napoli1993; voce «Teleamministrazione», inEnc. giur. Treccani, Roma 1993; Usai,Le prospettive di automazione delledecisioni amministrative in un sistemadi teleamministrazione, in Dir. dell’in-formazione e dell’informatica, 1993,163; Selleri, Gli atti amministrativi informa elettronica, in Dir. e società,1982, 133.L’atto amministrativo elettronico èdisciplinato altresì dall’emanandoregolamento di attuazione della legge59/1997: l’art. 18, comma 1, disponeche «Gli atti formati con strumenti infor-matici, i dati e i documenti informaticidelle pubbliche amministrazioni, costi-tuiscono informazione primaria ed ori-ginale da cui è possibile effettuare, sudiversi tipi di supporto, riproduzioni ecopie per gli usi consentiti dalla legge»;l’art. 19, comma 1, prevede poi che «Intutti i documenti informatici delle pub-bliche amministrazioni la firma auto-grafa, o la sottoscrizione comunqueprevista, è sostituita dalla firma digitale,in conformità alle norme del presenteregolamento».
ARGOMENTI
584NOTARIATON. 6/1997
A
�
a mano o a macchina». La normanasce, ovviamente, presuppo-nendo il supporto cartaceo comemateria documentale, ed in talsenso le espressioni «a stampa»e «con scrittura a mano» nonlasciano dubbi né alternative.L’espressione a macchina, vice-versa, consente un più ampiospettro di possibilità, essendocompatibile sia con la scrittura-zione su carta, sia con l’utilizzodi un supporto magnetico oottico, purché ciò avvenga, inentrambi i casi, mediante mac-chine e computers.Con specifico riferimento al pro-blema della giuridica configura-bilità dell’atto pubblico notarilein forma elettronica, occorreconsiderare che quest’ultimorichiede, a pena di nullità, unaserie di formalità, ricavabilidagli artt. 47 e seguenti L. not.:alcune di tali formalità compor-tano la necessità di arricchire ilcontenuto del documento condeterminate dichiarazioni omenzioni, altre incidono vice-versa sull’attività vera e propriadi documentazione (la presenzacontestuale delle parti, dei testi-moni e dei fidefacienti, la sotto-scrizione con nome e cognomein calce all’atto pubblico e suifogli marginali, la letturadell’atto pubblico da parte delnotaio con la presenza conte-stuale di tutti i soggetti suindi-cati), altre ancora riguardanoprofili inerenti alla conserva-zione del documento. Si tratta divedere se tutte o alcune delle for-malità in cui consiste la docu-mentazione pubblica notarile siaincompatibile con le caratteristi-che del documento elettronico.Non è incompatibile, innanzi-tutto, l’esigenza della sottoscri-zione con nome e cognome:come si è visto, nel documentoelettronico la sottoscrizione èsostituita, a tutti gli effetti, dallafirma digitale, e non vi è ragioneperché l’atto pubblico debbaavere, sotto tale profilo, un trat-tamento differente rispetto allascrittura privata.Non è di ostacolo neanche lanecessità della presenza conte-stuale delle parti e di eventualitestimoni e fidefacienti: è chiaroche il documento elettronico ma-
nifesta a pieno la propria utilità,rispetto al documento cartaceo,proprio nella contrattazione traassenti, e che in tal caso lo stessostrumento dell’atto pubblico nonpuò essere utilmente impiegato,ma ciò non toglie che, teorica-mente, nulla si opponga al fattoche più soggetti contestualmentepresenti dinanzi al notaio voglia-no documentare in forma elet-tronica le proprie dichiarazioni.Neanche l’esigenza della letturanotarile, eventualmente in pre-senza dei testimoni, dell’attopubblico rappresenta un osta-colo all’adozione della docu-mentazione elettronica: ilnotaio, infatti, può ben leggerel’atto sullo schermo del propriocomputer, anziché su carta.Quanto alla disciplina del docu-mento notarile pubblico in sensostretto, l’art. 54 stabilisce innan-zitutto che l’atto notarile deveessere scritto in lingua italiana:la norma può ben essere osser-vata mediante la redazione di undocumento elettronico, attesoche il linguaggio informaticoviene tradotto dall’elaboratorein linguaggio naturale (78), e ilrisultato che può essere visualiz-zato a video in nulla differisce daquello evidenziabile da un docu-mento cartaceo tradizionale.Non si ravvisa poi incompatibi-lità riguardo alle modalità didocumentazione disciplinatedall’art. 53 L. not. e, più in gene-rale, dall’art. 13 della legge 4gennaio 1968 n. 15 (scrittura-zione in carattere chiaro edistinto e facilmente leggibile,senza alterazioni, correzioni,abbreviature; modalità di corre-zione dell’atto mediantepostille): l’inalterabilità deldocumento elettronico è garan-tita, come sopra specificato,dalla crittografia dello stessoeseguita mediante l’apposizionedelle firme digitali, in modoancor più sicuro di quantoavviene per il documento carta-ceo. Quanto alle postille, diver-ranno praticamente inutili quelleprima delle sottoscrizioni,potendosi agevolmente effet-tuare le correzioni nel corpo deldocumento elettronico; sarannoinvece ben possibili le postilledopo l’apposizione delle firme
digitali delle parti, il che mate-rialmente avverrà associando aldocumento elettronico princi-pale un documento elettronicoaccessorio, munito delle firmedigitali delle parti e di quella delnotaio.Non vi sono neanche problemirispetto alla norma (art. 52 L.not.) che prevede l’apposizionedel sigillo notarile alla finedell’atto: l’art. 10, comma 6, delregolamento governativo, di-spone che: «L’apposizione dellafirma digitale integra e sostitui-sce, ad ogni fine previsto dallanormativa vigente, l’apposi-zione di sigilli, punzoni, timbri,contrassegni e marchi di qual-siasi genere».Quanto, infine, alle norme (artt.61 e 66 L. not.) sulla conserva-zione e rilegazione in volumidegli atti pubblici, si è visto, nelparagrafo precedente, come lerelative norme della legge del1913 debbano considerarsisuperate, da un lato con l’emana-zione dell’art. 2, comma 15,della legge 24 dicembre 1993 n.537, e dall’altro dalla normadell’art. 15, comma 2, dellalegge 59/1997, che espressa-mente dichiara valida e rilevantea tutti gli effetti di legge l’archi-viazione del documento elettro-nico con strumenti informatici.In conclusione, nessun ostacoloné concettuale né normativo sioppone all’adozione della formaelettronica per l’atto pubbliconotarile (79), subordinatamente
Note:(78) L’operatore umano digita allatastiera del computer in linguaggionaturale, che viene tradotto in bit, chea loro volta vengono tradotti, sul moni-tor o in stampa, in linguaggio naturale.
(79) In senso contrario la dottrina ante-riore all’emanazione della legge59/1997: Irti, La memoria dell’impresa(dai quadernacci di Francesco Datini ainastri magnetici), cit., scrive che «se lanorma richiede l’atto pubblico, allora lemoderne tecnologie debbono dichia-rare la loro impotenza. Non già per altrioneri formali, ma perché la leggestringe l’atto notarile al sostegno carta-ceo: l’immagine del foglio domina l’art.51 dell’ordinamento del 1913. Non èquesta la sede per esprimere voti odesideri: ma è certo che l’introduzionedell’atto pubblico elettronico non impo-
(segue)
ARGOMENTI
585NOTARIATON. 6/1997
A
�
all’emanazione delle norme tec-niche di attuazione, anche seprobabilmente viene meno, ri-spetto a tale tipo di atto, la con-creta utilità di adottare la formaelettronica in luogo di quella car-tacea tradizionale.
GLI ALLEGATIAL CONTRATTOELETTRONICOUn profilo particolarmente im-portante della documentazionecontrattuale in forma elettronicaè quello relativo all’allegazioneallo stesso di altri documenti,necessari o utili al fine di inte-grare la disciplina contrattuale, oprevisti dalla legge, a volte a penadi nullità. Si è precisato che «l’al-legato afferente ad un contrattocostituisce un documento auto-nomo ed indipendente rispetto aldocumento principale del qualecontiene informazioni integra-tive» (80). Le ipotesi normativa-mente previste di allegazioneobbligatoria sono molteplici:solo a titolo esemplificativo, sipuò rammentare che all’atto pub-blico notarile deve essere alle-gata, ai sensi dell’art. 51 n. 3 L.not., la procura; agli atti portantitrasferimento o costituzione didiritti reali immobiliari su terrenideve essere allegato il certificatodi destinazione urbanistica (art.18 L. 28 febbraio 1985 n. 47);all’atto costitutivo di società dicapitali deve essere allegato lostatuto (art. 2328 c.c.). All’attonotarile possono essere poi alle-gati documenti di varia natura,sia in forma di scrittura, sia informa grafica (ad esempio, plani-metrie e tipi di frazionamentocatastale).L’allegazione, secondo le moda-lità tradizionali, consistenell’unire materialmente il docu-mento cartaceo rappresentantel’allegato al documento cartaceoprincipale, in modo da formarneparte integrante (81). Ciò nonsignifica, peraltro, che l’unionedebba essere inscindibile (né,d’altra parte, potrebbe esserlo,trattandosi concretamente difogli di carta distinti). La garan-zia della corrispondenza deldocumento allegato con quelloche effettivamente è stato esibito
alle parti dal notaio è garantitadalla norma della legge notarileche prevede la sottoscrizionedegli allegati, a meno che si trattidi documento pubblico, auten-tico o registrato (art. 51, terzul-timo comma, L.not.), nel qualcaso il rinvio allo stesso docu-mento nel corpo dell’atto princi-pale è garanzia sufficiente perl’identificazione dell’allegato.Il problema si pone in manieraevidentemente diversa rispettoal documento elettronico. Og-getto dell’allegazione ad un do-cumento elettronico non può cheessere, ovviamente, un altro do-cumento elettronico, non ravvi-sandosi la possibilità di allegareun supporto cartaceo. L’allega-zione può avvenire associandoal documento principale il docu-mento elettronico accessorio, ilquale verrà contrassegnato conle firme digitali delle parti e delnotaio; trattandosi di un docu-mento elettronico provenienteda un’autorità pubblica, l’appo-sizione delle firme digitali delleparti e del notaio non sarà neces-saria.Il documento elettronico da alle-garsi potrà essere un originale,ovvero una copia, in forma elet-tronica, di un altro documento,cartaceo o elettronico. Pertanto,se l’originale del documento daallegarsi (procura, certificato didestinazione urbanistica, ecc.) ègià in forma elettronica, nullaquaestio; se, viceversa, l’origina-le è in forma cartacea, potrà effet-tuarsene una copia conforme informa elettronica, ed allegarequest’ultima; con l’avvertenzache il notaio o altro pubblico uffi-ciale non potrà in nessun caso ri-lasciare in forma elettronica unacopia di altra copia in forma car-tacea, potendo esclusivamentecertificare la conformità ad unoriginale, cartaceo o elettronicoche sia.Del problema dell’allegazione sioccupa, in parte, l’art. 16, comma4, del regolamento governativo,ove si prevede che: «Se al docu-mento informatico deve essereallegato altro documento formatoin originale su altro tipo di sup-porto, il pubblico ufficiale puòallegare copia informatica auten-ticata dell’originale, conser-
vando il documento originale conannotazione su di esso dell’avve-nuta utilizzazione e dei dati iden-tificativi del documento informa-tico cui è stato allegato». Ladisposizione, peraltro, non è suf-ficiente a risolvere i problemi intema di allegazione nell’ambitodella documentazione informa-tica. Occorre, infatti, tener pre-sente che, spesso, al notaio non èesibito, per l’allegazione, un ori-ginale, bensì una copia autenticasu supporto cartaceo: in tale ipo-tesi il notaio non potrà rilasciarecopia di una copia, e, salva l’ema-nazione di un’apposita norma
Note:(segue nota 79)
verirebbe la figura del notaro. Il comma3 dell’art. 47 – in che risiedono ladignità più alta e la responsabilità piùgrave del notaro – sopravviverebbecon diversi contenuti. L’obbligo di inda-gare la volontà delle parti, e di dirigerepersonalmente la compilazione inte-grale dell’atto, assumerebbe unastraordinaria densità tecnologica».Salvo l’auspicio di Irti, si può dire che –prima con l’emanazione dell’art.491–bis c.c., e con le norme che disci-plinano l’atto pubblico amministrativo,poi con il riconoscimento in genere delcontratto elettronico e con la disciplinadella firma digitale – l’iter deve ritenersiconcluso nel senso di una piena legitti-mità e cittadinanza dell’atto pubblicoelettronico nell’attuale ordinamentogiuridico, senza che il riferimentotestuale al foglio nell’art. 51 possaavere alcuna efficacia dirimente: lanorma sulle firme marginali, infatti, hauna precisa funzione che nel docu-mento elettronico non ha modo di espli-carsi, a meno che vi siano una pluralitàdi documenti elettronici, o files, tra lorocollegati, nel qual caso ognuno di essidovrà essere munito delle firme digitalidi tutte le parti, dei testimoni e delnotaio.
(80) Sugli allegati contrattuali, v. daultimo Di Sabato, Il documento contrat-tuale, cit., 159 ss..
(81) Casu, L’atto notarile tra forma esostanza, cit., 208: «Documento otitolo “allegato” all’atto vuole significaredocumento autonomo rispetto all’attostesso, cioè documento creato ante-riormente all’atto, da soggetto che soli-tamente non è lo stesso notaio, docu-mento che può rivestire o meno formadi atto pubblico. L’allegazione implicache questi documenti vengano fisica-mente acclusi all’atto notarile, del qualecostituiscono parte integrante, nelsenso che sono strumenti utilizzati perarricchire il contenuto dell’atto: trattasi,cioè, di documenti fisicamente distintidall’atto ma idealmente con esso colle-gati, perché servono a chiarirne o adampliarne il contenuto».
ARGOMENTI
586NOTARIATON. 6/1997
A
�
legislativa (e non regolamentare)che modifichi o integri il dispostodegli artt. 2714 e 2715 c.c., edell’art. 14 della legge 4 gennaio1968 n. 15, consentendo il rila-scio di copie informatiche dicopie cartacee, il problema rima-ne irrisolto.Per altro verso, l’art. 16, quartocomma, impone in via generaliz-zata una formalità (annotazionesull’originale cartaceo dell’av-venuta allegazione ad un docu-mento informatico, e conserva-zione dello stesso originale daparte del pubblico ufficiale) chesi giustifica esclusivamente perquei soli allegati che devonoessere utilizzati una sola volta (sipensi alla procura da utilizzarsi«in unico contesto»), ma che nonha alcuna ragion d’essere in tuttele altre ipotesi, costituendo soloun inutile appesantimento.
DOCUMENTOELETTRONICO ERILASCIO DI COPIEAUTENTICHEUna volta riconosciuta, nell’art.15, comma 2, della legge59/1997 la rilevanza e validitàdel documento in forma elettro-nica, ne discende automatica-mente – previa l’adozione, con ilregolamento attuativo, delleopportune modalità tecniche persostituire la sottoscrizione con lafirma digitale – la possibilità dirilascio di copie autentiche informa elettronica (82). Tale pos-sibilità è espressamente previstadall’art. 6, primo comma, delregolamento governativo, se-condo cui: «I duplicati, le copie,gli estratti del documento infor-matico, anche se riprodotti sudiversi tipi di supporto, sonovalidi e rilevanti a tutti gli effettidi legge se conformi alle disposi-zioni del presente regolamento».Al secondo comma, la norma ri-conosce alla copia rilasciata informa elettronica, se ad essa èapposta o associata la firma digi-tale del pubblico depositario au-torizzato o del pubblico ufficialeche la rilascia, la stessa efficaciaprobatoria della corrispondentecopia in forma cartacea (83).Si tratta, probabilmente, dell’in-
novazione più rilevante, sotto ilprofilo pratico, conseguente alrilascio di documenti in formaelettronica. La possibilità di rila-sciare copie autentiche con talimodalità renderà possibile la tra-smissione delle denunzie diiscrizione, ed il deposito degliatti notarili nei pubblici registri,unitamente alle relative note edomande di iscrizione, per viatelematica e senza quindi neces-sità di accedere materialmentepresso l’ufficio pubblico, effet-tuando mediante lo strumentoinformatico – ai sensi dell’art. 14del regolamento – anche i paga-menti delle somme previste dallalegge a titolo di tributi, tasse,diritti e via dicendo (84).La disciplina del rilascio di copiecon strumenti informatici pre-suppone la soluzione del pro-blema relativo all’identificazio-ne dell’originale: le tecnologieinformatiche, infatti, consen-tono di produrre più esemplariidentici del medesimo docu-mento, a ciascuno dei quali pos-sono essere associate le mede-sime firme digitali: si è all’uoporitenuto che il documento infor-matico possa essere creato in piùesemplari, e che gli stessi deb-bano essere riconosciuti comealtrettanti originali (85). Costi-tuirà pertanto copia autenticasolamente il documento infor-matico, rilasciato da pubblicoufficiale e contrassegnato dallasua firma digitale, che riporteràuna espressa attestazione di con-formità ad un ulteriore docu-mento informatico, contrasse-gnato dalla firma digitale dellostesso pubblico ufficiale e/o diterzi.L’art. 6 del suddetto regola-mento prevede, al terzo comma,anche la possibilità di rilasciarecopie informatiche di originalicartacei: «Le copie su supportoinformatico di documenti, for-mati in origine su supporto carta-ceo o, comunque, non informa-tico, sostituiscono, ad ognieffetto di legge, gli originali dacui sono tratte se la loro confor-mità all’originale è autenticatada un notaio o da altro pubblicoufficiale a ciò autorizzato, condichiarazione inserita nel docu-mento informatico e asseverata
con le modalità indicate daldecreto di cui al comma 1dell’art. 3». Ciò consente, prati-camente, al notaio di stipularel’atto in forma cartacea e tradi-
Note:(82) La possibilità di rilascio di copie informa elettronica, una volta disciplinatol’istituto della firma digitale, discende-rebbe peraltro automaticamente dalladisposizione dell’art. 14 della legge 4gennaio 1968 n. 15, per cui le copieautentiche di atti e documenti possonoessere ottenute, oltre che a mano od amacchina, «anche con altri procedi-menti che diano garanzia della riprodu-zione fedele e duratura dell’atto o docu-mento». D’altra parte, la necessitàinderogabile – de iure condito e de iurecondendo – dell’intervento di un pub-blico ufficiale per il rilascio di copie – aprescindere dalle tecniche adottabiliper garantire la conformità ad un origi-nale – discende dall’impossibilità di«sopperire allo svolgimento di un pro-cedimento intellettuale che devecomunque impegnare il pubblico uffi-ciale incaricato del rilascio della copia»(Di Sabato, Il documento contrattuale,cit., 141).
(83) L’art. 6 della bozza di regolamentorichiama esclusivamente gli artt. 2714e 2715 c.c.; devono, in realtà, ritenersiapplicabili tutte le norme della sezioneVI (artt. da 2714 a 2719), a secondache si tratti di copie integrali o parziali,di copie di originali depositati o menopresso il pubblico ufficiale che le rila-scia, ecc..
(84) Sui pagamenti in forma elettro-nica, anche con riferimento alle formegià diffuse nella prassi commerciale(Cash Dispenser e Bancomat, POSovvero Point of sale), v. in particolareMaccarone, I trasferimenti elettronici difondi nel diritto italiano, in Dir. dell’infor-mazione e dell’informatica, 1985, 605;Di Giovanni, Il contratto conclusomediante computer alla luce della con-venzione di Roma sulla legge applica-bile alle obbligazioni contrattuali del 19giugno 1980, cit., 587 ss.La raccomandazione emessa dallaCommissione CEE in data 8 dicembre1987 n. 87/598/CEE (in G.U. n. L 365del 24 dicembre 1987) ha definito«pagamento elettronico ogni opera-zione di pagamento effettuatamediante una carta a pista o a pistemagnetiche o incorporante un micro-processore, presso un terminale dipagamento elettronico o un terminalepunto di vendita».
(85) Di Sabato, Il documento contrat-tuale, cit., 147 ss.. Secondo Orlandi, Lapaternità delle scritture, cit., 502, «l’an-titesi tra copia ed originale si restringead un piano puramente cronologico,poiché i documenti hanno per defini-zione la medesima sostanza informa-tica ... Dinanzi a due dischi, recanti ilmedesimo contenuto informatico, pocoimporta stabilire quale sia l’originale oquale la copia: essi restituiscono lamedesima informazione elettronica».
ARGOMENTI
587NOTARIATON. 6/1997
A
�
zionale, e rilasciare poi informa-ticamente le copie per i pubbliciuffici.La norma regolamentare risolvealtresì – sia pure, a mio avviso,parzialmente – il problema dellatrasmissione ai pubblici ufficidegli atti originali, ove questa sianormativamente richiesta: bastipensare alle scritture private au-tenticate, non conservate negliatti del notaio autenticante, datrascrivere o iscrivere nei registriimmobiliari, o nel registro delleimprese, e per le quali le attualidisposizioni legislative e regola-mentari prevedono la trasmis-sione dell’originale. Il problema,ovviamente, non si ponenell’ipotesi in cui l’originale siaformato già su supporto elettro-nico: la normativa regolamentareha pertanto una sua ragion d’es-sere esclusivamente nelle ipotesiin cui l’originale sia formato susupporto cartaceo, e ne venganorilasciate delle copie su supportoinformatico. L’art. 6, comma 4,del regolamento, dispone che:«La spedizione o il rilascio dicopie di atti e documenti di cui alcomma 2 esonera dalla produ-zione e dalla esibizione dell’ori-ginale formato su supporto carta-ceo richieste ad ogni effetto dilegge». In effetti, deve ribadirsiche la norma regolamentare nonpuò in alcun modo abrogare unaprecedente norma legislativa chedisponga l’esibizione dell’atto inoriginale, mentre può, ovvia-mente, abrogare una precedentenorma regolamentare. Ne conse-gue che:— per quanto concerne l’iscri-zione nel registro delle imprese,l’esibizione della scrittura pri-vata rilasciata in originale è pre-vista dall’art. 11, comma 4, delD.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581(regolamento di attuazione delregistro delle imprese), chequindi, a seguito dell’entrata invigore del regolamento inoggetto, verrebbe implicita-mente abrogato per quanto con-cerne gli atti (o le copie) in formaelettronica (salvo che, per lesocietà di persone, si ritenga chel’art. 2296 c.c. imponga il depo-sito in originale della scritturaprivata autenticata rilasciata, nelqual caso occorrerebbe, per il
deposito della copia informaticain luogo dell’originale, un’appo-sita norma legislativa);— relativamente alla trascri-zione, iscrizione o annotazionenei registri immobiliari, l’ob-bligo di esibizione dell’originaleè imposto dall’art. 2658 c.c., chenon può essere modificato da unregolamento. Ne deriva che, finoall’emanazione di un’appositanorma legislativa che modifichiil suddetto art. 2658, non potràprodursi una copia informaticadi un originale cartaceo (purpotendosi, ovviamente, pro-durre l’originale informatico).
L’EFFICACIAPROBATORIADEL DOCUMENTOELETTRONICOGià anteriormente all’emana-zione della legge 59/1997, laprevalente dottrina ritenevaapplicabile al documento elet-tronico la disposizione dell’art.2712 c.c., ai sensi del quale ogni«rappresentazione meccanica difatti e di cose» forma pienaprova dei fatti e delle cose rap-presentate, se colui contro ilquale è prodotta non ne discono-sce la conformità ai fatti o allecose medesime. L’art. 5, primocomma, del regolamento gover-nativo dispone che: «Il docu-mento informatico sottoscrittocon firma digitale ai sensidell’art. 10 ha efficacia di scrit-tura privata ai sensi dell’art.2702 c.c.». Il successivosecondo comma prevede poiche: «Il documento informaticomunito dei requisiti previsti dalpresente regolamento ha l’effi-cacia prevista dall’art. 2712 c.c.e soddisfa l’obbligo previstodagli artt. 2214 e seguenti c.c. eda ogni altra analoga disposi-zione legislativa o regolamen-tare». Ciò significa, concreta-mente, che l’apposizione dellafirma digitale, comportando lapiena equiparazione tra docu-mento elettronico e scrittura pri-vata, determina altresì – ex art.2702 c.c. – l’efficacia di provalegale (86), fino a querela difalso, del documento così for-mato, limitatamente alla prove-
nienza della dichiarazione da chil’ha sottoscritta, se colui controil quale la scrittura è prodotta nericonosce la sottoscrizione,ovvero se questa è legalmenteconsiderata come riconosciuta(ad esempio, nel caso di firmadigitale autenticata). Occorreinoltre tener conto della disposi-zione dell’art. 2700 c.c. (appli-cabile anche al documento elet-tronico pubblico), in base allaquale l’atto pubblico fa pienaprova, fino a querela di falso,della provenienza del docu-mento dal pubblico ufficiale chelo ha formato, nonché delledichiarazioni delle parti e deglialtri fatti che il pubblico ufficialeattesta avvenuti in sua presenzao da lui compiuti.La portata dell’art. 2712 c.c.,richiamato nel secondo commadell’art. 5, deve essere quindidelimitata con riferimento allesole ipotesi di documenti elettro-nici privi di firma digitale.
TRASMISSIONEPER VIA TELEMATICADI ATTI E DENUNCIEPER L’ISCRIZIONENEI PUBBLICIREGISTRIUna delle novità più rilevanti,conseguenti al riconoscimentodel documento informatico, ècostituita dalla possibilità di tra-smissione per via telematica didocumenti, contrassegnati dallafirma digitale dell’autore equindi con garanzie di certezzadella loro provenienza, alla pub-blica amministrazione. Già daqualche tempo sono state intro-dotte nel nostro ordinamentodelle norme che disciplinano latrasmissione per via telematicadelle note di trascrizione e iscri-zione e delle domande di annota-mento alla Conservatoria deiRegistri Immobiliari o ai Servizidi pubblicità immobiliare degliUffici del Territorio per via tele-matica. In particolare:— l’art. 16 della legge 27 feb-
Nota:(86) Sull’efficacia probatoria della scrit-tura privata, v. Marmocchi, Scritturaprivata, cit., 974 ss..
ARGOMENTI
588NOTARIATON. 6/1997
A
�
braio 1985 n. 52, successiva-mente modificato con D.L. 20giugno 1996 n. 323, convertitoin legge 8 agosto 1996 n. 425,demanda ad un successivodecreto interministeriale la pre-visione dell’autorizzazione (edin un secondo momento dell’ob-bligo) alla presentazione dellenote di trascrizione e iscrizione edelle domande di annotamentoredatte su supporto informatico,ed alla trasmissione delle notestesse mediante l’uso di elabora-tori elettronici;— con D.M. 9 gennaio 1990sono state emanate le norme perla produzione delle note edomande su supporto informa-tico;— con D.M. 10 ottobre 1992 èstato istituito il servizio telema-tico per la trasmissione via cavodelle note e domande di cuisopra;— il D.M. 29 aprile 1997dispone che le note di trascri-zione, di iscrizione e le domandedi annotazione possono essereredatte su supporto informatico,ovvero trasmesse mediante l’usodi apparecchiature elettroniche.La norma peraltro stabilisce chela formalità si intende richiestaquando viene presentato in con-servatoria o all’ufficio del terri-torio il titolo relativo, anche se laproduzione del supporto infor-matico o la trasmissione telema-tica sia avvenuta in precedenza.Non è invece richiesta, comeavveniva con i precedenti decretiministeriali, la sottoscrizione delrichiedente sulla stampa carta-cea delle note, effettuata dall’uf-ficio all’atto della presenta-zione;— con altro D.M. in data 29aprile 1997 è prevista l’obbliga-torietà di redazione delle note edomande di cui sopra su sup-porto informatico, a partire dalladata stabilita, per ciascun uffi-cio, con decreti direttoriali; lamancata osservanza di talemodalità obbligatoria costituiràmotivo di rifiuto della formalità.Le disposizioni legislative suin-dicate disciplinano esclusiva-mente la trasmissione telematicadelle note e domande; peraltro,l’introduzione nel nostro ordina-mento della firma digitale com-
porterà, a seguito dell’emana-zione definitiva del regolamentodi attuazione della legge59/1997, la possibilità di tra-smettere per via telematica, oltrealle note e domande, anche lacopia autentica in forma elettro-nica dell’atto che dà luogo al tra-sferimento immobiliare. Devequindi ritenersi che, con l’ema-nazione del regolamento, vengaautomaticamente superata ladisposizione dell’art. 1, comma3, del D.M. 29 aprile 1997, nellaparte in cui prevedeva uno sfasa-mento temporale tra la data ditrasmissione della nota e la datadi presentazione del titolo pressol’ufficio, ricollegando a que-st’ultima gli effetti della presen-tazione della formalità.Si pone, peraltro, il problema dicome assicurare la certezzadell’avvenuta ricezione, nonchédella data di ricezione, da partedell’ufficio, di una trascrizione,iscrizione o annotamento che perlegge devono essere effettuatientro trenta giorni dalla stipuladell’atto, e comunque, ai sensidell’art. 2671 c.c., il più prestopossibile, tenuto conto che ilmomento di presentazione dellaformalità all’ufficio determina ilgrado dell’iscrizione o della tra-scrizione. Il problema – tenutoconto che le tecnologie informa-tiche consentono di determinareanche la data di trasmissione ericezione di un documento informa elettronica – è risoltodall’art. 12, commi 1 e 2 delregolamento governativo, se-condo cui: «Il documento infor-matico trasmesso per via telema-tica si intende inviato epervenuto al destinatario se tra-smesso all’indirizzo elettronicoda questi dichiarato. La data el’ora di formazione, di trasmis-sione o di ricezione di un docu-mento informatico redatto inconformità alle disposizioni delpresente regolamento e alleregole tecniche di cui all’art. 3sono opponibili ai terzi».Per quanto concerne il registrodelle imprese (istituito con l’art.8 della legge 580/1993), il rela-tivo regolamento di attuazione(D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581)non prevede la trasmissione pervia telematica delle denuncie di
iscrizione, pur prevedendo lapossibilità di spedizione perposta delle denuncie medesime.Al contrario, si è ritenuto in dot-trina che – in sintonia con l’art.2189 c.c. – il regolamento nonconsenta in alcun modo la tra-smissione telematica delledenuncie di iscrizione, preve-dendo invece, all’art. 11, che leiscrizioni sono eseguite su pre-sentazione della domanda sotto-scritta e previo accertamentodell’autenticità della sottoscri-zione da parte dell’ufficio (87).Una volta che sarà stato emanatoil regolamento di attuazionedella legge 59/1997, peraltro,deve ritenersi che le disposizionisulla firma digitale, unitamentealla disposizione dell’art. 12,comma 3 (secondo cui: «La tra-smissione del documento infor-matico per via telematica, conmodalità che assicurino l’avve-nuta ricezione, equivale allanotificazione a mezzo posta neicasi consentiti dalla legge»)legittimeranno la spedizione pervia telematica delle copie degliatti e delle denuncie di iscrizionee trascrizione, ed il pagamentodelle tasse e dei diritti in via tele-matica, ai sensi dell’art. 14 delregolamento stesso.
IL REGIME FISCALEDEL DOCUMENTOELETTRONICOLa stipula di contratti in formaelettronica comporterà la neces-sità di adattare alla nuova realtàtutta una serie di norme fiscaliche, attualmente, partono dalpresupposto che l’unica forma didocumentazione possibile siaquella cartacea. Nulla quaestioper ciò che concerne la disci-plina di quelle imposte (come, adesempio, l’imposta sul valoreaggiunto) che prescindono dalprofilo documentale del nego-zio. Nessun problema, d’altraparte, per le norme che prevedo-no la forma scritta quale presup-posto dell’imposizione tributa-ria, alla luce dell’equiparazione,
Nota:(87) Zagami, Firme «digitali», crittogra-fia e validità del documento elettronico,cit., nota 63.
ARGOMENTI
589NOTARIATON. 6/1997
A
�
sopra vista, tra documentoscritto e documento elettronico:così l’art. 2, lettera a) del D.P.R.26 aprile 1986 n. 131, chedichiara soggetti a registrazionegli atti indicati nella tariffa, seformati per iscritto nel territoriodello Stato; così anche perquanto concerne le norme delD.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642(disciplina dell’imposta dibollo) che fanno riferimento allascrittura. Per quanto specifica-mente concerne quest’ultimaimposta, nell’impossibilità di farriferimento in toto al concetto difoglio composto da quattro fac-ciate, di cui all’art. 4 del suddettoD.P.R., deve ritenersi, sin d’ora,estensibile per analogia al docu-mento elettronico la disposi-zione del secondo commadell’art. 4, che, con riferimentoai tabulati meccanografici,dichiara dovuta l’imposta perogni 100 linee o frazione di 100linee utilizzate. Sorgono, invece,problemi per quanto concerne lemodalità di pagamento dell’im-posta. L’art. 3 del D.P.R.642/1972 stabilisce che l’impo-sta è corrisposta, secondo ledisposizioni della tariffa alle-gata:— in modo ordinario, mediantel’impiego della carta bollata(modalità inapplicabile, per suastessa natura, al documento elet-tronico);— in modo straordinario,mediante marche da bollo, vistoper bollo o bollo a punzone;— in modo virtuale, mediantepagamento all’ufficio del regi-stro o ad altri uffici autorizzati.Con riferimento agli atti ricevutio autenticati da notaio, l’art. 1della tariffa allegata al suddettoD.P.R. prevede, alternativa-mente, quali modalità di paga-mento, la carta bollata, le mar-che, il bollo a punzione, oppureil versamento all’ufficio delregistro per gli atti soggetti aregistrazione in termine fisso eper le relative copie presentateunitamente ad essi. Esclusa l’ap-plicabilità della carta bollata, edanche delle marche o del bollo apunzone, rimane la modalità delversamento all’ufficio del regi-stro, che tuttavia è limitata agliatti soggetti a registrazione ed
alle copie presentate all’ufficiodel registro: rimane quindi ilproblema per gli atti non soggettia registrazione, e per le altrecopie degli atti registrati chesiano soggette a bollo. Pro-blema, allo stato, irresolubilesenza un apposito interventonormativo (a meno di ritenereche l’obbligo possa essereassolto mediante l’apposizionedella marca da bollo su copiecartacee appositamente formate:soluzione che peraltro sarebbepriva di qualsiasi base norma-tiva).L’art. 2 della tariffa, relativa-mente alle scritture private, pre-vede quali modalità di paga-mento soltanto la carta bollata, lemarche ed il bollo a punzone,tutte inapplicabili al documentoelettronico. Anche in tal caso,non resta che attendere un inter-vento normativo.Del resto, l’art. 4, comma 2, delregolamento governativo espres-samente dispone che «Gli obbli-ghi fiscali inerenti ai documentiinformatici ed alla loro riprodu-zione su diversi tipi di supportosono assolti secondo le modalitàdefinite con decreto del Ministrodelle Finanze». Occorrerà quindil’emanazione di un decreto mini-steriale per i profili non risolubiliin via interpretativa, tenendoperaltro conto della gerarchiadelle fonti normative, e quindidell’impossibilità che un decretoministeriale modifichi normelegislative. Con riferimentoall’attuale tariffa dell’imposta dibollo (approvata con D.M. 20agosto 1992, e contenente tral’altro le norme suddescritte sullemodalità di pagamento), la stessapotrà essere invece modificatacon il decreto ministeriale di cuiall’oggetto.
LA FATTURAELETTRONICAL’art. 21 del D.P.R. 633/1972dispone che la fattura si ha peremessa all’atto della sua conse-gna o spedizione all’altra parte.In particolare, il termine «conse-gna» presuppone il supporto car-taceo, mentre il termine «spedi-zione», più generico, può benadattarsi anche alla trasmissione
per via telematica. D’altra parte,la legge non impone in alcunmodo l’obbligo di sottoscrizionedella fattura, il che facilita ulte-riormente l’adozione di tecnicheinformatiche per la sua emis-sione, trasmissione e conserva-zione (88).Il Ministero delle Finanze,venendo incontro alle esigenzedella prassi e facendo correttaapplicazione dei principi suindi-cati, ha emanato una serie dirisoluzioni con le quali ammettel’emissione e la trasmissioneelettronica delle fatture (89) edanche la conservazione su sup-porto informatico (90). Daultimo, con risoluzione n. 132/Edel 28 maggio 1997, il Ministerodelle Finanze ha consentito chela fattura possa essere trasmessaelettronicamente al cliente,senza provvedere all’invio informa cartacea del documento. Ilcliente, a sua volta, può provve-dere direttamente alla registra-zione della fattura–documentoelettronico mediante la memo-rizzazione dei relativi dati. Inparticolare, il Ministero ha chia-rito che:— l’emissione della fattura siconsidera effettuata all’atto dellatrasmissione telematica dei dati;— l’esemplare della fatturadell’emittente deve avere lostesso contenuto dell’esemplaredella fattura del cliente, poten-dosene differenziare sotto il pro-filo della mera forma e disposi-zione dei dati;— la registrazione della fattura èeffettuata attraverso la memoriz-zazione dei dati e la materiale
Note:(88) Sull’ammissibilità della fattura informa elettronica, già anteriormentealla legge 59/1997, Giannantonio,Manuale di diritto dell’informatica, cit.,362; contra Grisostomi–Travaglini, Unesempio di EDI: la fattura elettronica, inGiur. it., 1993, IV, 163.
(89) Ris. Min. Fin. 30 aprile 1986 n.360879; Ris. Min. Fin. 19 luglio 1988 n.571134; Ris. Min. 21 febbraio 1990 n.570832; Ris. Min. Fin. 30 luglio 1990 n.450217; Ris. Min. Fin. 30 novembre1990 n. 451163.
(90) Ris. Min. Fin. 15 marzo 1990 n.450073; Ris. Min. Fin. 30.7.1990 n.450318. V. anche Finocchiaro, Docu-mento elettronico, cit. (ed ivi, risolu-zioni citate alla nota 2).
ARGOMENTI
590NOTARIATON. 6/1997
Astampa nei registri IVA previstidalla legge.
LA TENUTAELETTRONICADI LIBRI, REGISTRIE SCRITTURECONTABILILa recente normativa contienealcune rilevanti novità in tema:— l’art. 2, comma 15, dellalegge 24 dicembre 1993 n. 537prevede che: «gli obblighi diconservazione e di esibizione didocumenti, per finalità ammini-strative e probatorie, previstidalla legislazione vigente, siintendono soddisfatti anche serealizzati mediante supportoottico, purché le procedure uti-lizzate siano conformi a regoletecniche dettate, entro 90 giornidalla data di entrata in vigoredella presente legge, dall’Auto-rità per l’informatica della Pub-blica Amministrazione di cui alD.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39».Il riferimento (con la congiun-zione «e») a finalità amministra-tive e probatorie indurrebbe aritenere che la portata dellanorma sia limitata all’ambito diattività della pubblica ammini-strazione (anche se sorgonodubbi circa l’estensibilità dellanorma all’ambito della c.d.amministrazione pubblica deldiritto privato, in cui viene gene-ralmente ricompresa anche l’at-tività notarile). Le norme tecni-che di cui sopra (essenzialmenteriferite alle caratteristiche deisupporti ottici, dei files, dei mec-canismi di lettura) sono stateemanate con deliberazionedell’A.I.P.A. n. 15 del 28 luglio1994;— l’art. 2220 c.c. (come modifi-cato dall’art. 7– bis del D.L. 10giugno 1994 n. 357, convertitocon legge 8 agosto 1994 n. 489),al terzo comma, dispone, in temadi conservazione delle scritturecontabili, che «Le scritture e idocumenti di cui al presente art.possono essere conservati sottoforma di registrazioni su sup-porti di immagini, sempre che leregistrazioni corrispondano aidocumenti e possano in ognimomento essere rese leggibili
con mezzi messi a disposizionedel soggetto che utilizza dettisupporti». Con successivodecreto ministeriale (a tutt’ogginon ancora emanato) dovrannoessere stabilite le modalità diconservazione dei detti supporti.La norma non consente quindi latenuta delle scritture contabili susupporto elettronico, ma ne con-sente la conservazione con talistrumenti;— l’art. 7, comma 4–ter, delD.L. 10 giugno 1994 n. 357, con-vertito con legge 8 agosto 1994n. 489, dispone che: «A tutti glieffetti di legge, la tenuta di qual-siasi registro contabile consistemi meccanografici è consi-derata regolare in difetto di tra-scrizione su supporti cartacei,nei termini di legge, dei dati rela-tivi all’esercizio corrente, allor-quando anche in sede di controllied ispezioni gli stessi risultinoaggiornati sugli appositi sup-porti magnetici e vengano stam-pati contestualmente alla richie-sta avanzata dagli organicompetenti ed in loro presenza».La norma non consente quinditout court la tenuta su supportoinformatico della contabilità, epresuppone che comunque deb-bano esistere dei registri cartaceiprevidimati; consente tuttavia latenuta provvisoria della contabi-lità su supporto magnetico;— gli artt. 3, comma 147, letterac) della legge 549/95, e 3,comma 136, della legge662/1996 hanno delegato ilGoverno ad emanare norme perla semplificazione degli adempi-menti contabili e formali deicontribuenti, tenendo contodell’adozione di nuove tecnolo-gie per il trattamento e la conser-vazione delle informazioni.Del problema si occupa altresìl’art. 15 del regolamento gover-nativo, disponendo che: «I libri,i repertori e le scritture, di cui siaobbligatoria la tenuta possonoessere formati e conservati susupporti informatici in confor-mità alle disposizioni del pre-sente regolamento e secondo leregole tecniche definite coldecreto di cui all’art. 3». L’ap-provazione definitiva diquest’ultima norma comporteràquindi la possibilità di tenere, in
via generalizzata, tutti i libri eregistri obbligatori su supportoinformatico. Vi è peraltro daconsiderare che, attualmente,diverse norme legislativeimpongono, per la maggior partedei libri obbligatori, l’obbligodella vidimazione iniziale: così,ad esempio, gli artt. 2215 e 2421prevedono la vidimazione ini-ziale del libro giornale, del libroinventari e dei libri sociali obbli-gatori, e l’art. 64 L. not. prevedela vidimazione iniziale dei reper-tori notarili. L’abrogazione ditali norme legislative non potràquindi avvenire ad opera di unanorma regolamentare comequella succitata, ma solo con unanorma avente forza di legge,emanata la quale potrà averepiena applicazione il suddettoart. 15 del regolamento.