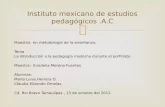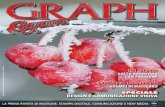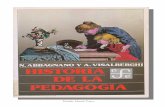ART 2009Marin Garcia IEMA Revista Espanyola Pedagogia Peervstutorassessment
"Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi Media"
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of "Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi Media"
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
1
INDICE
INTRODUZIONE…………………………………………………………………… 3
CAPITOLO 1: LO SCENARIO PEDAGOGICO DELLA POST-MODERNITÁ
1.1 La post- modernità.……………………………….……………………………… 7
1.1.1 Crisi della post- modernità………………………………….………………... 9
1.1.2 L’uomo post- moderno...…..………..….……………………………………13
1.2 La Società della comunicazione……………..…………..……………………… 17
1.2.1 Discorsi fondatori e indicatori temporali.....………………………………... 20
1.3 Il mondo come immagine………………………………………………………. 23
1.3.1 La realtà nel mondo come immagine………………………………….……. 28
1.3.2 Effetti del mondo come immagine….……………………………….……… 30
1.4 Digital divide: nativi digitali e immigrati digitali…………………………….… 35
1.4.1 Identikit del nativo digitale………….……………………..………..……… 36
1.4.2 I consumi mediali nell’epoca 2.0….…………………….....……………….. 37
1.4.3 Digital divide……….………………………………..…………………...….41
CAPITOLO 2: LA COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE 2
2.1 I significati della comunicazione ……………………………………..…………45
2.1.1 Assiomi della comunicazione…………………………………..……………47
2.1.2 Dimensioni e modelli della comunicazione……………………...…….…… 49
2.2 Elementi della comunicazione………………………………………………….. 53
2.2.1 Il Segno………………………………………………………...…………… 53
2.2.2 Il Codice………………………………………………………….………… 55
2.2.3 Il Testo……………………………………………………………………… 56
2.3 La comunicazione nell’era digitale: nascita e sviluppo del medium………….…57
2.3.1 Dal pensiero orale al villaggio globale ………………………...……………58
2.3.2 Nascita ed evoluzione dei mass- media……………………..……………… 62
2.3.2.1 Dal telegrafo al cinema………………………………………………….63
2.3.2.2 Dalla radio alla televisione……………………………………………... 65
2.3.3 Il computer e l’era di Internet: nuovi prodotti mediali………………………67
2.3.3.1 Comunicazione testuale……………………………..…………………. 68
2.3.3.2 Comunicazione Multimediale...…...…………………..……………….. 69
2.3.3.3 Espressione Multimediale del Web 2.0 e new media…...........................71
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
2
2.4 Principali media ed effetti sull’uomo moderno..………………………....……...72
2.4.1 Televisione ………………………………………………………..………... 75
2.4.2 Internet e new media…………..………..……………...…………………… 78
2.4.2.1 I Social Networks…………………..…………………………………. 82
CAPITOLO 3: PER UNA PEDAGOGIA DELLA COMUNICAZIONE DEI MEDIA 3
3.1 Presupposti morali: l’etica della comunicazione…………...……………… 91
3.2 Pedagogia della comunicazione educativa……………………………………… 98
3.2.1 Comunicazione è relazione…..…………………………...……………….. 105
3.3 Pedagogia dei media………………………………………………..….……… 110
3.3.1 Il campo della pedagogia dei media e ambiti di ricerca…………………. ...115
3.4 Educazione ai media…………………………………………………...…… ....117
3.4.1 Modelli e luoghi per un'educazione ai media..…………….…………….....118
3.4.2 Obiettivi dell’educazione ai media………..…..……………..……………. 121
3.4.2.1 Senso critico……………..………………………...………………….. 123
3.4.2.2 Educazione alla salute………...………………...…………………...... 125
3.4.2.3 Educazione civica………..………………………………………..…...126
3.4.2.4 Educazione all’identità di genere….………….………………………. 128
CAPITOLO 4: LA RICERCA EDUCATIVA NELLA MEDIA EDUCATION 4
4.1 La ricerca educativa nell’ambito dei media e ricerca nella Media Education… 129
4.2 La ricerca teorica...…………………………………………………………….. 134
4.2.1 Le metateorie………………………………………………………….……135
4.2.1.1 Inquadramento disciplinare……….………………………………..…. 138
4.2.2 Teorie strategiche………………………………………………………….. 141
4.2.3 Teorie Descrittive e Prescrittive…………………………………………… 144
4.2.4 Teorie Interpretative.………………………………………….…………… 147
4.3 Ricerca pragmatica...………………………………………….……………….. 148
4.4 Ricerca politica...………………………………………………………..……...153
4.5 La Media Education in Italia...………………………………………..……….. 157
4.5.1 Un progetto di Media Education a Bari: “Reputazione in rete”…………....161
CONCLUSIONI………………………………………………....……………….. 164
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………. 171
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
3
Introduzione
Prima di mettere mani su questo lavoro di tesi, ho voluto dare un’occhiata alla tesi
da me svolta nel corso dei primi tre anni di questo percorso formativo universitario.
Sebbene inizialmente mi sia accostata ad essa solo per un desiderio di riscoperta (e anche
per ricordarmi da dove partire per la successiva), pensando che il tema fosse
completamente diverso (“Il carcere utile”) rispetto a quello scelto quest’anno, mi sono
resa conto che in realtà sono proprio in quel lavoro le prime tracce di un percorso
riflessivo che mi ha portato qui.
Una buona parte della mia riflessione sul carcere, infatti, consisteva
nell’esaminare il tipo di concezione che i media riuscivano a creare nella mente di coloro
che ne fruivano e di come tale concezione non solo influenzasse il pensiero della massa
sull’argomento carceri, ma anche di come ciò comportasse anche un rallentamento sulle
riforme ad esso collegate. È stata una piacevole riscoperta e anche la conferma ulteriore
del motivo per cui ho deciso di intraprendere questo percorso di tesi.
Dopo questa breve digressione, cercherò di delineare il percorso intellettuale che
mi ha portato alla definizione dell’oggetto dei miei studi.
Il punto di partenza è stato la lettura della realtà che mi circonda, ormai caratterizzata
dall’ utilizzo sempre più invasivo e persuadente dei media. A seguito di tale lettura, mi
sono posta alcune domande che hanno successivamente guidato il mio lavoro: “Che tipo
di relazioni nascono e si formano attraverso i new media?”; “La persona in quanto tale
(come definita dal personalismo) che spazio può costruirsi all’interno di queste relazioni
mediata?”; “Qual è il compito della pedagogia? Come può accompagnare veramente ed
efficacemente la persona in questa epoca definita della “tecnica”?”.
Rispondere a queste domande implica rispondere anche ad un’altra domanda: “È da
imputare solo all’avanzamento tecnologico la crisi valoriale odierna, o è piuttosto la
conseguenza di una deriva già iniziata in passato?”.
Diverse sono le posizioni a riguardo. Umberto Eco le riduce nel dibattito tra “apocalittici”
ed “integrati”1, ovvero tra coloro che pensano che i nuovi mezzi di comunicazione sono
la causa di tutti i mali della nostra epoca e chi, invece, preso dall’entusiasmo del loro
utilizzo, riscontra in essi solo elementi positivi e di progresso. La mia posizione rispetto
1 U. ECO, Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Milano,
Bompiani, 1964
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
4
ad essi si trova nel mezzo e consiste nella considerazione globale di entrambi i risvolti,
positivi e negativi, che l’uso di tutti i mezzi di comunicazione comporta. Perché, se da
una parte è vero che il cattivo utilizzo dei media comporta non poche conseguenze
nefaste, è anche vero che, come afferma Morcellini, “[…] sull’orizzonte della
comunicazione, sulle dinamiche di rete, sulla navigazione nell’oceano dei link
ipertestuali, si accrescano le potenzialità individuali di accesso alle risorse della
conoscenza e dell’informazione”.2
Ciò che ne determina effetti più o meno positivi è, quindi, non il mezzo in sé, ma
come ci si approccia a tale mezzo. Entra in gioco, quindi, la necessità di educare
all’utilizzo dei media, attraverso una scienza specifica per tale ambito: la pedagogia dei
media. L’assunto che orienta questa tesi, quindi, è che i media possono essere un
vantaggio e un rischio e che siamo noi a decretarne la valenza. Alla pedagogia, quale
scienza del divenire umano, è affidato il compito di condurre le nuove generazioni (e le
meno giovani) a fare di questi mezzi, un uso più umanizzante.
I tempi corrono e la richiesta di dare un senso ai cambiamenti che vi stanno avvenendo
crea ancora di più l’esigenza di dar maggiore spazio alla pedagogia. Stiamo, infatti,
entrando nell’era 3.0, evoluzione dell’attuale 2.0, in cui tutto ciò che riguarderà la
telematica sarà sempre più “a misura di uomo”, ovvero sempre più personalizzato e
personalizzabile.
Tale situazione comporta uno stravolgimento totale del modo di vivere,
soprattutto per coloro che non sono cresciuti negli anni di questa rapidissima rivoluzione
tecnologica (mi riferisco a coloro che sono nati prima del 2000), mentre rientra nella
normalità per coloro che vengono ormai definiti Nativi Digitali, ovvero i ragazzi che sono
nati e cresciuti in un ambiente completamente mediatizzato. È proprio ad essi che ho
pensato quando mi sono chiesta quali fossero le conseguenze di questa situazione,
soprattutto perché l’attuale gap digitale tra loro e le generazioni precedenti, comporta non
pochi problemi dal punto di vista educativo e formativo.
Una metafora che mi sembra appropriata a descrivere questa situazione è quella
del funambolo. L’uomo moderno, difatti, è chiamato a diventare una sorta di funambolo,
che cammina sul filo della realtà (dove il virtuale costituisce non un suo contrario, ma un
modo ulteriore per far della propria vita una virtù), aiutato dal bilanciere dei suoi valori,
dei suoi sogni e progetti e di tutto il suo universo interiore. Il rischio di cadere nel baratro
2 M. MORCELLINI, La TV fa bene ai bambini, Meltemi, Roma, 1999, p. 15
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
5
del mero tecnicismo è presente ma la pedagogia ha il compito di mostrare il percorso, i
modi e i mezzi tali da non permettergli di sprofondare. La pedagogia ha il compito di
essere “luce nel buio” per condurre, anzi ricondurre, l’umanità verso un nuovo
umanesimo, dove l’uomo possa mantenere il suo primato rispetto alla tecnica.
Una delle strategie di cui si avvale tale scienza è la Media Education, sotto-area
della più vasta Pedagogia dei Media, che ha proprio il compito di educare i ragazzi ad un
corretto e libero (nel senso di non suggestionato) uso dei media. Prendendo in prestito,
ancora una volta le parole di Morcellini, possiamo affermare che la società attuale: “[…]
sembra investita da una rinnovata assunzione di responsabilità: alla scuola e alla
formazione è affidata la costruzione di una nuova e più salda mediazione culturale,
parallela a quella dei mezzi di comunicazione e capace di integrarsi con essa […]. La
comunicazione può assumere la valenza positiva di riuscire a cambiare le persone, se
adeguatamente ancorata alla diffusione della cultura di base e della partecipazione
scolastica”3
Comunicazione ed educazione, quindi, saranno le fautrici di un nuovo mondo, fine e
mezzo di ogni intervento di insegnanti, genitori ed educatori della società 2.0.
3 M. MORCELLINI, Media e identità scolastica. Significati di un cantiere aperto, in M. MORCELLINI (a cura
di), La scuola della modernità, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 14.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
7
CAPITOLO 1 :
LO SCENARIO PEDAGOGICO DELLA POST- MODERNITÀ
1.1. La post- modernità
Nel 1749 l’Accademia di Digione sul “Mercure de France” pubblica un bando di
concorso sul quesito: “Se la rinascita delle scienze e delle arti ha contribuito a purificare
i costumi”.
Rousseau, interessato alla questione, partecipa al bando scrivendo il “Discorso sulle
scienze e sulle arti”, successivamente premiato dall’Accademia. In questo discorso il
filosofo afferma che le scienze e le arti non hanno contribuito a migliorarci, tutt’altro: ci
hanno corrotti. Questo perché esse sono nate, non dalle nostre virtù, ma dai nostri vizi,
dalla nostra bramosia di potere. Le scienze e le arti abituano gli uomini ad “apparire”
piuttosto che a essere, a seguire schemi di comportamento artificiali, distanti da quelli
naturali. Rileva il noto filosofo che regna una vile uniformità e tutti gli spiriti sembrano
stati fusi in uno stesso stampo.4
Il fatto che già a metà del ‘700 ci si cominciasse a porre domande sulla valenza della
tecnica nella nostra vita è significativo. Già all’epoca vi era il sentore che si potesse
tendere al peggio, come Rousseau, da grande pensatore, ha in effetti riscontrato: la scienza
ha portato (già a quell’epoca e maggiormente nella nostra) ad una omologazione del modo
di essere, di pensare e di agire.
L’incipit di questa tesi, però, non si può fermare solo a questo: è necessario che si
conoscano i risvolti positivi e negativi della tecnica, in particolare mediale e soprattutto
le loro cause, per poter “correggere il tiro” nel futuro.
Bisogna essere consapevoli, come afferma Postman che “Ogni tecnologia è al tempo
stesso un danno e una benedizione, non è l’una cosa o l’altra, è l’una cosa e l’altra”5 e
che dipende dall’uomo renderla o l’una o l’altra.
La riflessione circa il rapporto uomo- tecnica, quindi, non può essere avulsa da quella sul
contesto storico- filosofico in cui tale rapporto si è costituito e rafforzato. Tale valutazione
è la condizione sine que non che permette di comprendere al meglio i meccanismi che
4 Cfr. F. BELLINO, Per un’etica della comunicazione, Mondadori, Milano, 2010, Prefazione, pp. IX-X
5 N. POSTMAN, Technopoly, Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 12
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
8
hanno costituito il terreno fertile su cui si è formata ed evoluta la società della
comunicazione- con tutte le conseguenze, positive e negative, ad essa connesse-.
Quando pensiamo al nostro tempo, la prima categoria a cui facciamo riferimento
è quella della post- modernità, termine introdotto per la prima volta da J. F. Lyotard, nel
testo La condizione postmoderna 6 . L’idea di portarsi oltre la modernità implica il
superamento di una soglia mentale, più che temporale, un superamento che riguarda la
concezione dell’uomo, che modifica i criteri con cui si interpreta l’esperienza umana.
Le cause e le connesse conseguenze di questo fenomeno sono molteplici, quindi in questa
sede mi limiterò a disegnare i tratti dello scenario storico- filosofico a cui afferiscono,
soffermandomi maggiormente, nei paragrafi successivi, su quegli aspetti strettamente
inerenti al mio lavoro di tesi.
In primo luogo nel periodo post- moderno assistiamo a diversi fenomeni che
portano alla destrutturazione delle categorie su cui società era precedentemente fondata,
a causa de “la caduta delle antiche credenze, il crollo delle ideologie, la pretesa
neutralità della scienza, la difficoltà di pensare l’uomo come soggetto o come coscienza”
7che hanno comportato l’inizio di una nuova fase, maggiormente complessa.
Verso la fine dell'Ottocento, infatti, per la prima volta nella storia dell’uomo, vengono
messi in discussione tutti i valori, le certezze, le istituzioni morali e religiose e le verità
epistemiche edificate dall'uomo nel corso dei secoli.
Quest’epoca è caratterizzata da una crescente complessità, che stimola
maggiormente l’esigenza di una riflessione pedagogica. Il discorso pedagogico, infatti, è
sempre contestualizzato a quello storico- culturale in cui si inserisce e dato che la nostra
epoca è caratterizzata dalla complessità, “La pedagogia si presenta sempre- specie oggi-
come una teorizzazione complessa sulla complessità”8.
Il paradigma della complessità (da cum- plexus, “tessuto insieme”) è fondato su tre
principi fondamentali: il principio dialogico (i dati sono reciprocamente costitutivi), il
principio della ricorsività (o della causalità circolare: ogni effetto è al contempo causa e
6 Cfr J.-F. LYOTARD, La condizione post- moderna, Feltrinelli, Milano, 1991
7 A. DANESE, Linee antropologiche per una bioetica personalista, in F. BELLINO (a cura di), Trattato di
bioetica, Levante, Bari, 1992, p. 165
8 G. ACONE, La Paideia introvabile. Lo sguardo pedagogico sulla post- modernità, La Scuola, Brescia,
2004, p. 24
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
9
prodotto di ciò che lo produce) ed infine il principio ologrammatico (reciproca
coappartenenza tra le parti ed il tutto). 9
La complessità non assume un’accezione negativa, soprattutto se vista alla luce dei
principi sopra descritti e soprattutto se non la si identifica con la complicatezza: “[…] non
bisogna confondere complessità e complicatezza. La complicatezza è uno degli aspetti
estremi della complessità.”10
1.1.1. Crisi della post- modernità
L’epoca post- moderna è stata definita epoca di crisi, in quanto vengono meno
tutti i capisaldi sui cui si era costituita la società del passato.
Il termine crisi indica il momento in cui le nozioni di una disciplina o teoria, vengono
messe in discussione sin dalla loro formulazione.
Il concetto di crisi trova nella critica della dialettica di Hegel il luogo privilegiato della
sua definizione e del suo concreto significato storico. Essa ha segnato la crisi della
categoria della totalità e di ogni razionalità egemonica e totalizzante o puramente
unificatrice.
La crisi della categoria della totalità per Emanuele Severino si sviluppa in una
duplice direzione: “da un lato si nega l'esistenza di un Senso, Fondamento, Centro che
raccolgano in unità la totalità delle differenze [...] dall'altro lato, questa frantumazione
della realtà totale si rispecchia nella frantumazione della conoscenza della realtà”.11
Per Maritain e Mounier i princìpi filosofici specifici del mondo moderno sono: il principio
immanentistico e quello trascendentalistico. Il principio immanentistico attesta che verità
e vita devono essere cercate unicamente all’interno del soggetto umano, poiché ogni
azione d’aiuto che proviene dall’altro, sarebbe un attentato contro lo spirito. Il principio
trascendentalistico, invece, sostiene che non esiste più alcun dato che ci misuri e ci
domini: la più intima sostanza dall’uomo trascende e comanda ogni dato.
Tali principi sfociano, nel mondo moderno, nel grande Principio dell’indipendenza della
Creatura, che annulla l’autonomia spirituale.
9 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, pp. 69- 72.
10 E. MORIN, Introduzione al pensiero complesso, Milano, Sperling & Kupfer, 1993, p. 69
11 E. SEVERINO, La filosofia contemporanea, Milano, 1986, pp. 21-22
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
10
Possiamo rintracciare nell’epoca post- moderna principalmente tre tipi di crisi12:
Crisi della ragione. L’inizio dell’epoca moderna è stata caratterizzata
dall’esaltazione della ragione umana e del suo strumento principale: la scienza.
Alla fine del 1800 la fiducia cieca nelle materie scientifiche cominciò ad
incrinarsi, in quanto si cominciò a mettere in dubbio il carattere di esattezza delle
scienze. Diversi sono stati i principi che hanno comportato ciò; ne prenderò in
esame solo tre: quello di verificazione di Wittgenstein e il Circolo di Vienna,
quello di falsificazione di Popper e quello del disincantamento del mondo di
Weber. Il primo afferma che hanno significato solo le proposizioni verificabili
empiricamente (eliminando, così, implicitamente la metafisica).
Popper, invece, nel suo principio di falsificazione afferma che una teoria è vera
solo fino a quando non viene confutata. Si può sapere se una teoria è falsa (quando
viene falsificata) ma non si può mai sapere se è vera. Il concetto di "teoria" non
può, dunque, aspirare allo statuto di "verità", ma solo alla validità provvisoria;
finché non viene falsificata rimane semplicemente un’ipotesi, una "congettura".
Non esiste, quindi, per Popper, un criterio generale di verità o di certezza. Il sapere
scientifico è congetturale, fallibile.
Infine con Weber troviamo il concetto di disincantamento del mondo, oggi più
che attuale. Weber afferma che la crescente intellettualizzazione e
razionalizzazione permettono all’uomo di conoscere senza far ricorso a nessun
mezzo magico o religioso. Questo vuol dire avere la coscienza o la fede che, se
soltanto si volesse, si potrebbe in ogni momento venire a conoscenza e che si
possa – in linea di principio – dominare tutte le cose mediante un calcolo
razionale. In questo consiste il disincantamento del mondo, cioè la fine del ricorso
a entità misteriose o trascendenti per spiegare i fenomeni naturali.
Possiamo, quindi affermare che la crisi della modernità ha comportato la crisi
della ragione assoluta e totalizzante a causa della ragione stessa.
L’unica categoria della scienza che non viene distrutta da questa crisi è quella
della tecnica, che anzi ne esce vittoriosa e ancora più forte.
Crisi antropologica. Il problema antropologico, riguardante il tema globale
dell’identità, è stato sempre oggetto di studio della filosofia.
12 Cfr F. BELLINO, Persona e ragionevolezza dopo Mounier, Levante Editori, Bari, 1997, pp. 41- 65
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
11
Nell’epoca moderna e maggiormente in quella post- moderna, l'uomo cerca di
autocomprendersi non misurandosi in rapporto a Dio, come succedeva nel
Medioevo, ma ritenendosi misura di tutte le cose e di se stesso.
Oggi l’uomo incontra delle difficoltà a trovare una risposta alla domanda “Chi
sono io?”. Ricoeur, filosofo personalista, afferma che ciò è la conseguenza degli
apporti di tre pensatori, definiti da lui filosofi “della scuola del sospetto”13: Marx
Nietzsche e Freud. L'immagine dominante dell'uomo della tradizione occidentale,
che assegnava il primato alla coscienza e al cogito e considerava l'uomo come
soggetto unitario e padrone della propria vita, viene messa in crisi dai concetti di
inconscio, di falsa coscienza e di volontà di potenza.
La coscienza risulta essere mossa da fattori inconsci di natura bio-psichica
(Nietzsche e Freud) o socio-economica (Marx), rendendola uno strumento di
occultamento della verità. La verità non è quella che il soggetto pensa, ma è
altrove. “L’ antropologismo contemporaneo nasce non tanto dal ricondurre tutti i
problemi filosofici al problema antropologico, quanto alla riduzione di tutti i
problemi e di tutte la realtà onto- assiologica (mondo, Dio, valori, natura)
all'uomo"”14. Il problema dell’antropologismo post- moderno è che riconduce tutte
le domande poste dall’uomo a problemi di antropologia, riducendo tutto a misura
di uomo, anche ciò che lo trascende. È da esso che nasce anche il solipsismo
ontologico e la solitudine esistenziale dell'uomo contemporaneo, un uomo solo
perché riduce l'Altro (mondo, natura, trascendente, uomo) a strumento e,
negandolo nella sua irriducibile alterità, lo rende medesimo. Il maestro di questa
tendenza è Nietzsche che ha messo in atto la sua arte dello smascheramento e del
sospetto, servendosi di una distruttiva e nichilistica psicologia che mira a
dissolvere ogni ideale e anche la stessa realtà. Egli fa una riduzione
antropologistica della metafisica, della religione, dell'arte e della morale. Questi
sono i presupposti nichilistici, alimentati anche dal riduzionismo e dallo
scientismo delle scienze umane, che hanno prodotto il "rimpicciolimento
dell'uomo" che per Nietzsche doveva essere l'unico fine affinché sorgesse una
specie umana più forte.
13 P. RICOEUR, Della interpretazione. Saggio su Freud, trad. it., Milano, 1967, p. 46
14 F. BELLINO, op. cit., 1997, p. 56
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
12
Crisi della morale. L’uomo post-moderno è stato definito un uomo senza qualità,
che non ricerca più spiegazioni ultime, che va perdendo la memoria storica e ha
come unica sua realtà l’esteriorità e la ripetizione della quotidianità. La radice
della crisi della morale risiede nel primato dell’avere sull’essere: l’uomo moderno
è l’uomo che ha perduto il senso dell’Essere, mettendo in atto un processo di
reificazione dell’uomo e personificazione delle cose. L’uomo ormai si identifica
con ciò che ha, con le sue proprietà.
Possiamo riassumere la crisi della morale con Eric Fromm che traduce l’ontologia
borghese consumistica in una semplice formula: “io sono= ciò che ho e ciò che
consumo”15.
La crisi della modernità comporta delle conseguenze importanti anche in un altro ambito:
quello educativo. Un ottimo contributo su questo tema l’ho individuato in un lavoro di
Acone.
Giuseppe Acone, nel testo “La Paideia introvabile. Uno sguardo pedagogico
sulla post modernità.” fa un’analisi della situazione post- moderna partendo dal concetto
di Paideia, definita dallo stesso autore come “[…] intersezione di Zeitgeist (Spirito del
tempo), Stimmung (atmosfera culturale), contesto sociale e strategie più o meno riflesse,
con cui una fase storica incarnata in una forma di civilizzazione affronta le modalità
educative (istruttive, formative, evolutive, socializzanti) delle giovani generazioni e degli
uomini in generale”16.
Essa è definita dall’autore “introvabile” perché scissa tra una sorta di ibridismo tra la
tradizione negata e l’incapacità dell’innovazione di dare risposte di senso. Anche la triade
che compone tale paideia (educazione, istruzione e formazione) ha perso la capacità di
assolvere pienamente alle proprie funzioni: mentre istruzione e formazione sono diventate
il “braccio armato” della tecnica, l’educazione non è più in grado di assolvere al suo ruolo
di offrire un orizzonte di senso all’uomo in cerca della sua piena affermazione. Ci si trova,
di fronte a due morali: la prima, quella religiosa, ormai obsoleta, (principio del fare il
bene), la seconda, quella individualista (prospettiva psicometrica del benessere\
malessere) non in grado di offrire un orizzonte di senso
Gli stessi elementi di crisi sono rintracciabili anche nelle istituzioni formali che
dovrebbero essere la culla della paideia: scuola, Chiesa e famiglia.
15 E. FROMM, Avere o essere, Milano, 1977, p. 47
16 G. ACONE, op. cit., p. 5-6
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
13
La crisi dell’educativo viene individuato non nella crisi della conoscenza, ma della
coscienza, ovvero dell’educare dentro una dimensione di senso, verso una dimensione di
senso. Vi è una contrapposizione (e non ancora un’integrazione) tra tradizione, valori e
senso, e l’innovazione, scienza e tecnica. 17
1.1.2. L’uomo post- moderno
Per intraprendere una riflessione sulla condizione dell’uomo post- moderno,
potremmo iniziare da un’osservazione di Martin Buber: "Io distinguo nella storia del
pensiero umano le epoche in cui l’uomo possiede una sua dimora (Epochen der
Behaustheit) dalle epoche in cui egli ne è senza (Hauslosigkeit). Nelle prime, l’uomo
abita nel mondo come se abitasse in una casa, nelle altre, egli è come se vivesse in aperta
campagna e non possedesse neppure i quattro picchetti per impiantare una tenda".18
Ci si chiede, a questo punto, nella nostra epoca, dove dimora l’uomo?
Riferendosi all’ uomo nell’età post- moderna Francesco Bellino lo associa alla figura
romanzesca di don Chisciotte. “Nella sua lucida follia don Chisciotte inverte il rapporto
tra realtà e mondo fantastico dei romanzi cavallereschi. Parafrasando Nietzsche, il
mondo, per don Chisciotte, è diventato favola e la favola è diventata la vera realtà”.19
Come per il personaggio del libro di Miguel de Cervantes, per il quale i libri romantici
diventarono la realtà, al punto da reinterpretare la realtà stessa come se fosse
l’ambientazione di un libro cavalleresco, anche per l’uomo postmoderno il mondo
mediatico è divenuto per un vero e proprio mondo, al punto tale da non riuscire a
distinguere dove risieda la realtà e la verità. Come annota Kapuscinski i media hanno
smesso di occuparsi esclusivamente di informazione: essi si occupano della creazione
della realtà.20
Quindi, a fronte di questa riflessione, potremmo affermare, riprendendo la
succitata frase di Buber, che nell’epoca contemporanea l’uomo non ha una sua “fissa
dimora”, potremmo definirlo un nomade il cui itinerario va dal reale al virtuale e
viceversa.
17 Id., pp. 5- 15
18 BUBER M., Il problema dell'uomo, ELLEDICI, Torino, 1983, p. 35
19 F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 14
20 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 1
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
14
Questa è un’utile premessa che ci permette di delineare i tratti dell’uomo moderno e,
successivamente, anche della sua “cyber- vita”.
Un punto di partenza dal quale iniziare è quello di una serie di filosofi e pedagogisti, che
hanno identificato nell’uomo contemporaneo “una condizione di accentuata
problematicità esistenziale”21, tale da essere oggetto di studi.
Il disagio esistenziale dell’uomo moderno si configura nell’impossibilità e
nell’incapacità di questo di porsi in rapporto con gli altri e il mondo che lo circonda.
Paradossalmente questa situazione si sta verificando nel periodo storico contraddistinto
dal massimo degli scambi comunicativi e dall’annullamento delle distanze spazio-
temporali, ma la comunicazione invece di preservare la relazione tra Io e Tu, si sta sempre
più autocentrando. Citando Giuseppe Elia, possiamo affermare che “l’abuso delle
tecniche di comunicazione rischia di trasmutare l’originaria attitudine al
miglioramento/facilitazione della comunicazione tra le persone, in sviluppo e
promozione di una sterile retorica, che vende la libertà in cambio dell’attitudine alla
persuasione”.22
Non è in grado di interrogarsi su se stesso, di leggersi dentro e quindi di prendere
pienamente consapevolezza di chi è. In questo modo diventa sconosciuto a se stesso e
agli altri.
L’indifferenza e la spersonalizzazione contraddistinguono sempre più le relazioni umane;
si afferma uno stile di vita sempre più narcisistico, basato sulla smisurata ossessione per
la propria realizzazione personale, a scapito della relazione con l’altro. 23 “Attraversiamo
una fase storico- culturale nella quale mentre sembrano ampliarsi le possibilità di
comunicazione, si assiste all’affermazione e alla moltiplicazione di tendenze
narcisistiche, da cui dipende la chiusura dei flussi interattivi e l’incapacità di dialogo e
di ascolto dell’uomo”24
Noi viviamo nell’età “della tecnica”. Ciò significa molte cose. Innanzitutto vuol
dire che viviamo in un’epoca nella quale gli strumenti tecnologici ci facilitano
21 L. PATI, Pedagogia della comunicazione educativa, La Scuola, Brescia, 1984, p. 5
22 G. ELIA, La comunicazione come creazione di uno spazio comune, in Quaderni di Dipartimento,
Università di Bari, Numero 8, Anno XI, Novembre 2008- Ottobre 2009, p. 89
23 Cfr G. ELIA, A. RUBINI, Educazione e comunicazione, in G. ELIA (a cura di), Le forme dell’educazione,
Laterza, Bari, 2006, p. 83
24 G. ELIA, op. cit., p. 83
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
15
enormemente la vita e ci permettono di comportarci come se tutto ciò che ci circonda
fosse al nostro completo servizio.
Ciò che comunemente definiamo “tecnica” si rivela un fenomeno ambiguo: da una parte
attua un potenziamento delle capacità umane, dall’altra introduce una sorta di filtro, una
barriera, tra l’uomo e l’ambiente del quale fa parte.25 Questo comporta che, malgrado il
continuo proliferare di mezzi di comunicazione di massa, l’uomo contemporaneo è solo.
Ha la sensazione di non avere più la possibilità d’incontrarsi, di confrontarsi e di dialogare
con il mondo. Come affermava D. Riesman, “Vi è solitudine in mezzo alla folla”.
Lo stato di isolamento è il più duro da accettare e da vivere nel momento in cui si
considera essere un’epoca contrassegnata dalla comunicazione. L’uomo contemporaneo
è posto in un mondo di messaggi nei quali la parola è sopraffatta da immagini
pubblicitarie e di propaganda e spesso non è il frutto della nostra spontaneità ma
ripetizioni di battute riprese da particolari produzioni cinematografiche e letterarie. La
comunicazione interpersonale ha perso, infatti, il suo valore esistenziale.26
Data la molteplicità delle caratteristiche dell’uomo moderno, le esaminerò
dividendole per sfere della vita: affettiva, psicologica, conoscitiva e morale, seguendo
l’impostazione.
Sfera affettiva. L’uomo del XX secolo non sa comunicare con i propri sentimenti.
La convinzione illuministica di poter affrontare e risolvere qualsiasi problema,
facendo ricorso alla ragione ha causato nel nostro tempo la frattura tra mente e
cuore, impedendo, così, di stabilire legami ideologici con il prossimo. Per J.
Lacroix la caratteristica propria dell’uomo moderno è quella di essere isolato. È
un essere incapace di comunicare, che ha perduto l’essenza stessa del comunicare
che è costituita dall’incontro con l’altro. 27
Sfera psicologica. L’uomo di oggi è incapace di dialogare con sé stesso. “Chi
sono?” È questo l’interrogativo che lo accompagna per tutto l’arco della sua vita.
Vi è l’incapacità di essere realmente se stessi e si assiste ad una vera e propria
«spersonalizzazione». Oggi, anche nell’adulto è presente il sentimento, in origine
prettamente adolescenziale, della solitudine e la paura di essere abbandonato a sé
25 Cfr. A. FABRIS, Etica della comunicazione, Carocci, Roma, 2006, pp. 25- 27
26 Cfr. L. PATI, op. cit., pp. 9- 12
27 Cfr G. ELIA, op. cit., p. 85- 86
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
16
stesso, incrementato dall’incapacità di colmare il vuoto interiore prodotto dalla
mancanza di identità.
Per tali ragioni l’uomo ha un comportamento opportunistico, ossia un passivo
adeguamento degli eventi, che prescinde da qualsiasi tipo di ideale. Tende,
piuttosto, a sfuggire dalle proprie responsabilità e ad annullarsi nel conformismo
di idee e comportamenti. Con il venire meno del senso di identità risulta incapace
il riconoscere nel proprio simile il prossimo, nel quale vede semplicemente il
riflesso del suo vuoto esistenziale.
Sfera conoscitiva. “L’uomo contemporaneo è inadatto a cominciare un dialogo
costruttivo con i prodotti della propria ragione, i quali, usati senza alcuna
preoccupazione circa l’utilità o il danno che può derivare dal loro impiego,
acquistano una tale autonomia rispetto al loro ideatore e costruttore da
assoggettarlo e dominarlo”.28 La creatività umana ha permesso di raggiungere
traguardi impensabili. Soprattutto all’inizio di questo secolo si è assistito ad una
accelerazione del processo conoscitivo ed il conseguente radicale mutamento
sociale. Nel corso di alcuni decenni si è passati da un lavoro prettamente manuale,
ad uno quasi completamente meccanizzato, che ricorre sempre più spesso
all’intelligenza meccanica.
Il computer oggi si avvia a diventare un elemento indispensabile, anche perché è
in grado di svolgere operazioni in tempi più brevi rispetto a quelli umani. Esso
favorisce l’adeguamento passivo all’ambiente circostante e l’esaltazione dell’utile
immediato. Si promuove insomma la «robotizzazione» dell’uomo, la sua completa
meccanizzazione. “Assistiamo […] al costante rivoltarsi del «nuovo modello di
sviluppo» contro la persona. Spesso non è l’uomo a sfruttare la macchina ma è
quest’ultima ad imprimere al primo un certo ritmo di produzione e di vita.”29
Sfera morale. L’uomo conduce la propria vita seguendo i dettami del semplice
esistere, trascurando di collocarsi in una prospettiva di senso. Osserviamo come
il vuoto valoriale spieghi ancora meglio l’instabilità della sfera psicologica,
conoscitiva, affettiva della personalità individuale: l’aridità e la mancanza di
significati producono estraniazione, sottomissione, adesione al futile ed
all’immediato. L’uomo d’oggi si dibatte tra il nulla e l’angoscia smarrendo la
28 L. PATI, op. cit., p. 15
29 Id. p. 16
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
17
speranza. Si adegua alla propria e all’altrui esistenza, rende duro il proprio cuore.
“La scelta alla quale siamo moralmente chiamati, insomma, è non solo quella fra
“bene” e “male”, anche in ambito comunicativo, ma, più radicalmente, quella
fra “essere” e “nulla”. […] Scegliere l’essere piuttosto che il nulla significa fare
in modo che i nostri gesti, i nostri atti, i nostri comportamenti, i nostri pensieri
risultino davvero permeati di senso. Solo in relazione a questa scelta lo possono
essere. Si tratta di un atto etico. Infatti etica è rapportarsi al senso di ciò che può
avere senso.”30
L’alienazione rappresenta uno degli aspetti più gravi del disturbo del processo di
comunicazione, in quanto vieta al singolo di allacciare autonome e costruttive
relazioni con l’ambiente circostante. Estranea l’uomo da se stesso e quindi anche
dal rapporto con gli altri, nega la storia le perplessità dell’altro. Inoltre si ignora il
funzionamento degli oggetti, si usano selvaggiamente incuranti di salvaguardarne
l’integrità.
1.2. La Società della comunicazione
Noi ci troviamo in «una società della comunicazione»31 in cui tutto si risolve nello
scambio di informazioni. Essa è caratterizzata dalla predominanza della categoria
comunicativa, che diviene “[…] la cifra per comprendere la realtà sociale attuale”32
“Oggi più che mai la comunicazione è un tema alla moda. I suoi processi, infatti,
incidono profondamente sulla nostra vita e la modificano in modo radicale: tanto che
non possiamo più pensare a noi stessi, né interrogarci sul nostro futuro, senza fare
riferimento agli strumenti e alle tecniche della comunicazione”33
Come vedremo successivamente, questa situazione si è amplificata (ed esasperata) con
l’introduzione dei new Media non più semplicemente pervasivi, ma ormai facenti
definitivamente parte della vita attuale.
All’interno della società la tecnica costituisce un vero e proprio sistema, di cui
quello mediatico è la parte centrale e propulsiva. Dalla seconda metà degli anni novanta
vi è stata la fusione dei mass Media globalizzati e personalizzati, con la comunicazione
30 A. FABRIS, op. cit., p. 133
31 Cfr E. NEVEU, Une société de communication?, Montchrestien, Paris, 1994
32 P.C. RIVOLTELLA, Teoria della comunicazione, La Scuola, Brescia, 1998, p. 49
33 A. FABRIS, op. cit, p. 9
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
18
mediata dal computer che ha permesso l’estensione della comunicazione elettronica a tutti
gli ambiti della vita. Questo sistema è stato definito “multimedia”.
La società della comunicazione cancella la linea di separazione tra pubblico e
privato, spingendo a mostrare in pubblico il proprio io interiore, rendendo quasi
obbligatoria l’esibizione pubblica del privato, come afferma Bauman. Chi si sottrae a
questa modalità è come se non esistesse.34 Per questo ora tutto è in rete, tutto alla portata
di tutti: dalle 10 meraviglie del mondo (talmente tanto pubblicizzate che al vederle non ci
si meraviglia più), alle foto e\o video di una rissa tra adolescenti avvenuta sotto casa. “La
nostra esperienza quotidiana e quanto abitualmente ci circonda e costituisce dall’interno
il nostro tempo sociale, anche a uno sguardo disattento si dimostrano ritmati dal dato
della comunicazione. Tale dato, pertanto, facilmente si presta a essere assunto come una
delle più efficaci categorie interpretative del nostro tempo, vero e proprio imperativo
categorico della modernità”35.
Tutto si basa sulla necessità di apparire, di mostrare. Questa regola implicita, però,
va a discapito del contenuto della comunicazione. Sembra che ciò che è importante è
comunicare (senza badare al tipo di contenuto scelto) e fare in modo che attraverso tale
comunicazione si abbia una certa visibilità. Questo vale sia per i “privati”, persone che
basano la propria identità sociale sul numero di “mi piace” o di visualizzazioni ricevuto,
sia per il “pubblico”, ovvero giornali e telegiornali che spesso utilizzano l’audience per
garantirsi una certa percentuale di share (termine ormai rientrato nel vocabolario di tutti
che indica i punti di percentuale di visualizzazione). In teoria, una comunicazione
corretta, dovrebbe basarsi sul rispetto per coloro che ne sono i destinatari, in questo caso
l’audience. Ma “[…] se il modo in cui qualcosa è comunicato prende il sopravvento su
ciò che viene comunicato, ne risultano esiti deleteri. In ambito giornalistico, ad esempio,
l’etica del primato dell’audience fa sì che lo stile con cui viene posta una notizia finisce
per essere più importante della notizia stessa. La forma diviene sempre più autonoma
rispetto al contenuto, e dunque suscettibile di rispondere ad altri principi ed altre istanze,
che non sono quelli motivati dalla fedeltà al contenuto stesso.”36
Gli strumenti tecnologici e le loro evoluzioni successive, i new Media, hanno
comportato effetti importanti sulle abitudini, gli usi sociali e i modelli di comportamento
34 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 2- 3
35 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., p. 15
36 A. FABRIS, op. cit., p. 81
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
19
degli utenti. Il primo effetto cognitivo è la configurazione del rapporto percettivo del
soggetto con le immagini con cui si trova a contatto, caratterizzato da una nuova modalità
di articolazione dello sguardo. Si passa da una visione reale, diretta, ad uno sguardo
incorniciato, che implica l’idea che vi sia un raddoppio di visione. Ad esso si accosta,
inoltre, uno sguardo ravvicinato, iperreale, che permette di guardare oggetti più reali della
realtà stessa. Infine, si può parlare di sguardo virtuale, che trasferisce il soggetto nella
realtà sintetica del mondo, come se appartenesse ad un grande videogioco.
Il secondo effetto cognitivo riguarda il rapporto tra testo e lettore: quest’ultimo
non è più passivo, ma attivo, in grado di scegliere i suoi percorsi di lettura e di modificarli,
aggiungendo collegamenti o altri testi. Si configura, così, un nuovo ruolo del lettore, che
diventa anche collaboratore, cooperando materialmente, nell’atto della lettura, alla
realizzazione del testo.
Infine, un ulteriore effetto si potrebbe riscontrare in quello che Pierre Levy
definisce intelligenza collettiva, che si struttura in relazione allo sviluppo delle forme di
comunicazione da un modello «uno- tutti» o «uno- uno» a un modello «tutti- tutti». Il
cyberspazio, infatti, consente a tutti di divenire potenzialmente emittente e ricevente37
Un altro ambito di ricerca molto importante è quello che studia la capacità delle
tecnologie di comunicazione di modificare il comportamento degli attori sociali in
situazione. Joshua Meyrowitz concentra i suoi studi su questo aspetto, in particolar modo
ponendo l’attenzione sul rapporto tra i Media e le situazioni sociali. La tesi da lui portata
afferma che l’avvento dei Media elettronici comporta un’emancipazione della
comunicazione che vede una sorta di “trasformazione territoriale”, da luogo fisico, a
luogo sociale. I nuovi mezzi elettronici, infatti, eliminano i limiti fisici (musi, cancelli,
siepi), crenando nuovi spazi sociali in cui è possibile comunicare anche a distanza.38
Rispetto alla comunicazione autentica della dimensione relazionale, quella dei
Media sembra costituire una perdita di senso. Gabriel Marcel afferma che “non vi è
autentica profondità che quando può realmente effettuarsi una comunicazione umana;
una tale comunicazione non sarà mai possibile fra individui centrati in se stessi, e però
sclerotizzati, né può esserlo in mezzo alla massa, nello stato della massa” 39 . La
differenza, però, non è molto netta, soprattutto nelle nuove forme di comunicazione
37 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 188- 198
38 Id, p. 245- 246
39 G. MARCEL, L’uomo contro umano, Volpe, Roma, 1963, p. 71
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
20
elettronica. Ad esempio, possiamo parlare di relazione nel caso della comunicazione in
rete? Da una parte sembra di sì, perché, seppur mediatizzato dallo schermo del personal
computer, in questa comunicazione l’altro viene incontrato e interagisce con l’Io. Ma,
dobbiamo anche considerare che, questa comunicazione, fa a meno del corpo, facendo a
meno del «peso» affettivo della presenza fisica. 40 “L’idea è chiara: una cosa è la
relazione, lo scambio personale che vive del rapporto diretto tra gli interlocutori, altro
la comunicazione di massa, generalizzata, impermeabile a qualsiasi possibilità di feed-
back”41
1.2.1. Discorsi fondatori e indicatori temporali
Neveu afferma che “la società della comunicazione non ha genitori legittimi, né
una data di nascita certa” 42, ma è possibile identificare i «discorsi fondatori» che hanno
permesso la sua nascita. L’autore ne riconosce tre: la teoria critica della Scuola di
Francoforte, lo studio della propaganda delle prime teorie sociali della comunicazione e
il programma cibernetico di Wiener.
La teoria critica parte dal concetto di industria culturale, intesa in senso negativo,
caratterizzata dalla produzione in serie della cultura (che annulla l’immaginazione ed è al
servizio del controllo politico) e dalla contrapposizione tra «spazio pubblico» e «società
chiusa».
Per spazio pubblico [Habermas] si intende il potere dell’opinione pubblica che
degenera nella cultura di massa, resa sempre più acritica dalla rincorsa dell’immagine a
tutti i costi da parte delle istituzioni e dell’azione deresponsabilizzante dei media. Ciò che
ne consegue è una società chiusa [Marcuse], scevra di tutte le sue differenze.
La società della comunicazione descritta da questa teoria è quindi una società vista in
senso negativo, in cui la cultura diventa merce, la parola chiacchiera e l’arte mera
propaganda.
Lo studio di Laswell si concentra, invece, sulla propaganda, diffusasi durante la
Prima Guerra Mondiale. La sua riflessione si concentra sulla gestione dell’opinione e
sfocerà nella celeberrima «teoria dell’ago ipodermico».
40 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 64- 66
41 Id, p. 65
42 E. NEVEU, op. cit., p. 20
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
21
Questa teoria affermava che i mezzi di comunicazione agiscono in modo tale da inoculare,
nei destinatari dei messaggi, delle convinzioni, che danno luogo a risposte immediate. La
forza della propaganda starebbe in questa capacità manipolatoria di determinare la
risposta richiesta. Per questo secondo l’autore la propaganda, insieme ai Media, sarà il
nuovo protagonista della scena politica contemporanea.
Possiamo quindi affermare che la società descritta da Laswell è una «società del
consenso», in cui possedere i mezzi della comunicazione significa avere il potere di
manipolare l’opinione della massa.
Infine, il programma cibernetico di Wiener aggiunge un ulteriore tassello per
comprendere le sfumatura della società della comunicazione.
Nel 1942 Wiener pubblica un saggio che porterà alla nascita di un nuovo
paradigma scientifico: la cibernetica. Dal punto vi vista teorico, esso si basa su un’idea
forte: la realtà non è altro che un sistema di relazioni. La consapevolezza, oggi diffusa,
che «tutto è comunicazione», nasce proprio da qui. Tutto è comunicazione perché in
questo modello non conta la consistenza reale, fisica degli esseri, ma solo gli scambi che
tra essi avvengono.
Questa teoria si è intrecciata anche con tre eventi avvenuti nel 1942, in cui l’utopia della
tecno- scienza ha dimostrato tutta la sua forza distruttrice: i primi bombardamenti degli
alleati, gli esperimenti sulla bomba nucleare e l’idea dello sterminio di massa a danno di
una intera popolazione. Di fronte a tale situazione di grave rischio per l’umanità, Wiener
decide di opporre la contro- utopia cibernetica, in cui le macchine dovrebbero sostituire
l’uomo nel suo compito politico e gli scienziati dovrebbero regolare tutto il sistema. Il
risultato è una nuova concezione dell’uomo: l’homo communicans, un essere sociale,
privo di corpo e di interiorità, che abita in una società trasparente (priva di segreti), dove
il suo essere è un «essere che comunica».
L’ultima declinazione del concetto di società della comunicazione, quindi, è quella di una
società trasparente, in cui tutto è superficiale e razionalmente risolvibile.43
Neveu individua, inoltre, degli indicatori epocali in cui si possono rintracciare le
origini della società della comunicazione. Egli, infatti, afferma che “esiste una logica
intellettuale che associa le rappresentazioni sociali emergenti negli anni Cinquanta, la
nuova sensibilità di un largo pubblico al tema della comunicazione negli anni Sessanta,
e la consacrazione ulteriore del modello occidentale come società della
43 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 25- 30
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
22
comunicazione” 44 . Saranno proprio questi gli indicatori temporali a cui si farà
riferimento.
Il primo indicatore è rintracciabile negli anni ’50 (definiti da Rivoltella anni in cui
si assiste alla “Cultura della fine”).
Aron, sociologo americano, legge le trasformazioni economiche di quegli anni come
indicatori di trasformazioni socio- culturali che porteranno alla fine della politica,
depauperata dalla tecnica, sino ad una possibile fine delle ideologie (evidente, come
processo storico, solo trent’anni più tardi).
Sebbene il tema della comunicazione, in questi anni, non è ancora centrale, come invece
succederà successivamente, è inevitabile che si ritagli uno spazio decisivo, soprattutto
nelle menti e nelle teorie di coloro che per primi ne hanno colto la valenza, più o meno
positiva.
Non a caso, infatti, in questi anni Orwell scriverà 1984, in cui delinea un tipo di
comunicazione onnipotente, basata sul sistema del «Grande Fratello», Laswell teorizzerà
il potere assoluto dei Media e Packard fornirà la visione della pubblicità come potere di
persuasione occulto che assoggetta i destinatari al punto da farli trovare in uno stato di
quasi- ipnosi.
Il secondo indicatore temporale è identificabile negli anni ’70. In questo periodo
storico il tema della comunicazione passa in primo piano, grazie al lavoro di alcuni teorici
come McLuhan, Marcuse e Debord.
Per quanto riguarda McLuhan, sono ormai famosissime le sue tesi: l’idea del «villaggio
globale», di Media come protesi dei nostri organi di senso e la considerazione che «il
medium è il messaggio». Sebbene queste tesi siano già state teorizzate in passato da
pensatori quali Innis e Mumford, il merito di McLuhan è stato quello di rendere i Media
un discorso sociale diffuso. Marcuse e Debord, invece, fanno una critica radicale alla
cultura di massa, intesa come ultimo stadio del capitalismo. In questi anni nasce anche la
semiologia.
Infine, ultimo indicatore epocale è quello che inizia negli anni ’80 sino ai nostri
giorni. In questi anni vi è la vera e propria consacrazione della comunicazione, che
compare anche nei discorsi politici. 45 La differenza sostanziale è che, mentre dagli anni
’50 agli anni ’70 il discorso circa la società della comunicazione era compiuto da critici
44 E. NEVEU, op. cit., p. 36
45 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 30- 33
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
23
o universitari, dagli anni ’80 in poi le promesse della società della comunicazione sono
ormai formulare dalle autorità legittime, legate allo stato46.
Emblematico, a tal proposito, è stato il discorso fatto da Al Gore, ex Vice- Presidente
degli Stati Uniti, al Summit del G7 di Bruxelles del marzo 1995. L’atteggiamento di
fiducia espresso dall’ex Vice- presidente durante questo discorso si evince dalle sue stesse
parole: “La comunicazione tutela e amplia la libertà di espressione di tutti i cittadini e
garantisce ai singoli il potere di creare l’informazione di cui hanno bisogno e che
desiderano sulla base dell’ingente flusso di dati disponibili in ciascun momento”47.
Inoltre, degno di essere preso in considerazione è il commento relativo all’utilizzo della
tecnologia: “oggi il nostro sogno non riguarda in particolar modo la tecnologia. La
tecnologia è un mezzo, non il fine. Il nostro sogno riguarda la comunicazione, vale a dire
lo strumento fondamentale mediante il quale educhiamo i nostri figli, curiamo i nostri
malati, rivendichiamo i nostri diritti e la libertà di esseri umani”48.
1.3. Il mondo come immagine
“«In principio era la Parola»: così il Vangelo di Giovanni. Oggi si dovrebbe dire
che «in principio è l’immagine»”49. La comunicazione- intesa come racconto del mondo-
e la realtà oggi sono ridotte a mera immagine.
Il nostro mondo è completamente immerso in un sistema mediatico. “Il mondo mediatico
è diventato un vero e proprio mondo, dapprima concepito per rappresentare e
interpretare la vita reale, oggi sempre più autonomo, con una sua logica interna, che
rischia di diventare autoreferenziale sostituendosi alla vita reale”50
Gli attuali mezzi di comunicazione hanno di gran lunga superato la loro originaria
funzione di mediare i messaggi della realtà attraverso immagini; essi, infatti, la creano:
l’immagine stessa è divenuta la realtà. Nella sua riflessione sull’epoca post- moderna
Vattimo afferma:
46Cfr E. NEVEU, op. cit., p. 46-47
47 A. GORE, La società dell’informazione alle soglie del Duemila, in «L’Unità», 4 marzo 1995, p. 3
48 Ibid.
49 G. SARTORI, Homo videns. Televisione e post- pensiero, Laterza, Bari, 2007, p. 15
50 F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 1
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
24
“La società dei mass media […] è tutto il contrario di una società più illuminata, più
“educata” […]; i mass media, che teoricamente rendono possibile una informazione
“in tempo reale” su tutto quello che accade nel mondo, potrebbero in effetti sembrare
una specie di realizzazione concreta dello Spirito Assoluto di Hegel, cioè di una perfetta
autocoscienza di tutta l’umanità, la coincidenza tra ciò che accade, la storia e la
consapevolezza dell’uomo. […]
Di fatto, […] rende sempre meno concepibile la stessa idea di una realtà. Si attua forse,
nel mondo dei mass media, una “profezia” di Nietzsche: il mondo vero alla fine diventa
favola.” 51
Sartori, inoltre, afferma che il primato dell’immagine si traduce nel prevalere del
visibile sull’intellegibile, porta a vedere senza capire, a non essere più capaci di pensare.
Secondo lui il video sta trasformando l’homo sapiens in homo videns, nel quale la parola
è sostituita dall’immagine. Prima di Sartori è stato Heidegger a definire l’epoca moderna
come “epoca dell’immagine del mondo”, cioè del mondo concepito come immagine.52
Infatti, mentre in passato le immagini esistevano nella realtà, oggi è la realtà ad esistere
nelle immagini e come immagine.
Ma, concretamente, in cosa consiste la realizzazione del mondo come immagine?
Con l’avvento della multimedialità non vi è più separazione tra immagini, media
audiovisivi, cultura popolare e cultura colta, divertimento e informazione: tutto è
costituito da processi di comunicazione, che si basano sulla produzione e consumo di
segni. Non c’è separazione tra questi e la realtà. In questo senso possiamo affermare che
tutta la realtà è espressione del mondo virtuale.
Inoltre, il mondo virtuale si basa su un codice binario di presenza \assenza: quindi tutto
ciò che non è presente sulla rete è come se non esistesse. Questo aumenta ancor di più il
divario tra realtà reale e realtà mediata.53
Tale situazione è stata ampiamente descritta da molti filosofi. In questa sede, ne citerò
solo due: Debord e Vattimo.
Il primo, nella teoria dello spettacolo, afferma che la comunicazione è incentrata
sulla spettacolarizzazione della realtà. Ciò implica che pur di fare spettacolo si
abbandonino tutte le regole morali ed etiche.
51 G. VATTIMO, La società trasparente, Garzanti, Milano, 1989, pp.13-14
52 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 11-12
53 Cfr. Id., p. 15
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
25
La parola “spettacolo” significa appunto apparenza, rappresentazione. Non a caso, a
preambolo della prima sezione, Debord cita un famoso pensiero di Feuerbach, tratto da
una prefazione dell’Essenza del cristianesimo: “E senza dubbio il nostro tempo […]
preferisce l’immagine alle cose, la copia all’ originale, la rappresentazione alla realtà,
l’apparenza all’essere […]”54. Debord ripete: “Tutto ciò che era direttamente vissuto si è
allontanato in una rappresentazione”55.
La tesi di Debord, elaborata alla fine degli anni ‘60, era frutto di una riflessione avvenuta
in un’epoca in cui la finzione, o meglio la rappresentazione della realtà, avevano sì
soppiantato la realtà stessa, ma si era solo all’inizio. Oggi tale situazione è stata
estremizzata: la tele- realtà è ormai completamente centrata sulla spettacolarizzazione di
tutto, anche di ciò che non dovrebbe fare spettacolo. Oggi, tutto si basa sul creare negli
utenti sensazioni e sentimenti che possano renderli partecipi dei drammi altrui, che li porti
a sapere tutto di tutti, soprattutto le parti più nascoste, quelle buie e dolorose.
Se pensiamo, infatti, alla maggior parte dei reality, ci rendiamo conto che le
persone che vengono scelte non sono quelle più talentuose o corrette, ma quelle che hanno
una storia migliore da raccontare, magari con qualche dramma da riutilizzare al momento
opportuno, per stimolare nel telespettatore un sentimento di compassione. Compassione
che però, potremmo definire vuota, anomala. Perché, se andiamo all’etimologia della
parola compassione, (dal latino: cum, insieme – patior, soffro), ci rendiamo conto che
questo sentimento nasce da una condivisione intima con l’altro, che porta a “soffrire con
lui” e a creare con lui un legame forte, basato sull’amore. La televisione, invece, utilizza
questo sentimento per legare gli utenti ai loro prodotti mediatici: personaggi che mettono
in mostra la loro intimità per acquisire consensi, per attirare l’attenzione e magari le
simpatie.
In questa continua spettacolarizzazione della vita, soprattutto intima, i sentimenti
vengono strumentalizzati per ottenere consensi, un pubblico fedele e sempre pronto a
rispondere positivamente ad ogni richiesta fatta dal suo “guru” mediatico.
“Nell’epoca dello spettacolo, del mondo stesso concepito come immagine, come
aveva profetizzato il situazionista Guy Debord, il reale non è più un dato
54G. DEBORD, La società dello spettacolo, trad. it, Salvadori P., Baldini e Castoldi, Milano, 2008, p. 51
55 Id, p. 53
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
26
naturale, ma è un prodotto, un insieme costituito di segni, simulacri, modelli di
controllo. È un iperreale, frutto del lungo processo di virtualizzazione […]; la
velocità ha reso il guardare sempre più superficiale […]. L’inflazione visiva ha
fatto assopire la capacità di scegliere, di riconoscere, di valutare e quindi di
comprendere ciò che stiamo percependo e ha reso obsolete le opposizioni
attraverso cui la modernità pensava al reale (vero\falso, originale\copia,
realtà\finzione).56
Vattimo, invece, nella sua teoria dell’estetizzazione dell’esistenza, afferma che al
centro della società non c’è lo spettacolo, bensì il bello, la dimensione estetica.
Ormai è un fatto assodato: è il bello che fa spettacolo, che si cerca di raggiungere. Il
modello estetico ha sostituito quello morale, impoverendo la nostra esistenza, svuotando
di senso ogni nostra azione. Possiamo così affermare, con le parole di Bellino che “il
“principio del piacere” prende il posto del “principio della realtà”.57
Se caliamo questa situazione nella vita della maggior parte dei nativi digitali, ci rendiamo
conto di quanto sia completamente integrata nel loro modo di vivere. Oggi, gli
adolescenti, hanno modo di raccontarsi in diversi modi, dai blog, ai social network. In
tutti questi “luoghi digitali” essi si presentano cercando ogni volta la foto migliore o la
frase più bella che possa presentarli al meglio.
In loro “aiuto”, sono state create una serie di applicazioni (Photoshop, GIMP, Photoscape
e altri), che permettono di modificare digitalmente la loro immagine, rendendoli
esteticamente più belli, ma moralmente più vuoti. Questo perché l’eccessiva (e a volta
compulsiva) ricerca dello scatto migliore o del migliore effetto da utilizzare, porta questi
ragazzi a pensare che sia una bella foto o il numero di “mi piace” che guadagna, per
decretarli importanti e piacevoli.
Secondo queste teorie, quindi, la società risolve se stessa nell’apparire, divenendo
solo immagine di se stessa. Sociologicamente questo fenomeno è stato preparato
dall’affermarsi del modello di realtà televisiva e della telerealtà. Esso, da una parte
risponde ad una logica dell’apparire, dove ciò che si mostra è più importante di ciò che si
vede nella realtà, a scapito quindi della verità; dall’altra si iscrive in una logica della
certificazione, per cui le cose avvengono solo nel momento in cui i media ne parlano.
56 F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 43
57 Id, p. 27
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
27
Con l’avvento dei nuovi media questa situazione pare addirittura enfatizzata: l’immagine
sintetica non è più restituzione del reale, ma realizzazione di un modello realmente
esistente solo nella mente dell’operatore.58
Ma perché la nascita dei tele- media ha comportato la riduzione al mondo come
immagine?
Ciò che contraddistingue il mezzo comunicativo è la sua essenziale capacità di
creare verosimiglianze, di moltiplicare le immagini e ampliare le possibilità di pensare. Il
mondo reale viene sempre rappresentato attraverso delle immagini. Queste non sono più
copie, rappresentazioni della realtà, ma hanno un loro autonomo sviluppo, si rivelano
capaci di creare la realtà stessa.
L’immagine ha acquisito una tale forza legittimizzante, che spesso si sente dire «L’ho
visto in televisione» per rafforzare un giudizio o un concetto. Questo perché ciò che passa
sullo schermo ha davvero la capacità di persuadere, di convincere della sua rilevanza e,
automaticamente, consente di considerare irrilevante tutto ciò che non appare in Tv.
Sempre più maggiormente emerge la consapevolezza che alla base della presunta
evidenza delle immagini, vi sia una sorta di lobby- a volte le emittenti stesse, altre volte
l’audience, altre ancora i giornalisti stessi- che decida non cosa è giusto far vedere, ma
cosa conviene far vedere, in un’ottica di share. Di certo, la selezione è inevitabile, non è
possibile dare visibilità a tutte le notizie che arrivano dal mondo.
Un’altra situazione occultata dalla televisione è che tutte le notizie in essa
contenute e raccontate dalle diverse fonti, non sono “obiettive” o comunque “vere in
generale” poiché in realtà sono sempre limitate ad una certa prospettiva, inserite in un
determinato orizzonte.
Tutto oggi è ripensato in funzione della sua visibilità, della sua capacità di mostrarsi, nulla
sfugge alla spettacolarizzazione, neanche l’ordinario e il consueto. Questo è il segreto
della fiction televisiva, che ci racconta di medici, carabinieri, preti, nonni, visti nella loro
vita quotidiana. Da questa totale e globale spettacolarizzazione della vita reale, si può
dedurre che tutto può essere un modello, ovvero che nulla è più un modello. Se tutto è
spettacolo, viene meno anche ogni distinzione tra “reale” e “apparenza”; stiamo
sviluppando una sorta di indifferenza tra ciò che è e ciò che appare.
58 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 18-19
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
28
Inoltre lo spettacolo dell’apparenza trova in sé il proprio scopo, immediatamente. Perciò,
appena apparsa, l’immagine si può dileguare. Quindi, l’immagine, l’apparenza non ha
uno scopo, risolvendo in se stessa il suo fine. Ma, nonostante questo, attrae e coinvolge.
Questo modus operandi della televisione in generale, lo possiamo vedere in pratica anche
nei telegiornali, in cui la notizia viene sintetizzata in informazione e intrattenimento.59
1.3.1. La realtà nel mondo come immagine
“Siamo in piena e rapidissima rivoluzione multimediale. Un processo a molti
tentacoli (Internet, computer personali, ciberspazio) che però è caratterizzato da un
comune denominatore: il tele- vedere, e per esso un nostro video- vivere”60
L’homo sapiens si configura come l’uomo in grado di comunicare attraverso
un’articolazione di suoni e segni «significanti», cioè dotati di significato. L’uomo,
definito animal symbolicum da Ernst Cassier, dispiega la sua capacità simbolica
attraverso il linguaggio.
Oggi si parla non di linguaggio, ma di linguaggi (del cinema, delle arti figurative, delle
emozioni, etc.). Tuttavia il linguaggio che caratterizza l’uomo è quello della parola, del
nostro parlare e pensare.61
Ma in un mondo che apprende attraverso le immagini, che ruolo ha la parola? “È
vero che una immagine può valere più di mille parole. Ma è ancora più vero che un
milione di immagini non danno un solo concetto. Riassumo in tre punti. Primo: il vedere
non è conoscere. Secondo: il conoscere può essere aiutato dal vedere. Terzo: il che non
toglie che conoscere per concetti (il conoscere in senso forte) si dispiega tutto quanto
oltre il visibile.”62
Se il mondo è immagine, apparenza, quindi non ci sono più fatti da raccontare. Non
avendo più fatti da raccontare, il multimedia li crea.
Giorgio Bocca parla di “disinformazione” e cita il “fattoide”, la falsa notizia
verosimile. Le agenzie che si occupano di diffondere le informazioni, non diffondono
realmente e solamente il fatto. Si parla, infatti, di Infotainment, un misto tra informazione
59 Cfr. A. FABRIS, op. cit., pp. 119- 122
60 G. SARTORI, op. cit., Prefazione
61 Cfr. Id., pp. 5- 7
62 Id, p. 149
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
29
e divertimento. Il lettore e il telespettatore vengono visti più come clienti che cittadini.
Cambiando la considerazione dell’audience cambia anche il prodotto da far loro vedere.
De Kerckhove parla, invece, di “attacco alla realtà”, da parte della cultura
contemporanea e dei media. Il messaggio viene manipolato e adattato ai vincoli del
medium. Sempre De Kerckhove teorizza la “legge della realtà decrescente”, in cui la
realtà svanisce secondo un determinato ordine: copertura diretta, diretta differita, servizio
confezionato, documento “obiettivo”, documentario “di parte” e infine “docudrama”63.
Noam Chomsky aggiunge alla tesi sopra riportata, lo studio sui cinque filtri attraverso
i quali passano le notizie:
1. Proprietà, coloro che controllano i media dominanti;
2. Pubblicità, fonte di finanziamento principale dei media;
3. “Sourcing”, fonti di notizie giornaliere credibili e che non costano troppo;
4. “Flak”, feedback negativi;
5. Anticomunismo, una sorta di religione di stato utilizzato come meccanismo di
controllo del malcontento (riguarda soprattutto l’America). Questo filtro assume
un nome diverso a seconda del paese che lo utilizza: se in America si chiama
Anticomunismo, in Oriente si chiamerà Anti- Occidentalismo, in Italia Anti-
europeismo (dati i continui discorsi contro l’Europa e la moneta unica che si
stanno facendo da qualche anno a questa parte) o Anti- Immigrazioni, Anti-
Politici e tanto altro. Comunque lo si chiami esso ha l’importante funzione di
“incanalare e controllare la rabbia- o anche il malcontento- che viene suscitato
dalle condizioni economiche e sociali”64. Spesso, anche per spostare l’attenzione
pubblica su questioni di poca importanza (i vari gossip dei Vip, entrati nel novero
delle notizie nazionali comunicate dai telegiornali) o su argomenti che si
trascinano per anni e anni, da tirare in ballo per non parlare di qualcos’altro di più
scomodo.
La notizia, quindi, non è mai “pura” ma sempre edulcorata dalle esigenze delle varie
Lobby del mondo mediatico.
Se ci spostiamo dal giornalismo, verso la televisione troviamo Baudrillard che parla
di “delitto perfetto” compiuto dalla televisione ai danni della realtà.
63 Cfr D. DE KERCKHOVE, La pelle della cultura, trad. it., Costa & Nolan, Genova, 1996, pp. 128-129
64 N. CHOMSKY, Il bene comune, trad. it., La Biblioteca di Repubblica- L’espresso, Roma, 2004, p. 55
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
30
Egli afferma che la televisione non è più surrogato o interpretazione della realtà, ma la
realtà stessa. Attesta, inoltre, che il reale è vanificato nei segni; la simulazione ha preso il
posto del principio di realtà. Ciò avviene perché “tutti i segni ormai si scambiano tra
loro, senza più scambiarsi con qualcosa di reale”65. La fine del reale, paradossalmente,
si esplicita attraverso un eccesso: l’iperreale, il più del reale, ovvero il reale riprodotto.
Le cose scompaiono, rimpiazzate dalle loro simulazioni, dalla loro spettacolarizzazione.
Baudrillard riscontra un’ulteriore conseguenza del mondo come immagine: con il virtuale
non si assiste solo alla liquidazione del reale, ma anche a quella dello “sterminio
dell’Altro” e di tutte le forme di alterità:
Quella della morte che si scongiura con l’accanimento terapeutico;
Quella del volto e del corpo, che si persegue con la chirurgia estetica;
Quella del mondo che si cancella con la Realtà Virtuale;
Quella di ciascuno che scomparirà un giorno con la clonazione;
Quella dell’altro che si sta diluendo nella comunicazione perpetua.
L’ “uomo storico” è stato così sostituito dall’ “uomo terapeutico”: un uomo che,
perdendo il senso della continuità storica, ha esasperato la ricerca terapeutica del
benessere del corpo e della mente.66 “La cultura iper- reale del nanosecondo col suo
ritmo annulla lo spazio e riduce l’orizzonte temporale individuale e collettivo
all’immediato, determinando la caduta della “coscienza storica” e l’avvento della
“coscienza terapeutica”. Mentre l’uomo storico si sacrifica nel presente e vive per il
futuro, l’uomo terapeutico abbandona ogni pretesa di missione storica. Ciò che conta è
“adesso”. Importante è avere la possibilità di vivere e di godere il momento.”.67
1.3.2. Effetti del mondo come immagine
Se l’immagine è diventata la categoria principale della nostra vita, ci tocca vivere
in un mondo in cui non ha valore il mondo, ma il suo consumo68. Asserviti a questa logica
sono i mezzi tecnici di cui ci si avvale per accedere al mondo. “Così anche la libertà di
usare certi apparecchi o merci ignora la “costrizione al consumo”.
65 J. BAUDRILLARD, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano, 1980, p. 18
66 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 21- 28
67 Id., p. 27
68 Cfr. G. ANDERS, L’uomo è antiquato, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, vol. I, p. 11
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
31
La mancanza di uno solo di questi apparecchi, chiamati musts, ovvero merci d’obbligo –
si pensi alla televisione, al computer, al telefono” 69 mette a repentaglio “l’intera
attrezzatura della vita […] Chi si prende la libertà di rinunciare a uno, rinuncia con ciò
a tutti e quindi alla sua vita. Si è in grado di farlo?”70.
La domanda posta da Anders sposta l’attenzione sul tipo di rapporto che si ha con
i Media, in particolar modo sulla loro pervasività nella nostra vita.
In che modo questi strumenti condizionano noi e i nostri atteggiamenti?
Gli studi degli effetti dei media sugli atteggiamenti e comportamenti individuali e
collettivi costituiscono uno dei più importanti ambiti di ricerca delle scienze della
comunicazione, a partire dalla scuola di Francoforte. Data la vastità dei contributi, in
questa sede mi limiterò a compiere una breve sintesi delle più importanti teorie, per poi
concentrare maggiormente l’attenzione sugli effetti del mondo come immagine. 71
Potremmo distinguere gli effetti dei Media sui nostri atteggiamenti e
comportamenti, seguendo la distinzione fatta da Rivoltella nel suo testo “Teorie della
comunicazione”72. L’autore, infatti, distingue tre tipi di effetti in base alla loro durata.
Seguendo questa tripartizione troviamo:
1. Effetti immediati. In questa categoria rientra la succitata bullet theory (“teoria del
proiettile”) di Lippmann e Laswell, secondo cui i media agiscono imprimendo i
loro messaggi nella mente dei loro fruitori come proiettili o come un ago
ipodermico.
2. Effetti a breve termine. Tra le teorie più significative troviamo quella degli usi e
gratificazioni e del two-step flow. La prima fa una considerazione attiva
dell’audience e valuta il consumo dei media come modo per ricercare delle
gratificazioni per bisogni individuali.
La teoria del two-step flow, invece, concentra il suo studio sul ruolo dei leaders
d’opinione nella determinazione della scelta degli elettori. Si giunse alla
conclusione che la comunicazione attivata dai media agiva su due livelli (da qui
il nome della teoria, two- step flow): dai media ai leaders d’opinione e da questi
69 F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 28
70 Cfr. G. ANDERS, op. cit., vol. I, p. 12
71 Cfr. F. BELLINO, op. cit., p. 28- 30
72 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 225- 231
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
32
agli elettori. In risultato dell’indagine rilevò la grande importanza e capacità di
persuasione della comunicazione non mediale.
3. Effetti a lungo termine. In quest’ultimo gruppo di teorie troviamo: le teorie del
potere dei Media, le teorie della dipendenza e le teorie degli effetti cumulativi.
Le prime rilevano l’importanza sociale dei Media, soprattutto in relazione alle
scelte dei consumatori, che tendono a conformarsi con quanto comunicato mezzo
Media. Il secondo gruppo di teorie riflette sul rapporto esistente tra sistema sociale
e sistema dei Media e afferma che l’ampiezza e l’intensità degli effetti dei Media
dipende dal grado di dipendenza che il sistema sociale ha dei confronti dei Media.
Infine nelle teorie degli effetti cumulativi, vi sono due teorie di cui è importante
parlare: la “teoria della coltivazione” e l’ “agenda setting”. La prima è stata
teorizzata da Gerbner, secondo cui i Media modellano valori e atteggiamenti,
attraverso la riproposizione di contenuti specifici, realizzando così una sorta di
allevamento o coltivazione della mente degli utenti.
L’ “agenda setting”, invece sostiene che i Media non intervengono sul pubblico
in modo persuasivo, ma in modo subdolo, determinando così i valori e le
informazioni che devono divenite importanti per il pubblico.
Una volta individuati gli effetti dei Media sui nostri atteggiamenti e comportamenti
abbiamo la base teorica per poter conoscere e comprendere gli effetti del mondo come
immagine. Essi, infatti, sono strettamente connessi all’utilizzo dei Media.
I principali effetti del mondo come immagine sono i seguenti:
Atomizzazione delle conoscenze ed esperienze. Se la realtà diventa “illustrazione
delle sue illustrazioni” 73 la conoscenza del mondo e la sua conseguente
conoscenza (spesso esperita attraverso le immagini) non potrà mai essere
completa, ma parcellizzata.
Passivizzazione e liquefazione dell’oggetto. Il consumatore è ormai abituato a
consumare i prodotti mediatici, senza poter replicare, “ci abituiamo a una
esistenza nella quale siamo defraudati della metà del nostro essere uomini. Chi
ascolta soltanto ma non parla e per principio non può contraddire non è solo
“passivizzato”, ma reso succube e schiavo”74.
73 G. ANDERS, op. cit., p. 233
74 Id., p. 234
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
33
Inoltre i prodotti mediatici, per essere più facilmente fruibili, ci vengono serviti
allo stato liquido. Questo modo di distruggere e liquidare l’oggetto non è solo
caratteristica dei mass Media, ma anche dell’intera produzione odierna, ispirata al
principio dell’ “obsolescenza guidata”75, basata sulla produzione di oggetti che
non durino molto tempo o che verranno soppiantati dopo poco da modelli sempre
più efficienti (un esempio sono tutta la gamma di prodotti di telefonia e computer,
prima fra tutti la Apple).
Libertà illusoria. L’uomo moderno, libero dalle ideologie del passato che
imprigionavano le sue azioni, oggi si ritiene libero. Ma in realtà non è così. Ha
sostituito, infatti, le ideologie tradizionali, con una molto più pericolosa e
vincolante: il consumo. Non vi è libertà di scelta, c’è solo la corsa al consumo,
all’omologazione. Anders afferma, addirittura, che noi non solo stiamo perdendo
la nostra libertà, ma “siamo persino defraudati della libertà di avvertire la perdita
della nostra libertà”76. Se ci trovassimo in una dittatura, avvertiremmo che la
nostra libertà è lesa per un’ovvia condizione restrittiva. Ma quando la “dittatura”
è subdola, nascosta dietro al bello e al piacevole, allora non siamo in grado di
poter renderci conto della nostra assenza di libertà.
Smaterializzazione. “Come la monade di Liebniz, che non ha finestre, ma che
comunica con le altre monadi, così l’homo mediaticus si sente perfettamente
separato e perfettamente interconnesso attraverso lo schermo di un computer
[…]”77. L’homo mediaticus, così definito da Bellino, può essere in qualsiasi posto
del mondo, restando comodamente a casa, può essere connesso con miriadi di
persone e non avere relazioni. Questa è la smaterializzazione: disgiungere il corpo
dall’Io, la vita reale (first life) dalla vita virtuali (second life).
Frantumazione dell’uomo e destrutturazione morale. L’uomo viene frantumato da
tutto ciò che gli giunge via radio, televisione, Internet e altro, senza alcun
collegamento logico. Un uomo che mescola tutta questa grande massa di
informazioni, non può che essere disarticolato, senza un orientamento e
soprattutto incapace di dare un senso univoco a ciò che legge o sente.
75 Id.,, p. 235
76 Id.,, p. 234
77 F. BELLINO, op. cit., p. 36
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
34
Per quanto riguarda le notizie trasmesse, esse non solo non hanno un ordine o una
costruzione razionale, ma vengono incentrate su notizie sensazionali, eccitanti, di
comportamenti trasgressivi e anormali. Ciò che fa notizia è ciò che esce fuori dagli
schemi, ciò che per guadagnarsi audience punta sull’amoralità degli eventi, più
che sulla moralità. Oggi ci stupiamo se al telegiornale, invece dei “soliti” omicidi
efferati, sentiamo notizie di “normale moralità”. Oggi viene normalizzato
l’anormale e anormalizzato l’anormale.
Affettivizzazione ed esteriorizzazione dell’uomo. Quasi una conseguenza di
quanto detto prima è questo effetto del mondo come immagine. Oggi il razionale
è soppiantato dal sensoriale, dall’affettivo, dall’immaginario. La prima reazione
dell’organismo di fronte all’immagine televisiva e filmica è una reazione emotiva.
Il problema è che le immagini che noi vediamo, non suscitano riflessioni, ma solo
sensazioni. Circola, a tal proposito, un’immagine in rete che spiega bene questa
situazione: un uomo seduto davanti alla televisione che piange guardando la scena
di un bambino denutrito; nello sfondo, si vede una finestra, al di là della quale c’è
un bambino che piange per la fame. Di fronte ad un bambino africano, noi
proviamo compassione, ma difficilmente andiamo oltre questa sensazione, per
riflettere sui motivi per cui quel bambino è denutrito o per fare qualcosa di
concreto per aiutarlo.
Violenza e adultizzazione dei minori. La massificazione della comunicazione
mediatica produce un duplice effetto: l’infantilizzazione degli adulti e
l’adultizzazione dei minori, che può essere considerata una forma subdola di
violenza. Si parla addirittura di “scomparsa dell’infanzia” o “bambini senza
infanzia”. Questo perché la “membrana protettiva” che serviva a preservare i
bambini da precoci esperienze e dai segreti del mondo adulto si è indebolita a
opera dei mass media, permettendo ai piccoli di poter accedere a tutta la gamma
di informazioni a cui accedono i grandi. In questo, però, c’è da rilevare che gran
parte della colpa non è solo dei media, ma anche dei genitori e soprattutto di quelle
agenzie che si dovrebbero occupare di “proteggere” lo sguardo dei bambini. In
realtà anche questo diritto fondamentale, il diritto ad avere un’infanzia, è asservito
al gioco dello share e del consumo.78
78 Cfr. Id., pp.31 -40
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
35
In particolar modo il rapporto tra media e infanzia verrà trattato nel successivo paragrafo.
1.4. Digital divide: nativi digitali e immigrati digitali
Dopo la riflessione sulla post- modernità e il mondo come immagine, ho ritenuto
doveroso prevedere una piccola riflessione anche su coloro che sono nati nell’epoca 2.0:
i Nativi Digitali.
Sebbene dal punto di vista teorico, ci sono ancora molte resistenze sul considerare il modo
di apprendere dei Nativi Digitali diverso dal nostro, è di certo un ambito di studio molto
importante, soprattutto per un’educazione ai media che, in particolar modo per loro, non
può prescindere da una maggiore conoscenza del loro mondo e delle loro modalità di
apprendimento.
La definizione “Nativi Digitali” appartiene a Marc Prensky79, che la coniò per la
prima volta nel 2001 in un articolo su "On the Horizon". Prensky non si limita a coniare
un termine per i bambini nati in piena rivoluzione digitale, ma ne individua uno anche per
coloro che in questa rivoluzioni si sono trovati in un certo senso catapultati: gli Immigrati
Digitali. Il termine “Immigrato” offre proprio il senso di una sorta di Esodo, da una terra
conosciuta e famigliare, ad una sconosciuta, piena di insidie e pericoli. Così si esprime
l’autore per identificarli: sono soggetti “che, come tutti gli immigrati, alcuni meglio di
altri, hanno dovuto adattarsi al nuovo ambiente socio- tecnologico, ma conservando il
loro accento, i loro piedi nel passato. […] è come se fosse una lingua nuova imparata
non da piccoli ma più avanti nel corso della vita e, come suggeriscono alcuni
neurobiologi, utilizzando una parte differente della mente o del cervello”.80
A tal punto ci si chiede: da che periodo in poi una persona può essere considerato
Nativo e non Immigrato? La linea di demarcazione (sebbene non sia possibile indicarla
con precisione) si potrebbe individuare nel 1996, anno in cui inizia la diffusione di massa
di Internet, anche se in Italia si sposterebbe sino a nati tra il 2000- 2001 e addirittura dopo
2005, con la diffusione della banda larga.
79 M. PRENSKY, Digital Natives, Digital Immigrants, in “On the Horizon”, NCB University Press, 2001, vol.
IX, n. 5
80 Id.,, p. 2
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
36
1.4.1. Identikit del Nativo Digitale
Ferri, uno dei maggiori sostenitori della teoria di Prensky in Italia, ha scritto un
libro, intitolato proprio “Nativi Digitali”, in cui spiega in cosa consiste tale fenomeno
generazionale. Egli afferma che: “I nativi digitali, in primo luogo, considerano le
tecnologie come elemento naturale del loro ambiente di vita e non, come facciamo noi,
una novità o entusiasmante o da temere”81. Essi non hanno un metro di confronto su
come fosse la vita prima dell’ipertecnolocizzazione, quindi per loro la tecnologia non può
configurarsi come qualcosa di positivo o negativo, in quanto fa parte della loro vita, come
gli alberi e le macchine.
Inoltre si sentono completamente a loro agio non solo nel manipolare le nuove
tecnologie ma anche nel personalizzarle, utilizzandole per i loro scopi. Infine tendono
naturalmente a condividere con i loro pari le proprie esperienze on- line.
In breve cercherò di delineare i tratti del Nativo Digitale82.
Rappresentazione del mondo. I Nativi Digitali vedono e costruiscono il mondo a
partire da un’esperienza differente dalla nostra, che vede la congiunzione tra il
reale e il virtuale. Per essi, infatti, il virtuale è la manifestazione del reale,
altrettanto influente e significativa. Non è qualcosa che si oppone alla realtà, come
invece pensavano, sino a vent’anni fa, gli Immigrati Digitali. Quindi essi fanno
esperienza anche di ciò che è presente del virtuale.
Il primo modo in cui entrano in relazione con il mondo virtuale è attraverso i
videogiochi, verso i tre anni. Questi rappresentano un “gioco molto serio” in
quanto al ludico uniscono la stimolazione di stili cognitivi, comunicativi e di
relazione del tutto nuovi rispetto alla nostra esperienza analogica. In questi giochi,
infatti, ogni livello presuppone di aver acquisito capacità specifiche e di poterne
acquisire delle altre attraverso il suo superamento; è possibile giocare con gli
Avatar di altri giocatori, sperimentando così la cooperazione mediata e anche la
sperimentazione di vari ruoli.
Intelligenza multitasking. I Nativi Digitali hanno a disposizione una infinita
quantità di codici, di strumenti di apprendimento e comunicazione formativa e
sociale come i Social Network, il cellulare, il Tablet, la consolle ecc.…
81 P. FERRI, NatId. Digitali, Bruno Mondadori, Milano, 2011, p. 9
82 Cfr. P. FERRI, op. cit., pp. 49- 58
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
37
Nell’approcciarsi a tutti questi strumenti, essi non hanno bisogno di un manuale
d’istruzione: imparano facendo, apprendono per esperienza (il learning by doing
di Dewey). Costruiscono la loro esperienza non linearmente, ma per successive
approssimazioni, secondo una logica più abduttiva, che deduttiva o induttiva. I
Nativi, quindi, hanno un approccio più pragmatico, personalizzato e meno
dogmatico del nostro alla cognizione, alla comunicazione e al sapere. Essi
apprendono in base a trial and error (prove ed errori). Essi hanno un approccio
open source alla conoscenza, basato sulla condivisione e la cooperazione.83
Stili di comunicazione partecipativi. Questa caratteristica è il frutto della fruizione
attiva dei Media. Jenkins84, autore del saggio Culture partecipative, definisce così
la cultura partecipativa: “è una cultura con barriere relativamente basse per
l’espressione artistica e l’impegno civico, che dà un forte sostegno alle attività di
produzione e condivisione delle creazioni digitali. […] All’interno di una cultura
partecipativa, i soggetti sono convinti dell’importanza del loro contributo e si
sentono in qualche modo connessi gli uni con gli altri”85. Questa nuova forma di
apprendimento e socializzazione si è formata all’interno del circuito
dell’educazione tra pari e delle relazioni comunicative e sociali informali dei
bambini. È un nuovo circuito di produzione e fruizione mediale, definito da
Jenkins produsage (produzione e uso) che si è manifestato dopo l’avvento delle
piattaforme digitali interattive di fruizione dei contenuti. Le tecnologie digitali,
infatti, hanno accresciuto la possibilità degli utenti di partecipare alla creazione di
nuovi contenuti e di nuovi formati mediali, come ad esempio Youtube e
Wikipedia.
1.4.2. I consumi mediali nell’epoca 2.0
Per conoscere meglio l’ambiente in cui i Nativi Digitali sono nati, bisogna
analizzare i dati relativi all’evoluzione dei consumi mediali e alle modalità con cui tali
83 Cfr. Id., pp. 40- 45
84 Henry Jenkins (Atlanta, 4 giugno 1958) è un accademico e saggista statunitense che si occupa di media,
comunicazione e giornalismo. È professore presso la University of Southern California. In precedenza è
stato al MIT dove ha codiretto il Comparative Media Studies Program.
85 H. JENKINS, Culture partecipative e competenze digitali: media education per il XXI secolo, trad. it.,
Guerini studio, Milano, 2010, p. 53
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
38
consumi avvengono. Per farlo mi avvarrò del Report circa i dati Istat relativi al rapporto
tra Cittadini e Nuove Tecnologie86, pubblicato il 19 dicembre 2013 e del Rapporto Censis
201387 (Tabella 1).
Quest’ultimo nel suo ultimo Rapporto, ha fatto un raffronto tra i dati relativi agli utilizzi
dei media nel 2002 e quelli del 2013.
TABELLA 1: L'EVOLUZIONE DEL CONSUMO DEI MEDIA DAL 2007 AL 2013
86 REPORT ISTAT, Cittadini e nuove tecnologie, 2013 Fonte: http://www.istat.it/it/archId.o/108009
87 CENSIS, Undicesimo Rapporto Censis/ Ucsi sulla comunicazione, L’evoluzione digitale della specie, Sintesi
per la stampa, Roma 11 ottobre 2013 Fonte: http://www.censis.it/17?shadow_pubblicazione=120563
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
39
I dati sull’andamento dei consumi mediatici nel 2013 confermano che la
televisione continua ad avere un pubblico di telespettatori che coincide sostanzialmente
con la totalità della popolazione (97,4%), con un rafforzamento però del pubblico delle
nuove televisioni: +8,7% di utenza complessiva per le tv satellitari rispetto al 2012, +3,1%
la web tv, +4,3% la mobile tv. E questo dato è ancora più elevato tra i giovani: il 49,4%
degli under 30 segue la web tv e l’8,3% la mobile tv.
Anche per la radio si conferma una larghissima diffusione di massa.
L’uso dei telefoni cellulari continua ad aumentare (+4,5%), soprattutto grazie agli
smartphone sempre connessi in rete (+12,2% in un solo anno), la cui utenza è ormai
arrivata al 39,9% degli italiani (e la percentuale sale al 66,1% tra i giovani under 30).
Gli utenti di internet, dopo il rapido incremento registrato negli ultimi anni, si assestano
al 63,5% della popolazione (+1,4% rispetto a un anno fa). Il dato sale nettamente
soprattutto per i giovani (90,4%).
Continua, inoltre, la forte diffusione dei social network, con una tendenziale
sovrapposizione tra internet e Facebook: non c’è istituzione, associazione, azienda,
personaggio pubblico che possa permettersi di non essere presente sul social network più
popolare. È iscritto a Facebook il 69,8% delle persone che hanno accesso a internet (erano
il 63,5% lo scorso anno), che corrispondono al 44,3% dell’intera popolazione. Il dato
relativo alla totalità dei giovani è del 75,6%.
Sebbene si registri la crisi della carta stampata, si segnala una ripresa della lettura dei libri
(+2,4%), dopo la grave flessione dello scorso anno, benché gli italiani che hanno letto
almeno un libro nell’ultimo anno sono solo il 52,1% del totale. E gli e-book arrivano a
un’utenza del 5,2% (+2,5%).
In questo arco di tempo, la spesa per telefoni e servizi telefonici ha registrato un
aumento del 366,4% (arrivando a oltre 22 miliardi di euro), nonostante la brusca frenata
del 2009, dopo una fase di crescita costante e prolungata, a causa dell’impatto sui consumi
della crisi economico- finanziaria.88
Per quanto riguarda il consumo dei prodotti tecnologici, nel dettaglio si assiste nel 2013
all’aumento, rispetto all’anno precedente, della quota di famiglie che dispone di un
accesso ad Internet da casa e di un personal computer (rispettivamente dal 55,5% al
60,7%, dal 59,3% al 62,8%).
88 CENSIS, op. cit., pp. 2-5
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
40
Le famiglie con almeno un minorenne sono le più tecnologiche: l’87,8% possiede
un personal computer, l’85,7% ha accesso ad Internet da casa. All’estremo opposto si
collocano le famiglie di soli anziani di 65 anni e più, appena il 14,8% di esse possiede il
personal computer e soltanto il 12,7% dispone di una connessione per navigare in Internet.
I maggiori utilizzatori del personal computer e di Internet sono i giovani tra i 15-19 anni
(rispettivamente, oltre l’88% e oltre l’89%).
Nonostante la grande diffusione di personal computer e di Internet, solo i nativi
digitali (15 e 24 anni) hanno competenze nettamente al di sopra della media nazionale e
non hanno problemi per quanto riguarda l’utilizzo di questi mezzi.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, si e andata sempre più diffondendo la possibilità di
essere connessi alla rete in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
Nel 2013, sono circa 9 milioni le persone di 14 anni e più che hanno usato il web
negli ultimi tre mesi per connettersi con device mobili in luoghi diversi da casa o dal posto
di lavoro (Tabella 2).
In particolare, il 22,4% delle persone di 14 anni e più ha utilizzato un pc portatile, il 26,7%
uno smartphone, il 4,8% un altro dispositivo portatile. Sono soprattutto le persone tra i 14
e i 24 anni ad accedere ad Internet in luoghi diversi da casa o dal posto di lavoro
utilizzando questi dispositivi mobili, circa il doppio della media nazionale.
TABELLA 2- CONSUMO MOBILE DI INTERNET DI UN CAMPIONE DI PERSONE DI 14 ANNI E PIÙ
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
41
1.4.3. Digital divide
All’inizio del XX secolo e durante tutto il novecento il mondo intero si trovava a
dover fronteggiare il serio problema dell’alfabetizzazione che, una volta diffusa, avrebbe
dato il via al reale sviluppo della società di massa. Grazie a lunghi programmi d’istruzione
nella gran parte del mondo, cosiddetto sviluppato, i tassi di alfabetizzazione hanno
raggiunto livelli ottimi e il problema, a distanza di anni, sembra ormai risolto.
“Il sogno di una società dell’informazione uguale per tutti si sta infrangendo contro
l’evidenza: Internet riproduce meccanismi di esclusione propri del passato e li ripropone
nel presente con forza del tutto nuova. Il modello della rete pervade la società, dà forma
alle relazioni umane, è alla base di ogni tipo di attività economica, politica, associativa
o religiosa. Chi non ha i mezzi per accedervi è fuori da tutto, intrappolato al fondo della
piramide sociale”89
Con “l’affermarsi e il dispiegarsi della rivoluzione digitale (1985- 2005)”90, il problema
dell’alfabetizzazione, in questo caso digitale, è tornato alla ribalta. Per poter comunicare,
lavorare, informarsi, non è più sufficiente saper leggere e scrivere, ma è necessario
imparare ad utilizzare tutti quei mezzi, in primis i personal computer, che hanno
rivoluzionato il quotidiano di ognuno di noi. Con l’espressione “alfabetizzazione digitale”
si intende, infatti la conoscenza e la capacità di utilizzo delle nuove tecnologie.
Quando si parla di digital divide (barriera creatasi a seguito della rivoluzione
digitale) si parla soprattutto di barriere fisiche ed economiche all’accesso. Esiste tuttavia
un terzo, importante elemento: l’età.
Il digital divide generazionale è un fenomeno particolarmente evidente in Italia, dove la
scarsa familiarità con la tecnologia, ed in particolare con il mondo di Internet, continua
ad interessare gran parte della popolazione adulta/anziana, come dimostrano i dati sotto
riportati91, relativi sempre al 2013 (Figura 1).
89 S. BENTIVEGNA, Disuguaglianze digitali: le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione,
Roma- Bari, Laterza, 2006, p. 4.
90 P. FERRI, op. cit., p. 139
91 CENSIS, op. cit., p. 6
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
42
FIGURA 1- UTENZA COMPLESSIVA DI NEW MEDIA E QUOTIDIANI: LE DISTANZE TRA GIOVANI
E ANZIANI
La struttura e soprattutto il contenuto di questo grafico, danno perfettamente l’idea
del Digital Divide che ancora interessa la nostra nazione. Mentre tra i giovani la quota di
utenti della rete arriva al 90,4%, tra gli anziani è ferma al 21,1%. Il 75,6% dei primi è
iscritto a Facebook, contro appena il 9,2% dei secondi; il 66,1% degli under 30 usa
telefoni smartphone, ma lo fa solo il 6,8% degli over 65; i giovani che guardano la web
tv (il 49,4%) sono diciotto volte di più degli anziani (il 2,7%); e mentre il 20,6% dei
giovani ha già un tablet, solo il 2,3% degli anziani lo usa.
Si nota qui anche il caso opposto, quello dei quotidiani, per i quali l’utenza giovanile (il
22,9%) è ampiamente inferiore a quella degli ultrasessantacinquenni (il 52,3%).
Quest’ultimo dato potremmo considerarlo solo una conseguenza di quanto prima rilevato:
i giovani, avendo a disposizione dispositivi attraverso i quali possono accede alle
informazioni più importanti del Mondo, fanno a meno dei quotidiani.
Come rileva Ferri “noi immigrati digitali ci troviamo strutturalmente in difficoltà
dal momento che siamo nati e cresciuti all’interno del mondo industriale o
postindustriale, che tuttavia hanno sempre fatto parte della galassia Gutenberg; la
galassia digitale […] è per noi un universo nuovo e non ancora familiare”.92
92 P. FERRI, op. cit., pp. 139- 140
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
43
L’accesso alla tecnologia è una tematica di forte attualità: il digital divide rappresenta un
serio ostacolo allo sviluppo, alla libera circolazione dell’informazione e alla crescita
culturale delle persone. Non bisogna inoltre dimenticare che differenti strumenti si
traducono in differenti schemi mentali e mappe concettuali, rischiando di acuire il divario
generazionale con conseguenze importanti sullo sviluppo e sul benessere della società.
Lo sviluppo digitale comporta delle grandi differenze dal punto di vista
antropologico. In seguito faremo riferimento alla sintesi sulle differenze tra Nativi e
Immigrati Digitali, fornita da Ferri93 (Tabella 3).
TABELLA 3- DIFFERENZE TRA IMMIGRATI E NATIVI DIGITALI
Sebbene le differenze siano molte e in alcuni casi “abissali”, non ci si può esimere
dall’eliminare questo divario. Nell’ambito della formazione, il superamento del divide è
oggi una tematica più scottante che mai dal momento che gli studenti di oggi sono tutti i
Nativi Digitali, ragazze e ragazzi abituati a utilizzare internet e smartphone per
comunicare e informarsi sul mondo che li circonda.
93 Id., p. 43
Immigranti digitali Nativi digitali
- Codice alfabetico
- Apprendimento lineare
- Stile comunicativo uno- molti
- Apprendimento per assorbimento
- Internalizzazione, riflessione
- Autorità del testo
- Primo: leggere
- Codice digitale
- Apprendimento multitasking
- Condividere e creare la
conoscenza (mp3, Wikipedia)
- Apprendere ricercando, giocando,
esplorando
- Esternalizzazione
dell’apprendimento
- Comunicazione versus riflessione
- No autorità del testo,
multicodicalità
- Connettersi, navigare per esplorare
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
45
CAPITOLO 2 COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE
2.
2.1. I significati della comunicazione
In un suo racconto Jorge Luis Borges individua nell’Aleph il “punto che racchiude
tutti i punti […], il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra”94.
In base a questa definizione possiamo ritenere la comunicazione, in particolar modo
quella attuale multimediale, una sorta di Aleph, dove confluisce tutta la conoscenza della
realtà concreta e virtuale.
Essa è ormai l’inevitabile modo di stare al mondo, ciò verso cui tutto converge e di cui
non possiamo fare a meno. In altre parole possiamo dire che “[…] senza comunicazione
l’uomo non può vivere; può semmai semplicemente sopravvivere”95.
Ma cosa è la comunicazione? Quali sono le sue caratteristiche?
“Parlare di comunicazione, oggi, sembra essere un compito a cui è proprio
impossibile sottrarsi. La comunicazione, infatti, si declina volta a volta come frontiera
tecnologica, questione di immagine, problema etico, costituendosi come zona di
intersezione e confronto obbligatorio per le professioni, l’educazione, il dibattito
giuridico e politico”.96
Oggi la comunicazione è tutto. Il suo ruolo, nel corso del XX secolo, ha subìto
un’espansione enorme, soprattutto negli ultimi anni. Ad essa si lega anche una graduale
rivisitazione del suo significato.
Un modo per renderci conto di questa mutazione graduale è quello di consultare
un dizionario importante come lo Zingarelli, facendo un confronto con le edizioni
precedenti, così da cogliere, assieme alla situazione attuale, anche il lento cambiamento
avvenuto a livello semantico in un periodo di circa novant’anni (la prima edizione è del
1922). La prima cosa che emerge con evidenza è lo spazio crescente dedicato al lemma:
nelle prime edizioni – fino al 1965 – la voce è fatta di 60 parole, mentre nelle ultime
edizioni (1983, 1993, 1999 e 2000) le parole sono quadruplicate.
94 J.L. BORGES, L’Aleph, trad. It., Mondadori, Milano, 1997, vol. I, p. 894
95 L. PATI, op. cit., p. 71
96 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., p. 9
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
46
Inizialmente la definizione attribuita alla parola comunicazione era "mezzo di
comunicare, aver relazione". Nell’edizione del 1970 la trattazione cambia completamente
e il primo significato segnalato – in termini di spazio dedicato – è: "atto del comunicare,
trasmettere ad altri: comunicazione di idee, di notizie; comunicazione orale, scritta.
Mezzi di comunicazione di massa, il complesso della stampa e degli audiovisivi impiegati
per la diffusione delle notizie e di spettacoli a tutti i livelli della società e tendenti a creare
comportamenti ideali e bisogni di massa".
Nelle edizioni successive la scelta di dare importanza al lemma viene ulteriormente
confermata; ci sono più dettagli e l’attenzione al contributo della tecnologia e degli studi
di settore è maggiore.
Nel 1983 due sono le novità da evidenziare: scompare la valutazione relativa ai mezzi di
comunicazione di massa e viene aggiunta la definizione: "Processo mediante il quale
l’informazione viene trasmessa, con appositi segnali, da un sistema all’altro". Solo
nell’edizione del 1999 si utilizzerà il significato della teoria dell’informazione che vede
la comunicazione come "scambio di messaggi fra un emittente e un ricevente:
comunicazione verbale, non verbale”.
Dall’esame dello Zingarelli si nota un progressivo superamento del legame
comunicazione/mezzi e vie di trasporto e insieme una sempre più ampia accoglienza dei
significati derivati dalla tecnologia e dagli studi sulla comunicazione.97
A seguito di questa premessa, è lecito chiedersi: come possiamo definire la
comunicazione?
Il concetto di comunicazione rinvia a così tanti significati che risulta difficile
individuarne una definizione unica. Quando si parla di comunicazione, nel senso comune,
si intende uno “scambio di informazioni intenzionalmente orientato, da un soggetto
emittente a un soggetto destinatario, tramite i mezzi offerti dalla più moderna
tecnologia”98.
Differente è il significato che assume il termine comunicazione analizzato da un punto di
vista etimologico. “La comunicazione (dal latino communis, da cum, che significa
“insieme”, e moinis o munis che si può tradurre come “dono, prestazione”) esprime la
reciprocità del dono, la interattività, è bidirezionale. Comunicare è rendere comune, fare
97 F. LEVER, P.C. RIVOLTELLA, A. ZANACCHI (Edd.), voce Comunicazione, in La comunicazione.
Dizionario di scienze e tecniche, Fonte: http://www.lacomunicazione.it/voce.asp?id=298
98 G. ELIA, A. RUBINI, op. cit., p. 125
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
47
altri partecipi di qualcosa, creare uno spazio comune di compartecipazione […] che va
ben oltre la mera trasmissione di notizie e informazioni”99
Infine, possiamo intendere la comunicazione come interazione tra le persone o gruppi,
allo scopo di scambiare informazioni e di stabilire relazioni significative.
È proprio la natura molteplice delle sue definizioni che ci permette di coglierne il
carattere sostanziale: la relazionalità, estesa e correlata a tutti i livelli della vita personale
e della realtà sociale. Comunicare dà alla persona la consapevolezza della sua dimensione
identitaria, ma non solo. È un processo in cui ognuno riconosce l’altro come soggetto,
simile a me, ma con caratteristiche distinte dalle mie, che ne determinano l’unicità.100
“Allora la relazione, mentre unisce, sottolinea pure la differenza e il valore dell’alterità.
Consiste in ciò il paradosso della comunicazione: la diversità personale è condizione
essenziale per la sua fondazione, al pari dell’intersoggettività, che coinvolge i due termini
e li fa coesistere nello stesso legame”101
Possiamo, quindi, affermare che esistono diversi modi di intendere la
comunicazione.
Essa in primo luogo è lo spazio e l’occasione in cui avviene l’incontro interpersonale che
trova espressione nel dialogo. Ma è anche informazione, in quanto rende possibile lo
scambio di esperienze, far sapere e venire a sapere, ampliando il proprio orizzonte
cognitivo. Ancora: la comunicazione è cultura, intesa sia come modo di essere, di vestire,
di muoversi (metacomunicazione), sia come trasmissione attraverso un libro o qualsiasi
fonte detentrice di esperienze o testimonianze. Infine sono comunicazione i media, in
tutte le loro forme: da Internet, alla segreteria telefonica, dalla radio alla neotecnologia.102
In altre parole: “la comunicazione significa tutto”.103
2.1.1. Assiomi della comunicazione
La scuola di Palo Alto, famoso gruppo del Mental Research Institute di Palo Alto
in California, negli anni ’70, ha permesso un ampliamento dell’idea di comunicazione.
Col testo di P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson, “Pragmatica della comunicazione
99 F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 6
100 Cfr G. ELIA, A. RUBINI, op. cit., pp. 125- 128
101 L. PATI, op. cit., p. 66
102 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 15- 16
103 A. CAVALLARI, La fabbrica del presente, Feltrinelli, Milano, 1990, p. 26
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
48
umana” del 1967, si afferma che tutti i comportamenti hanno valenza comunicativa,
quindi non solo quelli intenzionali. L’opera ha posto le basi per un nuovo paradigma della
comunicazione, evidenziandone cinque assiomi che prestano attenzione agli effetti
pragmatici dell’azione comunicazionale e danno valore all’influenza reciproca di tutti i
fattori coinvolti.
Il primo assioma dice che “non si può non comunicare”, quindi qualunque
atteggiamento assunto da un individuo diventa immediatamente portatore di significato
per gli altri. Potremmo descrivere questo prima assioma con le parole di Rivoltella: “la
comunicazione viene considerata come una realtà dell’uomo, una sua dimensione,
qualcosa che appartiene alla sua natura. L’uomo non può fare a meno di comunicare,
alla stesso modo in cui non può fare a meno di espletare le sue altre funzioni vitali.”104
Il secondo stabilisce che “ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un
aspetto di relazione, di modo che il secondo classifica il primo ed è quindi
metacomunicazione”. Il contenuto della comunicazione è sempre influenzato dal tipo di
relazione che intercorre tra i soggetti della stessa. Questo decreta il tipo di messaggio che
viene scambiato, formale o informale, ma anche la profondità dei temi toccati.
Il terzo assioma evidenzia che “la natura di una relazione dipende dalla
punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti”. Poiché la
comunicazione è un continuo alternarsi di flussi comunicativi da una direzione all'altra e
le variazioni di direzione del flusso comunicativo sono scandite dalla punteggiatura, il
modo di leggerla sarà determinato dal tipo di relazione che lega i comunicanti.
Il quarto assioma afferma che “gli esseri umani comunicano sia con il modulo
numerico sia con quello analogico”. Quando gli esseri umani comunicano per immagini,
ad esempio disegnando, la comunicazione è analogica. Esempi di mezzi di
comunicazione analogici sono: il termometro a mercurio o l'orologio a lancette. Quando
si comunica usando le parole, la comunicazione segue il modulo digitale. Questo perché
le parole sono segni arbitrari che permettono una manipolazione secondo le regole della
sintassi logica che li organizza. La comunicazione digitale si basa sull'uso di segnali
discreti per rappresentare in forma numerica i fenomeni e gli oggetti che intende
designare. Esempi di mezzi di comunicazione digitali sono: il fax, il compact disc,
l'orologio a cristalli liquidi (in cui l'indicazione dell'ora e delle sue frazioni è visualizzata
con scatti di cifre).
104 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 60- 61
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
49
Infine, per il quinto assioma, “tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici
o comportamentali, a seconda che siano basati sull’uguaglianza o sulla differenza”. Si
dicono complementari gli scambi comunicativi in cui i comunicanti non sono sullo stesso
piano (mamma/bambino, dipendente/datore di lavoro). Sono simmetrici gli scambi in cui
gli interlocutori si considerano sullo stesso piano: è questo il caso di comunicazioni tra
pari grado (marito/moglie, compagni di classe, fratelli, amici).105
2.1.2. Dimensioni e modelli della comunicazione
Individuare le dimensioni- quadro della comunicazione vuol dire individuarne le
strutture fondamentali. Bisogna, però, prima di descriverle, evidenziare come ogni
dimensione, seppur distinta dalle altre, non sia un’isola -sono integrate tra di loro- e che
nessuna di esse è propria solo di un determinato ambito comunicativo.
Inoltre ognuna può essere letta secondo tre ordini di analisi: sul piano economico (logiche
produttive, pratiche commerciali, contrattazioni reali o simboliche attivate), piano
tecnologico (ambienti e strumenti che consentono la circolazione delle informazioni) e
infine sul piano metaforico (dimensioni come una sorta di “griglia di lettura” della realtà
sociale).
Le dimensioni del comunicare le possiamo identificare in: informativa,
relazionale, partecipativa ed esplorativa. La prima riguarda tutto ciò che consente di
mettere qualcuno al corrente di qualcosa, nel senso di far sapere, informare, rendere noto
(prospettiva tecnica). Utilizza la metafora dello scambio, la dinamica comunicativa
sottesa è quella della trasmissione\ recezione e infine la logica che utilizza è quella
epistemica (area del sapere).
La seconda dimensione, quella relazionale, intende la valenza comunicativa come
essere in rapporto con qualcuno. Coglie nel comunicare il primato della relazione,
l’apertura all’altro, la componente psico- dinamica dell’incontro (prospettiva
antropologica). La metafora utilizzata per spiegare questa dimensione è quella del
dialogo, la dinamica comunicativa attivata è quella della relazione\interazione, mentre la
logica ad essa connessa è quella affettiva.
La penultima dimensione è quella partecipativa, che consente di leggere il
fenomeno comunicativo nel senso del mettere in comune, del partecipare intimamente. Si
105 Cfr G. ELIA, op. cit., p. 88, nota 9
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
50
muove entro una logica rituale (area dell’apprendere), attiva la dinamica comunicativa
della rappresentazione\riconoscimento e utilizza la metafora della memoria.
Infine, troviamo la dimensione esplorativa, che declina il termine storico-
geografico della circolazione, dell’esperienza della navigazione in un ipertesto o in
Internet. La metafora utilizzata è, appunto, quella del viaggio, la logica è quella euristica
(area della conoscenza) e infine la dinamica comunicativa a cui fa riferimento è quella di
desituazione \ risituazione.106
Potremmo quindi affermare che la comunicazione gioca un ruolo rilevante almeno
su tre livelli: teorico, in quanto criterio di lettura delle pratiche sociali che in essa si
svolgono; ontologico, perché riguarda la dimensione assiologica dell’essere; politico-
culturale- educativo, in quanto ha un ruolo molto importante per quanto riguarda
l’acquisizione e la distribuzione del sapere sociale, sul piano della costruzione della
cultura e della realtà politica.107
Di seguito verranno descritte in maniera più approfondita le due dimensioni più
importanti ai fini della trattazione di questa tesi: quello dell’informazione e quello della
relazione.
Il primo modello comunicativo a cui si fa riferimento è quello dell’informazione.
Esso parte dalla considerazione che, originariamente, “comunicare” significava,
“trasmettere” in modo puro e veloce. L’idea- guida a cui si fa riferimento, è, appunto,
quella del “trasporto”.
La comunicazione, quindi, viene vista come atto unilaterale, in cui viene
trasmesso un messaggio, da un emittente a un destinatario.108 “Tale operazione può avere
più o meno successo, ma l’iniziativa e il lavoro in essa spettano all’emittente. Il
destinatario si trova a ricostruire l’intenzione dell’emittente, a interpretare il messaggio,
a reagire ad esso o a rifiutarlo. Ma la situazione di base è quella della trasmissione pura
e semplice, come accade quando qualcuno spedisce una lettera a qualcun altro.”109
Colui che per primo ha concettualizzato tale modello è stato Roman Jakobson,
grande linguista, il quale ha fatto esplicito riferimento alla teoria dell’informazione
sviluppata precedentemente dal matematico americano Claude Shannon. L’obiettivo di
106 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 49- 53
107 Id, p. 22
108 Cfr. A. FABRIS, op. cit., p. 41- 42
109 U. VOLLI, Manuale di semiotica, Laterza, Bari- Roma, 2000, p. 8
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
51
quest’ultimo era quello di favorire un tipo di comunicazione in cui la trasmissione fosse
dispensata da qualsiasi tipo di ambiguità, disturbi o rumori di fondo, in modo da
massimizzare il “rendimento informazionale”. Nel suo modello, quindi, Shannon per
comunicare “bene” intende una trasmissione di informazioni, in modo pienamente
efficiente ed efficace. Questo modello si presenta come uno schema della comunicazione
semplice e lineare, in cui il processo informativo si può rappresentare come la
trasmissione di un segnale da parte di un emittente a un ricevente.
Jakobson applica la teoria shannoniana alla linguistica, permettendo di accostarla
a tutte le dimensioni della comunicazione. Per il linguista ogni evento di comunicazione,
ogni passaggio di informazioni tra due apparati o tra due individui, prevede sempre la
presenza (non necessariamente nello stesso tempo e luogo) di un emittente e di un
ricevente. Per regolare lo
scambio comunicativo tra questi
due protagonisti, ha elaborato
uno schema generale della
comunicazione (Figura 2), in
cui possiamo ritrovare: il
mittente, il contesto, il
messaggio, il contatto, il codice
e infine il destinatario.
Il mittente invia un
messaggio al destinatario. Per essere
efficace questo richiede, in primo luogo, il riferimento a un contesto (che possa essere
compreso dal destinatario e che sia verbale o, quantomeno, suscettibile di
verbalizzazione). In secondo luogo ci dev’essere un codice, interamente o parzialmente,
comune ad entrambi i soggetti del processo comunicativo; e infine un contatto, un canale
psichico, una connessione psicologica che consenta loro di stabilire e mantenere una
relazione.
Jakobson, inoltre, assegna ad ogni elemento del sistema, una funzione specifica
nello scambio comunicativo. Al mittente viene assegnata la funzione emotiva (o
soggettiva) che descrive il rapporto che intercorre tra emittente e messaggio (stati
d’animo, emozioni e atteggiamenti); al destinatario conferisce la funzione conativa (o
imperativa), che riguarda il rapporto tra il messaggio e il destinatario e indica la capacità
di ogni messaggio di produrre effetti su chi lo riceve.
FIGURA 2- MODELLO LINGUISTICO DI JAKOBSON
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
52
Secondo Austin, ogni atto linguistico si lascia comprendere a tre livelli: locutorio
(informare gli altri di qualcosa), illocutorio (ciò che si intende significare ma non si dice)
e perlocutorio (effetto che si intende produrre sull’ascoltatore).
Per quanto riguarda gli altri elementi del modello, vengono rispettivamente
attribuite al contesto, messaggio, codice e contatto, le seguenti funzioni: referenziale, che
indica l’orientamento del messaggio alla realtà; poetica, trasgressioni delle convenzioni
che regolano la comunicazione (contro la rigidità strutturale); metalinguistica, che
permette il riconoscimento del tipo di codice utilizzato nella comunicazione; infine quella
fatica, che consiste nel mantenere aperto il canale della comunicazione, garantendo la
permanenza del contatto.110
La comunicazione, però, non è solo volta a fornire informazioni, non è solo
“informare”. Essa ha anche il compito di dischiudere uno spazio comune di relazione tra
gli interlocutori. Si verifica, durante questo processo, un vero e proprio coinvolgimento,
un legame che va al di là del mero scambio di notizie. “I due soggetti comunicanti si
contraddistinguono per la loro ben delineata individualità, la quale non rimane chiusa
in un campo esperienziale egoistico, ristretto, ma inclina all’apertura ed alla relazione
con altre individualità”.111 È nell’incontro e nel riconoscimento di entrambe queste
individualità che si crea lo spazio in cui si realizza la comunicazione.
Affinché la comunicazione possa dirsi efficace, c’è bisogno di due componenti
fondamentali: che emittente e ricevente abbiano codici culturali e modelli mentali simili
e che vi sia intenzionalità sia da parte dell’emittente che da parte del destinatario.
Sia l’emittente che il destinatario, pertanto, sono soggetti attivi nella
codificazione, decodificazione ed elaborazione dell’informazione.112
Questo modello, che definiremo modello della relazione, si contrappone a quello
precedentemente descritto, che prevedeva uno scambio unilaterale, in cui il feedback
veniva considerato come momento successivo all’impulso iniziale. Nel modello della
comunicazione, l’interazione è sempre possibile (simultaneità) e il feedback è sin
dall’inizio previsto e richiesto, divenendo, così, parte integrale della relazione
comunicativa. In questo modo anche la distinzione tra emittente e ricevente si annulla.113
110 P. C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 92- 96
111 L. PATI, op. cit., p. 66
112 Cfr G. ELIA, op. cit., p. 87- 88
113 Cfr. A. FABRIS, op. cit., pp. 41- 48
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
53
Sarà a questo modello a cui, successivamente, si farà riferimento nella descrizione del
modello di riferimento per una comunicazione etica nell’era digitale. Data la successiva
trattazione, mi riservo di rimandare un ulteriore approfondimento di tale modello al
capitolo terzo.
2.2. Elementi della comunicazione
Come possiamo dedurre dal modello di Jakobson, possiamo ritenere molteplici gli
elementi che compongono l’atto comunicativo. Potremmo comunque distinguerli in due
categorie: umani, ovvero i soggetti agenti nell’atto comunicativo (emittente, destinatario,
ricevente) e tecnici, cioè gli elementi che contribuiscono a creare l’oggetto dell’atto, cioè
il messaggio. In questa sede ci limiteremo a considerare e descrivere solo questi ultimi,
ovvero segno, codice e testo.
2.2.1. Il segno
Nella nostra vita quotidiana abbiamo sempre a che fare con i segni. Li possiamo
classificare in: fonetici (con cui ci esprimiamo, articolando proposizioni dotate di senso),
grafici (attraverso i quali fermiamo su carta o sullo schermo di un computer il nostro
pensiero), iconici (che costituiscono la nostra realtà visiva), naturali (fenomeni invariati
nel tempo) e convenzionali (che variano in base al contesto culturale).
Da questa categorizzazione possiamo dedurre due ordini di idee. La prima è la
necessitò di comprendere il mondo come «sistema semiotico», in cui i significati non
sono dati, ma costruiti. La seconda riguarda l’interpretazione di questi segni
(ermeneutica). In questo modo è possibile cogliere la dimensione fondamentale del segno:
il segno significa, risolve la sua funzionalità nel rinviare a un significato, produce senso.
Il primo modello che ci ha permesso
di individuare il sistema di significazione
del segno è il triangolo di Ogdens e
Richards (Figura 3). In questo modello il
segno viene inteso come un sistema di
cooperazione a tre soggetti: il simbolo
(segno nella sua materialità significante),
idea o referenza (contenuto mentale, o
concetto, cui il segno rinvia) e il referente
FIGURA 3- TRIANGOLO DI OGDENS E
RICHARDS
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
54
(realtà rappresentata dal segno). Il rapporto tra segno e il significato a cui rimanda viene
pensato secondo una duplice modalità: legame naturale (vedere fumo all’orizzonte vuol
dire presenza di fuoco) e legame convenzionale. Mentre i legami naturali tendono a
rimanere invariati nel tempo, i segni convenzionali variano in relazione al contesto
culturale a cui appartengono, sia nel senso etno- geografico, che temporale. In realtà tale
distinzione non risulta più corretta in quanto il contesto in cui il segno si presenta
influenza anche il segno naturale.
Successivamente il segno diviene oggetto di una scienza separata dalle altre: la
semiotica. La semiotica, nata alla fine del secolo scorso, si pone il problema di una
definizione scientifica del segno. I primi due modelli a cui fa riferimento sono quelli di
de Saussure e di Peirce.
Fu Ferdinand de Saussure, nel primo decennio del XX secolo, a introdurre la nozione di
segno linguistico. Per de Saussure il segno linguistico è costituito da due componenti
fondamentali: significante e significato. Egli parla di "immagine acustica", espressa dal
suono (piano dell’espressione) per il significante e di "concetto" (piano del contenuto)
per il significato.
La più importante caratteristica del segno individuata da Saussure è l'arbitrarietà. Un
segno è arbitrario in quanto non esiste nessuna ragione particolare per cui un determinato
significante debba richiamare alla mente un determinato significato: la loro correlazione
è una convenzione. L’individuazione del rapporto tra significante e significato permette
di distinguerlo dai segnali naturali (la correlazione tra la fame o il sonno e lo sbadiglio
non è certo convenzionale) e di spiegare le differenze fra le varie lingue.
Il modello di Pierce, invece, parte dall’individuazione di tre categorie
fondamentali della realtà (possibilità, esistenza, necessità). Egli parte sempre da una
relazione triadica, in cui possiamo identificare i seguenti soggetti: l’oggetto dinamico,
cioè un’istruzione semantica che vincola il segno alla sua rappresentazione, rimanda alle
esperienze possibili in un determinato contesto culturale o sociale; l’oggetto immediato,
risultato della selezione tra i possibili oggetti dinamici; e infine l’interpretante, cioè l’idea
che il segno produce in chi lo riceve (non indica una persona, ma l’effetto mentale che il
segno produce).
Entrambi questi modelli presentano dei limiti: quello di de Saussure non è
dinamico, in quanto presta esclusivamente attenzione al segno linguistico, trascurando sia
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
55
l’oggetto che i soggetti; quello di Pierce, invece, rimanda ad un’idea di realtà filtrata dai
modelli culturali vigenti in un determinato contesto.114
2.2.2. Il codice
I codici, elementi basilari della comunicazione, giocano un ruolo fondamentale
nella produzione di senso. Si può definire codice un’unità di marche semantiche che
stabilisce equivalenza tra un sistema di significanti e un sistema di significati. De Marinis
definisce così i codici: “la regola (o l’insieme di regole) che associa gli elementi di un
sistema (veicolante) agli elementi di un altro sistema (veicolato)” 115 . Essi sono
innanzitutto un mezzo linguistico senza cui viene meno la possibilità stessa di
comunicare. Il codice non è mai sperimentabile al di fuori di un contesto, ma è sempre
integrato con esso. Per classificare i codici è possibile utilizzare due tipi di criteri:
verticale e orizzontale.
Secondo il criterio verticale, si possono distinguere tre categorie di codici:
culturali o generali (non specifici), culturali specifici (o spettacolari) e codici tecnici
specializzati (o convenzioni). I primi comprendono, in senso ampio, tutti i codici
semiotici che permettono di comunicare in qualsiasi contesto e senza i quali è impossibile
comunicare (codici assiologici, ideologici, linguistici, paralinguistici, cinesici, ecc.). Il
secondo raggruppamento di codici riguarda tutti i codici attivati in ambito spettacolare
(cinema, teatro, televisione, ecc.); infine l’ultimo gruppo di codici sono convenzioni
specifiche di ogni ambito spettacolare, che producono nel destinatario della
comunicazione, comportamenti di consumo codificati dall’uso. A loro volta le
convenzioni possono essere distinte in: generali, particolari e specifiche.
Secondo il criterio orizzontale, invece, possiamo distinguere i seguenti ordini di
codici: narrativi (testo, regole linguistiche e le modalità di discorso impiegate nella sua
costruzione), percettivo- figurativi (o della sfera visiva) e linguistici o sonori (della sfera
uditiva)116
114 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 82- 92
115 M. DE MARINIS, Semiotica del teatro, Bompiani, Milano 1982, p. 122
116 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 100- 105
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
56
2.2.3. Il testo
Altro elemento basilare nella comunicazione è il testo. Etimologicamente, la
parola «testo» si fa risalire al latino textus, participio passato del verbo texere, che
significa tessere, intrecciare. Possiamo definire testo “un sistema pluridimensionale,
costituito da una rete di parti coerenti e attraversato da una intenzionalità
comunicativa”.117
Storicamente tre sono le letture fondamentali del concetto di testo. La prima,
definita tradizionale, privilegia la dimensione scritta, intendendola a diversi livelli: prima
come successione fissa di significati grafici, che portano ad un significato semantico, ora
come materiale di cui il testo è costituito, ora come opera alludendo al suo contenuto. Con
l’avvento della linguistica testuale il significato della parola «testo», amplia il suo
orizzonte significativo, includendo anche la forma orale. Infine, l’ultima definizione del
testo, lo pensa come grande enunciato (o enunciato complesso), orale o scritto, costituito
e giudicato coerente, dove per enunciato si intende l’oggetto della comunicazione, il
messaggio.
Ciò che è basilare nella stesura di un testo, è la coerenza interna di tutti i suoi
elementi, indispensabile per la costruzione del senso che in esso si fa presente. Per poter
assegnare senso ad un enunciato, è indispensabile che l’autore ponga l’intenzione di
significare lo stesso.118
Un elemento molto importante per poter interpretare il testo è il suo contesto. Vi
sono cinque tipologie di contesti. Le condizioni spazio- temporali entro cui la
comunicazione si svolge (localizzazione, datazione, durata del testo e il contesto
circostanziale, cioè il rapporto del suo spazio- tempo rispetto a quello del lettore). Un
altro aspetto importante è il contesto esistenziale, ossia il riferimento ad un mondo, ad
una storia vera o utopica. Inoltre può far riferimento a un quadro normativo, cioè un
sistema di regole (etiche, linguistiche, culturali) che ne disciplinano l’uso (contesto
istituzionale). Infine troviamo il contesto azionale (che fa riferimento all’agire
comunicativo dei soggetti e al sistema si competenze che esso presuppone) e il contesto
transtestuale, ovvero l’insieme di tutti i testi che sono in relazione tra di loro.119
117 Id., p. 109
118 Id., pp. 100- 109
119 Id., pp. 115- 116
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
57
2.3. La comunicazione nell’era digitale: nascita e sviluppo
del medium
“Le società sono sempre state plasmate più dalla natura dei media attraverso i
quali gli uomini comunicano che non dal contenuto della comunicazione …. […] È
impossibile capire i mutamenti sociali e culturali senza una conoscenza del
funzionamento dei media”120
Analizzando il nostro tempo attraverso le lenti della comunicazione, ci rendiamo
conto che stiamo attraversando una transizione importante. Raffaele Simone l’ha definita
come la “terza fase”121. L’autore rileggendo le fasi dello sviluppo della scrittura da un
punto di vista culturale, identifica tre fasi, partendo da una sorta di “tempo zero”, definita
età dell’Oro, in cui trionfava la parola parlata. La “prima fase” è quella segnata
dall’invenzione della scrittura, la “seconda” in cui ritroviamo l’espansione della stampa
e infine la “terza”, quella attuale, in cui c’è una proliferazione dei dispositivi di
comunicazione.122
La genesi dell’attenzione storica allo sviluppo delle tecnologie di comunicazione
va ricondotta ai contributi di Harold Innis e Lewis Mumford. Il primo, dopo una serie di
studi sull’informazione, giunge a riflettere sulla storia della civiltà come storia delle
tecnologie della comunicazione. Il secondo, invece, concentra i suoi studi sul ruolo delle
tecnologie nel processo di rinnovamento della vita che contraddistingue la modernità. 123
Dalla riflessione di questi due autori McLuhan ha tratto spunto per articolare la
sua celebre trattazione storica della cultura. Egli ha diviso la storia in tre periodi,
caratterizzati da altrettanti stadi di avanzamento della comunicazione: 1) tradizione orale,
con una ‘società chiusa’, priva di individualità; 2) scrittura e stampa, che rompono
l’equilibrio tribale sostituendo ‘l’occhio all’orecchio’, favorendo il pensiero causalistico,
la razionalità e la comunicazione lineare; 3) elettronica, in cui i media estendono
circolarmente il sistema nervoso all’intero pianeta, ogni uomo è coinvolto nei problemi
120 M. MCLUHAN, Il medium è il messaggio. Feltrinelli, Milano, 1968, p. 8
121 R. SIMONE, La terza fase, Laterza, Roma- Bari, 2003, p. VII
122 Cfr V. BOCCI, Comunicare la fede ai ragazzi 2.0, Elledici, Torino, 2012, pp.47- 48
123 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., p. 244
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
58
degli altri e si ripropongono, su scala globale, contatti simili a quelli che avvenivano nel
villaggio (da qui “il villaggio globale”).124
La prospettiva storica verrà assunta anche nella trattazione di questa tesi, per
mezzo della quale seguiremo il processo evolutivo del comunicare umano, dai modelli
orali delle comunità di villaggio, attraverso la rivoluzione della stampa, fino all'industria
culturale di questo secolo e alle più recenti acquisizioni tecnologiche.
L'utilità circa l'adozione di questa prospettiva storica si fonda su tre ordini di
considerazioni che costituiscono altrettanti ambiti di analisi: livello tecnico, ovvero
studiare le soluzioni e i supporti fisici di cui l'uomo si è via via servito per veicolare
messaggi; livello psico- cognitivo, riflessione di tipo storico sullo sviluppo delle
tecnologie di comunicazione va cercata negli effetti che esse inducono nella struttura
psico-cognitiva dei soggetti; il livello socio- pedagogico, che ha ad oggetto non solo i
risvolti del comunicare sull’alfabetizzazione, ma anche sull’educazione. Ognuno di questi
piani di lettura ha un preciso trend che permette la comprensione del suo sviluppo. Per
quanto riguarda il piano tecnico, l’evoluzione comunicativa si potrà leggere nel senso di
una sempre maggiore velocità ed estensione (virtualizzazione), sul piano psico- cognitivo
si potrà registrare come la comunicazione, nel tempo, sia andata sempre più
complessandosi, tendendo al raggiungimento di obiettivi sempre meno individuali
(collettivizzazione). Infine, sul piano socio- pedagogico, la diffusione delle competenze
alfabetiche consentirà di leggere l’intero processo comunicativo come realizzazione della
razionalità (razionalizzazione).125
2.3.1. Dal pensiero orale al villaggio globale
Ogni tecnologia di comunicazione produce una trasformazione dei nostri set
mentali, influendo sul nostro modo di acquisire e scambiare conoscenze. Nella trattazione
che segue si cercherà di mettere in luce i passaggi che l’uomo ha compiuto sino ad arrivare
alle porte del nuovo millennio.
La prima fase inizia nella preistoria, epoca in cui la comunicazione si sviluppa
attraverso segni e segnali, tramite comportamenti acquisiti in maniera ereditaria.
124Cfr C. GAGLIARDI, in F. LEVER - P.C. RIVOLTELLA – A. ZANACCHI (Edd.), voce Villaggio Globale, op. cit., Fonte:
http://www.lacomunicazione.it/voce.asp?id=1338
125 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 124- 129
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
59
Si tratta di suoni (ringhi, urla, grugniti) che gli ominidi emettono senza il bisogno
di particolari sforzi di articolazione. Pur ricorrendo a suoni gutturali, l’uomo primitivo lo
fa in maniera codificata, introducendo la relazione tra un determinato suono e la comparsa
di un evento.
Tra i 90.000 e i 40.000 anni fa, si compie il passaggio dai suoni gutturali alla
parola articolata. Le ragioni di questo passaggio sono due, neurobiologiche e funzionali,
e coincidono con la comparsa dell’uomo Cro Magnon. Anatomicamente la struttura del
suo teschio e la conformazione della laringe, infatti, consentono di articolare suoni. La
comparsa del linguaggio verbale permette di codificare e decodificare facilmente ciò che
si vuole dire e accorda la possibilità di trasmettere messaggi più lunghi e complessi.
La comunicazione orale è globale perché coinvolge tutto l’uomo nella sua
interezza percettiva, ponendolo in relazione personale e immediata con i suoi
interlocutori. L’assenza di un supporto scritto, comporta che la memoria costituisca
l’unico valido supporto per la conservazione e la trasmissione del sapere. La
comunicazione orale, di conseguenza, si avvale di tutta una serie di aides a memoires
(frasi o intercalali che aiutano il recupero di dati nella memoria), come la formularità delle
espressioni, la ridondanza verbale, la forma metrica ed agonistica. Questo tipo di
comunicazione, delle comunità di villaggio (come direbbe McLuhan), è tipica di modelli
sociali «a solidarietà meccanica» (Durkheim), caratterizzate da una forte coesione
interna e dal tramandare la tradizione degli eventi più significativi del gruppo. La società
della cultura orale è una società chiusa dove l’innovazione non viene per niente favorita,
in quanto la conoscenza viene raggiunta ed accumulata con difficoltà. Gli anziani ne sono
i custodi.
Questa prima fase si conclude con l’ingresso nella cultura letteraria. Gli inizi della
cultura letteraria si possono far risalire circa al 4000 a.C. quando, in Mesopotamia e in
Egitto, fanno la loro prima comparsa i sistemi pittografici e convenzionalizzati.
L’uomo avverte la necessità di utilizzare strumenti che gli permettano di supportare la
memoria. Presto, però, la scrittura pittografica denuncia i suoi limiti, relativi soprattutto
all’enorme quantità di simboli grafici da tenere a mente e alla complessità che questo
metodo presentava nell’elaborazione di pensieri complessi.
Quando ci si rende conto di tali limitazioni cambia lo stile comunicativo
dell’uomo: nasce la fonetizzazione. I sumeri, a cui si deve questa importante conquista,
intorno al 1700 a.C., elaborarono la scrittura cuneiforme, un sistema che permetteva di
abbinare a parole o sillabe un determinato suono.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
60
Per l’elaborazione dell’alfabeto completo si dovrà aspettare il 700 a.C., grazie ai Greci.
L’invenzione della stampa a caratteri mobili, introdotta da Gutenberg, intorno al
1440, è parte integrante del passaggio dalla cultura orale e quella letteraria. Scrittura e
stampa diventano così due momenti, cronologicamente distanti tra loro, che
contribuiscono allo sviluppo comunicativo dell’Occidente. È una cultura dell’occhio,
contrapposta a quella dell’orecchio dell’epoca precedente. La comunicazione si fa
sintetica (raccolta nel soggetto e non è condivisa sempre e comunque dalla comunità),
silenziosa, istantanea (sottratta allo scorrere della narrazione). La fruizione dei messaggi
è individuale contro la fruizione “in contesto” della cultura orale.
La memoria perde l’importanza che aveva nella cultura orale. Il libro è
un’estensione della mente. Una sorta di memoria artificiale che libera l’uomo dal dover
memorizzare il sapere e dal tramandare solo quello che gli era più gradito. La memoria
non sarà più il tratto distintivo del sapiente. Ci si distacca dall’esperienza concreta. Con
la scrittura gli individui si emancipano dal contesto entro cui avviene la comunicazione
orale, ma al tempo stesso perdono quel surplus, quel valore aggiunto di significato che
solo la comunicazione orale può dare (gesti, espressioni facciali, postura, ambiente
circostante, ecc.) e perdono anche il destinatario in carne ed ossa.
È vero però che il libro permette un’analisi retrospettiva, un uso flessibile dei messaggi
di cui facilita anche la circolazione e la trasportabilità. Tuttavia nascono anche dei
problemi. Per dirla con Eco, si va sempre più perdendo l'intetitio auctoris. Ciò che rimane
è l'intentio operis. Si apre quindi il problema dell'oggettività del significato e della sua
interpretabilità da parte del lettore (emancipazione della lettura dall’atto
dell’enunciazione).
Con la rivoluzione della stampa e quindi con la riproduzione tecnica dei testi, si assiste
alla nascita della cultura di massa.126
Il nuovo modo di intendere la cultura vede nell’Illuminismo la sua massima
espressione. In questo secolo si accentua l’importanza dell’alfabetizzazione delle classi
inferiori, privilegiando la formazione di competenze specializzate e riservando una
grande attenzione agli aspetti morali dell’educazione. Nasce e si sviluppa, così, la cultura
dell’informazione, che si affermerà per tappe successive e che comporterà una nuova fase
di avanzamento tecnologico, che inizierà con il telegrafo, il telefono sino ad arrivare alla
126 Id., pp. 129- 158
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
61
radio, alla televisione e al computer. Questi mezzi varranno poi indicati come mezzi di
comunicazione di massa (mass media).127
Questi mezzi comunicativi hanno il grande pregio di permettere un tipo di
comunicazione immediata, in cui è possibile trasferire un gran numero di parole,
mantenendo invariata la natura simbolica dell’uomo. 128 Essi costituiranno la componente
fondamentale che permetterà il passaggio in un’altra era della comunicazione, l’ultima,
definita del “villaggio globale”. Tale definizione è un ossimoro (figura retorica che
affianca due concetti opposti) che si è imposto tra i più famosi cavalli di battaglia di
McLuhan nell’indagine sul progresso tecnologico della società: il ‘villaggio’ è la forma
elementare di abitato umano, mentre l’aggettivo ‘globale’ si riferisce all’intero pianeta. Il
significato dell’accostamento è ovviamente simbolico. La forzatura serve al mediologo
canadese per esprimere una situazione inedita, di difficile rappresentabilità: ciò che in
passato aveva dimensioni e distanze enormi, grazie all’innovazione delle comunicazioni
è ora a portata di mano, percorribile in lungo e in largo, anche in tempo reale. McLuhan
si esprime così: "L’accelerazione dell’era elettronica è per l’uomo occidentale [...]
un’implosione improvvisa e una fusione tra spazio e funzioni. La nostra civiltà [...] vede
improvvisamente e spontaneamente tutti i suoi frammenti meccanizzati riorganizzarsi in
un tutto organico. È questo il nuovo mondo del villaggio globale.”129
A ben vedere, McLuhan non è il primo a introdurre il riferimento al "villaggio".
Già Robert E. Park, sociologo della Scuola di Chicago che studia la "città", nel 1923
adotta la metafora del "villaggio" per descrivere la nuova realtà urbana segnata
dall'impatto dei media, nella fattispecie dei giornali: "I giornalisti e la stampa tendono,
consciamente o inconsciamente, a rispecchiare nella città, nei limiti del possibile, le
condizioni di vita del 'villaggio'. Nel villaggio tutti si conoscevano, si chiamavano per
nome. Il villaggio era democratico. Anche la nostra è oggi una nazione di paesani. Le
nostre istituzioni sono fondamentalmente quelle di un villaggio. Nel villaggio, il gossip e
l'opinione pubblica erano le principali forze di controllo sociale". 130
Oggi il concetto di villaggio globale è strettamente legato a quello di
globalizzazione, neologismo che indica la caduta di tutte le dogane e barriere
127 Id, pp. 159- 162
128 Cfr G. SARTORI, op. cit., pp. 7- 8
129M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, Garzanti, Milano 1986, p. 112
130R. E. PARK, The natural history of the newspaper, in The American Journal of Sociology, Novembre1923, pp. 277-278
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
62
internazionali, in vista di una più agevole e veloce condivisione di informazioni e risorse.
Quanto accade in un punto qualsiasi del pianeta è come se accadesse ‘sotto casa, accanto
a noi’.131
2.3.2. Nascita ed evoluzione dei mass- media
Oggi, nel postindustriale, viviamo in una fase più avanzata rispetto a questa
periodizzazione. Siamo passati dalla società dell’informazione (dominata dai mass media,
da messaggi monodirezionali tra una fonte e i destinatari) alla società della
comunicazione (segnata dalla multimedialità, dalla convergenza fra Tv, personal
computer e telecomunicazioni, in cui il soggetto è al tempo stesso destinatario e fonte di
messaggi polidirezionali).
Ogni fase del progresso tecnologico ha visto un medium subentrare all’altro
superandolo, ma senza per questo determinarne l’estinzione; anzi, il preesistente ha
trovato proprio nei rapporti con il nuovo le opportunità per ristrutturarsi e specializzarsi
in forme più avanzate. Così è stato per la scrittura sulla oralità, per il giornale sul libro,
per il cinema sulla fotografia, per la televisione sulla radio; così sta avvenendo per il
multimediale e per Internet.
McLuhan sosteneva che i media elettronici hanno abolito sia il tempo sia lo spazio,
facendoci perdere la capacità di ripartire i ruoli e di assumere punti di vista individuali.132
Ma cosa è il medium? La definizione di medium, come quella di comunicazione,
è di difficile determinazione. “Si possono ricercare le radici del concetto in quella attività
di significazione che si traduce a sua volta in uno sforzo per dare estensione e
permanenza all’atto comunicativo: al termine medium si può infatti attribuire
un’accezione vasta, metaforica, parlando allora di mediazione come condizione tipica
dell’esistenza stessa all’interno della cultura”133. Si può parlare di medium in senso
stretto ogni qualvolta che l’uomo si avvale dalla tecnologia come supporto capace di
potenziare l’attività di significazione e comunicazione (migliorando la qualità del
messaggio, svincolandolo dalle dipendenze spazio-temporali ecc.). Negli ultimi due
131Cfr C. GAGLIARDI, http://www.lacomunicazione.it/voce.asp?id=1338
132 Ibid.
133 A. CALVANI, Educazione, comunicazione e nuovi media, UTET Università, Torino, 2008, p. 21
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
63
secoli i rilevanti cambiamenti tecnologici hanno prodotto ulteriori amplificazioni, con
rilevanti effetti sullo spazio relazionale.134
Di questi cambiamenti, nei paragrafi successivi, verrà fatta una veloce panoramica
evidenziandone i vantaggi apportati alla vita dell’uomo.
A tal fine mi sembra doveroso far preliminarmente riferimento alla teoria
dell’evoluzione psico- culturale e psico- tecnologica della civiltà umana delineata da de
Kerckhove, in cui possiamo rintracciare cinque tappe fondamentali. Le prime due, della
comunicazione prima orale e dopo scritta, sono state già abbondantemente descritte
precedentemente. Per quanto riguarda le successive tre, il sociologo le descrive così: la
civiltà dei media elettrici (telegrafo, radio, televisione), che hanno dato origine ad una
forma di pensiero chiamata public mind in quanto si rivolgono alle masse; l’epoca del
computer, che con la sua velocità di processazione dei dati e con la possibilità
dell’interazione uomo- macchina ha contribuito a formare una accelerated mind e infine
Internet che permette la connessione di tutte le menti, in una sorta di intelligenza
collettiva.
De Kerckhove afferma che le ultime tre fasi di questa evoluzione hanno
comportato due grosse novità: l’esteriorizzazione della mente, che emigra dalla testa allo
schermo, spazio virtuale e la connettività secondo cui il pensiero perde le sue
caratteristiche di interiorità e diviene qualcosa di esterno, condiviso e intersoggettivo.135
2.3.2.1. Dal telegrafo al cinema
L’età dell’informazione inizia con la prima stagione della stampa popolare nella
seconda metà del XVII secolo. La stampa quotidiana e periodica sono la prima grande
occasione per trasmettere un gran numero di informazioni ad un pubblico ampio, con
notevoli difficoltà, però, di trasmissione sia per quanto riguarda lo spazio (grandi distanze
che intercorrevano da una città all’altra) che temporali (conseguenza delle prime).
Per ovviare a queste difficoltà bisognerà aspettare la comparsa dell’elettricità e,
nel 1840, la nascita del primo mezzo di comunicazione che cercherà di risolvere i
problemi di natura trasmissiva: il telegrafo.
Inventato da S.F.B. Morse, questo strumento, comporterà una rivoluzione comunicativa
di portata straordinaria, sia in ordine alla trasmissione dell’informazione (emancipando
134 Cfr Id, pp. 21- 25
135 Cfr D. FELINI, Pedagogia dei media, La Scuola, Brescia, 2004, pp. 27- 28
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
64
la comunicazione dai vincoli spaziali) che alla rappresentazione del mondo e alle nuove
forme di interazione sociale attraverso di esso realizzabili. Il telegrafo- potremmo dire- in
qualche modo anticipa gli sviluppi recenti dei media elettronici nel senso
dell’impersonalità dei messaggi e, soprattutto, del loro carattere di “apertura”, ovvero
l’elevato grado di integrazione cooperativa che da essi viene richiesto al lettore.136
Dopo il telegrafo fu la volta, nella seconda metà del sec. XIX, dell’invenzione del
telefono con il quale fu possibile superare molti dei limiti del sistema telegrafico. Infatti,
a differenza del predecessore, il telefono era basato sulla trasmissione della voce e quindi
non era limitato ai soli documenti scritti. Inoltre, mentre il telegrafo richiedeva una
qualche competenza tecnica e la capacità di decifrare l’alfabeto Morse, il telefono poteva
fare a meno sia dell’una che dell’altra. Agli inizi del sec. XX, grazie alla diminuzione dei
costi, il telefono era presente anche nelle case dei meno ricchi. L’installazione dei
centralini lo rese più competitivo rispetto al telegrafo, così dal 1880 in poi questi sistemi
di scambio si diffusero rapidamente. Già dieci anni dopo era enormemente cresciuta non
solo l’utenza dei professionisti, ma anche quella privata.
Alla fine del sec. XIX, grazie alla diffusione del telegrafo e del telefono, i
messaggi venivano distribuiti molto più velocemente, più facilmente e più lontano di
quanto non fosse possibile nel passato. L’informazione ne risultò avvantaggiata, così
come cominciarono a cambiare anche i lettori e il modo di leggere. D’altro canto la
transizione da un’economia agricola a una di tipo industriale aveva favorito
l’urbanizzazione e quindi la nascita della ‘società di massa’.
Negli stessi anni in cui Morse andava trasformando radicalmente il modo di
trasmettere informazioni, L. Daguerre, in Francia, a sua volta andava trasformando
radicalmente il modo di rappresentare la realtà.137 L’invenzione della fotografia (1839)
con i suoi sviluppi successivi aveva già favorito una nuova conoscenza di popoli, luoghi
e cose lontani, mentre la sua percezione pubblica come medium di massa cominciò a
diffondersi soltanto verso la fine del sec. XIX, quando la tecnica della ‘lastra a
mezzatinta’ rese possibile riprodurre le foto sui libri, i giornali e le riviste.
Nei primi decenni del sec. XX il fotogiornalismo godeva ormai di una grandissima fama.
La natura stessa del giornalismo ne risultò modificata. Furono introdotti nuovi formati,
136 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 162- 163
137 Id., p. 164
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
65
divenuti bagaglio comune del giornalismo contemporaneo. 138 Il perfezionamento di
questa tecnica ha influenzato grandemente il nostro modo di percepire la realtà.
Innanzitutto perché “lo sguardo della macchina […] si organizza in funzione del punto
di vista, dell’angolazione, dell’inclinazione, compromettendo il rapporto immediato di
chi osserva con l’oggetto della sua osservazione”139, facendoci assumere uno sguardo
filtrato della realtà, guidato dall’occhio di colui che ha fatto la foto. Inoltre, catturando gli
istanti di un flusso temporale, permette la riproduzione della realtà in modo frammentato.
McLuhan indica la fotografia come una sorta di “museo senza pareti”, perché consente di
visitare qualsiasi luogo, senza spostarsi dalla propria abitazione.
È in questo periodo che potremmo identificare l’inizio del mondo come immagine, perché
per la prima volta nella storia dell’uomo dopo l’invenzione della parola, l’uomo
sostituisce il messaggio con l’immagine.
La naturale evoluzione della fotografia è il cinema, nato il 28 dicembre del 1895,
quando i fratelli Lumière proiettano il loro primo documentario a Parigi.
Inizialmente gli spettatori erano semplicemente attirati dalla possibilità di vedere il
movimento su uno schermo. Successivamente il cinema acquisì l’importante funzione di
documentare la realtà, salvaguardando, attraverso le immagini, momenti che sennò
sarebbero finiti nell’oblio.
In seguito, grazie all’apporto di Meliès, teatrante di professione, il cinema acquisisce
un’altra funzione: quella di realizzare il mondo immaginario che risiede nella mente
dell’uomo. Grazie a questa evoluzione, le rappresentazioni cinematografiche non si
limitarono a raccontare la realtà, ma anzi ne crearono di diverse, realtà altre che suscitava
nello spettatore delle emozioni tali da potergli far sembrare la storia riprodotta la sua
storia, il personaggio rappresentato come se stesso.140
2.3.2.2. Dalla radio alla televisione
Negli anni Venti le trasmissioni radiofoniche accelerarono la transizione verso la
‘società di massa’. Già prima della fine del sec. XIX, Guglielmo Marconi era riuscito a
trasmettere dei messaggi in codice Morse senza l’uso di cavi. Subito dopo la prima guerra
138 T. PURAYIDATHIL, in F. LEVER - P.C. RIVOLTELLA – A. ZANACCHI (Edd.), voce Storia della comunicazione, op. cit.,
Fonte: http://www.lacomunicazione.it/voce.asp?id=1199
139 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., p. 164
140 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 165- 168
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
66
mondiale operavano negli USA diverse stazioni amatoriali che immediatamente
attirarono l’attenzione della gente, entusiasta all’idea di poter ascoltare musica e voci
attraverso apparecchi di poco costo. Nacquero nei primi anni Venti le prime grandi
emittenti radiofoniche che offrivano programmi regolari, il cui ascolto divenne presto un
hobby e una fonte di divertimento per molti. Alla fine del decennio, nonostante la Grande
Depressione, molte famiglie possedevano un apparecchio radiofonico. La radio cominciò
così a diventare un medium di massa.
L’uso della comunicazione senza fili aveva cominciato a diffondersi anche prima
della prima guerra mondiale e molti avevano potuto sperimentare la novità di una
tecnologia che permetteva la comunicazione a distanza in tempo reale. Negli anni Trenta
si creò un grande interesse attorno ai drammi, alle commedie, ai concerti e agli eventi
sportivi trasmessi attraverso la radio. In confronto ai giornali, la radio dava agli ascoltatori
una maggiore sensazione di immediatezza e di partecipazione diretta agli eventi del
mondo. Le famose ‘conversazioni accanto al caminetto’ del presidente Franklin D.
Roosevelt, trasmesse per radio, si rivelarono subito un modo molto efficace di comunicare
direttamente con il popolo americano. 141
L’avvento della comunicazione radiofonica ha permesso di rispondere a tre fondamentali
esigenze dell’uomo di quell’epoca: l’esigenza ludica, di poter avere un passatempo
piacevole, l’esigenza informativa, grazie alla possibilità di poter conoscere in tempo reale
informazioni importanti, e di partecipazione, grazie alla possibilità di poter interagire con
le trasmissioni radiofoniche attraverso il telefono.142
Con l’avvento della televisione, il primato della radio come medium di massa fu
seriamente messo in discussione. La prima trasmissione televisiva commerciale ebbe
luogo in Nord America nel 1939, ma è solo dopo la seconda guerra mondiale che la
televisione comincia ad affermarsi come medium di massa. Gli anni Cinquanta sono gli
anni della grande espansione del nuovo medium. I programmi inizialmente erano tratti
dalla radio e dal cinema, ma presto nacquero le prime trasmissioni di commedie e film di
avventura girate esclusivamente per la televisione.
141 T. PURAYIDATHIL, http://www.lacomunicazione.it/voce.asp?id=1199
142 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 169- 170
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
67
La vita familiare rimaneva ancora saldamente ancorata alla casa, specialmente la sera e
nei fine settimana, quando la televisione portava i suoi programmi di intrattenimento
direttamente nelle case degli americani.143
Lungo gli anni ’70, la nascita delle televisioni private (a partire dal 1972) e
l’avvento del colore (le trasmissioni ufficiali della RAI iniziano l’1 febbraio 1977)
trasformano la televisione in fenomeno di grande consumo, iniziando a produrre cultura
di massa anche in senso basso, quello che fa dire a Pasolini che “mai un “modello di vita”
ha potuto essere propagandato con tanta efficacia che attraverso la televisione. Il tipo di
uomo o di donna che conta, che è moderno, che è da imitare e da realizzare, non è
descritto o decantato: è rappresentato! […] Appunto perché perfettamente pragmatica,
la propaganda televisiva […] è enormemente efficace”.144
2.3.3. Il computer e l’era di Internet: nuovi prodotti mediali
L’innovazione tecnologica degli ultimi decenni ha dato luogo ad una straordinaria
rivoluzione. Negli anni, accanto ai mass media si sono sviluppate altre «famiglie»
mediali: i self media (registratore, videoregistratore), i media interpersonali (telefono,
fax), i personal media (computer) e infine i telemedia (trasmissione telematica,
telecomunicazioni).145
Con gli anni ’80 la storia delle tecnologie comunicative vive una drastica rottura
con il passato, grazie all’introduzione di innovazioni tecniche capaci di trasformare
l’intero sistema dei media. La digitalizzazione dei segnali è l’innovazione più importante
e consiste nella sostituzione della codifica analogica del segnale, con la nuova codifica
numerica. I vantaggi di questa invenzione sono molteplici, come ad esempio, la
possibilità di far passare su una stessa linea multimediale segnali diversi (telefonici,
televisivi, ecc.).
Ma la vera protagonista delle telecomunicazioni dell’ultimo ventennio è
l’informatica, scienza che si occupa di studiare tutto ciò che implica la riduzione di un
segnale, di un messaggio, in forma numerica. È molto importante grazie al suo ruolo
metamediale che essa esercita a diversi livelli: per la sua capacità di contaminare altri
mezzi (robotica), per le sue potenzialità tecnologiche e conoscitive e per la funzione di
143 T. PURAYIDATHIL, http://www.lacomunicazione.it/voce.asp?id=1199
144 P.P. PASOLINI, Scritti corsari, Garzanti, Milano, 1990, p. 59.
145 Cfr A. CALVANI, op. cit., p. 23
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
68
facilitatore comunicativo, favorita dalla proporzionalità inversa esistente tra la
complessità di programmazione e la facilità di utilizzo.146
Lo strumento che ha dato l’avvio alla nascita dei nuovi media è stato il computer.
Nato come uno strumento in grado di eseguire calcoli complessi e/o ripetitivi, il computer
si è prima trasformato in una macchina da scrivere avanzata per poi diventare - grazie ad
Internet - uno strumento di comunicazione potentissimo. La separazione tra hardware e
software resa possibile dalla digitalizzazione ha avuto un ruolo chiave nel permettere
l’evoluzione del computer come medium, in quanto consente di far evolvere l’esperienza
comunicativa semplicemente migliorando le caratteristiche del software.
Possiamo identificare tre fasi nello sviluppo del computer come medium. Esse
sono strettamente legate a quello di Internet, che ha permesso a ciascuna di possedere una
particolare interfaccia in grado di offrire nuove opportunità agli utenti.
La prima è quella Comunicazione Testuale (interfaccia testuale) che ha permesso
la comunicazione a distanza e la creazione di comunità virtuali svincolate da limiti spazio-
temporali. La seconda è quella della Comunicazione Multimediale (interfaccia Web) che
ha permesso l'accesso ad informazioni specifiche e multimediali all'interno di grandi
quantità di dati. Infine troviamo l'Espressione Multimediale (interfaccia Web 2.0) che ha
permesso agli utenti di esprimersi/creare contenuti da condividere all'interno di una
comunità virtuale. Il Web 2.0 consente anche di dare forma compiuta al concetto di
comunità virtuale introdotto dai media testuali attraverso i «social network»: una
piattaforma basata sul Web 2.0 che consente all’utente di gestire sia la propria rete sociale
(organizzazione, estensione, esplorazione e confronto), sia la propria identità sociale
(descrizione e definizione).147
2.3.3.1. Comunicazione testuale
La prima fase, della comunicazione testuale, è caratterizzata dallo sviluppo di
interfacce basate sul testo. I media testuali possono essere distinti in base alla
compresenza temporale dei soggetti che comunicano attraverso di essi.
Distingueremo, quindi, strumenti asincroni (posta elettronica e newsgroup) e quelli
sincroni (chat e MUD). La posta elettronica, o mail, ha un funzionamento molto semplice:
il soggetto emittente invia un messaggio- inizialmente solo testuale, ora può comprendere
146 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 174- 177
147 Cfr. G. RIVA, I social network, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 53- 54
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
69
anche immagini, links e altri files- a un dato indirizzo che corrisponde alla casella
elettronica del soggetto ricevente. Quando il messaggio arriva, il soggetto può aprirlo,
leggerlo e rispondere. I vantaggi della mail sono molteplici: consente di comunicare in
modo poco costoso e veloce, indipendentemente dalla locazione fisica del ricevente.
Accanto alle opportunità offerte, si inseriscono alcuni limiti: non garantisce il ricevimento
del messaggio, non è possibile fornire elementi meta comunicativi e consente un limitato
controllo sul tipo di messaggi ricevuti.
I newsgroup sono una variante della posta elettronica: una sorta di bacheca
elettronica che contiene una serie di messaggi chiamati «articoli» (news), inviati da
diversi utenti in relazione ad un argomento specifico. Essi offrono la possibilità di
ottenere rapidamente informazioni su un dato argomento, senza richiedere l’iscrizione.
Sono il primo “luogo elettronico” in cui su possono incontrare persone sconosciute.
L’evoluzione dei newsgroup saranno le comunità virtuali, in cui sarà possibile porre in
essere un tipo di comunicazione non più bidirezionale, ma multidirezionale.
Per quanto riguarda gli strumenti sincroni, il più importante è sicuramente la chat.
Con essa viene eliminato anche il limite temporale: la comunicazione avviene in tempo
reale. Inoltre viene garantito l’anonimato, attraverso l’utilizzo di un nickname, e
l’esclusività, cioè la possibilità di scegliere se parlare con tutti o soltanto con una persona.
I due principali svantaggi della chat sono che: non si possono avere informazioni dirette
sugli altri utenti e la comunicazione, attraverso la sincronia, viene maggiormente
rarefatta.
Altro social media sincrono è il MUD (Multi User Dimension) che permette ai
diversi utenti l’accesso ad un ambiente condiviso, formato da stanze, uscite e altri oggetti,
in cui i partecipanti possono parlare tra loro e anche visitare gli ambienti in cui si trovano
e interagire con gli oggetti. La principale opportunità offerta da MUD è quella di poter
sperimentare una nuova identità all’interno di un contesto regolato.148
2.3.3.2. Comunicazione Multimediale
La seconda fase è denominata della Comunicazione Multimediale e si distingue
nettamente dalla prima. Infatti, mentre la comunicazione testuale realizza un tipo di
comunicazione scevra della ricchezza della comunicazione faccia a faccia, attraverso
148 Id., pp. 55- 62
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
70
quella multimediale, e l’introduzione del World Wide Web, si cerca di superare questo
limite. Di certo, grazie all’introduzione del Web e della sua nuova interfaccia, è possibile
aumentare la velocità di connessione a Internet, migliorando così le capacità mediali del
computer. Esso, inoltre, diventa un medium di massa, perché permette la fruizione dei
suoi strumenti ad una fascia sempre più larga di utenti.
Per creare un’interfaccia grafica in grado di far esplorare in maniera ipermediale
i contenuti dei server che formano la rete, vengono introdotti due componenti: l’Html e il
Browser.
Il primo è un linguaggio di programmazione (Hyper Text Mark- Up Language) che è in
grado di presentare gli oggetti di un server all’interno di una pagina bidimensionale,
consentendo l’interazione con essi e con le pagine esistenti.
Il Browser, invece, è un programma che consente di interpretare il codice Html
consentendo la visualizzazione e l’interazione con gli oggetti. La nuova interfaccia,
inoltre, ha portato anche ad un miglioramento degli strumenti testuali di comunicazione
interpersonale e all’introduzione di nuovi strumenti mediali per agevolare l’accesso e
l’utilizzo di Internet.
Il primo di tali strumenti è il portale (letteralmente portal site), un insieme di siti
che hanno come obiettivo quello di essere un punto privilegiato di accesso al Web,
svolgendo funzioni di: ricerca, informazione, mediazione commerciale e comunità
virtuali.
Un altro strumento sono i siti di ricerca, la cui evoluzione sono i motori di ricerca,
che sono nati per categorizzare l’informazione in maniera automatica, per facilitare la
ricerca. Il primo motore di ricerca è stato Yahoo, nato nel 1994 con Galaxy,
successivamente soppiantato dall’attuale motore di ricerca più conosciuto e diffuso:
Google. Ad incrementare la lista di servizi offerti agli utenti del web, si aggiungono la
webmail, la webchat e la messaggistica istantanea. Le webmail sono delle applicazioni
che consentono di gestire una casella di posta direttamente dal Browser. Le webchat e
chat ipermediali, sono chat in cui è presente, oltre al nickname, anche l’avatar,
personaggio grafico stilizzato che può muoversi, compiere azioni ed esprimere stati
d’animo. Inoltre le chat testuali si evolvono in audio e video chat in cui il testo viene
integrato o sostituito dalla comunicazione vocale o da un collegamento video,
consentendo un grande vantaggio dal punto di vista della comunicazione. In questo modo
si cerca di ridurre la rarefazione della comunicazione. Il risultato dell’integrazione tra le
chat e la posta elettronica è l’instant messaging, che permette la conversazione sincrona,
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
71
testuale e\o vocale, tra più utenti contemporaneamente collegati a Internet, inclusi in una
lista di persone predefinite.149
Si viene così a creare un nuovo ambiente virtuale: il cyberspazio. Esso è uno
spazio virtuale risultante dall’interconnessione mondiale dei computer e delle memorie
informatiche, all’interno del quale si producono eventi di diversa natura: intrattenimento,
divertimento, transazioni economiche, apprendimento, studio arte ecc. 150
2.3.3.3. Espressione Multimediale del Web 2.0 e new
media
L’ultima fase, quella attuale, è dell’Espressione Multimediale del Web 2.0.
Mentre con il Web gli utenti non sono in grado di influenzare le caratteristiche e i
contenuti dei messaggi trasmessi, con il Web 2.0 ciò diventa possibile, grazie
all’introduzione di applicazioni innovative che offrono la possibilità di creare e
condividere con facilità contenuti multimediali.
A livello psico- sociale il Web 2.0 è caratterizzato da:
Facilità d’uso, in quanto le applicazione condividono la stessa impostazione
grafica e l’approccio a oggetti.
Dimensione espressiva: l’utente può esprimersi e generare nuovi contenuti.
Dimensione comunicativa: ogni nuovo contenuto è accessibile immediatamente
all’intera comunità di Internet.
Dimensione comunitaria: la versione finale dei contenuti è il risultato
dell’interazione tra una comunità di utenti.
Questa nuova interfaccia permette agli utenti di creare e condividere propri contenuti (siti
espressivi), di lavorare con altri utenti per raggiungere un obiettivo comune (siti
collaborativi) e di presentarsi e\o identificare utenti significativi con cui iniziare una
relazione, personale o lavorativa (siti relazionali).
Le innovazioni introdotte in questa ultima fase di sviluppo tecnologico sono
molteplici. Iniziamo con il Blog, che permette agli utenti di creare contenuti, senza alcuna
conoscenza specifica, senza richiedere agli utilizzatori il possesso di un dominio Internet,
gestendo il trasferimento dei contenuti su Internet in maniera automatica e trasparente.
149 Cfr. Id, pp. 62- 69
150 P. LEVY, La Cybercultura, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 40
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
72
Oltre al blog, troviamo i wiki, un sito o un blog in cui i contenuti sono sviluppati
e modificati in collaborazione, da tutti coloro che ne hanno accesso -un esempio è
Wikipedia, l’Enciclopedia libera- e i servizi di condivisione di contenuti multimediali,
come video (video sharing, ad esempio Youtube) e immagini (photo sharing).
Infine, innovazione resa possibile dall’evoluzione dei blog, troviamo i social
network. Essi, visibili agli utenti solo da alcuni anni, hanno una storia ben più lunga, circa
vent’anni, ed è passata attraverso tre fasi di sviluppo. La prima, quella delle origini, è
caratterizzata dalla possibilità di creare reti sociali chiuse, come nel caso di Sixdegrees
(1997), sito che permetteva di realizzare incontri online. Nella seconda fase, quella della
maturazione, vi è il passaggio dalla rete chiusa a quella aperta. Nati in questa fase sono i
social network Ryze.com (2001), primo “luogo” d’incontro commerciale e professionale,
e Friendster (2002), evoluzione di Sixdegrees. Infine, nella terza fase, quella espressiva,
i social network diventano vere e proprie applicazioni Web 2.0 in cui è possibile gestire
tutti gli aspetti della propria esperienza sociale. È in questa fase che nascono i social
network più conosciuti e usati oggi: Myspace (2003), Facebook (2004) e Twitter
(2006).151
A seguito di questo breve excursus possiamo notare come l’evoluzione del
panorama comunicativo nell’ultimo decennio sia stata contrassegnata dall’integrazione
tra media tradizionali e nuove forme di comunicazione mediate dalle tecnologie
informatiche e telematiche. Questa ha permesso la nascita di una “generazione 2.0” dei
mass media: i new media. Essi sono caratterizzati da tendenze molto evidenti che vedono
una sempre maggiore personalizzazione dei flussi comunicativi, un sempre più articolato
coinvolgimento del destinatario e una apparente scomparsa delle mediazioni tradizionali.
2.4. Principali media ed effetti sull’uomo moderno
L’evoluzione dei media nella società contemporanea ha seguito alcune tendenze
dominanti: lo sviluppo di un’industria dei media, la digitalizzazione (trasferimento dal
sistema analogico a quello digitale), la pervasività, l’integratività (trasferibilità di funzioni
in sistemi integrati) e la miniaturizzazione sono tra le più evidenti.152
Quale dev’essere l’atteggiamento di uno studioso, o di un appassionato della
materia, di fronte a tali mezzi?
151Cfr. G. RIVA, op. cit., pp. 70- 85
152 Cfr A. CALVANI, op. cit., pp.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
73
“Negli ultimi vent’anni, si è diffusa e legittimata nei media studies una visione
accomodante, e talora addirittura euforica, delle conseguenze sociali della
comunicazione. Ma è altrettanto innegabile che il processo di «beatificazione» della
comunicazione si misura oggi con evidenze empiriche, «fratture della coscienza» e
momenti di radicale ripensamento, che inducono a riconsiderare il modo in cui la
comunicazione forgia le parole, i sentimenti e i valori del clima culturale dominante.”153
Di fronte ai mutamenti generati dall’uso di questi nuovi strumenti, vi sono due
atteggiamenti contrapposti. Troviamo gli “apocalittici” e gli “integrati” che Neil Postman
definisce “profeti da un occhio solo”154 perché considerano i progressi tecnologici o solo
dannosi, oppure solo portatori di benefici.155
Tra gli apocalittici troviamo Giovanni Sartori che nel suo libro “Homo videns” fa
un’attenta esamina di tutte le conseguenze negative che hanno accompagnato la
diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare della televisione. In un
passo del suo libro afferma: “L’andazzo è di riempire le aule di televisori e di word
processors. Dovremmo, invece, vietarli (lasciandoli soltanto all’addestramento tecnico,
come si farebbe con un corso di dattilografia). A scuola i poveri bambini debbono essere
«divertiti». Così non si insegna nemmeno a scrivere, e il leggere è quanto più possibile
emarginato.”156
Egli da una parte afferma che “le potenzialità di Internet sono pressoché infinite, e tanto
nel male come nel bene”157, dall’altra, però, sceglie di “chiudere un occhio” sulle seconde,
auspicando, per il bene dell’umanità, un arresto alla situazione attuale, se non addirittura
un ritorno al passato: “a rischio di non esistere, io scelgo di resistere”.158
Sfugge, però, alla valutazione di Sartori e di tutti gli apocalittici che i mezzi di
comunicazione non si auto-creano né sono autonomi nel loro utilizzo, ma sono piuttosto
il prodotto della mente dell’uomo e del suo modo di impiegarli: è lui che ne decreta un
buon o un cattivo utilizzo.
153 M. MORCELLINI, Comunicazione e Media, Egea, Milano, 2013, p. 13
154 N. POSTMAN, Technopoly, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 12
155 Cfr. M. CALIGIURI, Comunicazione pubblica, formazione e democrazia, Rubbettino, Soveria Mannelli,
2005, p. 22
156 G. SARTORI, op. cit., p. 116
157 Id., p. 32
158 Id., p. 153
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
74
Inoltre bisognerebbe considerare che a questo punto è troppo tardi per desiderare
una totale eliminazione di questi mezzi. Questo per un semplice dato ormai assunto dalla
comunità scientifica: “l’intelligenza è mediata dal medium”159. La nostra intelligenza,
oggi, è ormai forgiata dai e sui nuovi mezzi di comunicazione. Eliminarli, quindi, non
gioverebbe a nessuno.
Presa consapevolezza di ciò, diviene necessario promuovere l’utilizzo del medium
tecnologico a favore di un completo sviluppo del potenziale umano. Tale potenziamento
non può essere avulso da un approccio ai media non passivo, ma attivo, che punti alla
creazione di un pensiero creativo e critico. “La scuola, le famiglie, i media, le istituzioni
devono informare e formare illustrando sia le grandi opportunità dei nuovi mezzi, sia i
limiti e i pericoli. Con la tranquilla consapevolezza che le prime sono molto superiori ai
secondi”.160
Per questo neanche l’atteggiamento di chi vede in questi nuovi mezzi solo dei
vantaggi è da condividere. L’entusiasmo che accompagna ogni nuova invenzione
tecnologica deve essere sempre associato ad una riflessione sulla reale valenza di tale
innovazione e, soprattutto, sul modo in cui il suo utilizzo può comportare un effettivo
miglioramento nella vita dell’uomo.
I media non sono moralmente neutrali e non sono nemmeno meri strumenti nelle
mani dell’uomo.
L’uomo, com’è noto, si costituisce grazie all’integrazione tra natura e cultura. Grazie a
queste componenti modifica se stesso, cambia. Ma, se nella sua cultura sono presenti i
media, che tipo di uomo questi contribuiranno a creare? Essi, infatti, hanno un potere
antropogenetico, possono, cioè, generare un nuovo essere umano. Presa considerazione
di ciò, ci dobbiamo chiedere, non “cosa possiamo fare noi con la tecnica”, bensì “cosa
può fare la tecnica con noi”.161
“Assistiamo […] al costante rivoltarsi del «nuovo modello di sviluppo» contro la
persona. Spesso non è l’uomo a sfruttare la macchina ma è quest’ultima ad imprimere al
primo un certo ritmo di produzione e di vita.”162 Ciò è la conseguenza di un utilizzo non
consapevole dei mezzi di comunicazione, generato dall’entusiasmo cieco suscitato dalla
159 Cfr. F. BELLINO, op. cit., p. 16
160 J.C. DE MARTIN, Ma twitter non è un bar, in “La Stampa”, 11\05\2011
161 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, p. 7-8
162 L. PATI, op. cit., p. 16
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
75
novità. Tale situazione comporta che “invece di giovare all’incontro interpersonale, alla
«liberazione» dell’uomo, conduce ad una svalutazione di tutto ciò che è umano.
L’individuo è trattato come cosa tra le cose; la priorità spetta alla macchina”163
L’atteggiamento che si è scelto di perseguire in questo lavoro di tesi è quello di
vedere con occhi disincantati ciò che i mezzi di comunicazione comportano nella vita
dell’uomo e al tempo stesso cercare dei punti di sviluppo che permettano di cambiare la
situazione in meglio. “La scelta alla quale siamo moralmente chiamati, insomma, è non
solo quella fra “bene” e “male”, anche in ambito comunicativo, ma, più radicalmente,
quella fra “essere” e “nulla”. […] Scegliere l’essere piuttosto che il nulla significa fare
in modo che i nostri gesti, i nostri atti, i nostri comportamenti, i nostri pensieri risultino
davvero permeati di senso. Solo in relazione a questa scelta lo possono essere. Si tratta
di un atto etico. Infatti etica è rapportarsi al senso di ciò che può avere senso.”164
Nei successivi paragrafi, mi limiterò a sottolineare i più importanti effetti che alcuni
dei mezzi mediali comportano nella vita dell’uomo, prevedendo uno spazio maggiore,
negli ultimi due capitoli di questo lavoro, all’individuazione di strategie utili a permettere
un uso positivo e morale dei mezzi di comunicazione.
2.4.1. Televisione
“La televisione non è soltanto strumento di comunicazione; è anche, al tempo
stesso, paideia, uno strumento «antropogenetico», un medium che genera un nuovo
ànthropos, un nuovo tipo di essere umano”165. Sartori identifica nell’homo videns l’
“uomo nuovo” generato dalla televisione: “[…] il video sta trasformando l’homo sapiens,
prodotto dalla cultura scritta, in un homo videns nel quale la parola è spodestata
dall’immagine.”166
L’homo sapiens deve il suo sapere e la capacità di progredire, alla sua capacità di
astrazione. Essa permette di trasformare i simboli del linguaggio umano, in
«rappresentazioni» che richiamano alla mente raffigurazioni di cose visibili, o che
abbiamo visto, parole concrete, che rientrano a far parte del mondus sensibilis, cioè del
mondo percepito dai nostri sensi. Ci sono, però, molti altri concetti intangibili, parole
163 Ibid.
164 A. FABRIS, op. cit., p. 133
165 G. SARTORI, op. cit., p. 14
166 Id., Prefazione
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
76
astratte, che non possono essere comprese dai nostri sensi e che rientrano a far parte del
mondus intelligibilis, un mondo fatto di concetti puramente mentali. È in questo campo
che opera la televisione, producendo immagini, cancellando i concetti e atrofizzando la
nostra capacità astraente e quindi anche quella di capire. In questo modo nasce un nuovo
tipo di uomo, l’homo videns, nel quale il linguaggio concettuale (astratto) è sostituito dal
linguaggio percettivo (concreto), infinitamente più povero di senso.167 Mentre la parola è
un simbolo, che rimanda ad un significato, che viene compreso solo se si conosce la lingua
a cui appartiene, l’immagine è pura e semplice rappresentazione visiva. Essa non richiede
nessuna competenza specifica: si vede e basta. La televisione, in particolare, opera una
sorta di sostituzione del rapporto tra capire e vedere.
Sino a ieri il mondo ci veniva raccontato, oggi, invece, ci viene mostrato. In questo modo,
la televisione, sta creando un nuovo tipo di uomo.168
I multimedialisti, così definiti da Sartori i promotori del pensiero mediato,
sostengono che la perdita della cultura scritta sia compensata dall’acquisizione di una
cultura audio- visiva. Ma non è così. Come osserva Ferrarotti, infatti, “la lettura richiede
solitudine, concentrazione sulla pagina, capacità di apprezzare la chiarezza e la
distinzione”169, mentre l’homo sentiens, equivalente dell’homo videns sartoriano, esibisce
caratteristiche del tutto opposte. “La lettura lo stanca […] Intuisce. Preferisce il
significato contratto e fulmineo dell’immagine sintetica. Ne è affascinato e sedotto.
Rinuncia al vincolo logico, alla sequenza ragionata, alla riflessione che necessariamente
implica il ritorno su di sé. […] Sceglie per sé il living on self- demand, quel modo di vita
che è tipico dell’infante che mangia quando gli va, piange se avverte sconforto, dorme,
si sveglia, soddisfa i suoi bisogni a caso”170
A queste conseguenze “antropologiche” dell’utilizzo della televisione, si aggiungono
quelle cognitive:171
Desensibilizzazione, in quanto osservare scene violente alimenta una reazione più
indifferente se in seguito si assiste alla stessa scena, o ad una ugualmente violenta,
dal vivo.
167 Cfr Id, pp. 21- 23
168 Id., pp. 13- 14
169 F. FERRAROTTI, La perfezione del nulla. Premesse e problemi della rivoluzione digitale, Laterza, Roma-
Bari, 1997, p. 94
170 Id., p. 95
171 Cfr D. MYERS, Psicologia sociale, Mc Graw- Hill, Milano, 2009, pp. 381- 382
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
77
Attivazione di script sociali, ossia una serie di sequenze mentali fornite dalla
cultura di appartenenza che suggeriscono come comportarsi quando ci si trova in
una situazione nuova. Dopo la visione di film o programmi a contenuto violento,
trovandosi nelle medesime situazioni, i ragazzi, non sapendo come comportarsi,
potrebbero attingere agli script derivanti da tali programmi, ponendo in essere
atteggiamenti aggressivi e pericolosi.
Alterazione delle percezioni. Le indagini condotte sia su adolescenti sia su
soggetti adulti mostrarono che coloro che guardavano la televisione per molte ore
al giorno (4 o più ore) erano più propensi a temere di essere aggrediti
personalmente rispetto a chi guardava per poche ore la TV (2 o meno ore).
Un’indagine svolta in America tra bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni
rivelò che coloro che guardavano per più tempo la televisione ammettevano di
aver spesso paura che qualcuno potesse entrare in casa o di venire aggrediti una
volta usciti, rispetto a coloro che la guardavano saltuariamente o per meno tempo.
Riattivazione di schemi cognitivi (priming). Guardare video con contenuti violenti
sollecita sistemi di idee collegate alla violenza.
Bisogna, però, vedere anche l’altra faccia della medaglia. Infatti, partendo dalla
consapevolezza dell’enorme potere che ha la televisione sulla mente dei suoi utenti,
dobbiamo riscontrare che gli stessi mezzi utilizzati in modo negativo dalla televisione,
potrebbero suscitare effetti opposti semplicemente cambiando i contenuti proposti. In
particolare, programmi di buon livello, adatti all’età dei bambini e ai loro interessi
possono offrire, come rileva Morcellini172, servizi utili e costruttivi:
o Comunicare informazioni: la televisione, infatti, è un mezzo molto efficace
per insegnare ciò che accade nel mondo, gli usi e i costumi dei popoli, nozioni
che possono essere comprese più rapidamente attraverso un filmato ben fatto
che leggendo le pagine di un libro.
o Parlare dei sentimenti: programmi che affrontano determinati argomenti
possono aiutare i bambini a capire meglio i loro sentimenti; programmi che
promuovono valori sociali come l’amicizia, la compassione e la generosità
possono favorire lo sviluppo morale del bambino ed indurre genitori e figli a
riflettere insieme su argomenti significativi.
172 M. MORCELLINI, La TV fa bene ai bambini, Meltremi, Roma, 1999
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
78
o Insegnare a risolvere i problemi: guardando programmi in cui i protagonisti
(specie se hanno la stessa età degli spettatori) devono cimentarsi con
situazioni complesse e fare delle scelte, i bambini imparano a considerare la
realtà nei suoi molteplici aspetti e a cercare soluzioni congrue ed originali.
o Proporre dei modelli: gli eroi e le eroine dei programmi per bambini possono
fornire modelli ideali a cui ispirarsi, in quanto, nella maggior parte dei casi,
si tratta di personaggi buoni, forti e generosi; in particolare, i programmi che
non stereotipizzano uomini e donne aiutano i bambini a capire meglio le loro
potenzialità e ciò che potrebbero diventare in futuro.
2.4.2. Internet e new media
Sebbene la televisione sia rimasta uno dei mezzi di comunicazione di massa più
diffusi nel mondo, il suo ruolo ha cominciato a perdere autorità dal momento in cui i
computer e i telefonini si sono imposti come mezzi “che uniscono tutti i mezzi”. “Infatti
siamo passati, o stiamo passando, a una età multimediale nella quale, come dice la
parola, i media sono molti e la televisione non è più la regina di questa multimedialità.
Il nuovo sovrano è, invece, il computer. Perché il computer (e con esso la digitalizzazione
di tutti i media) non solo unifica parola, suono, immagini, ma introduce nei «visibili»
realtà simulate, realtà virtuali”173
Il computer, e oggi maggiormente gli smartphone e i tablet, non solo sostituiscono
la funzione intrattenitiva della televisione (i bambini che in passato avevano la televisione
come babysitter, ora hanno telefonini touch e tablet) ma anche il suo contenuto.
Grazie, infatti, alla diffusione della banda larga e all’avanzamento tecnologico di software
e applicazioni, ormai è possibile guardare film, serie tv, telegiornali e quant’altro, facendo
un semplice click.
Come abbiamo già visto precedentemente, oggi non si parla più di mass media,
ma di new media. Con questo termine designiamo tutti i nuovi strumenti e prodotti
mediali: dal telefonino, a Internet con le sue applicazioni, dai videogiochi ai tablet e
smartphone che più di altri abitano le pratiche attuali.
Il telefono cellulare rappresenta uno strumento di comunicazione e
socializzazione ormai talmente diffuso, anche tra i pre-adolescenti, da poter essere
173 G. SARTORI, op. cit., p. 12
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
79
effettivamente considerato come un naturale prolungamento delle vite individuali e
sociali dei soggetti.
Secondo un’indagine su un campione di 1373 ragazzi, compiuta dal Cremit174
(Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia) sui
consumi mediali di giovani d’età compresa tra gli 11 e i 14 anni, emerge che: il 43,26%
dei rispondenti dichiara di usare il cellulare da 1 a 3 anni, il 37,14% da 4 o più anni, solo
il 14,93% da meno di un anno e bassissime sono le percentuali di non utilizzatori: il
3,28%.
Anche il telefono cellulare, come il computer, ha subito negli anni un’evoluzione
che lo ha portato dall’essere un semplice strumento per effettuare o ricevere chiamate e
messaggi, a diventare una sorta di computer in miniatura, una porta d’accesso per entrare
nel Cyberspazio, grazie ad Internet e alla sua applicazioni. Il cellulare e la Rete
funzionano oggi come connettori sociali, servono per sentire gli amici, rimanere sempre
in contatto e condividere emozioni.
Un altro strumento ormai diventato di grande utilizzo nel mondo attuale è il tablet.
Lo potremmo considerare una sorta di miniaturizzazione del computer che, sebbene non
abbia tutte le caratteristiche del calcolatore, permette di compiere molte azioni tra cui:
leggere e-book (mutazione digitale del libro cartaceo), fare video e fotografie ad una
risoluzione più che soddisfacente, prendere appunti, consultare le mail, ecc.
Di certo la grande diffusione e importanza che hanno assunto nel tempo cellulari
e tablet non sarebbe stata la stessa se non fosse stata accompagnata dalla graduale
pervasività di Internet e delle sue applicazioni. La maggior parte dei fruitori di Internet
hanno la possibilità di accedervi proprio da questi mezzi, come rilevato dalle indagini
Audiweb175 relative all’anno 2013 (Figura 4).
174 P.C. RIVOLTELLA, A. CARENZIO (a cura di), Ragazzi connessi. I preadolescenti italiani e i nuovi media,
dossier CREMIT, 2008, pp. 3-4
175 AUDIWEB, Ricerca di Base sulla diffusione dell'online in Italia, dicembre 2013, p. 2
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
80
FIGURA 4- ACCESSO AD INTERNET DA CELLULARI E TABLET
Vi sono alcune peculiarità specifiche che ne giustificano, almeno in parte, la rapidissima
diffusione e il ruolo che esso oggi assume nella vita di molte persone, in particolare dei
più giovani176:
Interattività. Internet implica interazione, soprattutto con l’avvento del Web 2.0,
l’utente non è più fruitore passivo della rete ma attivo e reattivo produttore a sua
volta di contenuti. Al tempo stesso, la possibilità di essere “sempre e comunque
connessi” è garantita dal cellulare, che consente di “navigare”, ricevere contenuti
dal web e assicurare la propria reperibilità.
Assenza di confini spazio-temporali. Internet consente, proprio in virtù della sua
rapidità, del suo annullare le distanze, del suo anonimato, di sperimentare una
condizione virtuale di onnipotenza, legata al superamento dei normali vincoli
spaziotemporali e, soprattutto, alla possibilità di esplorare differenti aspetti della
propria personalità. La comunicazione mediata dal computer promuove
un’apertura più spontanea della conversazione faccia a faccia.
Forte dimensione affettiva. Il fatto di non vedersi e di non sentirsi direttamente, o
di non entrare in contatto visivo, abbassa timidezze e inibizioni, per cui spesso
nella comunicazione in rete si raggiungono elevati livelli di confidenza e intimità
e a volte, di seduttività, proprio perché l’altro/a può essere uno sconosciuto e come
tale, liberamente immaginato e idealizzato. Più che mai, oggi, l’utilizzo di Internet
presuppone una dimensione affettiva, emotiva e relazionale.
Partecipazione e identità. Internet offre ai giovani la possibilità di sperimentare
forme di partecipazione e di libertà di espressione che difficilmente il mondo
adulto garantisce loro negli spazi reali del vivere quotidiano. La possibilità di far
176 W. NANNI (a cura di), Educazione e nuovi media. Diritti e responsabilità verso una cittadinanza digitale,
Manuale online per gli insegnanti, Fonte: http://www.savethechildren.it/
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
81
girare in rete contenuti (facilmente) prodotti attraverso cellulari o telecamere,
rende Internet ancora più interessante agli occhi dei ragazzi. Fenomeno oggetto di
riflessioni psicologiche e sociologiche, sembra spesso presente nei ragazzi il
bisogno di acquisire visibilità attraverso gesti concreti, come un modo per divenire
consistenti/esistenti.
Il gap generazionale. L’utilizzo di Internet e soprattutto dei cellulari si presta
particolarmente per evidenziare un profondo gap generazionale tra infanzia,
adolescenza ed età adulta (digital divide).
Scarsi i confini tra virtualità e realtà. Esiste un confine molto labile tra ideale e
virtuale, e tra virtuale e reale: il mondo stesso dei ragazzi proposto dai media è
percepito come una dimensione ideale, desiderabile, ma soprattutto “reale”, o
comunque verosimile. Questa percezione mediata della realtà, riguarda anche la
dimensione digitale, nel senso che i ragazzi vivono come molto concrete
situazioni e relazioni tipicamente virtuali e le considerano spesso privilegiate e
preferibili.
A queste considerazioni positive non possiamo non accostare anche i rischi che l’utilizzo
di Internet e il cyberspazio portano con sé. I ragazzi e le ragazze, pur essendo spesso
tecnicamente competenti, tendono, a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti,
e tale fenomeno è tanto maggiore quanto è più forte il coinvolgimento emotivo
nell’utilizzo dei Nuovi Media. È questo spesso il terreno fertile tramite cui certi rischi
possono diventare concreti. Tra i principali, sia di carattere comportamentale che di
matrice tecnica, ricordiamo:
• Possibile esposizione a contenuti violenti e non adatti alla loro età. La mancanza
di controlli, soprattutto da parte dei genitori, porta i ragazzi a far esperienza di
tali contenuti senza aver la possibilità di valutarli criticamente e soprattutto di
confrontarsi con chi è più grande ed esperto. Spesso si sottovaluta l’impatto che
tali visioni possono avere sul comportamento e soprattutto che “le persone
imparano a rispondere in modo aggressivo sia attraverso l’esperienza sia
osservando modelli aggressivi”177.
• Possibili contatti con adulti che vogliono conoscere e avvicinare bambini/e o
ragazzi/e (adescamento).
177 D. MYERS, op. cit., p. 366
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
82
• Videogiochi diseducativi che spesso sono basati sulla violenza. Anderson offre
dei resoconti statistici relativi ad una serie di studi che rivelano cinque
importanti effetti relativi all’utilizzo di videogiochi dal contenuto violento:
aumentano la sollecitazione corporea (fa aumentare la frequenza del battito
cardiaco e della pressione sanguigna); incrementano i pensieri e sentimenti
aggressivi (i livelli di frustrazione aumentano, come anche l’ostilità palese).
Comportano anche una maggiore comparsa di comportamenti aggressivi: dopo
aver giocato a videogiochi violenti, bambini e giovani giocano in modo più
aggressivo con i coetanei, litigano più spesso con gli insegnanti e partecipano a
un numero maggiore di zuffe. La fruizione di questi videogiochi, inoltre, riduce
i comportamenti prosociali: dopo aver giocato con videogiochi dal contenuto
violento, gli individui diventano più lenti nell’offrire il loro aiuto a una persona
claudicante incontrata sul marciapiede e più lenti nell’aiutare i loro coetanei.
Diventano inoltre meno sensibili alla violenza, come rivela un decremento
dell’attività cerebrale associata agli stati emotivi.178
• Pubblicità ingannevoli.
• Rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei, come ad esempio il cyber-
bullismo.
• Dipendenza ed isolamento, generati da un eccessivo utilizzo di computer,
videogiochi e cellulari.
Questi rischi si presentato soprattutto del caso in cui si faccia del mezzo un utilizzo
sostitutivo anziché integrativo. In tal caso, il ruolo dei Nuovi Media diventa eccessivo sia
quantitativamente che qualitativamente, in quanto per crescere è necessario sviluppare
relazioni significative con persone in carne ed ossa, cui legarsi affettivamente, e
apprendere e sperimentarsi concretamente all’interno di contesti sociali reali.
2.4.2.1. I Social Networks
Nel 2003 il tempo passato su social network e blog era di poco superiore al quarto
d’ora, per superare l’ora nel 2005 e sino ad arrivare le tre e mezzo nel 2014. La crescente
diffusione dei social network, però, non è solo un dato statistico, ma un processo di
cambiamento che ha un impatto significativo sulla nostra esperienza. Da una parte essi
178 Id, p. 383- 385
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
83
modificano le modalità comunicative, dall’altro tra anche trasformando il rapporto tra
uomo e tecnologie.179
L’introduzione dei social network non implica una semplice «rivoluzione
tecnologica», ma anche una riconfigurazione delle opportunità di mediazione culturale a
disposizione dei loro utenti.
Con l’introduzione del medium, il soggetto è «disincarnato» per il suo interlocutore: la
fisicità del corpo viene sostituita da quella del medium. In particolare, nei social network
il corpo viene sostituito dal corpo virtuale, composto da una pluralità di immagini parziali
e contestualizzare.
Le conseguenze riscontrabili sono tre. In prima istanza, il soggetto non può più usare il
corpo dell’altro per comprendere le emozioni, privando il soggetto di un importante
strumento di comprensione dei propri e altrui stati emozionali. In secondo luogo il
soggetto diventa, per coloro con cui comunica, ciò che comunica (il messaggio è il
soggetto): senza il corpo, i soggetti riceventi, possono costruire l’identità dell’altro solo
in maniera indiretta, facendosi, spesso, di lui un’idea sbagliata. L’errore più comune è
quello della pars pro toto, cioè di identificare il soggetto nel suo complesso con singoli
aspetti della sua presentazione. Infine, il medium si separa dal soggetto, acquisendo una
propria autonomia e stabilità. Mentre nel «faccia a faccia» il messaggio è evanescente,
nei social network tende ad avere una propria vita (secondo la famosa regola latina “verba
volant scripta manent”) perché viene scritto e spesso reso visibile agli altri utenti del
network, permettendo, così, al messaggio di continuare ad avere vita propria anche dopo
esser stato emesso.180
In base a quanto precedentemente descritto, possiamo individuare, nell’utilizzo dei
social network degli effetti positivi e negativi, avvalendoci dello studio effettuato da
Giuseppe Riva181.
I più importanti effetti positivi li possiamo individuare in:
La possibilità di creare e sperimentare diversi e molteplici Sé. Questa possibilità,
se utilizzata correttamente, può attivare il processo di self- empowerment, ovvero
un “processo di ampliamento (attraverso il miglior uso delle proprie risorse
179 Cfr. G. RIVA, op. cit., p. 8
180 Id., pp. 31- 32
181 Cfr. G. RIVA, op. cit., pp. 127- 142
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
84
attuali o potenziali acquisibili) delle possibilità che il soggetto può praticare e
rendere operative e tra le quali può quindi scegliere”182.
Attraverso di esso, quindi, sarebbe possibile innescare e facilitare un processo di
cambiamento del soggetto. Mentre nella vita reale non è facile cambiare
radicalmente (se sono basso, continuo ad esserlo anche se vorrei essere diverso)
o, comunque, richiede tempo e sforzi prolungati, nei social network, soprattutto
se non si dichiara esplicitamente la propria identità, è possibile sperimentare
diversi modi di essere. La possibilità di sviluppare nuovi ruoli e identità è un
aspetto importante durante lo sviluppo individuale. La psicologia sociale
sottolinea, infatti, come una vita di successo richieda l’acquisizione della capacità
di gestire numerosi ruoli che ci richiedono le diverse fasi di vita (marito, figlio,
fratello, amico, superiore, dipendente, ecc.). I social network, a tal fine, offrono
un importante banco di prova dove sperimentare, senza grosse conseguenze,
diversi tipi di ruoli ed identità.
La psicologa americana Katelyn McKenna ha mostrato, inoltre, che le persone
sono più disposte a rivelare il proprio vero sé nei social network di quanto non lo
siano nella vita reale. Questo perché all’interno di una rete di «amici» è possibile
condividere le proprie convinzioni e le proprie reazioni emotive più intime con
minore rischio di disapprovazione o di sanzione sociale. Ciò li rende lo strumento
ideale per narrarsi, decidendo in prima persona quali ruoli e quali eventi
presentare.
Dar inizio a relazioni sentimentali. In secondo luogo i social network stanno
avendo un ruolo crescente nel permettere e supportare il processo di seduzione e
la nascita di relazioni. In generale ciò avviene attraverso una sequenza di
interazioni relativamente stabile, che si articola in due fasi: la creazione di
un’impressione di sé nell’altro e la scelta di una strategia seduttiva. Un altro
elemento che caratterizza i social network è la possibilità, come e più che nella
vita reale, di usare le relazioni nel processo di seduzione. Infatti, un primo
approccio, il più semplice, è quello di ottenere informazioni sulla persona
desiderata passando attraverso la sua rete di amici. Un secondo approccio è quello
di usare i social network per contattare persone con cui c’è stata in passato una
relazione.
182 M. BRUSCAGLIONI, La società liberata, Franco Angeli, Milano, 1994, p. 12
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
85
Stimolare la creatività. Le reti sociali sono anche in grado di trasformarsi in COIN
- COllaborative Innovation Network» (rete collaborativa creativa) quando i suoi
membri si caratterizzano per un’elevata motivazione condivisa, in grado di
guidare l’azione dei membri del gruppo. Quando ciò avviene, la rete sociale si
trasforma in un gruppo creativo in grado di produrre nuovi prodotti, nuovi
concetti, nuove idee. La condizione necessaria per lo sviluppo di una rete creativa
è l’instaurarsi di un’esperienza ottimale di gruppo – definita “Networked Flow” -
nella quale l’intenzione soggettiva diventa collettiva, ovvero in grado di guidare
l’azione dei membri del gruppo. Ciò richiede che i membri del gruppo:
condividano gli stessi obiettivi e le stesse emozioni; sperimentino una situazione
di liminalità (uno stare insieme che tende ad un’azione sociale) e identifichino
nell’attività comune lo strumento per uscire da tale situazione.
Supportare la promozione pubblicitaria. I social network possono anche
rappresentare per le aziende un'importante strumento per comunicare
efficacemente con i propri clienti. Numerose ricerche sottolineano come la
condivisione di collegamenti a prodotti sia un'attività molto diffusa nei social
network. Il social network sta trasformando le caratteristiche e il ruolo del
consumatore, punto di riferimento per il mondo dell’advertising: da consumatore
passivo d’informazioni (spettatore televisivo) si sta progressivamente
trasformando in uno «spettAutore» (prosumer), che crea o modifica contenuti
esistenti secondo i propri bisogni, e in un «commentAutore» che discute dei
prodotti e che condivide le proprie riflessioni con gli amici. In particolare, il ruolo
attivo del consumatore introduce una nuova variabile – la reputazione –
d’importanza centrale per l’efficacia delle politiche di comunicazione aziendale.
Economia della felicità. Va infine sottolineato come a caratterizzare i social
network, non sia solo l’interesse individuale ed economico: molti utenti offrono
supporto e offrono attività gratuite per un senso di responsabilità sociale nei
confronti della propria rete. Clay Shirky suggerisce come possibile spiegazione a
tale fenomeno, la disponibilità di un «surplus cognitivo», di una maggiore quantità
di tempo libero frutto dello spostamento del tempo precedentemente dedicato alla
visione della televisione - solo negli Stati Uniti vengono dedicate alla televisione
circa 200 miliardi di ore l’anno - verso attività sociali e intrinsecamente stimolanti
come quelle possibili in un social network.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
86
Se è vero che i social network possono essere delle opportunità per molti di noi, è anche
vero il contrario. La natura ibrida dei social network presenta infatti due facce: una
positiva e l’altra negativa; una in grado di creare nuove opportunità e una in grado di
creare nuovi problemi183:
Comportamenti disfunzionali. Tra le pieghe dei social network si nascondono una
serie di comportamenti disfunzionali non sempre immediatamente visibili: dal
cambiamento di identità ai comportamenti aggressivi (troll- uso provocatorio o
irritante dei social network- e stalking- uso dei social network per perseguitare un
soggetto, spesso per motivi futili-), alla violazione e all’abuso dell’informazione.
Nel caso della violazione delle informazione, abbiamo l’hacking, che consiste nel
tentativo di penetrare nei profili altrui; la creazione di virus- applicazioni che si
inseriscono in altre applicazioni, per modificare i dati presenti-, spyware-
applicazioni che raccolgono informazioni personali degli utenti-, il phishing- per
accedere a informazioni personali o riservate mediante l’utilizzo di comunicazioni
fasulle che imitano la grafica e contenuti di siti istituzionali- e il lurking- consiste
visitare profili altrui senza averne l’autorizzazione e senza che l’utente ne sia
consapevole. Nel campo dell’abuso e della distribuzione dell’informazione,
troviamo tutte le situazioni in cui avviene uno scambio di programmi
commerciali, canzoni o film coperti da copyright e lo spamming- invio di
messaggi non desiderati di tipo commerciale-.
A incentivare questi comportamenti sono due aspetti. Da una parte l’anonimato,
possibile anche in un mondo come quello dei social network dove l’identità
apparentemente è sempre visibile. Dall’altra il desiderio di riconoscimento o di
rivalsa- che la struttura dei social network è in grado di amplificare- a seguito di
una frustrazione per un bisogno insoddisfatto (di entrare a far parte di una
determinata comunità o di essere considerato dagli altri soggetti presenti).
Fine della privacy. Un altro elemento critico è la grande quantità di dati e
informazioni personali - dai dati anagrafici, ai gusti, alle attività preferite, ai posti
visitati – presenti nei social network. Non solo: la maggior parte dei social
network applica politiche di accesso ai dati personali piuttosto «morbide» che
consentono ai propri inserzionisti, e non solo a loro, di raccogliere migliaia di dati
sui propri utenti. Acquisti e Gross hanno analizzato i dati inseriti su Facebook da
183 Cfr. G. RIVA, op. cit., pp. 145- 157
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
87
un campione di studenti universitari, scoprendo che una parte rilevante degli utenti
rivelava la propria data di nascita (84%), il numero di cellulare (il 40%), i corsi
frequentati (42%), le proprie idee politiche (53%) e il proprio orientamento
sessuale (59%).
Identità fluida e analfabetismo emotivo. I social network sono uno strumento che
consente di controllare e definire la propria identità sociale e quella dei propri
amici. Grazie a questo processo e alla fusione tra mondo reale e virtuale si produce
un'«identità fluida», che è allo stesso tempo flessibile ma precaria, mutevole ma
incerta. In una parola: instabile.
L’instabilità produce il primo dei paradossi dei social network: se è possibile che
io possa più facilmente cambiare la mia identità è altrettanto possibile che
l’intervento esterno possa modificare più facilmente il modo in cui gli altri
percepiscono la mia identità. Questo provoca una mancanza di sicurezza
relativamente all’immagine che si vuol creare di sé. Un esempio a questo
proposito è il fenomeno del tagging (etichettare) con cui nei social network è
possibile associare a un «amico», senza che lui lo voglia, un’immagine in cui lui
è presente o una nota di testo a lui riferita. L'essere «taggati» comporta che un
contenuto multimediale, in cui noi siamo presenti (foto) o in cui siamo citati
(testo) ma che non abbiamo scelto, apparirà nel nostro profilo. È vero che è
possibile impostare le notifiche di Facebook in modo da essere sempre a
conoscenza quando qualcuno ci tagga. Ma è anche vero che se mi dimentico di
farlo, o non sono consapevole di che cosa implica essere «taggati», appariranno
nel mio profilo, senza che lo abbia voluto, foto o testi.
Se un’identità fluida può essere un vantaggio per un adulto, può diventare un
problema per un adolescente che sta cercando di costruire la propria identità. In
particolare può portare a un rallentamento del processo di costruzione dell’identità
e a sostituire la stabilità e il futuro con un eterno presente privo di certezze e di
legami.
A rendere precarie e «leggere» le relazioni sociali nei social network è anche un
altro possibile effetto dell’uso massiccio dei social media: l’analfabetismo
emotivo. Infatti, nell’interazione mediata la fisicità del corpo è sostituita da quella
del medium. Le conseguenze di tale effetto sono molteplici: priva il soggetto della
consapevolezza e, quindi, del controllo delle proprie emozioni, rende, così, meno
consapevole il soggetto delle ragioni per le quali si prova una certa emozione e,
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
88
infine, lo rende incapace di relazionarsi con le emozioni e i comportamenti altrui.
Goleman attribuisce proprio all’analfabetismo emotivo alcuni dei problemi che
caratterizzano i nativi digitali (coloro che hanno sempre vissuto con Internet e i
nuovi media): bullismo, alcolismo, droga, disinteresse emotivo e psicopatie.
Eccesso di informazione. L’enorme quantità d’informazioni presente in un social
network richiede all’utente capacità di gestione non banali: non è facile gestire in
mezz’ora cinquanta messaggi sul proprio account di Twitter. Superato un certo
livello, infatti, l’informazione non contribuisce più a migliorare la qualità di vita
ma la peggiora (information overload), costringendo il soggetto ad analizzare
l’informazione per trovare dati rilevanti. Da un punto di vista psicologico, due
sono i comportamenti associati a questo fenomeno: o si crea nel soggetto l’ansia
da mancanza di informazione sufficiente- che lo porta a ricercare continuamente
notizie nuove, controllando compulsivamente il proprio profilo- oppure si realizza
la situazione opposta, di rifiuto di qualsiasi tipo di informazione. L’information
overload e i comportamenti a essa associati sottolineano come nei social network
stia progressivamente mutando il significato di informazione, che viene sempre
più legato a quello di esperienza.
Dipendenza da Social Network. A partire dalla fine del 2009 i social network sono
diventati la destinazione più popolare su Internet, con una permanenza media
mensile che supera le sei ore per italiano. Va sottolineato come dietro il valore
medio di sei ore al mese ci siano utenti che non utilizzano mai i social network e
altri che lo consultano per più di dieci ore al giorno. In particolare nei social
network sono le donne ad essere maggiormente vulnerabili alla dipendenza da
Internet perché, più che negli uomini, la loro autostima deriva dai rapporti che
instaurano con gli altri. Se un uso moderato dei social media inferiore al 20% del
tempo lavorativo (circa due ore al giorno) può produrre un aumento di
produttività, il superamento di questa soglia può nascondere un vero proprio
«disturbo di dipendenza da Internet» che ha un impatto significativo sulla
produttività individuale e sulla dimensione relazionale. Con «disturbo di
dipendenza da Internet» si definisce un disturbo psicofisiologico caratterizzato da
dipendenza, perdita delle relazioni interpersonali, modificazioni dell’umore,
alterazioni del vissuto temporale, attenzione completamente orientata all’utilizzo
compulsivo del mezzo. Alcuni autori, invece, sottolineano come non si tratti di un
vero e proprio disturbo, ma di una sindrome che al suo interno include diverse
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
89
tipologie di disturbi, quali: friendship addiction (dipendenza dalle relazioni
online), cybersexual addiction (dipendenza dal sesso online), muds addiction
(dipendenza dall’uso dei Mud) e compulsive online gambling (gioco d’azzardo
compulsivo online). Per questo è più corretto parlare di «psicopatologia dei nuovi
media».
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
91
CAPITOLO 3 PER UNA PEDAGOGIA DELLA COMUNICAZIONE
DEI MEDIA
3.
3.1. Presupposti morali: l’etica della comunicazione
“Oggi più che mai la comunicazione è un tema alla moda. I suoi processi, infatti,
incidono profondamente sulla nostra vita e la modificano in modo radicale: tanto che
non possiamo più pensare a noi stessi, né interrogarci sul nostro futuro, senza fare
riferimento agli strumenti e alle tecniche della comunicazione. Oggi più che mai, tuttavia,
l’agire comunicativo richiede di essere definito, regolato, orientato. Bisogna far
emergere i criteri, i prîncipi, i valori in base ai quali chi comunica compie le sue
scelte”184
La dimensione etica della persona è strettamente collegata alla dimensione
ontologica. I valori, infatti, non sono disincarnati ma strettamente legati alla struttura
umana. Tale dimensione conferisce efficacia alla piena realizzazione dell’uomo e assegna
un senso ad ogni sua azione.185 “La presenza di valori situa la comunicazione educativa
oltre il semplice livello della comprensione e dell’impegno di codici di significazione; fa
sì che non si trasmetta soltanto un sapere specifico e settoriale, ma anche e soprattutto
una visione del mondo e della vita”186
Per questo motivo, qualsiasi riflessione pedagogica sulla comunicazione, e soprattutto
qualsiasi tipo di azione su di essa, non può prescindere dall’individuazione del contesto
axiologico che motivi ed orienti la nostra azione educativa.
Sin dall’antichità il termine etica, in Occidente, è stato connotato come riflessione
filosofica delle azioni, atteggiamenti e comportamenti umani.
Da un punto di vista etimologico, invece, possiamo definire “etica” (dal greco éthos) tutta
quella serie di azioni, che possono consolidarsi in costume e abitudine, condiviso da una
comunità.
Nell’uso del linguaggio, infine, si distinguono due parole diverse per indicare l’azione e
la riflessione su di essa: etica e morale. Per morale intendiamo la sfera delle azioni umane,
184 A. FABRIS, op.cit., p. 9
185 Cfr. L. PATI, op. cit., pp. 95- 98
186 Id., p. 101
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
92
nella loro concreta storicità, mentre per etica la disciplina che le prende in esame e che ne
fa il suo oggetto specifico.187
L’etica, come altre discipline, è la madre di altre sotto-discipline. Quella a cui fa
riferimento la pedagogia per quanto riguarda l’ambito telematico è l’etica della
comunicazione.
L’etica della comunicazione è una disciplina che, in forma codificata e autonoma,
è sorta nella seconda metà del Novecento. In passato, ci si limitava a riflettere sui
differenti criteri di comportamento comunicativo, come nel caso dell’’ “etica della
comunicazione” di Karl-Otto Apel o dell’ “etica del discorso” di Habermas.
Oggi, invece, l’esistenza dei media e la diffusa mancanza di sensibilità morale
fanno emergere nuovi ambiti di meditazione. Nasce, infatti, l’esigenza, non tanto di porre
limiti e sanzioni all’uso incosciente di questi mezzi, quanto di dare ad essi una
legittimazione adeguata. Occorre, quindi, che nei processi di comunicazione ci si riferisca
ad alcuni principi di comportamento, ma anche che tali principi debbano essere
universalmente condivisibili, validi in generale.
Possiamo, quindi, definire come compito dell’etica della comunicazione, quello di
fondare, in termini filosofici, ciò che può essere detto “buono” in un senso morale e di
motivare l’adozione di comportamenti comunicativi che lo promuovano. Ciò implica
anche stimolare la responsabilizzazione degli attori dell’evento comunicativo.188 “La
possibilità di comunicare in modo nuovo e diffuso è un bene di tutta l’umanità e come
tale va promosso e tutelato. Quanto più potenti sono i mezzi di comunicazione, tanto più
deve essere forte la coscienza etica di chi in essi opera e ne fruisce.”189
I mezzi di comunicazione di massa e i new media, da un punto di vista morale,
non possono essere considerati neutri, in quanto interagiscono con il pensiero e con la
prassi dell’uomo, modificandone il rapporto con gli altri uomini e con il mondo.
Ci sono due modi in cui noi possiamo rapportarci eticamente alle numerose opportunità
che ci offre la rete.
Un primo modo è quella che potremmo definire “etica di Internet”, cioè una riflessione
sugli atteggiamenti e i comportamenti dell’uomo che la rete favorisce e che sostiene.
187 Cfr. A. FABRIS, op. cit., pp. 12- 14
188 Id., pp. 33- 37
189 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo
decennio del Duemila. Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, Ed. Paoline, Roma, 2001, n. 39.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
93
Ciò comporta anche una riflessione in merito al rapporto tra “reale” e “virtuale”. Sebbene
queste due esperienze della vita dell’uomo vengano considerate antitetiche, se andiamo
all’analisi dell’etimologia della parola “virtuale” ci rendiamo conto che in realtà non è
così. Essa trova la sua radice il “virtus”, virtù, parola che richiama e racchiude al suo
interno gli elementi della possibilità- maggiore ampiezza e ricchezza di determinazioni
rispetto a ciò che è già esistente-, della potenzialità- situazioni in cui si trova qualcuno
prima di realizzarsi pienamente- e della potenza- potere che qualcosa ha, in sé, di
compiere uno specifico atto o di realizzarsi in un certo modo-.
Se consideriamo questi elementi, nel momento in cui parliamo della “realtà virtuale” ci
rendiamo conto di quando, in verità, non vi è contrapposizione tra i due concetti. Inteso
in questo modo il virtuale consiste nel potenziamento della realtà e non in una sua
negazione: esprime quelle potenzialità dell’uomo, in lui insite, che le nuove tecnologie
hanno il potere di realizzare. In questa situazione si insinua il giudizio morale di tali
mezzi: essi vengono considerati buoni nel momento in cui permettono all’uomo di
realizzare pienamente se stesso e i propri desideri.
Ma oggi, insieme alla realizzazione del virtuale si assiste anche alla virtualizzazione del
reale, che comporta una perdita di consistenza dell’esistente. Reale, oggi, è solo ciò che
appare e questa situazione decreta il carattere antitetico dell’espressione “realtà virtuale”.
Stabilire i criteri morali che possono regolamentare l’utilizzo di internet, comporta il
passaggio ad un altro livello di analisi: dall’etica di internet, all’etica in internet.190
L’ “etica in Internet”, comporta un’analisi, una riflessione su quei comportamenti
che vengono adottati nell’uso concreto della rete, quando ad esempio scriviamo e-mail
navighiamo nel web.
A questo proposito sono già state elaborate specifiche prescrizione, che si fondano su
argomenti di carattere giuridico e morale.
Un esempio possono essere i «dieci comandamenti» del web identificati da Arlene
Rinaldi,191 una docente che negli Stati Uniti che ha elaborato un galateo di internet nella
forma, appunto, di dieci comandamenti:
1. Non userai un computer per danneggiare altre persone.
2. Non interferirai con il lavoro al computer di altre persone.
190 Cfr. A. FABRIS, op. cit., pp. 123- 126
191 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, pp. 127- 128
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
94
3. Non ficcherai il naso nei file di altre persone.
4. Non userai un computer per rubare.
5. Non userai un computer per portare falsa testimonianza.
6. Non userai o copierai software che non hai dovutamente pagato.
7. Non userai le risorse di altri senza autorizzazione.
8. Non ti approprierai del risultato del lavoro intellettuale altrui.
9. Penserai alle conseguenze sociali dei programmi che scrivi.
10. Userai il computer in un modo che mostri considerazione e rispetto.
In questo caso, però, più che di etica, forse è meglio parlare di etichetta, vale a dire un
modo di comportarsi che in molti casi sfiora il galateo. Queste regole, infatti, vengono
identificate con il neologismo inglese di Netiquette.
Un altro contributo importante allo sviluppo dell’etica in internet ci viene offerto
dall’etica hacker (da distinguere dai craker, pirati informatici). Il termine hacker significa
“fare a pezzi” in senso positivo, cioè scindere qualcosa nelle sue parti fondamentali, per
studiarne il funzionamento. Gli hacker sono i fruitori di una coscienza etica della
conoscenza: principio fondamentale della loro etica è quello di permettere una diffusione
libera del sapere. Essi, infatti, intendono la conoscenza come un bene comune e a tal fine
promuovono azioni volte a realizzare la libertà e l’apertura del codice informatico (come
ad esempio i free software, programmi gratuiti che rappresentano un’alternativa al
monopolio dei grandi produttori di programmi). Libertà di informazione, quindi, è fulcro
dell’etica hacker e, più in generale, della netica. Esistono tre tipi di libertà di
informazione: attiva (libertà di informare), passiva (libertà di essere informati) e riflessiva
(libertà di informarsi). Una società democratica è quella che permette la realizzazione di
tutti e tre questi livelli.192
Diverso è, invece, il caso di quei codici di autoregolamentazione, che spesso vengono
elaborati dagli operatori del settore e le aziende erogatrici di servizi. Tali codici
riguardano, per ora, alcuni degli abusi perpetrati dal web nei confronti di specifiche
categorie di potenziali utenti, come ad esempio i minori. Ma per garantire l’osservanza di
tali principi, occorrerebbero moderatori in ogni “luogo” del web, e ciò risulta impossibile.
192 Id., pp. 137- 139
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
95
Per questo, al di là dei singoli codici comportamentali, ogni utente è chiamato ad
assumersi le proprie responsabilità e, soprattutto, a trovare in se stesso le motivazioni che
lo inducono a porre in essere un comportamento corretto, “buono”:193
“[…] per regolamentare l’agire all’interno della rete non bastano i codici.
Bisogna invece fornire le motivazioni, stabilire perché bisogna compiere
determinati atti piuttosto che altri. E ciò propriamente l’etica in internet è
chiamata a fare, con il suo rinvio alla responsabilità di ciascun soggetto
connesso in rete. Ma anche questo non è sufficiente. Per giustificare l’adozione
di determinati comportamenti, infatti, l’etica in internet deve a sua volta essere
collocata in un contesto più generale, quello dell’etica di internet: che deve
stabilire i principi generali presupposti, di volta in volta, dalle scelte concrete.
Fondare tali principi è appunto il compito di un’etica della comunicazione”.194
Individuare i principi su cui fondare l’etica della comunicazione non è un lavoro semplice.
Possiamo, però, provare ad individuare quattro nodi teorici, tipici della riflessione
filosofico- morale, che rientrano a pieno titolo nell’ambito dell’etica della comunicazione
(in cui possiamo far rientrare sia quella di Internet che quella in Internet) e che potremmo
definire dal carattere generale e condivisibile.
Il primo è quello della libertà, intesa sia nel senso di avere libero accesso ai media,
ma anche di farne un uso secondo la propria personale coscienza, oppure ancora, libertà
di poter esprimere il proprio pensiero e la propria sensibilità senza divieti e restrizioni.
Il rovescio di questa medaglia è inevitabilmente la responsabilità, dove si intrecciano da
un lato le coscienze dei singoli utenti nella propria personale esperienza di fruitori dei
prodotti mediali e, dall’altro, le responsabilità deontologiche dei professionisti che
operano in questo campo, chiamati alla considerazione dei valori di verità, indipendenza,
qualità, rispetto della dignità della persona, ricerca di una reale artisticità del proprio
lavoro, positività dei contenuti trasmetti, considerazione degli effetti che la propria azione
può avere su un pubblico così ampio.
193 Cfr. A. FABRIS, op. cit., pp. 126- 128
194 Id., p. 128
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
96
Etimologicamente il termine “responsabilità” è legato al termine “rispondere”. In
italiano possiamo avere due utilizzi di tale verbo: quando intendiamo di “rispondere a”
qualcosa o qualcuno, oppure “rispondere di” qualcosa o qualcuno. Nel primo caso il
riferimento è al modello relazionale della domanda\ risposta. Nel secondo caso, invece,
la persona si “fa carico” di un potere nei confronti di qualcosa o qualcuno. Il “rispondere
di” è un atteggiamento di chi agisce secondo cause, scegliendo liberamente di essere
responsabile di un qualcosa o qualcuno che è altro da sé.
Da qui possiamo dedurre che la responsabilità è strettamente legata al concetto di libertà:
un soggetto libero, infatti, è un soggetto moralmente responsabile. Possiamo rileggere il
nesso tra responsabilità e libertà con Kant e il suo concetto di «imputabilità». Nella
“Critica alla ragion pura” Kant afferma che, nel momento in cui io decido liberamente
di porre in essere una determinata situazione, io sarò responsabile, non solo della
situazione in sé, ma anche delle conseguenze che essa comporterà nella mia vita e in
quella degli altri. Questo implica che, nel momento in cui decido, devo essere
consapevole delle conseguenze delle mie azioni e tenerne conto nelle attuali scelte. In
questa prospettiva, il mio agire si trova inquadrato in un orizzonte più generale di valori
e principi di orientamento, indicati dalla presenza, comunque riconosciuta, di un’istanza
superiore, per me vincolante.
Solo se le mie scelte, liberamente assunte e considerate nelle conseguenze che esse
comportano, vengono sottoposte al vaglio di una tale istanza, io posso davvero
comprendere fino in fondo la mia responsabilità morale. Ogni istanza può assumere una
forma diversa (Dio, un’ideologia politica, etc....) ma comunque, attraverso di essa, si
configura una responsabilità che non è solo un “rispondere di”, ma è anche un “rispondere
a”. Quindi si è responsabili nel momento in cui si accetta liberamente di rispondere dei
propri atti a ciò che si riconosce come vincolante.195
Oltre alla libertà e alla responsabilità, altri due termini riflettono il tema della
comunicazione massmediale: possibilità e senso. La prima riflette l’enorme mole di
opportunità che ci sono aperte grazie all’uso dei media. Opportunità prima impensate
sono divenute realtà che ci interrogano costantemente sull’esistenza e la natura dei limiti
che l’uomo può o non può riconoscere a se stesso. A questa situazione, quindi, non
195 Id., pp. 52- 56
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
97
possiamo non far conseguire quella del senso che alle esperienze mediali siamo chiamati
a dare.196
L’uomo non si trova di fronte al mondo della comunicazione: ne è parte integrante.
Egli ha, con tale mondo, un rapporto relazionale e interattivo. Nel mondo mediatico
l’uomo costruisce l’éthos, lo stile di vita, della persona e della comunità. Esso si crea
nell’interazione con la tecnologia, la cultura e l’immaginario. L’etica diventa saggezza
quando permea lo stile di vita.
Data l’enorme quantità di immagini e parole a cui ci sottoponiamo, il nuovo stile di vita,
basato sull’etica della comunicazione, dovrebbe basarsi sulla sobrietà, che eviti lo spreco
di tempo e soprattutto gli eccessi, che ci si sottragga al bombardamento continuo delle
parole e delle immagini a fronte del recupero del silenzio (luogo in cui parla la coscienza),
della bellezza, del gioco, della vita.
In una società come la nostra, dominata dalla spettacolarizzazione e dall’estetizzazione
della vita, l’unico modo per poter ricominciare una vita morale è cogliere dall’estetica
l’etica della vita.
Secondo McLuhan questa situazione si realizza trasfigurando ogni cliché in archetipo,
riportando alla coscienza ogni gesto e azione vissuta direttamente o indirettamente.
Mentre il cliché è la banalizzazione del mondo e dell’esistenza, dove ogni cosa che
appartiene al nostro mondo (gesti, immagini, ambienti) non è più percepita perché
onnipresente, l’archetipo è l’ “essenza sostanziale delle cose sensibili”, è
coscientizzazione di ciò che è, non mera registrazione del fenomeno.197
“Così la questione etica si fa sempre più attuale e sentita. Non si tratta solo di
vincolare i media a regole che tutelino in particolare i soggetti meno garantiti e
le categorie più marginali. In agguato sono nuove e pesanti forme di alienazione,
che possono condurre alla reificazione dell’uomo, ossia alla riduzione della
persona a cosa, a oggetto, a merce. Occorre stabilire regole precise per l’uso
degli strumenti e più ancora per definirne le responsabilità sociali. L’etica si
erige pertanto a via per l’umanizzazione di processi altrimenti destinati a
196 Cfr D. FELINI, Pedagogia dei media, La Scuola, Brescia, 2004, pp. 29- 30
197 Cfr. F. BELLINO, op. cit., pp. 82- 94
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
98
provocare conseguenze fortemente negative, sul piano personale, relazionale e
sociale.”198
3.2. Pedagogia della comunicazione educativa
Una volta individuati i principi etici condivisibili sui quali è doveroso fondare
l’agire umano, possiamo spostare l’attenzione sull’argomento cardine di questa tesi: la
pedagogia.
Sebbene l’attenzione maggiore in questo lavoro sarà concentrata sulla Pedagogia
dei Media, e in particolare su come concretizzare l’Educazione ai Media (o Media
Education), non posso esimermi dal descrivere, seppur brevemente, la branca della
pedagogia da cui tale disciplina nasce: la Pedagogia della Comunicazione.
L’epoca in cui viviamo fa sorgere, ancor più fortemente, l’imperativo pedagogico
di insegnare a comunicare, quindi l’esigenza di apprendere a dialogare in maniera
corretta. Per farlo, la pedagogia, non può che avvalersi dell’apporto di altre discipline
(quali la psicologia o la semiotica) che contribuiscano a creare il terreno su cui fondare il
ragionamento pedagogico e le conseguenti linee operative, senza, però, annientare la
specificità della pedagogia, che ha come campo specifico e privilegiato quello
dell’educazione della persona.
Essa, quindi, accostandosi all’ambito della comunicazione, è tenuta ad intenderla come
aspetto essenziale del processo educativo e a coglierne la portata umanizzante e
promozionale, oltre il mero tecnicismo. “La capacità di comunicare, di entrare in
relazione con gli altri, lungi dal diventare un occasionale scambio di messaggi o una
sorta di condizionamento, scaturisce dalla natura stessa dell’uomo e coinvolge il suo
essere.” […].199
In questo senso possiamo intendere la comunicazione, non come un problema
pedagogico, ma come il problema pedagogico fondamentale. Esso non riguarda solo le
tecniche comunicative, ma va oltre, verso la dimensione del senso, in una visione
axiologica globale della comunicazione. La comunicazione educativa si differenzia da
tutte le altre forme di rapporto perché è frutto di intenzionalità, è un atto guidato dalla
198 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e Missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali
nella missione della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2004, n. 87
199 L. PATI, op. cit., p. 7
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
99
coscienza, che non guarda solo al “qui ed ora” dell’uomo, ma lo inserisce in una
progettualità di crescita onnicomprensiva.200
Come è stato detto, nel suo lavoro, la pedagogia si avvale dei contributi di altre
discipline, come ad esempio le teorie della Psicologia dello sviluppo, utili per
comprendere quanto la cultura sia importante nel divenire umano. Lo sviluppo umano è
condizionato dallo stretto rapporto esistente tra natura e cultura. In altri termini possiamo
dire che esso è influenzato da fattori endogeni (interni) ed esogeni (esterni). Nei primi
facciamo rientrare tutto ciò che riguarda la persona, il suo essere, le sue esperienze, il suo
modo di vedere il mondo e di vivere in esso. Nel secondo ambito, quello dei fattori
esogeni o esterni, rientra invece la cultura, con tutto ciò di cui essa è costituita, dalle
tradizioni popolari, alle modalità di mediazione tra le persone. Possiamo, quindi, ritenere
il divenire umano come condizionato fondamentalmente da relazioni, con gli oggetti
(media) e i soggetti che abitano il suo mondo. “Il concetto di mediazione, come
negoziazione continua tra soggetto e cultura […], si caratterizza per una progressiva
valorizzazione del concetto che gran parte delle esperienze formative sono relazionali,
fondate su rapporti interpersonali diretti, remoti o simbolici, più o meno coadiuvati dai
media”201. L’osmosi tra le componenti esogene ed endogene plasma l’uomo e il suo
essere a tal punto che possiamo definire l’uomo come un essere in continuo divenire,
perché continuamente situato in un contesto e influenzato dalla cultura.
Dopo questa breve premessa psicologica, è lecito chiedersi: in che modo la cultura
attuale influenza l’uomo?
Il nostro vivere in una cultura iper-tecnologica, comporta delle differenze con il
passato, soprattutto in ambito relazionale, in quanto i media “sostituiscono gli spazi
dell’immediatezza con esperienze indirette”.202
Una società che fa della comunicazione la sua risorsa fondamentale, muta in profondità
tutte le strutture sostitutive dell’esperienza. Il modo in cui sperimentiamo la realtà e noi
stessi, “si modifica nelle sue dimensioni cognitive, percettive, emozionali […].
L’esperienza diventa […] un costrutto artificiale, il prodotto di relazioni e di
rappresentazioni […]”.203
200 Id., pp. 71- 76
201 A. CALVANI, op. cit., p. 56
202 Id., p. 53
203 A. MELUCCI, Il gioco dell’Io, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 10
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
100
“Secondo il mio punto di vista è necessario studiare i media perché essi sono
della massima importanza per l’esperienza, dandole forma. Ho sostenuto che questo
studio deve comportare una considerazione dei media non come una serie di istituzioni o
prodotti o tecnologie (o almeno non solo in questo modo), ma anche come un processo
di mediazione. I media vengono prodotti: e di questo produrre noi siamo gli agenti e i
destinatari”204
Bisogna partire, quindi dal presupposto che è nella mediazione, come luogo di
negoziazioni e rielaborazioni continue, che il soggetto si forma e fa esperienza. Se da una
parte, quindi, non possiamo prevedere un’immagine di comunicazione “scorporata, o
magari in contrapposizione rispetto a quello tecnologico e mediale” in quanto si
rischierebbe di basare l’intervento educativo “su un’immagine del tutto irrealistica della
condizione odierna”205 , dall’altra non possiamo non considerare i rischi che questo
sviluppo ha comportato sul piano della comunicazione, sia interpersonale che
intrapersonale. “Il discorso pedagogico […] deve promuovere l’elaborazione di migliori
modalità di rapporto, sviluppare inusitati schemi interattivi, porre in atto più duttili
modelli comunicativi”206.
L’importanza di tale ambito di studio ha portato alla nascita di una nuova branca
della Pedagogia: la Pedagogia della Comunicazione. Con la prima delle due parole di
questa disciplina si designa quella scienza che “esamina l’atto educativo nella duplice
accezione di trasmissione e di trasformazione culturale e la qualità delle relazioni
interpersonali che le rende possibili” [Bertolini].
Questa definizione rende pienamente il senso del sapere pedagogico. Un sapere che non
si limita a descrivere i processi educativi, ma punta soprattutto ad un loro miglioramento.
“Il discorso pedagogico è […] chiamato a diventare più di prima fattore di provocazione
intellettuale e a sospingere all’attenta riflessione circa la situazione presente mentre
propone alternative di vita. La pedagogia, in quanto scienza del «dover essere», è tenuta
a contrastare le tendenze massificanti e repressive e ad agire perché l’uomo progredisca
in dignità, in originalità, in valore”.207
204 R. SILVERSTONE, Perché studiare i media?, Il Mulino, Bologna 2002, p. 127
205 A. CALVANI, op. cit., p. 54
206 L. PATI, op. cit., p. 6
207 Id., p. 6
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
101
La seconda parola chiave, comunicazione, indica quel processo che provoca
sempre effetti nel processo formativo dell’essere umano. Unendo queste due componenti
possiamo definire la Pedagogia della Comunicazione come lo studio sistematico dei
processi comunicativi, studiati da un punto di vista pedagogico, con l’obiettivo di “[…]
tutelarne le modalità di espressione, per richiamare l’attenzione sulle negative
conseguenze che un suo uso distorto può provocare nel campo della crescita personale e
sociale”.208
La missione pedagogica, quindi, ha la finalità di recuperare e valorizzare dell’autentico
significato della comunicazione, ed è tesa a ricreare uno scambio qualitativo e
coscienzioso di informazioni. 209
Come si è affermato nel paragrafo precedente, l’unico modo per poter recuperare
un’idea di comunicazione educativa, è che essa si compia “[…] all’insegna di una
concezione axiologica” 210 della vita. Questo comporta considerare come […] la
pedagogia della comunicazione esalti la pedagogia della persona”211 e che quindi il
punto di partenza di questa disciplina, così come di tutta la pedagogia, non può non essere
l’uomo.
Con lo sviluppo, prima dei mass- media e in maggior modo dei new media, l’uomo
sta sperimentando una situazione nuova: quella di non essere mai solo.
Ciò non vuol dire non essere “fisicamente” mai solo, ma “mentalmente”. Soprattutto
nell’epoca del 2.0 ognuno di noi ha sempre la possibilità di essere connesso con gli altri.
Non solo. Sono talmente tante le opportunità offerte dalla rete che permettono di non
annoiarsi e di non stare senza far niente, che ormai è diventato difficilissimo dire di essere
davvero soli. L’unico modo per farlo, oggi, sarebbe di spegnere tutto: cellulare, tablet,
computer. Ma ciò nella maggior parte delle situazioni risulta impossibile perché se non si
è connessi, ci si sente persi. È come se la nostra vita virtuale giustificasse e desse senso
alla nostra vita reale.
Ma quali sono le conseguenze del non essere mai soli?
Di solito si considera la solitudine come un male dal quale sfuggire, qualcosa di negativo
da evitare. Questa considerazione è molto relativa, in quanto la solitudine può essere
208 Id., p. 80
209 Cfr G. ELIA, op. cit., p. 86- 87
210 L. PATI, op. cit., p. 7
211 Id., p. 7
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
102
vissuta in modo negativo, quando è conseguenza di una chiusura al mondo (e quindi non
causa, ma sempre conseguenza di un malessere), ma anche in modo positivo, quando
diviene lo spazio d’incontro tra l’Io e l’Io più profondo, quello che risiede nell’anima,
nella nostra coscienza. La solitudine, quindi, è quella condizione umana che permette di
poter instaurare dentro di sé un vero e proprio dialogo interiore.
La persona si forma attraverso il dialogo con l’altro. Tuttavia, anche quando l’uomo è da
solo, con se stesso o di fronte al mondo, si crea una relazione: la relazione riflessiva. Essa
ha una valenza primaria in quanto permette all’uomo di prendere coscienza del nucleo
più profondo del suo sé.
La solitudine, vista come “spazio” di affermazione di sé è il “luogo” essenziale all’interno
del quale fare esperienza della relazione. Chi non fa esperienza del dialogo interiore,
spesso incontra problemi anche nella comunicazione interpersonale.
La solitudine negativa, a cui si è fatto precedentemente riferimento, è quella che
caratterizza l’uomo post- moderno. Egli vive in un ambiente pieno di esperienze allettanti,
caratterizzato da una molteplicità di rapporti umani superficiali. L’isolamento
sperimentato in questo contesto non è occasione di riflessione, ma momento di
disperazione in cui l’uomo si sente abbandonato. Egli vive l’assenza di contatto
interpersonale come assenza di amore, nella consapevolezza di non poter fare affidamento
su forme di solidarietà interumana.
La solitudine positiva, invece, si caratterizza come “luogo” pieno di significato, a cui il
singolo attinge le risorse per condurre in maniera valida la propria esistenza: è una
solitudine fatta di Essere. Questa è la solitudine di chi vuole mettere in ordine la propria
esistenza, entrando in contatto con il sé più profondo ed autentico.
“L’individuo, sin dai primi momenti della propria esistenza, è predisposto a progredire
verso la personalizzazione ed in quanto tale si mostra con le caratteristiche dell’unicità,
dell’originalità, dell’irripetibilità. L’individuo è perciò vocato ad impegnarsi nel
processo di autoperfezionamento, ad attivare le proprie energie interiori per conseguire
significati onnicomprensivi”212
È questa la solitudine da rivalutare sotto l’aspetto pedagogico, perché è densa di
significati, è piena di valori, implica la progettazione. Essa ha due valenze fondamentali:
212 Id., p. 94
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
103
permette all’uomo contemporaneo di sottrarsi alla frenesia del mondo d’oggi e ne
favorisce la crescita personale.213
Al tema della solitudine si connette strettamente quello del silenzio. Per silenzio
non bisogna intendere l’assenza di parola e quindi di comunicazione, ma tutt’altro: esso
è pieno di significati. Il silenzio favorisce l’autocritica, che permette di individuare i
criteri operativi per migliorare se stesso. Questo movimento viene definito come silenzio
comunicativo intrapersonale e permette di far scoprire al soggetto qualcuno e qualcosa
da amare, in cui credere, adempiendo alla stessa funzione del dialogo. Il silenzio
comunicativo interpersonale, invece, è fatto di pause più o meno lunghe, dalle quali
scaturiscono disagi o intese, in base all’intimità del rapporto. Se, infatti, il silenzio sorge
tra due persone che non si conoscono, esso genera imbarazzo. Se, invece, si verifica tra
due coniugi o tra due amici, il silenzio si connota di valore e non viene vissuto come
disagio, ma anzi come momento di crescita personale e interpersonale.214
Recuperare la dimensione del silenzio, vuol dire dare tempo alla nostra mente di
creare idee, pensieri, che altrimenti non si potrebbero creare. L’uso delle moderne
tecnologie permea completamente la nostra vita, investendo anche ciò che di più umano
abbiamo: il pensiero.
Ma è nel silenzio che l’uomo coglie il senso dell’essere e dell’esistenza. Esso trascende
la conoscenza e permette all’uomo di compiere una ricerca del significato. Secondo la
definizione di Platone il pensiero è un dialogo senza voce tra me e me; pensare, quindi,
vuol dire ascoltare se stessi.
È attraverso il pensiero che si acquisisce la capacità di capire il senso della realtà e quindi
di valutarla e giudicarla, discernendo il bene dal male.215
Se l’uomo non riesce in questo, rischia di incorrere in seri rischi, tra cui quello di
creare un pensiero superficiale, un pensiero privo di fondamenta axiologiche, che si
riduce, sino ad annullarsi nell’immagine. Le conseguenze di questo tipo pensiero hanno
portato ai grandi drammi che caratterizzano i nostri libri di storia. Un esempio
rappresentativo di ciò a cui faccio riferimento, è quanto è successo durante la Seconda
Guerra Mondiale. Un evento che, sebbene sia conosciuto da tutti gli angoli della terra,
213 Id., pp. 223-227
214 Id., pp. 228- 229
215 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, pp. 197- 200
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
104
continua a suscitare domande di senso nella coscienza di quanti lo hanno vissuto,
direttamente o indirettamente, o ne sono venuti a conoscenza.
“La mia opinione è che il male non è mai ‘radicale’, ma soltanto estremo, e che
non possegga né la profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere
e devastare tutto il mondo perché cresce in superficie come un fungo. Esso sfida
come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità,
andare a radici, ed nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova
nulla. Questa è la sua “banalità” … solo il bene ha profondità e può essere
integrale”216
Questo è quanto ha affermato Hanna Arendt, in un passo celebre di una lettera inviata a
Gershom Scholem, dopo aver assistito al processo di Gerusalemme, in cui sono stati
incriminati e condannati i maggiori esponenti delle SS, fautori del più grande genocidio
europeo di tutti i tempi.
La Arendt afferma una cosa vera, spesso dimenticata. Il Male non è qualcosa
estremamente lontano dall’uomo, ma fa parte di lui. Il male, infatti, non è un’entità che si
impossessa dell’uomo, ma è ciò che si nasconde dietro la superficialità del pensiero e
nell’indifferenza. Bisogna risvegliare la coscienza soprattutto prendendo atto del rischio
che corriamo ogni volta che lasciamo correre questioni e situazioni importanti per l’uomo.
Ogni 27 gennaio ricorre la giornata della memoria e ogni anno si ribadisce quanto questa
sia importante perché non si ripetano più situazioni come quella dei campi di
concentramento o le leggi raziali. Si omette, però, a parer mio, di diffondere la
consapevolezza che Hitler o Himmler e tutte le SS più feroci, non erano uomini
straordinariamente cattivi, ma solo ordinariamente banali.
Bisogna diffondere la consapevolezza che il male risiede della mente di colui che non si
interroga sul perché degli eventi e soprattutto che non si interroga su cosa sia il bene o il
male. Per risvegliare le coscienze attraverso l’utilizzo della memoria, non serve far vedere
e rivedere le scene di quei poveri corpi straziati. Bisogna cominciare, invece, a parlare
del rischio che si corre quando permettiamo che delle immagini di eventi violenti e
catastrofici ci lascino indifferenti. Il silenzio e la solitudine, in questo caso, hanno la
216 H. ARENDT, La banalità del male, Milano 1964, pag. 75
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
105
valenza di scongiurare che si possano compiere atti privi di senso o guidati dall’istinto e
permettere all’uomo di poter gestire se stesso, in vista di un miglioramento.
Recuperare le dimensioni del silenzio e della solitudine, quindi, ha una doppia
valenza, sia per quanto riguarda le relazioni intrapersonali, che per quanto riguarda quelle
interpersonali, alle quali è dedicato il successivo paragrafo.
3.2.1. Comunicazione è relazione
Oggi si assiste a comunicazioni basate su una superficiale correttezza, dietro alla
quale, però, si nasconde indifferenza. Non solo. La maggior parte delle comunicazioni,
oggi, nascono, per ottenere una contropartita, che sia essa materiale (nel momento in cui
si conosce qualcuno che potrebbe servire per qualche secondo fine), che non materiale
(per avere approvazione sociale e riscuotere consenso). Come affermano Pati e Mounier,
nel momento in cui l’altro non è più visto come soggetto partner di relazioni interpersonali
-che chiede rispetto, aiuto e solidarietà- ma semplicemente come oggetto di nostro
possesso, atto a soddisfare i nostri desideri, l’alter diviene alienus e l’Io, a sua volta,
diviene estraneo a se stesso. “Qualora mancasse l’incontro dialogico interumano, anche
i valori perderebbero di senso”217 La comunicazione, infatti, oggi si è ridotta ad essere
mera chiacchiera, senza alcun senso e senza nemmeno la pretesa di averlo.218
Questa è la conseguenza di due fattori: da una parte, come abbiamo precedentemente
visto, c’è l’incapacità di comunicare con se stessi, dall’altra, la perdita del vero senso
della relazione con l’altro.
“La pedagogia della comunicazione si propone, quindi, di recuperare, nella dimensione
dialogico- relazionale, i significati personali ed i valori meta- temporali dell’esistenza
umana, che sembrano essere scomparsi dietro il baratro dell’inautenticità e del
solipsismo”219
Bisogna recuperare l’unità base della comunicazione, la diade, ovvero il sistema
a due soggetti legati tra loro in cui ognuno conserva la sua individualità.
Secondo Buber per entrare in relazione con qualcuno bisogna seguire due movimenti: “il
porsi in distanza e l’entrata in relazione.
217 L. PATI, op. cit., p. 100
218 Cfr G. ELIA, op. cit., p. 89-. 90
219 G. ELIA, A. RUBINI, op. cit., pp. 128- 129.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
106
Il primo è condizione dello stabilirsi del secondo, poiché l’uomo può intrecciare legami
con altri esseri simili a lui soltanto se li riconosce nella loro indipendenza. In tal caso la
relazione Io- Tu si consolida; se tale circostanza non si verifica, l’uomo tratta l’altro
come oggetto, pervenendo alla relazione Io- Esso”. 220
Secondo il teologo, entrambe sono fondamentali nella vita dell’uomo e spiegano
come l’Io non possa mai essere considerato da solo ma sempre in riferimento ad uno dei
due pronomi. Per Buber «all’inizio è la relazione»: già nei primi stadi della conoscenza,
non si ha la percezione immediata di un oggetto, ma l’atto preliminare è sempre teso a
stabilire una relazione con esso. L’uomo non può essere considerato in maniera isolata,
come ha fatto la gran parte della filosofia occidentale. Egli è continuamente in relazione,
tende alla comunicazione. Tutto lo sviluppo personale è contrassegnato dall’aspirazione
verso il Tu e soltanto essa dà consistenza all’Io e ne promuove la crescita: la persona
diventa tale nella misura in cui si apre all’alterità. Ciò non significa intenderla come un
fascio di relazioni ed esaurirla in esso, significa invece valutarla come un sistema attivo
di rapporti. “La comunicazione viene considerata come una realtà dell’uomo, una sua
dimensione, qualcosa che appartiene alla sua natura. L’uomo non può fare a meno di
comunicare, allo stesso modo in cui non può fare a meno di espletare le sue altre funzioni
vitali. Egli coglie se stesso in quanto uomo solo nel momento in cui si confronta e instaura
un rapporto con un tu, ed entrare in rapporto significa comunicare”.221
Secondo Buber il mondo si presenta sotto una duplice veste: c’è il mondo del Tu
e quello dell’Esso. Mentre nel rapporto Io- Esso, l’Io si rivela come individuo, nel
rapporto Io-Tu, egli si mostra come persona. Entrambi sono necessari all’esistenza del
singolo, senza il mondo dell’Esso l’uomo non potrebbe vivere, ma non può accontentarsi
di questo. L’uomo è colui che ha consapevolezza di sé stesso come realtà psico-fisica
distinta dalle altre individualità e mediante questo suo agire mira a creare le condizioni
atte a facilitare la sua vita. L’individuo diventa consapevole di essere un qualcosa di
definito, di preciso, di differente da tutto il resto.
Lo scopo della relazione è la sua stessa essenza, ovvero il contatto con il Tu. Per
Buber, però, non è possibile una netta distinzione tra individui e persone perché nessuno
è pura persona o puro individuo. La verità, come sempre, è nel mezzo. Quindi pur se tende
alla piena realizzazione della sua dimensione spirituale, la persona non può rinunciare
220 Cfr M. BUBER, Il principio dialogico ed altri saggi, San Paolo, Milano, 1993, pp. 15- 16
221 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., pp. 60- 61
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
107
alle proprie caratteristiche materiali. Non è quindi giusto distinguere l’essere dall’avere,
ma bisogna considerarle parti della stessa medaglia, in un’ottica inclusiva, non esclusiva.
Solo in questo modo si potrà recuperare il vero e autentico rapporto con l’avere, in vista
della necessità della sua presenza per costituire l’essere personale.222
Questa distinzione tra persona ed individuo ha portato la riflessione filosofica a schierarsi
su due opposti fronti, che a loro volta hanno influenzato il pensiero pedagogico: il
personalismo e l’individualismo. Secondo la definizione enciclopedica possiamo definire
personalismo:
“In generale, ogni concezione che affermi il valore assoluto della personalità
come principio esplicativo. In particolare, la dottrina di C. Renouvier affermante
la personalità quale categoria suprema e centro della concezione del mondo e la
dottrina di E. Mounier che, sul fondamento di una concezione cristiana e
cattolica dell’uomo, combatte sia l’individualismo astratto sia il collettivismo
assolutista, ponendo la persona umana come fine della vita associata.
A questo orientamento di Mounier, […] si collega il penziero pedagogico, che
postula una cultura educativa aperta ai valori classici e cristiani, al di fuori di
ogni nozionismo e tecnicismo, e preoccupata di promuovere intime certezze e di
svegliare l’impegno anche comunitario della persona.”223
Il termine persona ha radice dal greco πρόσωπον, letteralmente «volto»,
sineddoche che, attraverso l’indicazione di una sola parte, indica il tutto, cioè l’intero
uomo. In latino persona indica la funzione della maschera che, nel teatro classico, serviva
all’attore per far risuonare (per- sonare) la voce del personaggio, in rappresentanza delle
caratteristiche di quest’ultimo. Il termine rappresentanza, mutuato dal linguaggio etico-
giuridico, indica il parlare e l’agire a nome di un altro nella piena riconoscenza di colui
che viene rappresentato. La relazione esistente tra l’Io inteso come coscienza e corpo e
l’Io inteso come rappresentanza della persona intesa come maschera, sta nella
considerazione che il corpo costituisce un limite per il soggetto, in quanto la coscienza,
essendo situata (Husserl), in un corpo, è in grado di cogliere solo un aspetto, una parte
dell’oggetto che si guarda. Per questo si rende necessaria una de- situazione, per poi ri-
222 Cfr. L. PATI, op. cit., pp. 27- 31
223 Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/personalismo/
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
108
situarsi nel proprio corpo. È qui che risiede il nesso tra l’essere persona e la dimensione
relazionale: l’altro mi permette di superare i limiti del mio corpo e quindi di realizzare la
visualizzazione di un «oltre». Inoltre mi permette di riconoscere l’autenticazione dei punti
di vista altrui, come autentiche donazioni di senso.224
Quindi, mentre l’individualismo centra l’individuo su se stesso, il personalismo fa l’esatto
contrario: lo decentra da se stesso, per collocarlo in relazione con gli altri.
Secondo Levinas l’esistente, ovvero il singolo individuo, raggiunge il suo livello
massimo di esistenza quando depone la sua individualità e realizza la relazione con
l’Altro. L’incontro con l’altro avviene cercando il suo volto (visage), perché è nel volto
che vi è la traccia dell’Infinito o della Parola di Dio. Levinas afferma che: “il volto
dell’altro è la sua [di Dio] maniera di significare”. Perché è nel volto dell’altro, Dio si fa
evidente (Epifania del volto). Il volto dell’altro mi impone un atteggiamento etico, esso è
responsabilità, mi guarda e mi riguarda.
È proprio questa caratteristica che configura l’eticità della relazione con l’altro: l’incontro
con il volto dell’altro risveglia la nostra coscienza morale. Levinas pone al centro
dell’etica della relazionalità la responsabilità di accogliere l’altro, responsabilità che si
colloca al di fuori della sfera dell’Io e che presuppone la messa in discussione della
propria singolarità.225
Anche per Mounier, filosofo personalista, la comunicazione consente di uscire
dall’individualismo, caratterizzato dal ripiegamento dell’individuo su di sé, per passare
al personalismo, caratterizzato dal decentramento dell’individuo e la collocazione nelle
prospettive della persona, la cui manifestazione fondamentale è il continuo movimento
verso l’altro.226 Mounier evidenzia come l’esperienza fondamentale della persona sia la
comunicazione.
Ma in che modo avviene la comunicazione tra l’Io e il Tu?
Per vari studiosi la comunicazione interpersonale, poggia su di un previo rapporto
di relazione, che richiede un certo numero di interazioni, anche saltuarie, tra le persone
interessate. Ai fini di una positiva relazione è necessario che vi siano sequenze di
224 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op.cit., pp. 62- 64
225 Cfr ELIA G., A. RUBINI, op. cit., pp. 137- 138
226 Cfr ELIA G., op. cit., pp. 83- 85
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
109
interazioni contrassegnate da un dinamismo di scambio, per cui quelle passate influiscono
su quelle presenti, che a loro volta condizionano quelle future.227
Per far sì che si costruiscano relazioni sane e solide, è necessario riuscire a dedicare
all’altro del tempo. Un tempo che ha bisogno di rituali, di interazioni che implicano un
rapporto di vicinanza che non sia solo virtuale. A tal proposito è sempre attuale la storia
del Piccolo Principe e della volpe, di cui si seguito viene riportata una breve parte:
[…] “Non sei di queste parti, tu”, disse la volpe “che cosa cerchi?” “Cerco gli
uomini”, disse il Piccolo Principe. “Che cosa vuol dire addomesticare?”
“È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami” “Creare dei
legami?” “Certo”, disse la volpe. “Tu, fino ad ora per me, non sei che un
ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai
bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi.
Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell'altro. Tu sarai per me
unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo.” […]
“Che bisogna fare?” domandò il Piccolo Principe. “Bisogna essere molto
pazienti”, rispose la volpe. “In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così,
nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole
sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino”
Il Piccolo Principe ritornò l'indomani. “Sarebbe stato meglio ritornare alla
stessa ora”, disse la volpe. “Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle
quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà
la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad
inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io
non saprò mai a che ora prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti”. “Che cos'è un
rito?” disse il Piccolo Principe. “Anche questa è una cosa da tempo
dimenticata”, disse la volpe. “
È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore”.228
Antoine de Saint- Exupéry, in questo breve racconto del celeberrimo libro “Il Piccolo
Principe”, rivela con molta sensibilità e semplicità su cosa debba fondarsi una
227 Cfr. L. PATI, op. cit., p. 60
228 A. DE SAINT- EXUPÉRY, Il Piccolo Principe, Bompiani, 2000, pp. 64- 68
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
110
comunicazione realmente etica. Ci vogliono innanzitutto i riti, come afferma la volpe. Ci
vuole gradualità, ci vogliono attese, ci vogliono incontri. Tutto questo è quello che
perdiamo attraverso la comunicazione mediata: le attese vengono annullate, gli incontri
avvengono sui luoghi virtuali, si tende anche a far conoscere di sé più di quanto faremmo
conoscere dal vivo, grazie all’abbassamento delle inibizioni che comporta l’uso di un
medium.
Recuperare il vero senso della comunicazione, intra ed interpersonale, vorrà allora
dire anche recuperare quelle componenti fondamentali che possono contribuire a creare
relazioni durature e soprattutto vitali per l’essere umano. Vuol dire, quindi, che, per
quanto i mezzi attuali possano supportare le nostre relazioni, devono anche lasciar spazio
a quel tipo di interazioni e di gradualità che è tipico e proprio delle relazioni faccia a
faccia.
La Pedagogia della comunicazione sarà allora chiamata a salvaguardare queste forme di
incontro per permettere alla comunicazione mediata di non essere un surrogato della
comunicazione reale, ma un aiuto, un surplus costruttivo e non distruttivo di vere
relazioni.
Dopo aver visto le basi pedagogiche tradizionali, su cui bisogna sempre investire,
ora possiamo spostare l’attenzione su quei nuovi presupposti che entrano in gioco con
l’introduzione dei mezzi di comunicazione di massa e i new media.
3.3. Pedagogia dei media
“I mass media, la loro cultura, l’ambiente che essi contribuiscono a formare,
costituiscono oggi altrettante interpellazioni di fronte alle quali l’educazione non può
che interrogarsi. Lo si può affermare se si pone attenzione a tre semplici dati: il fatto che
essi occupino gran parte del tempo sociale dei soggetti in età formativa, che i mercati li
prevedano tra le competenze del personale qualificato che si apprestano ad arruolare,
che la scuola, agenzia educativa tradizionale e per antonomasia, lasci registrare nei loro
confronti un certo disagio”229
I media godono di un vero e proprio protagonismo culturale ed educativo, che si
esprime sia in termini quantitativi, che qualitativi. Questi ultimi sono caratterizzati non
tanto dall’orientamento operato dai media, verso determinati comportamenti e\o consumi,
229 L. MASTERMAN, A scuola dei Media, a cura di P.C. RIVOLTELLA, La Scuola, Brescia, 1997, pp. 5- 6
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
111
quanto dalla trasformazione “ecologica” del sistema socio- culturale vigente. Essi
promuovono l’innescamento di una serie di cambiamenti, “vere e proprie mutazioni
culturali”230 che stanno stravolgendo il nostro mondo. Tali cambiamenti si iscrivono
soprattutto nell’area cognitiva. I Media, in particolar modo i nuovi media, si collocano in
controtendenza rispetto alla cultura tradizionale, basata sulla conoscenza concettuale ed
astrattiva, che ha caratterizzato l’Occidente sin dall’avvento della scrittura, proponendo
un nuovo modello cognitivo basato sulla centralità dell’immagine, e quindi segnato dalle
leggi dell’associazione e dell’analogia.
Questa situazione ha creato confusione nella paideia tradizionale, soprattutto in
relazione alle agenzie preposte alla trasmissione dei saperi. In passato la scuola possedeva
una posizione di indiscussa centralità nella trasmissione e nel controllo del sapere. Con
l’avvento dei Media tale situazione è cambiata: la scuola perde di rilevanza ed è costretta
a confrontarsi con una nuova agenzia formativa, definita da diversi autori come “scuola
parallela”.231 “La “scuola parallela” è costituita dall’insieme di circuiti grazie ai quali
gli allievi […] ricevono al di fuori della scuola, informazioni, conoscenze, una certa
formazione culturale nei più svariati settori. Gli strumenti della scuola parallela sono
quelli delle comunicazioni di massa, cioè i mass media […] Qualunque opinione si
professi nei loro riguardi, il problema pedagogico che essi pongono non può essere
trascurato”232. Sebbene con largo anticipo sui tempi e prima della comparsa dei new
media (che hanno accentuato maggiormente questa situazione), il monito di Porcher oggi
è più che attuale. Benché non sia stato il primo libro a trattare le ricadute educative
dell’audiovisivo o della cultura di massa, questo testo ha il merito di porre il problema
della rapporto tra due mondi: quello della scuola e dell’educazione, da una parte, e quello
dei media dall’altra. Due mondi distanti e spesso percepiti come antagonisti.233
Possiamo identificare due modi in cui la scuola ha deciso di reagire a questa
condizione parallela234. Entrambi comportato dei rischi e sono suscettibili di critiche:
230 G. MANTOVANI, Comunicazione e identità, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 102
231Cfr L. MASTERMAN, op. cit., pp. 6-9
232 L. PORCHER, La scuola parallela, La Scuola, Brescia, 1976, p. 5
233 Cfr D. FELINI, op. cit., p. 15
234 Cfr L. MASTERMAN, op. cit., pp. 10- 11
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
112
- Un primo atteggiamento è quello dell’impotenza al cambiamento che si traduce
nell’accentuarsi del ritardo delle sue pratiche e programmi, rispetto alla situazione
attuale. Masterman individua due argomenti in base ai quali la scuola intende
giustificare tale situazione di stallo: da una parte c’è l’«argomento del tempo che
manca», giustificato dalla complessità della gestione dei mezzi di comunicazione
in classe, che risulterebbe incompatibile con l’onerosità dei programmi da
svolgere. Il secondo argomento è quello della «difesa della cultura», secondo il
quale l’esclusione dei media è un atteggiamento voluto al fine di salvaguardare la
“cultura alta”, di cui la scuola è gelosa custode.
- Il secondo atteggiamento è completamente opposto al primo e lo potremmo
definire come avanguardismo tecnologico. Consiste, infatti, nell’introduzione
selvaggia e priva di criterio, di tutti i mezzi tecnologici più nuovi e a stravolgere
la didattica all’insegna di uno sperimentalismo selvaggio. Tale situazione è
altrettanto rischiosa, quando la prima, in quanto, sebbene sia portatrice di
innovazione all’interno del circuito scolastico, la fa senza discernimento e
moderazione. Inoltre, in questo modo, non si promuove un buon utilizzo dei mezzi
tecnici, ma piuttosto un mero addestramento.
Sebbene esistano oggi delle situazioni diverse da quelle sopra descritte, di certo non
possiamo pensare che la scuola italiana sia media oriented, né tantomeno preparata per
quanto riguarda il tema dell’educazione ai media.
Ma se si perpetuasse in questa situazione, si rischierebbe di “emarginare l’identità
culturale di bambini- e più in generale degli alunni- che vivono e respirano dentro questo
universo di messaggi, di codici, di culture, di modelli di comportamento”235, obbligandoli
a riconoscersi in culture ormai obsolete.
Per questo motivo è necessario che si inseriscano nella società, in modo altrettanto
protagonistico come quello dei Media, scienze che si occupino del modo migliore per
integrare la telematica in un positivo sviluppo integrale della persona. È qui che si
inserisce la Pedagogia dei Media, “[…] pensata, a sua volta, come quell’ambito
trasversale di ricerca che si genera dall’incontro tra educazione, media e tecnologie e
vive, appunto, una relazione privilegiata con le scienze della comunicazione”236.
235 F. FRABBONI, Il libro di pedagogia e didattica, Laterza, Bari, 1998, vol. II, p. 132
236 P.C. RIVOLTELLA, Media education, La Scuola, Brescia, 2005, p. 55
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
113
Sebbene questa disciplina non sia stata istituzionalmente riconosciuta, nonostante se ne
ammetta l’importanza (anche a causa delle continue resistenze ad opera degli
“apocalittici”), sarà l’oggetto chiave di questa trattazione, proprio in virtù del bisogno, da
più parti sentito, di un sostegno educativo circa la mediazione dei media. “Riflettere sullo
sviluppo delle tecnologie della comunicazione significa, allora, riflettere
sull’avvicendarsi dei paradigmi pedagogici, sulla costante ridefinizione dei ruoli
educativi, sulla trasformazione dei metodi e degli strumenti che sono a servizio della
didattica”.237
Prima di iniziare con la descrizione dello statuto epistemologico della Pedagogia
dei Media, mi sembra doveroso far riferimento alla definizione fatta da Calvani, di questa
disciplina: “l’intero settore delle problematiche educative connesse all’uso dei media in
contesti formativi, nella sua dimensione più estesa; includiamo quindi in questo termine
l’insieme dei diversi indirizzi della ricerca educativa interessati al rapporto tra media ed
educazione”.238 L’autore, nel suo testo “Educazione, comunicazione e nuovi media”
mostra come la Pedagogia dei Media sia costituita da tre tipologie di educazione (ai
media, coi media, nei media)239 e di come essa abbia un forte connotato transdisciplinare
(Figura 5).
237 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, p. 128
238 A. CALVANI, op. cit., p. 59
239 Id., pp. 59- 63
FIGURA 5- PEDAGOGIA DEI MEDIA E
AREE TRANSDISCIPLINARI
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
114
La Pedagogia dei Media, quindi, attinge i suoi saperi costitutivi da quattro ambiti
fondamentali:
La dimensione tecnica (tecnologia dei media), che riguarda l’ingegneria di
supporto dei dispositivi e dei media, canali di trasmissione, l’hardware, linguaggi,
ambienti e software e il management delle informazioni.
La dimensione comunicativa, che riguarda i linguaggi dei media (semiotica), di
interesse prevalentemente comunicativo, le dinamiche relazionali (attività svolte,
forme di comunicazione, interazione uomo- macchina), i risultati dell’impiego dei
mezzi di comunicazione (programmi televisivi ecc.), contesto sociale di fruizione-
condivisione dei media, l’impatto dei media nella società (aspetto sociologico e
antropologico), le organizzazioni fondamentali per la produzione e la diffusione
dei media.
La dimensione didattica e costruttivistica, ovvero i concetti fondamentali della
didattica applicata agli ambienti di apprendimento, nuove pratiche di
autoformazione.
La dimensione critico- sociale, che riguarda la Pedagogia dei Media nelle sue
implicazioni ideologiche e negli effetti sul comportamento giovanile.
La Pedagogia dei Media mette, dunque, al centro dei propri interessi lo studio delle
relazioni soggetto- media nelle loro implicazioni formative, che potremmo
distinguere, come affermato precedentemente, in educazione nei, ai, coi media:
o Educazione nei media, concentra l’attenzione sul soggetto e sulle modalità di
fruizione, così come queste si vengono diffondendo. Come il rapporto con
cinema, televisione, computer, Internet modificano comportamenti,
atteggiamenti e le forme di pensiero delle nuove generazioni?
o Educazione ai media, in cui si sposta l’attenzione ai media come obiettivo del
percorso educativo stesso, vedendo, quindi, nella conoscenza tecnologica
l’oggetto del progetto educativo. In questo ambito ci si occuperà di definire i
concetti di alfabetizzazione o educazione tecnologica o di competenza
mediale, nozioni soggette a continue revisioni in funzione dei rapidi
cambiamenti delle tecnologie contemporanee, e di indicare chi e come deve
farsi carico di sviluppare queste conoscenze e competenze.
o Educazione con i media, considera i media come uno strumento che può
variamente arricchire il processo formativo del soggetto.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
115
Possiamo identificare le connotazioni prevalenti di questo ambito della
Pedagogia dei Media in ordine a quattro tipologie: studiare gli aspetti della
comunicazione educativa e come questa possa essere potenziata da apparecchi
tecnologici; costruire e sperimentare percorsi articolati o ambienti di
apprendimento potenziati dai media (istruzione programmata); migliorare le
interfacce in modo da garantire le potenzialità di apprendimento e infine
allestire oggetti, prodotti comunicativi a carattere educativo di intrattenimento
formativo (software didattici, videogiochi, trasmissioni televisive per ragazzi
ecc.).
3.3.1. Il campo della pedagogia dei media e ambiti di ricerca
La pedagogia dei media è, quindi, “quell’area della pedagogia che, in termini
interpretativi e progettuali, si occupa di studiare il campo delle relazioni intercorrenti
tra educatore, educando e strumenti\linguaggi mediali”.240
In pedagogia l’unità d’indagine, l’atomo logico su cui si riconduce il discorso interno è il
rapporto, in quanto questa scienza ha come punto di focalizzazione proprio il fenomeno
educativo visto come relazionale e sistemico. Nel caso della Pedagogia dei Media, non
possiamo limitarci a considerare il rapporto tra educatore ed educando, perché qui la
relazione è triadica: alle due polarità consuete si aggiunge quella dei media. Il considerare
i media come terzo soggetto dell’azione educativa comporta non trattarli né come
elemento ambientale o di contesto entro cui si svolge l’attività educativa, né come un
semplice contenuto di istruzioni. Essi, infatti hanno diverse funzioni che mettono in gioco
all’interno di questa relazione triadica:241
- Funzione attiva o formativa, in quanto essi hanno la capacità di trasmettere
messaggi, fornire modelli di comportamento, mettere in risalto opinioni e valori e
così via; questa è, appunto, una capacità genericamente formativa dei media.
L’educazione attuata dai media, però, non è intenzionale come quella che avviene
tra educatore ed educando perché l’emittente non si prefigge un intento formativo
esplicito e dichiarato nei confronti del ricevente, così come non c’è la scelta di
obiettivi e valori a cui ispirarsi. Inoltre c’è un’indubbia disparità tra il sistema
delle comunicazioni sociali ed il pubblico. Nel caso dei media, però, questa
240 D. FELINI, op. cit., p. 157
241 Cfr Id., pp. 157- 161
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
116
asimmetria è generata dal fatto che essi detengono il potere di distribuire in
maniera più capillare i messaggi, rispetto ad un singolo e hanno una grande
capacità di agire a livello macrosociale. Tuttavia a questa situazione asimmetrica
non corrisponde un maggiore presa di responsabilità da parte di essi.
- Funzione riflettente, questa funzione viene attivata in base alle concezione che,
dei media, hanno gli adulti che poi “rimbalzano” sui membri giovani della
comunità.
I media hanno una funzione riflettente perché sono l’oggetto di una sorta di
rispecchiamento di ciò che il gruppo sociale ha elaborato. Anche in questo caso il
rapporto tra educatore ed educando non è intenzionale, tanto che, correttamente,
è stato usato il termine di socializzazione.
- Funzione di tipo strumentale, ovvero quando i media divengono i veicoli di un
messaggio formativo. L’educatore, in questo caso, non è costituito dai media
stessi ma vengono scelti da un agente educatore (insegnante, genitore, catechista)
per agevolare la trasmissione di un messaggio o per veicolare un particolare
contenuto: i media entrano nel rapporto educativo con funzioni di supporto o di
facilitazione.
- Funzione oggettuale, questo è il caso dell’Educazione ai Media, all’interno della
quale i mezzi di comunicazione costituiscono il contenuto dell’intervento.
A seguito dell’individuazione delle funzioni che i media possono assumere all’interno
della triade educativa, possiamo identificare cinque direzioni di ricerca e di interesse per
la Pedagogia dei Media. In primo luogo c’è l’Educazione ai Media, di cui parlerò più
avanti, in secondo luogo la Socializzazione ai media che, essendo l’introduzione dei più
piccoli non intenzionale al modo di intendere e fare uso dei media, è in qualche modo
l’altra faccia (quella più spontanea e meno studiata) dell’educazione ai media. Un terzo
ambito è quello delle Tecnologie didattiche, relativo all’impiego degli strumenti mediali
all’interno dei processi educativi; l’Ergonomia dei media, con la quale è possibile
progettare interventi educativi con l’ausilio dei media, sia quelli più specificatamente
didattici, sia quelli a scopo ludico e di Edutainment rivolti a bambini e ragazzi (programmi
televisivi, siti Internet ecc.). Infine troviamo l’ambito della Pedagogia sociale dei media,
attenta a studiare a livello macro i fenomeni che riguardano il triangolo
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
117
educando\educatori\media, soprattutto in termini di prospettazione di una società
educante attenta al tema delle comunicazioni sociali in rapporto ai minori.242
3.4. Educazione ai media
Come abbiamo precedentemente visto, i campi della Pedagogia dei Media sono
molteplici. Tornando, per un attimo, al concetto di paideia, possiamo identificare
all’interno della Pedagogia dei Media, le tre componenti costitutive in essa presenti:
istruzione (Educazione con i media), formazione (Educazione per i media) ed infine
educazione vera e propria (Educazione ai media).
In quest’ultima parte della tesi verrà approfondito solo uno di questi, l’Educazione ai
Media, ritenuta l’ambito centrale su cui la Pedagogia del ventunesimo secolo deve
maggiormente investire, al fine di poter realmente garantire uno sviluppo umanizzante
della società.
L’educazione ai media ha lo scopo di informare su tutto ciò che si cela dietro ai
media, ma soprattutto ha il compito di formare la coscienza di chi li utilizza, per non farla
“assopire”243. Solo così si potrà dare valore al contenuto della comunicazione.
Oggi, infatti, ciò su cui si concentra la formazione è il medium, ma non il messaggio; il
mezzo ma non il contenuto. Ma il medium non può sostituire il messaggio, il quale ha
una sua strutturazione, un suo valore e significato, che va al di là del mezzo. Il medium è
ormai divenuto estensione del nostro corpo. Mentre l’etica della comunicazione consente
di compiere un discernimento etico, fondamentale per non permettere l’alienazione
dell’uomo, la pedagogia dei media, in particolare con l’educazione ai media, permette di
poter individuare le linee d’azione per poter rendere i soggetti consapevoli dei rischi e
delle possibilità dell’utilizzo del medium.244
Si precisa che in questa trattazione i termini di educazione ai media e di Media
Education verranno utilizzati in modo equivalente, sebbene vi siano pareri discordi su
questa corrispondenza (nei paesi anglosassoni con il termine Media Education si indica
242 Cfr Id., pp. 162- 163
243 Oggi, a tal riguardo, mi sembra sempre più attuale il quadro di Francisco Goya, intitolato “Il sonno della
ragione genera mostri”, raffigurante un uomo che, mentre dorme, viene circondato da mostri. Questa frase,
sebbene inizialmente dedicata all’uscita dell’umanesimo dal periodo buio del Medioevo, oggi potremmo
ricondurla proprio alla situazione di chi, preso dal sogno di un utilizzo meramente positivo dei media,
spegne la propria mente e non si chiede verso che direzione questo utilizzo lo sta portando.
244 Cfr. F. BELLINO, op. cit., 2010, pp. 77- 81
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
118
la ricerca educativa in ambito dei media, e quindi in un certo senso incorpora in essa la
Pedagogia dei Media).
Sebbene io sia concorde con la posizione di Felini che riconosce l’ambiguità del termine
inglese, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo che di esso si è fatto in Italia 245 ,
considererò, come già affermato precedentemente, i termini come sinonimici.
3.4.1. Modelli e luoghi per un'educazione ai media
Dal punto di vista pedagogico è possibile classificare le pratiche di educazione ai
media mettendo in luce l’intreccio tra le differenti finalità educative perseguite e le
metodologie didattiche utilizzate. In base a questo presupposto possiamo individuare tre
modelli di educazione ai media:
I. Educazione ai media come educazione alla comprensione. Questo primo modello
è quello più diffuso e mette al centro dell’attività didattica lo scopo di aiutare i
ragazzi a capire più a fondo la realtà mediale, sia nei suoi aspetti testuali
(comprensione del testo e dei suoi significati, dei generi, delle possibili
interpretazioni dei messaggi nascosti), sia in quelli di sistema (tecniche di
produzione, il mercato dei media, l’organizzazione delle istituzioni emittenti,
modalità di recezione da parte del pubblico).
II. Educazione ai media come educazione alla fruizione. Accanto al modello della
comprensione possiamo individuare il modello legato alle metodologie di analisi
del consumo. Con questa espressione si intendono tutti quegli interventi che
mettono al centro la situazione reale in cui si svolge l’utilizzo dei media da parte
del pubblico ed hanno come finalità educative quelle di rendere consapevoli gli
utenti stessi della loro fruizione mediale al fine di favorire l’assunzione di
comportamenti più adeguati. Queste pratiche si sono diffuse, da una parte a
seguito della preoccupazione della società adulta di fronte alla crescita
indisturbata del consumo televisivo da parte dei minori e, dall’altra, grazie alla
diffusione delle tecniche di analisi del consumo mutuate dall’etno- antropologia.
Questo tipo di educazione permette al ragazzo di riflettere direttamente sui propri
vissuti relativi a quel mezzo, provocando una conoscenza metamediale, secondo
un percorso che passa dalla consapevolezza di sé alla scelta responsabile.
245 Per un maggior approfondimento sul tema: Cfr D. FELINI, op. cit., pp. 145- 157
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
119
III. Educazione ai media come educazione alla produzione. Questo terzo modello è
molto praticato perché mette al centro attività di produzione mediale. Si tratta di
far realizzare ad allievi messaggi costruiti sull’esempio e con le tecniche dei
prodotti della radio, della televisione o della carta stampata; attività scelte dagli
educatori per il loro potenziale sviluppo della creatività intento espressivo o per
offrire agli strumenti per una maggiore partecipazione democratica nell’arena
massmediale (intento liberatorio). I prodotti mediali che oggi più riscontrano
l’apprezzamento degli educatori sono ancora il giornalino scolastico tradizionale,
il video e gli ipertesti multimediali realizzati al computer.
Una volta individuati i modelli per un’educazione mediale, è importante anche
individuare i luoghi all’interno dei quali tali modelli devono essere messi in pratica,
partendo da un assunto ormai acquisito: “[…] anzitutto che l’educazione non possa fare
a meno di occuparsi dei media; in secondo luogo che sia in particolare la scuola, tra le
diverse agenzie educative, a farlo- anche se evidentemente questo non significa che la
famiglia, come la società adulta, rimangano escluse da questo tipo di discorso”.246
Quindi, seguendo l’indicazione di Masterman, possiamo identificare tre luoghi per
un’educazione ai media: la famiglia, la scuola e il territorio. Essi intersecano, senza
sovrapporsi i tre modelli dell’educazione ai media.
Il primo luogo deputato per l’educazione delle nuove generazioni è la famiglia.
All’interno di essa, infatti, si fa largo la prospettiva del governo familiare della
televisione, o di qualunque mezzo mediale. Per governo famigliare della televisione e dei
media si intende innanzitutto l’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nel
guidare i figli ad un uso corretto delle tecnologie della comunicazione. Questa assunzione
di responsabilità è del tutto congruente rispetto al compito educativo genitoriale ed è
particolarmente efficace perché si può esercitare in due momenti: quello dell’infanzia,
cioè quando i bambini cominciano la socializzazione ai media e sono maggiormente
ricettivi rispetto alle concezioni che si hanno su questi strumenti; e il momento del tempo
libero, durante il quale i bambini hanno accesso alla tv, ai videogiochi, a Internet.
In secondo luogo il governo famigliare della televisione e dei media significa riconoscere
il ruolo dei media nelle dinamiche di relazione famigliare, così anche delle dinamiche
familiari nella fruizione dei media. Ad esempio, la televisione talvolta viene considerata
come stimolo per dar vita a discussioni e occasioni proficue di scambio, altre volte assume
246 L. MASTERMAN, op. cit., p. 12
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
120
la forma di catalizzatrice di tutte le attenzioni, annullando ogni forma di relazione. In
questo senso possiamo considerare maggiormente pericolosi i telefonini e i tablet, in
quanto soggetti all’utilizzo del singolo e di proprietà di esso. In questo caso la prospettiva
del governo famigliare dei media significa una gestione comunitaria degli strumenti e
delle loro possibilità di informazione e intrattenimento.
Il secondo luogo deputato all’educazione ai media è il territorio, costituito da
associazioni, consultori, parrocchie o scuole. Questo secondo soggetto apre la possibilità
della fattibilità dell’educazione ai media nel territorio. Esso può costituirsi come luogo di
una lifelong learning (educazione ai media in tutto il ciclo di vita) che riguarda tutti gli
ambiti educativi informali: dagli oratori, alle associazioni, gruppi, cooperative ecc.
Infine l’ultimo luogo incaricato di realizzare un’educazione ai media è la scuola.
Sebbene i ragazzi vivano l’esperienza più pregnante dei media nella vita extrascolastica,
la scuola può essere molto importante in quest’operazione di educazione. Come abbiamo
visto precedentemente non sono poche le resistenze che la scuola, soprattutto in Italia,
incontra nell’incorporare, all’interno dei suoi insegnamenti, anche quelli relativi ai media.
Parlare di educazione ai media in ambito scolastico vuol dire anche porsi il problema
della sua curricolarizzazione. Questo non vuol dire pensare all’istituzione di un’apposita
disciplina, ma prevedere all’interno della programmazione scolastica, moduli, incontri,
laboratori che abbiano ad oggetto i media e il rapporto che i ragazzi instaurano con essi.247
“Un’attenzione pedagogica alla realtà mediatica, a ben vedere, non manca
neppure nella realtà italiana, ma essa rimane […] condizionata da alcuni limiti
importanti: nel caso dell’educazione formale, il fatto di essere consegnata alla
creatività ed alla intraprendenza dei singoli, più che sostenersi sulla
progettazione e la legislazione a livello istituzionale; nel caso dell’educazione
informale, invece, l’assenza di coordinamento tra enti, gruppi e associazioni che
operano nel campo dell’educazione massmediale, spesso purtroppo senza una
competenza adeguata (od un sufficiente aggiornamento scientifico p) per
farlo”248
247 Cfr D. FELINI, op. cit., pp. 38- 49
248 L. MASTERMAN, op. cit., p. 12
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
121
Questo implica, a mio parere, che gli insegnanti e la scuola in generale, comincino a
considerarsi non dei meri trasmettitori di conoscenze e saperi, ma degli educatori che,
primo fra tutti, hanno il compito di condurre il ragazzo verso il suo pieno compimento
come persona, prima ancora che come alunno.
Ciò comporta, al tempo stesso, una riforma base della scuola in senso generale, che
riprenda l’importanza della triade educazione, istruzione e formazione e punti a tutti
questi ambiti e non semplicemente all’istruzione. È necessario, infine, che la scuola
italiana soprattutto diventi non solo luogo in cui si creino delle “teste ben fatte” ma anche
luogo in cui ci si possa preparare per vivere nel modo migliore il mondo che c’è al di
fuori, al quale i ragazzi che oggi escono dalla scuola non sono per niente preparati. C’è
bisogno che la scuola comincia ad adeguarsi, mantenendo ben saldi i principi su cui è
costituita, alle richieste di senso che provengono dal di fuori e cominci ad essere
un’istituzione integrata nella società e non da essa avulsa.
3.4.2. Obiettivi dell’educazione ai media
“L’educazione ai media è, prima di tutto, un’azione educativa nel senso forte del
termine, dato che gli obiettivi, intrisi di umanesimo, sono di formare persone più
autonome e più lucide”.249 Il macro obiettivo dell’educazione ai media è quello di far sì
che l’influenza dei mezzi di comunicazione sociale rientrino, in qualche modo, in un
piano di intenzionalità educativa, affidando un senso alla loro presenza e rendendoli
oggetto di un intervento di formazione personalizzante.250
Len Masterman, nel suo celebre testo “Teaching the Media” descrive gli otto
principi base della Media Education (ME):251
1. Il concetto principale della Media Education è quello di rappresentazione: i
media non riflettono la realtà, ma la rappresentano- essi, infatti, sono sistemi
simbolici o segnici. Se i media fossero come delle “finestre sul mondo” o
riflettessero la realtà, studiarli sarebbe superfluo come studiare una lastra di vetro.
Non si studierebbero i media in sé e per sé, ma solo gli argomenti e i contenuti
che essi veicolano (es. sport, notizie, fiction). Lo studio dei media deve essere
249 L. GIROUX, Introduction, in: J. PIETTE, Éducation aux medias et function critique, L’Harmattan, Paris-
Montréal 1996, p. 8
250 Cfr D. FELINI, op. cit., pp. 191-192
251 L. MASTERMAN, op. cit., pp. 71-76
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
122
basato sull’assunto che essi non sono trasparenti, ma anzi sono capaci di
modellare il contenuto dandogli certe forme caratteristiche.
2. Uno degli obiettivi fondamentali della Media Education è quello di smascherare
la falsa naturalezza dei media, rivelandone la natura di costrutto attraverso lo
studio delle questioni relative alla produzione e quelle relative all’impatto
ideologico delle costruzioni mediali presentate come “buon senso”, delle diverse
modalità con cui il pubblico legge e reagisce dinanzi al contenuto mediale.
3. La ME è principalmente investigativa. Non cerca di imporre valori culturali
specifici, mira piuttosto ad accrescere la comprensione degli studenti sui modi in
cui i media rappresentano la realtà. L’obiettivo è quello di produrre cittadini ben
informati che sappiano formulare i loro giudizi di valore, incoraggiando gli
studenti ad esplorare l’insieme dei giudizi riguardanti un dato testo esaminandone
le fonti e gli effetti.
4. La ME si costruisce attorno ad alcuni concetti-chiave considerati come strumenti
di analisi e non come contenuto alternativo. Le prime forme di ME erano basate
sull’analisi del contenuto dei testi. Il problema principale di questo metodo
nasceva dal fatto che nello studiare i diversi media venivano impiegati principi,
concetti e modalità di investigazione diversi e solo quando ci si rese conto di
quanto fosse importante trovare per la ME una propria specificità concettuale e
metodologica essa cominciò ad imporsi come area di studio.
5. La ME è un processo a lungo termine che dura tutta la vita. I mezzi di
comunicazione sono l’interesse principale per i bambini fin dalla prima età e
durano per tutta la vita adulta.
6. La ME mira a raggiungere non solo la comprensione critica, ma anche
l’autonomia critica. Questo obiettivo produce delle importanti conseguenze sul
piano dei contenuti dei corsi, delle metodologie didattiche e della valutazione.
Non è sufficiente rielaborare o riprodurre le idee e le informazioni che si ricevono,
si deve piuttosto puntare a creare negli educandi la capacità e la volontà di
praticare un’autonomia critica anche al di fuori del contesto scolastico.
7. L’efficacia della media education può essere valutata sulla base di due criteri
generali: la capacità di applicare ciò che si conosce (idee e principi critici) a
situazioni nuove ei l grado di impegno, interesse e motivazione dimostrato.
8. La Media Education parte sempre dall’attualità, ovvero cerca sempre di
illuminare le situazioni della vita quotidiana sfruttando l’interesse e l’entusiasmo
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
123
suscitato dagli eventi di attualità riportati dai media. La ME usa a scopo educativo
la grande quantità di materiali e di risorse offerta dai media, ma non deve limitarsi
all’attualità, deve piuttosto usarla per aprire quelle prospettive politiche e storiche
di più ampio respiro che i media in genere ignorano e per esplorare mondi più
vasti (storia, cultura, religione, problemi della giustizia, della pace, del mondo in
generale).
Da tali obiettivi si possono identificare delle aree di ricerca- azione, identificate da Felini
nel suo testo “Pedagogia dei media. Questioni, percorsi e sviluppi”, di cui si farà una
sintetica disamina nei paragrafi successivi.
3.4.2.1. Senso critico
Uno degli obiettivi più ricorrenti nel campo dell’educazione ai media è quello
dello sviluppo del senso critico. In pedagogia dei media quando si parla di pensiero critico
ci si riferisce ad una capacità, non innata ma educabile, di reagire attivamente ai messaggi
dei mezzi di comunicazione di massa, di contro ad una fruizione passiva ed incapace di
distanziamento.
Per far sì che lo sviluppo del senso critico non diventi una mera polemizzazione
su tutto ciò che accade, deve essere accompagnato da un percorso di educazione ai valori
che consenta al soggetto di confrontare le proposte dei media con un progetto di vita. Le
attività di educazione ai media, quindi possono contribuire allo sviluppo del senso critico
anche solo facendo in modo che i ragazzi si accorgano che dietro i messaggi dei media ci
sono delle filosofie di vita nascoste che devono essere vagliate facendo riferimento ad un
opportuno termine di paragone, ovvero una propria concezione del mondo. Inoltre
l’educazione allo sviluppo di un senso critico nei ragazzi vede il pensiero critico come
attività di questioning, ovvero di continuo porsi domande su tutto ciò che arriva ai ragazzi
sotto forma di messaggi subliminali da pubblicità, film, fiction e quant’altro.
Quest’azione di presa di coscienza ha anche la grande valenza di eludere il rischio che si
creino nella mente dei ragazzi, falsi miti ed ideologie che spesso i media contribuiscono
a creare.
Si è affermato che l’ingresso nella modernità abbia comportato la scomparsa dei
miti. Innanzitutto vorrei specificare quale accezione utilizzerò nell’utilizzare la parola
“mito”. Secondo il vocabolario della lingua italiana, il mito è un “fatto esemplarmente
idealizzato in corrispondenza di una carica di eccezionale e diffusa partecipazione
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
124
fantastica o religiosa”252. Considererò, quindi, come facente parte di tale definizione, non
solo le ideologie politiche, ma anche quelle connesse alla religione, in particolare quella
cattolica. Riprendo, a tal fine, una definizione fornita da Mircea Eliade, storico delle
religioni, che afferma che “[…] il mito è considerato come una storia sacra e quindi una
«storia vera», perché si riferisce sempre a delle realtà”. 253
Dopo queste precisazioni, torno a quanto precedentemente affermato sull’eclissi dei miti.
A ben guardare, e basandoci anche sulla situazione attuale, ritengo che questa
affermazione sia vera a metà. È sì vero, infatti, che sono cadute le antiche ideologie, quelle
su cui erano fondate originariamente le società, ma è anche vero che l’uomo, con il tempo,
le ha sostituite con altre. In realtà, ciò che è accaduto, non è una vera e propria scomparsa
del mito, ma solo delle regole vincolanti che questo impartiva. Se pensiamo alle vecchie
ideologie politiche o alle regole della religione cattolica (oggi molto contestate), coloro
che si definivano appartenenti ad una di esse, giustificavano tale adesione con
l’assunzione di comportamenti strettamente legati alle regole morali che tale
appartenenza comportava.
Si assiste oggi, non ad un’assenza di miti- ve ne sono anche fin troppi- bensì ad
un’assenza di regole etiche che, per quanto limitanti e a volte oppressive, permettevano
di avere un codice comportamentale (e morale) da seguire. I nuovi miti non sono portatori
di regole morali, intrinsecamente dotate di senso, fondate su una verità, per quanto
oggettiva. Sono semplici esplicitazioni dei vizi umani, che viaggiano nel mare del non-
senso.
Il pensiero critico, “[…] potrebbe rivolgersi a quel pensiero diffuso, irriflesso e
ideologico, la cui matrice è proprio in una certa forma di comunicazione mediatica”254
quindi, connesso all’educazione ai valori di cui la nostra società è portatrice, porterebbe
all’ eliminare questa situazione, o comunque ad una sua riduzione, a favore di un tipo di
pensiero libero, poiché non vincolato da regole imposte, e al tempo stesso moralmente
fondato, poiché riferito ad un orizzonte axiologico.255
252 G. DEVOTO, G. C. OLI, Vocabolario illustrato della lingua italiana, Selezione dal Reader’s Digest,
Milano, 1983, Vol. II, p. 148
253 M. ELIADE, Mito e realtà, Borla, Torino, 1966, p. 28
254 D. FELINI, op. cit., p. 199
255Id., pp. 193-199
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
125
3.4.2.2. Educazione alla salute
Il nesso tra salute e media è molto forte ma spesso non spontaneo. Se però si
pensare quanto all’interno di testi di canzoni, o di pubblicità oppure ancora di film o
fiction, si faccia vedere come non solo l’utilizzo di alcol, tabacco e droghe sia “normale”
ma anche indolore, divertente e privo di pericoli, si riesce a capire anche perché questi
due aspetti siano strettamente legati.
L’educazione ai media può rientrare in un discorso di educazione alla salute inserendosi
almeno su quattro temi rilevanti per l’educazione di preadolescenti, adolescenti e giovani:
l’abuso di sostanze che creano dipendenza (alcol, tabacco, droghe), i disturbi alimentari
(anoressia, bulimia, obesità), l’attività sessuale precoce e non protetta e, infine, la
promozione di una sana attività sportiva.
L’efficacia dell’educazione ai media in questo ambito consiste soprattutto nell’aiutare il
soggetto a riconoscere e a prendere coscienza dell’influenza sociale che hanno i media
sul proprio agire.
Secondo la lettura che fanno gli esperti di educazione sanitaria a livello ambientale
di convinzioni che facilitano il diffondersi di comportamenti contrari alla salute è da
considerarsi un fattore di rischio. L’idea di questa forma di educazione alla salute
attraverso i media è quella di fornire protective skills contro l’influenza negativa dei mezzi
di comunicazione di massa e preparatory skills che renda i ragazzi cittadini responsabili.
È, inoltre, ormai chiaro che il concetto di salute non possa essere ridotto ai soli aspetti
biologici della sanità fisica; è necessario anche considerare un livello psicologico, in cui
la salute è il benessere della persona in senso pieno, ed un livello socio-ambientale, dove
la salute si traduce in qualità di vita.256
Con il modello ICF- CY, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2004,
non si parla più di handicap ma di BES (bisogni educativi speciali).
“Il concetto di bisogno educativo speciale sposta l’attenzione dall’individuo o dal
problema alle esigenze reali di chiunque incontri una difficoltà di tipo educativo
correlata a una condizione di salute”.257 Questo modello, infatti, si occupa del concetto
di salute in senso globale, considerata dal punto di vista biologico, psicologico e sociale.
256 Cfr D. FELINI, op. cit., pp. 199- 203
257 V. ROSSINI, “I bisogni educativi. speciali secondo il modello ICF-CY”, in G. ELIA, Questioni di
pedagogia speciale, Progedit, Bari, 2012, p. 46
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
126
Sebbene, da una parte, questo atteggiamento possa comportare il rischio di un drastico
aumento di medicalizzazione di situazioni di difficoltà, dall’altro permette di occuparsi
della salute di ogni soggetto, anche se oggettivamente non presentano difficolta di
“funzionamento” (come viene definito dal modello ICF). 258
3.4.2.3. Educazione civica
Oggi l’educazione del senso civico deve essere intesa come educazione dei diritti
e dei doveri, che non trascuri né il piano delle conoscenze né quello degli atteggiamenti.
Il tema della cittadinanza attiva e consapevole non può non dirsi connessa con quello dei
media e dell’informazione: in uno stato di diritto, infatti, la libertà di espressione e di
stampa ed il pluralismo dei media e nei media sono principi imprescindibili, così come i
mezzi di comunicazione sociale sono veicoli irrinunciabili per la partecipazione di
ciascuno alla vita comunitaria. L’educazione all’informazione di attualità, allora, ha un
indubbio significato nella formazione del vivere civile e democratico.
Un primo obiettivo dell’educazione ai media in direzione della formazione del
senso civico è quella di abituare i ragazzi a restare aggiornati su quanto avviene nel
mondo, possibilmente non in maniera superficiale. I mezzi di cui disponiamo sono
molteplici e vanno dalla carta stampata alla radio, dalla televisione a Internet, sempre con
la doppia possibilità del rapido aggiornamento di cronaca (oggi costantemente in tempo
reale) e dell’approfondimento\dibattito sui temi, problemi e questioni più disparati.
L’enorme quantità di informazione fa nascere l’esigenza di imparare a leggere non solo
il testo dei messaggi che ci arrivano, ma anche il sotto-testo e il contesto, per essere in
grado di comprenderne bene le dinamiche sottese.
Un altro obiettivo è quello di promuovere una partecipazione attiva alla vita del
paese, attraverso un coinvolgimento politico. 259 L’analisi del rapporto tra giovani e
politica mette in rilievo la presenza di due fenomeni: da una parte il ritiro generazionale,
ovvero la mancanza di partecipazione del mondo giovanile nell’ambito del dibattito
politico, soprattutto se come riferimento di paragone si assumono le generazioni
impegnate deli anni ’60 e ’70. La seconda riflessione è quella della generazione invisibile,
espressione con la quale ci si riferisce al mancato coinvolgimento diretto negli ambiti in
cui tradizionalmente si esplicita la partecipazione politica, a totale favore di una presenza
258 Id., pp. 43- 74
259Cfr D. FELINI, op. cit., pp. 204- 210
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
127
sociale con cui l’impegno in contesti politici è sostituito dal volontariato diffuso e
dall’associazionismo. 260 Il senso di sfiducia che ha portato molti dei giovani ad
allontanarsi dalla politica, viene alimentato a causa della miriade di informazioni che
provengono dal Web, che spesso non vengono né controllate né tantomeno messe
minimamente in discussione. Ciò non vuol dire che la politica di oggi sia abitata sempre
da personaggi di tutto rispetto, ma che spesso si “spara a zero” anche su coloro che,
magari, tentano di avere un atteggiamento corretto.
Ma non è tanto la mancanza di partecipazione attiva alla vita politica che ci
dovrebbe lasciare sgomenti, secondo me, quanto piuttosto la consapevolezza implicita
che tale situazione comporta, cioè che il mondo non possa essere cambiato, che la
situazione attuale sia quella definitiva. Si è persa, quindi, non solo la fiducia nella politica
ma anche la speranza nel cambiamento. “Sii il cambiamento che vuoi veder realizzato nel
mondo” afferma in una famosa frase il Mahatma Gandhi: il cambiamento della società
non può che partire da quello del singolo. Un’altra frase molto celebre che circola nel web
afferma che “il mondo non cambia con la tua opinione, ma con il tuo esempio”, splendida
sintesi e critica del modo di agire attuale: tutti criticano tutto, ma pochi fanno qualcosa
per migliorare la situazione in cui vivono.
L’educazione ai media intesa come educazione civica alla partecipazione ha, quindi, il
compito di far prendere parte attivamente i soggetti alla vita del paese e del mondo,
attraverso un’informazione equilibrata e ponderata e di far riscoprire, attraverso
l’educazione ai valori, l’importanza di perseguire un cambiamento interiore che possa,
poi, in un futuro comportare il cambiamento del mondo in cui viviamo.
“Solo il “cittadino globale” che abbia una percezione piena, non parziale di sé, riuscirà
a non soccombere dinanzi ai mutamenti sociali e culturali, proponendosi da protagonista
e da soggetto di storia e di cultura. Infatti solo un’antropologia integrale può costituire
il punto di partenza per un’interattività mediatica sana e dialogica.”261
260 Cfr A. RUBINI, Pedagogia e politica. Il contributo dell’educazione per un educare alla cittadinanza
responsabile, Guerini, Milano, 2010, pp. 15- 16
261 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, op. cit., 2004, p. 30
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
128
3.4.2.4. Educazione all’identità di genere
Come abbiamo in precedenza affermato, i media sono uno strumento potentissimo
di rappresentazione anche e soprattutto di creazione, codificazione e diffusione delle
caratteristiche di genere. Sappiamo come durante la preadolescenza e l’adolescenza i
modelli rivestano un ruolo importante nella crescita della persona, poiché rappresentano
per il soggetto un termine realizzabile di positività e compiutezza umana meritevole di
essere imitato; comportarsi facendo riferimento ad un modello, fosse anche un idolo dello
sport o della musica, ed essergli vicino almeno mentalmente offre all’adolescente la
sensazione rassicurante di fare la cosa giusta. A questo punto ci si chiede quale contributo
possa dare l’educazione ai media in tale e delicato compito evolutivo grazie al quale.
Attraverso l’introiezione di un modello di vita, si costruisce la percezione di sé come
soggetto attuale e come soggetto potenziale. Posto che l’identità di genere si definisce per
una certa misura sulla base di materiale che proviene abbondantemente dal mondo dei
media, anche nella rielaborazione che i gruppi di ragazzi e adolescenti compiono dei miti,
degli stereotipi, delle figure, dei personaggi, insomma dell’immaginario collettivo.
Si possono immaginare due possibilità: la prima, in continuità con quella
precedente, consiste nell’utilizzo delle tecniche didattiche di analisi dei messaggi mediali
per decostruire e disarticolare gli stereotipi di genere che dominano sulla carta stampata
o sui teleschermi. L’obiettivo è quello di far cadere il falsi miti di donne e uomini perfetti,
cercando di far capire ai ragazzi che ognuno è bello a modo suo e soprattutto lo è perché
è unico e irripetibile. In questo senso la media education potrebbe farsi portatrice di un
messaggio tranquillizzante all’interno di una cultura che, invece, è generatrice di ansia
per molti adolescenti che non vedono alla ribalta modelli raggiungibili e per questo
vivono forti cali di autostima e faticano ad accettarsi per quello che sono.
Il secondo modo per poter stimolare la riflessione dei ragazzi sugli stereotipi
diffusi dai media è quello di pensare alla propria identità sulla base di un modello
sicuramente conosciuto, come quello di un calciatore, attore, musicista, giungendo poi
alla conclusione che ognuno è portatore di un desiderio di autorealizzazione identitario
differente da quello di altri.262
262 Cfr D. FELINI, op. cit., pp. 211. 215
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
129
4. CAPITOLO 4
5. LA RICERCA EDUCATIVA NELLA MEDIA EDUCATION
6.
4.1. La ricerca educativa nell’ambito dei media e ricerca nella
Media Education La ricerca nell’area della Media Education è parte integrante della ricerca
educativa sui media, un sotto- campo di indagine ad alta specificità (Figura 6). La ricerca
in campo educativo si definisce in relazione a tre
fondamentali elementi: un oggetto o campo di
indagine- di cui vanno circoscritti rigorosamente i
confini (piano ontologico) - un certo tipo di
discorso- che implica un posizionamento teorico e
delle scelte di metodo (piano metodologico) - e
un’agenda- riguarda i risultati che si intende
conseguire in relazione ad un determinato contesto
(piano funzionale).
Per ciascuno di questi piani ed elementi è possibile
individuare dei descrittori, ovvero indicatori che permettono di facilitarne il
riconoscimento e l’operazionalizzazione all’interno delle ricerche condotte: il punto di
vista e di focalizzazione.263
Il punto di vista appartiene al piano metodologico ed è funzionale alla definizione del
tipo di discorso che, attraverso la ricerca, viene elaborato in relazione ad un determinato
argomento. Secondo il modello di Jean- Marie Van der Maren264, è possibile individuare
quattro tipo di discorsi fondamentali:
La descrizione, che si occupa di identificare gli elementi e le loro relazioni
statistiche, delimitare l’oggetto della ricerca e classificare i suoi componenti e
definire lo stato della situazione.
263 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 17- 18
264 J. VAN DER MAREN, La recherche appliquée en pédagogie, de Boek, Bruxelles, 2003, pp. 34- 35
FIGURA 6- RICERCA EDUCATIVA SUI
MEDIA E MEDIA EDUCATION
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
130
La comprensione, che specifica le dinamiche e correlazioni tra i vari elementi di
una situazione, l’origine della stessa e la sequenza di eventi che hanno condotto
ad essa.
La spiegazione, ovvero l’evidenziazione delle regole e principi che si
manifestano, nel tempo e nello spazio, tra le circostanze simili o dello stesso
genere.
La formalizzazione, che consiste ne livello più astratto di elaborazione e riguarda
la teorizzazione generale di principi e regole validi per tutti i fenomeni dello stesso
tipo.265
Per quanto riguarda la focalizzazione, essa è relativa al piano ontologico e favorisce
la delimitazione dell’oggetto su cui la ricerca opera. Géneviève Jacquinot266 individua,
all’interno della ricerca educativa sui media, le seguenti aree di interesse:
L’analisi delle pratiche mediatiche, cioè dell’attività di lettura che vede
protagonisti i minori (“Cosa leggono e quando?”, “In che proporzione con i
diversi media?”, “Con quali trasformazioni nel tempo?”).
Lo studio delle rappresentazioni dei media, ovvero studi che hanno ad oggetto la
socializzazione, gli effetti della violenza sui comportamenti aggressivi del
pubblico, la funzione degli stereotipi mediali nella strutturazione dei quadri di
valore e di comportamento dei minori.
Lo studio della ricezione in contesto, area di studio che ha ad oggetto la
formazione delle culture giovanili in base al contesto mediale.
Lo studio del funzionamento dei media, vale a dire l’analisi delle dimensioni
economica- politica e semio- pragmatica dei messaggi. Géneviève Jacquinot
individua per entrambe le dimensioni, alcuni approfondimenti di ricerca. Per
quanto riguarda la prima, lo studio potrà concentrarsi sull’influenza della
deregolamentazione delle telecomunicazioni sui contenuti dei media, la
commercializzazione dei media attraverso il merchandising e l’utilizzo del
bambino come consumatore con il fine di promuovere un’autoregolamentazione
dell’industria dei media.
265 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 18- 19
266 G. JACQUINOT, Les jeunes et les médias, L’Harmattan, Paris, 2002, pp. 20- 22
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
131
Per quanto riguarda, invece, la dimensione semio- pragmatica, l’attenzione verrà
posta maggiormente sul processo di produzione di senso, sulle pratiche messe in
atto dallo spettatore per leggere criticamente i messaggi, sulla negoziazione di
significati che il testo attiva coinvolgendo lo spettatore attraverso strategie e
tattiche di posizionamento del suo sguardo e di suggerimento delle sue mosse
interpretative.267
Rispetto al piano funzionale, il descrittore utilizzato è l’orientamento funzionale. Van der
Maren, ancora una volta, ne individua le aree di interesse più importanti al fine di una
ricerca educativa:
La finalità pedagogica, la finalità della ricerca educativa più legata
all’insegnamento e alla formazione, in vista dell’ottenimento di un risultato
formativo efficace.
La finalità epistemologica, che nasce nell’indagine sullo statuto delle discipline e
sulla fondazione delle teorie e ha come obiettivo la discussione delle teorie già
individuate come lo scopo di favorire l’aspetto critico e polemico rispetto al
metodo e alle pratiche d’indagine.
La finalità tecnica, nelle sue due varianti: pragmatica- produzione di artefatti che
consentano di controllare l’ambiente fisico o di rispondere a dei bisogni- e
politica- sviluppo di servizi da mettere a disposizione degli individui o dei
gruppi.268
Di seguito viene mostrata una tabella riassuntiva (Tabella 4), in cui vengono elencati
gli ambititi della ricerca educativa e i metodi ad essi relativi.
Partendo dalla considerazione compiuta all’inizio di questo paragrafo, ovvero che la
Media Education è un sotto- insieme della ricerca educativa dei media, potremo allora
adoperare i tre descrittori- focalizzazione, punto di vista e orientamento funzionale-,
utilizzati precedentemente, per individuare le specificità della ricerca nell’ambito della
Media Education e rilevare in cosa si distingue dall’ambito- madre.
267 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 19- 20
268 Id., pp. 20- 21
TABELLA 4- TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RICERCA SUI MEDIA
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
132
Per quanto riguarda l’oggetto della ricerca, ovvero la focalizzazione, possiamo
individuare una prima area di distinzione tra Media Education e ricerche educative sui
media: mentre la prima si occupa di rendere possibile, rispetto ai media, un agire politico
ed educativo efficace (approccio education centred), la seconda è centrata sui media nei
loro risvolti educativi (approccio media centred).
Per quando riguarda il piano metodologico, e quindi il punto di vista, invece bisogna
rilevare ulteriori differenze. Il punto di vista della ricerca sui media è “esterno” rispetto
ai fenomeni che studia: il ricercatore non è necessariamente un educatore e comunque la
sua riflessione sull’oggetto della propria ricerca non coinvolge le sue prassi educative e
didattiche. Diversamente, il punto di vista della ricerca nell’ambito della Media Education
è sempre “interno”, quindi molto spesso il ricercatore è un educatore che si serve della
ricerca per migliorare l’efficacia del suo intervento o per produrre pressione sulle
organizzazioni o le istituzioni perché adottino la Media Education come quadro di
riferimento per la loro azione educativa rispetto ai media. Quindi potremmo definire il
tipo di ricerca posta in essere nell’ambito della Media Education, una ricerca- azione.
Infine, per quanto riguarda l’ultimo ambito, cioè quello funzionale, possiamo notare
come, mentre l’orientamento della ricerca sui media è prettamente conoscitivo (capire
come funzionano le rappresentazioni dei media in ordine agli apprendimenti, etc.…),
l’orientamento della Media Education è pragmatico o, meglio, più specificatamente
pedagogico in quanto tende all’agire educativo.269
Possiamo quindi sintetizzare che la ricerca della Media Education “[…], si
contraddistingue per una decisa centratura sulle pratiche educative, adotta
tendenzialmente un punto di vista interno (la ricerca si muove quasi sempre nel contesto
stesso dell’intervento educativo), manifesta un orientamento pragmatico, cioè si propone
come progettualità forte di trasformazione della realtà”.270 In breve, nella tabella che
segue, vengono sinteticamente mostrate le differenze tra ricerca educativa sui Media e
ricerca della Media Education (Tabella 5).
269 Id., pp. 24- 26
270 Id., p. 33
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
133
TABELLA 5- DIFFERENZE TRA RICERCA EDUCATIVA SUI MEDIA E
RICERCA NELLA MEDIA EDUCATION
Ricerca educativa sui Media Ricerca nella Media Education
Focalizzazione Media centred Education centred
Punto di vista Esterno Interno
Orientamento funzionale Conoscitivo Pragmatico
Jean- Marie Van der Maren 271 , al cui contributo si è fatto precedentemente
riferimento, suggerisce di adottare come criterio per descrivere i diversi ambiti di ricerca
in educazione quattro ambiti di ricerca:
Nomotetico, che definisce una ricerca finalizzata a produrre un sapere
ordinatore rispetto ai problemi funzionali.
Pragmatico, orientato ad un tipo ti ricerca che intende ricercare soluzione
ai problemi funzionali.
Politico, che designa una ricerca che intende proporre cambiamenti negli
individui e nelle istituzioni.
Ontogenetico, ovvero la ricerca come forma di autoconsapevolezza volta
al miglioramento di sé.
Una volta definito il quadro complessivo della ricerca educativa bisogna vedere come,
rispetto ad essa, si collochi la ricerca nella Media Education. Alcune considerazioni
preliminari sono doverose per individuare le linee guida su cui si dovrà impostare il lavoro
di descrizione di quest’ambito così importante della scienza dell’educazione.
Preciso preliminarmente che per quanto riguarda quest’ultima parte del mio elaborato,
farò principalmente riferimento al lavoro compiuto da Pier Cesare Rivoltella, uno dei
massimi esponenti e promotori della Media Education in Italia. Farò riferimento ai suoi
lavori perché più attinenti al tipo di riflessione che vorrò compiere.
Tornando all’ambito della ricerca, Rivoltella sottolinea come, rispetto ai piani di ricerca
sopra descritti, la Media Education si inserisce pienamente sono in alcuni di essi; altri
invece non sono stati ancora frequentati da questo ambito di ricerca. Si nota infatti:
- Una chiara preponderanza della ricerca teorica, privilegiando la strategia
monografica, tipica dello studio di caso.
- La ricerca pragmatica è orientata per lo più alla produzione di oggetti;
271 Cfr J. VAN DER MAREN, op. cit., p. 23
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
134
- Grande rilievo ha la ricerca politica, sia nella forma di ricerca-azione che in quella
di produzione di concetti
- Infine va registrata la presenza di ricerche impostate secondo il modello della
ricerca valutativa a scopo giustificativo. 272
Di seguito ci procederà con la descrizione delle aree di ricerca più frequentate dalla Media
Education, ovvero ricerca teorica, ricerca pragmatica e ricerca politica.
4.2. La ricerca teorica
La ricerca teorica nell’ambito della Media Education riguarda soprattutto lo studio
dei compiti della teoria, in base a cinque principali azioni modellizzanti, alle quali
corrisponde una specifica teoria:
Descrivere, cioè attività di ricerca delle condizioni di esistenza di un oggetto, le
sue dimensioni, i dispositivi che presiedono alle sue trasformazioni evolutive. A
questa corrispondono, quindi, le Teorie Descrittive, il cui focus è costituito dai
modelli e dalle esperienze della Media Education realizzati nei diversi paesi.
Obiettivo di questa teoria è di individuare ambiti di comparazione tra le diverse
teorie e individuare i possibili elementi costitutivi di un “modello perfetto” di
Media Education.
Prescrivere, fissare principi e criteri etici ai quali l’azione deve ispirarsi. Ad essa
corrispondono le Teorie Prescrittive, che si occupa di indicare obiettivi didattici,
contenuti e metodologie di lavoro degli insegnanti, con il fine di ottenere una
configurazione curricolare della Media Education tale da garantirle un
riconoscimento istituzionale.
Interpretare, leggere e capire determinati fenomeni, per cercare di trovare una
spiegazione. Fanno riferimento a questa azione le Teorie Interpretative, che
hanno il compito di stabilire gli strumenti di ricerca e lo studio di casi.
Progettare, definire una strategia in base alla quale orientare l’agire. Ad essa si
rifanno le Teorie Strategiche, che hanno come soggetto di studio il Media
Educator, in particolare la sua identità, il suo ruolo e le sue funzioni.
272 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 40- 44
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
135
La relazione tra queste cinque azioni è sistemica (Figura 7), ovvero esse non possono
ritenersi esaustive del fare ricerca se prese singolarmente, ma solo se considerate in modo
trasversale.273
4.2.1. Le metateorie
Possiamo individuare i principali obiettivi delle metateorie della Media Education
in due ambiti. Il primo riguarda la collocazione epistemologica della Media Education,
individuandone le matrici teoriche, vagliandone lo statuto disciplinare, cercandone una
definizione praticabile e condivisa; il secondo riguarda la ricostruzione dei principali
paradigmi di ricerca.
Inizieremo il nostro studio partendo dalle definizioni che, con il tempo, si sono
susseguite sulla Media Education. Sebbene le ricerche e gli studi sugli effetti dei media
sui nostri comportamenti ed atteggiamenti abbiano un inizio molto antico, quello
sull’educazione ai media lo potremmo definire più “giovane”. È agli albori degli anni ’70
che possiamo rintracciare l’inizio dei lavori in vista della definizione dell’educazione ai
media. Grazie ai congressi dell’UNESCO e di altre organizzazioni ad essa collegate,
comincia a sorgere la necessità di distinguere tra educazione ai media ed educazione
attraverso i media.
273 Id., pp. 45- 47
FIGURA 7- LE AREE DELLA RICERCA TEORICA NELLA MEDIA EDUCATION
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
136
Nel 1973 possiamo rintracciare la prima definizione di educazione ai media, ad
opera dell’International Film and Television Council (CICT), il quale inizialmente ne
evidenzia il carattere scolastico, collocandola all’interno delle scienze dell’educazione e
contrapponendola rigidamente a qualsiasi forma di ricorso ai media come sussidi
didattici: “Lo studio, l’insegnamento e l’apprendimento dei moderni mezzi di
comunicazione considerati come specifica ed autonoma disciplina nell’ambito della
teoria e della pratica pedagogiche, in opposizione all’uso di questi mezzi come sussidi
didattici per le aree consuete del sapere, come ad esempio la matematica, le scienze e la
geografia”274.
Successivamente, nel 1979, il CICT corregge il tiro, estendendone l’applicazione
e vedendola come legata non solo all’ambito dell’istruzione, ma anche a quello della
formazione: “La Media Education comprende lo studio – e per esso si intende il suo
apprendimento e insegnamento in vari modi e ad ogni livello: primario, secondario, post-
secondario, nell’educazione degli adulti e nell’educazione continua e in ogni circostanza
– della storia, della creatività, dell’uso e della valutazione dei media come arti pratiche
e tecniche; così come del ruolo svolto dai media nella società, del loro impatto sociale,
delle implicazioni che derivano dalla comunicazione, dalla partecipazione e dalla
modificazione delle modalità di percezione che i media comportano; nonché dell’accesso
ai media e del lavoro creativo che con essi si può svolgere”275
Nel 1990, alla conferenza di Toulouse (che inaugura la stagione dei grandi congressi
internazionali della Media Education) viene fornita una terza definizione, che inquadra la
Media Education nel contesto socio- politico e culturale della società. “Un’educazione ai
media è insieme una pratica e un processo di tipo educativo destinato a permettere ai
membri di una collettività di partecipare in modo creativo e critico (a livello di
produzione, distribuzione e presentazione) all’uso dei mezzi elettronici e tradizionali, allo
scopo di sviluppare e liberare gli individui e la collettività e di democratizzare la
comunicazione”276
274 B. PAVLIC, UNESCO and Media Education, in “Educational Media International”, 1987, p. 32, Cit. in
P.C. RIVOLTELLA, Media Education, Carocci, Roma, 2001, p. 23
275 Ibid.
276 C. BAZALGETTE, E. BEVÒRT, J.SAVINO, L’éducation aux médias dans le monde, Paris 1992. p. 167
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
137
Potremmo semplificare dicendo che si passa da una concezione pedagogica e
scuolacentrica (1973) ad una socio- culturale (1979) e infine a una concezione politica e
civile (1990).277
A seguito delle definizioni che si sono susseguite sull’educazione ai media, si è potuto
identificare delle aree di convergenza importanti per la definizione del suo statuto
epistemologico: 278
Rilevazione della crescente presenza dei mezzi di comunicazione nella società
contemporanea e della loro importanza dal punto di vista culturale.
Necessità di promuovere, da una parte, delle istituzioni politiche ed educative, una
comprensione critica dei fenomeni legati ai media, con un’alfabetizzazione
relativa ai tre sistemi simbolici sui quali si basano i media: immagine, parola e
suono.
Ritardo con cui le agenzie formative si stanno muovendo a questo proposito,
rallentando lo sviluppo della crescita democratica dei cittadini.
Necessità di un’assunzione di responsabilità non solo da parte degli insegnanti e
degli educatori, ma anche dei genitori, dei professionisti, del governo e dei media
stessi.
Ampliamento della materia alle dimensioni più vicine all’esperienza dei giovani,
cercando di aggiornare i temi trattati con essi.
Abbandono di un atteggiamento moralistico e critico nei confronti delle
comunicazioni di massa, per comprenderne e accoglierne i significati.
Potenziale liberatorio e partecipativo della Media Education, riscontrabile nella
sua capacità di far assumere all’alunno un ruolo di conoscitore e interprete dei
messaggi mediali.
Possiamo, quindi, sintetizzare il tutto affermando che i Media sono considerati una risorsa
integrale dell’educazione e che la Media Education “[…] rappresenta un tipo di lavoro
educativo di cui sempre più chiaro risulta essere il bisogno sociale all’interno di un
modello di società che come la nostra a ragione si può definire una learning society per
via del ruolo decisivo che in essa giocano i media e le nuove tecnologie dell’informazione
277 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 47- 50
278 Cfr D. FELINI, op. cit., p. 35
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
138
in relazione alla circolazione dei significati e all’organizzazione e archiviazione dei
saperi”279.
C’è bisogno, pertanto, di una riflessione per individuare quali potrebbero essere i
fattori di cambiamento su cui il mondo della formazione ed educazione deve confrontarsi
per far fronte alla situazione. Un primo elemento è la personalizzazione
dell’apprendimento, che si verificherebbe nel momento in cui si utilizzassero i new media
come supporto alla didattica. “Naturalmente sarebbe ingenuo pensare che sia sufficiente
l’integrazione della tecnologia perché automaticamente la didattica si trasformi. Questo
schema di tipo determinista semplice, forse accontenta i fautori più calorosi
dell’innovazione, ma certo non risulta pedagogicamente convincente”280 Il modello di
scuola che si verrebbe a delineare sarebbe un modello in cui le conoscenze vengono
costruite cooperativamente dall’insegnante insieme agli studenti, favorendo così
l’apprendimento collaborativo. La didattica tradizionale basata sui contenuti non è più
funzionale per l’attivazione di tutte le risorse cognitive degli alunni. A tal fine, però, si
rende necessaria, una «pedagogia del cambiamento», impegnata ad ampliare le esperienze
valorizzanti dell’alunno.
All’apprendimento personalizzato va ad associarsi una nuova funzione del docente, il
quale deve essere in grado di decentrarsi, spostarsi ai margini del processo educativo,
nella consapevolezza che solo così il suo lavoro potrà essere efficace. Si tratta di ripensare
l’insegnamento sul modello tutoring, in cui il tutor progetta la situazione didattica,
organizza le informazioni, orchestra gli strumenti, si offre come help in linea per gli
allievi. Questo aspetto sottolinea una seconda dimensione fondamentale del formatore nel
contesto (multi)mediale, che è quella della relazione. Essa, infatti, non deve venir meno
a causa dell’interazione uomo- macchina, ma deve essere sempre favorita, in quanto
bilanciere nel rapporto con le macchine.
Tali ambiti verranno approfonditi ulteriormente nei paragrafi successivi.
4.2.1.1. Inquadramento disciplinare
La ricerca critica metateorica si fonda anche sulla natura disciplinare della Media
Education.
279 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 40- 41
280 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 1998, p. 196
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
139
“Anzitutto la scienza è concorde nel ritenere la Media Education un’area di
interesse che vive al confine tra le scienze dell’educazione e della
comunicazione, mutando i temi, metodologie e strumenti delle une e delle altre:
se la progettazione, le tecniche didattiche, le metodologie di valutazione
provengono chiaramente dall’educazione, la strumentazione semiotica per
l’analisi dei testi, le tecniche di indagine del consumo e le categorie di
comprensione culturale dei media sono debito evidente della comunicazione”.281
La “questione disciplinare” si dipana su due diversi fronti: quello epistemologico che si
chiede se alla Media Education si possa riconoscere lo statuto disciplinare (con un oggetto
specifico, una genesi teorica, confini disciplinari e un metodo proprio) e quello
curricolare, che si pone il problema di capire se, l’ipotesi dell’inserimento della Media
Education nella programmazione scolastica, possa configurarla come disciplina come le
altre o come materia trasversale da richiedere a tutte le discipline.
Per quanto riguarda il livello epistemologico vi sono due posizioni antitetiche tra
loro: la prima considera la Media Education come disciplina a se stante, la seconda non
riconosce la sua indipendenza disciplinare.
Le argomentazioni riguardo alla prima di queste posizioni sono tre e sono basate sulla sua
considerazione come:
- Un sotto- campo (inter)disciplinare che si colloca tra le due scienze della
comunicazione e dell’educazione, dalle quali trae i presupposti teorici e
metodologici che stanno alla base del suo agire.
- Uno dei campi (assieme alla Tecnologia dell’educazione, all’Ecologia dei media,
all’Ergonomia cognitiva) che concorrono a costituire la Pedagogia dei Media
(come visto precedentemente nel capitolo terzo).
- Uno spazio di lavoro che le permette un continuo rimando alle discipline che già
si occupano del rapporto tra media ed educazione, come la psicologia sociale o la
sociologia della comunicazione.
Masterman, nel suo famoso contributo sulla Media Education, afferma che se anche si
volesse considerarla come una disciplina a se stante, non si dovrebbe prescindere dallo
sviluppo di tale disciplina su più fronti possibili.282
281 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, p. 53
282 Cfr L. MASTERMAN, op. cot., p. 81
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
140
“L’insegnamento dei media come area specializzata è destinato a sortire ben pochi effetti
se non riesce a permeare ed influenzare i vari modi in cui il materiale mediale viene
impiegato nelle altre discipline”283
Di certo i vantaggi dello studiare i media come disciplina autonoma sono notevoli.
Virtualmente tutte le attività curriculari trarrebbero vantaggi se, però, si disponesse di un
dipartimento specializzato di studi sui media, dotato di un’identità, fondi, spazi ed
apparecchiature e di una presenza permanente nella scuola. Questo assicurerebbe una
certa continuità didattica e un dibattito continuo e proficuo anche con gli insegnanti delle
altre materie.284 Però, realisticamente, nella situazione attuale, soprattutto per quanto
riguarda la scuola italiana, in continua crisi di fondi e, in alcuni casi, ancora impostata sul
modello tradizionale di insegnamento, pensare di poter creare uno spazio riservato solo
alla Media Education e dei fondi per la sua espansione, sarebbe a dir poco utopistico.
Inoltre si possono rintracciare ulteriori limiti dei limiti in questa posizione: il rischio di
una definizione troppo rigida, che la porterebbe a non confrontarsi con altre esperienze e
scienze e l’impossibilità oggettiva di racchiudere nei confini di un’unica disciplina
metodologie ed esperienze diverse e complesse.
Basandosi su tali limiti, si inserisce la seconda posizione, quella che non prevede
una definizione disciplinare della Media Education, vedendola, invece, come
appartenente agli ambiti di ricerca di altre discipline, dalla pedagogia alla psicologia e
sociologia. 285 “In particolar modo è necessario incoraggiare gli insegnanti di tutte le
materie ad adottare un approccio attraverso il quale i messaggi mediali vengano
collegati agli interessi politici, economici e sociali di coloro che li producono”.286
Sebbene la tesi sulla quale poggia questo lavoro si basi proprio sull’importanza di
educare ai media le nuove generazioni, anche facendo riferimento alla situazione italiana,
non penso che sia realisticamente realizzabile una disciplina a parte per insegnare ciò. Da
una parte perché la situazione di precariato degli insegnanti non pone le basi sociali per
poter pensare ad una situazione del genere, dall’altro perché è bene che si punti sulla
formazione degli insegnanti che attualmente occupano le cattedre delle nostre scuole e
dei nostri licei. Bisognerebbe partire da un’introduzione graduale del concetto di Media
283 Ibid.
284 Ibid.
285 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 54- 56
286 L. MASTERMAN, op. cit., p. 84
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
141
Education (che dovrebbe già esser stato presentato ed assimilato dagli insegnanti) nei
programmi didattici, prevedendo, magari, maggiore partecipazione a progetti e proposte
in tal senso.
C’è bisogno, quindi, che si crei all’interno della società una coscienza mediale,
che ponga le giuste basi per poter poi permettere una riforma scolastica in cui sia prevista
la Media Education come disciplina a se stante. Se oggi il Ministro dell’Istruzione
prevedesse una riforma scolastica che abbia ad oggetto l’introduzione della Media
Education come disciplina, non solo non verrebbe accettata dal corpo docenti, ma anche
da tutta la società, ancora “dormiente” per quanto riguarda questo aspetto.
4.2.2. Teorie Strategiche
Come abbiamo visto in precedenza, le Teorie Strategiche hanno ad oggetto lo
studio di una nuova figura professionale, il Media Educator, con l’obiettivo di
individuarne l’identità e le funzioni.
In primo luogo, possiamo affermare che egli è innanzitutto una figura specializzata, in
quanto si trova in un terreno caratterizzato da una complessità dell’oggetto (la Media
Education) e del campo d’azione. Egli avrebbe il compito di condurre i ragazzi verso una
maggiore consapevolezza dei rischi celati dietro ai media, non semplicemente la
trasmissione di informazioni, ma con un vero e proprio intento formativo in vista di
un’autonomia critica: “il compito veramente importante ed impegnativo per il media
educator consiste nel creare negli alunni sia la capacità che la volontà di continuare a
farlo per il resto della vita”.287
Per quanto riguarda la sua identità professionale, il Media Educator, andrà assumendo
profili diversi in relazione ai contesti entro cui opererà:
Scuola, come insegnante di una specifica disciplina oppure come esperto in grado
di formare secondo le esigente di progettazione educativa delle diverse scuole (la
sua identità varia, in base alla considerazione, o meno, della Media Education
come disciplina).
Extra-scuola, costituisce una forma particolare di animatore o operatore socio-
culturale.
287 Id., p. 74
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
142
Profit e no profit, il media educator potrebbe costituire quella figura che, in un
contesto fortemente mediatizzato, garantisce all’organizzazione un servizio
formativo adeguato e nuove possibilità di intervento.
Sebbene sul piano teorico tutto questo sarebbe auspicabile, se passassimo alla realtà dei
fatti, anche in base a quanto affermato pocanzi, ci renderemmo conto che tale figura
avrebbe molte difficoltà nell’affermarsi. Inoltre, sarebbe più auspicabile, piuttosto che
creare una nuova figura in toto, che si lavorasse affinché gli educatori già formati,
acquisiscano delle competenze tali da fare dei media e delle tecnologie dimensioni
costitutive del loro intervento. Questa esigenza proviene sia dalla considerazione delle
difficoltà di ritagliare al Media Educator uno spazio professionale autonomo, sia dalla
consapevolezza che il lavoro con i media è divenuto, ormai, uno degli ambiti di azione e
intervento degli educatori.288
“Prima di parlare del media educator, ovvero di un nuovo professionista
dell’educazione, occorre sostenere con forza che qualsiasi educatore deve avere
la volontà e la capacità di assumere il fenomeno mediatico come importantissimo
per realizzare con gli educandi un’autentica comunicazione. Ciò significa e
comporta una piena consapevolezza che il rapporto con i media rappresenta
comunque un evento educativo significativo, intervenendo (nel bene e nel male)
nel processo formativo di ogni persona ovviamente complessificandolo. E
significa sostenere che di conseguenza l’apporto delle scienze dell’educazione al
riguardo deve essere visto innanzitutto all’interno del processo formativo degli
educatori in quanto tali, al punto che i loro rappresentanti dovrebbero
rendersene conto e misurarsi con l’esperienza mediatica che connota comunque
la vita dei bambini e dei ragazzi.”289
Il termine “educazione” deriva dal latino educĕre (“condurre fuori”) e fa riferimento allo
“sviluppo di facoltà ed attitudini negli esseri umani, all’affinamento della sensibilità, alla
correzione del comportamento, alla trasmissione e acquisizione di elementi culturali,
288 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 57- 63
289 P. BERTOLINI, L’apporto delle scienze dell’educazione alla formazione del media educator, relazione al
convegno “Nuove professionalità per i nuovi mercati della formazione: il Media Educator”, Napoli, 12-13
ottobre 2001
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
143
estetici, morali”. 290 Per poter riuscire a far sì che ognuno degli educandi riesca a
“condurre fuori” da se stesso tutto ciò che lo caratterizza come persona unica, e quindi
progetti, aspirazioni e il suo modo di essere, l’educatore non può non far riferimento ai
mezzi di comunicazione, perché essi formano il suo essere, spesso lo condizionano. È
imprescindibile, quindi. “[…] leggere le scienze della comunicazione come elemento
indispensabile nella riflessione dell’educatore, perché il mondo della comunicazione
costituisce per la formazione sia una straordinaria provocazione a ripensare i propri
compiti e strategie sia un’importante risorsa per migliorare l’efficacia dei suoi
interventi.”291
Liberare i soggetti da tutti i vincoli che impediscono loro di essere pienamente se stessi,
comporta anche riuscire a lavorare su questo aspetto importante. “I media, il computer,
non possono sostituire o costituire la relazione educativa, ma si situano nella relazione
educativa, attivando le risorse dei singoli nell’ottica di una sinergia di gruppo
comunitaria, in cui il formatore rimane comunque polo e zona di intersezione delle
comunicazioni”292
Ma i soggetti coinvolti nell’educazione ai media non sono solo gli educatori, ma
anche gli insegnanti, che lavorano costantemente a contatto con bambini e adolescenti,
occupandosi della loro formazione e guidandoli attraverso i percorsi didattici. Per questo
una formazione in ambito mediale, che abbia come obiettivo non solo l’istruzione e la
formazione, ma anche l’educazione, deve essere vissuta anche dagli insegnanti. Questo
per un semplice motivo: spesso nelle scuole manca la figura dell’educatore. Gli
insegnanti, quindi, hanno il compito di “supplire” anche a tale mancanza, non snaturando
il loro ruolo formativo, ma arricchendolo con le competenze di un esperto in ambito
educativo e comunicativo.
“[…] se non è la figura del docente, del formatore, a farsi carico di funzionare da
catalizzatore del cambio di paradigma didattico, la didattica (multi)disciplinare può
risultare una delle più tradizionali: così posso continuare a fare lezione frontale
mostrando e commentando una videocassetta, posso perpetuare una impostazione di tipo
290 P.C. RIVOLTELLA, Media Education, Carocci, Roma, 2001, p. 21.
291 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 1998, Premessa, p. 12
292 Id., p. 197
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
144
istruzionale anche facendo ricorso al computer, posso “scolarizzare” i media
neutralizzando la loro specificità educativa”.293
Divenire insegnanti preparati e formati sul piano della comunicazione e dell’educazione
vuol dire, necessariamente, anche adeguare il proprio modo di lavorare, in cui i media
non devono essere strumenti ausiliari della didattica tradizionale, ma dei veri e propri
agenti propulsori di conoscenza e di una didattica più partecipativa, attiva e democratica.
Masterman, a tal proposito, afferma: “[…] è oltremodo importante che ogni insegnante
sia in fondo un media educator, capace di sollevare interrogativi fondamentali quali:
come questo programma\giornale\film costruisce il mondo? Negli interessi di chi?
Usando quali tecniche? Per quale pubblico? E in nome di quali valori?”.294
Gli insegnanti devono partire da una consapevolezza, indicativa dei tempi che sono
cambiati e soprattutto dell’inadeguatezza della didattica tradizionale, che quando i
bambini arrivano da loro e si approcciano alla loro materia, essi non sono più delle tabula
rase riguardo alla sua materia. Essi portano in classe le più diverse idee, preconcetti,
convinzioni (spesso frammentarie) raccolte dalla pubblicità, dalle soap opera, da internet,
dai telegiornali, dalle riviste, ecc., tali da renderli già formati a riguardo. Solo quando gli
insegnanti prenderanno sul serio l’importanza di quella che precedentemente è stata
denominata “scuola parallela”, potranno dare la giusta importanza alla Media
Education.295
4.2.3. Teorie Descrittive e Prescrittive
Negli ultimi due decenni le esperienza di Media Education si sono diffuse, prima
in Nord America e in America Latina, poi, in maniera sempre più convincente di Europa.
Una delle esigenze più impellenti, derivate da questa diffusione, è stata quella di ottenere
una mappatura abbastanza attendibile in ordine alle forme e ai modelli che queste
esperienze hanno assunto e incarnato nei diversi paesi.
Questo è l’oggetto di analisi delle teorie descrittive, ovvero delineare quali sono
gli orientamenti di ricerca condivisi da tutti i paesi che hanno posto in essere percorsi di
Media Education nei loro curricula e individuarne i presupposti pedagogici.
293 Id., p. 196
294 L. MASTERMAN, op. cit., p. 88
295 Id., p. 89
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
145
Il più diffuso modello di educazione ai media dei paesi anglosassoni è quello della
Media Literacy “Il termine Literacy indica la capacità di saper leggere e scrivere, e può
essere tradotto con la parola italiana alfabetizzazione”.296 Questa disciplina ha avuto il
compito di far adottare nei percorsi disciplinari, una nuova prospettiva
sull’alfabetizzazione che consentisse di estendere l’idea anche oltre i confini
tradizionali.297 “Si rende necessario estendere questo concetto di alfabetizzazione al di là
delle forme scritte per includere una vasta gamma di altri media, e al di là del “come”
(abilità e competenze) per includere il “che cosa” (generi, stili, formati, codici e
registri)”.298
Renée Hobbs definisce la Media Literacy “l’abilità di accedere, analizzare, valutar e
produrre messaggi secondo la varietà di formati mediali”.299 Questa definizione di Media
Literacy si basa sull’individuazione di quattro processi cognitivi (competenze mediali)
che, nel loro insieme, costituiscono l’alfabetizzazione mediale300:
- Accesso, che si riferisce all’ampia gamma di abilità che vanno dalla basilare
capacità di leggere e scrivere, all’arricchimento del vocabolario personale, dalla
capacità di trovare, riorganizzare e memorizzare le informazioni, alla sintesi di
testi (scritti e audiovisivi). Tale abilità è data, quindi, sia dalla capacità di navigare
in Internet usando efficacemente i mezzi a disposizione, sia dalla competenze di
tipo “transmediale”, come quelle di letto- scrittura o la capacità di saper ricavare
informazioni da un video.
- Analisi, ovvero la capacità di “capire che le persone sono sempre coinvolte nella
costruzione dei messaggi mediali e che tali messaggi sono quasi sempre costruiti
per un certo scopo, sia esso quello di informare, intrattenere o persuadere”.301
Questo obiettivo è, per certi aspetti, quello centrare dell’educazione ai media
secondo l’approccio della media literacy, strettamente legato ai cinque concetti
fondamentali della media literacy elencati dalla Conferenza nazionale presso
296 D. FELINI, op. cit., pp. 111- 112
297 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 67- 69
298 A. HART, La nuova alfabetizzazione, «Intermed», 1, 1998, p. 1
299 P. AUDERHEIDE, Media Literacy, the Aspen Institute Wye Center, Queenstown Maryland, December 7-
9, 1992, p. 79
300 Cfr D. FELINI, op. cit., pp. 117- 120
301 R. KUBEY, Think. Interpret. Create. How Media Education Promotes Critical Thinking, Democracy, Health
and Aesthetic Apppreciation. Fonte: http://www.medialit.org/sites/default/files/547_CIC_ML_Report.pdf
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
146
l’Aspen Institute nel 1992, ovvero: “1) i messaggi mediali sono costruiti [nel
senso che sono rappresentazioni intenzionali] e costruiscono le realtà; 2) i
messaggi mediali hanno implicazioni commerciali; 3) i messaggi mediali hanno
implicazioni ideologiche e politiche; 4) forma e contenuto sono correlati con
ciascun medium, ognuno dei quali ha una specifica estetica e suoi codici e
convenzioni; 5) il significato dei messaggi mediali è negoziato dai riceventi”.302
L’analisi, allora, viene concepita come una comprensione interpretativa dei
messaggi dei media che richiede la conoscenza di concetti e categorie appropriate
(tratti dalla semiotica) e l’uso dei nessi logici (prima\dopo, causa\effetto), la
capacità di determinare il genere del prodotto, di identificarne il significato, il
punto di vista e gli interessi politici e economici ad esso sottesi.
- Valutazione, atta a promuovere nei ragazzi giudizi sulla rilevanza ed il valore che
un messaggio ha per ciascun lettore, anche in termini di significato. Prevede
l’identificazione dei valori etici, estetici e culturali sottostanti un certo messaggio
ed il confronto tra questi e l’orizzonte axiologico del soggetto.
- Comunicare, consistente nella produzione di messaggi mediali, nei molteplici
formati (testuale, audiovisivo o digitale).
Possiamo quindi ritenere, attraverso questa considerazione preliminare sulla “cugina
anglosassone” della Media Education, che i temi di maggior interesse su cui basare
l’azione di ricerca e di intervento possono essere considerati, da entrambe, i seguenti: 303
1. Media Agencies: chi comunica e perché?
2. Media Categories: che tipo di testo è?
3. Media Technologies: come viene prodotto?
4. Languages: come sappiamo qual che vuole dire?
5. Audiences: chi lo riceve e come ne coglie il significato?
6. Representations\Constructions: come presenta il suo contenuto?
Questi tipi di domande sono definite «triangolari», in quanto non sono dirette (lineari),
ma passano attraverso la mediazione di un terzo soggetto. La M.E, infatti, si propone di
mettersi nei “panni” del soggetto in formazione, chiedendosi ciò che lui si dovrebbe
chiedere, rendendolo così, protagonista della riflessione.
302 P. AUDERHEIDE, op. cit., p. 80
303 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 27- 28
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
147
Per quanto riguarda, invece, le Teorie Interpretative, esse hanno ad oggetto la
progettazione curricolare nell’ambito della Media Education, organizzata secondo tre
ordini di criteri: il livello di scolarità, i temi riguardanti i media e le discipline. Per quanto
riguarda il primo criterio, la progettazione curriculare fa riferimento ad una sorta di
modello piagetiano, prevedendo per ogni fascia di età, degli obiettivi cognitivi da
raggiungere; il secondo criterio, invece, pone l’attenzione sul fornire all’insegnante una
tavolozza completa di tutti i temi educativamente rilevanti che si possono associare
all’insegnamento dei media. Infine l’approccio incentrato sulle discipline, privilegia lo
sforzo a declinare la Media Education secondo le specificità delle singole discipline.
Quest’ultima area d’interesse è stata acquisita nei paesi anglofoni, dove sono stati
elaborati dei curricula disciplinari che, individuando nella lingua inglese la disciplina cui
attribuire il lavoro didattico riguardo ai media, hanno permesso di inserire e costituire una
disciplina ad hoc: i Media Studies. Alcuni critici del settore, però, preferiscono
all’istituzione di una disciplina a parte, la creazione di curricoli trasversali304.
4.2.4. Teorie Interpretative
La Media Education è nata e si è consolidata tradizionalmente attorno al lavoro di
lettura critica dei messaggi. Questo approccio, se da una parte consente la costruzione del
senso critico del soggetto, dall’altra compie due importanti omissioni:
o La prima è relativa ai contesti, per cui il rischio è di isolare i messaggi delle
circostanze reali della loro ricezione con il risultato di aprire una forbice tra il
vissuto quotidiano dei ragazzi (in cui i media sono sempre contestualizzati) e la
situazione didattica in cui il testo viene smontato sotto la guida dell’insegnante.
o La seconda omissione è che l’analisi dei testi si realizza proprio in relazione agli
usi concreti che dei media e dei loro messaggi i soggetti fanno nella loro vita
quotidiana: in questo modo la Media Education, mentre si pone il problema di
come insegnare ad essi a leggere correttamente i messaggi dei media, non si
preoccupa minimamente di lavorare su come di fatto essi li leggano e in relazione
a quali appartenenze subculturali.
304 Id., pp. 71- 78
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
148
I Cultural Studies forniscono strumenti teorici utili a colmare proprio questa duplice
mancanza, consentendo alla Media Education di recuperare lo spazio dei contesti e la
centralità nel lavoro educativo e didattico sui media. Il contesto di un messaggio, di una
produzione mediale, nella prospettiva della Media Education è legato soprattutto al suo
spazio e al suo tempo.
Lo spazio va colto almeno in due sensi: lo spazio dei media, cioè la collocazione
nel palinsesto, in relazione al sistema complessivo di cui fanno parte; e lo spazio sociale,
ovvero il posto che i media vanno ad occupare nella giornata dello spettatore, il rapporto
che intrattengono con le sue altre pratiche di consumo quotidiane e l’importanza che
rivestono all’interno delle routines discorsive di cui è protagonista. L’iscrizione dei media
in questo duplice tipo di tipo di spazio produce effetti sulle aspettative dello spettatore e
influisce sulla sua comprensione dell’immagine. Lavorare educativamente sui contesti
significa, quindi, elaborare strategie adeguate a far cogliere questi nessi per raggiungere
una piena consapevolezza.
Lo stesso tipo di intervento va fatto sul tempo. Anche in questo caso
individueremo due tipi di tempi: il tempo dei media, che ha a che fare sia con la durata
che non l’emissione del messaggio; e un tempo sociale, che è il tempo dell’individuo e
dei gruppi entro cui il tempo dei media interviene producendo modificazioni e subendo
un processo di appropriazione. Educativamente trovano spazio e in questo campo tutte le
considerazioni sulla funzione dei media in ordine alla modificazione del tempo
individuale e famigliare, sulla loro funzione rituale.
4.3. Ricerca pragmatica
Per quanto riguarda il piano teorico della comunicazione, l’ideale della Media
Education parte dalla concezione pragmatistica della comunicazione. L’approccio
pragmatista sposta il focus dell’analisi dal semplice passaggio emittenza- ricezione, al
processo interpretativo che accompagna entrambi i momenti, ponendo al centro
dell’interesse non più il cosa viene comunicato e da chi, ma piuttosto il modo in cui i
soggetti e i gruppi sociali attribuiscono significato ai prodotti della comunicazione. Si
tratta di un ideale di comunicazione complesso, iniziato negli anni ’50 con la teoria degli
“Usi e gratificazioni” e seguito dai Cultural Studies sviluppatisi a partire degli anni ’70.
Questi studi hanno definitivamente liquidato il modello semplice e lineare del “pacco
postale” (Colombo), teorizzando una comunicazione che non si conclude quando il
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
149
“pacco” o messaggio giunge a destinazione, ma diventa un circuito complesso in cui si
compie una negoziazione tra pratiche comunicative differenziate e tra bisogni
diversificati, divenendo ambito privilegiato dell’esercizio di identità.
La Media Education, dunque, quale ricaduta educativa di tale problematizzazione della
comunicazione in ambito sociologico, si fonda su un’idea di comunicazione che, se da un
lato comprende i media come sistemi socio- economici di utilizzo delle tecnologie,
dall’altro ne evidenzia il ruolo di mediatori non tra cose (“i messaggi”), ma tra soggettività
sociali che si sviluppano dentro i contesti e le relazioni
Il visibile sociale che Sorlin indica come “ciò che i fabbricanti di immagini cercano di
cogliere per trasmetterlo” e che “il pubblico accetta senza stupore”305 su cui si dovrebbe
focalizzare l’attenzione educativa di un’ottica media oriented è uno dei luoghi privilegiati
della riproduzione sociale. Esso, infatti, opera al livello non sospetto di un senso comune
fatto di automatismi percettivi ed esprime tutto il suo potenziale in quel senso di paga
soddisfazione delle attese che attanaglia l’utente durante il consumo di comunicazione.306
Il fine di questo tipo di ricerca, quindi, è quello di individuare quelle esperienze
che possono essere ricondotte entro l’ambito della Media Education, ovvero di interventi
consapevoli e sistematici di educazione ai media. Il rischio che si potrebbe correre, in
questo ambito, è quello di puntare alla mera produzione tecnica, senza alcun tipo di
preoccupazione pedagogica.
Per organizzare l’analisi di queste metodologie è opportuno individuarne tre ambiti
principali:
- Il primo è quello relativo alle attività di costruzione\creazione. Si possono
ricondurre ad esso tutte quelle esperienze (dal giornalino, al video, al multimedia)
in cui l’intervento educativo non passa attraverso la promozione di adeguati
atteggiamenti di lettura consapevole dei messaggi, quanto piuttosto attraverso la
loro creazione;
- Un secondo ambito è costituito da manuali, quaderni operativi, guide didattiche
per insegnanti, ovvero da tutti quei materiali che sono funzionali a promuovere e
guidare le attività didattiche con i media.
305 P. SORLIN, Sociologia del cinema (trad. it.), Milano, Garzanti, 1979, p. 68
306 Cfr., M. G. ONORATI, Media, società, educazione. La Media Education come risposta educativa alle
istanze della complessità, in ONORATI M. G., T. GRANGE SERGI, a cura di, La sfida della comunicazione
all’educazion, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 62- 63
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
150
- Infine merita di essere preso in considerazione il settore dell’Educational, cioè
l’offerta di prodotti (libri, audiovisivi, multimedia) che garantiscono all’educatore
un supporto in funzione dell’intervento educativo riguardo ai media.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la rilevanza circa il “fare media” in classe è
sottolineata da alcuni aspetti quali: la produzione di effetti sulle pratiche educative, la
costruzione per gli allievi di un tipo di attività assolutamente originale e la possibilità di
elaborare nuove modalità di espressione, anche al di fuori del contesto scolastico.
Dal punto di vista pedagogico il valore che la Media Education riconosce alle attività
di produzione mediale in contesto educativo si può ricondurre a tre principali istanze: la
funzione conoscitiva del fare, la cooperazione come opportunità di apprendimento, la
funzione educativa del linguaggio. La prima istanza rinvia all’esperienza di Celestine
Freinet che nella sua idea di scuola dava maggiore rilevanza all’ “attivazione degli
allievi”, che si realizza attraverso le visite in contesto, i “resoconti liberi” degli allievi su
quanto hanno potuto osservare e la creazione di prodotti mediali. Didatticamente questo
tipo di scelta permette di saldare tra loro il momento dell’acquisizione di competenze e
quello della loro operazionalizzazione con grande vantaggio per l’efficacia
dell’apprendimento (seconda delle tre istanze a cui si è fatto riferimento pocanzi). Questo
nuovo modo di intendere la didattica, non fa riferimento semplicemente alla dimensione
laboratoriale, ma anche alla didattica “trasmissiva” basata, però, sulla riorganizzazione
cooperativa dell’apprendimento. “[…] non si apprende solo da una fonte esperta
(insegnante o software specialistico). Anzi, […] momenti importanti di apprendimento
avvengono anche quando i non “esperti” interagiscono tra loro, spostando così il focus
dalla modalità con cui i docenti insegnano al modo in cui gli studenti elaborano e
costruiscono le conoscenze tra loro. L’apprendimento collaborativo supera
definitivamente la metafora della “trasmissione” del sapere, puntando decisivamente a
una costruzione attiva della conoscenza da parte di tutti i partecipanti all’evento
educativo”.307 La terza istanza, che fa riferimento alla centralità dei linguaggi, riconosce
alle attività di produzione mediale una posizione di rilevanza in virtù delle sue valenze
conoscitive e metodologiche. Produrre media in contesto educativo facilita la riflessione
dei ragazzi sulle strutture di fondo del dispositivo linguistico poiché consente di verificare
le varie fasi della lavorazione (dalla scrittura, alla ripresa, al montaggio), gli snodi interni
307 B. LIGORIO, Come si insegna, come si apprende, Carocci, Roma, 2003, p. 45
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
151
dei fenomeni linguistici contribuendo a saldare insieme le diverse discipline e i singoli
saperi.
“Un educatore del XXI secolo deve saper padroneggiare e utilizzare la
comunicazione nelle sue diverse forme (oralità, multimedialità, in rete o fuori
rete), e saperne fare al tempo stesso una risorsa e un obiettivo di apprendimento
per l’educazione. I media sono partner cognitivi e agenti di socializzazione: è
urgente riconoscere che… esiste… una «mediacultura» di cui la scuola deve
tenere conto. È questo che permetterà di passare da un «nuovo relativo» – in
questo caso introdurre i media o le nuove tecnologie a scuola – a una vera
innovazione fondata sul desiderio di costruire un’altra società e, dunque,
un’altra scuola. Una scuola dove si impara, come sempre, qualcosa che non si
può apprendere altrove, ma a partire da ciò che si sa, si vede, si sente e si
comprende… delle modalità di comunicazione hic et nunc”.308
Per quanto riguarda, invece, la possibilità dell’elaborazione di nuove modalità espressive,
anche al di fuori del contesto educativo, si fa riferimento all’eventualità di trasferire la
scuola “dentro” i luoghi in cui i media vengono prodotti, eleggendo questi luoghi a vere
e proprie aule didattiche decentrate nel quadro di un’azione formativa coordinata ed
integrata, nella quale momenti di riflessione in classe, attività di laboratorio in scuola e
momenti di immersione nell’esperienza presso le imprese dei media (attraverso tirocini
formativi, stages) costituiscono gli ingredienti di un unico ed organico processo.
L’obiettivo è quello di produrre, attraverso il coinvolgimento del contesto professionale,
un’attivazione didattica ed educativa dei soggetti.
Tralasciando il secondo punto a cui si è fatto precedentemente riferimento, ovvero quello
che riguarda la produzione di manuali e quaderni operativi per gli insegnanti- perché poco
attinente ai fini della riflessione di questa tesi-, passiamo al terzo punto, l’Educational.
Con questo termine inglese si fa riferimento alla “produzione televisiva e audiovisiva con
308 J. JACQUINOT-DELAUNAY, “Dall’educazione ai media alle «mediaculture»: ci vogliono sempre degli
inventori”, in M. MORCELLINI, P.C. RIVOLTELLA (a cura di), La sapienza di comunicare. Dieci anni di
media education in Italia ed Europa, Erickson, Gardolo 2007, pp. 140-141.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
152
finalità educative”309, facendo riferimento anche dalla produzione multimediale off e on
line.
In sostanza questo tipo di produzione fa riferimento a quella vasta area della produzione
mediale che si rivolge intenzionalmente ai contesti educativi e viene quindi progettata e
prodotta per supportare l’insegnamento e l’apprendimento. Bisogna però notare, che non
sono tanto l’intenzionalità autoriale o la struttura intrinseca di un testo a decidere la sua
iscrizione o meno nell’ambito dei prodotti educational, quanto piuttosto gli usi concreti
di tipo educativo che ne vengono fatti. Il risultato di questa riflessione è che l’educational,
inteso come categorie di prodotti a sé non esiste, proprio perché nella creatività
progettuale dell’educatore e del formatore tutto può divenire educational.
Ne deriva un’ambivalenze di prospettive, entrambe legittime: una costruita sulla
produzione, dove sono le caratteristiche del testo a legittimarne la natura educativa, l’altra
basata sul consumo, in cui sono le scelte dell’educatore che convalidano la valenza
educativa del prodotto mediale.
Per quanto riguarda la prima prospettiva, possiamo individuare tre sottocategorie,
riconoscibili in relazione al tipo di scrittura attraverso la quale vengono prodotti:
o “Grado zero” della scrittura: riguarda tutti i casi in cui si registra un evento nella
prospettiva di riutilizzare la testimonianza che ne deriva in situazione didattica.
La scrittura è qui definita di grado zero perché non traduce un progetto, non segue
una sceneggiatura ma si limita a registrare i fatti, a documentare la realtà.
o “Grado medio” della scrittura: in questo caso di fa riferimento a un tipo di prodotti
studiati specificatamente per funzionare come sussidi didattici e costruiti in modo
tale da affidare la commento parlato il compito della mediazione didattica.
o “Grado forte” della scrittura: è rappresentato dalla cosiddetta “fiction didattica”,
cioè da tutti quei casi in cui la mediazione didattica viene fatta passare attraverso
le regole di genere della fiction (possiamo far rifermento, in questo tipo di
scrittura, al fenomeno, oggi tanto di moda, dei “Video- tutorial”, in cui proprio
attraverso un prodotto audio-video, si è in grado di trasmettere conoscenza).
Per quanto riguarda, invece, la prospettiva del consumo, possiamo individuare nove
modalità di consumo dei film:
309 F. LEVER, P.C. RIVOLTELLA, A. ZANACCHI, La comunicazione. Il dizionario di scienze e tecniche, Eri-
LAS-Elledici, Roma 2002, p. 418
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
153
1) Modo spettacolarizzante, che traduce l’esperienza di guardare un film come uno
spettacolo; sono enfatizzati i tratti di stupore per qualcosa di inatteso.
2) Modo finzionalizzante, in cui lo spettatore “vibra all’unisono con il film” e la sua
esperienza è immersiva e identificativa.
3) Modo favolizzante, in cui si attribuisce alla riproduzione una morale.
4) Modo documentarizzante, quando lo sguardo dello spettatore si rapporta al film
come a un documento sulla realtà.
5) Modo argomentativo\persuasivo, traduce l’esperienza di guardare un film per
ricavarne un discorso\insegnamento.
6) Modo artistico, in cui lo sguardo isola l’opera dell’autore (tipico del cinefilo).
7) Modo estetico, in cui l’attenzione dell’utente è concentrata sull’aspetto tecnico
delle riprese.
8) Modo energizzante, in cui avviene un coinvolgimento percettivo integrale.
9) Modo privato, proprio del cinema amatoriale e di famiglia. Questo tipo di sguardo
consente allo spettatore un ritorno esistenziale sul suo passato, per la sua vita,
rafforzando la coesione del gruppo a cui appartiene.
Di certo la presenza di questi modi di approcciarsi ai prodotti mediali, in particolare ai
film e a tutte le riproduzioni video, non è autoesclusiva, anzi essi possono coesistere.
Tutto dipende dal tipo di contesto entro cui il film viene visto e dalle intenzionalità
dell’enunciatore e dello spettatore.
4.4. Ricerca politica
La categoria entro la quale far rientrare la ricerca “politica” della Media Education
è il potere di convocazione, nel quale possiamo identificare due dimensioni: una politica,
che fa riferimento alla capacità di produrre determinati effetti; l’altra comunicativa, che
qualifica questi effetti nel senso di un richiamare autorevole, capace di attivare l’iniziativa
del destinatario della convocazione.
I destinatari di tale convocazione sono le istituzioni, la società civile, gli educatori (in
particolare insegnanti e genitori), gli apparati dei media e i professionisti in essi
impegnati. Nei confronti di tutti questi soggetti, la convocazione si articola a più livelli:
Livello educativo, poiché occorre convincere i decision makers e gli educatori
della necessità di fare azione educativa in relazione ai media e dell’opportunità di
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
154
sviluppare il senso critico, soprattutto nelle nuove generazioni, in relazione ai
messaggi e alle pratiche dei media.
Livello etico, nel senso di un richiamo alla responsabilità come atteggiamento
corretto da assumere da parte sia dell’emittente che del ricettore.
Livello istituzionale, cioè il richiamo della doppia istanza di un’attenzione ai
rischi della comunicazione mediale, soprattutto per il minore, che si traduca nella
richiesta di leggi e autoregolamentazione adeguate in un’organizzazione del
sistema dell’istruzione.
Questa triplice azione di convocazione ispira quelli che Van der Maren definisce due
ambiti fondamentali: la ricerca- azione, il cui obiettivo è di presentare l’azione come
soluzione del problema, e lo sviluppo di concetti, ovvero il tentativo di suscitare bisogni
attraverso l’introduzione di nuove strategie.310
Si può pensare alla ricerca prodotta nel campo della Media Education negli ultimi
trent’anni come un programma di accreditamento e certificazione del concetto stesso di
Media Education. Di questa ricerca sono parte integrante tre concetti: cittadinanza,
pensiero critico e l’idea del media educator come figura di educatore, nuova figura la cui
presenza è stata resa indispensabile dall’assunzione operativa dei concetti precedenti.311
“[…] i teorici esperti di Media Education, soprattutto in area anglosassone, sostengono
[…] che educare alla comunicazione significa costruire la cittadinanza e difendere la
democrazia”.312
Il tema della cittadinanza in relazione ai media è da considerarsi in relazione
all’idea di una nuova forma di educazione civica. Essa ha due funzioni fondamentali:
costruire comportamenti adeguati in una società democratica, trasmettere i valori e i
principi che la fondano e costruire una capacità critica. Queste funzioni vengono assunte
dalla Media Education per permettere: la partecipazione alla costruzione della cultura, la
necessità di apprendere e porre in atto comportamenti adeguati, l’autonomia e il senso
critico. Essi sono tutti aspetti che appartengono agli obiettivi tradizionali di chi lavora con
i media negli spazi educativi.
310 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 151- 153
311 Id., pp. 153- 154
312 P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 1998, p. 22
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
155
Sebbene il tema della cittadinanza sia caratterizzato da instabilità costitutiva, che non
permette di definirlo nello specifico, possiamo comunque individuare alcune dimensioni\
declinazioni che permettono, altresì, di individuare relativi ambiti di ricerca:
Diritti civili, ovvero la libertà della persona, sia in quanto individuo (di pensiero
o espressione), sia nella relazione con gli altri (di riunione e di comunicazione).
Nel caso della Media Education, il tema dei diritti civili si lega con la questione
del controllo politico e ideologico dei media, con il diritto di accesso agli
strumenti di comunicazione (digital divide), con i temi relativi alla privacy e alla
tutela dei soggetti deboli, soprattutto dei minori.
Cittadinanza politica, che racchiude i diritti più strettamente politici relativi alla
partecipazione del cittadino alla sovranità e alla sua possibilità di prendere parte
alle scelte dei poteri politici cui è sottomesso. In quest’area si colloca il lavoro più
“istituzionale” della Media Education, ovvero la mobilitazione della base sociale
attraverso la costituzione di associazioni di cittadini interessati ai temi dei media
e dell’educazione, il loro coordinamento, e la possibilità di poter esprimere il
proprio pensiero.
Cittadinanza sociale, che fa riferimento a quei diritti economici e sociali la cui
attribuzione non dipende dalla nazionalità e che attivano spazi di collaborazione
con le agenzie formative e le imprese dei media.
Cittadinanza culturale. In essa confluiscono tutti quei diritti che vanno
riconosciuti alle persone in virtù della loro appartenenza culturale.313
Uno degli aspetti su cui si fonda la cittadinanza, a cui si è già fatto precedentemente
riferimento, è la creazione di un pensiero critico, che coincide anche con il fulcro di ogni
progetto di intervento della Media Education. Possiamo definirlo utilizzando quanto
affermato da Ennis: “il pensiero critico è una forma di pensiero razionale e riflessivo che
è centrato sul decidere cosa credere e cosa fare”. 314 In base a questa definizione,
possiamo individuare le caratteristiche distintive del pensiero critico:
Un pensiero razionale, cioè basato sulla ragione e quindi impegnato nel doppio
“respiro” che è tipico del lavoro razionale, di analisi e sintesi dei fenomeni di cui
è spettatore.
313 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 154- 156
314 H. ENNIS, A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities, in J. B. BARON, R. J. STERNBERG,
Teaching Thinking Skills: Theory and Practise, W. H. Freman & Company, New York, 1987, p. 10
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
156
Un pensiero riflessivo, ovvero basato sulla consapevolezza dei processi cognitivi
con e per esso attivati.
Un pensiero in azione, quindi strategico che porta a prendere una decisione in
relazione ad un determinato problema.
Il pensiero critico, quindi, partecipa in una doppia natura: da una parte è legato al
pensiero logico- convergente, poiché richiede di sottoporre i messaggi dei media al vaglio
della ragione, di domandarci quale sia il fondamento delle affermazioni che sentiamo fare
e di verificare i passaggi logici dell’argomentare. Sul versante opposto, invece, il pensiero
critico si sposa con il pensiero divergente e si avvicina alla facoltà creativa perché richiede
di pensare in maniera differente rispetto alla massa, di staccarsi dal sentire comune e di
saper esprimere un’opinione originale e magari anche controcorrente. Il senso critico,
però, non è ipercriticismo ma discernimento applicato alle situazioni che quotidianamente
incontriamo e che implicano l’appropriazione personale di uno stile di vita, di un
ventaglio di valori e di una concezione del mondo. Solo se si è dotati di questi speciali
“anticorpi” si è in grado di non farsi condizionare dai messaggi che continuamente
vengono a bombardare la nostra realtà.315
Gli educatori parlano di pensiero critico inteso come un “insegnare a ragionare”, o
insegnare a ragionare “in modo analitico”. In questo modo lo sviluppo del senso critico
va di pari passo con quello delle abilità del pensiero in quanto tale.
Se facciamo riferimento alla tradizione di ricerca della psicologia cognitiva, possiamo
identificare il pensiero critico come la capacità di risolvere i problemi (problem solving),
l’attitudine a prendere decisioni (decision making) e la capacità di controllo riflessivo
sulle proprie attività cognitive (metacognizione).316“[…] si comprendere perché l’idea
del pensiero critico sia così importante per la Media Education: un soggetto capace di
ragionare in proprio, riflessivamente e in modo da informare le proprie scelte a una
capacità di giudizio valutativo autonoma, è un soggetto che può interagire con i media
senza la paura di essere condizionato dalle loro logiche comunicative e ideologiche”317
Possiamo quindi riassumere quanto detto sino ad ora sulla ricerca politica, dicendo che:
“Un’educazione ai media è insieme una pratica e un processo di tipo educativo destinato
a permettere ai membri di una collettività di partecipare in modo creativo e critico (a
315 D. FELINI, op. cit., pp. 194- 195
316 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 157- 159
317 Id., p. 159
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
157
livello di produzione, distribuzione e presentazione) all’uso dei mezzi elettronici e
tradizionali, allo scopo di sviluppare e liberare gli individui e la collettività e di
democratizzare la comunicazione”318
Questi obiettivi strategici della Media Education, vengono supportati dalla ricerca-
azione. Quando si parla di ricerca- azione (o di ricerca- intervento) si fa riferimento ad
una metodologia tipica delle scienze dell’educazione. Essa consiste nel prospettare un
intervento educativo che sia allo stesso tempo occasione di ricerca o nel pensare a
un’ipotesi di ricerca che offra spazio all’intervento educativo. Questa metodologia
permette di superare un limite annoso dei contesti educativi, ossia la frattura tra ricerca e
prassi: la prima spesso chiusa nell’astrattismo, la seconda spesso improntata a uno
sperimentalismo senza controllo scientifico.
Possiamo identificare tre forme possibili di ricerca- azione:
La ricerca- intervento funzionalista, centrata sul cambiamento del funzionamento,
mira alla riduzione di un eventuale disfunzionamento, senza modificare le finalità
o la visione del mondo del soggetto a cui è sottoposto. Il soggetto può essere un
individuo, un ente o una situazione.
La ricerca- azione di adattamento. Essa intende produrre cambiamenti di tipo
strategico o normativo, interni alla struttura su cui si intende intervenire. Ad
esempio, l’intervento di un media educator in una realtà educativa (soprattutto
scuole) volta a modificare le prassi decisionali e didattiche di quella realtà.
La ricerca- azione di trasformazione, che si propone di apportare cambiamenti
mettendo in discussione la relazione del potere con una determinata situazione. A
questo tipo di ricerca- azione si possono ascrivere tutte quelle esperienze che
intendono far pressione sulle istituzioni perché qualcosa possa cambiare nella
considerazione e negli spazi concessi alla Media Education.319
4.5. La Media Education in Italia
Vorrei, a questo punto ripercorrere brevemente il cammino e le sorti della media
education nel contesto italiano.
318 C. BAZALGETTE, E. BEVÒRT, J.SAVINO, L’éducation aux médias dans le monde. Nouvelles orentations,
BFI – CLEMI – UNESCO, Paris, 1992, p. 167, cit. in P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005. p. 49
319 Cfr P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2005, pp. 172- 174
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
158
L’espressione entra nel dibattito scientifico a partire dagli anni ’70, in Francia, e
si sviluppa in Italia negli anni ‘90 a seguito dell’affermazione delle tecnologie della
comunicazione, sempre più addentrate nel tessuto sociale e, in particolar modo, nella vita
quotidiana delle giovani generazioni. Una delle prime definizioni di Media Education in
Italia sottolinea il connubio tra le Scienze della Comunicazione e le Scienze della
Formazione, essendo intesa come “quel particolare ambito delle scienze dell’educazione
e del lavoro educativo che consiste nel produrre riflessione e strategie operative in ordine
ai media intesi come risorsa integrale per l’intervento formativo”320.
Per i cittadini le sollecitazioni vengono dagli organismi nazionali ed internazionali.
L’Onu e l’Unesco sono intervenute più volte su questo argomento: “Piuttosto che
condannare o esaltare l’indubbio potere dei media, noi dobbiamo accettare il loro
significativo impatto e la loro penetrazione nel mondo intero, come un fatto indiscutibile
ed anche apprezzare la loro importanza come un elemento di cultura del nostro tempo. I
sistemi politici ed educativi dovranno essere consapevoli del loro compito di promuovere
nei cittadini una comprensione critica del fenomeno della comunicazione”.321
Sul piano nazionale, invece, troviamo diverse associazioni che si occupano della
diffusione della Media Education322:
Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia
(CREMIT), attivo presso l’Università Cattolica di Milano, con lo sviluppo del
programma OMERO (Online Media Education Resources for Organizations)
orientato alla formazione degli insegnanti e all’intervento nelle classi scolastiche.
Osservatorio della Comunicazione (OSSCOM) e il Servizio di Psicologia
dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età Evolutiva (SPAE), sempre facenti
parte dell’Università Cattolica.
Osservatorio Mediamonitor Minori, attento alle abitudini e ai gusti delle
popolazioni giovanili, creatosi presso l’università La Sapienza di Roma.
AGCOM, l’Authority per la comunicazione relativa ai programmi tv, che
attraverso il Consiglio Nazionale degli Utenti rappresenta gli spettatori e gli utenti
dei media tutelandoli dall’uso distorto della Tv. L’Authority promuove ricerche
320 Cfr. P.C. RIVOLTELLA, op. cit., 2001 p. 37
321 Dichiarazione di Grunwald, 1982
322 Cfr U. MOSCA, ICitizen Media Literacy, rId.sta online dell’Università di Torino. Fonte: www.media-
italia.eu
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
159
nel campo della Media Literacy e raccomanda azioni di protezione dei minori a
contatto con i media.
Sempre in ambito governativo, il Ministero delle Comunicazioni si è distinto con
una serie di progetti relativi volti a informare insegnanti e genitori circa i rischi
dell’ICT (Information & Communication Technologies) e l’importanza della
Media Education su questi fenomeni.
MED (Media Education), un’associazione di docenti, educatori e professionisti
dei media, creata nel 1996 e volta a realizzare numerose e variegate azioni
formative rivolte alle generazioni più giovani
AIART (Associazione Spettatori Onlus), associazione culturale e di volontariato,
che si rivolge in particolare agli insegnanti e alle famiglie per aumentare la
consapevolezza nei confronti dei media;
Osservatorio sui Diritti dei Minori, creato nel 2001 da un team di sociologi,
psicologi, psichiatri dell’infanzia, ufficiali delle forze dell’ordine, esperti
nell’educazione dei giovani ed avvocati esperti nel campo dei diritti dei minori,
che promuove campagne e iniziative che aiutino i minori ad orientarsi nella
società dell’immagine e a difendersi dallo sfruttamento dell’immagine dei ragazzi
e dai contenuti che possono costituire un pericolo;
MOIGE (Movimento Italiano Genitori), il cui obiettivo è quello di creare
consapevolezza presso i genitori e le famiglie rispetto alla sicurezza nell’uso dei
media, in particolare la televisione e internet.
Associazione Megachip-Democrazia nella comunicazione, nata nel 2002 e
composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e media experts la cui attività si
concentra sull’analisi critica del sistema dell’informazione e della comunicazione;
Centro Zaffiria di Bellaria-Igea Marina, che lavora direttamente nelle scuole con
laboratori teorici e pratici e si è distinto in particolare con alcuni progetti dedicati
alla popolazione immigrata.
Associazione Culturale MediaEducation.bo (aME.bo) svolge una funzione di
informazione sui vari media e propone una varietà di servizi rivolti agli insegnanti
e ai genitori con un occhio particolare verso il pubblico dei più piccoli.
Museo Nazionale del Cinema di Torino, con un programma di visite, proiezioni e
laboratori,
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
160
Associazione AIACE Torino, che da decenni propone percorsi didattici, corsi di
aggiornamento e cicli di formazione.
Adiconsum, associazione creata nel 1987, che promuove l’utilizzo di internet e
delle nuove piattaforme tecnologiche con l’obiettivo di fornire ai ragazzi
competenze utili a contestualizzare l’informazione e a svolgere un ruolo attivo nei
confronti di essa
Nel campo della Media Industry (grande industrie di produzione mediale), attività di
Media Education sono state sviluppate principalmente dalla RAI. Innanzitutto dobbiamo
fare una breve considerazione. La RAI, Radio Televisione Italiana, è stata la prima
“promotrice” in Italia della Media Education, con il programma televisivo “Non è mai
troppo tardi”, in cui Alberto Manzi insegnava a leggere e scrivere a coloro che non lo
sapevano fare. Grazie a questo programma, infatti, sono state molte le persone che hanno
avuto la possibilità di colmare le proprie lacune linguistiche. Tornando ad oggi, sono
diversi i programmi con finalità educative promosse dalla televisione nazionale. In
particolare si fa riferimento alle attività di RaiTre e di RaiEducational, con programmi
come Blob, Screen Saver, Tv Talk e Melevisione. Anche SAT2000, oggi TV2000, il
canale della Conferenza Episcopale Italiana, si dedica alla produzione di contenuti di
Media Education.
Ancora nell’ambito della Media Industry viene segnalata un’altra iniziativa rivolta
al web: SicuramenteWeb, ideata da Microsoft Italia, focalizzata sui temi della
navigazione protetta dei minori sul Web e della sicurezza informatica, in collaborazione
con l’UNICEF. Sotto il nome SicuramenteWeb sono identificate tutte le attività e i
programmi che Microsoft realizza per sensibilizzare, sostenere e promuovere – in
particolare nei confronti di ragazzi, genitori e insegnanti – iniziative che abbiano un
impatto concreto in termini di sicurezza per i minori e per contribuire a innalzare i livelli
di consapevolezza e capacità reattiva nel Paese rispetto agli attacchi informatici.
Nel campo degli eventi culturali, infine, offrono un contributo decisivo alcune
manifestazioni dedicate alla rappresentazione dei giovani e alla loro diretta creatività: il
Giffoni Film Festival di Salerno, fondato nel 1971, che ha il compito di avvicinare il
pubblico giovane al mondo del cinema e dell’audiovisivo attraverso la partecipazione
all’attività critica come giurati; il Festival Internazionale CIAK Junior, ideato nel 1986 e
organizzato dal Gruppo Alcuni, che realizza tutta una serie di attività volte alla
produzione e alla diffusione di contenuti audiovisivi da parte degli studenti stessi e infine
il Sottodiciotto Film Festival, nato nel 2000 e organizzato dall’AIACE di Torino e dalla
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
161
Divisione Servizi Educativi della Città di Torino, che presenta diverse sezioni di
Concorso dedicate ai vari ordini di scuola e un Concorso di prodotti realizzati in ambito
Extrascuola.
Nell’abito dell’Extrascuola è da mettere in rilievo, un progetto innovativo e
stimolante promosso dalla Polizia di Stato dal titolo “Una vita da social” 323, progetto che
ha ad oggetto la sicurezza nell'uso della Rete rivolto agli utilizzatori dei social network e
in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai loro
insegnanti e ai loro familiari.
La finalità di questo progetto è quella di far comprendere l’importanza della legalità e
sviluppare una coscienza collettiva dei rischi e pericoli connessi ad un cattivo utilizzo
della Rete. La campagna di educazione alla legalità su Internet ha, per questo motivo, un
carattere itinerante su tutto il territorio nazionale che viene visitato gli specialisti della
Polizia all'interno di un autocarro.
Questi gli obiettivi che la Polizia si propone di raggiungere:
Sviluppare uno strumento in grado di promuovere una più matura riflessione
sull’uso responsabile e legale dei social network per prevenire comportamenti
compulsivi e/o illegali;
Informare genitori e insegnanti dell’esistenza di strumenti di controllo e di
restrizione d’accesso alla rete internet;
Fornire istruzioni su come installare ed usare un software di protezione.
Coinvolgere oltre 500.000 studenti dell’anno scolastico 2013/2014
Sino ad ora la partecipazione è stata molto ampia e il successo riscosso è andato oltre le
aspettative.
4.5.1. Un progetto di Media Education a Bari: “Reputazione
in rete”
Il Comune di Bari, con l’Ufficio Regionale per la Puglia e l’Università degli Studi
di Bari, hanno promosso un progetto di educazione ai media, dal titolo “Parli Facebook?
Prendiamoci per mouse! Identità, Socialità e Reputazione in Rete”, che ha visto coinvolte
18 scuole di Bari. Il progetto- pilota (è infatti il primo anno in cui si è realizzato) è stato
finalizzato a promuovere l’uso consapevole dei nuovi media tra gli adolescenti e gli adulti
323 https://www.commissariatodips.it/vita-da-social.html
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
162
Ha avuto inizio il 13 Dicembre 2013 e si è concluso il 9 Aprile 2014 con un incontro tra
i rappresentati delle diverse scuole, presso la biblioteca della scuola “E. Fermi” di Bari.
Dopo i primi incontri su una piattaforma Moodle riservata ai docenti coinvolti nel
progetto, coordinati dal prof. Baldassarre dell’Università di Bari e dalla professoressa
Anna Montefalcone, Consigliera incaricata del Sindaco di Bari per i Diritti di
Cittadinanza Digitale, sono iniziati i lavori con gli studenti nelle singole scuole.
Il progetto, ha avuto come “luogo d’incontro” virtuale, un gruppo chiuso su
Facebook, “Prendiamoci per Mouse”, in cui in questi mesi si sono confrontati molto
attivamente studenti, docenti e, recentemente, anche alcuni genitori, sull’uso consapevole
dei social network. Questo spazio virtuale si è arricchito di testimonianze e molti
documenti, video, riflessioni riferite sia ad eventi drammatici che a buone pratiche,
sperimentando così anche un esempio di gruppo “ideale” da creare su Facebook. I risultati
e le produzioni dei ragazzi sono state diversi e vanno dai testi scritti ai video, dalle
immagini a scene di animazione, ecc.
Il 20 marzo 2014, in continuità con gli obiettivi promossi dal progetto, le scuole hanno
incontrato la Polizia di Stato, impegnata nel suo tour informativo "Una vita da social”.
Tra i vari prodotti multimediali realizzati dalle diverse scuole, uno mi sembra
particolarmente identificativo e sintetico dell’esperienza: la Costituzione del Web 2.0,
realizzata dai ragazzi del liceo “E. Fermi”324.
In questo testo, composto da 13 articoli, si parla di “cittadinanza digitale” non come
alternativa a quella tradizionale, ma come vera e propria condizione di cittadino. Come
tale essa comporta diritti e doveri, tra cui troviamo il diritto di formarsi e informarsi e il
dovere di formare coloro che ci circondano. Questo primo punto, posto non a caso come
introduzione della Costituzione, mi sembra quello più importante e, al tempo stesso,
quello meno ovvio soprattutto per ragazzi adolescenti. In un’epoca in cui il “dare il buon
esempio” richiama alla mente modelli di vita forse troppo lontani dai ragazzi della
generazione 2.0, il “dovere di formare” richiama all’esigenza di essere testimoni di una
vita positiva. Il rispetto di questo dovere comporta, da una parte, la rielaborazione
personale di quanto sentito ed imparato, affinché si trasformi in stile di vita, dall’altra
l’esigenza di non tenere per sé queste conoscenze, di uscire dal proprio guscio, dal proprio
mondo e andare verso l’altro per insegnargli il modo giusto per stare nel mondo (digitale).
Altri temi toccati dalla Costituzione del Web 2.0 li possiamo così sintetizzare:
324 http://www.liceofermi.gov.it/index.php/studenti-25451/308-reputazione-in-rete
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
163
Il rispetto della propria e dell’altrui persona (art. 4 e 8), ovvero l’attenzione nel
non ledere i sentimenti altrui, rispettandone la privacy e, soprattutto, rispettandone
la personalità. Rispettare gli altri vuol dire, inoltre, anche presentarsi per come si
è, senza maschere, senza modificare la propria immagine o i propri dati personali,
nella piena sincerità e lealtà.
Il rispetto e la tutela del diritto d’autore (art. 5 e 12), attraverso riferimento diretto
all’autore, nel momento in cui si fa una citazione.
L’attenzione nel confrontare e ricercare diverse fonti relative ad una notizia (art.
11-12), per evitare di diffondere o comunque di credere vere notizie che in realtà
sono fake. Inoltre è bene sempre controllare se le informazioni che si vogliono
condividere sono di carattere personale o se contengono dati sensibili di altre
persone.
L’importanza di conciliare vita reale con la vita digitale (7-9-13), per cogliere in
entrambi i luoghi le opportunità che possono offrire, in ambito relazionale,
personale, lavorativo, formativo, ecc.
La necessità di prendersi del tempo prima di scrivere qualcosa di sgradevole a
qualcuno (art. 6), tempo che serve per ricordarsi che dietro a quello schermo in
realtà si trova una persona, della quale bisogna avere rispetto sempre e a
prescindere da tutto ciò che possa aver fatto o detto.
L’attenzione nei confronti dei materiali che si ricevono e che possono nascondere
virus, ma soprattutto nei confronti delle persone che entrano in relazione con i
ragazzi, che a volte possono essere malintenzionati (art. 10).
La scelta di concludere questo lavoro di tesi con un progetto di Media Education,
promosso nella mia città, da un professore di Pedagogia, non è stata fatta a caso.
Con esso, infatti, vorrei esprimere una doppia speranza: che tale progetto venga
riproposto al più presto, magari anche coinvolgendo più scuole e anche gli studenti
universitari, per dare un segnale positivo alla società e soprattutto un motivo per ricredersi
a coloro che vedono nei mezzi di comunicazione di massa solo un male dal quale stare
alla larga; e che questo comporti una rivalutazione del ruolo della pedagogia all’interno
della società, scienza che ha un ruolo centrale in tutti gli ambiti dello sviluppo umano.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
164
Conclusioni
Giunta alla fine di questo mio lavoro e dopo aver fatto riferimento agli illustri
studiosi della materia che, con le loro teorie, mi hanno permesso di strutturare la mia tesi,
vorrei ora esprimere quelle che sono le mie riflessioni ed aspettative circa il tema che ho
approfondito.
Il mio approccio a questo lavoro è stato duplice: da una parte di scoperta, in quanto ho
avuto modo di approfondire il tema dell’educazione ai media; dall’altro lato però, potrei
definirlo anche di sintesi, rispetto a tutto ciò che ho imparato in questi anni di formazione,
soprattutto in ambito pedagogico.
Questa tesi non ha la presunzione di essere un’attenta riflessione né sul fenomeno
mediatico, né tantomeno per quanto riguarda la Media Education. La mia ottica, più che
di una ricercatrice, potrei definirla di un’appassionata alla materia che, seppur con un
metodo di ricerca non professionale, ha cercato di portare avanti la sua idea: l’importanza
di educare ai media per permettere una crescita sana e umanizzante a tutti coloro che
vivono in quest’epoca.
Mi permetto di delineare in questa sede, alcuni ambiti di sviluppo, su cui, secondo
me, si dovrà investire il prima possibile, senza ulteriori indugi.
Innanzitutto, in ambito scolastico, in cui si sente il grande bisogno di una Riforma
che consenta una riorganizzazione interna (per quanto riguarda metodi di insegnamento
e i programmi ministeriali) che consenta anche di dare il giusto spazio ad un approccio
basato sull’educazione ai media, dei media e attraverso i media.
Quest’ azione non può prescindere da una riscoperta del ruolo educativo e formativo della
scuola, da concretizzarsi anche attraverso un’inversione di rotta circa le modalità di
valutazione degli apprendimenti, che condizionano pesantemente i modi e i contenuti
dell’apprendimento, piegando il processo di insegnamento sulle prestazioni e sulle attività
richieste dalla valutazione (“teach to test”).
Le modalità valutative tradizionali, infatti, si limitano ad accertare i processi cognitivi più
semplici ed elementari, congruenti con le caratteristiche delle prove strutturate, mentre
non sono in grado di apprezzare abilità più complesse quali i processi di analisi e sintesi,
la riflessione critica, soluzioni creative ed originali a problemi aperti ecc., determinando,
così, uno schiacciamento del processo formativo su un sapere di tipo riproduttivo.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
165
Inoltre il sapere scolastico ha anche il grosso limite di rimanere incapsulato nel contesto
scolastico e, quindi, di essere inadeguato a fornire conoscenze utili a situazioni di vita
reale. Tale incapsulamento si ripercuote anche sulla valutazione, la quale tende a basarsi
su compiti astratti e decontestualizzati, incapaci di agganciarsi a contesti reali,
significativi e comprensibili.
A causa del regolare impiego delle prove individuali; viene inoltre attribuito scarso rilievo
a prove di gruppo e ai correlati processi di comunicazione sociale, di confronto culturale
e di collaborazione, importanti nei contesti professionali e nelle situazioni reali.
Ciò evidenzia come la funzione prevalente della valutazione scolastica rimanga quella di
classificare gli studenti in rapporto alla qualità delle loro prestazioni e a giudicarli
attraverso il successo scolastico.
Oggi la scuola non può permettersi di restare ancorata a questo modello e soprattutto ad
una concezione di efficacia dello studente riscontrabile solo nella sua capacità di
riprodurre quando letto o ascoltato.
Si dovrebbe puntare, piuttosto, sull’ancorare a compiti autentici e significativi il sapere e
sull’opportunità di fornire feed-back immediati per studenti ed insegnanti.
Bisogna, quindi, mettere al centro del ripensamento dell’Istituzione scolastica il costrutto
di competenza e la relativa esigenza di passare da una valutazione delle sole conoscenze
e abilità ad una valutazione delle competenze, ovvero della capacità del soggetto di
impiegare produttivamente il proprio apprendimento per soddisfare i propri bisogni e
rispondere alle esigenze sociali, mettendo quindi in gioco non solo il suo sapere, ma anche
il suo saper fare e saper essere.325
È necessario allora che si prenda atto, una volta per tutte, di questa situazione, per poter
dare inizio ad una nuova scuola al passo con i tempi, in grado di dare davvero una “forma
mentis” ai ragazzi, valida anche al di fuori di essa.
Dopo queste considerazioni, vorrei concentrarmi su un’altra questione. Sino ad
ora si è considerato il lavoro di educazione ai media, prettamente dal punto di vista
scolastico. Da una parte questo è più che naturale, dato che la scuola è l’istituzione
preposta ad istruire e formare le generazioni, dall’altra, però, se vogliamo che l’operato
della Media Education sia realmente pregnante, non ci si può limitare a vivere tale
esperienza solo all’interno della scuola.
Questo per tre semplici considerazioni:
325 Cfr M. CASTOLDI, Valutare a scuola, Carocci, Roma, 2012, pp. 170- 174
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
166
- Gli alunni, sebbene siano impegnati in un progetto appassionante di scoperta, lo
vedono come un ulteriore strumento di valutazione. In questo caso
l’apprendimento sarebbe più che altro funzionale al voto che ad un reale interesse.
Ciò non esclude che questi temi possano suscitare nell’alunno interesse, ma questo
sarebbe sempre subordinato all’esigenza di avere un buon voto.
- L’attenzione rivolta ai media, se solo concentrata in un’unica parte della giornata
di questi ragazzi, rischia di non radicarsi pienamente nella loro vita, soprattutto
considerando che il tempo passato a scuola è sempre in misura inferiore rispetto
a quello passato nell’extra scuola.
- I genitori spesso manifestano delle difficoltà nel seguire questi ragazzi. Anche
loro necessitano di essere coinvolti in questi percorsi di Media Education. Il gap
digitale che spesso li allontana dai loro figli, rende difficile per loro vivere
pienamente il ruolo di educatori e formatori.
Per questi motivi si rende necessario che l’educazione ai media si estenda anche al di
fuori dell’ambito scolastico, per poter rendere più efficace la sua opera.
Innanzitutto nella famiglia, dove i genitori spesso sono impreparati a guidare i
propri figli in questo mondo virtuale. Capita non di rado di sentir parlare di episodi
spiacevoli in televisione relativi all’uso sbagliato e non consapevole dei media e questo
porta i genitori a demonizzare il mezzo. Questo atteggiamento, per quanto plausibile, si
rivela contro produttivo, sia perché così facendo, chiudono le porte alla comunicazione
con i loro figli, sia perché non hanno la possibilità di scoprire le reali opportunità del
mezzo.
Accanto a questa situazione, però, si assiste ad un altro fenomeno, anch’esso rischioso,
ovvero l’ingresso dei genitori nel mondo mediatico, con il relativo pericolo che anch’essi
si lascino abbindolare dal luccichio accecante dei mezzi di comunicazione digitale,
sottovalutandone o non considerandone i rischi.
Per questo c’è bisogno di un aiuto anche rivolto ai più adulti, perché in quanto educatori
e\o diretti fruitori di questi mezzi, siano in grado di riconoscere e di svelare ai loro figli
vantaggi e svantaggi dell’uso dei media. Naturalmente per farlo hanno bisogno di essere
aiutati, condotti. Ed è qui che subentra il lavoro di istituzioni quali la scuola o associazioni
culturali che possano fornire risposte al bisogno di aiuto dei genitori, attraverso incontri,
laboratori o dibattiti di approfondimento.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
167
Oltre alla scuola e alle associazioni, possono venire incontro a queste esigenze di
comprensione della realtà mediale, anche altre istituzioni, che hanno ad oggetto del loro
operato proprio la cura verso una crescita ottimale dell’essere umano.
In particolare faccio riferimento alla Chiesa e in modo specifico alle Parrocchie e agli
Oratori, in quanto luoghi attenti alla crescita dei ragazzi e alla serena gestione familiare,
di cui ho un’esperienza positiva e incoraggiante.
Gli Oratori possiamo definirli spazi dove i giovani crescono liberamente e dove è
possibile costruire relazioni educative più profonde, non vincolate ad esigenze di
programmi e curricula da seguire. In questi luoghi, in cui l’educazione dell’anima e
dell’Io più profondo sono il fine di ogni azione, non si può non dare spazio ai media.
In primo luogo da un punto di vista formativo, perché per le catechesi vale la stessa
riflessione fatta per i metodi scolastici: se impostati ancora su quelli tradizionali rischiano
di sortire solo l’allontanamento dei ragazzi. Inoltre i Media hanno una grande importanza
per la Chiesa, anche dal punto di vista apostolico: ad essa viene affidato il compito di
“abitare” i luoghi virtuali, per offrire una testimonianza diretta di un buon uso degli stessi.
A tal riguardo, mi piace portare un esempio positivo relativo al tema dell’abitare
i mezzi di comunicazione, rappresentato da un evento che ha avuto luogo quest’anno
proprio a Bari. Infatti, nei giorni dall’ 1 al 4 Maggio nella Parrocchia Maria SS.
Addolorata, oratorio Don Guanella, si è svolto il Meeting del Movimento Giovanile
Guanelliano, dal titolo “Tàggati per credere. Samaritani per le strade del mondo
digitale”, che aveva come oggetto il rapporto tra fede e media e in particolare, come si
evince dal titolo, la questione importante di come poter essere testimoni credenti e
credibili anche nella rete. Circa centocinquanta ragazzi, provenienti da diverse città del
Centro- Sud, hanno avuto modo di riflettere su questo tema, grazie anche alla
testimonianza di don Luigi Maria Epicoco, cappellano dell’Università dell’Aquila. In
questi giorni si è avuto modo non solo di riflettere sul ruolo che un buon cristiano
dovrebbe avere all’interno del mondo mediatico, ma anche su come i media possono
influenzare i propri comportamenti ed atteggiamenti e sull’individuazione di modalità di
utilizzo meno dipendenti e più consapevoli.
L’importanza di tale incontro sta proprio nel fatto che prima di questo, pochi sono stati i
ragazzi che hanno avuto modo anche solo di soffermarsi e di rendersi conto degli effetti
dei media sulla loro vita. Già l’aver permesso ciò è un elemento da non sottovalutare e fa
comprendere l’immensa risorsa che si cela dietro a quest’importante istituzione.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
168
Il compito degli oratori, e in generale della Chiesa, è proprio quello di educare i ragazzi,
attraverso modalità ludiche e insieme formative, ad un utilizzo positivo di questi mezzi.
Molte persone, ancora oggi, considerano i mezzi di comunicazione come nemici di un
vissuto cristiano profondo e credibile.
A tal proposito mi sembra doveroso richiamare le parole di Papa Francesco (il più grande
Media Educator dei nostri tempi), in vista della XLVIII Giornata mondiale delle
Comunicazioni Sociali, il quale, ci permette di interrogarci sulle modalità migliori per
abitare i luoghi del mondo digitale:
“Come allora la comunicazione può essere a servizio di un’autentica cultura
dell’incontro? E per noi discepoli del Signore, che cosa significa incontrare una
persona secondo il Vangelo? […] Trovo una risposta nella parabola del buon
samaritano, che è anche una parabola del comunicatore. Chi comunica, infatti,
si fa prossimo. E il buon samaritano non solo si fa prossimo, ma si fa carico di
quell’uomo che vede mezzo morto sul ciglio della strada. Gesù inverte la
prospettiva: non si tratta di riconoscere l’altro come un mio simile, ma della mia
capacità di farmi simile all’altro. Comunicare significa quindi prendere
consapevolezza di essere umani, figli di Dio. Mi piace definire questo potere
della comunicazione come “prossimità”.
Quando la comunicazione ha il prevalente scopo di indurre al consumo o alla
manipolazione delle persone, ci troviamo di fronte a un’aggressione violenta
come quella subita dall’uomo percosso dai briganti e abbandonato lungo la
strada, come leggiamo nella parabola. […] Oggi, noi corriamo il rischio che
alcuni media ci condizionino al punto da farci ignorare il nostro prossimo reale.
Non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè semplicemente essere
connessi: occorre che la connessione sia accompagnata dall’incontro vero. Non
possiamo vivere da soli, rinchiusi in noi stessi. Abbiamo bisogno di amare ed
essere amati. Abbiamo bisogno di tenerezza. Non sono le strategie comunicative
a garantire la bellezza, la bontà e la verità della comunicazione. Anche il mondo
dei media non può essere alieno dalla cura per l’umanità, ed è chiamato ad
esprimere tenerezza. La rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non
una rete di fili ma di persone umane. […] Proprio per questo la testimonianza
cristiana, grazie alla rete, può raggiungere le periferie esistenziali.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
169
Lo ripeto spesso: tra una Chiesa accidentata che esce per strada, e una Chiesa
ammalata di autoreferenzialità, non ho dubbi nel preferire la prima. E le strade
sono quelle del mondo dove la gente vive, dove è raggiungibile effettivamente e
affettivamente. Tra queste strade ci sono anche quelle digitali, affollate di
umanità, spesso ferita: uomini e donne che cercano una salvezza o una speranza.
Anche grazie alla rete il messaggio cristiano può viaggiare «fino ai confini della
terra» (At 1,8). Aprire le porte delle chiese significa anche aprirle nell’ambiente
digitale, sia perché la gente entri, in qualunque condizione di vita essa si trovi,
sia perché il Vangelo possa varcare le soglie del tempio e uscire incontro a
tutti.”326
La Chiesa, quindi, con la scuola, hanno il doveroso compito di stimolare nei ragazzi a
loro affidati, e anche i loro genitori, la riflessione circa l’impiego di tali mezzi e
soprattutto di favorirne un utilizzo educativo e realmente formativo.
Non è un caso se tra i soggetti a cui ho fatto riferimento, verso cui è importante una
rivoluzione digitale consapevole, ci siano le tre istituzioni formali tradizionali su cui si è
sempre basata la nostra società. Questo perché io credo fortemente non solo che esse siano
e saranno le colonne portanti della nostra società, ma anche che solo il lavoro sinergico
ed integrato di queste tre realtà potrà davvero contribuire ad un cambiamento significativo
della realtà. So che forse, allo stato attuale delle cose, tale situazione è a dir poco utopica.
Ma ho fede nell’uomo e nella sua capacità di trovare le strategie migliori per determinare
un suo cambiamento e nella pedagogia come scienza in grado di supportare ed orientare
questi propositi di bene.
326 PAPA FRANCESCO, Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 2014. Fonte:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-
comunicazioni-sociali.html
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
171
Bibliografia
ACONE G., La Paideia introvabile. Lo sguardo pedagogico sulla post- modernità, La
Scuola, Brescia 2004
ANDERS G., L’uomo è antiquato, Bollati Boringhieri, Torino 2007
ARENDT H., La banalità del male, Milano 1964
AUDERHEIDE P., Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on
Media Literacy, the Aspen Institute Wye Center, Queenstown Maryland, Dic. 7-9 1992
AUDIWEB, Ricerca di Base sulla diffusione dell'online in Italia, Dic. 2013
BARON J. B., STERNBERG R. J., Teaching Thinking Skills: Theory and Practise, W.
H. Freman & Company, New York 1987
BAUDRILLARD J., Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 1980
BELLINO F. (a cura di), Fare cose con la filosofia. Pratiche filosofiche nella consulenza
individuale e nella formazione, Apogeo, Milano 2005
BELLINO F., Per un’etica della comunicazione, Bruno Mondadori, Milano 2010
BENTIVEGNA, S., Disuguaglianze digitali: le nuove forme di esclusione nella società
dell'informazione, Roma- Bari, Laterza 2006
BERTOLINI P., L’apporto delle scienze dell’educazione alla formazione del media
educator, relazione al convegno “Nuove professionalità per i nuovi mercati della
formazione: il Media Educator”, Napoli, 12-13 ottobre 2001
BOCCHI G., CERUTI M., Educazione e globalizzazione, Cortina, Milano 2004
BOCCI V., Comunicare la fede ai ragazzi 2.0. Un proposta di catechesi comunic-attiva,
Elledici, Torino 2012
BORGES J.L., L’Aleph, Mondadori, Milano 1997
BUBER M., Il problema dell'uomo, ELLEDICI, Torino 1983
BRUSCAGLIONI M., La società liberata. Nuovi fenomeni, opportunità, categorie di
pensiero, Franco Angeli, Milano 1994
BUBER M., Il principio dialogico ed altri saggi, San Paolo, Milano 1993
CALVANI A., Educazione, comunicazione e nuovi media, UTET, Torino 2008
CALIGIURI M., Comunicazione pubblica, formazione e democrazia. Percorsi per
l'educazione del cittadino nella società dell'informazione, Rubbettino, Soveria Mannelli
2005
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
172
CASTOLDI M., Valutare a scuola. Dagli apprendimenti alla valutazione di sistema,
Carocci, Roma 2012
CAVALLARI A., La fabbrica del presente, Feltrinelli, Milano 1990
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Orientamenti pastorali dell’Episcopato
italiano per il primo decennio del Duemila. Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia, Ed. Paoline, Roma 2001
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e missione. Direttorio sulle
comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, Libreria Ed. Vaticana, Roma 2004
CHOMSKY N, Il bene comune, La Biblioteca di Repubblica- L’espresso, Roma 2004
DEBORD G., La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 2008
DE KERCKHOVE D., La pelle della cultura. Un’indagine sulla nuova realtà elettronica,
Costa & Nolan, Genova 1996
DE MARTIN J.C., Ma twitter non è un bar, in “La Stampa”, 11\05\2011
DE MARINIS M., Semiotica del teatro, Bompiani, Milano 1982
DE SAINT- EXUPÉRY A., Il Piccolo Principe, Bompiani, 2000
DEVOTO G., OLI G. C., Vocabolario illustrato della lingua italiana, Selezione dal
Reader’s Digest, Milano 1983
ECO U., Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa,
Milano, Bompiani, 1964
ELIA G., La comunicazione come creazione di uno spazio comune, in Quaderni di
Dipartimento, Università di Bari, Numero 8, Anno XI, Novembre 2008- Ottobre 2009
ELIA G. (a cura di), Le forme dell’educazione, Laterza, Bari 2006
ELIA G., Questioni di pedagogia speciale, Progedit, Bari, 2012, p. 46
ELIADE M., Mito e realtà, Borla, Torino 1966
FABRIS A., Etica della comunicazione, Carocci, Roma 2006
FELINI D., Pedagogia dei media. Questioni, percorsi e sviluppi, La Scuola, Brescia 2004
FERRAROTTI F., La perfezione del nulla. Premesse e problemi della rivoluzione
digitale, Laterza, Roma- Bari 1997
FERRI P., Nativi Digitali, Bruno Mondadori, Milano 2011
FRABBONI F., Il libro di pedagogia e didattica, Laterza, Bari 1998
GORE A., La società dell’informazione alle soglie del Duemila, in «L’Unità», 4/3/1995
HART A., La nuova alfabetizzazione, «Intermed», 1, 1998
JACQUINOT G., Les jeunes et les médias. Perspective de la recherché dans le monde,
L’Harmattan, Paris 2002
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
173
LEVER F., RIVOLTELLA P.C., ZANACCHI A., La comunicazione. Il dizionario di
scienze e tecniche, Eri-LAS-Elledici, Roma 2002
LEVY P., La Cybercultura, Feltrinelli, Milano 1999
LIGORIO B., Come si insegna, come si apprende, Carocci, Roma 2003
MARCEL G., L’uomo contro umano, Volpe, Roma 1963
MANTOVANI G., Comunicazione e identità. Dalle situazioni quotidiane agli ambienti
virtuali, Il Mulino, Bologna 1996
MASTERMAN L., A scuola dei Media. Educazione, media e democrazia nell’Europa
degli anni ’90, La Scuola, Brescia 1997
MCLUHAN M., Il medium è il messaggio. Un inventario di effetti, Feltrinelli, Milano
1968
MCLUHAN M., Gli strumenti del comunicare, Garzanti, Milano 1986
MELUCCI A., Il gioco dell’Io. Il cambiamento di sé in una società globale, Feltrinelli,
Milano 1991
MORCELLINI M., Comunicazione e Media, Egea, Milano 2013
MORCELLINI M. (a cura di), La scuola della modernità. Per un manifesto della Media
Education, Franco Angeli, Milano 2004
MORCELLINI M., La TV fa bene ai bambini, Meltremi, Roma, 1999
MYERS D., Psicologia sociale, Mc Graw- Hill, Milano, 2009
NEVEU E., Une société de communication?, Montchrestien, Paris, 1994
ONORATI M. G., GRANGE SERGI T. (a cura di), La sfida della comunicazione
all’educazione. Prospettive di media education, Franco Angeli, Milano 2006
PARK R. E., The natural history of the newspaper, in The American Journal of
Sociology, Novembre1923
PATI L., Pedagogia della comunicazione educativa, La Scuola, Brescia 1984
PASOLINI P.P., Scritti corsari, Garzanti, Milano 1990
PIETTE J., Éducation aux medias et function critique, L’Harmattan, Paris- Montréal
1996
PORCHER L., La scuola parallela, La Scuola, Brescia 1976
POSTMAN N., Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia, Bollati Boringhieri,
Torino 1993
PRENSKY M., Digital Natives, Digital Immigrants, in “On che Horizon”, NCB
University Press 2001
RIVA G., I social network, Il Mulino, Bologna 2010
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
174
RIVOLTELLA P.C., CARENZIO A. (a cura di), Ragazzi connessi. I preadolescenti
italiani e i nuovi media, dossier CREMIT 2008
RIVOLTELLA P.C. (a cura di), La sapienza di comunicare. Dieci anni di media
education in Italia ed Europa, Erickson, Gardolo 2007
RIVOLTELLA P.C., Media education. Fondamenti didattici e prospettive di ricerca, La
Scuola, Brescia 2005
RIVOLTELLA P.C., Teoria della comunicazione, La Scuola, Brescia 1998
RUBINI A., Pedagogia e politica. Il contributo dell’educazione per un educare alla
cittadinanza responsabile, Guerini, Milano 2010
SARTORI G., Homo videns. Televisione e post- pensiero, Laterza, Bari 2007
SILVERSTONE R., Perché studiare i media?, Il Mulino, Bologna 2002
SIMONE R., La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Laterza, Roma- Bari
2003
SORLIN P., Sociologia del cinema, Milano, Garzanti 1979
VAN DER MAREN J., La recherche appliquée en pédagogie. Des modelès pour
l’enseignement, de Boek, Bruxelles 2003
VATTIMO G., La società trasparente, Garzanti, Milano 1989
VOLLI U., Manuale di semiotica, Laterza, Bari- Roma 2000
Sitografia www.audiweb.it
www.censis.it
www.commissariatodips.it
www.cremit.it
www.istat.it
www.lacomunicazione.it
www.liceofermi.gov.it
www.media-italia.eu
www.mediaeducationmed.it
www.media.mit.edu
www.savethechildren.it
www.treccani.it
www.vatican.va
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
175
RINGRAZIAMENTI
La realizzazione di questo lavoro è frutto non solo dei tre anni di Magistrale, ma
di tutte le esperienze e conoscenze che ho accumulato in questi anni. Il mio primo
ringraziamento, quindi, va ad ogni professore che mi ho incontrato in questo percorso.
Ringrazio anche le persone che mi hanno guidato e formato durante i miei due tirocini e
durante l’anno di Servizio Civile, che nel bene o nel male, hanno contribuito a farmi
compiere un passo in avanti nella mia formazione umana e professionale.
Giunta alla fine di questo lavoro, non posso non guardarmi indietro e vedere che, ad ogni
passo del cammino, sono stata accompagnata, guidata ed incoraggiata dai miei angeli
terreni e non. A loro va il mio più profondo ringraziamento.
Grazie innanzitutto alla mia famiglia, fonte inesauribile di amore, fiducia e
coraggio.
Grazie a mio padre, che mi ha trasmesso il senso del dovere e del sacrificio, per amore
della famiglia.
Grazie a mia madre, che mi ha insegnato l’importanza di una vita completamente spesa
per amore, in ogni situazione e relazione.
Grazie a mio fratello, il vero Dottore della famiglia e mio punto di riferimento, che mi ha
trasmesso la passione per lo studio.
Grazie a Mary, sempre dolce e premurosa, ormai diventata per me come una sorella.
Grazie ai miei nonni, tutti e quattro, che continuano a vegliare sul mio cammino, di cui
sento forte la presenza accanto a me, soprattutto nei momenti di difficoltà.
Grazie ai miei zii, alle mie cugine e a tutti i parenti, di vario grado, che mi hanno
trasmesso sempre il loro amore e la loro fiducia.
Grazie ai miei pazzi amici, che riempiono ogni mio giorno di sorrisi, di attenzioni
e risate. Grazie a chi c’è sempre stato e a chi mi conosce da poco. Grazie anche a chi è
lontano, ma sempre presente in ogni evento importante, a chi, seppur vicino, c’è solo a
volte, ma su cui so di poter sempre contare.
Grazie perché arricchite la mia vita e siete le mie ancore di salvezza. Grazie per tutti i
momenti di gioia che mi fate vivere e per il sostegno e conforto che non mi fate mai
mancare.
Fosso Irma, “Educazione e comunicazione. Per una pedagogia della comunicazione dei nuovi media”
176
Grazie soprattutto perché siete uno splendido esempio di coraggio e amore, per come
portate avanti le difficoltà della vita, per come siete riusciti ad alzarvi dopo le tante
cadute. Il vostro esempio e il vostro amore per me vale molto di più di tutte le parole che
si possono dire.
Grazie alla mia seconda famiglia, la mia Parrocchia, e al Movimento Giovanile
Guanelliano. In particolare ringrazio la mia comunità, in ogni singola persona, sempre
pronta ad aiutarmi, a offrirmi un sorriso e una parola di fiducia.
Un grazie particolare va a Gabriella, sempre pronta a incoraggiare qualsiasi persona
che bussa alla sua porta, soprattutto per l’aiuto che mi ha dato per la realizzazione dei
pensierini della laurea.
Grazie ai ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni, dai più grandi ai
più piccoli, che mi riempiono ogni giorno di allegria e affetto.
Grazie ai preti che ho conosciuto attraverso il Movimento, ognuno di loro mi ha
insegnato qualcosa, mi ha dato qualcosa che non potrò mai cancellare né dimenticare.
In particolare voglio ringraziare don Santino, il mio parroco, colui che è diventato per
me come un secondo padre, che mi ha aiutato a crescere spiritualmente e non solo.
In ogni singolo ringraziamento precedentemente fatto, c’è sempre la traccia, la
presenza di colui che traccia il mio cammino, che mi guida e mi incoraggia.
Grazie a Te che mi sei sempre accanto, che non permetti che mi abbandoni a futili e
inconcludenti pensieri e mi dai sempre la forza di migliorarmi e continuare a camminare.