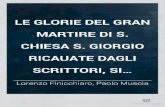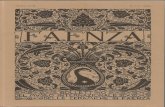martire di s. - chiesa s. giorgio - Fondazione Prospero Intorcetta
Antonio Labriola e il problema dell’espansione coloniale, in Annali della Fondazione Luigi...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Antonio Labriola e il problema dell’espansione coloniale, in Annali della Fondazione Luigi...
r
CHIARA OTTAVIANO
Antonio Labriola e il problema dell’espansione coloniale
Estratto dagli
ANNALIDELLA
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI
Torino - Voi. XVI - 1982
Chiara O ttaviano
Antonio Labriola e il problema dell’espansione coloniale
1, Le posizioni apertamente colonialiste di Antonio Labriola, connesse ad alcune affermazioni ai limiti del razzismo, hanno spesso costituito motivo di imbarazzo per molti degli studiosi del pensiero del filosofo socialista. L’imbarazzo è stato, com’è comprensibile, soprattutto fra quegli storici che hanno tentato una sorta di canonizzazione di Labriola in quanto padre spirituale della parte ideologicamente più consapevole del movimento operaio italiano. Il Labriola che discuteva da pari con Engels, che era giunto al marxismo percorrendo la via maestra dell’hegelismo, che avversava ogni compromesso ed ogni contaminazione positivista, sembrava difficilmente conciliabile con lo stesso che, isolato fra i socialisti, tacciava i pacifisti di « cretinismo organico » giacché sofferenti di « antico- lonite acuta ».
La tendenza è stata sovente quella di sorvolare su questi che apparivano lasciti spuri, confluiti poi, magari dopo essere stati patrimonio dei cosiddetti anarcosindacalisti, nel bagaglio di intellettuali sostenitori del regime fascista \ Non sono mancati tentativi di completa assoluzione dal peccato di colonialismo a; più spesso però, specie a proposito della famosa lettera ad Alfredo Baccarini del ’90, il caso è stato risolto come una
1. Roberto Michels in L’imperialismo italiano (Milano, 1914) si appellò a sostegno della legittimità dell’espansionismo coloniale anche all’autorità di Antonio Labriola, « l’Engels del socialismo italiano », che « nutriva la speranza che un giorno Tripoli potesse diventare la colonia ideale del proletariato italiano, capace di incanalare per secoli le forze elementari demografiche della nazione », ivi, p. 94. Sull’accusa rivolta a Labriola di « ambiguità » e « opportunismo » a proposito del « suo realismo nella questione coloniale » cfr, A. G u e r r a , Antonio Labriola e il « colonialismo », « Paese sera. Libri », 12 febbraio 1971.
2. Cfr. C. Carbone, L’anticolonialismo italiano durante la prima guerra d’Africa, «Studi storici», XIII, 1972, pp. 418-421.
20 .
306 CHIARA OTTAVIANO
sorta di incidente di percorso dovuto all’inesperienza politica del professore 3 4 5. Per l’intervista sulla questione di Tripoli invece si è sovente fatto riferimento al dibattito, allora alle prime battute, che i « revisionisti » ed i « socialimperialisti » stavano imponendo all’interno della Seconda Internazionale, così da far apparire relativamente meno grave quel peccato \ Altri, più apertamente, se non hanno proprio accusato Labriola di mancanza di leninismo, gli hanno però rimproverato l’incapacità di aver elaborato qualcosa che potesse reggere al confronto con quanto andava scrivendo negli stessi anni Rosa Luxemburg s. Di segno totalmente diverso è l’opinione di Dal Pane che ha spiegato la proposta del Novanta come dovuta alla maggiore consapevolezza di Labriola che «cominciava già a giudicare più in fondo alle cose dei suoi contemporanei » 6, mentre Giuseppe Are — evidentemente dello stesso avviso — ha interpretato l’isolamento del filosofo fra i socialisti come il segno di una maggiore chiarezza e lucidità di chi affrontava problemi estranei ad un dibattito interno attardato al mantenimento di vecchi miti solidaristici internazionali 7.
Obiettivo di chi scrive è dimostrare come i vari interventi sulla questione coloniale siano testimonianza del fatto che Labriola non era poi così irrimediabilmente estraneo a quella cultura da cui era circondato e da cui si vorrebbe che fosse rimasto del tutto incontaminato; né del tutto
3. Cfr. G. Arfé, I socialisti e le guerre d ’Africa, in: Omaggio a Nenni, Roma, 1973, p. 378; V. Gerratana, Introduzione a: Antonio Labriola, Scritti politici 1886-1904, Bari, 1970, pp. 58 segg.; V. Gerratana, Antonio Labriola e l’introduzione del marxismo in Italia, in: Storia del marxismo, voi. II, Il marxismo dell’età della Seconda Internazionale, Torino, 1978, p. 648; C. Dota, Il dibattito sul problema coloniale nella stampa socialista (1887-1900), «Storia contemporanea », X, 1979, p. 1061.
4. E. Ragionieri (Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani, Milano, 1976, p. 238) fa riferimento alle posizioni di Engels, in polemica con G. Manacorda che nella recensione a La prima guerra d’Africa di R. Battaglia (« Società », XIV, 1958, p, 1179) si rifà ai noti sviluppi delle posizioni di alcuni socialisti tedeschi. Lo stesso Ragionieri ritornando sull’argomento (in La storia politica e sociale, in: Storia d’Italia, voi. IV, Dall’Unità a oggi, 3, Torino, 1976, p. 1888) sottolinea il contesto storico italiano e il dibattito sugli orientamenti nuovi della politica estera. Sui problemi suscitati all’interno della Seconda Internazionale dai cosiddetti « social-imperialisti » si rinvia a F. Andreucci, La questione coloniale e l’imperialismo, in: Storia del marxismo cit., pp. 865-893.
5. F. Sbarberi, Il marxismo di Antonio Labriola, in: Antonio Labriola, Scritti filosofici e politici, voi. I, Torino, 1973, p. xeni.
6. L. Dal Pane, Antonio Labriola nella politica e nella cultura italiana, Torino, 1975, p. 218.
7. G. A re, La storiografia sullo sviluppo industriale italiano e le sue ripercussioni politiche nell’età dell'imperialismo, « Clio », X, 1974, pp. 283-284.
ANTONIO LABRIOLA E L’ESPANSIONE COLONIALE 307
isolate erano le sue posizioni nel confronto che su quei temi in Italia si stava svolgendo all’interno della sinistra, ancor prima del dibattito imposto dai « social-imperialisti ». La spinta verso l’espansionismo coloniale — che riscuoterà così ampio consenso nel nuovo secolo e che contribuirà al consolidamento del regime fascista — trovava in effetti già nella stessa area dei primi socialisti ed all’interno della cosiddetta cultura positivista, molte delle tesi a suo sostegno.
Rispetto a Labriola, inoltre, appare ancora una volta evidente quanto sia improponibile la vecchia spiegazione delle divergenze fra Turati e Labriola in quanto dovute all’essere uno organizzatore e politico e l’altro ideologo e dottrinario 8. È vero che gli interventi di Labriola avevano sempre un fondamento « dottrinario » (e spesso un intento pedagogico nello stimolare i socialisti ad una maggiore acquisizione di « ideologia ») ma al contempo aspiravano sempre ad incidere sulla realtà. La totale indissolubilità fra teoria e prassi era un principio tanto dichiarato quanto praticato. Ma come Labriola non era solo « teoria », allo stesso modo Turati non era solo « prassi ».
2. La lettera ad Alfredo Baccarini venne scritta nel febbraio 1890 e pubblicata per la prima volta su « Il Risveglio » di Firenze il 9 marzo; seguirono numerose ristampe su altri giornali. Proprio in quei mesi era in pieno svolgimento al Parlamento il dibattito intorno all’ordinamento della colonia Eritrea. Le opposizioni dei socialisti e dei radicali sul problema dell’opportunità o meno che l’Italia avesse una colonia apparivano polemiche del tutto superate, e di esse non è dato trovare traccia nei resoconti parlamentari. Le uniche vivaci discussioni si svolgono intorno al tipo di « colonizzazione » che lo stato italiano doveva scegliere di attuare dopo la conquista 9.
È questa la premessa di Labriola: « In Africa tanto ci siamo e ci rimarremo » è affermato laconicamente. « Ormai tutti i rimpianti sono vani »: « tocca ora di discutere seriamente e fortemente del modo di ordinare la colonia » 10.
Erano trascorsi alcuni anni da quando il professore dell’ateneo romano, dopo un debutto politico fra i conservatori — finito con la disillusione per l’inattuabilità di quella rivoluzione dall’alto che aveva creduto
8. Cfr. in riferimento al problema coloniale, M. B attaglia , La prima guerra (l’Africa, Torino, 1958, pp. 488-496.
9. Ivi, pp. 426 segg.; R. R a in er o , I primi tentativi di colonizzazione agricola e di popolamento dell’Eritrea (1890-1895), Milano, 1970, p. 21; I d e m , L’anticolonialismo italiano da Assab ad Adua, Milano, 1971, passim.
10. Antonio Labriola, Scritti filosofici e politici cit,, p. 107.
308 CHIARA OTTAVIANO
possibile — e dopo un non breve periodo di silenzio, aveva deciso il rientro nella politica attiva. Nell’86 era stato sul punto di presentarsi candidato alle elezioni nello schieramento radicale, quindi aveva partecipato a pubbliche manifestazioni in opposizione adoperato del governo, era intervenuto sulla stampa, aveva tenuto conferenze nei circoli operai. Nell’89 un ciclo di lezioni sulla rivoluzione francese era stato sospeso a causa dei disordini in aula suscitati da studenti poco propensi ad accettare lezioni da un professore socialista; nello stesso anno si riparlò di una nuova candidatura, anche questa poi non andata in porto, nello schieramento anticlericale 11.
La lettera di cui si discute è indirizzata all’on. Baccarini, uno dei ricorrenti interlocutori di Labriola in quegli anni.
Baccarini, che nell’83 si era dissociato dal governo Depretis insieme a Zanardelli, era esponente di quella sinistra radicale che, ponendosi seriamente il problema del recupero del ritardo economico del paese rispetto alle altre nazioni, vedeva nell’intervento dello stato nell’economia una necessità non rinviabile. A lui si deve la legge sulle bonifiche dell’82, che faceva ricadere i costi delle aree più vaste da bonificare sul bilancio dello stato, e l’opposizione fierissima condotta contro Depretis fautore dell’esercizio privato delle ferrovie 12.
Ad un ex ministro, sensibile alle istanze di modernizzazione della società civile, si rivolge dunque Labriola nella speranza di stimolare un intervento che ponesse il problema della colonizzazione dell’Eritrea « fuori dei termini ordinari della politichetta che corre ».
Le argomentazioni addotte sono quelle che in teoria avrebbero dovuto suscitare l’interesse di chi, come nel caso di Baccarini, fatte tutte le debite differenze, apparteneva a quella che potremmo definire l’area dei Kathe- dersozialisten di casa nostra. Si parla infatti di una nuova occasione of-
11. Per il percorso politico di Labriola cfr. soprattutto la già ricordata biografia di Dal Pane e il saggio di V. G erratana, Antonio Labriola e Vintroduzione del marxismo in Italia, cit.
12. Cfr. G. P. N it t i , Laccarmi Alfredo, in: Dizionario biografico degli italiani, voi. V, Roma, 1963, pp. 4-8. Sull’influenza esercitata dal modello bismarchiano anche su uomini della sinistra democratica come Baccarini e Seismid-Doda, cfr. V. Castronovo, La storia economica, in: Storia d’Italia, voi. IV, Dall’Unità a oggi, I, Torino, 1975, p. 91. Non si condivide invece il giudizio di G. Porisini (Le bonifiche nella politica economica dei governi Cairoli e Depretis, « Studi storici », XV, 1974, pp. 620-621) che vede nell’espandersi delle bonifiche grazie alla legge Baccarini solo un modo per « assicurare alla grande proprietà fondiaria un flusso continuo e crescente di spesa pubblica » senza contropartita.
Si ricorda inoltre che Baccarini, accanito sostenitore, insieme a Zanardelli e a numerosi deputati della Destra, dell’esercizio statale delle ferrovie, aveva proposto nel ’78 (allora ministro dei Lavori pubblici) ampi allargamenti della rete ferroviaria. Cfr. G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, voi. VI, Milano, 1974, passim.
ANTONIO LABRIOLA E L’ESPANSIONE COLONIALE 309
ferta a « questa grande lotta della giovane Europa contro tutta la corrente del liberismo economico », un’occasione che l’articolo 4 della legge proposta all’approvazione della Camera (« concedere a società, ed a privati italiani, indigeni e stranieri, terreni demaniali o di qual si voglia natura, e determinare le condizioni ») si lasciava evidentemente sfuggire. Tale articolo infatti — affermava Labriola non senza una punta d’ironia — sembrava ispirato « a questi stessi alti e nobili principi di economia sociale dai quali derivò l’esercizio privato delle ferrovie » (contro cui appunto si era battuto lo stesso Baccarini). In conclusione si accenna al segnale della nuova storia che viene dalla Germania; ed è da supporre che il riferimento, oltre che ai successi della socialdemocrazia tedesca, fosse anche nei confronti della politica di interventismo statale già da tempo attuata da Bismarck. In concreto la proposta di Labriola si sintetizza nel consiglio di non prendere decisioni affrettate: « teniamo la terra a titolo di proprietà di stato, ed aspettiamo studiando ». Il suggerimento è comunque di creare un sistema di coltivazione diretta o sussidiata provando le forme della partecipazione o della cooperazione. Tutto ciò perché non si percorrano le strade della « peggiore tradizione della politica coloniale » affidando la « terra ancora libera da ogni titolo di diritti storici e stabiliti in piena balia dei capitali d’impresa » e sottraendo così ai poveri contadini che emigrano nell’America del sud la possibilità « di cambiare direzione e di acquistare in Eritrea dei piccoli lotti, giacché nessuna misura di buon governo li sussidierà di capitali e degli altri strumenti di lavoro ».
Labriola dunque riteneva che l’occasione della colonia Eritrea potesse rappresentare (e per questo era un’occasione da non perdere) una soluzione in positivo per i « poveri contadini che emigrano ».
3. Il tema dell’emigrazione, com’è noto, accompagnerà in modo indissolubile il dibattito sul colonialismo italiano dalle prime spedizioni ottocentesche fino alle affermazioni espansionistiche del regime fascista13.
13. Cfr. R. Faucci, Elementi di imperialismo nell’Italia prefascista, in: L’imperialismo italiano e l’occupazione fascista della Jugoslavia, Urbino, 1979, pp. 19 segg.; G. Are e L. G iu st i, La scoperta dell’imperialismo nella cultura italiana del primo novecento, « Nuova rivista storica », LVIII, 1974, pp. 549-588, 1975, pp. 100-167; C. Dota cit.; G. D inucci, Il modello della colonia libera nell’ideologia espansionistica italiana. Dagli anni ’80 alla fine del secolo, « Storia contemporanea », X, 1979, pp. 427-480.
Il legame emigrazione-colonie (il riferimento era comunque quasi sempre alle colonizzazioni « storiche » intese come migrazioni di popoli) apparteneva ad un dibattito tradizionale fra gli economisti tedeschi. Spesso il convincimento era che l’emigrazione fosse una sorta di legge di natura atta a riequilibrare le condizioni fra popolazioni e risorse. Cfr. E. F. Schaffle, Struttura e vita del corpo sociale, « Biblioteca dell’economista », serie III, voi. VII, Torino, 1881, p. 190; Idem, Il sistema
310 CHIARA OTTAVIANO
L’uria e l’altra manifestazione erano d’altro canto corollari diretti di quella che fu, per tutto il secolo scorso, una sorta di ossessione demografica di vaga derivazione malthusiana, preoccupazione costante in quanti, pur partendo da diverse premesse ideologiche, finivano per concordare (e per convincere) sul fatto che in Italia una reale possibilità di riforme, che dovevano partire dalle campagne, si scontrava con il dato oggettivo di una popolazione esuberante rispetto alla disponibilità di terra u . Era un convincimento fondato in parte su elementi di realtà: l’indice del rapporto popolazione-terra coltivabile era infatti senza dubbio sfavorevole all’Italia rispetto a tutti gli altri paesi più avanzati15.
Così chi si opponeva alle imprese coloniali — se aspirava ad essere convincente presso la più ampia opinione pubblica — sapeva di dover fare i conti con questo tipo di argomentazioni più che appellarsi al diritto dei popoli (contro cui aveva gioco facile il principio del diritto della civiltà contro la barbarie) 18. Andrea Costa, che condurrà la propria opposizione contro ogni avventura coloniale (« né un uomo né un soldo ») re-
sociale dell’economia umana, ivi, serie III, voi. V, Torino, 1879, p- 828; F. E. Geffchen, Politica della popolazione, emigrazione colonie, ivi, serie III, voi. XIII, Torino, 1889; già prima W. Rosciìer, Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung, Leipzig und Heidelberg, 1856.
Kautsky si misurò spesso con questi temi; cfr. gli articoli apparsi nell’83 su « Die Neue Zeit » ed ora in K. Kautsky, La questione coloniale. Antologia degli scritti sul colonialismo e sull’imperialismo, a cura di R. Monteleone, Milano, 1977, pp. 38-54.
14. Era questo il convincimento di Pasquale Villari, di Leopoldo Franchetti, di Jacini, di Nitti, ed anche di Arturo Labriola, per fare solo alcuni nomi. Cfr. F. Manzotti, La polemica sull’emigrazione nell’Italia unita fino alla prima guerra mondiale, Milano, 1962, passim-, M. L. Salvadori, Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci, Torino, 1963, passim. Sui benefici effetti dell’emigrazione così un economista tedesco affermava tra l’altro: « E se avvenga che l ’emigrante, per procurarsi i mezzi necessari per emigrare, venda a basso prezzo case e fondi, ciò profitterà a coloro che rimangono, i quali in certo modo verranno così a partecipare, in qualche misura, ai vantaggi che toccano agli emigranti per l ’occupare che essi fanno quasi gratuitamente le terre dei nuovi paesi, dove portano la loro forza lavoro » (G. Lexis, Il consumo economico-sociale, « Biblioteca dell’economista », serie III, voi. XI, Torino, 1886, p. 884). Per le tesi degli economisti classici sul fenomeno dell’emigrazione e sugli effetti sui salari cfr. R. D. Collison Black, I classici e l’imperialismo, « Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali», XX, 1973, pp. 640-649 e 1071-1080 (ora in L’economia classica. Origini e sviluppo (1750-1848), a cura di R. Faucci e E. Pesciarelli, Milano, 1976, pp. 314-331). Per la vivacità del dibattito italiano su temi malthusiani nel corso degli ultimi decenni dell’800 cfr. T. I senburg, Il dibattito su Malthus e sulla popolazione nell’Italia di fine ’800, « Studi storici », XVIII, 1977, n. 4, pp. 41-67.
15. G. Are, Economia e politica nell’Italia liberale (1890-1915), Bologna, 1974, p. 156.
16. Su questo tema fra Bovio e Ghisleri si era svolta una lunga polemica nel- l’87 sulle colonne di « Cuore e critica ».
ANTONIO LABRIOLA E L’ESPANSIONE COLONIALE 311
spingeva le tesi avversarie sostenendo che in realtà non vi era alcuna sovrabbondanza di popolazione, e nel caso questa vi fosse, la soluzione si doveva ricercare airinterno del paese: in Sardegna, nell’Agro romano, nella Maremma vi erano ancora estesi territori non coltivati che era compito dello stato bonificare e poi assegnare ai contadini17.
L’opposizione alle spedizioni crispine era venuta però, con altre argomentazioni, anche da parte di quel largo schieramento liberale che così come si opponeva alla politica dei dazi protettivi, allo stesso modo respingeva una politica coloniale che appariva soprattutto determinata dal desiderio di allargamento dei confini nazionali entro cui potere affermare la politica protezionistica: si poteva sì tentare di indirizzare il flusso migratorio, ma questo doveva pur sempre, così come l’esportazione delle merci, poter scegliere la propria destinazione secondo le opportunità offerte dal mercato 18.
Anche Labriola aveva espresso un’opinione del genere. Il « Don Chisciotte della Mancia » registra nel gennaio dell’89 che il professore cassi- nate, riprendendo il corso di lezioni di filosofia della storia ed esponendo la differenza fra popolazione e società, aveva colto l’occasione per parlare dell’emigrazione sostenendo che la « colonizzazione di un paese straniero debba essere un fatto non imposto da alcuno, ma un movimento demografico spontaneo, per istinto, libero da ogni istituzione ». E a proposito dei possedimenti in Africa aveva aggiunto che inevitabilmente sarebbero rimasti « sempre deserti », mentre in America del sud vi erano centocinquantamila italiani e ve ne sarebbero stati sempre di più, ci fossero al governo Crispi o Fortis, Nicotera o Leone XIII 19.
Se si pensa alla lettera inviata a Baccarini solo pochi mesi dopo non può che sorprendere un cambiamento di idea davvero straordinario. Né è facile darne spiegazione se non tenendo conto della « crudalità » del biennio 89-90 nella vita di Labriola: la partecipazione a manifestazioni di piazza; il passaggio dall’area radicale a quella socialista; l’adesione al marxismo dopo aver subito, come si vedrà, sia pure per un tempo brevissimo, l’influenza di Loria. Coraggiose pubbliche risoluzioni ed inediti impegni politici si sommarono a nuove letture e a nuove suggestioni culturali, spesso dando luogo ad incertezze ed ondeggiamenti: le opinioni espresse intorno all’espansione coloniale italiana ne sono testimonianza.
17. A. Co s t a , Confronti storici e considerazioni economiche, ivi, 1887, pp. 140-142.
18. Cfr. G. A re - L. G iu s t i cit., passim.19. Gli articoli del «D on Chisciotte della Mancia » sono ripresi da N. S ic i
lia n i de Cu m is in Note su Antonio Labriola, « Studi storici », XII, 1972, pp. 619-620.
312 CHIARA OTTAVIANO
Ma Labriola non era stato il solo a cambiare idea. Nel frattempo infatti le inchieste che la Società Geografica stava in quegli anni conducendo per conoscere le reali opportunità dei lavoratori italiani all’estero rispetto all’accesso alla proprietà della terra (che questa opportunità vi fosse era stata opinione dominante specie nei confronti dell’emigrazione diretta verso l’America latina) incominciavano a delineare un quadro meno roseo di quanto fino ad allora si era ritenuto 20.
Per altro verso i successi conseguiti da un paese come la Germania, che per molti aspetti, non ultimo quello culturale, tendeva ad essere presentato come paese modello, imponevano una rinnovata attenzione anche per le componenti ideologiche e per le giustificazioni dottrinarie del protezionismo e dell’imperialismo bismarchiano. Johan Gustav Droysen decenni prima aveva sostenuto l’ineluttabile proiezione della politica europea in un sistema internazionale mondiale, e dunque l’idea che la Germania avrebbe dovuto spingersi ben oltre i confini europei21. Gustav von Schmoller aveva teorizzato la necessità della conquista dei mercati esteri — dopo l’esaurimento di quelli interni — pena la non sopravvivenza del capitalismo. Solo la Gran Bretagna (che aveva già un impero), la Russia e gli Stati Uniti, nazioni che possedevano vasti territori e altrettanto numerosa popolazione, avrebbero potuto astenersi — secondo Schmoller — dal cercare nuovi mercati all’estero. Per gli altri quella ricerca era vitale 22.
Le affermazioni sulla necessità della ricerca di nuovi mercati (in un momento in cui l’Italia non aveva poi né grandi quantità di merci, né capitali da esportare 23 ) non ebbero immediatamente il sopravvento, anche se dieci anni più tardi le cose si sarebbero profondamente modificate. Per il momento l’unico problema che appariva impellente era quello della esportazione delle braccia. Una diminuzione dell’offerta di lavoro in patria appariva un dato positivo ai fini del miglioramento delle condizioni
20. Cfr. G. D inucci cit., pp. 421 segg. e G. A re - L. G iusti cit., passim.21. Cfr. I. Cervelli, Stato nazionale e imperialismo in Germania, « Studi sto
rici », XVI, 1975, n. 1, pp. 5-8.22. I. Cervelli (ivi, p. 8) definisce Schmoller a tal proposito come « un ti
pico intellettuale organico rispetto alla linea dello svolgimento politico del suo paese prima e dopo la fondazione del Reich, prima e dopo la caduta di Bismarck del 1890 ». Per l ’imperialismo tedesco cfr. soprattutto H. U. W ehler, Crescita industriale e nascita dell’imperialismo tedesco, in: Studi sulla teoria dell’imperialismo, a cura di B. Owen e B. Sutcliffe, Torino, 1977, pp. 85-107. Le tesi dei Katheder- sozialisten furono ampiamente discusse da R. Luxemburg (L’accumulazione del capitale, Torino, 1968, pp. 281-286). Note interessanti in B. Semmel, Imperialism and social reform. English social-imperialism thought 1896-1914, London, 1960, pp. 18 segg.
23. Sulle oggettive condizioni economiche dell’Italia si rinvia, anche per i molti lavori cui fa riferimento, a R. Faucci, Elementi di imperialismo cit.
ANTONIO LABRIOLA E L’ESPANSIONE COLONIALE 313
della classe lavoratrice, ma non trovava giustificazione l’abbandono al proprio destino di lavoratori italiani e soprattutto lo spreco di quella che in ogni caso appariva una delle poche grandi ricchezze nazionali: l’energia del lavoro umano.
Mentre Labriola scriveva la sua lettera a Baccarini, alla Camera Leopoldo Franchetti, di ritorno dalla sua spedizione-inchiesta a Massaua, illustrava un progetto che, se attuato, doveva essere risolutivo del problema dell’emigrazione (ed è su questa base che ottenne il pieno consenso del neoconvertito colonialista Ferdinando Martini). « Dobbiamo noi lasciare le terre dell’altopiano incolte ed aspettare che il moltiplicarsi naturale delle popolazioni indigene produca coltivatori che hanno ancora da nascere? » domandava retoricamente Franchetti agli onorevoli colleghi sostenendo un piano che si caratterizzava per l’esclusione della possibilità di instaurazione del latifondo e per l’avversione contro ogni tipo di manovra speculativa 24. Ciò che veniva proposto era una esperimento di coltivazione dell’altopiano eritreo diviso in piccoli lotti affidati a famiglie contadine cui lo stato avrebbe dovuto anticipare capitali e strumenti. Le opposizioni ad un tale progetto non mancarono, così come le proposte alternative di colonizzazione 25.
Franchetti, senza dubbio, rappresentava quell’area moderata, ma sicuramente incline a progetti di riforma economica, a cui Labriola aveva con fiducia guardato un decennio prima; ora quei tempi erano passati e Labriola aveva già fatto pubbliche dichiarazioni di fede socialista. Eppure, evidentemente, Labriola non ritenne che la partita che si stava giocando in Parlamento fra i due schieramenti governativi (di San Giuliano si batteva, in opposizione a Franchetti, per offrire il maggior numero di possibilità a un massiccio impiego di capitali privati) fosse cosa di cui non valesse la pena occuparsi. La proposta contenuta nella lettera a Baccarini non sembrava proprio essere una proposta di « experimentum ad ab sur - dum », come Labriola stesso avrebbe dichiarato a Ghisleri in seconda battuta dopo le critiche di Engels e Turati, ma il tentativo di far pesare nella discussione anche l’opinione dei radicali e dei socialisti, magari con una proposta propria: quella di favorire le cooperative dei lavoratori. Che si tratti di questo, e non solo di un’occasione per far propaganda (che tipo di propaganda e quale diffusione di idee si esaminerà dopo), è testimoniato dal gran da fare che in quella circostanza si diede il professore (anche se con Ghisleri si sarebbe schernito dicendo che « buttando giù quattro parole da far leggere a un deputato » non si sognava « di far na-
24. Il discorso di Franchetti è ricordato da R. Battaglia cit., p. 525.25. Per quel dibattito si rimanda ai lavori già ricordati di Battaglia e Rainero.
314 CHIARA OTTAVIANO
scere una così seria discussione»2*1). Scrisse infatti un po’ a tutti: a Ghisleri inviò copia del « Messaggero » con la lettera di adesione di Achille Loria alla sua proposta; scrisse a Turati; si convinse che Turati fosse pieno d’entusiasmo per la « questione d’Africa »; sollecitò Ghisleri affinché si facesse al più presto una manifestazione a Milano: « Ma non c’è tempo da perdere »; scrisse a Loria perché intervenisse anch’egli in riferimento all’articolo 4 « a proposito delle nostre idee per la buona causa » 26 27. Scrisse anche al traduttore di Engels, Pasquale Martignetti. Le poche frasi della lettera inviata a quest’ultimo sono quelle che più possono illuminarci sulla « teoria » sottesa all’iniziativa di Labriola e che possono spiegare altresì il valore di propaganda socialista che egli vi scorgeva. « Scrivete per il “ Fascio ” un articolo sulla questione della terra Ubera — esortava Labriola. — Bisognerebbe che scriveste per far capire agli operai italiani, come io la questione l’abbia posta e che significato abbia. E poi eccitarli ad occuparsene. Far vedere che è il caso pratico dell’origine della proprietà borghese. Non vedete che gli operai bisogna istruirli? Combattere il capitale in aria? Fate presto ed una cosa piana ma efficace » 28.
Di « terra libera » parlerà ancora nella risposta a Turati (rendere commerciale la terra libera — spiegherà — significa aprire le vie al salario) mentre a Ghisleri scriverà che « fra i tanti che declamano a vuoto contro il capitale e contro la borghesia è bene che ci sia chi faccia vedere in modo pratico come il capitale nasca, perché lo sfruttamento che dicesi salariale sia insito nella natura della società borghese, a che cosa questa rivolga la forza dello stato, la finanza pubblica, il servizio militare obbligatorio, il patriottismo » 29.
4. Labriola non era sicuramente all’oscuro di quell’importante dibattito che si era svolto soprattutto all’estero (ma che aveva avuto i suoi
26. Le lettere di Labriola a Ghisleri sono state pubblicate a cura di P. C. Masini (Ventitré lettere di Antonio Labriola ad Arcangelo Ghisleri. 1888-1890), in « Rivista storica del socialismo », II, 1959, pp. 585-603. Qui, come sopra, si fa riferimento a quelle inviate fra il marzo e l’apriìe del 1890.
27. La lettera di Antonio Labriola ad Achille Loria e la risposta di Loria sono state pubblicate da R. F a u c c i, Revisione del marxismo e teoria economica della proprietà in Italia, 1880-1900: Achille Loria (e gli altri), « Quaderni fiorentini », V-VI, 1976-77, pp. 624-625.
28. La lettera di Labriola a Martignetti è conosciuta nella trascrizione che quest’ultimo ne fece in una lettera inviata ad Engels in data 2 6 /3 /’90 (K. M arx- F. E n g e l s , Corrispondenza con italiani 1848-1895, a cura di G. Del Bo, Milano, 1964, p. 364).
29. Ventitré lettere di Antonio Labriola ad Arcangelo Ghisleri cit., pp. 596-
ANTONIO LABRIOLA E L’ES PANS IONE COLONIALE 315
echi anche in Italia) a proposito dei primi stadi della società e della varietà dei sistemi della proprietà terriera. Un dibattito che, partito dagli storici tedeschi, e in particolare dai germanisti (si pensi a von Maurer, a Weitz, ai fratelli Grimm ecc.), arricchito dai contributi di Henry Summer Maine, era poi diventato argomento di polemica e battaglia politica contro l’assetto borghese della proprietà (il cui valore assoluto veniva messo in discussione dalle fondamenta) grazie agli scritti del belga Emile de Laveleye e, successivamente, agli echi della propaganda elettorale di Henry George, opinion maker di successo e riformatore agrario negli Stati U niti30.
Nella lettera a Baccarini si fa esplicito riferimento ad un « sistema di proprietà nuova » che potrebbe essere impiantato in Eritrea « con buona licenza di tanti dottori della legge, che insegnano e predicano il diritto con soverchio ossequio alle vecchie formule » e della colonia come una « terra ancora libera da ogni titolo di diritti storici e stabiliti ». La fonte prima cui fa riferimento Labriola è, comunque, facilmente individuabile. Si tratta àt\Y Analisi della proprietà capitalista di Achille Loria edita un anno prima dalla casa editrice dei Fratelli Bocca a Torino. « Si prepari l’ottimo mio collega Loria — si legge quasi a conclusione della lettera pubblicata sul « Risveglio » — ad aggiungere in una futura edizione del suo eccellente libro sul capitale, ai tanti che ha scritti, un nuovissimo capitolo, documento di esperienza paesana, sulla storia antisociale, antiumana, e anzi dirò cinica dell’iniquo sfruttamento che gli europei cristiani e civilizzatori praticano da secoli sulla terra libera d’Africa, d’America e d ’Australia ».
Se Labriola, appena entrato in corrispondenza con Engels, nell’aprile di quello stesso anno 1890, presentando se stesso e narrando dei suoi trascorsi, assicurava che si era « quasi completamente convertito alla concezione socialista » tra i 1879 e il 1880, è certo però che la prima lettura di Marx deve essere per lo meno fatta risalire dieci anni dopo, anche se il nome del fondatore del socialismo scientifico compare in uno scritto la- briolano già nel 1883. Ma il tipo di citazione che viene fatta non fa presupporre né una conoscenza diretta né un’opinione particolarmente positiva sull’amico di Engels 31.
30. Per gli storici tedeschi cfr, E. W. B òckenfòrde, La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decìmonono. Problematica e modelli dell’epoca, Milano, 1970; per il dibattito in Italia cfr. soprattutto P. G r o s s i , Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà nella coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1977. R. Faucci (Elementi di imperialismo cit., p. 27) intravede nell’intervento di Labriola sull’Eritrea un’eco diretta delle tesi di Henry George.
31. A n tonio L a b r io l a , Recensione a: F. von B a e r en ba c h , Die Socialwissen- schaften zur Orientìerung in den socialwissencbaftlìchen Schulen und Systemen en der Gegenwart. Kritisch und gemeinfasslich dargestellt (Leipzig, 1882), in « Ri-
316 CHIARA OTTAVIANO
Alla fine degli anni Ottanta Labriola, ancora non definita fino in fondo la sua adesione al socialismo, aveva avuto modo di leggere alcuni scritti di Loria, quelli che diverranno negli anni successivi i testi di lettura fondamentali della formazione di queiramplissima schiera di giovani socialisti. (Loria sarebbe per questo finito per diventare per Labriola una vera e propria « ossessione » —- come ebbe a dire Croce — giacché erano i suoi testi ad essere diffusi ed a sostituire la lettura di Marx fra i socialisti) 3i!.
È assai probabile che il professore cassinate si fosse già occupato di Loria nel corso delle lezioni di filosofia della storia delP87; sembra esservi infatti un chiaro riferimento ne I problemi della filosofia della storia a proposito di alcune tesi del Mario « ripetute di seconda mano, con minore efficacia e con altri intenti » 33. Si tratti o no di un riferimento a Loria (contro cui Croce ripetè in seguito l’accusa di aver plagiato anche Mario), è da rilevare in ogni caso che il giudizio di Labriola nei confronti di chi tendeva a «subordinare tutti i movimenti più importanti della storia civile al criterio della lotta per l’esistenza, e della distribuzione della proprietà e del lavoro » era già chiaramente espresso in termini negativi. Ma se la Teoria economica della costituzione politica — è questo il titolo del fortunatissimo volumetto di Loria edito nell’86 (in cui, utilizzando una larga serie di esemplificazioni, si formulavano tesi ispirate ad una concezione economica della storia con ampi prestiti marxiani) — suscitò l’interesse di Labriola senza però convincerlo, altro effetto ebbe la monumentale Analisi della proprietà capitalista 34. Tale affermazione non si fonda sul fatto che il volume viene ricordato nel corso della lettera al Baccarini o sulla lettera che Labriola scrisse al collega ringraziandolo e richiedendo
vista critica delle scienze giuridiche e sociali », I, 1883, ripubblicata in Antonio Labriola, Ricerche sul problema della libertà e altri scritti di filosofia e pedagogia (187t)-1883), a cura di L. Dal Pane, Milano, 1962, p. 333.
32. Cfr. C. Ottaviano, Una « disgraziata polemica »: Achille Loria e la « Critica sociale» (1892-1893), in: Gli Italiani e Bentham. Dalla «felicità pubblica» all’economia del benessere, a cura di R. Faucci, Milano, 1982, pp. 197-207.
33. Antonio Labriola, Scritti filosofici e politici cit., p. 10.34. La Teoria economica della costituzione politica fu recensita in Italia e al
l’estero sui più autorevoli periodici. Se Salandra ne parlò come di « un vero e proprio capitolo della filosofia della storia e di sociologia », sia pure intriso di « volterrianesimo meschino » (ora in A. Salandra, Politica e legislazione, Bari, 1915, pp. 241-259), Turati ne raccomandò caldamente la lettura all’amico Ghisleri (La scapigliatura democratica. Carteggi di Arcangelo Ghisleri 1873-1890, a cura di P. C. Masini, Milano, 1961, p. 103), mentre Ardigò, in una lettera inviata a Loria in data 4 /5 / ’86, manifestò accenti di vero e proprio entusiasmo (la lettera è conservata fra le Carte Loria presso la Sovrin tendenza Archivistica per il Piemonte e la Val d’Aosta a Torino).
ANTONIO LABRIOLA E L ESPANSIONE COLONIALE 317
ulteriori interventi, ma proprio sul dato che è fondamentalmente loriana la tesi di fondo della proposta sulla colonizzazione dell’Eritrea.
NAV Analisi della proprietà capitalista è sviluppato per intero il « sistema » che rese celebre l’economista mantovano. Si tratta di un « sistema » capace di spiegare per intero lo sviluppo della storia passata come anche l’evolversi di quella futura. L’elemento fondamentale è il rapporto terra-popolazione; la modifica di questo rapporto {che funge da filo rosso) determina il mutare tanto della struttura economica quanto della sovrastruttura (i termini sono proprio quelli di Marx). Così se in un primo stadio dell’umanità l ’abbondanza di terra libera e fertile aveva determinato l’esistenza di una società fondamentalmente democratica — giacché la disponibilità di terre libere da coltivare impediva la vendita del proprio lavoro o comunque la possibilità di sfruttamento — successivamente, dopo un atto usurpativo e con l’aumento costante della popolazione, la scomparsa di quelle terre libere aveva determinato la nascita della società capitalista. Questa, secondo una visione della storia per stadi, era stata nella prima fase una società schiavile, quindi feudale, dunque salariale. La vendita del proprio lavoro era diventata la caratteristica dominante della società salariale, una società irrimediabilmente divisa in classi contrapposte: da una parte i proprietari di capitali e di terre, detentori del potere assoluto, anche se mascherato sotto forme apparentemente democratiche, dall’altra i salariati alla completa mercé dei primi. Era anche poi prevista una classe intermedia di « lavoratori improduttivi » (burocrati, giornalisti, avvocati, militari, ecclesiastici ecc.) che, in cambio della partecipazione alla ricchezza della classe dei proprietari, assicurava il consenso sociale grazie a quelle che Loria chiamava le « istituzioni connettive »: religione, morale, diritto, opinione pubblica.
L’intimo legame con alcune affermazioni labriolane è evidente: « È bene che si faccia vedere in modo pratico come il capitale nasca » aveva scritto Labriola a Ghisleri; e a Turati: « Bisogna mettere sotto gli occhi dei proletari, non la questione astratta della proprietà e del capitale, ma dei casi concreti come quello dell’Eritrea, in cui si vede come nasce la proprietà borghese e come il capitale si impossessa della terra ». Il capitale, la proprietà borghese, avevano dunque la propria data di nascita nel momento in cui avveniva l’impossessamento esclusivo della terra per opera di alcuni, nel momento cioè in cui scompariva la terra libera. Questa era proprio la tesi di Loria, e come Loria aveva tentato di illustrare l’esattezza della propria ipotesi ripercorrendo la storia degli Stati Uniti d’America (le cui tappe, a suo avviso, erano identiche a quelle che avevano scandito la storia del vecchio continente, ed erano solo percorse in modo accelerato a causa di un aumento di popolazione anch’esso accelerato), così
318 CHIARA OTTAVIANO
Labriola pensava che la vicenda della colonia Eritrea — terra vergine e « senza storia » — potesse offrire una chiave di lettura evidente dei meccanismi usurpativi su cui era fondata la società capitalista.
È indubbio che esiste un’intima contraddizione nel pensiero di Labriola. Se infatti egli ritenne praticabile la sua proposta di colonizzazione, perché soluzione razionale rispetto ad alcuni problemi di ordine economico — l’emigrazione innanzi tutto — che dovevano essere risolti dal paese, allo stesso tempo non nutriva alcuna speranza che la classe dirigente italiana sarebbe riuscita ad adottare una politica di maggiore respiro e lungimiranza. Su questo secondo aspetto insisterà nella risposta a Turati, dopo che anche Engels si sarà dichiarato assai scettico sulla possibilità di affidare le colonie alla piccola economia contadina, giacché « tutti i governi sono troppo venduti e legati mani e piedi ai finanzieri e alla borsa perché gli speculatori non debbano impadronirsi delle colonie per sfruttarle a loro vantaggio » 3'\ Labriola vide così un alto valore di propaganda nella manifesta incapacità di una classe dirigente — anche di quella parte radicale e « democratica » — di dare soluzione ai problemi più generali non legati ad interessi particolari; contemporaneamente però non riusciva ad esimersi, e questo accadrà anche in seguito, dal mettersi nei panni di quella classe, indicandole le soluzioni da adottare. In più si aggiungono, come si è visto, le non troppe digerite tesi loriane, di cui in seguito non rimarrà alcuna traccia — essendosi Labriola, dopo la lettura di Engels, confermato nella sua originaria diffidenza e dopo aver trovato probabilmente già in Wakefield — anche questo per suggerimento del vecchio Engels — alcuni degli aspetti che più lo avevano interessato in Loria; tesi da cui derivava l’idea che l’affermarsi di soluzioni capitalistico-speculative in Eritrea poteva acquisire valore di parabola universale3e.
Engels, Turati e Labriola ritennero impossibile che il Parlamento potesse decidere per soluzioni antispeculative e che fossero avviati originali tentativi di colonizzazione a vantaggio di famiglie contadine 87. I fatti non diedero loro ragione visto che la Camera approvò il progetto di legge so- 35 36 37
35. K. Marx-F. Engels, Corrispondenza con italiani cit., p. 356. Uno stralcio della lettera fu pubblicato su « Cuore e critica » il 16 aprile 1890.
36. Engels già nella lettera a Martignetti a proposito dell’Eritrea aveva ricordato E. G. Wakefield (A view of the art of colonisation, London, 1848) a cui Marx aveva fatto riferimento nel 24° capitolo del I libro del Capitale. Loria trasse da Wakefield, spesso ricordato nei suoi volumi, buona parte degli elementi costitutivi del suo sistema. Croce avrebbe poi sostenuto il plagio di Loria anche nei confronti di Wakefield.
37. La discussione fra Labriola e Turati, insieme alla lettera di Engels, con il titolo La questione sociale e la colonia Eritrea, fu pubblicata su « Cuore e critica »• del 16 aprile 1890.
ANTONIO LABRIOLA E L’ESPANSIONE COLONIALE 319
stenuto da Franchetti. Quel progetto poi sostanzialmente fallì, ma ciò si deve ad una ampia serie di fattori, non certo alla protezione di quelle previste forze capitaliste e speculative 88.
A parte questo tipo di considerazioni, dalla risposta di Engels Labriola non potè trarre nessun tipo di preclusione di principio alle imprese coloniali. Il vecchio amico di Marx si attenne infatti scrupolosamente al problema di che cosa potessero chiedere i socialisti al governo circa i nuovi demani, senza sfiorare minimamente il problema dell’approvazione o meno dell’espansione coloniale. Quante oscillazioni ci fossero in Engels rispetto a questo tema è stato ampiamente documentato 38 39 (un numero di incertezze pari forse a quello sul tema della piccola proprietà, la lettera indirizzata a Martignetti in risposta a Labriola è un documento indicativo anche riguardo a questo aspetto). Né d’altra parte Labriola, che pure accettò in questa occasione il punto di vista di Turati, riuscì poi a convincersi delle irriducibili posizioni anticolonialiste di quest’ultimo.
5. In parlamento i socialisti per tutti gli anni Novanta continuarono a mantenere posizioni coerentemente contrarie ad ogni impresa coloniale. Era Andrea Costa in genere a prendere la parola per dichiarare il dissenso del proprio gruppo nei confronti di richieste di aumento di spesa per gli stanziamenti africani; anche dopo la disastrosa sconfitta di Adua venne ripresentata la mozione per il « ritiro delle truppe » 40. Queste erano le posizioni maggioritarie ed ufficiali del PSI, ma il dibattito interno, ospitato soprattutto sulle colonne della « Critica sociale », mostrava un’ampia varietà di opinioni. Spesso venivano discusse positivamente esperienze di colonizzazione (il termine era usato essenzialmente per le colonie di popolamento) sia pure escludendo ogni risvolto di tipo militare; e nel ’93, alla vigilia dell’accantonamento dell’esperimento franchettiano, il giovane Arturo Labriola con un articolo Un po’ d’Africa tentò chiaramente di riproporre il tema dell’utilizzo della colonia eritrea come soluzione del problema delPemigrazione 41. A suo avviso era infatti precipuo interesse dei
38. Su questo concordano sostanzialmente le opinioni di R. B attaglia cit., pp. 525 segg. e di R. R atnero, I primi tentativi di colonizzazione cit., pp. 143 segg.
39. Cfr. F. A n d r e u c c i, Engels, la questione coloniale e la rivoluzione in occidente, « Studi storici », XII, 1971, pp. 437-480; G. H a u p t - C. W e il l , L'eredità di Marx ed Engels e la questione coloniale, ivi, XV, 1974, pp. 270-324.
40. Per le posizioni ufficiali del partito socialista, oltre agli studi già ricordati, cfr. anche E.S.M.O.I., Attività parlamentare dei socialisti italiani, voi. I-II, Roma, 1967-1970.
41. A r tur o L a b r io l a , Un po' d’Africa, « Critica sociale », a. 5, n. 13, 1° luglio 1895, pp. 196-199. Per il dibattito sulla « Critica sociale » cfr. più in generale C. D o t a , Il dibattito sul problema coloniale nella stampa socialista (1887- 1900), «Storia contemporanea», X, 1979, pp. 1047-1087.
320 CHIARA OTTAVIANO
socialisti « favorire le grandi correnti dell’emigrazione » che avrebbero rallentato « la tenace concorrenza fra i lavoratori della madrepatria ». Era da preferire l ’emigrazione delle famiglie contadine verso i paesi dove queste potevano diventare proprietarie delle terre che lavoravano. Non si negavano i buoni propositi contenuti nel progetto Franchetti, ma quest’ultimo, sosteneva Labriola, era un sognatore e il suo piano era « troppo intinto di socialismo ». L’occasione era colta per intervenire anche sulla questione della piccola proprietà, leit-motiv dei congressi internazionalisti in quegli anni12. La soluzione della proprietà coltivatrice presentava — a giudizio del giovane articolista — « non pochi germi di socialismo » quando venivano affermati i concetti di inalienabilità ed indivisibilità del possesso. L’obbligo del lavoro diretto della terra con le, proprie braccia {elemento presente anche nel progetto di Franchetti) era garanzia contro la possibilità di sfruttamento. Ed ecco come viene spiegato il motivo per cui la piccola proprietà non era in contraddizione con i programmi collettivisti dei socialisti: « Ora, poiché il comuniSmo non è possibile se non là dove i mezzi di produzione sono monopolio di pochi — affermava Arturo Labriola che ricorderà nelle sue memorie di essersi accostato al marxismo attraverso i libri di Achille Loria 42 43 — e l’infinita maggioranza è alle dipendenze di essi, come reazione a questo stato di fatto; per adesso non avrebbe per sé nessuna giustificazione non solo l’appropriazione comunistica del suolo africano, ma anche la sua gestione comunistica. Del resto la storia delle colonie prova che, al loro inizio, l ’associazione dei produttori ed il controllo sociale della proprietà è impossibile » 44. Non mancò di essere ricordato il dibattito del ’90, e alla autorità dei contendenti di allora, Antonio Labriola ed Engels, il giovane napoletano si appellò a sostegno delle proprie tesi.
6. Profondamente diversi furono i termini in cui venne affrontato, sempre sulle colonne della rivista di Turati, il problema dell’espansione coloniale alla fine del secolo. Di colonie di popolamento si parlò infatti sempre meno e sempre più invece andò affermandosi l’idea dell’impe- rialismo legato alla necessità del sistema capitalistico di acquistare dimensioni mondiali. Olindo Malagodi, con le sue corrispondenze dal-
42. Sul dibattito intorno alla piccola proprietà all’interno della Seconda Internazionale cfr. H. G. Le h m a n n , Il dibattito sulla questione agraria nella socialdemocrazia tedesca e internazionale. Dal marxismo al revisionismo al bolscevismo, Milano, 1977.
43. A rturo L a briola , Spiegazioni a me stesso. Note personali e culturali, Napoli, 1945, pp. 38-53.
44. I d e m , Un po’ d’Africa cit., p. 198.
ANTONIO LABRIOLA E L ’ESPANSIONE COLONIALE 321
l’Inghilterra, informava sulla complessità di un fenomeno che aveva del fisiologico — rispetto alla natura del sistema industriale — e che era riuscito ad ottenere il consenso di parte della classe operaia britannica. Claudio Treves, a proposito della spedizione in Cina, opponendosi a Turati, aveva affermato la non opportunità per il partito socialista di « straniarsi dalla conquista capitalista dell’Asia », giacché quello era il senso della storia e non era possibile contrastarlo. Ivanoe Bonomi manifestò accenti entusiastici per l ’ingresso di nuovi popoli nel grande campo della produzione mondiale in seguito alle guerre commerciali:« E il socialismo — scriveva in un articolo intitolato La politica internazionale e il proletariato, pubblicato nel febbraio del 1900 — , che deve servirsi della produzione mondiale moderna, per ripartirla non più coi criteri di classe, ma col più equo criterio della individuale attività di lavoro, non può che essere lieto di questo nuovo slancio e di questa nuova diffusione della produzione capitalistica. Infatti, più essa avrà accumulate le ricchezze che danno col benessere materiale la possibilità di una maggiore elevazione intellettuale, e più l’umanità futura, entrandone in possesso sarà vicina ad una felicità superiore » 48.
In Parlamento il gruppo socialista — sulle cui posizioni si trovava sostanzialmente Turati — continuò a battersi contro ogni impresa militare. L’opposizione ai progetti governativi non si richiamava però a nessun ideale risorgimentale di indipendenza dei popoli, né si arroccava su posizioni di pregiudiziale ripulsa per il fenomeno imperialistico: ciò che si sosteneva era la non convenienza e la non opportunità di imprese del genere, viste le condizioni dello sviluppo dell’industria italiana. Così nel ’99 Bissolati dichiarò a proposito della spedizione in Cina: « Noi socialisti, rappresentanti del proletariato, diciamo che no. In ciò siamo d ’accordo con i rappresentanti delPindustrialismo più sviluppato, dell’industrialismo dell’alta Italia. [...] Noi lo abbiamo sempre detto, e lo ripetiamo, che lo sviluppo del socialismo è condizionato dallo sviluppo dell’industrialismo; noi, come ombra inseparabile seguiamo lo sviluppo del capitale industriale » 46. Quest’ultimo si oppo-
45. Olindo Malagodi sviluppò i temi trattati nelle corrispondenze all’estero per la « Critica sociale » fra il 1898 e il 1899 ne L’imperialismo. La civiltà industriale e le sue conquiste. Studi inglesi, Milano, 1901. Cfr. anche l’articolo di C. T r e v e s , Proprio « né un uomo né un soldo »? Una diversa campana, in « Critica sociale », a. 10, n. 14, 16 luglio 1900, pp. 211-213. Antonio Labriola espresse pubblicamente la propria adesione alle tesi di Treves nella lettera inviata al direttore della « Tribuna » nell’agosto di quello stesso anno (ora in A nto n io L a b r io l a , Scritti politici cit., pp. 460-463). Di I vanoe B o n o m i cfr. La politica internazionale e il proletariato., in « Critica sociale », a. 10, n. 4, 16 febbraio 1900, p. 52.
46. E.S.M.O.I. cit., voi. I, pp. 490-492. 21
2 1 .
322 CHIARA OTTAVIANO
ne va all'impresa perché non vi era alcuna convenienza ad intraprenderla: impossibile era pensare all'esportazione dei prodotti e velleitario pensare a quella dei capitali47. Era dunque un’impresa voluta dalle forze improduttive: « Lo stato italiano — si legge nel resoconto dell’intervento di Bissolati — è nelle mani del partito militare e dell’altis- sima burocrazia ed era naturale che i loro interessi facessero valere ». Nel corso dello stesso dibattito parlamentare Ferri affermava: « In questi ultimi anni è avvenuto nella politica internazionale il contagio del così detto imperialismo coloniale [...]; l ’Italia ha voluto adottare questa politica imperialistica senza avere nelle sue condizioni anteriori le ragioni della propria espansione » 48. Alcuni anni dopo lo stesso Ferri avrebbe precisato: « L’espansione coloniale deve essere non l’espansione fittizia di una velleità di conquista a cui mancano i mezzi, ma deve essere (ed è la sola sua giustificazione) la espansione irrefrenabile di un organismo sociale che si senta costretto nei suoi confini naturali ». L’Italia non si trovava affatto in queste condizioni49.
Siamo proprio alle prime battute del dibattito sull’imperialismo. Esso appare come conseguenza naturale del sistema capitalistico, che ha sempre bisogno di investire, di trovare nuovi mercati, di esportare capitali. Il problema dei socialisti italiani era quello di riuscire a misurare quale fosse la reale distanza fra questa fase di massima espansione, che preludeva al crollo (ed allora sarebbe stato il tempo della classe operaia, una classe cresciuta in numero e consapevolezza con lo sviluppo stesso di quel sistema) e il momento storico che si stava vivendo. Per Bissolati, Ferri, Turati e decotti l’Italia era ben lontana dal dover affrontare il suo momento di espansione, assai meglio sarebbe stato per l’industria nazionale una politica di raccoglimento e non d’avventura 50.
Già Kautsky nel ’97 aveva affermato quanto deteriore fosse la prevalenza dell’interesse di militari e burocrati rispetto al colonialismo liberista delle forze industriali51. In Italia i socialisti potevano contare
47. Così Bissolati avrebbe ripetuto nella seduta del 9 febbraio 1904: « L’Italia ha soprattutto bisogno di promuovere le esportazioni di merci e di uomini, ma non ha punto bisogno di esportare capitali, perché appunto di capitale abbiamo bisogno noi, per promuovere la produzione nostra » (ivi, voi. II, p. 397). Sull’imperia- lismo italiano come privo del fattore essenziale del modello hobsoniano-leniniano (l’esportazione dei capitali) cfr. R. Fàucci, Elementi di imperialismo cit., pp. 3 segg.
48. E.S.M.O.I. cit., voi. I, p. 495.49. Ivi, voi. II, p. 269.50. Cfr. l’intervento di Ettore Ciccotti al Parlamento nella seduta del-
l ’11/12/1902 (ivi, voi. II, pp. 245-246).51. L. Kautsky, Altere und neue Kolonialpolitik, « Die Neue Zeit », 1897-98,
pp. 801-816, ora in K. Kautsky, La questione coloniale cit., pp. 64-80.
ANTONIO LABRIOLA E L’ESPANSIONE COLONIALE 323
sulPautorità di uno scienziato capace di dare una spiegazione « razionale » anche di questo; ancora una volta ci si imbatte negli scritti di Achille Loria.
L’economista mantovano, che aveva stimolato e che continuava a stimolare studi economici e sociologici sulle realtà coloniali52, e che aveva fondato il suo sistema proprio sul rapporto terra-popolazione, non aveva però mai avallato nessuna giustificazione espansionistica che si fondasse su motivi di carattere demografico. Le colonie infatti, a suo avviso, non erano nell’antichità mai state fondate per mancanza di terre, né un eccesso della popolazione sulle sussistenze le aveva determinate; se veramente si volevano ricercare le cause del fenomeno bisognava essenzialmente ricercarle nel tipo di assetto della proprietà della madrepatria 53 54. Nella Teorìa economica della costituzione politica aveva affermato, suscitando grande scandalo, che le crociate non erano state altro che guerre commerciali, mentre l’Unità d’Italia era stata essenzialmente determinata dalla necessità della borghesia industriale di allargare il mercato interno per i propri prodotti. Anni dopo, nel 1907, scrivendo per la « Revue économique internationale », avrebbe adottato in pieno le tesi marxiane affermando che « l’imperialismo economico dilaga il campo d’impiego dei capitali della metropoli, e con ciò vi attenua la pletora dei capitali, vi eleva il saggio di profitto, vi stimola l ’accumulazione e differisce infine l’avvento della crisi commerciale » fi4. Ma nel saggio apparso nel ’95 sulla « Revue du droit public » gli elementi prevalenti da considerare erano altri. Dopo aver negato infatti ogni validità alle tesi demografiche, che presentavano il colonialismo come soluzione al problema dell’eccesso della popolazione, coglieva nella « irrequietudine » della classe dei lavoratori improduttivi (militari e burocrati soprattutto) la spinta fondamentale alle avventure espansionistiche. L’« irrequietudine », a giudizio di Loria, diventava naturalmente più sensibile nei periodi di crisi, « non appena le fortune
52. Ricordiamo soprattutto U. R a bbeno , La questione fondiaria nei paesi nuovi, Torino, 1898; M. F anno , L'espansione commerciale e coloniale degli stati moderni, Torino, 1906. Carlo Giglio in diverse occasioni ha sottolineato l’influenza di Loria fra gli africanisti: cfr. C. G iglio , L'imperialismo coloniale nella interpretazione di Achille Loria, in: Studi in onore di Carlo Emilio Ferri, Milano, 1973; I d e m , Colonizzazione e decolonizzazione, Cremona, 1971.
53. Cfr. A. Loria, Verso la giustizia sociale, Torino, 1915, voi. I, pp. 285-296. Il saggio a cui si rinvia è la ristampa deU’articolo Les conquètes et la démographie, pubblicato probabilmente sulla « Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger », nel gennaio-febbraio 1895, ma citata come « Revue de droit public ».
54. I d e m , Les deux notions de l'imperìalisme, « Revue économique internationale », sep. 1907, poi in Verso la giustizia sociale cit., voi. II, pp. 285-296.
324 CHIARA OTTAVIANO
della classe proletaria vengono per qualche motivo a declinare e con essa declina la sua munificenza verso i suoi clienti e devoti ». Costoro, insoddisfatti delle proprie condizioni, « cercano per mille modi di promuovere guerre, alfine di integrare, a spese della proprietà straniera, il proprio reddito insufficiente ». È dunque « codesta classe anfibia fra la ricchezza e la povertà, fra la proprietà e il lavoro », ad essere « la materia prima delle conquiste e dei conflitti internazionali, che da secoli dividono e dilaniano la famiglia umana » 55.
7. Nel febbraio del ’97 Antonio Labriola decise di intervenire nuovamente in modo diretto sul problema dell’espansione coloniale. L’occasione fu offerta da una pubblica manifestazione in favore della Grecia per il possesso di Candia. L’opinione di Labriola non è equivocabile: è assurdo a suo avviso che « un gabinetto sorto nel malaugurato momento della disfatta militare e della prostrazione morale, rimanga esso solo arbitro delle sorti d’Italia, proprio ora che si prepara la catastrofe dell'Oriente ». « Liquidiamo per ora la Turchia europea. Quella d’Asia, da Brussa a Bagdad, sopravviverà ancora un pezzo. In quei territori, fatta eccezione degli armeni, non v’è popoli che siano capaci di vera e propria autonomia politica. Su quel campo della Turchia asiatica continuerà ad esercitarsi l’influenza del capitale, del commercio e dell’industria europea, conte a modo di conquista. In questa gara conquistatrice, che è sempre legittima là dove non sono nazionalità vitali, la parte che tocca all’Italia è indicata da tutte le ragioni della opportunità e della difesa: intendo dire di ciò che alla Turchia rimane in Africa, ossia la Tripolitania.
Non brontolino i socialisti: anzi mettano sicuro il piede sulla terra della politica. Noi abbiamo bisogno di terreno coloniale, e la Tripolitania è a ciò indicatissima. Pensino che duecentomila proletari all’anno emigrano dall’Italia, senza indirizzo e senza difesa, e ricordino che non può essere progresso del proletariato, là dove la borghesia è incapace
55. Ivi, voi. I, p. 466. Sull’espansionismo italiano che finì per essere di vantaggio soprattutto a gruppi legati all’apparato statale concordano largamente tutti i più recenti studi sull’argomento. Cfr. la voce Colonialismo di G. R ochat in 11 mondo contemporaneo. Storia d’Italia. 1, Firenze, 1978, pp. 106-120. Anche Schumpeter, com’è noto {Zar Soziologie der Imperialismen, 1919), affermò che la spinta fondamentale all’imperialismo veniva essenzialmente da militari ed intellettuali. Se Loria — non smentendo il suo economicismo — spiegava « l’irrequietudine » di questi ceti facendo appello a motivazioni economiche, Schumpeter fece ricorso invece ad elementi di natura extra economica come il retaggio di « istinti guerrieri » in contrasto con la natura stessa del capitalismo interessato ad una pacifica espansione commerciale. Da qui la definizione schumpeteriana delT« imperialismo come forma di atavismo » (J. A. Sc h u m p e t e r , Sociologia dell’imperialismo, Bari, 1972, p. 70).
ANTONIO LABRIOLA E L’ESPANSIONE COLONIALE 325
di progredire ». L’intervento si concludeva con l’affermazione secondo cui l ’Italia, dopo un lungo periodo di decadenza, avrebbe dovuto riprendere — grazie alle colonie — « nuovamente posto nella storia » 56.
In passato più volte Labriola aveva censurato la « malaugurata impresa d’Africa » e l ’operato di Crispi per aver gettato centinaia di milioni nel deserto africano » 57. Ma la polemica nei confronti della politica africanista era venuta da tutte le parti, anche da quella dei più ardenti colonialisti come un Brunialti e un Turiello 58 59.
L’intervento per Candia prende le mosse da considerazioni di politica estera: il « crollo dell’Oriente » e i cattivi servigi della Triplice Alleanza nei confronti dell’Italia. Nel corso delle lezioni universitarie svolte da Labriola nel 1900-1901 — i cui appunti avrebbero dovuto presumibilmente costituire materiale per l’ultimo dei saggi rimasto incompiuto — la politica internazionale, con riferimento alla Triplice Alleanza e agli altri accordi fra le potenze, era il punto d’avvio da cui il professore socialista prendeva le mosse 50. Minutamente venivano esaminate, sotto i più vari aspetti, le condizioni economiche degli stati, la loro produzione industriale in rapporto alla popolazione, all’importazione e alla esportazione delle merci, ai movimenti migratori, alla produzione delle materie prime ecc. Pur lontano da ogni tipo di meccanicismo e da determinismo economicistico Labriola era pur sempre convinto che « l’economia è il fondamento di tutto » 60. Le dimensioni dell’economia nel xix secolo erano divenute internazionali, il risultato più evidente di questo era la totale « interdipendenza economica delle diverse circoscrizioni attive e passive »: « Siamo entrati nella politica
56. L’intervento di Labriola fu pubblicato la prima volta su « Il Mattino » del 23-24 febbraio 1897. Ora in A ntonio La briola , Scritti politici cit., pp. 431-434.
57. Cfr. Idem, Il socialismo italiano, in: Scritti politici cit., p. 244.58. Cfr. R. F a u c c i, Elementi di imperialismo cit., pp. 24-25. I vecchi liberali
dal canto loro avevano modificato l’originaria rigida opposizione di principio in presenza di processi di espansione commerciale e finanziaria, non determinati solo dallo spontaneo gioco della domanda e dell’offerta, in atto in tutti i paesi industriali. Le posizioni anticolonialiste di Colajanni e di De Viti de Marco perderanno via via sempre più consenso. Cfr. G. A re - L. G iu s t i cit., pp. 569 segg.
59. Gli appunti di Labriola sono stati utilizzati da Dal Pane che ha tentato, con una operazione piuttosto discutibile, di portare a termine il quarto saggio la- briolano rimasto incompiuto: A ntonio L abriola , Saggi intorno alla concezione materialistica della storia. IV. Da un secolo all’altro. Considerazioni retrospettive e presagi. Ricostruzione di L. Dal Pane, Bologna, 1925.
60. « Chiunque dice economia dice rapporti fra uomini; onde si capisce che la formula vera non è spiegare la storia mediante l’economia, ma nell’intendimento della storia cominciare da quello fra i rapporti dell’uomo che è il più immediato e la condizione del resto» (ivi, p. 61).
326 CHIARA OTTAVIANO
mondiale — affermava — per effetto della economia mondiale»"1; « L'imperialismo è la parola d'ordine, la crociata senza finzioni » 6a.
Tali considerazioni sono la premessa per capire quanto « l'interventismo » labriolano fosse del tutto coerente con il bagaglio teorico a cui Labriola faceva riferimento.
« La caratteristica dei vari tipi politici e lo studio su la Triplice e la Duplice — si legge sempre negli appunti delle sue lezioni — furono come un tentativo di ricondurre i motivi della politica del presente momento alle condizioni più generali della struttura sociale. E questo è il momento economico del Marxismo!
Ciò era evidente nei tratti generali della spartizione del mondo — proseguiva Labriola — e della riabilitazione del Mediterraneo, che fu un tentativo di storia descrittiva degli ultimi decenni che compendia tutta la storia del secolo.
Tutto ciò sarebbe stato impossibile senza il prospetto economico che avevo premesso: e Dio sa che fatica! Io mi sono dunque incontrato più volte nel Marxismo, e anche nella critica di esso, nella critica che viene dalle cose (storiche) e non dalle opinioni del sig. X » M.
Se l’economia, come la politica, avevano dunque ormai connotazioni internazionali, l’Italia non avrebbe in alcun modo potuto estraniarsi da certi processi; occorreva solamente decidersi se trovarsi dalla parte dei popoli passivi o di quelli attivi. Nessun orrore doveva esserci per l’esercizio della forza, elemento questo che pienamente faceva parte dei processi della storia 61 62 63 64.
61. Ibidem.62. Ivi, p. 98. Loria nella Prefazione a: A. Lafargue, L’origine e l’evoluzione
della proprietà (Palermo, 1896, p. 93) vantò il fatto che la propria interpretazione delle crociate (come mascheratura di guerre commerciali) fosse diventata ormai un luogo comune condiviso « ogni giorno dagli spiriti più intelligenti della scuola socialista ».
63. Antonio Labriola, Saggi intorno alla concezione materialistica cit., p. 227.64. « Noi italiani — si legge nella lettera a Teodoro Moneta — che ci siamo
vista crescere strepitosamente la potenza inglese e francese qui attorno a noi nel Mediterraneo, proprio dacché ci siamo ricostituiti ad unità di stato; noi che vediamo di continuo svolgersi l’influenza austriaca nei Balcani, e passare di sopra a quella influenza la merce tedesca e il capitale tedesco ormai invasore della Turchia asiatica — noi platonicamente aspetteremo gli arbitrati, senza cercare Ì modi e senza tentare le vie per aumentare le condizioni materiali di nostra potenza, senza ulteriori sforzi di quell’arte politica, la quale non è solo abilità, ma è prestigio ed esercizio di forza? » (Antonio Labriola, Scritti politici cit., p. 471). Sulla considerazione da parte di Labriola della violenza come una « forza storica » insistono Dal Pane {Antonio Labriola nella politica cit., p. 211) e G. Are (Economia e politica cit., p. 61.
ANTONIO LABRIOLA E L’ESPANSIONE COLONIALE 327
L’idea dell’esistenza di popoli e di razze con caratteristiche diverse ricorre di frequente negli scritti labriolani. « La posizione attiva è sempre tenuta, alla fin delle fini e nel tu tt’insieme — si legge sempre nel quarto saggio — , dai neo-germani e neo-latini: e ci troviamo perciò rimandati alla lunga tradizione della civiltà mediterranea antica, continuatasi nella unità cattolica del medio evo.
Qual meraviglia, dunque, se la politica della conquista, della supremazia, della sopraffazione, dell’intervento di paese e paese, e della guerra, o fatta o soltanto minacciata, sia stata e rimanga l’inevitabile conseguenza e l ’istrumento decisivo della espansione capitalistico-bor- ghese? » 06.
■ Nelle lezioni dell’87 aveva tentato — non ancora marxista — di spiegare la complessità degli elementi da cui è costituita la storia affrontando direttamente anche il problema della razza. « La razza come tale non è storia — spiegava agli studenti — . Questa è dinamica, e quella è fissa o di formazione più lenta. La razza è preistorica, e quindi predisposizione. Non si può negare che vi siano razze più o meno disposte alla civiltà, ma non ve n ’è alcuna assolutamente refrattaria. D’altra parte i popoli storici sono spesso incontro di più razze, e, p. e., l ’italiano s’è fatto dentro la storia. Quando la storia comincia la razza come tale cessa » ft\
Nella lettera a Baccarini del ’90 aveva accennato agli « indigeni, moderatissimi nei bisogni e servili per istinto »; nell’intervento a proposito di Candia parlò di popoli incapaci di « vera e propria autonomia politica ». La celebre battuta sull’educazione del papuano che, riferita da Croce, sarebbe stata duramente censurata da Gramsci nelle note dei suoi quaderni, è in coerenza con tutto ciò. « Provvisoriamente — aveva infatti risposto a chi gli chiedeva quale fosse la migliore pedagogia nei confronti di un indigeno papuano — lo farei schiavo » 65 66 67. I popoli avevano diversi punti di partenza, ma dopo il loro ingresso nella storia, nella civiltà, il preistorico elemento della razza si sarebbe via via annullato. Il compito del capitalismo — per le sue caratteristiche, per la sua necessità d’espansione e per l’assioma della civiltà liberale, la concorrenza — era quello di pervadere tutto il mondo. Solo nel xx secolo era prevista la catastrofe della concorrenza e l ’avvento della società nuova di cui parlava Marx. Il socialismo però già si andava affermando nelle coscienze. Esso era portatore di una nuova etica che avrebbe mo-
65. A ntonio L abriola, Da un secolo all’altro cit., p. 29.66. L. D al Pane, Antonio Labriola nella politica cit., p, 198,67. A. G r a m s c i , Quaderni del carcere, voi, II, Torino, 1975, p. 1366.
/
328 CHIARA OTTAVIANO
dificato anche i rapporti fra le nazioni: « il postulato della solidarietà » avrebbe sostituito « l’assioma della concorrenza » 68 69.
Labriola non sfuggiva alle certezze del secolo xix: prima di tutte quella nel progresso, legata all’idea della storia che non poteva procedere per salti ma solo per tappe essenziali raggiungibili Luna dopo l’altra. Se il papuano doveva diventare in primo luogo schiavo, l’Italia, per la sua storia, non poteva che trovarsi a fianco delle nazioni più « attive », nel momento, non rinviabile, dell’espansione del capitalismo che avrebbe determinato l’entrata nella civiltà di tutti i popoli della storia. Poi sarebbe venuto il tempo del socialismo. Occorreva però anche una classe, la borghesia, consapevole del ruolo che le era stato assegnato.
Se Bissolati, intervenendo alla Camera a proposito della spedizione in Cina, aveva trovato conforto alla propria opposizione nel fatto che si trovava dalla stessa parte della borghesia attiva del nord, e dunque dalla parte delle forze del progresso contro quelle della reazione, per Labriola le scelte di quella stessa borghesia apparivano il simbolo di una totale inadeguatezza. « L’Italia ha la disgrazia non solo di non avere il socialismo — si legge in una lettera indirizzata a Croce nell ’aprile del ’97 — , ma di non avere neanche una borghesia capace di concorrere con quella degli altri paesi, cosicché p. e. a Candia fa la figura del ladro che non sa che rubare, e non ha la forza di rubare » 89. E un anno dopo, sempre a proposito degli « allegri facenti funzione di borghesi » così aggiungeva: « La cosa strana è come l’Italia che possiede un così gran numero d’imbroglioncelli che tentano di fregarsi reciprocamente, non è buona di mettere assieme una di quelle grandi compagnie d’imbroglioni di grande stile che negli altri paesi sono riuscite a creare quelle così dette grandi forze della civiltà che sono il capitalismo, la colonizzazione, la conquista del mercato et reliquia. È un letame che non impiegato in forma di concime appesta l’aria » 70.
Il terreno da concimare era chiaramente quello della storia, ed era un terreno che si pensava non potesse mancare di dare i frutti previsti.
68. Antonio Labriola, Da un secolo all’altro cit., p. 98.69. I d e m , Lettere a Benedetto Croce 1885-1904, Napoli, 1975, p. 207.70. Ivi, p. 313.