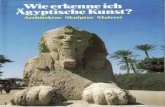Štih - Il posto dei ministeriali nell'organizzazione e nell'amministrazione dei conti di Gorizia
Conti e la fondazione del "Teatro Romano". Giunio Bruto e Marco Bruto in scena.
Transcript of Conti e la fondazione del "Teatro Romano". Giunio Bruto e Marco Bruto in scena.
ANTONIO CONTI:UNO SCIENZIATO NELLA RÉPUBLIQUE DES LETTRES
a cura diGuido BaldassarriSilvia ContariniFrancesca Fedi
I L P O L I G R A F O
4
© Copyright settembre !""#Il Poligrafo casa editrice srl$%&!& Padova piazza Eremitani - via Cassan, $'tel. "'# ($)"((* - fax "'# ($)"()'e-mail [email protected]
ISBN #*(-((-*&&%-)!%-%
La presente pubblicazione viene realizzatacon il contributo del Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Padova
Atti del Convegno InternazionalePadova, Palazzo del Bo!* febbraio - & marzo !""*
progetto grafi co Il Poligrafo casa editriceLaura Rigon
5
! Premessa Guido Baldassarri, Silvia Contarini, Francesca Fedi
"# Una diffi cile assimilazione: Conti, le metafi siche e la nuova scienza Ferdinando Abbri
$! Conti e la Massoneria Gian Mario Cazzaniga
%& La ‘denonzia’ di Antonio Conti per ateismo John Lindon
!" L’Arcadia della scienza. Qualche ipotesi di rilettura Alessandra Di Ricco
'& Antonio Conti nel dibattito settecentesco sul rapporto tra letteratura e scienza e sulla poesia didattica Elvio Guagnini
(! I carteggi Conti-Vallisneri Ivano Dal Prete
""# Antonio Conti e Scipione Maffei Gian Paolo Romagnani
"%# I «sillogismi taciti»: Conti tra Hutcheson e Wolff Silvia Contarini
")! La traduzione e la circolazione del Rape of the Lock Francesca Fedi
INDICE
6
"'( La migliore armonia. Dialoghi e interlocutori per Il Globo di Venere Duccio Tongiorgi
$"" Per l’edizione dei Dialoghi fi losofi ci Renzo Rabboni
$%# I pensieri sulla musica di Antonio Conti Franco Arato
$&! Dal «mistero teologico» alla «sapienza civile»: l’inno Sopra il lavacro di Pallade Annalisa Nacinovich
$!" Conti e la fondazione del «Teatro Romano». Giunio Bruto e Marco Bruto in scena Beatrice Alfonzetti
#*# «È nota l’istoria di Davide che suonando l’arpa danzava». I cori tragici dal Cesare al Druso Valentina Gallo
##& Sintassi e metrica nel Riccio rapito Rodolfo Zucco
#)& Sogni di fi losofi . Antonio Conti tra Keplero e Muratori Gianmarco Gaspari
#'& «Un ordine lunghissimo di spettri». La strada verso il sogno di Antonio Conti Rinaldo Rinaldi
%*" «Scrivere e lagrimar»: Conti e la ripresa delle Eroidi nel Settecento italiano Salvatore Puggioni
%$& L’infl usso contiano sulla Chioma di Berenice di Foscolo Christian Del Vento
%%# Indice dei nomi a cura di Salvatore Puggioni
!"#
Beatrice Alfonzetti
CONTI E LA FONDAZIONE DEL «TEATRO ROMANO».GIUNIO BRUTO E MARCO BRUTO IN SCENA
Antonio Conti non fa eccezione: anche le sue tragedie intrattengono uno stretto rapporto con la pratica scenica del tempo che per tutto il Settecento si chiama ‘riforma’. Sfuggito agli studiosi per il persistente pregiudizio di un tea-tro tragico lontano dalle scene, questo legame si incarna in uno spazio scenico preciso (il teatro San Samuele) e in una compagnia di comici professionisti, fra i quali spicca la fi gura di Gaetano Casali, il perfetto attore nei ruoli seri del primo Goldoni. Certamente Il Cesare, scritto quasi vent’anni prima, nasce in un diverso contesto, in cui però non va sottovalutato il ruolo avuto da Elena Balletti e Luigi Riccoboni, i più grandi attori della riforma teatrale del nostro primo Settecento. Grazie alla mediazione di Maffei, che li mette in contatto con l’abate padovano, nel loro salotto si svolge la prima lettura parigina (o ‘prova’) della tenuta teatrale della tragedia, non ancora fi nita.# Conti è l’interlocutore dei loro primi scritti teorici, animati da spirito polemico verso il teatro francese, inserendosi così l’abate nello stesso sentiero segnato dai primi riformatori: Gravina, Muratori, Maffei. Una è la parola d’ordine: la rinascita del teatro italiano che attori e let-terati sognano soprattutto per la tragedia. Le antiche tragedie italiane come le moderne sono portate sulla scena principalmente a Venezia, la città teatro per eccellenza. È una storia di speranze e sconfi tte, di tentativi che ogni volta fanno gridare al miracolo, dei quali mancano repertori e ricostruzioni per l’estrema frammentazione dei luoghi, la dispersione dei documenti e il poco rilievo dato alla tragedia settecentesca. Tutte le volte, però, che ci si accosta a testi e autori più o meno dimenticati, si compone un pezzo di questo puzzle, scoprendo che in qualche teatro, pubblico o privato, la nostra copiosa produzione tragica è andata in scena.
# Cfr. Risposta del Signor Abate Antonio Conti al Signor Jacopo Martelli, in Il Cesare. Tragedia del Sig. Ab. ANTONIO CONTI nobile veneto. Con alcune cose concernenti l’opera medesima, Faenza, Nella Stampa di Giosef-fantonio Archi Impressor Camerale e del S. Uffi cio, #"!$, pp. $#-$!.
%&'()*+& ',-./0&((*
!"!
Così è accaduto alle due tragedie ‘repubblicane’ di Antonio Conti, Lucio Giunio Bruto e Marco Bruto, la cui vicenda scenica ed editoriale merita di essere guardata da vicino, non solo per le sorprese ‘fi lologiche’ che può riservare, ma anche per la sua rispondenza a determinati orientamenti e iniziative del sistema culturale di Venezia fra gli anni Trenta e i Quaranta. Cerniera fra la fi losofi a, la politica e la società civile, la tragedia svolge un ruolo insostituibile: l’insegnamento «delle virtù per via dell’immaginazione e delle passioni: le due cose, delle quali gli uomini fanno maggior uso che della ragione». Sono parole di Conti (tratte dalla Prefazione al Marco Bruto), che nel suo ultimo decennio di vita sembra vincere cau-tele e incertezze, siglando un patto sempre più stretto con il teatro e soprattutto con l’identità d’autore. Dall’apparizione del primo tomo di Prose e poesie (#"12) al Druso (#"34), Conti s’inserisce a pieno, con edizioni, dediche, progetti e recite delle sue tragedie, nell’ambiente culturale e politico di Venezia. I suoi orizzonti di riferimento sembrano mutare come i suoi interlocutori: l’apertura al mondo ‘tedesco’ fa registrare un cambiamento in cui forse non sono assenti valori e compiti massonici. Fra questi ultimi c’è la fondazione di un teatro romano atto a educare l’uomo alla benevolenza, patria e religione.
#. Le edizioni e le recite
Basterebbe soltanto un primo confronto fra l’edizione ‘accademica’ del Cesare e le edizioni provvisorie sia del Lucio Giunio Bruto che del Marco Bruto per far ipotizzare un mutamento di prospettiva nell’ultimo Conti. Nel #"!$, il paratesto a più voci del Cesare aveva l’intento di marcare l’ingresso della stessa tragedia nella repubblica delle lettere, annunziando quasi il rientro, dopo tredici anni, dell’abate in Italia. Molti erano i testi che lo componevano: la dedica al cardinale Bentivoglio d’Aragona (quasi un trattato di poetica tragica), la Lettera di Jacopo Martello, la Risposta dell’autore, i versi accademici del Frugoni ecc. Dotte le argomentazioni di Conti sulla scelta di campo dell’argomento storico rispetto al favoloso, sul privilegio da accordarsi alla storia romana, in partico-lare al soggetto della morte di Cesare, ma già personale si profi lava il metodo critico adottato, in base al quale Gravina era situato accanto al Dubos, Martello a Gravina. L’«intelligente equilibrio» fra gli antichi e i moderni si riversava sulle posizioni assunte nei confronti della rinascita italiana della tragedia, cui anche l’abate intendeva partecipare senza vietarsi di segnalare la perfezione dell’Athalie di Racine, tradotta e poi pubblicata in Prose e poesie.! Racconta l’allievo Toaldo, nelle Notizie postume, che i versi «sublimi» del Frugoni «dispiacquero al Conti,
! Il giudizio è di G. Gronda, L’opera critica di Antonio Conti, «Giornale storico della letteratura italiana», CXLI, #2$3, p. 4. La traduzione ora in A. Conti, Versioni poetiche, a cura di G. Gronda, Bari, Laterza, #2$$, pp. #56-!55.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!"1
vedendovi trattata con poco onore la Nazione Francese, a cui si professava obbligatissimo, e sé da Cartesiano, cosa che non si sognò mai».1 D’altra parte il taglio antigallico del Frugoni («O pregiato lavoro, onde ormai ceda / A le Italiche scene il primo onore / Francia superba!»3) interpretava un sentire condiviso, cioè lo stesso orizzonte d’attesa nei confronti soprattutto del genere tragico. Dai Primi disegni di Muratori al Libro della tragedia di Gravina, senza dimenticare Della perfetta poesia italiana, la riforma arcadica del teatro era stata scandita dalla contrapposizione al teatro francese che, in forme meno esposte, si ritrova anche nell’esordio tragico di Conti, intenzionato a «dar moto al teatro italiano, intro-ducendovi la morale, la politica, e tutto ciò che diletta ammaestrando», e sicuro che le tragedie italiane a venire «saranno ben più perfette delle franzesi, il verso delle quali sarà sempre affettato, gli amori soverchi ed inutili i confi denti».6
Fra il #"31 e il #"33 Conti fa stampare il Lucio Giunio Bruto e il Marco Bruto per consentirne la rappresentazione in un momento ritenuto propizio alla rinascita del teatro veneziano e italiano. L’uso della postuma (Bonducci, #"6#) per quanto attiene alle tragedie, a eccezione del Cesare, ha cancellato la loro ‘storia’: le de-diche, il rapporto con la scena, le modifi che apportate nelle seconde edizioni, stampate a ridosso delle rispettive recite. Fatta salva la dedica al Bentivoglio, la Bonducci conserva le prefazioni (al Lucio Giunio Bruto al Marco Bruto e al Druso), mentre cassa il restante paratesto del Cesare, secondo la volontà dell’autore espressasi nella seconda edizione della tragedia.$ Invertendo l’ordine cronolo-gico delle stampe e con qualche lieve ritocco ai titoli originari, la postuma dà il seguente prospetto: Giunio Bruto, Marco Bruto, Giulio Cesare, Il Druso. La ‘per-dita’ di questi documenti ha sottratto senso all’operazione di Conti, in quanto le dediche, espunte dalla Bonducci, hanno una stretta relazione con la scelta di far recitare soltanto le tragedie che fi ssavano in emblemi positivi la storia repubblicana di Roma, la fondazione della Repubblica e la sua caduta:
Nella rappresentazione degli avvenimenti tragici delle cose Romane io trascorsi dal principio della Repubblica fi no al fi ne, senza passar per i mezzi che includono in circa uno spazio di 655 anni; io voglio dire, da Giunio Bruto trascorsi al Marco Bruto."
1 Cfr. Prose e poesie del Signor Abate Antonio Conti patrizio veneto, II, in Venezia, presso Giambatista Pasquali, #"12-#"6$, [Cui precedono le Notizie spettanti alla sua vita, e suoi studj], p. $#.
3 Il Cesare, cit., p. 46.6 Cfr. Conti-Bentivoglio, s.d., «ma ante !2 maggio #"!6», in R. Rabboni, Il carteggio fra Antonio
Conti e Cornelio Bentivoglio (con lettere inedite), «Atti e Memorie dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti», CXIII, !55#, p. 2!.
$ Il Cesare, tragedia del Sig. Abate ANTONIO CONTI nobile veneto, Venezia, Pietro Bassaglia, e Giuseppe Bettinelli, #"31.
" Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie composte dal Signor Abate ANTONIO CONTI patrizio veneto dedicate a S.E. il signor conte Emanuelle di Richecourt, I, Firenze, Bonducci, #"6#, p. #31.
%&'()*+& ',-./0&((*
!"3
Per la postuma furono adoperate le seconde edizioni del Lucio Giunio Bruto e del Marco Bruto (Pasquali, #"31 e #"33), rare ma non quanto le prime, che persino la Drammaturgia dell’Allacci non segnala interamente. Allo stato attuale delle mie ricerche, proverò a ricostruire la loro vicenda editoriale e teatrale, dando conto soltanto delle modifi che testuali più rilevanti che si inquadrano nella peculiare fi lologia del testo teatrale.4 La prima tragedia, Lucio Giunio Bruto, è pubblicata più volte nel corso del #"31 in due differenti stampe di Pasquali che appaiono, rispettivamente, prima e dopo le recite (due sere al San Samuele). La prima è anonima ed è corredata soltanto dall’Argomento:
Lucio Giunio Bruto instituì in Roma il Consolato, e la Libertà, per la conservazione della quale condannò a morte i due Figliuoli, che avea. Scoperti questi da uno Schiavo a parte della Congiura tramata dal Re Tarquinio Superbo per ritornare in Roma, bastò questo al Padre per condannarli.2
L’estrema brevità del testo induce Conti all’uso di una scrittura insolita, assertiva e paratattica. L’argomentazione è suddivisa in due blocchi: la notizia storica, in cui è fondamentale il nesso consolato-libertà, e la fi nalità poetica delle invenzioni sia riguardo alla congiura che alla rivalità fra i due fratelli, necessarie «per dar connessione alle parti della Tragedia, ed introdur varietà negli affetti». Vi è già il rimando a una «lunga Prefazione» in cui si chiariranno – secondo la precettistica di Aristotele che Conti legge soprattutto secondo il Castelvetro – il principio il mezzo e il fi ne della tragedia, nonché «la parte critica, che riguarda lo Storico, il Poetico, ed il Morale». La seconda edizione sostituisce l’Argomento con la Prefazione, arricchendosi della dedica «A Sua Altezza Anna Caterina di Sassonia Contessa d’Orzeska Duchessa d’Holstein-Beck», fi glia dello scomparso elettore di Sassonia e re di Polonia Augusto II, e sorella dell’attuale Augusto III, come per altro Conti ricorda nell’elogio della casata di Sassonia che chiude la lettera. Residente a Venezia e unitasi in matrimonio con un membro della casa reale danese, Anna Caterina assiste alla rappresentazione della tragedia e ne legge il testo:
Io comincierò dal ringraziar Vostra Altezza del benigno compatimento, col quale ella s’è degnata d’udir più volte, e di leggere la mia Tragedia del Giunio Bruto. L’acuto discernimento di Vostra Altezza, il gusto che Ella ha per la Poesia, e particolarmente
4 Riservandomi di esporle più in dettaglio, magari in una riedizione del testo, riporto solo quelle più signifi cative.
2 Lucio Giunio Bruto. Tragedia, Venezia, Presso Giambattista Pasquali, #"31. L’edizione ("! pp. in #!) è posseduta dalla Biblioteca Braidense, dalla Marciana e dalla Bibliothèque nationale (qui catalogata anonima sotto il titolo). Cito dall’esemplare di quest’ultima. Devo alla gentilezza della dott.ssa France-sca Tamburlini l’informazione che nel Fondo Manin della Biblioteca V. Joppi di Udine si trova un altro esemplare con errata, evidentemente una stampa successiva.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!"6
per la Dramatica, tanti ammaestramenti di purgata, e scelta dottrina, raccolti da’ più bei libri scritti in varie lingue, e non leggiermente trascorsi, ma meditati, e discussi [...] Ogni ragione vuol dunque, che io le offra la mia Tragedia, or che appar in pubblico più corretta e limata, e con l’ajuto della Prefazione [...].#5
Fra gli spettatori illustri c’era anche la corte di Modena, rifugiatasi a Vene-zia negli anni dal #"3! al #"32 durante la guerra di successione austriaca, che la vedeva insolitamente schierata con il blocco franco-spagnolo. Questa notizia si apprende dalla corrispondenza fra Muratori e il suo segretario, Ercole Gherardi, che seguiva, presso la tipografi a Pasquali, la stampa degli Annali. Grazie ad alcu-ne lettere a Muratori, dalle quali per altro emerge il fascino che emanava dalla fi gura di Conti, si può fi ssare la recita del Lucio Giunio Bruto al gennaio #"31, in quanto Gherardi ne parla nella lettera del !$ gennaio. In questa data la tragedia risulta già stampata e dunque si può ritenere che la stampa provvisoria servisse proprio alla rappresentazione. Così come a suo tempo era accaduto con il Cesare, quando l’abate Greco aveva condotto una copia manoscritta a Muratori e al marchese Orsi, anche la prima stampa Pasquali del Lucio Giunio Bruto è inviata a Muratori per riceverne «risposta e giudizio» e procedere così ai rifacimenti in vista di una seconda edizione (lettera del #6 marzo). Prima di darne conto, leggiamo la lettera del !$ gennaio, pur se lacunosa nella trascrizione:
Ha [egli] composta una tragedia in versi italiani intitolata il [Giunio Bruto]. L’ha fatta stampar dal Pasquali. L’ha data [...] pubblico teatro a S. Samuele. Ha avuto [...] que’ commedianti l’hanno rappresentata [...] e con plauso dell’uditorio. In due volte vi si è portata ad udirla la nostra corte, e n’è partita assai contenta. Il rimanente degli spettatori veneziani ne sono rimasti soddisfattissimi. E lo merita ben essa, perciocché nelle parti sue materiali, ma molto più nelle formali, simmetrizzata ed espressa se-condo i precetti dell’arte e ricolma di nobili sentimenti e sostenuta ne’ suoi caratteri e ravvivata da buono stile di scriver poetico.##
Motivata con la necessità di correggere gli errori del proto, la nuova edi-zione sembra invece obbedire alla logica della scrittura d’autore, di un autore che ha superato favorevolmente la prova del teatro e che ora fi nalizza il testo alla stampa defi nitiva.#! Firmandola e dedicandola, Conti presenta la tragedia al pubblico dei lettori sotto un’altra veste tipografi ca che fa risaltare la sua identità
#5 Cfr. Lucio Giunio Bruto. Tragedia del Signor Abate ANTONIO CONTI Patrizio veneto, seconda edizione, Venezia, Giambatista Pasquali, #"31.
## L.A. Muratori, Carteggio con Pietro E. Gherardi, a cura di G. Pugliese, Edizione Nazionale del Carteggio, !5, Firenze, Olschki, #24!, p. #6". La lettera del #6 marzo è a p. #$!.
#! Per alcuni rilievi di metodo sulla progressione stampa provvisoria-recita-stampa defi nitiva, rinvio a R. Turchi, Dalla Pazzini Carli alla Didot, in Alfi eri in Toscana, a cura di G. Tellini e R. Turchi, Firenze, Olschki, !55!, pp. 6#-46.
%&'()*+& ',-./0&((*
!"$
di poeta tragico. Lo stesso testo è rivisto e corretto in molti punti, apportandovi alcune variazioni con lo scopo di chiarire qualche aspetto un po’ oscuro, ma soprattutto con quello di attenuare l’impatto del rigore (o virtù) di Bruto sul lettore-uditore del tempo. Nel complesso le varianti introdotte sono aggiunte di versi, per un totale di poco più di sessanta, che non alterano l’assetto e il numero delle scene. Inoltre esse sono concentrate esclusivamente nel primo e nel quarto atto, a eccezione di qualche sparso intervento formale nei restanti. Se il prospetto degli Attori e la descrizione della scena (il Foro Romano) restano immutati, l’incipit è sottoposto a una prima modifi ca per dare maggior risalto, con l’ipotiposi di Tarquinia rivolta ad Arunte (legato del re Porsenna alleato dei Tarquini), alla contrapposizione fra il regno di Tarquinio e la neonata repubblica consolare, simboleggiata dai sedili del Tribunale dei Consoli e dai recinti in cui si assiepa la Plebe:
Eccoci al Foro. Quì seder solea, / Quando parlava all’adunata Plebe, / Il Re mio Padre. Ma che seggi incolti / Sorgono in luogo dell’augusto Trono!#1
Eccoci al Foro, Arunte. Ancor vi veggo / Col diadema in capo, e in man lo scettro, / Il Re Tarquinio, il mio gran Padre, e v’odo / Gli applausi e i voti della lieta plebe, / Lui ragionando... Ma del trono in vece / Perché sorgono là due seggi incolti? / Qua perché infi ssi i mal contesti legni?#3
Nella scena seconda, quando Arunte avvicina Tito e Tiberio, le sue rac-comandazioni di non tradire la regia causa e il giuramento si arricchiscono di tre versi che correggono l’incongruo ruolo di Tarquinia in quello di Tullia, dando immediatamente l’informazione che i due fi gli di Bruto, a causa della sua simulata follia, sono stati allevati dalla Regina. Più avanti, nella stessa scena, quando si profi la la distanza fra i due fratelli rispetto alle ragioni che li spin-gono a congiurare contro la patria (Tito per amore di Tarquinia, Tiberio per ambizione), sono inseriti alcuni versi in merito alla concreta possibilità della successione femminile al trono. L’aggiunta rende più verosimile l’aspirazione di Tiberio a diventare re, sposando Tarquinia. La rivalità fra i due fratelli, pur non procedendo dalle fonti storiche, non ha una fi nalità romanzesca, come l’avrebbe l’amore di Tito,#6 quanto piuttosto morale e politica, per non dire che essa sembra alludere ai confl itti dinastici di quegli anni. Se invariata resta la constatazione di Tito sul passaggio del trono ai fi gli maschi («Ma dov’è il Regno, che sarà mercede / Del tradimento? Regneranno i Figli, / Morto Tarquinio»),
#1 Lucio Giunio Bruto (#a ed.), cit., p. 6.#3 Per le prefazioni e il testo delle seconde edizioni uso la postuma (Le quattro tragedie, I, cit., p. 3#).#6 Così P. Luciani, Fonti storiche e invenzione romanzesca nel Giunio Bruto di Antonio Conti, in Bruto
il maggiore nella letteratura francese e dintorni, a cura di F. Piva, Fasano, Schena, !55!, pp. !!"-!3$.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!""
cambia la replica di Tiberio, che è smembrata in due sequenze, attraverso le quali si precisa che Tullia, oltre ad aborrire i fi gli in favore delle fi glie, «[...] tur-ba / Delle nozze i maneggi».#$ Il tradimento di Tiberio ha quindi uno spessore politico e ci suggerisce di leggere la variante con l’occhio rivolto alle guerre di successione polacca e soprattutto austriaca. D’altronde, proprio nella Prefazione alla tragedia, l’abate indica nel tradimento della patria e nel parricidio il trait d’union fra gli antichi e i moderni: esso è un delitto cui anche nel presente si è avversi per istinto naturale, disciplina e costume.#"
Un criterio per orientarsi nella lettura dei vari livelli del testo tragico è quello intertestuale, in quanto dagli scarti anche minimi emergono slittamenti di senso. Così, confrontando il Lucio Giunio Bruto con le altre tragedie sull’eroe romano cui Conti accenna nella Prefazione, senza però nominarne gli autori (le italiane, l’in-glese e la francese), si notano alcune differenze che assumono immediatamente rilievo. Fra le italiane ci sono il Bruto di Saverio Pansuti (Firenze, ma Napoli #"!1) e il Bruto di Gorini Corio (Milano #"!3), entrambe riedite rispettivamente nel #"3! e del #"15. Se la tragedia milanese, dal taglio eroico-militare, è assai distante da quella di Conti, la napoletana, invece, ha un’impronta marcatamente repubbli-cana che costituisce per certi aspetti il problematico sottotesto del Lucio Giunio Bruto. Nella fattispecie, mentre nel Bruto di Gorini Corio la gelosia di Tiberio scaturisce dalla preferenza accordata da Bruto a Tito (qui innocente e, alla fi ne, acclamato come un secondo liberatore), nel Bruto di Pansuti agisce soltanto Tito – così poi nel Brutus di Voltaire che a sua volta procede dalle tragedie della Bernard e del padre Porée –, amante sì di Tarquinia, ma traditore e congiurato per ragioni di censo, che alludono al punto di vista dello stesso autore congiu-rato e tribuno del popolo durante la congiura di Macchia. In sintesi, nel Bruto di Pansuti la congiura nasce dalla ribellione contro la temuta parità legislativa dell’ordinamento repubblicano, così come la fermezza di Bruto affonda le sue radici nello stesso ethos giuridico dell’eguaglianza formale del cittadino.#4 Più in generale si può dire che è lo stesso codice tragico, trasversale a tutta la dramma-turgia europea, a innestare nelle parti storiche le invenzioni, nelle cui variazioni quasi sempre si colgono le allusioni del testo. Pur procedendo dal romanzo di Madeleine de Scudéry, sia il Lucius Junius Brutus di Lee che il Brutus di Voltaire (le altre tragedie cui Conti verosimilmente accenna) sono improntati al codice allegorico, in base al quale nell’esempio antico si proiettavano gli interrogativi del presente, con allusioni più o meno velate alle situazioni storiche e politiche
#$ Cfr. Lucio Giunio Bruto, #a ed., cit., p. 2; !a ed., cit., p. 3".#" Prefazione al Giunio Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., p. !$.#4 Cfr. B. Alfonzetti, «Il Bruto»: «perfetta tragedia» del mito asburgico (Saverio Pansuti e Gioseffo Gorini
Corio), in Bruto il maggiore nella letteratura francese e dintorni, cit., pp. #"1-!5$.
%&'()*+& ',-./0&((*
!"4
in atto.#2 Se il Tito amoroso dell’abate Conti si richiama a una lunga tradizione tragica, la rivalità fra i due fratelli, qui diversamente connotata come aspirazione al trono da parte di Tiberio, costituisce lo scarto più interessante.
Nella stessa direzione sembra muoversi l’altro inserto della scena terza, in cui appaiono per la prima volta Bruto, Collatino, Valerio in mezzo a una gran turba di popolo e senatori. Nella lunghissima parlata di Bruto ai Quiriti, in me-rito alle richieste di Tarquinio (fra cui quella di rientrare da privato cittadino) il console li mette in guardia dal rischio che il tiranno, forte dell’alleanza stretta con i Toscani, possa tramare per ritornare al trono, trasportando altrove «la sede dell’Impero».!5 Assente nella prima edizione, anche questo accenno poteva suonare allusivo, dato che, con l’elezione del duca di Baviera al Sacro Romano Impero come Carlo VII, Vienna non ne era più la sede.
Parlare di allusioni, che ben inteso rientrano nei codici tragici della tragedia moderna, nel caso di Conti non è un’ipotesi, ma una certezza, anche se può risultare diffi cile sciogliere il velo delle allegorie. Non potendoci soffermare su questo punto, è utile ricordare almeno la differenza fra allegoria chiara e allegoria oscura, illustrata da Conti nella Prefazione a Prose e poesie, che costituisce lo stesso metodo del lavoro critico dell’abate, basato sulla decifrazione del senso nascosto (così ad esempio nelle Annotazioni critiche alle odi di Orazio!#). Con la prima delle due allegorie «insegnavano gli antichi la morale a’ fanciulli, alle donne, e a tutto il popolo, ma ascondevano con l’oscura gli arcani della politica e della Religione». Perdutasi questa pratica, non restava che procedere per «ipotesi» nel comprendere se, ad esempio, la Tebaide di Stazio «sia un panegirico indiretto delle azioni di Domiziano, come l’Eneide ne è uno delle azioni di Augusto». L’uso dell’allegoria presente sin dai geroglifi ci egizi aveva nella poesia la funzione di insegnare i costumi e «l’arte della vita e de’ Regni»:
Di questa comunemente si servirono i Poeti antichi per instruire senza arroganza, per lodare senza affettazione, per accusare senza pericolo, e per far le cose grandi e mirabili senza esporle alle irriverenze e a’ disprezzi. [...]. Pari dunque negli antichi Poeti fu lo studio dell’imitazione che dell’allegoria.!!
Nella prefazione al Lucio Giunio Bruto Conti torna sul procedimento dell’alle-goria, pur se in termini molto generali. Parlando dei tre livelli del testo, storico, poetico e morale, afferma, sulla scorta di Gravina, che il piano morale («il primo
#2 Cfr. per i signifi cati allegorici della tragedia inglese M. Giulietti, Intrecci nella storia del Lucius Junius Brutus di Nathaniel Lee, ivi, pp. 42-#5".
!5 Cfr. Lucio Giunio Bruto, #a ed., cit., p. #1; !a ed., cit., p. 6!.!# Cfr. Versioni poetiche, cit., pp. 1!3 sgg. Si tratta dell’ode II e della XII ad Augusto, edite con dedica
«A S.E. il Signor Girolamo Ascanio Giustiniani il Giovane», in A. Conti, Prose e poesie, I, cit., p. I.!! Prefazione, ivi (pp. non numerate).
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!"2
nell’intenzion del Poeta», «l’ultimo nell’esecuzione») comprende «l’astratta idea» della tragedia. Assumendo, poi, la forma della sentenza, essa «è atta ad instruire per via della reminiscenza ne’ casi opportuni».!1 E qui, accentuando il motivo della libertà rispetto a quello della repubblica su cui invece si fonda il Bruto di Pan-suti,!3 Conti mette insieme, in maniera volutamente ambigua, sia le rivoluzioni scoppiate in Portogallo e in Svezia, che le guerre civili di Francia e Germania, per concludere che «coloro che salvarono da’ ribelli la libertà, che godevano i popoli sotto i Regni de’ loro legittimi Re» meritano le stesse lodi tributate a Bruto.!6 Così come lo zelo di Bruto poteva valere sia nel governo repubblicano che in quello monarchico, esso s’incarnava, dalla parte della legittimità contro l’usurpazione, anche nei confl itti dinastici che funestavano l’Europa dall’inizio del secolo. Su questa trama larga del testo, che comprende ogni possibile riferi-mento in nome della libertà, della patria e delle leggi, sarà opportuno tornare più avanti, quando si accennerà ai valori massonici dei testi dell’abate. Qui ci basti notare che proprio in funzione di quei valori ‘universali’ era possibile che fra il pubblico, a distanza di qualche anno dall’invasione della Slesia da parte di Federico II, la corte di Modena sedesse accanto alla sorella dell’elettore di Sasso-nia, da un anno ritiratosi dalla coalizione antiaustriaca dopo aver riconosciuto la Prammatica sanzione. Se nel giudizio di Muratori il nuovo scontro fra la Francia e la casa d’Austria era una nuova «tragedia»,!$ anche Conti compiva un gesto di civile pietà, schierandosi dalla parte dello stato più debole, costretto di lì a poco a rientrare nel confl itto al fi anco dell’Austria contro la Prussia.
Come per il Brutus di Voltaire, il punto incriminato era lo zelo di Bruto. Per questo motivo Conti interviene in maniera massiccia nel quarto atto, quando Bruto apprende della congiura e del tradimento dei fi gli. Se nella prima edizio-ne Bruto assume immediatamente il ruolo di difensore di Roma, dando ordini militari e sociali (difesa delle mura, biade e sgravi alla plebe), nella seconda esso è preceduto da un drammatico confronto con i fi gli. I nuovi versi, distribuiti fra Valerio, Collatino e soprattutto Bruto, sono tutti intonati alla sua identità paterna. Dapprima è Valerio a notare il turbamento del console, poi è Collatino
!1 Prefazione, in Le quattro tragedie, I, cit., p. 14.!3 Sulle due tradizioni, del Bruto edile e del Bruto console, cfr. A. Mastrocinque, Lucio Giunio Bruto.
Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana, Università di Trento, La reclame, #244. In particolare su Lucio Giunio Bruto «il primo tribuno e il primo edile della plebe» e su Tarquinio «oppressore della plebe» (tradizione cui attinge Pansuti), pp. 23 sgg.
!6 Prefazione, in Le quattro tragedie, I, cit., p. 14. Sulla libertà del Giunio Bruto come idea politica da inserirsi in un sistema di relazioni concrete, cfr. lo studio fondamentale di N. Badaloni, Antonio Conti. Un abate libero pensatore fra Newton e Voltaire, Milano, Feltrinelli, #2$4, p. #"5.
!$ L.A. Muratori, Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno 1749, XII, In Milano, a spese di G. Pasquali, p. !$4.
%&'()*+& ',-./0&((*
!45
a invocare che miti «sensi risvegli in lui l’amor di Padre!». Infi ne, ecco Bruto che, smessi i panni del Console, parla ai fi gli «qual Padre», interrogandoli in maniera pressante, affi nché gridino la loro innocenza, svelino chi li abbia sedotti: se le lusinghe di ricchezze e onori o Tarquinia. Bruto si appella alle tenerezze di padre, al suo amore, all’esempio della virtù, per poi lasciarsi andare al dolore delle mancate speranze, riposte nel creder che l’essere fi gli del «Liberatore» fosse per loro motivo di gloria. Leggiamo solo l’inizio e la fi ne della lunga parlata di Bruto (sc. IV), in cui il registro stilistico teso al patetico si modula su un ritmo rallentato dalle sospensioni:
Qual Consolo sin ora io vi parlai,Or qual Padre vi parlo. [...]Io m’ingannai nella mia speme? ... allora Che stesi la mia man sul vostro capoNel giuramento, non so qual ribrezzoMi gelava le vene... Oh fi gli miei!Tu piangi, Tito... Tu, Tiberio, fremi...Parlate, rispondete; me d’affannoE di dubbio sciogliete... Ancor tacete?Ed in vano da Padre io vi parlai?Itene, ingrati fi gli.!"
Nella dedica ad Anna Caterina di Sassonia, Conti sostiene che lo scopo educativo del Lucio Giunio Bruto ruota attorno all’opposizione virtù-vizio, in base alle due tradizionali «maniere d’ammaestrare»: per via positiva (lo zelo di Bruto) e per via negativa (Tiberio che giura e si adopera per la morte del padre). Con argomentazioni più complesse lo stesso concetto è ribadito in più punti della Prefazione, soprattutto laddove Conti defi nisce lo zelo di Bruto (su cui si fonda l’azione della tragedia), richiamandosi alla passione della gloria, come «una delle più veementi, che senta il core umano», in quanto non si può concepire «un maggior bene, che quello di procurare a tutto un popolo la libertà».!4 Nel passato la prudenza aveva indotto Virgilio (Eneide, VI, 4#"-4!1) ad attribuire lo zelo di Bruto a una smoderata cupidigia di lode, perché – afferma Conti – scri-veva sotto Augusto «che avea distrutta la libertà della Repubblica dallo stesso Bruto stabilita».!2 Nel presente, invece, assente ogni ragione politica, soltanto chi condanna l’eccesso nei caratteri tragici potrebbe biasimare il comportamen-to di Bruto: è uno dei tanti slittamenti da un piano all’altro del discorso (qui dal piano politico a quello poetico) che caratterizzano l’argomentare di Conti.
!" Cfr. Lucio Giunio Bruto, #a ed., cit., p. 6#; !a ed., cit., pp. #5"-#52.!4 Prefazione, in Le quattro tragedie, I, cit., p. 15.!2 Ivi, p. 1#.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!4#
Appellandosi alla natura e al costume, l’abate prospetta una lettura univoca della tragedia, senza tuttavia sottrarsi all’argomento più spinoso della presunta legittimità delle rivendicazioni di Tarquinio basate sulla continuità del regno. Forte degli insegnamenti giuridici di Gravina e di Montesquieu, risponde che «i Re sono soggetti alle leggi come gli altri, e meritano, violandole, d’esser puniti; tanto più che il governo dei Re Romani non era assoluto ed indipendente, come il Monarchico».15 In realtà, se Virgilio «non scopre quel ch’egli pensa», non lo fa sino in fondo neanche l’abate Conti.
L’esperienza di spettatore «per tre sere consecutive» dell’Ulisse il giovane dell’abate Lazzarini, andato in scena al San Samuele il $ dicembre #"3!, spinge Conti a trasportare sulle scene il progetto di un teatro romano tratteggiato nella Prefazione a Prose e poesie (su cui ritorneremo). Allo stesso modo il riscontro scenico del Lucio Giunio Bruto lo induce a ritentare la via del teatro, facendo stampare frettolosamente anche il Marco Bruto:
Io credeva che questo progetto fosse solo ideale, e lo proposi, come Platone la sua Repubblica; ma nell’anno scorso essendomi fatte varie istanze, perché io dessi al pubblico il Giunio Bruto, io molto vi resistei sotto varj pretesti, non credendo mai che l’ipotesi di un Teatro Romano potesse convenire ad uno spettacolo venale, ma fui molto sorpreso nel vedere, che con sommo silenzio si ascoltò da tutto il Teatro la lunga concione di Giunio Bruto, la quale, poche cose cangiate, è la stessa, che quella di Dionigi d’Alicarnasso.1#
L’iter del Marco Bruto segue lo stesso procedimento della precedente tragedia (stampa provvisoria - rappresentazione - stampa defi nitiva): il tutto nel corso del #"33. E anche questa volta Conti invia al Muratori un esemplare «slegato» della seconda edizione, approntata dopo le due repliche al San Samuele durante il Carnevale.1! L’unica differenza con il primo esperimento teatrale concerne la paternità d’autore, esibita ora sin dalla prima stampa, pur se all’interno, in testa alla dedica a «Sua Eccellenza il Signor Lodovico Manin senatore». L’ori-ginario paratesto comprende, inoltre, un’avvertenza («A chi legge»), in cui si annuncia «una prefazione a spiegarne a lungo il fondamento storico che diede occasione all’artifi zio poetico della Tragedia».11 Richiamando il Cesare, Conti specifi ca nell’avvertenza il diverso intento del Marco Bruto nel cambiamento
15 Ivi, p. !4.1# Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., p. #25. Per il riferimento all’Ulisse il giovane,
p. #4$.1! Cfr. la lettera di Ercole Gherardi del !1 maggio #"33, in L.A. Muratori, Carteggio, cit., p. !5$.11 Marco Bruto. Tragedia, Venezia, Presso Giambatista Pasquali, #"33 (45 pp. in #$), p. 2. L’esemplare
reperito è posseduto dalla Biblioteca Marciana. La tragedia non è segnalata da nessun altro catalogo delle più importanti biblioteche, italiane ed estere.
%&'()*+& ',-./0&((*
!4!
dell’azione, ridotta «alla risoluzione che prende Marco Bruto d’uccider l’amico per l’amor della Patria». A differenza del Cesare e dei discorsi che lo riguardano, tutti improntati al dilemma etico e politico rispetto alla congiura, allo stato di decadenza della repubblica e agli intenti di Cesare, la dedica del Marco Bruto è univoca nel giudizio storico e politico dalla parte di Bruto:13
La materia è la morte di Giulio Cesare, il più grande Uomo nel militare e nel politico, che abbiano avuto i Romani, ma che meritò la morte in pena della sua smisurata ambizione, e per aver estinte non che debilitate ed infrante quelle poche reliquie di Repubblica che ancora restavano. L’azione è la risoluzione ponderata, determinata, eseguita da M. Bruto d’uccider Cesare in mezzo del Senato, luoco principale del delitto di lui. Marco Bruto traeva l’origine paterna da Lucio Giunio, e la materna da Ahala Servilio, due illustri esterminatori de’ tiranni. Egli egregiamente prese ad imi-tarli, né da lui mancò, che l’antica Repubblica Romana non ritornasse nel suo primo splendore. L’amor della Patria in lui si superò tutti gli altri riguardi, che meritò d’esser considerato da’ più gravi Storici come l’ultimo cittadino di Roma.16
Queste argomentazioni sottintendono il parallelismo Roma-Venezia e la loro corrispondenza, in quanto repubbliche, al genere tragico. Esse non si di-scostano, se non per la loro icastica brevità, dalla prefazione al Marco Bruto (che ovviamente nella seconda edizione prenderà il posto dell’avvertenza), dove, parlando della tragedia di Sebastiano Degli Antoni, La congiura di Bruto, Conti sostiene che essa gli ha suggerito la possibilità di fare «due Tragedie separate, e nell’una conciliar a Bruto la compassione per la sua virtù, e nell’altra a Cesare per la sua magnanimità».1$ Chiaramente dalla parte di Cesare con il pentimento fi nale di Bruto che scopre d’essere fi glio naturale di Cesare,1" la tragedia di Degli Antoni, in cui il personaggio del dittatore è assente, offre a Conti il modello per costruire un testo in cui la compassione non sia più scissa fra Cesare e Bruto, ma sia convogliata tutta nel cittadino Bruto.14 Come anticipato nella Prefazione a Prose e poesie, «riguardando una cosa da diversi lati, si può, secondo il vario punto di vista, variarne ancor la fi gura». Trasformato Cesare in personaggio «invisibile»,
13 Cfr. il cap. su Conti, in B. Alfonzetti, Il corpo di Cesare. Percorsi di una catastrofe nella tragedia del Settecento, Modena, Mucchi, #242, pp. #13-!55, in cui si erano utilizzate le seconde edizioni e la postuma.
16 La dedica è ristampata anche nella seconda edizione: Marco Bruto. Tragedia del Signor Abate ANTONIO CONTI Patrizio veneto, seconda edizione, Venezia, Giambatista Pasquali, #"33.
1$ Prefazione, in Le quattro tragedie, I, cit., p. #"$. La prefazione e il testo della seconda edizione sono citati dalla postuma.
1" Così anche La Mort de César di Voltaire. Costoro «per appassionar le loro Tragedie sfi gurarono la più bella e la più celebre azione d’un Cittadino Romano». Prefazione al Marco Bruto, cit., p. #63.
14 Cfr. La congiura di Bruto, fi gliuolo di Cesare. Tragedia del Signor SEBASTIANO DEGLI ANTONJ, Vicenza, s.n.t., #"11. Ho consultato la tragedia nella riedizione non priva di ammodernamenti del Teatro italiano del secolo decimottavo, III, Firenze, Cambiagi, #"43, in cui è compreso anche il Giunio Bruto di Conti.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!41
Conti appiana il problema ‘estetico’ (la scissione dell’unità di interesse ora per Cesare ora per Bruto), senza pervenire tuttavia a un giudizio storico-politico unitario sulla congiura. L’introduzione del principio della legittimità del potere (e dell’usurpazione), grazie al ricorso agli storici antichi e moderni sino a Rol-lin, gli consente di affermare la tirannide di Cesare.12 Ma in realtà è soprattutto Plutarco lo storico seguito nel delineare l’immagine virtuosa di Bruto, fi losofo stoico votatosi alla difesa della patria e della libertà. Lo stesso dettato limpido non si coglie ancora nella Prefazione a Prose e poesie, da cui si apprende che Conti ha rivisto il Cesare alla luce dell’inquietante Apologia di Cesare di Alessandro Guarini, utilizzata per una prefazione rimasta incompiuta, secondo quanto attestato da Toaldo. Conti, però, si limita a scrivere che Guarini «tutti prevenne» (anticipò) gli altri storici nel comparare le fonti, mentre si accinge, nel riformare (o riscrivere) il Cesare, a dare un ritratto ideale del dittatore, ponendo «l’azione nell’esecuzione del disegno ch’egli ha di riformar la Repubblica, dandogli un capo elettivo»: unica condizione, ormai, per riabilitare la fi gura di Cesare e quindi per una tragedia speculare e opposta, in base al diverso ‘punto di vista’, al Marco Bruto.35
Alla luce di quanto detto, si comprende come le modifi che apportate al Marco Bruto, «stampato e ristampato»,3# siano assai più complesse rispetto al Lucio Giunio Bruto: aggiunte di ampie porzioni testuali, eliminazione di alcuni versi, smembramento di parlate e di scene, spostamento di sequenze, cambiamento dei versi lirici nel primo coro, modifi ca del personaggio di Bibulo, fi glio di Porzia, da presenza muta a persona drammatica vera e propria, introduzione del sogno profetico di Servilia nel quarto atto e del personaggio dello Schiavo nel quinto. Nel complesso la tragedia assume una struttura più ampia e drammatica per quanto attiene sia alla fi gura di Porzia, isolata in uno splendido soliloquio nel-l’ultimo atto, che a quella di Bruto in cui il maggior peso assunto dal dilemma è controbilanciato dalla lucida demarcazione fra vendetta privata e sfera degli affetti, da un lato, e doveri del cittadino, dall’altro, riassunti nell’amore per la patria. I cambiamenti introdotti sembrano obbedire non solo a ragioni ideolo-giche, ma anche a ragioni poetiche e teatrali, come si coglie dai vari riferimenti della Prefazione agli attori e alla scena.
Tra i nuovi inserti, volti a caratterizzare negativamente la fi gura di Cesare e per converso a far risaltare l’umanità di Bruto, si segnalano quelli del primo
12 Cfr. Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., pp. #"! sgg.35 Prefazione a Prose e poesie, I, cit. Anche per il Cesare occorrerà un confronto fra edizioni, stesure
e recite. In proposito cfr. le Notizie, cit., p. $! e la lettera di Conti del !" marzo #"!4 su una recita di nobili dilettanti a Torino da una copia del Cesare non ancora stampato, in A. Conti, Lettere da Venezia a Madame la Comtesse de Caylus 1727-1729. Con l’aggiunta di un Discorso sullo Stato della Francia, a cura di S. Mamy, Firenze, Olschki, !551, p. #42.
3# Prose e poesie, II, cit., p. "1.
%&'()*+& ',-./0&((*
!43
e del secondo atto. Dialogando con Albino, Cassio ricorda di aver infi ammato l’animo di Bruto con l’iscrizione posta sotto la statua di Giunio Bruto:
Ei lesse i motti; s’infi ammò di zelo.E pensieroso egli a osservar più diessiDi Giulio tutte le parole, e gli atti.
Ei lesse i motti; s’infi ammò di zelo:E ad osservar più diessi attento l’artiDel pieghevol ingegno, e i fi nti affettiD’una scaltra pietà, d’un’ira cauta,E il non più simulato amor del RegnoE di Monarca l’arroganza e il fasto.
(atto I, sc. II)3!
Al suo primo ingresso scenico, situato nel secondo atto, dopo i dubbi etici (trucidare l’amico e il padre d’elezione) espressi a Porzia, Bruto manifesta a Cassio il timore che la congiura possa apportare rovina, scatenando una devastante guer-ra civile, secondo uno schema di ragionamento che connota fra gli altri il pensiero e la drammaturgia romana di Voltaire dalla Mort de César al Triumvirat:
Bruto. Esterminato un’altra volta il mondoDunque io vorrò? Ma quando anche il volessi,Gli Dei non ponno favorir quest’opra.
BrutoEsterminato un’altra volta il mondoDunque io vorro?
Cassio Per migliorar l’Impero.
BrutoMa se si sfascia e si distrugge? Ah miraDividersi, assalirsi, lacerarsiLe Città tutte, le Provincie, e i Regni;Il Senato, ed il popolo discordeTrafi ggersi a vicenda; quella Roma,Che ad innalzar costò tante fatiche,Nel sangue involta, saccheggiata, ed arsa?Gli Dei non ponno favorir tal’opra.
(atto II, sc. II)31
3! Cfr. Marco Bruto, #a ed., cit., p. #"; !a ed., cit., p. !!5. Nella #a ed. «moti» qui corretto.31 Marco Bruto, #a ed., cit., p. 13; !a ed., cit., p. !3!.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!46
In coda alla scena quarta, sempre nel secondo atto, si registra un’altra aggiunta di otto versi distribuiti fra Cassio, Albino e Porzia. Quelli recitati dai due congiurati rimarcano l’attentato portato da Cesare e da Antonio alle due potenze legislatrici del Consolato e del Tribunato (episodio dei Lupercali e imprigionamento dei tribuni narrato da Plutarco), mentre l’invocazione di Porzia a Catone accresce il senso sacrale della congiura, più avanti defi nita da Bruto «sacrifi zio grande» per la patria. Così si giustifi ca il superamento della «fl uttuazione dell’animo di Bruto», diventando inoltre più stretto il legame fra Bruto e Catone, nume tutelare della stessa congiura: «Padre, tu che dal Ciel miri, e compiangi / L’ombre e gli errori della nostra notte, / Rischiara Bruto, ed il tuo cor gl’infondi».33
La narrazione del sogno di Servilia è inserita nella prima scena del quarto atto, durante il teso confronto fra Servilia e Bruto, a sua volta molto rimaneg-giato. La sequenza trae lo spunto dalla Congiura di Bruto di Degli Antoni, dove Servilia, che sospetta di pratiche segrete e della congiura, fi nge di averle sognate nel tentativo di arrestare Bruto.36 Rispetto alla prima edizione, sono cassati tre versi di Bruto poco rispettosi verso la madre («[...] Taci, / Né provocare rispettoso fi glio / A palesar che di Servilia il sangue / Men corre in lui, che quel di Giunio Bruto») e sono aggiunti oltre novanta versi quasi tutti pronunciati da Servilia. Dopo aver enfatizzato la sacralità di Cesare (dittatore, imperatore e padre della Patria, consacrato a Vesta e Venere), Servilia narra le sequenze del sogno. Scor-rono così le visioni: il fuoco che arde la città, Bruto posto in salvo da Minerva; l’esercito di Bruto, prossimo alla vittoria, assalito da una tempesta scatenata da Venere e Vesta; Bruto, spinto dall’Ombra di Cesare, in atto di pugnalarsi. Il sogno come uno specchio è profezia dei «futuri eventi», secondo un topos già adoperato nel Cesare a proposito del sogno di Calpurnia (atto IV, sc. I), e quindi la sua aggiunta si spiega con il clima di suspense che deve aleggiare prima della catastrofe, soprattutto nella drammaturgia della congiura.
Soltanto a proposito di Bibulo, fi glio di primo letto di Porzia, Conti accenna nella Prefazione ai ritocchi portati al testo originario: qualche anno in più per sciogliergli la lingua, modellandolo sulla «fantasia contagiosa» di Porzia «in cui l’amor della Patria è misto col desiderio della vendetta della morte del Padre».3$ Due sono le sequenze in cui Bibulo da presenza muta assume la parola: nella prima con due brevi repliche alla madre mostra l’intento di andare a pregare per la patria (atto I, sc. III); nella seconda invece le originarie parlate di Porzia e di Bruto sono smembrate e intercalate dalle parole antitiranniche di Bibulo
33 Cfr. Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., p. #$"; #a ed., cit., p. 1"; !a ed., pp. !34-!32.36 Cfr. S. Degli Antoni, La congiura di Bruto, cit., atto I, sc. IV, pp. #"#-#"!.3$ Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., pp. #"4-#"2.
%&'()*+& ',-./0&((*
!4$
(ad esempio: «Quando mel dici, nel mio petto io sento / Crescere sempre più l’odio al tiranno»). Gli altri versi aggiunti sono suddivisi rispettivamente fra Porzia e Bruto che ha modo così di sublimare la sua personale adesione alla congiura, separando la sfera privata degli affetti da quella pubblica (amore e salvezza della patria):
BrutoAdunque per timor d’ira privataTenerezza di Padre, amor di SposoDesterammi a dar morte al caro Amico...Non fi a mai ver, al sacrifi zio grandeNon altri appella me, che la saluteDella Patria e l’amor; amor che primoD’ogni altro nasce a un Cittadin nel petto,E a cui sacrifi car debbe se stessoMille volte, non che la moglie e il fi glio.
(atto III, sc. II)3"
Muta radicalmente la dinamica del precipitare degli eventi con l’introdu-zione dello Schiavo (atto V, sc. V), anch’essa suggerita dalla tragedia di Degli Antoni in cui Cratilio, dopo aver udito Cassio, Bruto e Casca concertare la congiura, ne riferisce il piano a Servilia.34 Nella versione originaria Servilia re-stava confusa di fronte al delirio di Porzia che invocava l’ombra di Pompeo per poi essere sopraffatta da visioni: lo sposo trafi tto, l’eclisse, la rovina. Nel testo rivisto, invece, Servilia arriva al seguito dello Schiavo che la rende edotta degli abboccamenti in casa di Bruto e dei suoi vani tentativi di avvertirla. Il delirio di Porzia, qui suddiviso in due scene, fa intuire a Servilia la veridicità delle parole dello Schiavo, subito inviato a Cesare. Il parlare visionario di Porzia prosegue nel lunghissimo soliloquio della sesta (speculare a quello di Calpurnia del Ce-sare, atto IV, sc. V), determinando la crescita del numero delle scene, da nove a dieci, nel quinto atto. La canonica narrazione della congiura, affi data a Casca, è ritoccata in un solo punto riguardante il ruolo di Trebonio prima in atto di fermare Cesare, ora Antonio.
Un altro cambiamento di rilievo riguarda il primo componimento del primo coro in cui la canzonetta di due sestine e una quartina di ottonari è sostituita da un’ode in due strofe di quinari sdruccioli e tronchi. Al centro campeggia la fi gura di Catone: nella prima versione ritratto in una posa più ‘realistica’ volta a istituire la continuità ideale fra Giunio Bruto e Catone («Quante volte il gran
3" I primi tre versi sono aggiunti (cfr. Marco Bruto, #a ed., cit., p. 65; !a ed., cit., pp. !$$-!$").34 Cfr. S. Degli Antoni, La congiura di Bruto, cit., atto III, sc. V.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!4"
Catone / Ritornando dal Senato / Co’ Triumviri sdegnato / Venne in questa pia magione / Sé a specchiar nel Simulacro / Al vetusto Bruto sacro!»), poi raffi gu-rato secondo l’identità del personaggio in Virgilio e in Dante: «O infaticabile / De’ Numi interprete, / Che al sempre lucido / Etere Elisio / Conduci l’anime; / Onde dell’Erebo / Le vie tu illumini, / L’atroce Cesare / Uopo non ha».
Nel complesso la seconda edizione del Marco Bruto è l’esito di un traguar-do in cui scena e testo sono strettamente intrecciati. Avendo fatto tesoro della pratica scenica, la Prefazione si sofferma sugli aspetti più strettamente teatrali, toccando innanzitutto il nodo della teatralità del genere tragico. Le dotte ar-gomentazioni sulla versifi cazione e sulla varietà, gravità e chiarezza consentite dall’endecasillabo, grazie alle cesure e allo smembramento in più periodi nei dialoghi, sono commisurate alla concreta recitazione degli attori:
Da questa chiarezza ne nasce, che i Comici più facilmente imparano a memoria i versi endecasillabi, e più naturalmente gli pronunziano e atteggiano. Interrogati da me su questo punto, concordemente me l’attestarono, ed io per tre sere consecutive udii l’Ulisse il giovane del Lazzarini, nel quale i versi di sette e di undici sono intrecciati, e ritrovai coll’esperienza e sul fatto vero il detto de’ Comici.32
Fra gli attori della compagnia del San Samuele Conti ha parole di elogio per Gaetano Casali, l’interprete del personaggio di Giunio Bruto e forse di Marco Bruto:
Tra gli altri Attori, che hanno il lor merito, rappresentò il Giunio Bruto il Signor Gaetano Casali, a cui può applicarsi ciò che Cicerone dice di Roscio, e così piacque la Tragedia che io mi determinai ad arrischiar in quest’anno la seconda, o il Marco Bruto. Ella si rappresentò verso il fi ne del Carnevale, o in un tempo nel quale a Venezia amano gli uomini più di ridere che di piangere; contuttociò si può dire, che due volte fu con diletto e con meraviglia veduta da coloro che v’intervennero e poteano giudicarne, né la ritrovarono oscura, se non quelli del popolo, che poco o nulla intendeano la Storia Romana. Ciò mi fece concludere che potevasi a Venezia riformare il Teatro.65
La notorietà di Casali, «uomo onesto e civile, ed il meglio istruito degli altri nel suo mestiere», si deve soprattutto a Goldoni, che ne traccerà in più scritti, dalle prefazioni all’edizione Pasquali sino ai Mémoires, un ritratto proiettivo e paradossale rispetto alla sua riforma. L’attore era stato il tramite fra Goldoni e la compagnia Imer-Vitalba e quindi con i teatri dei Grimani, il San Samuele e il San Giovanni Grisostomo, per i quali Goldoni lavora sino al #"31. Sulle parti tragiche interpretate dal novello Roscio si hanno le testimonianze di Gianvito Manfredi e dello stesso Goldoni che lo ricorda come più incline alle tragedie,
32 Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., p. #4$.65 Ivi, pp. #25-#2#.
%&'()*+& ',-./0&((*
!44
nelle quali «riusciva mirabilmente, e soprattutto nelle parti gravi, come nel Catone di Metastasio, nel Bruto dell’Abbate Conti, nella parte di Giustiniano nel suo Bellisario».6# Il trattato sull’attore di Manfredi risponde alla duplice esigenza di istruire i comici, la cui arte è tanto apprezzata presso le corti europee, e di rivalutare proprio la compagnia dei comici del San Samuele, dove il «celebre» Gaetano Casali, come in precedenza «il famoso Lelio, con la sua brava Flaminia» (i Riccoboni), «si studia ridurre il teatro al gusto de’ buoni tempi, e per lo più rappresenta tragedie di buoni autori con concorso numeroso, ed applauso».6! Casali, «presenza davvero cruciale nel panorama teatrale degli anni ’15-’65»,61 è per unanime consenso il più bravo di tutti e sembra prestarsi al progetto di rivalutazione del repertorio tragico che, dopo i gloriosi anni Dieci-Quindici, riparte alla fi ne degli anni Trenta a Venezia.
!. La fondazione del teatro romano
Per pura coincidenza, il #"12, anno del primo tomo di Prose e poesie, è anche l’anno dell’arresto (e del processo) di Tommaso Crudeli. Superati gli indugi Conti si fa voce attiva in ambito editoriale e teatrale, partecipando fra l’altro al rinnovamento del repertorio del San Samuele, secondo il progetto di riforma voluto da Michele Grimani. A Pietro Conti dedica nel #"35 le traduzioni delle poesie di lady Montagu moglie dell’ambasciatore Montagu, già gran venerabile della loggia inglese.63 In questo quadro va letto l’accenno polemico alla corta vista degli impresari nella Prefazione del #"12, laddove Conti espone il progetto di un teatro venale che, su modello inglese e francese, rappresenti esclusivamente fatti esemplari della storia romana:
6# C. Goldoni, Prefazioni dell’edizione Pasquali (t. XIII), in Tutte le opere, a cura di G. Ortolani, Milano, Mondadori, #216-6$, vol. I, p. "#1.
6! [G. Manfredi], L’attore in scena. Discorso nel quale raccolte sono le parti ad esso spettanti, Verona, Ramanzini, #"3$, pp. $# e 15.
61 Cfr. A. Scannapieco, Alla ricerca di un Goldoni perduto: «Osmano re di Tunisi», «Quaderni veneti», XX, #223, p. !2, cui rinvio per altre testimonianze su Casali, da Baretti a Griselini.
63 Stampate nel #"35, insieme alla traduzione del Riccio rapito di Pope, come appendice al primo tomo di Prose e poesie, apparvero solo nel secondo. Cfr. Versioni poetiche, cit., p. $66. Non escluderei ragioni di cautela per la collocazione ‘massonica’ del nome della Montagu e di Pope. E del resto basti leggere il commento al Comte de Gabalis nella dedica del Riccio rapito «Al Sig. Marchese Manfredo Repetta»: «Nel secolo passato facea gran rumore la compagnia de’ Fratelli intitolati della Croce rosea, i quali era-no tutti applicati a coltivar la scienza Cabbalistica in ordine all’invenzione della pietra fi losofale su cui scrissero tanti libri enigmatici, in cui profanarono l’uso delle cose sante, e le dottrine stesse rivelate, con scandalo de’ buoni, e sommo danno della vera Filosofi a. L’Abbate di Villars introduce nel suo libro un certo Signore Alemanno chiamato il Conte di Gabalis, e che si fi nge morto d’apoplessia, o strangolato dal Diavolo, per aver pubblicati i secreti de’ saggi», Prose e poesie, II, cit., p. XXVI.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!42
È lungo tempo, che io medito su queste cose, e qui preventivamente le espongo per far conoscere quanto s’ordinerebbe, purgarebbe, illustrerebbe il Teatro Italiano, se gl’Impresarj persuasi una volta dell’indegnità delle nostre Commedie, e della stuc-chevolezza de’ Drammi musicali, conoscessero i loro propri interessi.
Cinque anni dopo, nella Prefazione al Marco Bruto, conferma la sua adesione e il suo contributo non tanto alla scrittura di tragedie d’argomento romano, per altro già avviata con il Cesare, quanto piuttosto alla fondazione di un ‘Teatro Romano’, ricordando soltanto le due tragedie andate in scena al San Samuele:
Conformandomi io a tali saggi precetti non dal Gravina, ma dalla natura, o dall’espe-rienza, e dalla Filosofi a stessa dettati, ho fi n ora dal mio canto contribuito al comincia-mento del Teatro Romano con due tragedie, il Giunio Bruto, ed il Marco Bruto.66
L’esclusione forse momentanea sia del Cesare, in vista della sua ‘riforma’ (dare a Cesare un carattere ideale), che del Druso si spiega con una selezione voluta, rispondente agli intenti dell’ultimo Conti (scena pubblica, teatro romano, valori di patria, repubblica e libertà), in cui rientra la stessa scrittura del Marco Bruto, ora addirittura defi nita «la più bella e la più celebre azione d’un Cittadino Romano». Conferma questa mia lettura l’importante lettera al Bentivoglio del #"15, da cui si apprende che il Druso è quasi ultimato, mentre il Bruto è in fase di abbozzo, e che le tre tragedie «fanno un sistema compiuto» della storia romana: inizio e decadenza della repubblica, monarchia. Il nuovo soggetto (Giunio Bruto), inoltre, offrirebbe la possibilità di «introdurvi ciò che è stato insegnato di più grande e di più bello dagli antichi e da’ moderni su la stessa temperatura de’ governi politici».6$ Sino al #"15 Conti dunque riteneva concluso il ciclo della sua drammaturgia romana con il Lucio Giunio Bruto e soltanto nella Prefazione del #"12 nomina il Marco Bruto, con cui in realtà prende le distanze non tanto dalla tragedia di Degli Antoni, quanto piuttosto dal suo Cesare e dalla Mort de César di Voltaire, la cui cifra comune era l’ambiguità: «In ordine al proposto disegno ho io composto quattro Tragedie, che contengono l’Epoche principali dello stabilimento della Repubblica, del suo cangiamento in Monarchia, e de’ vizj strabocchevoli de’ Monarchi».6" Poi nella Prefazione al Marco Bruto, per marcare la continuità fra il progetto e la sua realizzazione, Conti cita ampi passi della
66 Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., p. #65.6$ Cfr. Conti-Bentivoglio, in R. Rabboni, Il carteggio fra Antonio Conti e Cornelio Bentivoglio, cit., p. #13.6" Cfr. Prefazione a Prose e poesie, I, cit. Più che da Gravina il modello del ciclo romano procede da
Pansuti (amico di Gravina e allievo di Caloprese) che Conti non nomina mai forse per la partecipazione del suo autore alla congiura fi loasburgica del #"5#. Sul ciclo di Pansuti apparso dal #"#2 al #"!2 (Orazia, Bruto, Virginia, Sofonisba, Sejano) e poi postumo (Le tragedie, #"3!), cfr. B. Alfonzetti, Congiure. Dal poeta della botte all’eloquente giacobino (!"#!-!$#!), Roma, Bulzoni, !55#, pp. 1"-#5".
%&'()*+& ',-./0&((*
!25
Prefazione a Prose e poesie che metteva in parallelo, sotto il segno di un teatro nazionale, la corrispondenza fra il teatro inglese e quello romano:
Chi può biasimar colui, che veggendo gli Uomini del suo secolo tanto innamorati della Storia Romana, tenta di promuovere il modo più facile e dilettevole per farla più universale? V’è un’altra ragione: gl’Inglesi amano le Tragedie dei loro Re, perché dai fatti dimestici meglio s’impara che da’ stranieri. Noi siamo tutti Cittadini d’Italia, egli ci è dunque naturale amar le cose che accaderono nel nostro Paese, e lusingarci almeno con la memoria della grandezza delle virtù, e dell’Imperio di coloro che do-minarono tutto il resto della terra a lor nota, e vi dominano ancora con le leggi, che a tutte l’altre nazioni parteciparono.64
Utile alla «società civile», anche il teatro tragico può e deve aprirsi alle scene pubbliche, senza il timore che possa risultare incomprensibile. All’obiezione che il Marco Bruto sia troppo carico di storia romana, «ignorata dal popolo spettatore ne’ Teatri venali», Conti replica distinguendo fra la «vil plebe», a cui sarà oscuro, e un «aggregato di persone» informate della favella e della storia romana, an-che superfi cialmente, che lo troveranno chiaro. Così facendo, non solo indica il concreto lettore-spettatore del suo teatro romano («colui dunque, che non ha alcuna tintura d’Istoria Romana, non vegga né legga le mie Tragedie»), ma anche il legame che unisce il linguaggio del passato con quello del presente, poiché allo stesso modo si argomenta «oggidì» nel Senato, nel Foro «o nelle case de’ politici affari». A differenza del Cesare, volto a istruire soprattutto i Principi e le Repubbliche,62 il teatro romano andato in scena al San Samuele si rivolge a tutti i ceti sociali (con l’esclusione della bassa plebe) in grado di comprendere il linguaggio delle istituzioni e della politica.$5
Conti compie quest’esperimento confortato dal fatto che negli ultimi tempi «Poeti saggi ed ingegnosi» si sono volti all’opera di riformare il teatro, essendo ormai prevalsa «la comune opinione, che non si debba, né si possa distruggere il teatro per i vantaggi che ne ritrae la società civile».$# In effetti, da sparse notizie è documentato che dal #"14 al #"3" si rappresentano al San Samuele sei tragedie francesi (di Voltaire, Gresset, Corneille, La Motte ecc.) e varie tragedie italiane (di Goldoni, Lazzarini, Rucellai, Conti ecc.). La rappresentazione dell’Ulisse il giovane dell’abate Domenico Lazzarini, replicata per più sere e preceduta dall’Oreste di Rucellai, già interpretata da Riccoboni nel #"#5, fece scrivere allo
64 Cfr. Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., pp. #42-#25. Sul valore nazionale del teatro romano già l’importante monografi a di M. Ariani, Drammaturgia e mitopoiesi. Antonio Conti scrittore, Roma, Bulzoni, #2"", p. #!.
62 Cfr. «A Sua Eminenza il Signor Cardinale Bentivoglio d’Aragona», in Le quattro tragedie, II, cit., pp. 1!! e 1!4-1!2.
$5 Cfr. Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., pp. #4"-#42.$# Ivi, p. #31.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!2#
Zanetti nelle sue Memorie ch’era iniziata la «vera epoca del buon gusto intro-dotto nel Teatro Italiano».$! Il San Giovanni Grisostomo, sempre di proprietà dei Grimani, rinnova l’affi tto a un gruppo di nobili e borghesi (Pietro Foscarini, Luigi Pisani, Giovanni Mocenigo, Jacopo Sanvitali, Federico Borromeo, Bono-mo Algarotti, Jacopo Hertz, Piero Vendramin, gli stessi Grimani, ecc.), che vi fanno rappresentare varie opere, soprattutto di Metastasio, «non senza notabile perdita», secondo lo Zanetti.$1
In ambito editoriale si gioca la partita decisiva. Nel #"31 compare presso l’edi-tore Bettinelli il Nuovo teatro italiano che comprende l’Ulisse il giovane di Lazzarini, La Merope di Maffei e il Cesare di Conti, raccolta che si richiama a quella del Teatro italiano di Maffei, in cui erano state edite per uso delle scene le nostre tragedie cinque-secentesche. Nel #"31 è la volta del Lucio Giunio Bruto, nel #"33 del Marco Bruto. Nello stesso anno appare anonima la traduzione della Merope di Voltaire, segnalata per altro dalle Novelle della repubblica letteraria per l’a. 1744 quale opera dell’«illustre penna di chi poco fa ci diè le due pregevoli tragedie Marco Bruto e Lucio Giunio Bruto».$3 Del #"31 è l’Illustrazione del Parmenide di Platone con una Dissertazione preliminare. Dopo anni di silenzio, l’attivismo dell’abate sembra collegarsi alle funzioni affi date al teatro anche in ambito massonico.$6
Un altro tassello di questa ricostruzione, per altro assai incompleta, è l’aiuto dato a Goldoni nel #"35, quando Conti lo «animò» a rappresentare al San Samuele la tragedia Enrico Re di Sicilia in occasione dei festeggiamenti per il soggiorno veneziano di Federico Cristiano di Sassonia, fi glio ed erede di Augusto III re di Polonia ed Elettore di Sassonia.$$ In realtà l’inserimento dell’Enrico nel pro-gramma del San Samuele si deve proprio alla mediazione di Conti che aveva conosciuto due anni prima il principe durante la sosta a Padova del corteo regale che accompagnava la principessa Maria Amalia (sorella di Federico Cristiano) a Napoli dopo le nozze per procura con Carlo di Borbone. Del lungo viaggio del
$! G. Zanetti, Memorie per servire all’istoria della inclita città di Venezia, «Archivio veneto», XXIX, #446, p. #5". Professore di lettere latine e greche dal #"## all’Università di Padova, Lazzarini muore nel #"13. Non escluderei che la recita al San Samuele sia stata promossa da Conti che con l’abate partecipava all’Accademia dei Ricovrati. Cfr. la nota introduttiva a D. Lazzarini, Teatro, a cura di N.F. Cimmino, Roma, Abete, #2"5.
$1 N. Mangini, I teatri di Venezia, Milano, Mursia, #2"3, pp. #31-#33.$3 Cfr. la nota fi lologica alla Merope, in Versioni poetiche, cit., pp. $"1-$"3. Ma cfr. la lettera del
!! agosto #"33 di Ercole Gherardi a Muratori: «Il signor abate Conti la riverisce. Traslatò egli la Merope francese di Voltaire. L’ha data alle stampe e le ne presenta l’ingionta copia», L.A. Muratori, Carteggio, cit., p. !#6.
$6 Per Gian Rinaldo Carli Conti era «l’esponente più in vista della reazione antimodernista e antifrancese a Venezia», anzi uno dei capi, insieme a Gasparo Gozzi, della «Setta Peripatetica». Cfr. M. Ariani, Drammaturgia e mitopoiesi, cit., p. 3#.
$$ Così Goldoni nella lettera del #"6# inviata a Federico Cristiano con la richiesta di potergli dedicare Il Moliere. Cfr. C. Goldoni, Opere complete, VII, Venezia, Municipio di Venezia, #2#5, p. 2".
%&'()*+& ',-./0&((*
!2!
principe (#! maggio #"14-giugno #"35) ci resta manoscritto e autografo il Journal du voyage con la descrizione delle varie tappe e degli incontri: la Serenissima, Padova, Napoli, Roma, Modena (Muratori), Verona (Maffei), Venezia (dicem-bre #"12-giugno #"35).$" Tramite Maffei e altri letterati che l’avevano incontrato durante il fruttuoso anno della permanenza romana, ospite dei cardinali Anni-bale e Alessandro Albani, erano noti i suoi interessi per l’archeologia e gli studi antiquari, le sue visite al Museo Clementino, all’Accademia di San Luca e a quella di Francia, la sua nomina a socio onorario dell’Arcadia. Ritratti pittorici e componimenti poetici degli Arcadi in sua lode, stampati nel #"12, contribuirono a diffondere la fama del giovane principe dotato di un non comune talento nelle arti del disegno e conoscitore del classicismo romano.$4
Seguendo l’esempio di Muratori, che solo un anno prima aveva dedicato il primo tomo delle Antiquitates Italicae al re di Polonia,$2 Conti sceglie come dedicatario il principe ereditario Federico Cristiano per il primo tomo di Prose e poesie (alla zia Anna Caterina indirizzerà il Lucio Giunio Bruto). A differenza delle dediche di Muratori, che cementavano il legame del ducato estense con la casata Wettin, consolidatosi dopo il matrimonio (#"#2) fra il futuro Augusto III e la primogenita dello scomparso imperatore Giuseppe, quelle di Conti stupisco-no per l’apertura al mondo politico tedesco, verso il quale sino al Discorso sullo stato della Francia appare molto cauto per non dire ostile."5 Certamente su tale cambiamento occorrerà indagare più a fondo, senza dimenticare le posizioni fi loimperiali di Marco Foscarini"# e forse l’iniziazione di Francesco Stefano di Lorena (#"1#). Sembrava realizzarsi l’utopia del Principe Filosofo di Platone?
$" Cfr. M. Gemin, L’Adria festosa per Federico Cristiano. La lunga visita, in L’invenzione del gusto. Corelli e Vivaldi. Mutazioni culturali, a Roma e Venezia, nel periodo post-barocco, a cura di G. Morelli, Milano, Ricordi, #24!, pp. #2#-!5" (qui dalla trascrizione di alcune carte del diario compare il nome di Conti fra i visitatori del principe); Ch. Weyers, Il viaggio a Modena del principe ereditario Federico Cristiano di Sassonia, e i suoi rapporti con la casa Estense, in Corte, buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori, Firenze, Olschki, #22$, pp. 66-$2.
$4 Cfr. W. Fastenrath Vinattieri, Sulle tracce del primo Neoclassicismo. Il viaggio del principe ereditario Friedrich Christian di Sassonia in Italia (1738-1740), «Zeitenblicke», III, !551.
$2 Alla prima seguiranno le altre cinque, tutte rivolte ai cinque fi gli maschi del re. La seconda dedica a Federico Cristiano è datata 3 giugno #"35. La ricostruzione delle mediazioni e dei contatti avviati da Muratori sin dal #"1$ in F. Marri, La dedica delle Antiquitates Italicae, in Corte, buon governo, pubblica felicità, cit., pp. "#-4$.
"5 Cfr. le lettere alla Caylus e il Discorso, in A. Conti, Lettere da Venezia, cit., che smentiscono l’ipotesi di un Conti legato, tramite Dubos, alla diplomazia segreta di Dubois volta a garantire la successione dell’Orléans: ipotesi avanzata da S. Ingegno Guidi, Tra Francia e Italia. Discussioni letterarie nell’epistolario di G.G. Orsi ad A. Conti, in Accademie e cultura. Aspetti storici tra Sei e Settecento, Firenze, Olschki, #2"2, pp. #$#-!52 (contributo per altro prezioso).
"# Sui rapporti con Conti e più in generale su Foscarini cfr. F. Venturi, Settecento riformatore, I, Da Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, #224, pp. !"! sgg.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!21
Al di là del fatto che Conti fosse massone o meno (ma certamente molti suoi rapporti e i testi fanno pensare di sì),"! il primo tomo di Prose e poesie ha la struttura di un libro ‘massonico’ di cui la dedica a Federico Cristiano è il compendio."1 Se Muratori farà l’elogio della liberalità, conoscenza delle lingue e amore delle lettere, per ben reggere i popoli, del principe, Conti ne mette in risalto soprattutto la «cognizione delle belle arti» e fra queste la competenza nell’architettura:
Non è facile credere con quale chiarezza d’idee, e precisione di termini V.A.R. mi fa-vellasse e di Storia, e di Lingue, e di Poesia, e quindi di Perspectiva e di Architettura civile, molto compiacendosi di avere di sua mano delineati gli ordini con tutte le loro proporzioni e misure, e sommamente desiderando di vederne eseguiti i modelli ne’ Tempj, e nelle Basiliche erette in Italia da più famosi architetti. Raro genio, e che nel corso di più secoli s’incontra appena in uno o due Principi pari a V.A.R.!
Dall’elogio del giovane principe si passa a quello del suo educatore, al quale in maniera obliqua sembra indirizzata in realtà la stessa dedica. Fra le varie doti possedute da Federico Cristiano, il discorso esalta quelle «tratte dall’esempio Paterno, di fi ssar nell’animo le massime più utili a’ Popoli», dovute all’accortezza politica dell’uomo politico e cultore delle lettere che lo guida:
Ma non si poteva aspettar altro dalla scelta, che da due gran Re l’Avo ed il Padre di V.A.R. è stata fatta del saggio Ministro che la dirige e la forma, istruendola di quelle cognizio-ni, ch’Egli viaggiando, ed indefessamente applicandosi ad ogni bell’arte ha raccolte, e suggerendole que’ consigli, che a’ due Monarchi furono di tanto vantaggio."3
Un altro accenno alla singolare fi gura ritorna poi alla fi ne della dedica che ha inteso esporre in sintesi l’architettura del libro in cui il principe troverà esposte le idee della virtù (bellezza e armonia), radicate nel suo animo e soprattutto «coltivate con assidua cura, e sviluppate senza fatica da chi sempre vegliando al
"! Così G. Giarrizzo, Massoneria e illuminismo nell’Europa del Settecento, Venezia, Marsilio, #223 che in-quadra Conti, accanto a Maffei, Algarotti, Cocchi, in una terza via tra meccanicismo e platonismo (p. 12).
"1 È quanto mi propongo di verifi care in un prossimo contributo. Penso che soltanto una lettura improntata alle corrispondenze simboliche fra mito e scienza possa spiegare il «mistero» dell’approdo al platonismo, che non risolverei, come Badaloni, «in senso metodologico ed in direzione dell’espe-rienza». Se Conti vede nella fi losofi a pitagorica e ionica «un modello teoretico di struttura della natura» (Un abate libero pensatore, cit., pp. #3 e #66), questo accade in virtù della convinzione che fra i vari siste-mi fi sico-astronomici e le cose platoniche vi siano «convenienze» (lettera a Cerati sul Globo di Venere, in Prose e poesie, I, cit., p. #2). D’altronde lo stesso Conti smentisce un supposto approdo platonico, datando tale interesse al soggiorno francese (Prefazione, ivi). Talete, Pitagora e Platone sono tutti ricondotti al sistema egizio cioè al libro di Iside e Osiride di Plutarco, testo fondamentale per comprendere il senso simbolico del platonismo ‘massonico’ di Prose e poesie.
"3 Anche nella dedica (#"35) a Federico Cristiano del secondo tomo delle Antiquitates Italicae Muratori elogia, nominandolo, il conte di Wackerbarth.
%&'()*+& ',-./0&((*
!23
fi anco le sta»; virtù che gli avevano conciliato «la venerazione e l’amore di tutta la Germania e di tutta l’Italia». Il ‘saggio Ministro’ è il torinese Joseph Anton Gabaleone di Salmour, poi in seguito all’adozione da parte del terzo marito della madre conte di Wackerbarth."6 Già diplomatico e consigliere segreto, accompa-gnava il principe in qualità di educatore ed è molto signifi cativo il suo ritratto eseguito da Rosalba Carriera con un libro in mano, in segno dell’interesse per gli studi (arti e scienze)."$ Il conte di Wackerbarth inoltre si distingueva per la diffi cile opera di conciliazione confessionale, dato che la conversione pubblica al cattolicesimo dell’elettore di Sassonia datava al #"#", quando il padre di Federico Cristiano aveva abbracciato la fede cattolica con cerimonia pubblica a Vienna. E per Conti la pace in Europa era il valore supremo da raggiungere per la felicità dei popoli e il progresso delle scienze e delle arti."" Interlocutore della dedica, il conte di Wackerbarth sta per la corte di Dresda che dal #"14 (anno della bolla In eminenti fi rmata da Clemente XII) è uno dei centri di maggiore promozione e protezione massonica."4
I sonetti eroici di Prose e poesie sono una spia del nuovo sguardo rivolto da Conti alla realtà politica tedesca e dello stesso carattere obliquo della dedica (e per inciso anche del cauto atteggiamento assunto, come si evince dal primo sonetto volto a celebrare proprio Clemente XII). Il mondo francese e quello germanico sono accomunati grazie all’allegoria di Chirone che si traduce nell’utopia del Re fi losofo di Platone. Prima era stata la volta della Francia ed ecco il sonetto, che risale alla incoronazione di Luigi XV, dedicato al cardinale de Fleury per aver acceso «nel cuore del grande allievo quelle virtù che attribuì Platone al Re Filosofo, sotto il quale sono felici gli Stati». Ora è la Sassonia che ha riavuto il regno di Polonia grazie alla politica del conte di Wackerbarth, lodato con parole commosse per l’opera di formazione di un principe che promette felicità a tutta l’Europa:
"6 Una scheda del conte in L.A. Muratori, Carteggi con Vannucchi... Wurmbrandt, a cura di M.L. Nichetti Spanio, Firenze, Olschki, #24!, pp. 1$2-1"5, dove è edita una sua lettera a Muratori.
"$ Questa e altre notizie, come l’aver studiato presso il collegio dei nobili di Parma, in W. Fasten-rath Vinattieri, Sulle tracce del primo Neoclassicismo, cit.
"" Cfr. la lettera del #6 maggio #"!", in A. Conti, Lettere da Venezia, cit., p. #3#. Fondamentale quella dell’4 maggio #"!4: il machiavellismo è necessario affi nché i principi non siano i Paladini immaginari del teatro, ma «des héros qui veillent pour le bien de leurs peuples, pour la grandeur de leur nom, et pour les avantages de leur postérité» (p. #24).
"4 La prima loggia nata a Varsavia si trasferisce a Dresda nel #"14. Gran Maestro è il conte Rutowski, fratello adulterino di Augusto III. Nel #"3! i cronisti suonano l’allarme che alla «tribù satani-ca» partecipino gli scrittori e persino le donne. Cfr. G. Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., p. 312. Il principe di Lubomirski, gran Maresciallo di Augusto III, fa parte nel #"1$ della loggia parigina Custoz-Villeroy, nel #"33 fonda a Varsavia la loggia «aux trois Frères». Cfr. C. Francovich, Storia della massoneria in Italia. Dalle origini alla Rivoluzione francese, rist. anast., Firenze, La Nuova Italia, #242, p. 2$.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!26
Sua Eccellenza il Sig. Conte di Wakerbarth fu prima eletto Ambasciator Plenipotenzia-rio alla Corte di Vienna in luogo del Marescial di Fleemeisigh. Passò quindi per affari importantissimi Ambasciator ordinario a Roma; e morto il Re Augusto fu mandato in Polonia dal presente Re, alla cui elezione egli con tanta saviezza e costanza d’animo contribuì. Egli era stato poco prima chiamato dal defunto Re alla sopraintendenza dell’educazione di Sua Altezza Reale ed Elettorale di Sassonia. Io son testimonio di vista quanto ella abbia profi ttato sotto una disciplina sì saggia; ed io non cesserò mai di dire che felice sarebbe l’Europa, se tutti i Principi fossero così educati."2
Nella Prefazione del #"12, Conti afferma di aver destinato le quattro tragedie al terzo tomo insieme al poema fi losofi co, in quanto «esempi nella parte più utile della Poesia». Il teatro è in grado di riunire in sé le arti fondate sull’udito e la vista, cioè sui sensi della bellezza e dell’armonia, secondo quanto espressosi nel teatro antico:
ove erano combinate l’architettura, la scultura, la pittura, la danza, tutte spezie d’imi-tazione, che si riferiscono alla vista, colla Musica e colla Poesia le due spezie, che si riferiscono all’udito.
Il Teatro è l’arte architettonica per eccellenza, in cui sono fondamentali sia la costruzione e la prospettiva, sia la scena. Allegoria e fantasia architettonica sono i mezzi e i principi con cui l’umanità si è espressa «ad insegnare i costumi, e quindi l’arte della vita e de’ Regni» soprattutto nell’imitazione poetica. L’alle-goria ha preservato poeti e fi losofi da pericoli e disprezzi e la stessa Repubblica di Platone è intessuta di allegorie della vita politica e civile. Dai sapienti e sa-cerdoti egizi Platone aveva appreso «l’idea della loro fantasia architettonica», che più in generale si può ritrovare sia nell’architettura che nella poesia degli antichi. Tuttavia la radice delle dottrine di Talete, Pitagora e Platone è comune: «è un solo sistema, ed è l’Egizio, conservatoci da Plutarco nel libro d’Iside e d’Osiride». Passando a parlare dei Romani, Conti rileva che «nelle Metamorfosi Ovidio ci conservò con l’idea del Poema Ciclico quella delle trasformazioni Pittagoriche», esaltando poi Dante, fra tutti i poeti italiani, per i sensi allegorici e la poesia architettonica. Se a questa defi nizione di poesia Conti ha improntato
"2 Prose e poesie, I, cit., pp. CX-CXI. Questo il sonetto: «Pria che il Sarmata Augusto al Ciel salisse / A te rivolto, ed il Nipote stretto / Tenendo al seno: con paterno affetto / A te lo fi do, e tu gli forma disse // La mente e il cor. Sempre ne l’alma fi sse / Pietate abbia e giustizia; ond’ei diletto / Sia de’ popoli in pace, e forte il petto / Esponga in guerra a chi turbarli ardisse. // Tu ’l prendesti, e con saggie arti leggiadre / L’alta virtute gl’infondesti e ’l senno, / Che Polonia ammirò, l’Imperio, e Roma. // Ond’ei fattosi legge or del tuo cenno / L’alma apparecchia a la futura soma / Che grave d’anni lascieragli il Padre» (p. CXI). Esso è seguito da un altro sonetto in cui il poeta invoca la Vergine, affi nché con i bagni di Ischia guarisca il principe dall’infermità ai piedi.
%&'()*+& ',-./0&((*
!2$
lo stesso sogno allegorico del Globo di Venere,45 sono soprattutto le tragedie a rispondere all’intento di una poesia come «sistema di fantasmi sommamente dilettevoli [...] espressi ed applicati dalla facoltà civile a insegnare la verità e la virtù». In gioco non è più soltanto la tragedia come componimento poetico, bensì è il teatro come edifi cio scenico (architettura) e come scena a incarnare la sintesi di una ricerca speculativa che intende farsi allegoria della morale e della politica. Di qui prende corpo il progetto di istituire un teatro dove regolarmente si rappresentassero le tragedie romane:
In questo si vedrebbe in un’occhiata quali fossero le vesti de’ Romani secondo le diverse lor dignità, le acconciature del capo, e gli altri ornamenti delle donne; l’architetture dei’ Palagj, de’ Templi, e i vari aspetti di Roma, i Vasi, le Statue, e mille altre cose, che ansiosamente si cercano ne’ libri degli antichi, quando mancano o le medaglie, o i bassi rilievi, o le reliquie delle rovine. Il Poeta profi tterebbe de’ lumi somministratigli da’ Critici, ed ornerebbe magnifi camente la Scena, cosa che assolutamente manca al Teatro francese non meno che l’armonia e la melodia necessaria al compimento ed alla continuazione della Tragedia.
Nelle tragedie la scena è sempre specifi cata in riferimento alla statuaria, ai templi, alle pitture. Si nota tuttavia progressivamente un interesse crescente per la scena tragica. Se all’altezza del Cesare («La Scena è avanti l’Atrio della Casa di Giulio Cesare situata accanto al Tempio della Clemenza» che «dee essere ornato di trofei, che esprimano quella virtù»), Conti cita soprattutto il monumentale lavoro dell’antiquario de Montfaucon come modello del costume storico degli attori per un’eventuale recita,4# nelle tragedie degli anni Quaranta le indicazio-ni sceniche risentono della concreta esperienza teatrale e del forte recupero dell’architettura vitruviana e palladiana che si respira a Venezia soprattutto per impulso del console Smith, fi gura centrale di antiquario e collezionista.4!
45 In proposito M. Ariani, Drammaturgia e mitopoiesi, cit., ne rileva «la simbologia quasi massonica» (p. 15"), avendo già evidenziato la «cultura antiquaria ed esoterica» (p. !$5) di Conti e il suo intendere il mito «come allegoria di verità occulte ma essenziali» (p. !64). Tuttavia è proprio il «tempio neoclassico» dove si celebra l’apoteosi poetica della donna defunta a rivelarci la cifra misterica (simbolica) del Globo di Venere: il Tempio a lei consacrato ha l’atrio cinto di colonne «qual era il tempio de l’efesia dea» cioè di Artemide e per questo è adornato da varie statue, fra cui una tutta di «mamme» da cui sgorga «argenteo raggio di rotonda luna» (A. Conti, Il Globo di Venere, a cura di M. Farnetti, Roma, Salerno, #223, v. 4!2, vv. 2"5-2"#). Il richiamo a Iside per le statue è dello stesso Conti nella lettera a Cerati (p. !4). Per una più estesa corrispondenza fra la Luna, Diana e Proserpina (e dunque Artemide-Diana) «la stessa che Iside come mostra l’Egizia mitologia» e la spiegazione ‘astronomica’ della favola di Endimione, cfr. Prose e poesie, I, cit., pp. 165-164, dove ancora una volta è citato il libro di Iside e Osiride, alla base del platonismo di Conti. Sul carattere iniziatico del Globo di Venere rinvio al contributo di D. Tongiorgi in questo volume.
4# Per il breve commento alla scena si veda la dedica al Bentivoglio, in Le quattro tragedie, II, cit., pp. 113-116 e 134. Sull’antiquaria anglo-scozzese come scienza simbolica cfr. G. Giarrizzo, Massoneria e illuminismo, cit., p. 1". Il collegamento de Montfaucon-Bacone interessa anche Conti.
4! Cfr. F. Vivian, Il console Smith mercante e collezionista, tr. it., Vicenza, Neri Pozza, #2"#, lavoro prezioso anche per la documentazione iconografi ca. Ma sul senso del collezionismo come «cammino
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!2"
Nel Lucio Giunio Bruto la didascalia scenica recita: «La Scena è nel Foro Romano, situato tra il Palatino ed il Tarpeo, dove è il Tribunale de’ Consoli, ed un recinto, ove si raguna il Popolo distribuito in Curie». Come per il Cesare, l’architettura scenica è di natura simbolica, secondo quanto espresso nella Prefazione, in cui l’abate fornisce una descrizione dettagliata della scena «visibile» (varia pur nel rispetto dell’unità di luogo): da una parte si vede il Tempio di Giove, fatto costruire da Tarquinio, da cui sale il popolo, dall’altra, dove è situato il tribunale dei Conso-li, si scorge in lontananza il Monte Palatino, già Saturno sotto i Re; nel fondo della scena si ergono le rovine dell’arco trionfale e del Colosso abbattuto dal Re, presso il recinto dove si raduna il popolo.41 Come si noterà, nella Prefazione pubblicata dopo la recita, Conti completa la descrizione con il fondo scena cor-rispondente al concreto spazio scenico del San Samuele.43 E inoltre si preoccupa di specifi care il luogo «invisibile», costituito da una valle contigua al Palatino dove si nascondono l’Oratore e Tarquinia sino a quando parla Bruto (atto I, sc. III). I vari luoghi della scena sono praticabili, come chiariscono soprattutto per il Tempio varie didascalie del secondo atto: da esso esce il popolo nella prima scena o vi si recano Vitellia, Tarquinia e Tito nell’ultima.
Ancora più complessa è la scena ideata per il Marco Bruto: «La Scena è un Portico della Casa di Marco Bruto in cui terminano varj appartamenti; dai lati si vede la statua di Giunio Bruto co’ fi gliuoli a’ piedi, con altre statue di Ahala Servilio, di Catone Censore, e di Catone Uticense, con pitture allusive a’ viaggi, ed alla morte di quest’ultimo». Sulla spiegazione di questa scena, Conti si sofferma a lungo nella Prefazione, in cui si notano alcune discordanze rispetto al testo: dalle statue è eliminata quella di Catone il Censore: «Io colloco la statua di Giunio Bruto in mezzo alle statue di Catone e di Ahala. Orno la Sala di molti quadri», quasi tutti riferiti a Catone (in mezzo al Senato in Utica, mentre si suicida). Nella Sala si aprono tre porte: una conduce agli appartamenti di Servilia, un’altra, collocata di fronte, a quelli di Porzia; la gran porta è nel mezzo e si apre alla fi ne, quando Bruto entra con tutto il popolo.46 Secondo lo stesso schema è commentata nella prefazione la scena del Druso («La scena è nel palagio romano, in quella spezie di tempio, ov’era consacrata una statua ad Augusto») che prevede nel fondo una loggia sostenuta da colonne, da cui si accede agli appartamenti di Tiberio, Livia e Livilla, e nelle parti laterali due scale da cui scendono gli attori.4$
massonico verso la perfezione» si veda F. Fedi, Comunicazione letteraria e «generi massonici» nel Settecento italiano, in La Massoneria («Storia d’Italia, Annali», !#), a cura di G.M. Cazzaniga, Torino, Einaudi, !55$, pp. 65-42 (la cit. a p. 6!).
41 Prefazione al Giunio Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., pp. " e !1.43 Un apparato scenico del S. Samuele (#"61) dopo la ricostruzione seguita all’incendio del #"3",
in N. Mangini, I teatri di Venezia, cit., tav. #$.46 Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., pp. #"2-#45.4$ Cfr. Prefazione al Druso, in Le quattro tragedie, II, cit., p. 323.
!"#$%&'" #()*+,"$$&
-./
Le tre porte si richiamano alla scena del Teatro Olimpico di Vicenza e quindi all’architettura di Palladio (l’arco aperto al centro che corrisponde alla porta regia di Vitruvio, affi ancato da due porte più piccole), tassello fondamentale, com’è noto, della storia della libera muratoria secondo le Constitutions del 01-2./1 In ambito teatrale il recupero della tragedia porta con sé l’esaltazione della scena palladiana, come si vede ad esempio dal disegno «fait à l’imitation du Théâtre Olimpique de Palladio» riportato nel secondo tomo della Histoire du théâtre italien di Riccoboni, la cui Dissertation sur la tragédie moderne (01-/) ha in Conti l’inter-locutore nascosto. E probabilmente si deve a Conti il suggerimento della dida-scalia scenica dell’Enrico di Goldoni, in cui si parla di «vera antichissima scena».// A Venezia, dagli anni Trenta in poi la cosiddetta ditta Smith-Pasquali costituisce il centro di convergenza fra gli interessi per Palladio e per Newton del console Smith e le innumerevoli iniziative editoriali della stamperia Pasquali che cul-mineranno nell’edizione dei Quattro libri dell’Architettura di Palladio (013/)./. Fra i tanti dati da richiamare, si ricordino almeno le committenze fatte da Smi-th ad Antonio Visentini per riprodurre disegni e incisioni di edifi ci palladiani e neopalladiani soprattutto inglesi. Autore del disegno che illustra Il Globo di Venere nell’edizione Pasquali, Visentini lavora anche per il celebre Giovanni Poleni che, già professore di astronomia e di matematica all’Università di Padova, occupa la cattedra di fi losofi a sperimentale fatta istituire da Conti. A sua volta amico di Smith (come del resto Conti) e in corrispondenza col palladiano lord Burlin-gton, Poleni commissiona a Visentini tutta una serie di disegni per l’edizione di Vitruvio non portata a termine, dove architettura e scena tragica trovano la loro perfetta corrispondenza..4 La felicità delle lettere (nome della libreria Pasquali) è non solo la più grande importatrice di libri stranieri della Serenissima (Locke, Pope, Fontenelle, Malebranche, Buffon, Voltaire, Fielding, Richardson ecc.) ma anche il luogo fi sico dove Conti incontra letterati e scienziati uniti dalla ricerca incessante di libri. Di qui lo sguardo rivolto come un’erma bifronte verso l’antico con le sue civiltà da esplorare, i miti da decifrare, ritenendo che in essi potesse rivelarsi una sapienza antica espressasi nelle forme architettoniche, dai templi al teatro, modellato sulla fi gura del tempio e luogo di riti da far rivivere sulla scena moderna anche con l’uso ormai controcorrente dei cori e della musica.
/1 Anche Ariani ravvisa nella scena del Druso «una ripresa, in chiave neoclassica, dello spazio chiuso palladiano» (Drammaturgia e mitopoiesi, cit., p. 01/).
// C. Goldoni, Tutte le Opere, cit., IX, p. 02--. Per l’ipotesi, già avanzata da De Courville, che la Dissertation di Riccoboni si rivolga, come le due lettere di Elena Balletti, a Conti, cfr. B. Alfonzetti, Un Discours critique sur la tragedie françoise: il Monsieur **** è Luigi Riccoboni?, «FrancoItalica», III, 0..2, pp. 51-/2.
/. Cfr. F. Vivian, Il console Smith mercante e collezionista, cit., capp. V e VI..4 Si veda l’apparato iconografi co, ivi. Conti cita più volte Poleni nelle Rifl essioni su l’Aurora boreale,
in Prose e poesie, I, cit., pp. 13 e 1/.
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
!22
Tornando alla Prefazione al Marco Bruto, Conti descrive in dettaglio persino le fi nestre della sala che devono aprirsi per far vedere i prodigi letti dagli anti-chi romani come presagio di eventi straordinari, mentre forse si era trattato di un’Aurora boreale, come quella vista a Londra nel #"#$.2# Le fi nestre si spalancano durante il soliloquio di Porzia, dopo il teso confronto con Servilia, situato nella scena quinta del secondo atto. Qui Conti elimina due versi dalla parlata ispirata di Porzia («I destrieri s’affrontano; su scudi / Risuonan l’aste, e le percosse spa-de») per lasciare indefi niti i «luminosi mostri» dell’apparizione2! che spingono Porzia a invocare il soccorso degli auguri, per sciogliere il senso dei prodigi, e soprattutto Giove: «Il fulmine sospendi, o Sommo Padre; / Non invidiar la bella gloria a Bruto / D’estinguer i Tiranni».21 Le fi nestre restano aperte e consentono a Porzia di vedere l’eclisse del Sole durante il delirante soliloquio del quinto atto, quando Porzia ha le visioni di Bruto trafi tto e, abbracciando Bibulo portato dalle Serve, gli addita la pittura di Catone in atto di suicidarsi. È una delle tante sequenze del testo in cui la scenografi a interagisce con i movimenti degli attori e con la stessa recitazione dei versi.
La lettera al Bentivoglio affrontava come ultimo punto la differenza fra lo spettacolo all’aperto degli antichi e quello chiuso in una sala dei moderni, au-spicando che se «il teatro moderno non può uguagliare in vivacità di spettacolo l’antico, almeno per l’ammaestramento morale e politico sia reso più utile allo spettatore».23 Conti tenterà di colmare questo divario con la scenografi a archi-tettonica palladiana e con la scrittura di due tragedie politiche in cui si esalta l’amore per la patria e la libertà. Dopo aver reso omaggio da «buon Cittadino [...] alla sua Patria» nel Proteo,26 Conti approntava un’altra allegoria della patria libera nel Marco Bruto, proiettando nel carattere di Bruto sì il carattere del «cittadino romano», ma insieme il ritratto ideale del nuovo cittadino del mon-do libero e felice, fatto dall’amore per la religione e i parenti, dall’amore per la patria e dall’amore per la libertà. Le riserve morali e il controverso giudizio storico-politico sulla congiura erano superati in nome del nuovo decalogo in cui patria e bene pubblico occupavano il primo posto:
Nel Giunio Bruto dimostrai, che un Cittadino deve sacrifi care gl’interessi del proprio sangue alla Patria; nel Marco Bruto dimostro, che si deve ancora sacrifi care l’amico.L’uomo onesto deve anteporre il ben pubblico al privato [...].2$
2# Prefazione, in Le quattro tragedie, I, cit., pp. #45-#4#.2! Cfr. Marco Bruto, #a ed., cit., p. 3#; !a ed., cit., p. !63.21 La narrazione di altri prodigi in atto III, sc. III, con alcune modifi che fra le due edizioni
(cfr. #a ed., cit., p. 6#; !a ed., cit., p. !$4).23 Le quattro tragedie, II, cit., pp. 165-16#.26 Così nella dedica a Federico Cristiano di Prose e poesie, cit.2$ Prefazione al Marco Bruto, in Le quattro tragedie, I, cit., pp. #36 e !54.
%&'()*+& ',-./0&((*
155
Abstract
Contro il pregiudizio di una tragedia settecentesca astratta e letteraria, il contributo ricostruisce la vicenda scenico-editoriale delle due tragedie ‘repubblicane’ di Antonio Conti: Lucio Giunio Bruto e Marco Bruto. E la inquadra nella peculiare fi lologia del testo teatrale, secondo lo schema: stampa provvisoria - rappresentazione - stampa defi nitiva. Il confronto fra prime e seconde edizioni ha portato alla luce notevoli modifi che testuali, molte delle quali vanno attribuite alla concreta esperienza della scena, come Conti rico-nosce soprattutto nella Prefazione alla seconda edizione del Marco Bruto. Dati signifi cativi emergono anche dal differente paratesto che correda le quattro stampe (e si noti che la prima del Lucio Giunio Bruto appare anonima), a sua volta espunto dalla postuma (Le quattro tragedie, Bonducci, #"6#). Quest’ultima è solitamente usata dagli studiosi con grave perdita del senso dell’operazione teatrale e culturale realizzata da Conti fra il #"31 e il #"33. Essa può riassumersi nel progetto della fondazione di un ‘Teatro Romano’, già annunziato nella Prefazione a Prose e poesie del #"12. Questo progetto diventa operativo con la deci-sione di far stampare dall’editore Pasquali le due tragedie con la fi nalità di farle recitare al San Samuele dalla compagnia Imer-Vitalba-Casali. L’esclusione del Cesare (Faenza #"!$), in vista di una riscrittura mai portata a termine, corrisponde alla scrittura del Marco Bruto, dove l’abate mette fra parentesi i dubbi sull’operato di Bruto, visibili nella prima tragedia. Si può pertanto ipotizzare che Conti scelga per fondare il teatro romano le due tragedie ‘repubblicane’ in cui l’insegnamento delle virtù morali e politiche si fonda sui ‘doveri’ del cittadino romano: l’amore per la libertà e per la patria. Per decifrare l’allegoria di questa scelta (secondo la stessa poetica di Conti) ho ipotizzato un cambiamento d’orizzonte nell’ultimo decennio di Conti, confermato soprattutto dall’apertura al mondo politico tedesco, come dimostrano, fra l’altro, le dediche alla casa di Sassonia di Prose e poesie e del Lucio Giunio Bruto (II ed.). La prima soprattutto disegna la possibilità che l’utopia del Re fi losofo di Platone stia per realizzarsi, forse per la presenza di logge di corte a Dresda (e per la stessa iniziazione di Stefano di Lorena). Al quesito dibattuto dagli studiosi sul-l’appartenenza o meno di Conti alla massoneria, il lavoro risponde con una serie di rilievi sia sul platonismo simbolico di Prose e poesie (per il quale è fondamentale il richiamo al libro di Iside e Osiride di Plutarco) sia sul carattere architettonico del teatro. Espressione della ‘fantasia architettonica’, il teatro che Conti tratteggia, dopo il Cesare, sarà improntato all’antiquaria e alla scena di Palladio, in sintonia con il contesto padovano e veneziano (Giovanni Poleni, il console Smith ecc.).
Against the prejudice of an abstract and literary Eighteenth-century tragedy, this study re-constructs the stage and publishing history of Antonio Conti’s two ‘republican’ tragedies: Lucio Giunio Bruto and Marco Bruto. It contextualises this history within the particular philology of the theatrical text, following the scheme: provisional printing - staging - defi nitive printing. The comparison between fi rst and second editions has brought to light noteworthy textual modifi ca-tions, many of which must be attributed to concrete stage experience, as Conti himself recognises principally in the Preface to the second edition of Marco Bruto. Meaningful information also emerges from the different paratext that accompanies the four printed versions (it should be noted that the fi rst edition of Lucio Giunio Bruto appeared anonymously), in its turn expunged from the posthumous edition (Le quattro tragedie, Bonducci, !"%!). This last edition is habitually used by scholars thus overlooking the sense of the theatrical and cultural operation carried out by
+./(* & ,' -./7'0*./& 7&, «(&'(). ).8'/.»
15#
Conti between 1743 and 1744. This operation can be summarised in the project of the foundation of a ‘Teatro Romano’ (‘Roman Theatre’), previously announced in the Preface to Prose e poesie (1739). This project becomes operative with the decision to have the publisher Pasquali print the two tragedies with the goal of staging them at St. Samuele with the Imer-Vitalba-Casali company. The exclusion of Cesare (Faenza 1726), with a view to a rewrite that was never completed, corresponds to the writing of Marco Bruto, where the man of the cloth brackets his doubts on Brutus’s doing, visible in the fi rst tragedy. One can thus hypothesise that Conti chooses for the foundation of his Roman theatre the two ‘republican’ tragedies in which the teaching of moral and political virtues is founded on the ‘duties’ of the Roman citizen: love of liberty and of the homeland. To decipher the allegory of this choice (following Conti’s own poetics) I have hypothesised an ideological shift in the last decade of Conti’s life, confi rmed above all by his opening up to the German political world, as demonstrated by the fact that Prose e poesie and Lucio Giunio Bruto (second ed.) are dedicated to the House of Saxony. Above all the fi rst inscription suggests the possibility that the utopia of Plato’s philosopher King is about to come into being, perhaps due to the presence of court lodges in Dresden (and the initiation of Stephen of Lorraine). To the debated question of whether Conti was a Freemason or not, this study replies with a series of observations both on the symbolic Platonism of Prose e poesie (for which the reference to Plutarch’s Isis and Osiris is vital) and on the theatre’s architectural character. An expression of ‘architectural fantasy’, the theatre that Conti sketches, after Cesare, will be imbued with the old and with Palladio’s theatre, in line with the Paduan and Venetian context (Giovanni Poleni, the consul Smith, etc.).