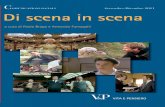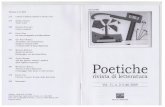L’opera di Giuseppe Nicola Nasini nella chiesa di San Michele Arcangelo a Passignano
Varianti d’autore, varianti di scena, in L’opera prima dell’opera. Fonti, libretti,...
Transcript of Varianti d’autore, varianti di scena, in L’opera prima dell’opera. Fonti, libretti,...
VARIANTI D’AUTORE, VARIANTI DI SCENA Nel secolo XVIII la tradizione testuale che precede il debutto, la ripresa o la pubblicazione di un’opera è generalmente connessa coi sistemi di produzione, perché libretti e partiture devono attraversare almeno due potenti mercati. Quello editoriale, sfornando i singoli drammi o le raccolte di best sellers, tende a falsare l’attribuzione ossia ad ascrivere a qualche nome altisonante una pièce che l’autore presunto ha confezionato soltanto in parte o non ha mai riconosciuto come propria. Per esempio L’impresario delle Canarie e Siface, regalati a Metastasio, o La scuola moderna affibbiata a Goldoni. Si tratta invece di un intermezzo adespoto e di due pasticci, uno serio e uno giocoso, che i massimi esponenti del teatro italiano settecentesco hanno soltanto contribuito a redigere quand’erano alle prime armi1. Il mercato teatrale, ancor più feroce, può intervenire già nella princeps, modificandone il dettato rispetto all’autografo. Le virgolette a margine segnalano i versi non intonati o non eseguiti e perciò recuperabili soltanto mediante la lettura. In molti casi la prima stampa riporta l’indicazione di una o più arie interpolate o cambiate e talora di pezzi d’assieme sostituiti. Inoltre le autorità controllano e censurano il testo pubblicato, lasciando alla partitura manoscritta l’onere di conservare la lezione originaria. Dunque la tipologia delle fonti presenta due casi limite che comprendono tutte le possibilità intermedie: da un lato gli autografi del compositore o del poeta, risolutivi se non fossero perduti quasi sempre; all’estremo opposto il pasticcio, ottenuto assemblando brandelli di provenienza disparata. Nell’un caso e nell’altro, se i testimoni superstiti sono i libretti confezionati per la rappresentazione oppure le copie calligrafiche della musica, il lavoro svolto in precedenza si rende irriconoscibile. Considerazioni di questo genere, peraltro abbastanza scontate, stanno alla base di quattro progetti di ricerca, due dei quali sono giunti a conclusione: - un sito internet che ospita i ventisei drammi di Metastasio nelle centoquarantuno redazioni licenziate dal poeta cesareo2; - un CD ROM che contiene, oltre alle pièces di cui sopra, l’edizione complanare delle versioni considerate d’autore, riveduta da Anna Vencato3. Altri due progetti sono tuttora in corso: - un secondo CD ROM che presenta l’edizione ipertestuale e multimediale del Filosofo di campagna di Goldoni e Galuppi, la cui fortuna è testimoniata da una cinquantina di libretti, da una ventina di partiture, da tre ristampe nelle raccolte letterarie e da un corredo iconografico di scene, vignette e locandine4;
1 Amico lettore, in La scuola moderna o sia La maestra di buon gusto, Venezia, Fenzo, 1748, p. 3; M. F. Robinson, L'opera napoletana, Venezia, Marsilio, 1984, p. 218; L. Tufano, Itinerari librettistici tra Sei e Settecento: dalla “Forza della virtù” di Domenico David a “Siface” di Pietro Metastasio, in Il melodramma di Pietro Metastasio. La poesia, la musica, la messa in scena e l’opera italiana del Settecento, a cura di E. Sala Di Felice e R. Caira Lumetti, Roma, Aracne, 2001, pp. 193-231. 2 P. Metastasio, Drammi per musica, http://opera.maldura.unipd.it/metastasio/, a cura di D. Albanese (progetto grafico), A. L. Bellina (progetto scientifico), E. Bojan, L. Grappeggia e S. Marin (cura dei testi), L. Tessarolo (progetto informatico), A. Vencato (revisione dei testi); enti finanziatori: Università di Padova, MIUR. 3 P. Metastasio, Drammi per musica, CD ROM, a cura di A. L. Bellina (progetto scientifico), E. Bojan, L. Grappeggia e S. Marin (cura dei testi), L. Tessarolo (progetto informatico), A. Vencato (revisione dei testi e delle varianti), Venezia, Marsilio, 2003. 4 C. Goldoni - B. Galuppi, Il filosofo di campagna, ipertesto poetico e musicale, CD ROM, a cura di A. L. Bellina (progetto scientifico), M. I. Biggi (ricerca iconografica), A. Gasparini (cura della partitura D-Sl), L. Martelletto e M. G. Miggiani (cura della partitura F-Pn), G. Polin (recensio), L. Tessarolo (progetto informatico), A. Toffolini (cura delle partiture descriptae), A. Vencato (cura dei libretti), in corso; enti finanziatori: Università di Padova, fondazione teatro La Fenice, MIUR.
- un sito in cui si pubblicano tutti i libretti di Goldoni, circa un’ottantina compresi gli intermezzi, i drammi seri e quelli giocosi5. Le due ricerche metastasiane riguardano in parte gli stessi oggetti dal punto di vista filologico ma non da quello informatico perché nel sito e nel CD ROM si applicano tecnologie diverse. Entrambi contengono i testi in edizione critica, elencati in ordine alfabetico o cronologico, il lessico automatico e l’indice dei nomi, il tutto consultabile mediante un motore veloce e flessibile, progettato da Luigi Tessarolo. In particolare nel CD ROM è possibile ottenere, per ciascuna interrogazione, la rappresentazione grafica della frequenza nei diversi drammi, rapportata alla dimensione dell'opera. Per esempio cercando la stringa amor*, in cui l’asterisco sostituisce un numero indeterminato di caratteri, gli istogrammi evidenziano in quali pièces Metastasio si sofferma sulla passione erotica. Oltre a Semiramide, superano il 41% Achille in Sciro, Ipermestra, Romolo e Ruggiero, tutti destinati, forse non per caso, a celebrare gli accoppiamenti giudiziosi degli Asburgo: rispettivamente le nozze di Maria Teresa con Francesco Stefano, di Marianna con Carlo di Lorena, del futuro Leopoldo II con Maria Luisa di Borbone e dell’arciduca Ferdinando con Maria Beatrice d’Este.
5 C. Goldoni, Drammi per musica, http://opera.maldura.unipd.it/goldoni/, a cura di D. Albanese (progetto grafico), A. L. Bellina (progetto scientifico), M. I. Biggi (ricerca iconografica), A. Bogo e K. Gianni (scansione dei testi), L. Tessarolo (progetto informatico), S. Urbani e A. Vencato (cura dei testi), in corso; enti finanziatori: Università di Padova, Casa di Goldoni, MIUR.
Ripetendo l’operazione con la radice amic*, si vede che l’amicizia trionfa nella Clemenza, grazie al nobile sentimento che unisce Tito, Sesto e Annio, e nel truculento Artaserse perché il monarca persiano è legato ad Arbace con cui ha condiviso l’infanzia, l’adolescenza e la gloria militare. A questi drammi si aggiunge L’olimpiade, com’è prevedibile, ma non Ruggiero, benché sia costruito sullo stesso plot.
Infine, cercando past*, si conferma la totale assenza di ovini e di armenti nel dramma metastasiano, politicamente impegnato e fortemente urbano piuttosto che arcadico e silvestre. Infatti non esistono pastori né pastorelle, a meno che non si tratti di sovrani celati in rozze spoglie come Demetrio, Ciro e Abdolonimo, di gentildonne cretesi malamente travestite e presto smascherate come nell’Olimpiade o di principesse reali come la sorellina smarrita di Zenobia e la protagonista di Nitteti.
Il motore permette di selezionare porzioni di testo (recitativi, arie, personaggi, didascalie, titoli, altra prosa), di limitare la richiesta al corpus di una singola edizione6 o di combinare variamente qualsiasi possibilità. Inoltre prevede interrogazioni molto raffinate e complesse, nel sito come nel CD ROM. Per esempio si può cercare am*, radice di amore, escludendo amb* e ami* per non trovare ambedue, ambire, ambasciatore, amico e derivati. Aggiungendo la condizione che am* sia menzionato nella stessa scena insieme al verbo dovere, indicato con deb*, dev*, dob* o dov*, si verifica la frequenza del ben noto conflitto che lacera i personaggi metastasiani, in bilico fra l’urgenza delle passioni e il peso della regalità. Dalle due liste di voci, che il programma fornisce per default, si cancellano facilmente i termini che non interessano come amaro, ammirare, debole, dove e simili. Anche se Didone abbandonata dovrebbe comparire in prima fila, vista la tremenda incertezza che affligge il povero Enea, dal risultato emergono invece altre pièces fra cui Ezio, Adriano in Siria e Il re pastore che superano il 13%.
6 Oltre alle principes (indicate con P, P1, P2, P3), P. Metastasio, Opere drammatiche, Venezia, Bettinelli, 1733-1745 (B); P. Metastasio, Poesie, Parigi, Quillau, 1755 (Q, Q1, Q2); P. Metastasio, Poesie coll’aggiunta della “Nitteti” e del “Sogno”, Torino, stamperia Reale, 1757 (R, R1, R2); P. Metastasio, Opere, Parigi, Hérissant, 1780-1782 (H).
Consultando nel CD ROM la complanare delle diverse redazioni, in cui il programma elabora il testo evidenziando le discordanze mediante un altro colore, si vede che talora le varianti di scena interessano anche la princeps tramandata in due versioni. Per esempio un confronto fra le Mutazioni delle stesure di Ezio, la veneziana a sinistra e la romana a destra, a occhio e croce mostra come il teatro lagunare di San Giovanni Crisostomo, che ospita la première nell’autunno 1728 con musica di Porpora, disponga di un budget più risicato rispetto alla sala delle Dame, dove si svolge la recita del carnevale 1729 con le note di Auletta, impreziosita da fontane, fiori, cascate e grottesche.
Anche se non c’è motivo di supporre che le scarse varianti dell’opera siano state apportate da Domenico Lalli che firma la dedica in laguna, Metastasio dimentica o disapprova indirettamente la lezione veneziana del testo, ossia la prima assoluta, dato che accoglie la versione della città eterna nelle ristampe licenziate successivamente e in particolare nell’Hérissant che considera definitiva. Al contrario appartengono sicuramente alla sua penna, come testimoniano lettere, avvertenze e dichiarazioni, sia il nuovo finale di Catone, sia le modifiche sostanziali apportate per la scena madrilena a Semiramide, Adriano in Siria, Alessandro nell’Indie e soprattutto a quella Didone abbandonata che il poeta affida nel 1724 alle scene napoletane e riscrive per quelle spagnole nel 1752. I cambiamenti riguardano la grafia, la morfologia, le didascalie, la sostituzione, l’aggiunta o il taglio di arie e di recitativi, il rimaneggiamento d’intere scene, i finali riscritti di sana pianta, la licenza per la festa di corte aggiunta al dramma commissionato in origine da un teatro impresariale.
Invece Nitteti, sempre destinata a Ferdinando VI di Borbone, presenta un caso intermedio fra i due precedenti. Per l’ingresso trionfale del faraone Amasi, Metastasio aveva previsto un pomposo elefante bianco. Ma l’amico Farinello, che organizzava le fiestas reales, gli propose di trasportare il sovrano mediante un carro trainato da cavalli, meno impegnativo e meno ingombrante. Il poeta approva esplicitamente la variante7, che compare nella princeps del 1756, ma restaura il pachiderma nell’edizione Reale e nell’Hérissant, destinate alla lettura.
7 P. Metastasio, Lettere, in Tutte le opere, a cura di B. Brunelli, Milano, Mondadori, 1951, III, p. 1076.
La linea di demarcazione fra le varianti d’autore e quelle degli operatori, che montano la rappresentazione, risulta molto sottile: nel caso di Ezio non sappiamo a chi si debba la lezione della princeps, diversa rispetto alla seconda edizione approvata dal poeta nelle raccolte successive; nel caso di Didone, quasi trent’anni dopo la prima stesura, lo stesso Metastasio apporta cambiamenti molto radicali per un nuovo allestimento; nel caso di Nitteti accetta di buon grado i cavalli proposti dall’amico Farinello al posto del macchinoso elefante. Esclusivamente alle varianti di scena è dedicato invece il terzo progetto che riguarda Il filosofo di campagna e che intende sfruttare le potenzialità offerte dal mezzo informatico per mettere in relazione le fonti dirette e indirette, verbali, musicali e iconografiche, relative a un solo dramma. Dunque il CD ROM contiene l’edizione critica di tutti i testimoni, libretti e partiture, trascritte con Finale, che si possono ascoltare grazie al sistema MIDI in dotazione per ogni computer. Si tratta di una pièce molto longeva, conservata anche dalle raccolte non licenziate dall’autore8, rappresentata a Venezia nel 1754 e ripresa almeno una volta all’anno fino al 1772 nelle piazze più disparate, comprese San Pietroburgo, Dublino e Malta ma escluse l’Italia meridionale e la Francia protezionista. Nel corso di queste vicende burrascose, i cambiamenti che si producono sono in tutto analoghi a quelli riscontrati per i drammi metastasiani: grafia, morfologia, tagli, sostituzioni e
8 C. Goldoni, Opere drammatiche giocose, Venezia, Savioli, 1770-1772, V, pp. 87-134; C. Goldoni, Opere drammatiche giocose, Torino, Guibert e Orgeas, 1777-1778, I, pp. 1-50; C. Goldoni, Drammi giocosi per musica, in Opere teatrali, Venezia, Zatta, 1794-1795, XLIII, pp. 63-122.
simili, con l’aggiunta dell’intervento censorio per le allusioni ritenute più scabrose, naturalmente nei territori dello stato pontificio. Un programma dedicato, in grado di eseguire da solo, senza alcun intervento, un confronto verbale assolutamente automatico fra le numerose redazioni, si attiva selezionando una riga qualsiasi, nel recitativo, nell’aria o nel pezzo d’assieme. Nella finestra che compare, si danno quattro casi sottolineati da uno sfondo diverso: verde per la concordanza con la scritta «uguale», arancio per la microvariante segnalata per intero, bianco per l’indicazione del primo e dell’ultimo verso omessi, grigio per la porzione di testo sostituita. Oltre ai cambiamenti, il sistema verifica l’estrema longevità di alcuni brani, non solo dei concertati, che richiedono l’accordo di due o più interpreti, ma anche di certe esibizioni giocose affidate a personaggi secondari come il notaio Capocchio (II, 4). Grazie alla collazione, fin dalla prima battuta dell’opera emergono facilmente le linee portanti della tradizione ossia dello stemma, se si riscontrano gli stessi tagli o la modifica dei medesimi brani. Per esempio sessanta versi spariscono a Roma nel 1757 e a Venezia nel 1761, mentre se ne omettono centoquarantadue a Vienna e a Presburgo nel 1759.
Evidenziando l’inizio del secondo atto, si trova conferma perché Roma 1757 concorda con Venezia 1761 nella sostituzione di quarantacinque versi, mentre nel 1759 a Vienna e a Presburgo si pratica lo stesso taglio, allargato nella ripresa coeva di Bruxelles.
Naturalmente il cambiamento dei brani solistici, trattandosi di un dramma comico, riguarda soprattutto i cantanti seri, in percentuale doppia rispetto ai buffi che costituiscono l’asse portante delle compagnie girovaghe e dunque garantiscono la persistenza del repertorio. I mezzi caratteri estraggono dal loro capiente baule i pezzi favoriti, talora senza modificare né l’affetto previsto da Goldoni né il profilo del personaggio né la situazione emotiva e drammaturgica in cui si trova. Per esempio l’aria di tempesta Se perde il caro lido (I, 1) con cui si presenta Eugenia, Giovanna Baglioni a Venezia nel 1754, subisce numerosi interventi.
Tuttavia la ragazza, promessa dal padre al buffo Nardo, un contadino avveduto e facoltoso, ma innamorata di Rinaldo, il soprano en travesti, resta in alto mare spesso e volentieri, perché difficilmente la prima donna rinuncia all’esibizione virtuosistica dell’aria di tempesta. Agitata in seno al mare, sotto il ciel funesto e nero, non m'appare alcun sentiero, son portata a naufragar. (Il filosofo di campagna, Siena, Bonetti, 1756) Torbida notte intorno il ciel d'orror circonda, strepita il vento e l'onda freme agitando il mar. (Il filosofo di campagna, Parma, Monti, 1758) Pria di lasciar la sponda mira il nocchier attento
come s'increspa l'onda, dove più spira il vento e poi s'espone al mar. (Il filosofo di campagna, Münster, Koerdink, 1764) Interrogando il sito dedicato al poeta cesareo, si vede che l’ultima strofa è un prestito metastasiano malamente pasticciato. Pria di lasciar la sponda il buon nocchiero imita; vedi se in calma è l'onda; guarda se chiaro è il dì. (Ipermestra, II, 1) Quindi, siccome i seri utilizzano le arie di Metastasio, adatte al loro linguaggio elevato, sembra lecito chiedersi se i comici non riciclino i brani dello stesso Goldoni provenienti dagli altri drammi giocosi. La risposta si trova nel quarto e ultimo progetto, quello che riguarda i libretti del commediografo veneziano, sempre in edizione critica. Per esempio il duetto fra i buffi nella prima del Filosofo di campagna, Lieti canori augelli (III, 9), diventa Ho nel core un non so che nella ripresa del 1760 a Cremona. Consultando il sito goldoniano si vede che il pezzo proviene dalla Calamita de’ cuori (III, 7) interpretata da cantanti diversi al San Samuele nel carnevale 1753, sempre con la musica di Galuppi. Anche il sito goldoniano, come quello metastasiano, è dotato di un indice dei nomi e di un lessico automatizzato che permette di confrontare immediatamente l’atteggiamento stilistico dei due librettisti, dovuto in parte alla netta opposizione fra serio e giocoso, ristabilita nel Settecento razionalista. Il poeta cesareo si dedica soltanto al genere alto, impiegando un monolinguismo selezionato, marmoreo e levigato. Scegliendo la zeta, una lettera iniziale poco usata nell’alfabeto italiano, si vede infatti che usa tre lemmi soli in ventisei drammi: «zeffiro», «zelo» (con la variante «zel») e «zuffa». Naturalmente non si contano Zeilan, Zenobia, Zopiro e Zoroastro, perché si tratta di nomi propri citati nel recitativo, nell’Argomento o nelle didascalie.
Invece Goldoni frequenta quasi esclusivamente il comico, incline alla canzonatura poliglotta e all’apertura sbarazzina o sperimentale verso i livelli bassi del toscano e dei dialetti. Pur senza prendere in considerazione l’ipercorrettismo caricaturale «zerva» per «serva» o l’onomatopea «ziff» e «zaff», l’avvocato veneziano si sbizzarrisce con ventuno lemmi in ventidue drammi, quelli pubblicati finora nel sito. Dunque mediante una proporzione semplice (21 : 22 = x : 26) si misura la sua varietas (x = 24,81) grosso modo otto volte superiore a quella di Metastasio.
Non è dato conoscere in anticipo il futuro che ci riservano le nuove tecnologie: quelli che sembrano semplicemente strumenti più complessi, e all’apparenza più comodi, talora inducono risultati imprevisti. Certo il formato elettronico non sostituisce il libro che si può leggere tranquillamente stando in poltrona, a letto oppure a bordo di un mezzo pubblico, ma permette operazioni che mediante la carta stampata risultano impossibili, in particolare il confronto più o meno automatico di un sistema di varianti numeroso, complesso e incontrollabile com’è quello dell’opera. La disinvoltura dei cantanti, che utilizzavano nei contesti più strampalati i materiali con cui riempivano i loro bauli, è cosa risaputa e documentata. Ma il supporto informatico rende più semplice e insieme più sistematica l’identificazione della provenienza. Comunque il punto di partenza, per garantire un tasso minimo di acribia, rimane la costituzione di testi critici attendibili da cui emergono un Metastasio diverso rispetto a quello pubblicato da Bruno Brunelli e un Goldoni sensibilmente nuovo rispetto alla vulgata di Giuseppe Ortolani9. Per dotare la rete di strumenti d’interrogazione verbale applicati a lezioni arbirarie, la presenza del filologo non è affatto necessaria. Al contrario, per consegnare all’intero web, e in certa misura anche ai posteri, un dettato 9 C. Goldoni, Opere complete, a cura di G. Ortolani, Venezia, Municipio di Venezia, 1908-1951; C. Goldoni, Tutte le opere, a cura di G. Ortolani, Milano, Mondadori, 1935-1956.
infedele o corrotto, è più che sufficiente un esperto informatico intelligente e ben allenato. Ma anche quest’ultimo diventa relativamente superfluo se si pubblicano manoscritti o stampe in facsimile, confezionando una piatta serie di scansioni, in pratica fotocopie elettroniche, utili a chi non vuole ordinare le riproduzioni in biblioteca ma impermeabili alla ricerca e in compenso molto dispendiose.